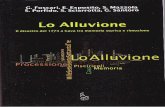PETIT (J.-P.), SANTORO (S.), La Gallia Mosellana nell’età dei Severi: il caso del vicus di...
-
Upload
univ-lorraine -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of PETIT (J.-P.), SANTORO (S.), La Gallia Mosellana nell’età dei Severi: il caso del vicus di...
AMERICAN JOURNAL OF ANCIENT HISTORY
Editor, New Series: T. Corey Brennan, Rutgers University
Associate Editor: Christopher Mackay, University of Alberta
Assistant Editors: Dobrinka Chiekova, Bryn Mawr College; Debra Nousek, University of Western Ontario Editorial Advisory Board: W. Robert Connor, President, The Teagle Foundation, New York; Erich S. Gruen, University of California, Berkeley; Sabine MacCormack, University of Notre Dame; Stephen V. Tracy, The Ohio State University and Director, American School of Classical Studies, Athens.
Editorial assistant: Andrew G. Scott, Rutgers University
For Contributors: From New Series volume 1 (2002) the editorial office of the Journal is at The Department of Classics, Ruth Adams Building 007, Rutgers University, 131 George Street, New Brunswick, NJ 08901-1414, (USA), tel. 732.932.9493, fax 732.932.9246, email: [email protected]. For further information, please visit the journal website www.ajah.org. All editorial correspondence should be addressed to the Editor.
Typescripts intended for publication should be at least double-spaced (text and notes), with the notes numbered consecutively and following the text. Journals should be abbreviated as in L’Année philologique; modifications customary in English will be accepted. No indication of the author’s identity should appear on the typescript: the name and address should be on a separate page. References to the author’s own work should be in the same style as references to the work of others. Personal acknowledgments should not be included: they may be added after the article has been accepted for publication. Authors who want rejected articles returned should enclose postage.
For Subscriptions: From New Series volume 2.2 (2003) [2007] AJAH is published by Gorgias Press. All correspondence on business, subscription, advertising and permission matters should be addressed to Gorgias Press (AJAH), 954 River Road, Piscataway, NJ 08854 (USA), tel: 732-885-8900, email: [email protected]. Subscriptions are $85/vol. for individuals and institutions, plus shipping, handling and sales tax when appropriate. All prices are in USD and payments can be made by credit cards or checks drawn on US banks. Prepayment is required for shipment.
TH E R O MA N EMP IR E
D U R IN G
TH E S EV ER A N D Y N A S TY:
C A S E S TU D IES IN H IS TO RY,
A RT, A R C H ITEC TU R E, E CO N O MY
A N D LITER ATU R E
Edited by Eric C. De Sena (American Research Center in Sofia
and John Cabot University, Rome)
This volume is dedicated to the tens of millions of brave people
in North Africa and the Near East
(the homelands of Septimius Severus and Julia Domna)
who in 2011 and 2012 have risked and, even, lost their lives
in order to improve the conditions
of their countries and to achieve the unalienable rights of life,
liberty, justice and the pursuit of happiness.
Gorgias Press LLC, 954 River Road, Piscataway, NJ, 08854, USA
www.gorgiaspress.com
Copyright © by Gorgias Press LLC2013
All rights reserved under International and Pan-American CopyrightConventions. No part of this publication may be reproduced, stored in aretrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic,mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise without theprior written permission of Gorgias Press LLC.
Printed in the United States of America
2013 ܘ
9ISBN 978-1-59333-838-1 ISSN 0362-8914
v
TA B LE O F C O N TEN TS
Εditor’s Νote ................................................................................... ix Ιntroduction ..................................................................................... xi
SEVERAN HISTORY AND LITERATURE ...................................1
The Parthian Campaigns of Septimius Severus: Causes, and Roles in
Dynastic Legitimation ...............................................................3 Mark K. Gradoni
“Unitas ex Africa: Was Tertullian the Origo
of Imperial Unification?” ........................................................25 E.T. Walters
URBAN TRANSFORMATIONS
DURING THE SEVERAN PERIOD......................................67
La Gallia Mosellana nell’età dei Severi:
il caso del Vicus di Bliesbruck ................................................69 Jean-Paul Petit Sara Santoro
Water Works and Monuments in Gaul in the Severan Age:
Some Considerations...............................................................95 Alice Dazzi
More Water for Rome: Nothing New in the Eternal City?
Water-Related Monuments as Part
of the Severan Building Program .......................................... 117 Jens Koehler
A Note on the Architectural Decoration
of the Severan Period in Pamphylia and Cilicia .................... 151 Müjde Türkmen-Peker
vi THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
L’Attività edilizia a destinazione pubblica fra i Severi
e i Soldatenkaiser: continuità e trasformazioni ..................... 173 Simone Rambaldi
Il tempio di Serapide sul Quirinale:
note di archeologia e topografia tra Antichità e Medioevo. .. 207 Ottavio Bucarelli
Alcune osservazioni sulla Sicilia durante il periodo dei Severi .... 227 Giancarlo Germanà
Vestigia architettoniche del periodo di Settimio Severo
in Tunisia .............................................................................. 255 Paola Puppo
ASPECTS OF SOCIETY AND ECONOMY
DURING THE SEVERAN PERIOD.................................... 285
The Origo of the Thracian Praetorians in the Time of Severans ... 287 Ivo Topalilov
Un riempimento fognario di età Severiana dalle cosiddette
“Terme di Elagabalo” a Roma .............................................. 301 Edoardo Radaelli
La ceramica ad ingobbiatura nera di Treviri –
una merce costosa in Pannonia durante l’epoca Severiana ... 341 Eszter Harsányi
Baetican Oil and Septimius Severus ............................................. 361 Lúcia Afonso
Economic Growth in the Early and Middle Imperial Periods,
Pre-200 AD: an Economic Approach
from a Peripheral Hispanic Province, Lusitania ................... 377 José Carlos Quaresma
Economy and Trade of Sicily During Severan Period:
Highlights Between Archaeology and History...................... 415 Daniele Malfitana – Carmela Franco – Annarita Di Mauro Thematic Maps By G. Fragalà
TABLE OF CONTENTS vii
SEVERAN ART AND IDEOLOGY ............................................ 463
Between Tradition and Innovation –
the Visual Representation of Severan Emperors ................... 465 Florian Leitmeir
Ideological Messages and Local Preferences:
the Imagery of the Severan Arch at Lepcis Magna ............... 493 Stephan Faust
Elagabalo invictus sacerdos: l’imperatore fanciullo
e la centralizzazione del sacro attraverso
lo specchio delle monete ....................................................... 515 Andrea Gariboldi
The Arch of Septimius Severus in the Roman Forum:
a Re-Consideration ................................................................ 541 Maria Lloyd
69
LA G A LLIA MO S ELLA N A
N ELL’ETÀ D EI S EV ER I :
IL C A S O D EL V IC U S
D I B LIES B R UC K
Jean-Paul Petit (Parc Archeologique Européen de Bliesbruck-Reinheim)
and
Sara Santoro (Università Gabriele d’Annunzio)
UN MODELLO INTERPRETATIVO IN DISCUSSIONE:
LA CRISI DELLE GALLIE NELL’ETA DEI SEVERI
Gli studi sulla Gallia raramente prendono in considerazione l’età severia-
na in quanto tale. Albert Grenier, il grande archeologo della Gallia, in-
cludeva quest’epoca in quella che egli chiamava, cento anni fa, la deca-
denza dell’impero (Grenier 1906). Ancora di recente, nel 2005, Alain
Ferdière, nel suo bilancio sulle Gallie, tratta l’età severiana nel capitolo
intitolato “Un secolo di crisi” (Ferdière 2005). In generale, essa viene
vista come « une période transitoire, riche en innovations et en transfor-
mations, et annonciatrice de changements profonds ». In una visione più
ampiamente diacronica, R. Bedon1 identifica un lungo periodo unitario di
1 Bedon 2001, 25: « L’impression que dégage l’époque est celle d’une pro-
gression générale vers plus de monumentalité, de commodité et de confort pour
les habitants….. »
70 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
sviluppo in Gallia, dai Flavi ai Severi compresi, caratterizzato da un au-
mento costante della monumentalità e del benessere degli abitanti.
Le difficoltà di riconoscere l’età severiana come un periodo dotato di
proprie caratteristiche e marcato da un trend di sviluppo dipendono in
gran parte dal peso della storiografia che ha sempre riconosciuto come
l’età d’oro delle province galliche il regno degli Antonini, enfatizzando e
generalizzando le difficoltà politiche che toccarono l’impero, ed in parti-
colare le Gallie, alla fine di questa dinastia. I regni di Marco Aurelio e di
Commodo furono certamente segnati dalla pressione dei barbari sul Da-
nubio e dalle incursioni germaniche nella Gallia Belgica, ma è forse trop-
po ritenere che subito dopo l’assassinio di quest’ultimo la situazione di
instabilità politica avrebbe precipitato queste regioni “dans la décadence
économique et le déséquilibre social” così profondamente da coinvolgere
in questa visione pessimistica anche il periodo dominato dalla successiva
dinastia dei Severi. A. Ferdière, pur non aderendo alla vecchia visione di
declino e decadenza espressa da A. Grenier, constata, a partire dal regno
di Marco Aurelio, “una certa stagnazione, o meglio un inizio di regres-
sione” nelle province galliche, genericamente intese, in città come in
campagna. Occorre, tuttavia, articolare meglio l’interpretazione, sia delle
fonti che del dato archeologico, anzitutto in senso spaziale: le Gallie han-
no sempre costituito un insieme vastissimo e differenziato, che impedisce
di trattarne in modo generale. Qui ci si limiterà ai dati archeologici relati-
vi alla Gallia Mosellana, quella parte della Gallia Belgica costituita dalle
civitates dei Treviri, dei Mediomatrici e dei Leuqui.
Come aveva già riconosciuto Yves Burnand (Burnand 1990, 147–
188), tratteggiando il quadro della civitas Mediomatricorum, il periodo
turbolento della fine del II sec. d.C. fu seguito da una incontestabile fase
di benessere in età severiana. Quelle turbolenze della fine del II sec. d.C.,
per di più, non sembrano aver lasciato traccia archeologica evidente, al-
meno in questa regione.
E’ vero che in passato diversi archeologi hanno menzionato strati di
distruzione in tutto l’est della Gallia e li hanno datati al 160–170 d.C. o
alla fine del II, riprendendo i lavori, all’epoca pionieristici, di J.-J. Hatt
(Hatt 1970), che aveva cercato di mostrare l’esistenza di rotture cronolo-
giche nello studio delle stratigrafie sia urbane che rurali. Oggi questa di-
retta messa in relazione fra dati archeologici, talvolta mal datati o la cui
datazione è soggetta a progressiva revisione, e gli avvenimenti storici,
tipico di una histoire évenémentielle, appare una spiegazione semplicisti-
ca. Cercheremo dunque di dimostrare, attraverso i dati archeologici, come
LA GALLIA MOSELLANA NELL’ETÀ DEI SEVERI 71
questo assunto dell’epoca severiana come di un’epoca di crisi vada rimes-
so in discussione, almeno per i territori della Gallia nord-orientale e come
anzi il primo trentennio del III sec. d.C. corrisponda ad una fioritura
economica di quei territori, che si tradusse in una monumentalizzazione
anche nei siti minori ed in un concreto miglioramento delle condizioni di
vita degli abitanti.
LA CIVITAS MEDIOMATRICORUM NELL’ETA DEI SEVERI
La grande città della Mosella fu Treviri. Essa fu dotata di una cinta mura-
ria negli anni 160–180 d.C., certamente in relazione alle pressioni germa-
niche sul limes e alle difficoltà interne di quell’epoca ma soprattutto come
espressione monumentale della potenza economica della città e della ric-
chezza delle sue élites. Nella costruzione delle mura, non furono utilizzati
materiali di reimpiego, come si può constatare invece negli apparati di-
fensivi costruiti più tardi: il loro esteso, articolato percorso sottintende un
progetto accurato, unitario, non eseguito sotto la spinta dell’emergenza.
Fu probabilmente in questa epoca che Treviri divenne la capitale della
Gallia Belgica. Certo la città fu particolarmente fiorente nel primo terzo
del III secolo (Heinen 1985), come dimostra il lusso dei monumenti fu-
nerari, quale quello dei Secundini di Igel, che danno l’immagine di un
ceto mercantile ricco e di commerci fiorenti gestiti dalle élites di Treviri
sia verso la Gallia che nelle regioni del Danubio. I sontuosi mosaici delle
ville del suo territorio, come quello “dei gladiatori” della villa di Nen-
ning, l’ampiezza e ricchezza stessa delle ville, i ricchi contesti di materia-
li, la fioritura delle produzioni ceramiche confermano la solidità econo-
mica del territorio in quel periodo.
La civitas Mediomatricorum viveva nell’orbita di Treviri e beneficiò
dello stesso sviluppo, anche se su una scala minore. I dati che concernono
il suo capoluogo, Divodurum (Metz), sono ancora insufficienti per misu-
rare chiaramente il miglioramento dell’epoca severiana nell’area urbana,
ma è certo che a partire dagli inizi del III sec. d.C. gli insedimenti rurali
raggiunsero il loro massimo splendore. E’ il caso delle grandi ville di
Liehon e Peltre a sud di Metz, ed anche della sontuosa villa di Reinheim:
la ricchezza di queste residenze extraurbane si esprime nelle dimensioni,
nella complessità delle planimetrie, nella presenza degli impianti termali,
negli apparati decorativi.
E’ ancora aperta le discussione sul fatto che questa fioritura si estenda
anche agli insediamenti minori, la cui dipendenza dalle ville o dalle città
72 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
resta problematica, ma la cui importanza nel sistema economico e demo-
grafico dell’impero in area centro europea è stata dimostrata da innu-
merevoli scavi, studi e pubblicazioni a partire dal convegno su Les ag-
glomérations secondaires tenuto nel 1994 a Bliesbruck-Reinheim. Sulla
fioritura vs. crisi dei vici in Gallia nel III secolo, M. Rorison (Rorison
2001) cita numerosi esempi, piuttosto contraddittori fra loro, senza giun-
gere a delle conclusioni definitive : alcuni vedono il loro apogeo nel II
sec. d.C, come per es. Argenton-sur-Creuse, mentre altri lo raggiungono
piuttosto nel primo venticinquennio del III, come Bliesbruck. Anche in
analisi meno generali, ma limitate a regioni circoscritte, i dati archeologi-
ci sono contraddittori: per esempio, nella regione della Côte-d’Or, la crisi
del II sec. d.C. è sensibile a Mâlain, dove tuttavia il periodo severiano è
segnato da nuove attività edilizie e, pur essendo complessivamente un
periodo di recessione economica, si iscrive piuttosto nella linea della con-
tinuità che in quella di una rottura con la fase precedente. Ad Alesia, gli
scavi non hanno restituito nessuna evidenza dell’impatto sulla vita della
città da parte dei torbidi della fine del II secolo e nell’età severiana la città
sembra essere stata altrettanto attiva e prospera quanto lo era stata nel
secolo precedente (Bénard, Mangin, Goguey, Roussel 1994).
LA FIORITURA SEVERIANA DEL VICUS
DI BLIESBRUCK-REINHEIM
Fra gli insediamenti minori della Civitas Mediomatricorum, si segnala
come eccellente esempio il vicus di Blisebruck che, con la sua fioritura
monumentale, confermata dagli scavi recentissimi, mette particolarmente
bene in evidenza questo “apogeo” severiano.
Il vicus è oggetto di ricerche programmate dal 1985, che hanno porta-
to alla realizzazione di un Parco archeologico europeo, franco-tedesco.
Sono stati scavati in maniera estensiva e stratigrafica le terme pubbliche e
due quartieri artigianali (quartiere est e quartiere ovest). Dal 2008 è in
corso lo scavo del centro pubblico del vicus, in partenariato fra il servizio
archeologico del Dipartimento della Mosella e l’Università di Chieti-
Pescara.
Il vicus di Bliesbruck si trova nella parte orientale della civitas Me-
diomatricorum. L’importanza di questa “agglomération secondaire” di
carattere certamente urbano e il suo inserimento in un sistema denso di
insediamenti minori della stessa natura suggeriscono una revisione dello
schema organizzativo tradizionale di quella civitas, incentrato esclusiva-
LA GALLIA MOSELLANA NELL’ETÀ DEI SEVERI 73
mente sulla vallata della Mosella. Bliesbruck era collocato invece su un
asse parallelo a questa, corrispondente alle vallate della Sarre e della
Blies, in uno spazio geografico proiettato verso le regioni renane e la civi-
tas Trevirorum (Petit, Brunella 2005, 24).
Una serie di tumuli di tarda età halstattiana, fra cui la celebre tomba
della principessa di Reinheim, indica l’esistenza, fra V e IV sec. a.C. di
un popolamento diffuso organizzato in poli principeschi ed in contatto
con le culture del Mediterraneo. A questa fase appartengono alcune strut-
ture abitative poco caratterizzate, ai piedi della collina, mentre non è stato
ancora trovato l’insediamento tardo lateniano, documentato alla fine del I
sec. a.C. da una necropoli (Reinhardt 2010, 213–214) e da un grande san-
tuario (Reinhardt 2010, 250–317).
In età romana, la vallata della Blies appare organizzata su più poli in-
sediativi: 1) un vicus dalla struttura propriamente urbana e razionalmente
organizzata su un asse viario NS, corrispondente alla strada dipartimen-
tale moderna; 2) adiacente a questo, la grande villa di Reinheim, con una
grandissima corte recintata, con costruzioni perimetrali ad intervalli rego-
lari, appartenente a quella tipologia a piano assiale, così diffusa in Gallia
(Sarateanu-Müller 2007 e c.s.; Ferdière et al. 2010); 3) alcuni nuclei rurali
e forse santuariali, sull’altura di Homeric e nel territorio nord-orientale di
questo vasto anfiteatro di colline (Reinhardt 2010, 251–303).
Le prospezioni geofisiche e gli scavi sistematici, condotti dal 1990 in
poi, consentono di avere un’idea precisa del nucleo principale del vicus e
del suo sviluppo storico. L’inizio dell’insediamento strutturato risale al
regno di Claudio, ma questa fase iniziale, caratterizzata da costruzioni in
legno, è conosciuta solo in modo puntiforme. I più antichi materiali resti-
tuiti dalla villa di Reinheim appartengono a questo stesso periodo.
Una prima fase di sviluppo, in materiale durevole, corrisponde all’età
traianea, quando furono costruite le terme (nella loro prima versione) e i
due quartieri artigianali e residenziali. L’apogeo dell’insediamento, ed
anche della villa la cui relazione con il vicus è certa ma non in termini di
acclarata dipendenza o priorità, corrisponde all’età severiana, senza che si
colgano rotture con la fase precedente. In questo periodo, l’ampliamento
delle terme pubbliche, la costruzione di un ninfeo monumentale nel cen-
tro dello spazio pubblico, di fronte e in asse con quelle e di un grande
edificio a pianta basilicale sul lato nord della piazza segnalano
un’accelerazione della monumentalizzazione pubblica. Nelle abitazioni
private, la costruzione di ambienti sotterranei di stoccaggio e/o soggiorno,
di piani superiori e di ambienti riscaldati indica che non si trattò sola-
74 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
mente di fenomeni di evergetismo, imperiale o privato, o di interventi
pubblici della comunità locale ma che effettivamente la qualità di vita
degli abitanti del vicus era notevolmente migliorata. La crisi, documenta-
ta da livelli di distruzione e temporaneo abbandono, si manifesta fra la
metà e la seconda metà del III sec. con due differenti episodi di distru-
zione, uno collocabile al 260 e l’altro al 276 d.C., come si evince tanto
dai dati archeologici quanto dal quadro dei rinvenimenti numismatici (Pe-
tit 2011, 195); alla fine del III secolo la villa viene quasi completamente
abbandonata e l’insediamento evolve in modo differenziato, con
l’abbandono di alcuni quartieri ormai in rovina e la trasformazione di al-
tri, che sono abitati fino agli anni 430–440 d.C.
IL CENTRO PUBBLICO NELL’ETA DEI SEVERI
Fin dalla fase di età claudia, un asse viario principale, con andamento
Nord-Sud, struttura l’insediamento su una lunghezza di circa 800 m ; di
qua e di là da esso si articolano due quartieri a vocazione artigianale e
commerciale (quartiere est e quartiere ovest), costituiti da costruzioni
rettangolari che affacciano sulla strada con il lato corto. Queste cos-
truzioni associano, in un’unica entità edilizia, spazi artigianali, commer-
ciali e residenziali e si prolungano posteriormente in corti, che danno adi-
to a strutture annesse, pozzi, magazzini e depositi.
Quello che riteniamo essere il centro dell’insediamento, pur senza
averne la certezza (le prospezioni geofisiche rilevano costruzioni allineate
di qua e di là della strada ancora per seicento metri verso sud, senza altri
spazi vuoti) è caratterizzato da un amplissimo spazio aperto rettangolare,
delimitato da edifici su tre lati e dalla strada sul quarto (m 110 x 90): nel
III sec. d.C., esso occupa, con gli edifici pubblici che vi si affacciano,
circa un ettaro.
Su di esso affacciano anzitutto le terme pubbliche, di carattere monu-
mentale, fiancheggiate da un asse di circolazione parallelo alla strada
principale, integrate in un complesso che comprende anche due ali di bot-
teghe, con fronte porticato che si allunga verso nord e verso sud;
l’insieme costituiva dunque una facciata architettonica unitaria.
Le terme (Petit 2000) furono costruite alla fine del I sec. d.C., su pre-
cedenti strutture in terra e legno pertinenti alla prima fase del villaggio.
Esse erano costituite nella loro prima fase dalla sequenza balneare tradi-
zionale di frigidarium, tepidarium e calidarium, questi due ultimi riscal-
dati tramite ipocausti; un allineamento di 7 botteghe di uguali dimensioni,
LA GALLIA MOSELLANA NELL’ETÀ DEI SEVERI 75
porticate, si prolungava verso sud e verso nord formando così un lungo
fronte di portici. Dietro alle botteghe settentrionali l’ampio cortile (m 20
x 20) della palestra racchiudeva al centro una piscina. Nel corso del II
sec. d.C. furono fatte migliorie marginali, come la costruzione di nuove
latrine. Alla fine del secolo ebbe luogo invece un’importante trasforma-
zione generale, con moltiplicazione delle stanze riscaldate e degli spazi
conviviali, commerciali e di accoglienza: l’ingresso fu completamente
ristrutturato con la costruzione di una grande sala rettangolare, che prece-
deva la sequenza delle sale balneari; il calidarium fu ricostruito amplian-
dolo. Nella palestra, la piscina fu chiusa e riempita; nella grande corte
così ottenuta fu costruita un’edicola o fontana, verso sud, poi sostituita da
un’altra grande stanza riscaldata. L’ala sud delle boutiques fu ricostruita.
Alla metà del III sec. d.C. la fronte delle terme appare ulteriormente
avanzata verso la piazza con la costruzione di due ulteriori grandi sale
riscaldate ad ipocausto; l’accesso all’edificio non è più monumentale, da
questa parte, verso la piazza, ma probabilmente laterale. Il portico di fac-
ciata dell’ala nord delle botteghe viene trasformato in galleria coperta,
chiudendo parzialmente gli spazi fra i pilastri; l’ultima delle botteghe ri-
ceve un impianto di riscaldamento a ipocausto e la prima, la più vicina al
nucleo del complesso termale, ingloba anche il portico e diventa una
grande sala anch’essa riscaldata. Le modifiche avvenute in età severiana,
dunque, fra la fine del II e la prima metà del III sec. d.C., soprattutto la
moltiplicazione delle stanze riscaldate che tuttavia non hanno funzione
balneare, sembrano corrispondere ad un cambiamento progressivo della
natura del complesso, orientato sempre più ad essere un luogo di conven-
tus e di otium, di discussione, di riposo e di gioco.
Nella seconda metà del III secolo, le terme furono oggetto di incendi e
distruzioni; fra la fine del III e gli inizi del IV secolo, abbandonata la loro
funzione originaria, furono utilizzate come abitazioni e ateliers di bron-
zisti fino alla metà del IV sec. d.C. e poi furono frequentate episodica-
mente fino alla fine di quel secolo. I ruderi, che dovevano essere impo-
nenti, furono poi riutilizzati da una casa forte nel XV–XVI sec.
Le terme costituivano dunque, soprattutto nel II e III sec. d.C., una
facciata urbana unitaria che si apriva su una piazza in cui le prospezioni
aeree e geofisiche, ed ora gli scavi, hanno individuato altre costruzioni
pubbliche. Nella prima fase dell’insediamento, questo era un amplissimo
spazio aperto, in terra battuta o solo parzialmente lastricato, compreso fra
l’asse viario generatore dell’insediamento e l’altra strada, ad essa paralle-
la e più prossima al corso del fiume Blies, lungo cui sorgeranno le terme.
76 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Questa strada gira attorno ad esse, puntando verso ovest e verso il fiume.
Al di là di essa, le prospezioni geofisiche indicano la presenza di alcuni
grandi recinti quadrati che suggeriscono edifici: l’ipotesi era che si tra-
tasse dell’area santuariale, uno spazio religioso che non poteva certo
mancare nell’insediamento, ma gli scavi del 2012 non hanno confermato
questa ipotesi, mettendo in luce un’altro quartiere residenziale. In età
traianea, quando vengono costruite le terme nella loro prima fase, una
serie di percorsi impietrati attraversano e perimetrano la piazza: oltre a
quella via già citata che costeggia le terme, altri due viottoli accura-
tamente pavimentati in pietre partono dall’ingresso del complesso termale
con andamento obliquo divergente, verso sud-est e verso nord-est. Al
centro della piazza, in uno spazio lastricato, fu costruita una vasca rettan-
golare, poi racchiusa in un’ edicola rettangolare nel secondo terzo del II
sec. d.C. Fra la fine del II e gli inizi del III sec. d.C. vasca ed edicola fu-
rono compresi al centro di un monumentale ninfeo in forma di emiciclo,
di 12 m di diametro, certamente collegato all’acquedotto che alimentava
anche le terme, captando l’acqua dalle colline orientali, ma che non è sta-
to ancora rintracciato. Di questa monumentalizzazione severiana e del suo
significato ideologico parla in questa stessa sede, più specificamente, Al-
ice Dazzi. Il ninfeo fu abbandonato poco dopo la metà del III sec. d.C. e
progressivamente spogliato degli elementi lapidei maggiori; i suoi muri
furono rasati e tutto il materiale recuperato. Secolari, intensi lavori agri-
coli di quest’area, occupata da orti fino a qualche decennio fa, hanno as-
portato gli strati relativi alla tarda antichità.
Un’altra ala di botteghe allineate con portico frontale chiudeva verso
sud la piazza, agli inizi del II sec. d.C.; gli scavi hanno evidenziato che vi
avevano sede anche attività artigianali produttive, anche se non si è com-
preso il ciclo di lavorazione a cui appartenevano i resti rimessi in luce.
L’ala di botteghe si concludeva, verso la strada, con un’ultima bottega
che, alla fine del II sec. d.C. e agli inizi del III sec. d.C. fu ristrutturata,
dotandola di un vano interrato (cave) di stoccaggio, come accade nello
stesso periodo in numerose altre case dell’insediamento. La bottega con il
suo vano interrato furono utilizzate fino alla fine del III sec.; in seguito,
rasati i muri, la cave fu riempita da un potente riporto, ricco di monete di
IV secolo soprattutto negli strati superiori, poi sistemato per
un’occupazione. Anche qui, tuttavia, gli strati superiori sono stati asporta-
ti dai secolari lavori agricoli.
Verso nord, in un primo tempo, la piazza si estendeva assai di più, fi-
no ad un edificio rettangolare con portico, che presenta un’ interessante
LA GALLIA MOSELLANA NELL’ETÀ DEI SEVERI 77
planimetria: è composto infatti da due grandi sale identiche (m 15 x 7,50)
e due più piccole, simmetricamente disposte. Il modulo della pro-
gettazione corrisponde a 50 piedi romani (pes monetalis). Si trattava cer-
tamente di un edificio pubblico, ma di funzione per ora ignota, costruito
alla fine del I sec. d.C. o agli inizi del II e rimasto in uso fino alla fine di
quel secolo, quando fu intenzionalmente rasato per prolungare le ultime
due parcelle del quartiere ovest. Nello stesso momento, agli inizi dell’età
severiana, parte della piazza da questo lato nord fu occupata dalla cos-
truzione di un grande edificio a pianta basilicale, di 31 x 15,50 m, dunque
dalle armoniose proporzioni e impostato sul modulo metrologico del
piede romano. Dotato di uno spazio coperto, forse un portico verso la
strada, l’edificio, rimesso in luce dagli scavi 2009–2011, presenta fonda-
zioni e basamento (conservato per un’altezza massima di m 0,70) in accu-
rata tecnica edilizia a piccoli conci lapidei rettangolari (petit appareil),
allineati in filari regolari di opus vittatum, ben legati da malta bianca te-
nace. Si tratta del tipo di muratura utilizzata in tutto l’insediamento per
gli edifici di migliore qualità. Lo spessore dei muri è di 2 piedi romani (m
0,60). La copertura in laterizi (tegulae ed embrices), era sorretta da 8 co-
lonne, probabilmente anch’esse in legno, poggianti su imponenti ba-
samenti monolitici in gres profondamente calati nel riporto di livellamen-
to interno, reso necessario dalla pendenza del terreno da est a ovest, verso
la Blies. Questo riporto era costituito fra l’altro di materiali provenienti
dalla distruzione di impianti ad ipocausto e volte, con molta probabilità
delle vicine terme, il cui calidarium fu rifatto interamente alla fine del II
sec. d.C.
L’edificio presentava dunque un impianto di tipo basilicale, a tre na-
vate, di cui quella centrale larga m 8,50 e quelle laterali m 2,80–2,85, con
un rapporto di 1 a 3: ancora una volta proporzioni e moduli appartengono
chiaramente alla cultura edilizia romana. La distanza fra un sostegno e
l’altro, nel senso della lunghezza, era di circa 8 metri, troppo ampia per
poter sostenere i muri della parte superiore della navata centrale; la coper-
tura doveva, pertanto essere semplicemente a due falde. L’apertura di
accesso, che doveva essere larga circa 2 m, era al centro del lato corto che
affacciava sulla strada principale. Un eventuale altro ingresso, sul lato
lungo verso la piazza, non è dimostrabile in quanto i muri sono conservati
in fondazione contro terra per un’altezza inferiore al livello a cui si
sarebbe dovuta trovare l’eventuale soglia. La pavimentazione interna
doveva essere un assito legno che poteva essere poggiato sulla risega di
fondazione interna che le pareti conservano.
78 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
L’ angolo interno orientale dell’edificio, in facciata, fu sede fin dal
principio di attività artigianali o commerciali, costituite da installazioni
complesse (in legno e in argilla) che, in breve tempo, richiesero di cir-
coscrivere questo spazio con muri in pietra, trasformandolo in un am-
biente quadrangolare, quasi al centro del quale era rimasto comunque il
pilastro di sostegno del tetto, in linea con gli altri del corpo della basilica.
L’ambiente era suddiviso in due parti da un tramezzo ligneo, di cui resta
l’incasso orizzontale: una parte più ristretta, a est, ed una più ampia a
ovest, dotata di un focolare realizzato in tegole. Nel corso dei cinquanta o
sessant’anni in cui questo ambiente fu utilizzato, il focolare fu rifatto,
spostandolo, almeno tre volte, in occasione di rifacimenti del suolo di
calpestio. Non si è individuato l’accesso alla stanza. Non sono stati tro-
vati elementi per definire l’attività che vi aveva luogo: una fossa di scari-
co di cenere, carboni e terra conteneva qualche piccolo scarto di bronzo.
Da strati differenti, ma pertinenti alla stessa fase di vita, provengono 16
sfere di ferro di 2–4 cm di diametro ed una di piombo, di tre differenti
dimensioni e con valori ponderali in progressione, dai 41,62 grammi ai
147,31, interpretabili come pesi per bilancia da posare su un piatto con-
cavo, come rappresentato in alcuni noti rilievi romani. Il pochissimo ma-
teriale ceramico è tutto databile entro il III secolo,2 così come l’unica
moneta .
L’edificio nel suo complesso sembra essere stato distrutto, probabil-
mente da un incendio, intorno al 260 d.C. come si ritiene per gran parte
degli edifici dell’insediamento rimessi in luce. Seguì una fase di recupero
dei materiali (fra cui l’assito ligneo del pavimento) e di avvio del ripristi-
no, ma il cantiere fu interrotto da una nuova, e definitiva, devastazione,
probabilmente nel 276 d.C. Dopo questa data, non ci sono tracce di ulte-
riori occupazioni ma solo di recupero di parte dei materiali crollati.
La funzione originariamente prevista per questo edificio, certamente
pubblico date le dimensioni imponenti e la localizzazione su uno spazio
pubblico, non è chiara: non sono stati trovati elementi atti a definire con
certezza le attività che si svolgevano al suo interno. Non sembra trattarsi
2 Ceramica “engobé” a pasta bianca, terra nigra, sigillate e ceramiche tipo Ei-
fel che compongono il tipico “orizzonte Niederbieber”, dal castellum omonimo
nella Renania-Palatinato, considerato come esempio delle distruzioni barbariche
del 250–260. Vd da ultimo, con le recenti revisioni cronologiche: Heising 2010.
LA GALLIA MOSELLANA NELL’ETÀ DEI SEVERI 79
di un horreum,3 perchè mancano i caratteristici contrafforti delle pareti
perimetrali, necessari a reggere il peso di un piano superiore di stoc-
caggio, e le pareti da sole, con uno spessore di soli due piedi, non sareb-
bero state sufficientemente robuste. Invece, l’accesso unico dalla strada,
stretto e controllabile, sarebbe appropriato a questa funzione, così come il
portico di facciata (sempre sulla strada), lastricato, che fu aggiunto forse
in un secondo tempo ma sempre nel corso della prima metà del III secolo
e che avrebbe consentito di scaricare i carri al coperto. Il pavimento in
legno, certamente sollevato rispetto al piano di costruzione come indica la
risega di appoggio, è altresì un elemento a favore di questa ipotesi. Pla-
nimetrie molto simili, anche se con dimensioni più ridotte, sono note: per
esempio, un ampio horreum pertinente ad una villa rustica, nel suburbio
settentrionale della città cisalpina di Parma, presenta una pianta davvero
molto simile, compreso l’ambiente quadrangolare su uno dei lati corti, ma
è dotato dei tipici contrafforti.4
Circa l’ipotesi che questo edificio fosse stato un magazzino pubblico,
non risultano casi di vici con presenza attestata di magistrati o funzionari
pubblici preposti alla raccolta e stoccaggio di merci destinate all’esercito
o all’uso della comunità in horrea publica dell’insediamento stesso.
Data la posizione sulla piazza centrale, sembra in effetti più appropria-
ta l’interpretazione come basilica forensis, nel senso di un edificio dove
si svolgevano attività diverse, dalle riunioni politiche comunitarie
all’esercizio della giustizia e del commercio, ma l’apparato decorativo,
tipico di una basilica ed indispensabilmente legato alla sua dignitas, sem-
bra piuttosto modesto. Inoltre, l’unico accesso documentato è piuttosto
stretto e collocato in modo inusuale sul lato corto verso la strada anziché
sul lato lungo verso la piazza. La presenza di attività artigiana-
3 A differenza dei magazzini agricoli e di quelli militari, gli horrea publica
non sono stati oggetto di studi sistematici dopo l’opera ancora fondamentale
Rickman 1971, che tuttavia non prende in considerazione gli insediamenti mino-
ri. Le due tipologie fondamentali individuate dall’A. sono il tipo a corridoio e
quello a corte centrale. Per una revisione generale sull’argomento vd. Dominguez
2009. 4 Edificio fra via Europa e via Milano. Presenta al suo interno una doppia fila
di 8 pilastri quadrati e un ambiente quadrato nell’angolo; l’ingresso è tuttavia al
centro del lato lungo e le pareti hanno contrafforti verso l’esterno, in corrispon-
denza con i pilastri interni. Catarsi Dall’Aglio 1998.
80 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
li/commerciali è congrua con la funzione basilicale: sono noti numerosi
casi di botteghe che costituivano un intero lato di questo tipo di edifici
(Gros 1994; Cavalieri 2002). Che negli insediamenti minori, oltre che una
popolazione talvolta demicamente consistente, fossero presenti anche dei
magistrati (magistri vici) preposti alla gestione amministrativa della “pic-
cola città” (per esempio la cura degli incendi e la supervisione dei colle-
gia locali) sia giudiziaria, relativamente a cause di entità minore (sono
note vici sententiae in area sabellica dall’età repubblicana), sia soprattutto
religiosa ed onoraria, non è più messo in discussione.5
Basiliche in insediamenti di tipo vicano sono note, in alcuni casi, tutti
concentrati nella Gallia Narbonnensis, ma spesso non sono ben documen-
tate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature ed attività interne, o
il loro inserimento urbanistico non è chiaro. Tale è il caso della grandiosa
basilica del vicus Lausonnae6 (Vidy, presso Losanna), nel paese degli
Helvetii, il cui lato lungo verso la piazza era interamente formato da bot-
teghe di uguale dimensione, aperte verso un portico. Al suo interno, una
sola fila di pilastri suddivideva lo spazio in due navate, lasciando un’ area
libera verso nord per un possibile tribunal, separata da tre pilastri in se-
quenza ortogonale rispetto all’asse più lungo dell’edificio. L’accesso era
al centro del lato lungo, fra le botteghe. Un altro vicus, quello di Boutae
(Annecy- le- Vieux), nel paese degli Allobrogi, dipendente dalla città di
Vienne, di fondazione augustea, nonostante le modeste dimensioni (25
ha. in tutto), oltre a presentare un ben organizzato piano urbanistico sud-
diviso in insulae regolari e uno spazio centrale altrettanto regolare, fu
dotato anche di una basilica di 46 x 22 m datata alla seconda metà del II
secolo d.C. e menzionata anche da un’iscrizione (CIL XII 2533) come
[basi]lica cum p[orticibus ].7 Essa affacciava sulla piazza con il suo lato
lungo, mentre il lato opposto all’ingresso era articolato in tre absidi, due
semicircolari ed una rettangolare; lo spazio interno era suddiviso in tre
navate da colonne che scandivano un corridoio perimetrale rispetto
5 Sul tema, vd. Tarpin 2002, p. 273 passim.
6 Per le misure, che sono differentemente indicate da diversi autori, vd. Cava-
lieri 2002, p. 72, n. 16. 7 La basilica sarebbe stata dedicata da tal Sex. Caprilius Attcianus a numini-
bus Augustorum, probabilmente Marco Aurelio e Lucio Vero. Broise 1968, p. 41.
LA GALLIA MOSELLANA NELL’ETÀ DEI SEVERI 81
all’aula centrale, secondo una planimetria che appare in assoluto la più
diffusa.
MIGLIORIE NEI QUARTIERI OVEST ED EST
Di qua e di là dell’asse viario NS, che struttura l’insediamento, le abita-
zioni/botteghe che ne costituiscono la caratteristica si dispongono con
regolarità, senza che tuttavia si possa riconoscere un piano urbanistico
realmente ortogonale. Le case, del tipo rettangolare allungato (Strei-
fenhäuser) si affacciano su di essa con il lato corto.
Il quartiere ovest, di cui è stata messa in luce e musealizzata una se-
quenza continua di 14 unità abitative (Petit, Brunella 2005), presenta una
prima fase costruttiva intorno agli anni 40–50 d.C., con edifici con strut-
tura in legno e alzato in torchis, ricoperti di intonaci dipinti e tetto in te-
gole laterizie, divisi fra loro da qualche ambitus (largh. 0,80 m). La sem-
plice struttura iniziale, che vede spazi artigianali sul fronte porticato e
focolare nella stanza centrale, si complica progressivamente nel tempo,
nel corso del II sec. sec. d.C. con la ricostruzione programmata e realizza-
ta in modo unitario di gruppi di edifici (le parcelle 2–6, della stessa
lunghezza di 17 m e di larghezza compresa fra 8 e 10 m) in materiale la-
pideo, almeno per il piano terreno. La parte anteriore delle case viene
articolata in botteghe, aperte su un portico di facciata continuo che affian-
ca la strada e gli spazi abitativi si espandono progressivamente verso il
cortile retrostante, fino a trasformarlo in una corte coperta, compresa fra
due blocchi costruiti, uno anteriore, con la bottega, ed uno posteriore, con
vani di servizio dietro i quali si apre l’hortus, talvolta dotato di pozzo-
rifiutaia. Le attività produttive e/o commerciali che vi si svolgevano sono
svariate, dalla lavorazione del bronzo, dell’osso, del ferro, alla pro-
duzione ceramica e alimentare (pane, birra, cauponae).
La struttura e articolazione del quartiere est ed il suo sviluppo nel
tempo sono analoghe a quelle del quartiere ovest e ancor più accentuata è
la sua vocazione artigianale, soprattutto di ambito alimentare, come indi-
cano molti forni, focolari e strutture di combustione. Questo quartiere nel
III sec. d.C. appare composto da otto parcelle molto allungate, perpendi-
colari alla strada, separate da stretti ambitus o direttamente contigue. La
presenza di un portico di facciata è certa solo nella parcella 1 e in quelle
successive a questa verso sud. La parcella 5 si differenzia dalle altre per i
suoi caratteri edilizi particolari e per il materiale che ne proviene, fra cui
82 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
aste di stendardi, strumenti musicali, finimenti di cavalcature e servizi
ceramici per bere di insolita ricchezza (Petit 2010).
A Bliesbruck la fioritura economica nel corso del II sec. e del primo
terzo del III sec. d.C. è testimoniata anche, sul piano numismatico, da una
considerevole presenza di denari d’argento rinvenuti nel corso degli scavi
(Gricourt 2009, 748 e 778), benché le monete appartenenti a questo pe-
riodo siano complessivamente in quantità minore rispetto al lungo perio-
do di crescita regolare che arriva fino al regno di Commodo: ciò dipende
anche dal fatto che continuano a circolare i bronzi antoniniani, la cui
enorme quantità emessa era sufficiente al commercio minuto.8
Questa fioritura economica corrisponde, sul piano edilizio, all’ esten-
sione dello spazio dedicato, nelle case, alle attività economiche con il
raddoppio del portico di facciata e allo spostamento delle funzioni resi-
denziali al piano superiore, nel quartiere ovest. L’eccellente livello abita-
tivo di questa fase è indicato anche dalla presenza quasi costante, al piano
terra, di ambienti riscaldati e decorati da intonaci dipinti secondo il gusto
delle province centro-europee, destinati probabilmente a molteplici
funzioni, da quelle di soggiorno a quelle di piccoli bagni privati. Quasi
tutte le case sono dotate di un ambiente sotterraneo (cave), connesso al
pianterreno tramite una scala in pietra ampia e ben costruita. La funzione
di questi ambienti sotterranei, che costituiscono un fenomeno diffuso nel-
la Gallia settentrionale così come in Germania e in Britannia fra II e pri-
ma metà del III sec. d.C., resta piuttosto incerta, a causa della cura con
cui sono stati realizzati, probabilmente eccessiva per dei vani di semplice
stoccaggio domestico. Questi ambienti sotterranei sono infatti accura-
tamente realizzati in blocchetti di calcare montati con la tecnica del petit
appareil, i cui giunti in malta presentano stilature dipinte in rosso; sono
dotati di nicchie voltate, intonacate e dipinte e prese d’aria a bocca di lu-
po accuratamente realizzate. La presenza, in alcuni di esse, di imponenti
tavole rotonde in pietra, dipinte (in rosso, in bianco), rappresentate anche
su alcune stele ha fatto ipotizzare un uso recettivo e religioso, anche se
quest’ultimo è difficile da dimostrare sulla base dei materiali raccolti,
poche statuette isolate, relative a culti domestici, generalmente trovate nei
riempimenti di queste cantine successivi al 276 d.C. (Santoro, Mastrobat-
8 Per una visione cartografica della distribuzione delle monete dal 193 al 260
d.C. vd. Petit 2011, fig. 3, p. 186.
LA GALLIA MOSELLANA NELL’ETÀ DEI SEVERI 83
tista, Petit 2011, 193–199). Non mancano tuttavia confronti in tal senso:
ad Alesia, per esempio, in una di queste cantine c’è una raffigurazione
dipinta di una mater, a Entrains una statuetta con offerte era collocata in
una nicchia, altrettanto a Châtelet (Haute-Marne), e a Montbouy (Loiret).
Il confronto più stringente è con lo straordinario ambiente sotterraneo
della sede di una sconosciuta ma ricchissima corporazione, nel vicus di
Schwarzenacker, posto a una 30 di km da Bliesbruck verso N, ambiente
le cui funzioni anche religiose sono testimoniate dalla presenza di un lara-
rio con un complesso di statuette in bronzo di eccellente fattura.
In quel vicus assistiamo anche allo stesso fenomeno di sostanzioso
miglioramento della qualità delle abitazioni private, nello stesso periodo
severiano. Entrambi i vici sono caratterizzati dalla presenza di queste sedi
di corporazioni: a Bliesbruck, oltre alla possibile funzione in tal senso
dell’edificio a pianta basilicale, anche la parcella 5 del quartiere est sem-
bra aver svolto questa funzione, sulla base dei materiali qui rinvenuti.
Questo fenomeno della fioritura delle corporazioni è particolarmente evi-
dente per l’età severiana in tutta la Gallia.
In tutto il vicus di Bliesbruck in età severiana la struttura viaria princi-
pale subisce una modificazione importante: il portico continuo sulla stra-
da viene trasformato in galleria, con l’aggiunta di piccoli ambienti fra i
pilastri, aumentando così lo spazio destinato ad attività commerciali ma
salvaguardando la continuità dei percorsi. Un fenomeno analogo è noto
anche a Schwarzenacker e ad Alesia, dove i portici sono raddoppiati da
una seconda fila di pilastri o colonne. Sembra dunque che almeno nel
primo trentennio del III sec. d.C. in questi vici a forte vocazione commer-
ciale e produttiva lo spazio destinato a queste attività sia potenziato al
massimo.
CONCLUSIONI
Altri vici della regione, sebbene siano noti solo per qualche costruzione,
manifestano il loro massimo sviluppo in termini di confort abitativo e di
infrastrutture nell’età severiana. Tale è il caso, per esempio, di Entrains
(département de la Nièvre) nel territorio degli Edui, che con i suoi 120
ettari di estensione è uno dei più vasti insediamenti minori della Gallia
Belgica, insieme ad Alesia, Mâlain e Mandeure, ed è dotato anche di un
teatro, noto tuttavia solo dalle foto aeree (Petit, Mangin 2002, 103), o
ancora Baâlon, ai confini fra la civitas Mediomatricorum e la civitas Tre-
virorum. Anche i siti rurali in vario modo connessi ai vici risentono di
84 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
questo sviluppo severiano: tale è il caso di quelli noti prevalentemente da
raccolte di superficie nei dintorni di Bliesbruck, oltre 150 fra ville e fatto-
rie, che presentano un’occupazione prevalentemente nei secoli II e III
(Göring 2000). Tre di queste sono state scavate integralmente (Erfweiler-
Ehlingen, Sarreinsming-Grosswald et Sarreinsming-Heidenkopf) e pre-
sentano il loro apogeo nella prima metà del III sec. d.C.
Dunque, in epoca severiana, gli abitanti del vicus di Bliesbruck, così
come quelli di Swarzenacker e di alcuni altri (non tutti) della regione,
beneficiavano di un reale confort urbano, sia nelle proprie residenze pri-
vate che nella dotazione monumentale dell’insediamento, corrispondente
ad un ruolo sempre maggiore delle attività economiche a cui questi vici
erano vocati. Questo incremento economico si traduce nell’aumento degli
spazi e delle attrezzature ad esse dedicati, ma anche nella volontà di ren-
dere visibilmente presente la potenza di Roma attraverso gli agi della vita
che essa garantiva, primo fra tutti il controllo e la disponibilità dell’acqua
e del calore, anche in questi insediamenti, certo secondari sul piano giuri-
dico e demografico rispetto ai capoluoghi di città, ma fondamentali
nell’articolazione economica e politica dell’ impero.
Poiché l’archeologia è una disciplina storica, e come tale non può sot-
trarsi al dovere di interpretare i suoi dati storicamente, riteniamo che
questa fioritura economica, tanto delle città quanto dei centri minori delle
civitates dei Mediomatrici e dei Treviri, sia derivata dal rafforzamento
della presenza militare nell’area renana, ma anche dall’essere stata la re-
gione sostanzialmente indenne dalle turbolenze dell’ultima parte dell’età
antonina, riuscendo così a salvaguardare ed anzi a portare a compiuta
maturazione il proprio sistema economico e politico, concepito con lun-
gimiranza e caratterizzato da un eccellente equilibrio distributivo tanto
del popolamento quanto della rete di rapporti istituzionali e produttivi.
* I paragrafi 1,2,4 sono di S. Santoro, 3 e 5 di J.P. Petit, le conclusioni
sono ovviamente comuni.
BIBLIOGRAFIA
Bedon R., Atlas des villes, bourgs et villages de France au passé romain
(2001)
Bénard J., Mangin M., Goguey R., Roussel L. (eds.), Les agglomérations
antiques de Côte-d’Or, Annales Litteraires de l’Université de Besan-
çon, 552, série archéologique 39 (1994).
LA GALLIA MOSELLANA NELL’ETÀ DEI SEVERI 85
Broise P., Découverte d’un edifice public sur le site gallo-romain de Bou-
tae (Les-Fins-d’Annecy), Latomus 27 (1968), 33–44.
Broise P., L’urbanisme vicinal aux confins de la Viennoise et de la Sé-
quanaise, in « ANRW » II, 5.2 (1975), 603–629.
Burnand Y., Les Temps Anciens. 2. De César à Clovis, (Encyclopédie
Illustrée de la Lorraine. Histoire de la Lorraine) (1990).
Catarsi Dall’Aglio M., Parma. Via Europa-via Milano, casa protetta per
anziani del Comune, “Archeologia dell’Emilia Romagna”, II/2 (1998),
60–61.
Cavalieri M., Auctoritas aedifiorum. Sperimentazioni urbanistiche nei
complessi forum-basilica delle Tres Galliae et narbonnensis durante i
primi tre secoli dell’Impero (2002). Dominiguez J. S., La investigaciòn sobre los horrea de època romana:
balance historiogràfico y perspectivas de futuro, CuadPrehistA 34
(2008), 2009, 105–124.
Ferdière A., Les Gaules (Provinces des Gaules et Germanies, Provinces
Alpines), IIe s. av J.-C./Ve s. apr. J.-C (2005).
Ferdière A., Gandini C., Nouvel P., Collart J.-L., Les grades villae « à
pavillon latéraux multiples alignés » dans les provinces des Gaules et
des Germanies : répartition, origine et fonctions, RAE 59.2 (2010),
357–446.
Göring R., L’environnement rural de l’agglomération secondaire de
Bliesbruck à l’époque gallo-romaine (2000), 295–322.
Grenier A., Habitations gauloises et villas latines dans la cite des Mé-
diomatrices (1906).
Gricourt D., Naumann J., Schaub J., Le mobilier numismatique de
l’agglomérationsecondaire de Bliesbruck (Moselle). Fouilles 1978–
1998 (2009).
Gros P., s.v. Basilica, E.A.A. I, suppl 1971–1994, 612–616.
Hatt J.-J., Histoire de la Gaule romaine (120 av. J.-C.–451 apr. J.-C.)
(1959/1970).
Heinen H., Trier und das Trevererland in römischer Zeit (1985).
Heising A., Perspectiven der Limesforschungen am Beispiegl des Kastells
Niederbieber, in Henrich P. (ed.), Perspektiven der Limesforschung.5.
Kolloquium der Deutschen Limeskommission 19./20 Mai 2009 in
Römisch- Germanischen Museum der Stadt Köln (2010), 57–71.
Petit J.-P., Mangin, M. (eds.), Les agglomérations secondaires: la Gaule
Belgique, les Germanies et l’Occident romain, Actes du colloque de
Bliesbruck-Reinheim (1994).
86 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Petit J.-P., Mangin, M., Alesia, Bliesbruck et autres sites de l’Est de la
France. Refléxions sur l’architecture privée, artisanale et domestique
dans les « petites villes » de la Gaule Belgique et des Germanies, in
R. Gogräfe, K. Kell (eds.), Haus und Siedlung in des Römischen
Nordwestprovinzen, (2002), 81–131.
Petit J.-P., Le complexe des thermes de Bliesbruck (Moselle). Un quartier
public au coeur d’une agglomération secondaire de la Gaule Belgique
(2000).
Petit J.-P, Auberge ou lieu de réunion d’une association professionelle ou
religieuse : le bâtiment de la parcelle 5 du quartier Est de l’agglo-
mération secondaire de Bliesbruck, in C. Ebnöther, R. Schatzmann
(dir.), Festscrhift Stefanie Martin-Kilcher, Antiqua 47 (2010), 291–
323.
Petit J.-P., Le développement de l’agglomération secondaire de
Bliesbruck (Moselle, F.) au IIIe et au début du IVe siècle, in
R. Schatzmann, S. Martin-Kilcher (red.), L’Empire romain en muta-
tion. Répercussions sur les villes dans la deuxième moitié du IIIe
siècle, Actes du colloque de Berne/Augst 2009, Archéologie et His-
toire Romaine 20 (2011), 181–200.
Petit J-P., Brunella Ph., Bliesbruck-Reinheim. Celtes et Gallo-Romains en
Moselle et en Sarre, (2005).
Reinhardt W., Kelten, Römer und Germanen im Bliesgau, Europäischer
Kulturpark Bliesbruck-Reinheim (2010), 251–303.
Rickman G., Roman granaries and store buildings (1971).
Rorison M., Vici in Roman Gaul, BAR International Series 933 (2001).
Santoro S, Mastrobattista E, Petit J.-P., I sacra privata degli artigiani e dei
commercianti: qualche riflessione su due vici della Gallia Belgica a
partire dall’evidenza pompeiana, in M. Bassani, F. Ghedini ( eds.),
Religionem significare. Atti dell’incontro di studi (Padova 8–9 giugno
2009) (2011), 181–204.
Sărăţeanu-Müller F., Les grandes villas de notables en Gaule: l’exemple
de Reinheim, in J.P. Petit, S. Santoro, Vivre en Europe romaine. De
Pompéi à Bliesbruck-Reinheim, (2007), 201–207.
Sărăţeanu-Müller F., The roman villa complex of Reinheim, Germany, in
Villa Landscape in the Roman North, Actes du Colloque de Vaals
(Pays-Bas), 30 oct.–1 nov. 2008 (in press).
M. Tarpin, Vici et pagi dans l’Occident romain, Coll. EFR 299 (2002).
LA GALLIA MOSELLANA NELL’ETÀ DEI SEVERI 87
ILLUSTRAZIONI
Fig.1: Localizzazione del vicus di Bliesbruck
88 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Fig. 2: il vicus di Bliesbruck (A), la villa di Reinheim (B),
strutture rurali e religiose sulla collina di Homerich (C),
santurario tardo La Tène (D), ricostruzione dei tumuli celtici (E)
LA GALLIA MOSELLANA NELL’ETÀ DEI SEVERI 89
Fig. 3: Bliesbruck:
pianta dell’area centrale e dei quartieri ovest ed est (2010)
90 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Fig. 4: ricostruzione ipotetica delle terme di Bliesbruck nel III sec.d.C.
LA GALLIA MOSELLANA NELL’ETÀ DEI SEVERI 91
Fig. 5: Bliesbruck, area centrale, il ninfeo ad emiciclo (2010)
92 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Fig. 6: Bliesbruck, area centrale, l’edificio a pianta basilicale (2010)
Fig. 7: Bliesbruck, area centrale, ala delle botteghe meridionali (2011)
LA GALLIA MOSELLANA NELL’ETÀ DEI SEVERI 93
Fig. 8: Schwarzenacker, planimetria generale (da Petit, Mangin 2002)



































![PRELOŽNIK A., GUŠTIN M.: Cinturoni da parata: esempi di contatti tra l’area veneta e la Dolenjska nell’età del ferro. - Archeologia Veneta 35, 2012 [2013], s./p. 118-127.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63161c373ed465f0570be358/preloznik-a-gustin-m-cinturoni-da-parata-esempi-di-contatti-tra-larea.jpg)