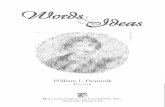Pellegrini, Senatori e Papi - gli xenodochia a Roma tra V e IX secolo, in RIASA S.III, XIX-XX ...
Transcript of Pellegrini, Senatori e Papi - gli xenodochia a Roma tra V e IX secolo, in RIASA S.III, XIX-XX ...
RICCARDO SANTANGELI YALENZANI
PELLEGRINI, SENATORI E PAPI.GLI XENODOCHIA A ROMATRA IL V E IL IX SECOLO
ESTRATTO DALLA
. Riùistú dell'Istítuto Nazionale d.'Archeologia e Storia deU'Arte,Serie III - Anno XIX XX t996 199?
ROMA - t998
INDICE GENERALE
C. MNcoNr, L'anioa di Apollo. S l frontone ctrientale del quinto tempic.t dí Apollo aDelfi
A. DE Fn-lPHS, Da lrpai a Cuma: ux itineraúo fra Sicilía, Eolie e Campania settentflt)
P'
21
6Ì
,, ltj
> 203
> 227
> 251
F.
F,
C,
Dr Capn*ns, P .lerarlb Isawicc, e *x nuouo mofiumekto
ZEvl, Cicerafie ad Ostìa. Costruttoli eccellenti pet le îftufi di Ostía
CAPrrNa, Plastica ma noreo dí uno stadio nella Villa Adriana a Tiuc.tli, con Appendicedi P. PENsABDN!, Molello templare ostíente in marmo lunense dal Collegio degli Aaga-
P. Lwr*,xr,Il monamento dntonino di Efeso
C ar ' rN , I tontli adrnn"i dell Aro dr (otaatìto
R. Sanr,qNcsr-r Var-erzrxr, Pellegtixi, senataú e papi. Gli xenodochia a Roma tra ilV e ilIX secoÌo
153
> 409
> 41)
M. D'ONoIRJo, fu rdrledtale di Gaeta
A. CAsroNNA, <Copr; grande di antíchi sepolú>. Sugli scaui delle necrctpc.tlí ix Italia merrtJionale tta Settecento e inizio Ottoce to
A. Mt ar-.c Il Mu,eo Reale di Napoli al renpo di C*,eppe Bonaparre e di Crcacchìno
D. DoMBRo'irsK, ,4ggrr nte all'attiL,ità di Andrea Bolgi
ATTn'rrA Dr rìrcERcA pRESso LìsT1rrjTo
P. F. Fur'nc,rru, la Genîza italiana: diecí anni d.i rícerche (1986.1996)
M. BoNFtoLr, Attiuià di ricerca di stotia dell'arte biTantina presso I'Istltuto .
M. DEILA VALLE, Colîî1îîittenz! artistica e ptuduzione di cod.icí al tempo di Anna Palealogina (1341-136t ca.) > 421
Gli xenodocbia a Roma tra ilPellegrini, senatori
e il IX secoloapr.
RICCARDO SANTANCET,I VALENZANI
Ail c.r me fos lai pelegris,Si qùe mos tuslz e nos tlpisr-os pels sieùs belhs huclhs remiraÉlBe.m parra jo-vs quan li queray,Per amor Dieu, l'albeit de lÒnh:E, ía liers platz, dlberguamì
Uru'ù RLDTL, lr,4,a, lí jaú to, kxc dt ndr)
1 Nell'anno 162, scrivendo ad Arsakios,gran sacerdote della Galazia, I'imperatore Giu-liano lamentava gli scarsi risultati ottenuti dallapropaganda religiosa pagana; <... perché dob'biamo credere che (rendere onore agli dei) sia
sufficiente, quando vediamo che è Ia loro (dei
cristiani) benevolenza verso gli stranieri, la lorocura per le tombe dei n,orti e la pretesa santitàdelle loro vite che ha dato tanto incremento al-l.uers-ror...'. De(iso a combdrlefe il cri\lianesimo sul suo stesso campo e con le sue stesse
armi. Iimperarore ordrrar: qu'rdr al .uo,o-ri-sponderte <.... in ogni città devi istituire nume'rosi Esr,oóorei( cosicché gli stranieri possanoprofittare della nostra qrl.ov0QorÍo ...> I. Tra leattività caritatevoli e le opere di pietà che aisuoi occhi, malevoli ma attenti, apparivano ca
ratteristiche dei cristiani, Giuliano poneva dun-.1ue rl o ino posro lasi.rcnu.r agli .tra rie-:. e.
in un quadro di dichiarata imitazione dellesrrurru-e as.i.renziaÌi della Chic-, I rri uzioneài xenoclachia per dare ospitalità agÌi stranrenirdrgeli gli zpparira come la rerlizz"uio re piirurgente. Questa importanza deÌla figura dellostraniero quale oggetto di carità e di assistenza
Jerivc c.ro dalla cert alira, nella merralira an
tica, del rapporto tra I'uomo e \a polis, che faapparire lo straniero come I'ematginato per ec-
cellenza, e quindi particolarmenre bisognoso diaiuto. A questo aspetto della figura dello stra-niero il Cristianesinlo ne aggiunse però un al
tro, desrinato a grande fortuna nei secoÌi a ve-
nire: non si viaggia pirì solo per commerciare oper incarichi di ser.rizio, ma per visitare le
204
lombe dei martiri e vedere i luoghi della vita
e de ; pa.siore di r ri.ro. O,oirr e e riutarcquesti vjaggiarori della fede diviene attivìtà ca
útativa tra le più importanti. La figura delpellesrino comincia quel suo viaggio nell'im-maeinario collettivo che la poterà, nel pieno
-"Jio.uo, " raffigurare, fin nelle metafore dei
poeti, l'uomo bisognoso di aiuto e di ospiialìtà
Dalla lettera di Giuliano appare evidente
come, almeno nella parte orientale dell'Lrpero,a cui si riferisce l'imperatore, le varie chiese do
vevano avet messo in piedi, già alla metà del tt'
secolo, una efficiente tete di enti assistenziaÌi
destinati all'accoglinenro dei viaggiatorì e degli
srr,n'eri. lrcl O..iderre la cre,r/ionc d qucsri
istituti sembra essere st:ìta meno precoce' e 1o
di-ro.rra a r.he il ldr.o che. qrando ,pp.r-iranno, essi saranno chiamati anche qui con Inome greco xenotlochta pi]ttosto che con l'e_
cuivalente latino ,óosprrar;, che si diffonde solo
ìn epoca assai avanzata. Questo non significa'
owìamette, che in Occidente I'assistenza agll
siranieri non venisse pralicata, ma probabil
mcnre e\.a erd ge,r r ahrin'en'i dar n"onasr" i
o tramire l'ospitalità e I'cvergetismo delle fami
slie cri'rian. dell ari'roc.azia A Rona n pani-
cola.., non abbiamo documentazione dell'esi
stenza di istituti specificatamente destinati al
l'assistenza agli stranieri e ai pellegrini sino alla
fine del w secolo. Nei secoli seguenti la docu
mentazione si fa relativamente più abbondante,
fino agli inizi del rx secolo, epoca alla quale risalgono le ultime attesrazioni di compiessi desi-
gnli .ol norre dr ^crodocla.e'interdorÈat'tiazione destinata all'ospitalità per gli stranren e
i pellegrini sembra subire un profondo cambia-
l) I!LjÀN., Ep'Jro1, XXll, ed. V. C \vRrcrn, Loeb Ckssical, London'New YoLk 1921
2) Susl\ xe"Òdo.Aid ia senetale O IÍLTBRUNNÈR, i' RE'
xvllÌ- Ì9Ò7 .oì1. l8i 110\ s\ 'ek.da.hlra. Hr ', L/ /. . \V, I d I'ì' \ fr XwT- ldi
,r ., B D lì -. .a,. ù Po . I
4,4C.4. l. 1866. DD. 17 5l,lAl.ri.o/ 1t\'t dht d i1! '
RraalFJ! tr\ r.\\tirll lnLL\_ZnNl i2l
mento con l'affermazione delÌe srlolac nazro
nali. (' opo J.l preserr. l.rvo o è qtrello d .n,'-lizzare la documentazione relativa agli xenodtt
cÀua a Roma tra la tarda antichità e I'altomedioevo, tentando di individuare le linee di svi-
luppo del fenomeno, l'organizzazione degli enti
e i ìoro rapporti con le altre strutture assrsten
zrz.li'.
2. C1i xenodochi. o complessi analoghi, at
testati a Roma dalle fonti sono una quindicinaIn qLresta prima parte dcl lavoro anaLizzercmo
la documentazione su ciascuno di essi, tcntandoJi g,trrgere. "\e uo''rb'. ,r Jclle cor,l't"rrsulla lolo localizu.zio^e ,opoo rr:, J 'r rl ro
rologia e .u e rnod lrr, d.ll .o o r'tirrr/ior'"
2.1. Xenoàochíun Pannachìi La prina at
testazione nella zona di Roma, e nell'intero Oc-
cidente, di un complesso delnito xenolochnun'
è contenuta in una lettera scrilla, verso 1à fìne
del 197, da s. Gerolamo al nobile senatore
Pammachio, quale consolazione pcr la mofledella moglie Paolina: <,Audío te xenoelochiunt
in porttt fecísse lomana et uirgtm de albarcAbrahatn ìn Attsonìa plantasse líttote>' La tra'dizionale identificazione di questo complesso
con un grande edificio a pianta basilicale messo
ìn luce nel secolo scorso nei pressi del porto diTraiano, proposta da G. B. de Rossi e per
lungo tempo mai rimessa in discussione', è
stata conftrtata da P. A. Février', e attuaÌmen
te non riscuote alcun credito'l Pasquale Testini
\a recentenente ipo'izzato ura locaìizz'zioncde1lo xenodochio nelf isola Sacta, in prossinità
e in connessione con il santuario di s lppolito "
D] 2At
anche se, in assenza di ogni riscontro archeologíco, cotvicne per ora lasciare aperta la que'stione. Dopo la menzione di s. Girolamo non àbbiamo più Dessuna notizia di questo complesso.
2.2. Xenodochiwn Anich;brz;z'. Questo xe-
roJocl- o e a re. aro drre rol.. dall. ionu: 'naprima volta in una epistola di Gregorio Magno,
ove vicne menzionato un diacono, di nome Flo-renlio, preposto ad esso', ed una seconda voltanel catalogo delle chiese e dei monasteri diRoma contenuto nella biografia di Leote III,ove e ciLaLo Jn ùrdrourm sdncrrc Lu.ie rr "cnodoch'o q.li d', i r - Arichiorum . Tl norrc in
dica chiaramente un rapporto tra qr.resto comp cs.o c ì oru nporanre a nig.'a de.l ali.ro-crazia senatoria del v e degli inizi del i,r secolo,quella dcgli Anici". La localizzazione di questo
xcnodochio è ovviamente collegata alÌ'identificazione dell'Oratorio di S. Lucia menzionato nelLiber Potti;ficalìs. Cìià llùlsen aveva propostodi identíficarlo con la posteriorc Chiesa di S.
Lucìa dc CaÌcarario " che sorgeva, fino alla suademoÌizione avvenuta alla fine degli anDi '30, su
via delle Boneghe Oscure. Questa ipotesi ha ri-\cruro uìd
"osrerz"le co'feln, dal rinr<ni
menro di una ìscrizione metrica greca venutaalla luce nel 1950 t piazza Paganica (IGUR,69), a brevissnna distanza quindi dal sito di S.
Lucia dc Calcarario- L iscrizione, edita da M.Guarducci '', è un'epigralè onoraria che accom
F(;. 1 Lùnione ICUR 69 di [d,na: xcrntla.ha'.
pagnava I'effige di un Fausto, designato conl'appellativo di !s(roóóro! (fig.1). PurtroppoI'interpretazione generale dell'eÌogio è tun attroche agevole. Esso è stato inleso come insegna diosteda ", come una sorta di <<guida topogralica>pcr giungere dal F'oro Olitotio alf ingresso delloxenodochio '', come iscrizione funeraria ", comeepigrafe onoraria legata a degli annunci dr vrttorie militari'" o comnìemorativà della cosrru-zione di un impianlo termale ''; a distanza diquasi trcnt'anni è ancora valido quello che diquesra iscrizione scriveva sulle IGUR Luigi Mo-retti: <quod camen significet, pos! tot doctrssr
8) QucrÒ t,ùrgd; Ìiprcndc paziJnenrc quaDto siàcspo*o in un precedente hrÒrc nnla zona del Cahriirio RSì\r^NcEU VrlnziNr, Tz 1, PÒúnu' ùtt"'.id e I CdhM.
I " - r.o I t'it.o \
,_l,V€1, XXl. 1991, pp 5l 98.'. ,p/. t;ò I | ... o ;u" -p., ol. ., . .{.i,
Àìàgno si ù f!ÌÌÒ ÌiÈriDcrr. rlÌcdizionc di P. EIV^LD L MHmN\NN, MCII. Ili,nrh$ 19781
t0) L Cr^cLo llf( ( r\,. \obtti x,u,. I totc,r ,tI4àJt 1:L.71.), in t\t.\\', Attt ld..nEt$ ù1. nzi.adtu dt ttudìnú.?/,,,. ÌìoD. 1981,pp.7l 96,^ \'l.Nucr-r,,!o. C1l,'lrrij ctì xaìÒc liú ktr0 ld t \t.olo tl C. \n Seca"la ú"rib,tatlla:torid LrÌi rtth.lis,t, Romr l9ó0, fp.2ll-2t1.
11) Crr. HtbL!, L. dta. .li P,a,u "cl
lt4 ùe),li
r2l Nl (;lrrróu.rr, /l r,,r/,,n dì B.ll.". t ilCrú Fk
,tiùÒ h M etctdn,,a grcn tlel bast ttup.t. in BC.LXXlll, r9t9 50, pp ttl6i EnD, L,tatnÒ .l ep4tutnnastto,lel ba::o Lrz*o corrrne"E il vntuúh 'li B.Io"d e ICntu lldrtnliÒ, i. RF,1, 82, 1951, pp. t$ t9i: Et,Ò, 1-cl)ì
srawta lyat ù fausto ,: h nuÒr. not.tt. ih C.mpa Mùaa,in RdlPú"tAt,12. t969 7A, pp 219 21)
ìll G!^ùu(r, Il '.tt'.ria cit. a nota 12.r,1l Gu^ronc.r, lntont all'.?tsùî"nr cìt. a noÌa 12i
LaD., L.?iEù|"îa greca cit. n nota 12.rt) J RoB.rr'L. RoùrRr, rcc.
^ Gr^n)t).:.1, tl sd"ttú1.
cii a nora 12, i. lÙ1C, LXVI, l9tl, p 208.16) S. M^zz^nNo, <A"i,"a" e eablid t,t.tttid" L'i-
It1. .1... It.t-.dlr.eì .tà a^h rúM,1, Bali 19?1, pp 228 250
17) G. lvl^NcANA(o, Dr. rór. tdtd.drtiLh., in ZPE,91,1992, pf. 281.29.1
206 kl!Lilllio \-N rN! tLl \.LENZ Nl
mos labores, incerfum manebÙ Non è certo
mia intenzione aggiungere a queste un altra, e
a,sai mcro .1o.rr rr za, inlcrp-el.l/ioì(i lurld\ ir'se si tiene conlo del fatto cbe Fausto è uno dei
nomi rrzdizonali di uno dei J'rir.'orli ranidelÌa gezs Anicia, e in realtà quasi esclusivo diquest; famisÌia'', sembra assai difficìle soste'
"-. l, *'..,rti.; del rinven'mcn o di una i'' rizione che onora un (Anicio) Faùsto, designato
con Ì'appellativo di xeinotlochos' nella stessd
,te, d"ue eir, pe alrrc s r"J. ndipendenri er'r
slato propost; di localizzare Io xenod,ocbiutn
Arnhioriu la coincidenza sarebbe quasl m
credibile. Si può quindi ritenere estremamen
re probabile, secondo I'ipotesi avanzata dalla
Guarducci, che la controversa eprgrate cr tra-
smetta la memoria del fondatore tleIlo xenolo',h.rt Ary bio"t 't. Qresto comple''o c"i'te I
ziale dovette sorgere all'interno dell'area de1
lalri.a lo"zrur t4i u'n, l:t cti collo.rziorenell,r zo.rJ tra via Jclle Bo eghc o'crre ' via
IV Novcmbre è stata accertata sulla base del
oo.iziona nenro di ur 'rarnenro del a fo' ni rh. seuer ar,' Va .hi e lAri'io fau'ro ri
cordato nell'elogio? Margherita Guardr.rcci ha
proposto di integrare, alla fine del primo verso,
la parola drnqxoÉ, che si adatta perfettamente
alla metrica''. L'ipotesi sembra estremamente
convincente, e si può pensare che a questa pa-
L4l
rol:r vada co'lega o il Pu tn: all inizio dcl 'econdo verso, piuttosto che, come generalmente
supposto, a EÈLloòór'roE:r, dando così l'indica_
zione della carica di prae;t'ectus tJtbi rivestita da
Fausto. Due sono i personaggi che potrebbero
cc ri.porderc a'l idcnrikir del nos ro: ,4rr'inAcilius Glabrío Faustus, console nel 438 e prae-
lectus IJrbí oer tre volte tra il '10E e il 417' e'Anícius
Aciiius Aginantitts Fdustll\' consoie nel
4E) e p/aefectas r/rl una Prima volta tra il 475
e il ,{8) e una seconda nel 502 l " Il primo diquesti due personaggi ha lasciato un'altra trac-
.ìu del ""o interessamenlo per la zona della
Potticus Minuciat un'iscrizione, oggi perduta'
incisa su un architrave rinvcnuto nel xr secolo
a via delle Boneghe Oscure" (fig 2), ricorda
dei restauri effettuati dal Praelectus Urbi Anícíus Acilius Glabtio Farrrrr a Lìn monumento' 1l
., i ronc pu lfonpo c perdu o m, cl_e '^n'idemndo che la lacuna dovrebbe essete di 15 20
lenere", che l'oggeno è di genere femminlle e
che il ìuogo di rinvenimento coincide con la re-
cinzione neridionale dclla Mz)rzcà, sembra as
sai probabile doler integtare Patticlln M1:"ù
rmru. Ne1 iatale caso che da reggiò ìl monu-
mccro dcre. cor cprni ero'ir'gliar' e*cre risto il terremoro del 40E", e quindi iì restauro
va attribuito alla prinra prelettura di Glabrione
FaLrsto". Questa deve essere considerata anche
logo ,lcl presbit*o costrntinopolitano :drL!rór' dcllepoù di
ai,si.iai" (F. l IALKN, Brit1'b îheú basiartdlìú snct )'e'lBrulelks l'ìt7, \ol I P 2l0r
2J, I oorÒ,.Tc" ,.,t',d o. o_ i ' r 'r lJ
s.v. fd,Jr,r, nn '1 e 8, PP 151'15'l241 CIL. vl. 1676 DD NN Aeîetnit Pt'"d!ib!t HÒ
tu..1 - i'úùÒ tc-' 4t. ttlL 'l..c '"1
ltdli a b
pd\ù\ lt t" .. '. 1ù4tt)
-) N.lo'. ,1,'r"'. ffi'.'io'll " "vniot Aqastai, dcle essere intesrùro .r TlrÒl'li' A'U o
snnili26r ra GuDouo\r (r cura dil,I t.".n!J,lù,r ìt!]Itlll
ih It.tid e rdlrt.d "kdit.td,d BoLog.r 1989. p 608
2?) Que$o conscnte di fhste agli an.i irìDedràtùùe'rc
seuucnti ai .los la ptinm ptefctÌùu di GlabioDe. h cÙi 'laù
"*ilì! ira il 408; il .121. IJI-RE, ll. s.! f.trî,ó n 8. PP
1i2154
18) L \'loRrrrr, InlriPtn"et Ctueraa Uúi Ro"la'' L'
Ronra 1968, n 69, P. 62
19 | | \r., fl I i r' "D"-'o at L' IaLltÒtd i1ùr" t'.túo dg_ '8n o ''I Po nIRI' '
-At| / r't,h- .,,".1. , . . I tJ ddt ?/- "8 Po
q -u dr
,lmo I / iPP' altt a ît"'lldlu L \'I L:a
iii.,,t",.. ;n xeRt,loi, reel l pp. 661-708 con bi'Lil-,ùd,. p, cl",c.lìs"n| "do. D N4 \"oÚ\i i, ,;:,..- .tr"r, ".. - ' a r \ìn -î t"0 ,tkPú;n,' Mì"acia.inP.DÈLú.r \^ cúa.li)' La íÒti' úa"Ò
1\ t'f|'d' :'- 'a''')'î'J aIù...J1^.,. rir.n/" tnol Pp {. I \.\i,\,t .rr a nota 8
21) Gú!ùu..r, L.ltilt lntù ErccÒ cir' a nora ì2 p
2),422) a{roòóxaa va inlcce piobtbllncnte l'reso come
Dpellatiro onorifico deìÌo st€ss. fauro, come nel cam 2na
247
HONORIPRfÉ'Fvr
L.ì ,:lrrazione pa\t qucnî peî l'istiruzione dellorcnodochio, in quanro I'indicazione che la Porr/.rJ tosse stata fcstituita aìl'aspetto e all'usor. Fdelri senhrJ crlr lere 'n".r.nerro in.. J rr ."rpì<*o d' ruu Jlrfo.ipo e J(.rir,-
zione. Nel fatto chc il Faùsta xeina.locho\ si^ da\rrcro Cl.b-,one o."n Ar icro
\!i.!rtio, o eventuaÌmente con un altro urerr::o deììa gerr, sembra tLrnavia di poter rÌcono:ierc, in analogia con alrri casi notj per leta:.rr.lo antica", un converllere di interessi di:Ìcnbri di una fessa lanriglia su uno stesso:ronumento, oggerto almeno duc volte in pochirj.cenni di atti di evefgciismo. Nell'area immcL:iiìlaDente a ovesi della Potticus Mlnucia, con-, r. aJ e,.a. ror, r'ell
' l"rre',rrr: : ' h.ol"gica
o r. Ar." Sr. .,r d Largo {rp.nr.na. nei p-,ìr..rtni del lr sccolo si venne ad impiantare un arricolalo complesso, nel quale ho recentemenre
lrrupn rc J ico rn.cc-c ìl \4.ia,t, tit ,r BÒ. utj,rrrz noro da un passo dd Liber Pontftcalis)'. I
PRr-t c l.vJ
nome di questo monastero indica un rapportotra esso e Lrn Boezio, nel quale, con estrenra verosimiglianza, è da iconoscere il celebre filo,sofo di ctà teodericiana Anicio Severino ManlioBocz.o. uro deeìr Lhirri e de: pir- illr-srri r'p-presentanli della stirpe degli Anici. Sc quesLaproposta di identiicazione cogliesse nel scgno,il ou"Jro de1 r rrrencrri de' r Q,,, An. ,t :tquesta zonà della ciaà ne risuherebbe ancorpiù articolato c coerente.
2.). Xenodochium a Valetiis. Un caso pcrcerti verci parallelo a quello dello xenotlctchiuntAnichiorun è costitlÌito <lúlo xenotlochiutn Valerii o a Valerits, noto da due epistole di s. Gre,gorro Magr.o /l\. o0 82,. dr una ,rraziorenella vita di Stefano III (76E 772) e dal calalogo:r.c.rro nelìa brog-aria Ji Leone lll, or. rienericordato un <aratoium Sdncti abba Cy4 qutpotitd, tr xetodo.li' qùt app.tloh" d Valp4 \...Le due lenere di Gregorio I, praricanenteidentiche tra di loro, sono indirízzate I'una a urcerto presbitero Domizio, abate del monasterosiciliano dei santi Màssimo e Agara, l'altra al<<srbdidL.onus Ahtoníus, praeposittrs xenodochiìin hac urbe kuna c,.)stitrti .tuod Valerli nuncu.patu'. Ogge1s Jclle e, . e r il .on er.,rosoche si trascinava da lungo tempo lra il mona-
28) S{N1.r\( LLr V,\LL\/ \\ . ,t ., ! nota E.29) NoD rronìo qui rr qucfu !rcpor! di iJenrùcr.
ziore. pcÌ h quale riD.rdÒ I s\\r,r\ri.ù Vr .LNAu, rrl
Ì:(.2 Isftirnùe CIL,\1,16t(,li A"n" C,Ìdhrn) tu'r'\, rehùr I rfàùri u omùchi. l)tubrbilmentc llh /ìrdr
ta'l208
stero e lo xenodochio riguardo la proprielà1 di
rrc Pos\essiofie\ poste nel terlitorio di Palermo'
.lii-rt" pn;no, Nasoniano e Libiniano ll ri
ferimcrro zi rurr'cro'r Prc' edc ì i cmmrnrs rd
tori delro rcrodo,l-:o co nv"l i n'lb d'prt r
rende chiaro che esso doveva esistere già da Pa-
re\!l-:o empo ll su. ro-ne d:'rra îa-rr'. in
dica un suo legame con I'importante famiglia
dei Valeti, a1 cui evergetismo sr deve' con ognr
probabilira la 5Lia 'srirLr/ioîe chc 'i d've
àrrndr r,- ri*li e c Irrima dellr g rcrra gorrca'
e' cri uonice ,n'he lz gc-' Valcria c'cc dal'a
.'"'t. fur i" n-rrr.,n,, di prove. c Jifficile
.iug!,ire ,ì'lì !errJTionc di egnre rslrr'/r^nc
,i"Lii *.nodochio all'attivitàL evergerica di Mela-
"iu i"ni"t" . <lel madto Piniano, attività per la
ouale essi aljenarono gran parte dell Lmmenso
parrir,,orio d.l', .rmiglra Proprro :rr hrse a
o.resto rrDporo Lon i \arerr C B De Ro*i
J.opo.e l, lo.uli',",'"n' oerro rc rodo' h o 'ul"c.ll-'ì. iootirtn"ao che si fosse impiantato al
I n erno d.lla 1" za' di quell' f'n elir' lc c tt
p..i,i.". "..r"," dll, ( I- esr dr > qtehro Ro
i.ndo è assicurata da una eccezionale sene c1L
rinvenimenti epigrafici" Questa ipotesi è stala
ncn.tal-ent. a.fett"ta", anche se in reaìràL non
,.*". , un, ,r ,' si ,oprofondrra ll ' orf-ort o
.on il .r'" dello ' +'16"t' "'' A tt"bia'* v tn
nanzitlìtto, mostra che non c'è nessuna neces_
sità di ipotizzare una relazior, e topograbca tra I
luoshi di residenza e i luoghi oggetto dell'evcr-
geti,rro d.ll. laniglic dellr-isr"c-:'ia *r "roriatardoantica, né vi è alcun elemento per lPo z-
zar-- una continuirà tra lo xenodochio c il po-
sr.r.or. n.na.rcro dr S. frasmn. rc'rirnon r'n Iparrrre dal vr se.olo re'l rr.a Jell ''rtic ' 1" '''Jci Vaìe-i . Cl elen'nt lrc nndono di icrle
accettirre quecll ro.a'ruz lzio le \nno.!o\trn/rr'
-.n,. Ju., la*crza di ogn n''rzior' di rn
'lelio,Luogo Ji culto deartcto a s aóba urrc \uL
e la notizia, contenuta nella vemlone p1u com
r,lera d.lla ' ra Jr " Velaria ' h' lu Jo"- d''\ rL..i '."n. '.nou"
dopo il 'dcco Jel 4l0 c\e
la distrusse quasi completàmente " E evidente
l'inconciliabilità di questo passaggto tlr pro
orierà con f ipotesi che Ìa stessa dozas sLa stata
ion'..'c, J-'g i ,res5i Valeri. per lr tosrirr "ion(
di un ente assistenziale. Anche in questo caso'
come pcr quello de1lo xenodochio degli Anici'
.".. i".. tr-" " lrcr rclr:rrc Ind plau"ib'e lo_
ca tz. i.'t. d(ì co nlrlc"o. dall rdc ìlrlrcr/lone
derl o,ato-.o I c 'or'" i luogl-: di ' ultn rrol J
Roma dedicati ai maniri desssndrini ,(liro e
Giovanni. popolarnente roti come s abbr (liro
o con \'arie deiorrrazioni di questo nome: r '{'bdct,ra ad Alcldnttttt s Abfutto Transtihetun e
s. Abba4r() de 1]rlìtii5' c'J è estrcnamentc pro_
L bil. cnc d cr-o ' no Ji q rr' '' " l^r r' io
dello xenodochio dei Valeri Va sLrbito esclusa
l'<ecclesia s. Abbacytì atqtte Archangeli nì Alc'
209
.":!rljt>;r ciàta nella biografia di Gregorio lV!2r 8.1.1), poiché è evidentemenre rurt)uno con
t.ì!tnre sancti Abbaqri in didconia sdnctì At-,:.rrgelz menzionato nella sressa biografia diLor . Tll nella qua)e e ri,ordaro lorarorioilello xenodochio. Si trata quindi di un luogoJi culto inserito all'inremo di un'altra chrcsa, eùon può quindi essere identificato con la nostracappelÌa. Più compìesso il caso dt S AbbacltiTranstìbeim'i. L'origine di quesra chiesa, se-
' rJo r nr pa io Lontenura in un lezior;"iodellà Chiesa di S. Maria in via Lata e riponaradal Martinelli',, risalirebbe all'epoca della rra-
,zione Jci corpi dei .arri Ciro e Ciovann,, av-renuia al rempo di Innocenzo I QA2.4t7): tcorpì dei due martiri, in atesa della colloca. rore dcfin:,iv,. .o-ebbero s.rti -À",pzar.I t vúeiq aad ft-eodo,a"t ,e'eiún,.1 w..l:i,ua>. Dopo la traslazione delle reliquie nellaSrsilica sulla via Portuense, una parre della casa
eodora sarebbe srara d, lri rasrormau in:!iesa. Non è possibiÌe dire quale fiducia vadar.cordata alle norizie riporrate dalla prrrtu, c or
-o non e po..ibiJc propor.c rr r J"ra .o...Jte per la traslazione deile reliquie; ruttavraron si può escludere che esse abbiano un fon,Jrmento, tanto più che è forse possibile docu:ìentare la sloricità dell'esistenza della pra veJova Teodora, se, conre mi sembra probabile,
essa è da identificare con i'omonima marronacono.crurr da Pa-ì,clio. che r rriro Ronr proprionegli arri dcl por rit:caro di lrrocer zo l, c dalui additata ad csempio per la santità dellavitar'. Le vicende all'originc di quesra chiesalranstiberina rendono cornunque difficile proporne l'identificazione con l'oralorio deho xcnodochio, tanto piir che non sembra possibilelro\are ne.\un rappofto rd l.l Tcodora proprie-r.r.ia dclla.o'r c L gr.? dei Vclcn. I unrcadeÌle chiesc dedicarc ai sanri Ciro e Giovannrche potrebbe essere idenrificara con il nosrrooratorio, è pertanlo quella di s. Abbaciro /r za:lùtis. La o-ima a. e.rrzione dr qLes r chi.sa ri-saÌe al xtt secolo., ma in realtà essa deve esscrcdi molto anteriore, dato che il culto per i duemartiri alessandrini decadde compleramenre nel,o so dell altom.diocro . I e'arra , ^ìlo.azioredi questa chiesa nell'ambito della zona de11eMili,,ie L sràr I cLLefra, \olo di -e..rrre gr,zi.aÌÌ'analisi di alcuni documenti inediti che hapermesso di localizzarla all'inrerno della sala se-micircolare posra rll'estremità serentrionaÌedeÌÌ'emiciclo dei Mercati di Traiano.,. Perquanio la mancanza di ogni elemento posrtrvorenda impossibile giungerc ad una identifìcazione cerfa, si può peftanto proporre, ìn via diipotesi, di localizzare Io xeaodochiztn Valeriírell crca der Mcr,ari di fraiano f..c si sa
16) HaL$N, op t r.où 11. p. Ìó2: L Lorir S^NJrppo,.-îr|o-aî. I Jt L. ogA, 1o-,o,La , t. tr,, l 7, .r1\q!f tl1191. pp.211268, in par. pp.2lj 2t6
l7) HU6EN, ,t d7 r.orr ll. D 16li8) F. lvlArrNtrLlr, P na j,.)1.. t|lli Sn. Crc.. úútr
:'i Rú,'t relk 'ù Ldt. h \ i,/.rz . Ronn 16t5. D. rrrl9) P^LLADro, H,nó,; t,!n,.ì I ed c L M Bdfte.lfk. Fordùjone Lorcnzo VrÌL. llilù. t97,4)i ledi aDche/ Dr 1.. u. 08.. ... rL. 1.,.. , I J I -.eJdoh. r.o .
Jn.. ,I tr 'a d' Abbo . . .boo, ,n.io Vr.idno eCorr n i/4./z\i etr V.. .u, , ...errpe. .pog'' d- \'fr'r..: u J"l ..o a , r ..u - ," -,-.Ma @ntempdùra del nùún,. Àlcnuto neì 104, e qùindinon puo esse.e rd€nùncrt! .or Ir norrl
40) II!1s."_, r,r .t. a noù 11. DD. lj9 l6Ìi M.,{srL.ùM C C& rEJ l-1, L. .ra! ll RÒ,1; ttat \et rv at ,e. XrX,
.11) S. Abb.ciro in Trdsrevùe scomDùe nel cor$ oernedkrevo, ncnùe la clice delle Miìi,G e .ìuettj e\t.artrbdnrNlk via PoúueDsc sono note coi il nonc d;forndro in S paceù, S. Pascr o simili, che mormno com€ Ioris,nùia dedi.cazione fose caduù cónpletamc.re nell'oìrìiÒ.
.r2) R MENFclll|r, R,,,r Rnú.L. "el
Falo,li1rukno.N'aui d.ti ttthealasi.i..l aEhì,n) nlurtuk,tì t. unenta fl.dí.rah d.l nla"uÍt."ta e k.Li.td.I s. Mdtit íi CdnpÒCútea,in ,4tlel, XIX, 1992, pp 1091)6
. lì I'i.,i eìdp,ot. "-i D ao.i,,.a...cor, 1,,
di un secoÌo iì dibartìto sulla localiz,aziore dcÌìo xenodociióda V'le'i. An.liri rrrvJ Lid !o,. .o Iid1,,.,d-io€ìeì , -h e. "'< [1i ,k . .n Io , - . c,.o n. ta b.oe, .':di LsDe IÌ, anche s. la moùvrzion€ da lùi dddoiÌr, ùè ldt'. n." de ivJ. io. " del r6p1n.p6 . 7,u- lq. '. "n.l-.. k îdr ', r' nr,hlk \l t/ - d_V,r /.scmbrd difficilncnre sosrenibile. M. ARrELrrr, l. .7,,,e .r,R0,/,, Romr 1887, pp. 92 95.
L8l210 klL!rnD! \/\NrrN.rL \ \LLNZìi L
rebbe ouùdi installato all'interno di un ediÉicio
pubblico, occr.rpando pane degli ambiend del
ero,rdc .ontple""o traiunco, ancora una volta in
significatna analogia con lo xenolochitm Ant
2.1. Pdùperibus habitacula ad b Petran, b'
Paulum et ad :. Ldurcfiîiu t Questi tre tsututt
assistenziali sono menzionati solo una volta dal
Liber Ponirtcabs, che ricorda la loro fonda-
/ or e ad opcrr dr oaoa Si nmaco, 49ò-514
Ir deron"naziore pot'p'rbL, 'abttd t'tr 'n1cui sono definiti porrebbe far pensare a qual-
cosa di tipolosicamente diverso dagli rerolocÀza veri c propri, anche se la loro localizza'
uior" rer n-* dei r-e .anru;n 'uburoa ri piu
veneratj rende estremalnente probabile che
l'accoglienza dei pellegrini rientrasse tra ie loro
funzioni principaÌi.
2.5. Xenadochíum in L'ía L,ttd (.= Xenotlo'
chlnn Finnís?). La biogtafia di papa Vigiliorst7.ìq5, -rporJ. rcll el.rca.'iore di un: '"-icdi donazioni e di atti di evergetismo conPrutr
da Belisario a seguito delle sue vittorie militari'anche la notizia della costruzione dì uno xeno'
dochio: "Ferri f íLìsaiu s pat rìcíus xenodochiutn
tu L,ia L,tta>>. L^ Ioc lizzazione di questo istituto
n ro consiJer.r .i terra \r-i do umenri îe'le-i:li ci-ano 'a chi".a, urr.rra esi'rcn e Ji S Va
ria in Trivio o dei Crociferi' col nome di Ecrle
:M :a'lr,a. \tla".c ta \ anJo.L n e la rorizi'r
dclla 'uc co'truzion. da prnt di Bcli'arro si
tramandava ancora nel {r xlll secolo, sebbene
circondata da un alone di leggenda, come mo
srrà una iscrizione murata all'esterno della
chiesa". Nel catalogo inserito nella biografia diLeone III non è ricorddto nessuno tryolo'lttu,. t' ut' La'a, tn e ttL-o rrn o-a urirl'rSanctae Dei Genetricis, sito in Senodochio Firmiu", ne1 quale l'analogia della dedica della
chiesa alla Nladonna consente forse di vedete lo
stesso istitutor\. ll nome Flzzri potrebbe essere
ir,teso come nome proprio, anche se nessun
personaggio d] rilievo con iale nome è noto per
Ì'.poca in q,te.tionc'", tt,a, sorgendo lo xenodo-
chlo , riJo*o J. c I .,' . J.llz,,a \ trgo. ri
tengo possibilc che ì'ir',rzir possa essere in rerhìcorruttela dì un orieinerio ht) Forntis
2.6. Xenorhci:i:t,;: T;rtitrn La biografìa di
Leone lll nenziona. nel piu Iolte ricordato ca-
talogo rlelle chiese rli Roma, un <oratorllrnl
Sanctorum Cosmae et Daniani, qui Ponrtur m
xenodochic, qui appellatur TLrcium> Húlsen
mise ouesto stràno app€llativo in rappofio con
qu.llo d.ìl n4ro locra, una diramazione dcl'
lAppi.r .o . l arer;r o' L ''i*erza al Lat'
'.';- J ,. ." nplc''o .s'isrcrzirle. arcì " "non denominato xenodochio ei apparente
menre. non specificatamente destinato all'assi
stenza ai iorcstieri, è nota da una bolla di Ono-
rio lI. darrta I maggio 1128, nella quale è citato
lI "rneubile Ptochlùl íuxta palaliln]î I'atetu
/?crîe>'. Nonostante l'attestazione di questo
istitLllo assirenziele sia decisamente più tarda
)4 LP | 26\ l\\r "LLl t\tllr HLrrsLN ,/ .// a n.tJ Ìl l 1(rr
| ,/ n i a' \lltt ' t ob
p-ù î.J.. .t 'ol ltù,;,. ^., ,...,
.,1 t . \' '. I I \d'' ''' 'P t d' D "1
iriscuiom è ciÌah da V. F.tN:,tlL^ I!.tiziaú .l'lle 'hì'tc '.d., nt.. p .1t d.l . \t . r .. ., .. ?, R .,3" 8,.ol x.Drt .',no,d|| r., B {.-
zionc. ll lero è ripofat(r, con aÌcune imprccìsioni dr ARLrr-'
-,,. "; ;. , .', ,{. p - d, .{. 8' ,, , . ir. ?/-,ij i. . P,. \v," ra-!.p 'l $. 1du ".. L rr. rA'\" \l " 1
.rh )iIII úttt4,r,? 4ure ín ItìLat ln b"! ùdhtc ct\|d"t t
Ro$a 1918. Ìr\ XL. n '1.rl) /f. II D Ì2 (1.. IlI).16r / P. Il. D la, n. l08i C CE(rrLr!r. S ù1''?i? '' i"rn'
RoDa 1925. ppl ú ú. ù'lrtt G Nl\rrr0.]r' /-' 'i'a' lr
R.,r tÌrl I rl r\ n'.d/,. R.ma ì962. p 1S6
,191 l'l.RE ll lll. sr'50) C C.R\Frttu. D.!!Aùrù T..ú Í Rúqì tttl )laIÒ
E, Incni!.rtÒt. \r.11.a,Ì.shl ú Il ttúttù"'!r' s tt'n. t. 1870. pP 12 t2. (.6 80. lt; l,6r Hr Lr!\' /'l ''/ r noÌa
51) K|HR,,l t. r n.ri ll. F ll
PtLLtrCR]NI. SLNAIOIII L PÀPt 21t
::.:-roca dÌ cui ci stiamo occupando, l'uso,: .: ;eirnirlo, di una parola greca, spinge a fe: .ì.ir.ìrne Ì'istituzione almeno ad epoca prc,:.,,ingia. L'identificazione dello xenodocbíutt: :rri con tl ueterabíle ptachium l^teî^nense
.b a ..tlernane ' e probab'e. o'c '. co '.r. r . \- l.r paro)" lu t .". o l"t ,,,t i ro ru-t "::re h normale grafia latina della parola greca
rrL,rTtiov. L'uso come nome proprio dello xe'Ju.h o d 1,, r<rrrrine cfc irr gre, n hr un .i-
cnificaro generico, dimostra l'eccezionalità delI uso a Roma di questa parola. L'unìca aftra ar-restezione a Roma di un edificio così defiruLo sr:
'ella brog a'ir d. Pel.gio ll ,s78 rîu', ,r cri:i deve I'istituzione di uno Ptochlwn nella suacasa". L'eccezionalià del ternine rende forsepossibiìe identificare questo edificio con lo prochium I^teranetlse xenodochitn'l ucium, c ate-sto consentirebbc di precisarne la cronologiaagli ultimi decenni del vr secolo.
2.1. Xenotlochtmt ilxt,t gladus beati Peti.La notizia dell'esistenza di uno xenodochio <arlttlnctwn Petnult apattolonn púncipe .b> è con.renuta in una lenera di Gregorio \,fagno,, c1e1
l'anno 598, dalla quale ò peraltro ìnpossibìlecapire se s; trarri di un istirulo preeshten!c o dinuova fondazione. NelÌa descrizione della basilica vaticana di Pietro NIallio. risalente al xn secolo'r, è tuttavia ricofdaro chc Gregorio I <<,&rz7
\,.u.1u,.1 ,,-, tj..8u\. .1,.' !"..!t.. . I t.:"1canttitait ibí trcs cuxtol.es ú t ptintcerìo...". Sit.atta con ogni probabilirì del Dedesimo com-plesso citato nella ìenera dello stesso pontefice,e non sembrano condirisjbili i duì:bi espressrdal Kehr suìla verìdicirà deìl anLibuzionc dello
xenodochio a Gregorio Magno", tanro più chetale attribuzione conpare già nell\,ur secolo se,
come sembra ragionevolc supporre, lo rc'rzorlochìun :. Cregoríi è iutt'Lrno con I'hospìtale s.
Ct"ertì cì.nto ne r rrra di Adri.rro I .or e -.i.stenle nell'area della basilica vaticana, presso ladiaconia di S. Silvestro.
2.8. Xenorlochiun de uìa Noua. Tndirizzando, nel j91, una lunghìssina lettera al sud,diacono Pietro, amminisrratore dei beri dellachiesa di Rona iu Sicìlia, Gregorio Nlagno, uasvariate altre dìsposizioni, 91i ordina: <.... Pezszoncs xenr ochii de \tia Nal)a, quaittds nîíhí inil.cdsti quia dp .l te habe:, nobi: diiger...>'".Non sembra giustilìcata I'incertczza di Ashbv eManhiac su quale dellc due stradc note conquesro non-( Jcbba e.s. e."rsroe-: a.pnrimadell'istituto ". La via Nova del Palatino, infatti,non è mai attestara per tutra l'età imperiale, ede a..a' dubbro . \e .rbb r con.e r;ro rl proprionome e i1 suo stesso carattere di strada pubblicadooo Icra rer.rr. rr ' In Fpo. I rrlJo ,:r ri, a
l'uníca strada nota con il nomc di via Nova è legrande strada severiana che sostituisce o af-fianca il tracciato urbano della via Appia, ed èsenza dubbio su di essa chc sorse il nostro rcrrod",l-'o. S'c,olua ar bu..n, l .riruzro'eallo stesso Cregorio, ma in realtà scnza alcunelemento probarte"; la cosa sembra anzr rrrealtà assai improbabile, se si tiene conto che Ialettera chc menziona lo renodochio ò soro cupo. \i re.r .ucLe..ir; rll .l.rrzior e di t, cporioal sogÌio pontificio, e quindì la data del 591 èda considerarsi solo un termine atte 4aezz perla sua esistenza. Recentemcnte ne è stala plupo
52) LP,I, r. )a' tP.li4t'i 1I5l) Ep lX. 6,.5,1) Ìrlm NIAL]ir, O,r,r,1,,r latlo@. iìdr. d" tuùi1i'.
!r"a bdílì.a 5. Pd, i" \',t!tùtu. in R. VnlF\rrrr c. Z!.ctlEîî1.ùiice tapÒE liL.,l!L: dr,ì ,1il?.,d, ItI, RoDd t9r6,
t5) KEin, ,t ,7 ì rÒri ll. p 1.19.i6) Ep. L 12t7) S B Plrrtrn Tú. n\ ú\, A TÒpÒrt!úndL DnL'a
,r'f al Àh.nt1 Row, O\tÒrd 1929, p t8ti l\'hrr r^1.,t., i noÌa t8, p 186..ò R.<,\ \,'\rrt....rgc. 91, 1969 90, pp. 2l10.
5r) ù1 G. CE.. )i),Ca"tìbtti llla torÒptu[tu t.tk R.8t.". <D,ulLrnd PMnld Ptbtk. rbi tirit,, .ru.ta cturùtu"in pùiala dltÒti.dhral., iD lv1c. LXIV, 12, 1988. fp.89 107, rn pd. p. 9,1.
tr0l212
sta la localizzazione all'intemo del complesso
delle Terme di Caracalla6', in base alla presenza
cuì di una necropoli databile al tardo vl'vlt se
colo e al pos. bil. -nppo r^ r, lo \cn'do'l'io c
la J,aconia coleg,ra.'lJa 'hie'a
dei ss Nereo tAchilleo che sorse tultora davanti alle 'Ierme
La presenza di nécropoli all'interno degli edifici
oubblici di età imperiale costituisce in realt' un
i"no-"no fr"q.,.nt. nelÌa Roma altomedievale'
e non c'è alcun motivo per collegarla alla pre
senza dello xenodochio'' Più complesso il pro-
blem; posro oa' appono trcgli ,c"oJo'L a ' 'ediaconre .rl quale rornerò diÍu'ame ìle î 'c_
llcc^RDo!^NTÀi!GEL]\'^LENz^Nl
suito-l bas,iqui d're che quc'lo fappono è 3l
i"*r'., no" pu., del a met, oell r ' s,c"lo e
'crrbra d.r dover.'drl ibuire d Jr,r rio-ganizzr-
zione del ser,,izio assistenziale dovuta all'opera
di sre.:rnoll lr ncs'uro J'i ,r' cl c D^c5ir'ro
documentare una diaconia si affianca o sostitui
sce uno degli xenodochi di v o vl secolo' ne
questi li vediamo mai collegati ^
rtr titula\ ^s'
sai ìmprobabile sembra pertanto una connes
sione rra 1o xenodochio de uìa Noua e ì, titulus
Fasablae o la posreriore diaconia dei SS. Nereo
e Achilleo". In definiriva non esiste nessun ele-
mento che consenta dì localizzare lo xenodo
60) ll!1.ìvedi holtre Eú C,npar"d '* !d'a tt82'it)'in A^ Vv.. R,,,/ Ar.húlosir
".1 Caùn ll Ran^ 198t ' rip
t68 t94i lltD, R.rrb Xll, ,/irinl e tourdpPalr1'nt n Mùa
úbía!. 7.2, 19A5, Pli 2J )A'orj n. ll^..i'*1'-n. S^^-r'!cEU vrr-ENzNr. JeP"'re'aa bootD'
1.' ':'ì
;," ií, "-.," Òu8 o rD '"'-Jt,.a r'ltr' P!' 0U! 'it at<a t / 1 r'-,o-"&r '\À arp 2l ì-.\'i."',,i"..'r^ l(1,'e. l' r' rb' *' lL J-r'lir -bu ron" deeì: r ai u pe .L r Ji ' rU
'r "rn" dr u
;..;-J;a""; iFn ..i r ..( rnLi ' du "T d
...o r- .,Je.siu.,n .l ... - on..'20, n " r' r'\ l0 1'n1'ir^.i.., -"t"i -.", ',uu, f e' lon
:":i, . "
."" ' * . p r e. " e ' 'r' r "c" r '
rir.. .ìù di 20 rombc: Crc.H!u, in Ro,d cn a nota Prcce
à.ni"li. p.i p*.r't ... .i.aphce il. morilo pd cons aúdre
noi.arr'd. u -.-r ' ' nrr_ o "hno r_o \" h
In, L'r\J"/r d, '.o 'Ir;-1r!'ry L' r- -
ì,,i t.'-"" I tor'"-J " I K)' ú\
t9q;. Dp 8. 'o, .' r iPe', "bb n -,1; I on rroJ,o';e, ,''ne, rPc'ce'r'Jo\"\r'^"'('" nf' 'lenza uomini)'-...1:i i.l. a..."i" 'i."ne
ancora fordrnertrle il qua
.', ;.....'"p, ó, nquJ dn. li ú rror'"ce'h "' F
,1,".n ddÒ B'. IP ldúdJt dd1"d,ii.irj" . t"! .-z,ut,, r'\P rrxx ro1 Do r<
D-,.:;F.;-;: "o,..-, ùr.n,/of,dI.D,n'., D -,,lh ù'ltd"! d r " 6@1ù " I' P obl;'" r' Lb 0ti= CEaf tlirr Prri' Rome !qqo pF Ì61 18ì
Jr L, o. ' -r-on.d q'e ìir"iiol 'r'root'.,d;.";'..'po, renec l" o'crut arL-'"rrlcoda clre qucl pòtefice crlerídn bútÒú'j rtúttr'* NÙ4
.t Achíll.i btd. niùid intn ,et$tat. dernrc at4'e dqat'ni,rr'lr" o; rerlctì turta ..,.le rcl4ìd1' "'ner
d l"rdt,'. ; ,- ". p".,", ,! , w, tP np 'utt,. tlt',t -' d" J'rLry' < rhei cr hJ dm"rréroche lìttùdle chjee è dd .rtribùire interam€ntc a q!c{î r'co
, L-2...- ', "lnLU R KP" / aa t\ ttd 0r'
,;.;,.,, , , ' -.0 . t t '1. "' \"r 'o ra/ PP
I tl)- .,i!s,..,' ondr'" oc. drl"dl rono
f'"-", i.'. ', '".,"ro ibi ll, T"f' "d("'"..;J,'.s,q. no Ir-llo/e'J'" ^ ''nl
inL.r,c\(,:, I K t' .."c.r .1 .1 \. .1 . ,td
tt'd -t,t." Burr lE. ).r, r <ab-'1.., p.-.,bir,....n-.'-tr. i..ro. '\ \.-u. a.hlleo i, -"'"1:' o'r 'n-d -'o")l !àLt :-
1"" il. rt^-, p**.t*", *n sia da ricercarc sono h chiesa
dturlc. ma dre,r:r, sia dd inrenderc, piir corettdnìent€ der"nr'ooÌorsio.!or
r-,." t t -2t ' hi 'ji'h. PÒn tíar h. in \'.tchd, 16, l979, PF 201 2l9l' A quc'4,...r,..".,i e ot "uro,. ,r:i".1";' r,o
' .tlr, ' on( d'_ " to'."i, i"Ai.-" r" ':,t,."-u'
del lneÌlo di calpestio, na dcre
;'.,"."- -*'" úe$ "ir un lrhr.ì lìogo Pìrì a''" l-r
iili','p*i.a"*. a"** u,jndi esscre Fo* non lLnsl dJlìÌiuale. mr tÒn iùxso dr qù.rd. rìunr qùo lru brsr di q!cÌÌ! ng.!ùnÌa dù grrnd' nÌcrr s€
fdiì;i { Nl soktu lc Ternìc AntoniniaDe c rÌ cLf rc'nc
"aiiii", -+" t. .hiÈsr di L..ne lll A NÒrd ovcr delÌc'lnnn.
'\nrori.irnc. iLrori del reirrpie'o sul qùùle sorge 1i
;. .. - l n'o I loJ' r'rrf 'ni "lor -do , r _ cj \o's' rr ' ' rp <"o rúeoloelo or" r
deri"jone rr'e' r' c''''1, "Rq$
Y'| \'' 'fl
D
t r' 1 R, nr' r drli i o "
_ léló \'\' r'dcDz. CoDundlc hanno Pemcso di ùiaíre ìn Prte le rro'og € . , I . -roED Jc l" r, ruc.D\4. \'
^,i,,ns,.- \l\"1 D"a I'd'1o'L- i O4lt
)tL A*h,A"g. i-llrle XIl, Ron. 199l,.pP.tlt8) Di,."",' 1.... ù \..,ù ef.n.,.^Jrr" di'r'
',1' J, on '-' uo l' ' 'co"' r'e'h 'olùi e 'e ni u_ l, o '" o ''t ' r lroJ' dr ''
-"-"' '..::, r "' l' d J r '_r on e" o e \';;J.a;;;." " t;na"ro Ò'"rile d."o r" o . r'r o Lco*ruzione, in un'open vittat. nolto r€gohrc rmbm da drm-..rr;iÀs't" aa ,r *-1. ln ùn ep;a $rc'csila ! trbside'
c'r'' nln'r'Inry" ttt, !'b "riL!î 'LJ 'onù .r'o r ."n'ii " r d Dr cu {4r ù'rsenìcùpoh sembm ssi probabilc úconos{e in qÙ$to edi
li PrLLr:(ìlùNi \ENii)lu E rAPt 211
.hio ,L, r/.r Nord all'interno delle Terme Anroniniane !. né di colÌegarìo con la chiesa dei SS.\ereo e Achilleo, e noll è pertanto possibileprecrsarne la posizione nelÌ'ambito dellc arecricine alla grande strada severiana.
2.9. Xenodochìan in pÌatdna; Xenodachtum,lidcaniLtc sa ctdc Mariac i cttput Portici; Xehotlochium diaconiae sanctì Sill)esti. h un passodelìa biografia di Stefano II (]j2jj1), di in,porlanza centrale per il nostro dhcorso, e sulq ric .i ,orrcra ditrusarnenrc in .eguiro, è riL.or-data l'anività dcl ponrefice nei riguardi dell'organizzazione assistenziale: <Mox ueto res tautatnt.t qrattrut t, Ia, Rorya.ta ùú. \ d d/ttq, tt.:cenodocbia, quae a tliuturnis et longt7Là tempo-ribus denituita mc ebant et ì adinatd, annonttilitdtem in tlimsis eorun locls eis disponens,latu! etian et /otis; ín quibus et mu|a cantlllitdana, qude ct per pirilegil pdginanz stb anathe-nîatis ínte ictun ca fitnauit. Paú ntodo a aowfttndasse dìnoscitur et xe adothitm i PLarana,cent m parperun Chrtsri. dis-positrm ì//ic fatiens, catídiana ùLlehcct ríct n eon!n? decenenstibri Ndn et foriî 11/ ro\ htius ciuitati: Ro-ftane \ecus baslicanl benti Petrl dpostali dao feclt xenotÌocbia, in qtibus et phn b]jtúlit.lonaqude et sachuit L)eneraklihts litconiìs illic fotsexlstentlb s pefenntter penú ete, it! ett liacontde sanúae Dez genetfi$ et bedti Silrestrù, gpril,ilegít apostallcts pcrenniter pernanenda n,niui>n'. Ttalascrando per ora la rnenzione dei ,1
xenodochi allora esistcnti. sulla quale torne-remo a suo luoÉio, il passo ci dà la notizia dellaro\rruzione dr al ri ," .r". r.;p 1 Or;n-o .
quelÌo definito ln platana, taponimo che, cor,lrrriarnen,e a ournro ipo,:zraro d-r Larrcia ri ,
più che rifedrsi ai platani del Teatro di ponpeo. Jere in,e,e, roî( rve\J jo relLlmrrte !isto il Duchesne6r, essere collegato all'idendcadenominazione della Chiesa di S. Eusrachio,c\iarxa n platdaa .î, ru nrrosi docrnrenrimedievalii'. Pochi anni prima Gregorio Il(115-731) aveta istituiro presso Ia sressa chresauDa diaconia, e vcdiamo qui attesraro quc1 rap-porto ,r: \enodochr e d acorie Ji cui si craparlato a proposito de\Io xenodochium tle uia\ora e sS. N.reo c A. nirreo, e cl-c rirrori.rmonegli altri due xenodochi fondati dall,ilsLancabìle Stefano II, ambedue posti ne1le rmmediare vicinanze di S. Pietro e coÌìegati alle diaconie di S. Maria zz Capat Particí e dj S. Sil\testro6e. Di quesr'ulrimo complesso è diffícile srabilire la relazione con 1o xenodachium iuxtabeati Petri, o*.vero l'hospitale ranctí Grcgoi chevedemmo essere indicato, nella biografia diAdriano I, come sorgere anch'esso accanto alladiaconia di S. SiÌvesrro. È possibile che i dLreenti siano slari fusi (anche in questo caso, pertanto, l'opera di Stefano ll sarebbe stata piii direstauro dt un complesso preesìstente che dinuova istituzione), ma non si può owiamenreescÌudere che essi fossero indipendenti, beDchevicini uno all'altro. Di nessuno dei tre xenodo-ch. ford:ui da 5rLtano ll lfo!rxîo in scguiropiù notizia, e non sono citarí neppure, pocnrdecenni dopo, neì catalogo inserito nella bio-grafia di Leone III, dove evidentemente sc,nocompresì nella menzione delle dspertive dia-
65) lP, I, pp. '140 4,41.6ó) R. LA!.r^Nr, /_'tlrel,,b ti Eittlctetn e I'orr"e d,
B.".dcto Ca"a,iÒ, in ManArt,I, 1891, .a11. $1 ir2.ó7) lP. I, p. 156, nora r.
,, 68) A$rrLúlJ C.CCHELJ ), op..ì1. a nat^ qO, pp. t2r-t)0,}IULSN, ot dr. I nora 11, pp.2t12t2._- 691 Su cucre chiese v. IIùLsrN, oz .,r a nora 11, pr).)24.16'1.
,. o. | | Neto d, . | ..,o J ., , r,, o,óo J"F,. t|lir,t .t , . \."o. \."rt". . d-te,enedrér".d/, d.\i. ."d. {( | L.n,no.rro.
r tc.r .,tor. oopo " J ,
o,r sr ti i I. r ; li ".Ù. o, .p.,*r ,; ael..'.^ne :l ^nif!,,, I . "l J.t .u o...o . n.Jo, ,. dl;.j, r 1 't ' ' ,d. d.' , q'-d. ro d-! "-l r,.r. 2.t -e h.d .
roenrrcdnonL ! quesr ùk'nro
IL2lRraaÀrìDo s,\\l'\i\G[LÌ VrltrNzlri]2t1
2.10. Hos\itale S Peregtiní in Nautnachìa'
Leone III <hospítaletn b Pettu apastalo ìn loca
a.d.. nautxachìa a funtlamexti n(juùet con'
ittu"ns, diu"rsa illic tlomotunt aeltficía tlecom
rit.. i qra ctìdlfi /1tdltJr îft corpora deletefis
,"ro*rLi;i;t a rlmnia, quae in praetlicto hosaitale
ilo,t ,"r"uorto, conittuxít Ptaelía etiatx ìllic
urbana ueL rustica prc alintctniis Chlhti pdupe'rrn
seu arlr"nì, oit peregtinís obl llt"." Lo
.i.l.o f-"o"" U dota l'ente di un oratorio' che
nella stessa dedica ne richiamava la funzone as
sirclziJte: o/a a k'1 \a4 l; I'er|tt' 1,ral po
a !r; .. !.a\pltat" dr' ti't co aJ nu'laú a'a- '
NJla r'ra di ta'qualc f 18 i E24ì Lhe lÒ cor'
Le.\c rr _rìor,r'lcro Ji S t (cilia ir Tri\Ievere
fint..o .o.pl"r.o appare intitolato a S Pere_
srino ,,holpitale s Perellìni pasitutr '1d.
bcnt m
i?etru,n a1:ostolu. in loco quí naunacbu xoca'
ir,',". La posirio". di questo 'orP7t'lr
è fissala
i" q,,.ll. ic',.fi."c di ' Pcrlegrino ' he nell'
Lorîe asurìte Jooo la r'co'rruzione delL lnedel xvl secolo, si è mentenuta trno ad er' mo-
2.11. La tabella a fianco ricapitola i dad re-
l,t:ri agli :,enooocl i Jllesrllli lr Romr' lJ cul
probabil. 'ocalizzazione e indicalr nLlla Drarra
a frg.3.
asli enti assistenziali di altro tipo conferma que
.io qurd.o, s Gerolamo ricorda un rosoro
neioi fonàato dalla nobile Fabiolar', mentre a
.. earrc, figlia delJ Au-elo Simrnr'o 'aprr '"za-i,,..orro Ieoderico 'i devc Iiqri uziore.del nonxrero di S. qrefaro fIrggiore. In vatcdno
dove veniva svolta un'àttività di assistenza per
oli indisen i . ler arere norizie di simiìi arr'virr
i",,,''!.. fi-.'"" ""'. Ja oa re deJle gercnh e
e,cre.ir.riche bi.ogna girrgetc lr,no a plpa
\,mmr,o \4qE_51'1r, rl qu,ìe 'i deve lr'r'lu,io* a.i ,.. paupetibus habitacula' ptesso S
2
1
'7
t2
ll
1t2 it1'i52 it7
152-151
l9i 316
'li ,'",.,
198 Evdserrmo Prn'ùro
v sccolo Ercrserisro PrlatÒ
\ sec.lÒ Elelgetisnro PrilarÒ
.lr8 tl] Pxp3lc
5lr ittt79 i902
L L'analisi dei singoll xenodochia . 'Ioctt'menraii a Roma permette di tentate di deli
neare un quadro articolato dello sviluppo dL
questi enii assistenziali Come appare chiara'
Àente dalla tabella, vi è una dìstinzione tra I
oiù antichi, atttibuibili all'attività evergettca
i.ìl"lrriel'" d"ll ,r:r", razia serrroria. e quellr
t"r.'i":'itt, ri re del r'.colo la cri forda-
ii... *-U* dovuta all'iniziativa papale' Que
s.a dire.erziazion. e evidenrc arche 'olo rb.r.e alla denoninaziore dei 'on_lrle5sr
ds''slLl
z rli. chl per quclli p:u ar r:chi c rratu ddl ger-
,iii,i. a.i ".ú,t iondato-i rt 4^Joct't-'"? AtL
chiarum, a laletiis)' mentre per quelli poste-
riori deriva generalmente dalla collocazione to
pografica. Il-p"chi"simo che sappiamo riguardo
ro) lf, Il, p. 2t) (leo [l)i Ksrn. oP 'r' a nora ]J' p
71) Ll', ll, pp 80.81 (Leo llÌ).12J LP Il, P 11 la\'!'alìt)7J .r' l\ op / dr'o,ll I rlú (rd' 'l\' 'D
., a nota Ó1, Pt 175 177.
74 Hrtk. Er. 77, 6tr 1,. ; \.1A \o D,, l\ rr I rì r \o/
JPPaP I t"aac" \1' I t1d
'11..),i.itt1 \)'XlV 'q'4 _1, \0-rì4 1- a t D 'a nora 1.1, pP. 119127
i6) I'P,\, P 26 lsll"ndch'n'
Pietro, S. Paolo e S. Lorenzo,,. È ovvia,ncnredifficile stabilirc quale possa essere stara la funziore Jclla r \ie.' r.l ,o e. rare - irJirrzzarepotenti evergeti; conunque Ì impressionc, perquello che la desolanre scarsità di dati o consente di dire, è che quesre à!ti!'ità assisienzialisjano state, per ruto il \ secolo, gesrire a livelloprivato dall'aristocrazia senaroria, e che irr esscuna secolare tradizione di evergetismo si lcgasseaìle c'iger ze sp rilLd.i . rF"( d"l c-:"riane.in o.agli intenti celebrathi delle nobili casare gentili-zie. Nel caso dello xenodochio degli Anici, adesempio, sul quaÌc la docunentazione ci con
PtLLtr(;RINI. SLNAIOI]I L PAPI
!)t::l
iitl
f.. I Localizzrzi.iÈ Jerli rd'aJó,nr noti x Roma ddlc bnri. I .um{i sì iferncono alla tabelh ! ! 2l-1.
'i
.t
EJ
L
a
sente forse di fare un po'píù di luce, 1a stessasccÌta dell'area in cui impianrare il complessoi.\jstcnziale. drsarrc 'ia dar 'uoghi verer;ti coggetto dì pellegrinaggio sia dalle srrade di ac-cesso alla città, ma in una zona nella quale sonoresrimoniati altri interventi di membri della.re"sa lamiglia. sembra .e ìz rlrro da doverv artribuire agli intenti celebrativi della gezs. È si-gnificativo che i fondatori di qvesti xenoLiachitlprovengano dalle principali famigÌie, per dignità e ricchezza, della aristocrazia senatorja".Fondazioni di questo ripo si pongono evidente,rrrre al livelo piu alro r a c ari\irJ e\L.eeri
216 nraa^n|( ) sn\ !'\\(r.u vnlEìiziN!
chc intraprese dai clartssinì deÌ I secoÌo, con
rna forte ricaduta in termini di prestìgio' di cui
le ioerboliche lodi di s Gerolamo a Pammachto
. fabio a e I scrizro re Ji l.rr*o re zol""ln ei
lfasmettono una lontana eco
N,.rlla si può dire sull'organizzazione di que
sti enti. ancie se è estremamente probabile che'
rÌl arro Jclla loro i5rrtLr/ione : fordaro-i s siano
Dreoccupati anchc di fornirli di rendite e pro-
pLietà per garantirne I'efficienza, così come, ad
esempio, ci testimor,ia Palladio per.i monasterr
fondati da Melania e Piniano' pcr rl cùl mante
n.r.c rro la Pr.drgc copoia '.r[o. J'lla rorale
alierazior. Jci pr"p iL.r'ipo'seJ "renti ir si-
cilia. Canoania e Africa" A tale riguardo non
è forse casuale che. come sì è visto' negli ultimj
anni del vi secolo lo xenodochio dei Valeri
avesse delle proprietà in Sicilia (o comunque rr-
rcr di..*e.i' di e's" J.i dirlri': ron st ouo in
iatti escludere che i tre fwdi contes; fossero
stati lesati allo xenodochio dagli stessi fonda-
to.i. . iu......o parte della sua dotazione orlgl_
naria, in considerazione dell'esistenza in Sicilia
di vaste pfopúetà delÌa gezs Valeria"Asli inizidelu secolo, con Ìe tre fondazioni
subuÀane di papa Simmaco, abbiamo per laprima volta tcitimoniato LLn intervento diretlo
.t"tt. ,-h.-, di Ro-la nc' crmpo Jeìì asrs erza
,.enzacaqreagli srr,rieri oo'eri \ul rsi puo
dire della consistenza di questi enti, né deJ mo-
rito L,e il ulalL il brogralo npicghi per Jefi
nnl ul re rn rc, pt p 'l'u: Lab n'tla 'hesalvo errorc, mi sembra imPiegato solo in que
sto caso. L'atipicità del nome potrebb' forse
rradire l'incertezza ne1 definirc delle strutture'
degli cnti assistenziali gestiti direttamente dalla
Chiesa. oer la quale mancavano a Roma esempl'
e quindi una ierminologia definita È difficile
staÈilire il motivo per il quale la Chiesa abbia
17) Secoido ZÒsio, Vl 7, 1, gli Anici leso l'ini2ìo deL
r secolo. crano .ddiitÌùu i soÌi rimastr ù Posscde'c Ùc
sentito l'esigenza di entrare drrettanenre n.Jn'oo nellorsarizza,' ioce d.lle arrrvrr 's'i.,.nii"li in utr .o-.ttto in cui l'aristocràzra sc
natoria, a cui finora questo compilo era slato
den, andaro, è ancora (benché orlrai per poco)
,l s ro po.ro arla g..rida dc lr crlr' Sr ;otrebbeipotizzcre ..rn; .on rdlio'F lìcL drll\lla <\crge
tica della nobiltà, consesuenza forse dalla per-
J ra dei p anJ l a rirr ' Ji' oca'i nell' o-ovir-
cic. e particolarmentc in Africa, ormai in mano
ai barbari, oppure una preferenza accordata da
gli e'crpet o:i'ari /g irene ìli ,r alizz;rr n'rqurfliel| !er rr.rli del'a irr.r' .5c,'r.bbero go-
iuto evidentemente di una maggiore 'visibilità',
e .rpp:rriuno or indi piu raz.onaìl ir rrr ot'i'amirante al conseguimento del preslglo socla
ìe derìr'ante dall'atto benefico Fin da quesro
prin-n cr:o s c\ider/i, int,r' i quella c\e tcra
i,n, delle cararr.-i.ri,he dellc ror'dazioni porri'
ficie, che le distingLre da quelle dovute aÌl'ever
setismo aristocratico: la razionalità della loro
i'n,alizzazione in relazione agli itinerari e alle
mère dei pellegrini.Più difficilmente collocabile il caso dello
xenodochio in via Lata. È ptobabilc che Beli
sario abbia voluto riallacciarsi al tradizionale
evergetismo della aristocrazia romana, ma lo
,t."sà fono .h. la notizia ci sia stata tramandata
rel r biop a'ia de' p,pr r""'" .\' la lurzione
della gerarchia ecclesiasiica dovette essere rn
oue5to Laso r ero r drgrnrle d qudl'^ dr(vrm^ruDDo(to De e /rlrc ronJ,r/iori di prirat A
ou.'Lo 'i deue for.e il tar".l-e la coll"cazionc
ie o xenodochio appare anche qui razional
mente collegata alla sua funzione, sorgendo ner
pressi di r,rnì delle principali vie di acccsso alla
cltta.Da que.ro noncnro in poi rurri g er r' r'
sistenziali di cui ci rimane notizia sono dovuti
| -ll
t8) P^LL^Dro. H,!r -I-r,r. 61
791 ^.
C^ùNDh'.r tr |Lr, Ftlotolnar L' ulk dt Pid'rAflìúí,d,Pa],etno 1982. in Pdr PP. 1148.
-til 211
rd iniziàiiva papalc. Come ci dimosrra I'ecce-zion!ìe documenrazione dell'epìsrolado di Gregorio lvla€ino, questo non significa la fine delle<lonazioni dei privati, ma esse appaiono qualìtarilemente diverse da quelìe dell'aristocrazia delt secolo e, specialmente, diversa sembra esserela firnzione della Chiesa. Qualitativanente ctre.F. f,oiche oudsi sempre .r rrar.a orc di la.cirr
reslamentaris: l'evergetisno inteso come liturgia caraneristica della classe egemone della so-cietà e funzionale al mantenimento del suc, ;,restigio ha Ìasciato il posto aÌla beneficenza desti,nata a garartirsi le preghiere per la salvezza del-''"nima. in u1 oli, d che porr.mn-o Jefiri-e grapieDamente medievalc. Diversa la fìrnzroned.lla t hiew..he aop;rc ora serìpre co'ne rntermediaria tra il donatore e i beneficiari delladonazione: quando, nel 599,lsidoro, uìr inlu-s1rts ,?elnoiae, las.i^ :una somma per la cosrrìlzione d: uno rerodoc\io a Palermu. t regoriod, Ji'po.izion. rhe. qua ora la .orpl p6n .'sultasse sufficiente per la cosrruzione di Lrn
nuovo complesso, il terreno gìà acquistato e ilder"-o lirn;nerr. \.r \.er^ Je\olur al preesistente xenodochio di S. Teodoro',. È evidentel'assoìuta discrezionalità della gerarchia eccle,siastica nel gestire i fondi messi a dísposizloDedai privati bencfattori, i cui desideri riguardo ladestinazione degli stessi rìnrane a livello di unmpegno morale non strettamenle vincolante.L'intera organizzazione assistenziale appare oraconcentrata nelle mani della gerarchia ecclesia-stica: in un passo della vita di Gregorio Magno
di Giovanni Immonide!:, di cui Jean Durliat hafeccntemente rivendicato l'ìnportanza",, gli xanodocbia appaiono tra gli enri per il cui manre-nin_cnro il por rellcc vers, qullro rolr. lannouna somma stabilita, e in un alrro passo deÌlastessa opera è esplicitamente affermato che ilpapa sceglieva personalmente gÌi amministrarondelle diaconie e degìi xenodochi!!. I tre di cuiI'Epistolario ci ha tramandaro il nome sonotutti e tre ecclesíastici: FLnentlu: diaconus delloxe a.lachiutTl Anicbíontntr', A tanius subdiacanus pruepasius xenodachìun Valetií"n e un Crcscens diaconus, di nn non nominato xenodochiodi Palermo". Credo che sarebbe un erroreproretiare questa siruazione troppo indietro neltcmpo. La presa di possesso da parre dellaChiesa di Roma dell'organìzzazione assrstenziale deve essere probabilmente considerarauna conseguenza della fine, come classe sociale,della le.chra ari.roc-ar.a ser aroria, ed es,er.isviÌuppata, favorita da1ìa posizione preninenteche la legislazione bizantina riconosceva al ve-scovo, nel corso del vr secolo.
Nonostante questa dipendenza daÌla gcrar.hia ecclesr. vi.a. daìl "pi.toìario di C.cgorioMagno gli xenodochi ci appaiono dotati dr unafigura giuridica individuale e di una anpia au-tonomia amministrativa !3; essi dispongono diproprietà e rendite|!. ricevono legari reslamentari'", intenrano azioni legali,,. Fuorviante sa-rebbe luttavia voler assimilare a questo modellouna situazione che doveva presentarsi variegau,con tradizioni differenti nelle diverse regrori
E0) Grc@tuo MAcNo, Ep lV. 8j tX. Iti lX. 8r IX. ó1jx]lt 28.81) GRE.oNo lvL(i\o. Fr. lX. ItÒrì i D ^r urp!o./ \"to^1 u-a ll )4 ".I P Nlr!,tr. lL Lx\V .oll q6q;)8l) DùùL\r. at. d/. a nora 62. pp. 16t t6ó.6l L .\ D , ' ".,..Utp .t.t l, ,.d| | V, \ JJ . \,\V ., I t O.-/!.. ,. ",,,p./.,.,.,,,. p,
Ìeí'nililt Chliri GtromMirsh .ti.ca"n\ ".t x.nodaciii,
..-ù' Jot J,Ì.n t,-. l tt ..l .rmrn ,-,.no, ro d , i , (.! ro u-- ;. , ",.'t.p.,, ' ."" ,.";.ro ho ,. co.p- Jl ..,Iod., v.tr.i /p t\ .Ò. \
82)
8t) tp. lX 8.86) Ep. lX. ó6; LX 82.87) llp XllÌ. 11
88) Taito ch€ Grcsorio consìdcmvr le capacirà Dc$e iimostra Dell'anministrare uno renodocìrio ùn buoi titolo perspirarc dlìa carica di vcscovo di Pd.mo (8. XlIl, 14t
89) À/, lX, 66i lX, 82 (prcpdelà i. Si.ilia dello x.,o/,chi"n vdklii\t IY, 8 trtuedi"h di DroDrì€rà dello re,o.1o.chi,tu TLÒ,ùe àì CxltiiJù \x, l7o {;asìa di prop età detÌoMadÒ.|Jiùn ld,cti TbtÒd.ri dì patermo| l. 12 (reDdtrr !oI)ane lello xùiotlo.htnn A,i.biotu,i).
90) E?. lX. 8i lX, 6l91) Ep lV,8; IX,66ì lX, 82.
218 [1b]
dell'Occidente. Sempre s. Gregorio ci dà ad
esempio indicazione del caso di uno renodoc\io. lo 'daro ;d Aug r.roJurun dalla -ecin.r
franca Brunigilda, annesso ad un monastero,
dal cui abate dipendeva". Caso isolato o relitlo,in una area rrlargìnale che conservava strutturedi tipo pirì arcaico, di una fase in cui i servtrassisrenziali erano gestiti dai monasted? Betlo'lini, come è noto, ipotizzò proprio questo per lepirì antiche diaconic romane"', e d'altra parteanche da altre fonti abbiamo notizia di assl'ser.,a agìi inJigLrr erogrrd d.1i Inonacrc'i Lr"
brrr \on abLian'o ne.-u rz irdicazior'c po'i.tiva di una organizzazio|tc di questo tipo pcrquanto riguarda i nostri xenodochi più antichi,atchc se la contiguità topogrdfica e la continultà nell'intervento gentilizio che ci è sembrato diindividuare tra lo xenodachium Anichíotun e ll.\r1o'tau-/n "1 Bott.a.rn 'quio't .i voglir r..cenare la mìa identificazione di quest'ultimonel compìesso altomedievale di Largo Argentina), può forse costituire un indizio in tal senso.
Dopo Gregorio Magno, per quasi un secoloe mezzo, non abbiamo più nessuna menzione dlxenotlochia a Roma. Questo silenzio delle fonti,certo dovuto ìn gran parte alle carenze della
ro'rr, doc'r n.nrazion. Jcrc perrlt-o ri5pcc_
chiare una reale decadenza dcglì istitutr assr
stenziali. Quando, inÎatti, i\ Liber Pontificalison d d pJ- ,rre dr xenodochi rc- gia citato
passo della vita di Stefano II, troviamo che iqu^rtr(t xenodochía esisrer,rj À <dlulur is et lafi'giquis temparíbas destit ita manebant et inordihata>. Si rr^tra, con ogni probabilità, degli
stessi quattro istituti che troviamo, circa círquant'anni dopo, menzionati nclla biografia diLeone lII, gli xenodochia Anìchiorun, Valerìí,Tuclun e Fìrmis. Ad essi si deve aggiungere,come ancora esistente, Io xenodachtunî s. Petì,al quale si fa implicito riferimetto nella vita diptpL lacca ia ,,,11 ,.2\ ma .hc n^r p:ofientrare tra quelli restaurati da Stefano II, inquanro I L.ú.' Po?,/r.r/\.pe,ifi.d f\( quc.lerano tutti e quaiifo urbani. Si sono inveceperse le traccc dello xenotJocbíutn tle uìa Noua,forse a causa dell'impaludamento della valÌe trail Celio e il Píccolo Aventino, che di lì a pochide.enni,rLebl,. cost-etto leore TTT a lar ricostruire ex zoao la chiesa dci SS. Nereo e Aclilleo Srn-h-a d,r q re ch. ,lncno rell, r,'n,mrra Jcl \ | .ec.ln lorgar i.zaz.onc a.ri.ter_ziale della Chiesa di Roma abbia subìto unagfavc crisi, che è difficile non nlcttere in rela-
zione alla crisi economica della cinà causaudalla rottura delle reìazioni con I'inpero blzan-tino e dalla confisca delle proprietà sicilianed.lla al iesa r(gL n r ,r cnnresr .ullo qucstion.del cLrlto delle inuragini"'. Non è forse casuale
che le unichc indicazioni che I'epistolario diGregorio Magno cì fomisce su proprietà e ren'dite degÌi xenodochi romani, si riferiscano alla
Sicilia, a riprova della centralità deìl'isola nelI'approwigionanenro delle attività assistenziali
della Chiesa rornana. Ma come si spiega uDa
così eclatante attività di ripristino da parte diStefano II, che non si limita a restaurarc g1ì isti-tuti fatiscenti, ma addirittura ne fonda ben trenuovi? " È evidente che tale intervento sr pre
92) Gù(uro M^cNo, fu. XIII, rì XIII, ll.9i) B|úrtrNr,,p .r. a noù 62;confd lliRlt\r,,2 dr'
94) Vcdi il cso sià citaÌo Jel non.rero di S. Stelanomasgiore Lo sorico gr€co Zosimo. fur.tinveso l'asÌio dclp,' ror' ou Lie. . . t.mo ,,. "ìAi,- a, p \"loDsideme ra le dtivitì, rormalì dei moiàsreri (V.21, 1: <t
nonaci .. si sono apprópriÍi dì molte terre e, con il pretesto
di JisùihuùLe ai pov{i, hanio rcso porei quAi ÌuÌttr'95) L P , I, p. 1t5 l7i(hdridt). dót si cirano delle dom'
ziani <.t.upcribr\ d pet.Etrtú .t'i fui bcalln P.hunj lat.
e6) P DELocL, Ld 'Ìa,a
!a,atti.4 .li Ro"D k. úta,Ì.lieo.tu l"tto.1".ia"..L 'e,t"rt, in DD.cr (r cum di).ap..iÌ a rcr!20, pp rr 29 |. M^a.zzl, Il tutflnto tu t..,.tll t.di- t'tnú 1tt. t t Jl .t"Rand. r"ipateti ù ìn.t$tÒh., in Itn-tR. t9. 1991. plJ.
2lr-251971 È Nsri probabile che al'epoc! di Srcfù. ll si rlèri
scano Ìe duc lonule conseMtc nel /-,r., Drrti,r fehtnedlla istitùzionc di xeno.lochi (f.,,r,tu. LXll c LXYII e.l.'lH. S!:KEL, Libu li,ùtrt tÒ"nn11 pÒ"1,Íùq.\'\ntl'bn.ú1889. pp. ó2 6l).
2t9
:rntr come eccezionelc. non soìo quàntitatlvamentc. rìrà à.chc qualitd!;vamenre, qualifican-I .i .or e rn" rera e propria -:organtztatior,c
di rutro il servizio di ospitalirà per i pelìegrur.Gli xenodochi di nuova istituzione sono inianitntì collegati a una preesistenre diaconia, deli.1, al do Lrna ration"litzatiore dc. .enru i as,isrenziali gestiti dalla Chiesa. Viene spontaneocoìlegare l'attività di Stefano lI in tale canrpo aquella che è, piii in generale, la sua attività poli-ti, a. { lui. cone e roro. si de'.., .,rro l.r n-rnaccia longobarda e consralata l'insanabilità dellarottura con Bisanzio, jl massimo impulso dato aqueila politica tilofranca deì papato, che culminerà con l'incoronazione della notte di Nataledell'anno 800. A Stclàno II si deve l'unziore orPipino nella Cattedrale di St. Denis, che diedeil Jeiinirivo :rraììo .ll L,sLr.p,zion. cornpiu a ,rdanni di Childerico, e il conferimenro al rc oerritolo dí paticius, che lo designò quale prorertore di Roma e del papato. TitoÌo non mera-mente onofifico: per due volte I'esercito francovenne in ltalia per stornare Ìe nire dei Lc,rgo-bardi su Roma"r. La riorgànizzazione dei servútdi assistenza ai pcllegrini si deve inserire nelquadro di quesra ricon|ersìone di Roma e delpapato da un'otrìca nedirerraneo-bizantila auna conlinentale,franca. Le scarne notizrc Ìnnostro possesso sui pellegrinaggi ad llnina apo,stolar m ci testrmoniano infatti quasi esclusrvamente la presenza di peììegrini di srirpe franca,longobarda o sasso.e: rrà le iolle che accorrc-vano al sepolcro di Pierro ìe Ìingue germanichee i volgari neoÌatini arcvano senza dubbro ranetta prevalenza rispeco uì greco, tenuto lontano dalla crescenre insanabile rivalità tra lesedi di Roma e Cosranrinopoli. Il culto di Pie
tro costituiva uno dei più importanri legami cheRoma manteneva con le popolazioni del noro, eil principale molivo del presrigio e dell'in-fluenza mantcnutí dal paparo nei loro riguardt.Una ecÌatante riprova di qLrcsto, e deìl'importanza che il papa gli anribuiva, si ha neita celebre Ìettera che la cancelleria di Stefano II inviò a Pipino nel 756, mentre i longobardi diAstolfo cingevano d'assedio Roma, per chiedereil suo intervcnto: essa vcnne scritta coxre sefosse stata inviara da s. Pierro in persona, esortando il re a correre in aiuto suo e <del popoloche mi appartiene>, accompagnandola con mrnacce di dannazione crerna in càso di indugio.In questo contesto ben si comprendc la coe-renza dell'azione di Stcfano lI: ì'inreresse adagevolare la venuta dei pellegrini, con Ia norgar.tt,tttone e lr rrn-rsa in .ifrcr.nzo dei serrzilLsi " ornr-e loro as.is.r,". viere a leg, si rtutta I'azione poli!;ca e pastofale del pontefice,.er d"r re r raiio-2,.e n o.r , n odo r legarr iconlc popolazion dc.) Lu-op, scrr.r'rrior,le c a incrementare, con il cuÌto di s. Pietro, iì prestigioe l'autorità di Roma e della sede aposrolica,'.Se, due secoli e mezzo prima, papa SimmacoJveva cLtLanil-ìJmenrc di., rihuito i .uor parpot rr t abì'a. ula rrJ rrc .an u. -, subu b,n, prirvenerati, ora Stefano II concentra le sue fonda,zioni a S. Pietro, divenuto ormai la mèra pnvr-legiata dei peìlegrini, e quella di cui vi cra ilnagg.or rn ere5.e a dif o rder. la rer er"., iorrin qud,to tl.r.non:,r1za del primcro Jei ve-ov:d'Rora. Olr-e rìlo:,er od",l"in Ji eregor,cMagno e l Jue di St.tano ll. pchi decernidopo si venne ad instalìare nei pressi della basilica Vaticana anche I'hospitale fondato daLeone Ill zr naumachia. Oltte a quesro gr uppo
981 O BERrolrNr, Raz, ,it I'tate r Bnhzia e dì Lo,rob.tdi, Bó]lEn 1911, prd nÌr 51t.t8t
99) In qusro reso.ó.re$o di rioGanizzazion. e diin.crcmenro d€i sÙvi2l di ospiraliri pe. ipellesrini sideve f.^€por€ aich€ Ìekbóiizioie. negÌi i.ni imn.diatahenre seglenti al pontilicato di Srelìio Il. dell'iriiemdo del C.lc:cúr.1r,,tr r2ó. In eso va \isro uno srNmenro etabu,ao a
Roma, con osni probabilirà in ambienii uificiaìi, destinato aìpeilearini e Ìesato ai servizl assi*enzidi d.Ìld Chiesa. A(únoqù, solo r querto eccezi.nale docunìcnro, sul luale conto ditornare approlondit,úenre in rÌrm sede. Sul c.d. Anonjmo diEinsiedeln dr ultimo c. N/^tstr. DE Eih\i.dl.r l"rntat!únnl"sE,,'l dù Prleeúhtú l,rch Rah (CÒtt* Efteedt."i^ )26), e Hnhtit 5)), Strìftsùt 1987.
224 RIL!,\|iDt, s,\\1,\. ( l \1t\z\Nì f18l
vaticano, uro sguardo alla carta di distribu-zione degli xexodochía nostra con chiarezza Ìa
loro concentrazione nel settore nord occidentale della città, in funzione della basilica di S.
Pietro e della via Flaminia, e quindi dì visrtatorrprovenienti quasi esclusivamentc da nord Dcgliunici due istituti localizzali nel settore meridionale della città, lo xenodochiutn dc ria Noranon sembra superare 1a crisi dclla prima metà
dell'vn secolo. Non credo si possa considerare
un fatto casuale: se Stefano II non ritennc ne_
cessario inserirlo nel suo programma di rrprrstino del seNizio assislenziale, è evidentementeper la scarsa inportanza che la via APpia do-
veva ormai rivestire per il rraffico dei pellegrini.In turta la parte meridionale e orientale diRoma, l'unico xenodochìo esistente ormai è il'fucium, legato alla residenza deÌ Laterano.
Come si è già avuto modo di dire, nel cata-
logo delle chiese di Rona contenuto nella biografia di Leone IIl, sono cìtati gli oratori deiquattro xenodochi esistenti: Anicbbrun. Vale
ùi, Fitmis e Tuciun. Mancano i tre xenodochifondati da Stefano II, ma questo non deve stupi-e. ncl c,raogo. intani. gli renoJo.hi r,'nsono elencati in quanto tali, ma solo per identì-ficare i rispettivi oratori, ai quali viene fatta ladonazione del pontefice. È evidente che quelliJr ruora ionJazio re sono considerzti as.icnealle diaconie alle quali sono collegati, a dimosLraziore de. a loro m.,r' arza di aur^r^mia an'ministrativa. Questa nella biografia di Leone IIIè I'Lrltima menzione, ne1le nostre fonti, di xcno-dochi in attivìtà. È probabile che, con un processo paralìelo a qucllo individuato per le dia'coniei!!, essi abbiano visto, ncl corso deì u se'
co1o, svuotarsi e decadere la loro funzionc assi_
stenziale, alla quale soprawivevano i loro ora_
ror:, de.tinal r drv.ri-e dell..hr.te a.e *,nri.in qualche caso tunora csistenii. L'unico xcno_
dochio che sfuggì a questa sorte sembra esscre
il Tuciun che, se è valida I'identificazione pro-posta con il ucnerabile ptocbiutn latennense,manteneva le sue funzioni assistenziali ancora
nel xtr secolo, mentre del suo oratorio dedicatoai SS. Cosma e Damiano si sono prccocementepcrse le tracce. È posslbile che questo dlversodestino sia legato alla sua particolare loca[zzazione in un'area prir,a di altre struttute assrsten_
ziali, mentre nella zona di S. Pietro il scrvizio dio.piulir" per glr .r-.rrr"-i e i pellcgrn è o,n risvolto dallc qu,attro scholae petegrinorun deiSassoni, dei Frisonì, dei Longobardi e dei Fran, hi. la .ui prrr r rerziorrc c c.rrerrrra. in tignificativa coincidenza con l'ultima notizìa suglixenodochi, nella biografia di Leone lll "". Questi cornplessi si dovertcro costituire nel corso
dell'vrrr secolo, divenendo punto di riferimentodegli stranieri residenti o di passaggio a Roma,
e sostituendo così g\i xenoàochía pontifici nelle
loro funzioni assistenziali ".
.1. Un aspetto che nelle nostre fonti sr-rgli
xenodochi è lasciato in ombra è qucllo del tipooi rs. s.er /a .hc r ven'r.r prrricdtu. Spe.\o \i L
anche una certa ambiguirà suìle funzioni diquesri istituti: erano specificatamente deslrnatr,
come vorrebbe I'etimologia, all'ospitalità agli
'rr:rie- di pas.aggo, Ron ". irr p.llcornaggioo per altri notìvi, oppure più genericamente al
I'assistenza agli indígenri, non necessariamente,
o cs(lusi\ànenre loresrre-', Cli *..rd o'i rno
100) BLrtuLNr, rt ., . nota 62
tor) Sulìc.!.loldd Pa.Ei"ot,n ck \v. D J CtoxE.''? L tol P 'F tr
Drhlì,R.,. L, t89a, pp.94106i105 117ìL DucrFSNE, N,1.' lar la lÒpasa?hic L RÒ,'e ., Ma!e" A!. Vdhú,r tpIII), i Súipî. Mì"ora (= CEFR ll), Ronra 1971, pp l14 rrl i
c i. lroocE\yErú1., [email protected] Frunhcn en Sakw te Ro,nt tnM./elRo,,. lll. s. V, 1917, pp. I 70. A. NL Cìu\rELLl, .tldr,,ùi!tid".. ciîtà aho,'./1ieuk,\n AtÌíVl Ca"sr.e nttu"dta
r.l. ,11 Arheohrio Cl,ìrr,,, RoDa 1986. pf 109-125: l-C^ss^NLt | 1. (;ti i,rtlidnu t
"ot.li.ì ì" bory. h al\lu lÒ ù
ttihÒrtr," e ld utt.h.. leí Cúoliiri t À,,r,. D Ar\\ 'Rofl. t l.tù .ú.lin!ì., RoDa L97aJ. Irp 21t 22:
102) GucLrEL\o Dr }hrtirsBriR\ C.ihl P't'ttrx \tElÒ'za: fed. Stubbs. I, LÒndot 1E81. p 109i. r..rdr l. conru,ione Ji u.o reno.lochb di trrc .1el rc Otl! lll llcrcr Del
lìmbno della Jrlotu tarora,r iellìin. 79r. CsrirL. ,t dr. r
ir',1
derni h.ìnno a vohe complicato ancor più ilproblera. iponzzardo an,le cna r...tcrrzo:r,malati, assimilando quindi xenodochi e uoso-comi '. Nessuna rorizia a nostra disposrztonearrlla in realtà quesr'uhima ipotcsi, peraltrocrrdenlelrlente inoppor.tuna anche da un punrodi yista ;gienico sanirario. S. Girolamo ha benpresente 1a dìstinzione tra xenodochjo e rosoconio, e non solo impiega le due paroìe distintamente per definire le fondazioni dovure all,e-ycrgetismo di Pammachio e Fabiola, ma neÌpumo caso si lancia in ura seric di ardite ncraforc incentrate sul tema de11'ospitalità, menrrenel secondo dà una Iorte descrizionc delle sof-lerenze dei maiati ospìri delÌ'isliiuro. Diverso i1dÌscorso per quanto riguarda la possibilità cheI a'.isen,a .i n' olpis.e r r.lri rali rJ,gcnrr. .rdiocndelenr,.r'e drl .a r" .c fos.1s 51 ,n,.r,orrpu-c no. InJi-uibrlrnene lo,p,rrlira per r
peìlegrini rappresentava il modvo principarc, ravefa ragion d'essere di questi istituti. Lo sra adrmostrare, come si è r'isto, la localizzazione digran parte di queìli di fondazione pontificia,chiaramente connessà àlle nète dei pellegri,raggì. Varie indicazjoni, tuttrÌvia, sembl.aro re-.I.mo ìrrrL Lr'rJ ccr" . i"rrìir.t Jr qre.r LrirrrriGià la definizione di ptupeifus habitacaÌausata dal biografo di papa Simmaco per definire i complessi da lui fondati sembra indicareuna desrinazione diversa da quella della sempìice assisteDza ai fbresrier.i. anchc se la localizzazione nci pressi dei santuar.i più venerati fa ritenere che rra i lor.o ospiti non dovessero mancare ì pellegrlni. In qucsto, come in altri casi, la\'rnpl;(c Inen/,one di r,ureri .Lrrlr. an,L,igrain quanto può rifefirsi ranlo a indigenti localiquanto a stranieri privi di mczzi dì sostenLam€nto r'rr. Meno dubbi dovrebbero essercr Ir,
,l9' q rt''.lo.li _.r ' ,.i .a! .,r., -\..., o-lieB,,, o
Daraù ...,i LLc.r ùNr, ,r d/ r ioh 61, si dfernce allo xenododìio /.,2
^b,r dlrctÌmcùe cone<noso.ohio,
l04l Vedi !d erD,pò cru(iùr) Nlrc\o. Ep. ìX 6r:
guardo allo ptochíLo istitùita da Pelagio IIneìla sua casa, in quanto ìa specificazione cheesso fosse destinato pauperun senun seml:raindicarne una destinazione diversa sia dalì'al-bergo per stranieri sia dalla gcneríca assisrenzaagli indigcnri. L'introduzione di questa [.onte1(l no.r-^ Jo5\ier. r,rrari:. c r..a probl<rn.rrrc,dai dubbi sulÌ'identificazione dj quesro compÌesso con lo rezolorÀ íLm Tucian ptocbimt ldteranetlse. Le fonti dalle quali questa versarilitàdsulta e'.,idente si riferiscóno, forse non casualmente, agli ultimi xenodochi pontifici, queÌÌo rzPktana e qucllo in Naunachia. Di quesr'r trmoiÌ Liber Pontificalis affcrma chc fosse dotato <tr<graedia... urbana tel rlsticd pla alìmaniis Chn.stl pduper n seu drlLení! uel peregùnk>; àelrprimo iì biografo di Stefano Il ricorda l'rsuruzione, contestualmenre alla sua lbndazione, dirr se-rizio che garar rir" giorr,lnr.n e rl r irro ocenro paupera/n CÀ,írli. Quest'ultima norzrarno\,rJ una n^.e\ole rrlinira , or il rpo d: a.s,-stenza che veniva praticata nelle diaconie cpscopalir ', e non va dimenticato che arìrbedue lefonti riportate si riferiscono agli ultimi xenodochi pontifici notì, successivi alla riforma di Ste-fano II che, come ci è sembrato di vedere, collegò strenamente xcnodochi e diaconie. Una\crrl, \ovrdpposi,/ior< r' . Jue ripr di e r i .r,sister'ìziali deve dunque essersi verificata, anchese è impossibiìe dire se si sia rranato di un fe-tomeno derivato da1la riforma di Stefano II ogià precedentemente manifestatosi. Che una or-stinzione tra i due tipi di jslituti si mantenesseanche in quest'uÌrima fase è tLrrravia dinosrrarodalla stessa notizia del Libel Ponttfìcalis, cheror parla d' un d'nll.drne ìto o pn enziarrerto
deue n,Le\i.ren,di,,or.c. rr r.o.,ili,a che adaicunr dr csse. clidtegicamÈntF di.locrrc ri
221
' .Brxt.., p, ..nn,a. . d.,. .H"...o...,..o
.t oa p...5, . 0,, ., 1 Jr .1 t ., ,. Do.r/att^ herentlùt \ \,ae pd,L t, dliqt,tq Je,.l,ak r
105) B.nrÒLiu,,p .r. a noe 62
222
spetto agli itinerari dei peÌÌegrini, venne ag
siunto lo xenodochio, che doveva quindi man
t"n.r. uur.uu specificità. È evidente che laprincipale differenza tra le diaconie e gli xeno
dochi è rappresentata dal fatto che quesri ultimidovevano essere dotad di dormitorì. Gli altriservizi, quali il virto, il bagno, di cui è stata
rn*v r lr,e lirponarzai eIa'si'trnza'piriru.,le. porcran. ..serc si nil. d quc- i drlLclinelle diaconie, e nell'ultima fasc forse unifìcaticon quesd. È qr.Lindi probabììe che l'attività as
\irren/idle s\ol , dagh rLrodochi b"e arti.o-lata e forse diversificata: per gli stranieri doveva
esserc previsto I'alloggio temporaneo, instemc
con il l'itto e i servizi acccssori, menire non sap_
piamo sc in ogni momento dell'evoluzione diquesli istituti o solo nell'ultima fase, quando ne
abbiamo testimonianza, era attuato anche, in fa_
vore degli indigetti, un sen'izio sul tiPo diquello svolto dalle diaconie.
i. La traduzionc dei dati forniti dalle fontiscrite nella realtà architenonica degli xenodochi romani è purtroppo impossibilc. La cono-
s.er.,a archeo ogi." Jei lo-o r'.*i c ini"rrr qua'inulla, se si eccenuano gli edifici di culto, so
prawis:uti allà fine dell'attività. assistenziale, e
ìn qualcbe caso tutlora eslstenlr, ma che poco
aiutano a fasi una idea dell'articolazione diqucsri con]plessi. Dei tentativi di identificareion lo xenàdc'chíunt Pamnachii un srande edificio di Porto e con quello dc uìd Noua alcuniinrerventi tardo antichi nelle Terme di Cara-
crlla.i i ga derro.oo a Parland" di questi sti
tuti, ed è inutile tornatci. Per un allro com_
plesso è stata proposla I'identificazione con uno
r,crodocnio: .a rovJd.rra ba. ca c-isti;nasul decumano di Ostia Antica (fig. 4) '". Benché
tutt'altro che certa'", l'ipotesi merita di essere
analizzala. L'iscrizione posta sull'architrave diura delle portc delleditici". rr rrìr'orrìre i
quattro fiumi del Paradiso "'', lestimonia I'ap
tartenenza dell'edificio, databile sulla base
della recri.a cdil zia r-a le rine del rr e i prinrJccerni dcl ' .e. olo , r un.ì Lon_unllà '"rstiana. Esso si conpone di tre ambienti (G, L,F) che si aptono su un portico colonnato (A), a
II(.C^RDO S,ìÀ'îÀ\GELI \JALLNZA\I
r
sua volta aperto su un'area scopcrta (D)l dalportico si accede a una piccola aula absidata(B), mentre dall'area scoperta, tramite un pas-
saggio su cui è l'architrave con la citata rscrl_
zione, in LÌn altto ambiente absidaro (C), nclquale è presente una vasca semicircolare LaHeres ha supposto chc le sale absidate C e B
120l
Ii1
II.]II
+
frc..l Piùnra delh cosi.ldeilr "b.silicJ ùsridr" di Orú1dr HLtLs)
211 22)
lossero destinate al cuì!o, nentre ; rrc anbienriE. F c C fossero i dormitori. L'iporesì che nelconplesso sia da riconoscerc la sede di una rsuiLrzrone assistenziaic mi sembr.a senz'ahro pÌau-sibile. L'unione di una aula absìdata con unrDìbicnte dotato di vasca richialra fortcmenre. r-.1 . he ."pp.arro dell. po.reriorr J.acori. romane, nelle quali era sempre presente un oÌ-aro-rio e un anbiente per lI /u:;ma, cioè il bagro,che costituiva uno dei principali servizi svoltoda queste istituzioni, ricco di valenze simboliche c religiose, oltre che di una evidentc finalitàigienicaiLr; non è neppure il caso di sottolincareIa congruirà con questa destinazione dell'epigrafè che ricorda i fiLrmi del Paradiso e rnvrraad <accedere alle fonti dei Cristiani>. Se quindiI'identificazione della <basilica Cristianu conun complesso assistenzìalc sembra convincerre,dubbia mi sembra invcce ìa possibilità che inesso sia da riconoscere wo :;enodochium. \ ttepresunti dormitori, infatri, si atfacciano direLLamente sul portico, con una aperrura larga l'in,tera parete e due colonne a reggere l'architrave.E evidente che una sinìic erchirertula appareassai poco funzionale per uù doùnilorio, praucamente inutilizzabìlc nei mesl in,.ernali. Moltouiu logi,o perrl'q,r.e,,r e.!i d-bren .<rvissero invece per Ìe ahre lrilità chc, sempre con-tinuando ì'enalogia con lc posteriori diaconre,venivano svohe da questi enti assistcnziali, ìnparticoÌare per la distribuzìone del vitto. Nella<basilica Cristianu su1 decumano di Osria an-JreLbe ùLrrdi rcnro.c.r, ura pre,,ios.r rcsri-
nronianza di quelle più antichc diaconie, di rido.r. drn'crr.ionr. chc prec.dono l.r .reazi"r.delle grandi diaconie episcopali aftomedrevar,suÌÌe quali ha richiamato l'attenzione il Dur-liat''.
Degli xenodochi romanÌ, come si è deno,non sopra\rvrvono, ne sono documentate, strutture se non relative agli edifici di cu1to. Neppure le grandi demolizioni per I'allargamento divia delÌe Botteghe Oscure hanno messo in lucestrunure anribuibili allo xenodochiun Aníchìo.rum, o alneno non ne rimane documcnrazionerr'. Nel 1941 tuttavia, Lìn cavo aperto neìlaJDpFr,r,rfal, rir d.ll. Borreg\c O..ure mr.cín luce una parte dell'abside, rjcosrruibile conuna Ìarghezza di m 6,5, e dcl muro di fondodel"a rtr.".hiesa dr \ Lucia. Dr qr,csro rirverrmento è coDservata in copia ncgli archivi dellaSovraintendenza Comunale alle Antichità unascarna documentazione, consistente in rreschizzi di mano di Cuglielmo Gani corredatida al.urr .rpounri 'trgg. r. h l".rrr-rrrrr è
costituita da una fondazione in <blocchi di tufoirregolari,', su cui poggia l'elevato, costruiro (a.onrrra rarda-. Dagli aopunri .ernb a d. capire, \e ' b occlri d' t"rdazion. dell ab.ide p"ggrc,s€ro su terra, menrre quelli de1 piccolo trattodel muro di fondo su dì una fondaziore cencntizia. Benché sia certo azzdrdato trarrc conclu-sioni da così pochi dati, tuttavia l'uso della recnica costrlrttiva in blocchi di reimpiego per lefondazioni costituiscc a Roma, conìe è noro,una caraneristica dell'architettura d'età carolin
106) !rR!, r\r, ,, d/ tr nola 62 pt j0 tt.r07) T. L llr:k.!. )l.ut qlntt nllt "Bilitnr C"i
\lrtht, tL ort. 11"1\,. ]n .\1ù LJt?,,,. XLII. n s 7. lr8o, trp
108) Ripo(dd ùhrÌi ùn mol, Jùbbt neipii, r.ccnrj h-lori su Osia ari.d: C. P.nL tLt\I. I t itr 4t.l;Jt,w d Aú.,q-n D"l, i"8 . .b" D , -.a I A.. .,o,n. B., l ^o.pt. -r. I BVI Onù tuleaùittiú!.lloD. l9s.l. pp. .lt.19
109) l- inrerprcbziorc piir pl,usible scnbia L XpCúx Finu Ttsrs E Idt lnl ùit\tli.|a11tn ntnjtc fo"t.t.dove il TI nlÌiitio dell. sccÒila ,ier rd Ja considc .e uD
efrcfe del hpicida, che lu ryèruta l^ p^t.h I irrn1a"a/',,scuiÌr M ngd precedcnt.
ll0) lllù, op ., a nora 1o7i PavolrNr, C,'i, ctr a
111) BrRrof!. ap .ìt t tu)ra 62, pti tt)5:t.112) D!RLhî, ot cit. r noa 62.111) Sùi L{ri nr ù dcÌle llotteahc Orù.c Ìì. s^rr^N
c!ù ú]LN7^N, Rnitúìtaati dtbúloAid t, rid B.ucrh.Oúa, in L. CsDr. (a cún ,lit. (;I A"ti drt GaM".n.2r,, Romr 1995, pp 89 9l
ll.1) Archnio G.Ìri, Rjone IX, ni 119.j, 119t.
f1)1CCARDO SANT,{NGELI VA]-ENZ'{NI
,,, 1,. .
:,:' f' ,
:,, :l:I
I
. : .. r.. , ......;.,i.ì
.1..;
' i i .r:;:lirl'';:,
."1-
:,r.',.\I \r 2) \ \:)'.\'. ú" -'. lc;' L 6'f",
,,. tq,t,' :fL .' l,' ', ' r .."1,.Ì .' ' .-r. ,' .' ' ,,'.,, "ì ,l rr
I: {\:l--:jrl ' . ., ':'t,i:ìì:t:::,ì,1:: : t-- -*'- ,,-
.. ',ì
'I
'lr',
i ldi:: r- t--!- i \ -',1 : ' ' .. -, ; ,';
i:..)'f*!{-* , . , \ ., 'r::,t,.:.':,:i:::l ' ., : t,:'i.:::'..'.'':::".,..::ir..,;-. . \. .. - \ .:.i. ,,r,;.:'.. ..:- ,.::i.::ì::',:':: i,..:
r', . r . 8. !\ c,.h \:o dei, x Rjp0rti'7one d'r 'Jm',re
silil:": Yj"'J; ',ii ìU '|n
cri(c1o d"U 'Ò'i'h d ìL
'hiesa dr ! Lu'ra ùc !
l2rl IELLLGRINI sENA'IORI E PAFI
Frc. 6 R.MA Archn,ó Jell. x Riparizione ier conune: appunti di c. crn rchrivi ar rirvcnihenro dclrbside delr.Chiee di S Lucia de Calcam;ir d!.!nte ilalori det 19,41.
225
rorio dello xenodochio, ma a un suo rifaci,mento. La differenza rilevara d, Gafti rra lafondazione dell'absìde e quella deÌ muro dilondo della chiesa, la prima poggiata su terra, laseconda su una ulteriore fondazíone in conglpmerato, può forse indicare nell'abside uru ag-giunta delÌa ricostruzione carolingia, mentre ilru-o di fondo avrebbe -:o.e,o quello piu antico. Non conviene tuttavia spingersi oltre nelI'interpretazione di dati così scarni "..
Della chiesa di S. Abbacito de Militiis abbirrr.o già delro che e"sa sorse, coì1e fecertistudi sembrano dimostrare con cetezza, aÌÌ,in-
gia (2' metà vu Ix secolo) rir, e questa cronolo-gia nor è conrralderra dall u,o di una corrinalaterizia di aspe,ro -rardo... I resri rirvenurr, .rtal caso, non si riferirebbero all'originario ora-
ll'r Vedl d, .l l- o I L ..,.t L.1."a...1pra aiÒ-.e.'1t. '. Eltdto dt L c. l,î""r., if D. V . , . prA L. Za
^. 1.r \r,kA/'.\,'t,.,!c. ,-bd t. po.,d,pt ALÒ Ue-
A,nc . n R. Jtu,. , u \, d.r,J J.. r, 1o,,, /-.tAka M.diaùa lhtia@ (\1.\ t..Òb) ath t,ce tett.rcheato!a,Iirenze 1991., pp. 6.10 óto, ii paricola.€ p. 649, con bibio.
\(i'
J,
226 I{I(I:AIÙO SN\TN\(;IU lNLf, NZANI 1241
teflo dclÌa sala semicircolafe ell'estremità set
rentrionale dei Mercati di Traiano. Secoli diriutilizzazione della struttura e, ancor piùr, i dis.ruui\r rLsJLr-i d.gli rr nr V.rr e T-<nt".hanno fatto sparire ognì traccia dell'edificio. Se
essa fosse veramente dr identificare con l'orarorio dello xenodocbiun yrlÉ'rr, resti di quesl ultimo complesso potrebbeto essere vistí tn atcune strutture che vennero ad occuparc ìa sede
della 'tlJ, c\( cc revr .-a i Mcr..,tr c l.mi.iclo del Foro Traiano"'. Artualmente si con'serva ancora visibjle una strutîur.a in laterúto,poggiara direttamente sui basoli della strada,
chc si addossa al muro pcrìmetrale del ForoTraiano, delimitando un ambiente quadrangolare, e alla quale si affianca un lrruro in opera
vittata, che sembra delimitare un ulteriore am_
biente dalle parcti curvilinee. Dalla documentazione dello sca"o si ricava che il complesso dou, ', c.re.e, :l l orrcnr. Jc -i 'r'erinenro.
r.s,ripI \orservrlo Inr PLr_rolDo e or.ìlai roo'sibile ricostnrirne l'articolazione.
Nella Chiesa di S. Maria dei Crocileri ' ', o
in Trn'io, i rifacimenti rinascimentali e postcriori hanno cancellato ogni traccia della medie-
valc chiesa in SinotLtchrb c, ancor piit, delì'ora'torio di Belisario, c ìo stesso vale per la Chiese
ài S. Eusr'àchio in Platd a.
L'unico oratorio rcIati\o À ùna xenochíumnel quale vi sono resti attribuibili alla fase ongrnaria è qucÌlo di S. Pellegrino. Come ha mcsso
in luce Krautheimer''', infatti, alla chiesa diLeone III è da attribuire un tfatlo di mufonella .olira re. ri.a cJrolinCia ri bloccl-i d. rc n'piego. Anche qui, tunavia, non si è consen'atanesslrna iraccia delle strutture deglì impiantìassistenziali.
6. L'evoluzione ,Jegli xenotlochia di Rona,così come ci è semblato di poter delineare sulla
La*e de e po,le roriz c di cui di.poniam". ripercorre con coerenza le vicendc di Roma tra
tardo antico e altomedievo. Senbrano potersr
individuare alcuni monrenti di profonda trasforrnazione: innanzitutto all'epoca della guerra
goticà, con il passaggio di consegne, alla dire'zione della città, tra la vecchia aristocfazia sena
toria e il nuovo potere del papato. Anche il ser
vizio assistenzidle segue questo processo) e ve-
diamo gli xenotlochìa, che testimoniavano nelloro stesso appellativo I'cvergetismo delle nobiligeztes del clarissimato, passare in geslione allat l- c.r. che d oru in poi . p-co' ' upera .nprima persona anche di increnentare il servrzto
con nuove fondazioni. È probabile che anctre r
servizi assistenzìali abbiano usufruito dell'instaDcabile opera organizzatrice di Gregorio Ma'gno, anche se è facile correre il rischio di sopralvalutare il suo operato, abbagliati dall'im'prowr. r d spon:bilira di Ina cLL(" ondle e ricchissima fonte quale è il suo Epistolario. Dicerto gli xenodochi risentono de1la crisi dcllaprima metà dell'vru secolo, dalla quale esconon,lcnr.: dt,ta tt tnùrdt4ala. Tu rn rvers.onc
della politica romana da Bisanzio ai Franchiprovoca sui nostri enti un effetto sorprendente:e..i dircrgoro ur iFDorrdrle arma ir n-. n" rr
pontefici per prornuoverc, col culto di Pietro, ilprestigio della Chicsa di Roma e del papato.
Non .olo ri.nc futro u r norerole 'for'-o pc r'.pristinare e incrementar-e il servizio, ma dalla
stessa dislocazionc dci complessi restaurati e diquelli di nuova isrituzione traspare chiaramentela centralirà del culto di Pictro e l'ìmponanza,ormai esclusiva, dci rapporri con il Nold. Conil rr secolo nuole folme di assistenza prendonoil predoninio. e gli rrrorlailr'l ledono plogres-silamente perdere l,ì lofo funzionc. Anche mqueslo crmpo, l età carolingia si qualifica comemonento di cernierà tra le ormai esauste strut-turc eredilate dalla città tardo antica e il nuovoassetto della città n,edievale.
116) In considemzione lel f,Ìto chc Ìomtorio di S. l,u, ,",.m , i.r' "ì.,ì ,r. d, L"on_ lllpuLe esdudere .hc cs. sir rato aegiunÌo lllo xcnodochiosolo alÌn fi,,e dell\x secolo. alfiancdrdo o so$ituendo unprec€dente luosÒ di cuÌto.
ll7l l,redne Devo Iindìcùione allìnico RoberÒ À'lc'
I 18) PÙ qùcr\ftina cÌries! KhrirHErÀrERi oP d/ a nota61, l. pp.216217
ll9) KM!Èùùlu( .t .ìt ^ not^ ó1, lll, pp. 175 ll7.