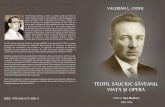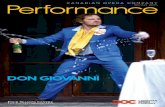Opera magna seconda parte
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Opera magna seconda parte
1
MICHELANGELO:PROGETTO PER LA FACCIATA DI SAN LORENZO A FIRENZE: la costruzione diquesta facciata fu voluta da Leone X medici per dareuna facciata alla chiesa di famiglia. Fu così indettoun concorso a cui parteciparono molti architetti. Unconcorso che tuttavia aveva un vincolo ossia quello dirappresentare una cornice scultorea che celebrasse lafamiglia Medici quali collezionisti d’arte.Michelangelo elabora un progetto monumentale tanto da vincere ilconcorso. Il progetto prevedeva una divisione su due registri, entrambicaratterizzati dalla presenza della travata ritmica all’interno dellaquale si instaurassero delle nicchie con delle statue. Erano previstianche bassorilievi. Sul primo registro si nota l’ordine con la suatrabeazione e la presenza di tre portali che identificano le tre navateinterne. Per il secondo registro, seguendo sempre quello che èl’andamento del registro sottostante, va a creare nella sezione centraleun tempietto sorretto idealmente da paraste su piedistallo. Tuttavial’opera rappresenta un grande dispendio economico considerando anche ilfatto che i tempi di costruzione risultavano essere notevoli. Così dopouna presa di coscienza sui costi e suoi tempi si decise di non portare atermine l’opera.
BIBLIOTECA LAURENZIANA: la biblioteca laurenziana per volontà dellafamiglia Medici, fu inserita all’interno delcomplesso laurenziano nella zona del convento. Lavolontà era quella di rendere disponibili a chiunquegli innumerevoli volumi che la famiglia avevaaccumulato nel tempo. Al piano terra (quello del
convento) viene disposto il depositodella biblioteca, mentre si volevacostruire la biblioteca su unlivello sopraelevato. Per questo motivo bisognavaalleggerire la struttura e Michelangelo decise di farloattraverso l’apertura in serie di finestre e la presenzadi contrafforti perimetrali di sostegno accennati dalleparaste interne. Per la decorazione degli interni dellalunga sala lettura, Michelangelo decide di operare gliinterni come se fossero esterni. Questo prevede quindi lapresenza di paraste che inquadrano finestre, la presenzadi cartelle superiori ed una bicromia data
dall’avvicendamento di pietra serena ed intonaco. Il soffitto ligneo èdecorato a cassettoni. Tuttavia l’opera di Michelangelo nella salalettura molto luminosa (per necessità) non si limita soltanto allastruttura, ma anche agli arredi interni in particolare i leggii che eglistudiò nella massima funzionalità andando alla ricerca della perfettapendenza. Per quanto riguarda l’ingresso alla sala lettura, Michelangeloaveva in mente di stupire il visitatore che si apprestava ad entrare. Il
2
Vestibolo si caratterizza per la verticalità delle pareti, spartite intre ordini con doppie colonne incassate nel muro, mensole a voluta,finestre edicola timpanate e incorniciate da lesene insolitamenterastremate verso il basso. La scalinata, originariamente pensata daMichelangelo in legno di noce, fu eseguita in pietra serena nel 1559 daBartolomeo Ammannati su un modello dello stesso Buonarroti. Di grandeoriginalità, presenta una struttura a pontile ed una forma tripartita,con rampa centrale a gradini ellittici. Si nota come inoltre il grandeportale d’ingresso incastonato tra due coppie di colonne binate siasormontato da un timpano spezzato mentre nella soluzione angolare duecoppie di colonne binate si fondono andando a creare una sola coppia dicolonne, stesso comportamento per le mensole.
MICHELANGELO A ROMA: CAMPIDOGLIO: in quella che era l’antica arx romana dove sorgeva iltempio di Giove, con il tempo si viene a creare un’area deditaall’amministrazione romana. Questo poiché a Roma non vi era una piazzacon duomo e comune come in molte altre città e per tantol’amministrazione viene collocata nel luogo più centraledella città. Tuttavia inizialmente vi era soltanto il
palazzo senatorio e quello deiconservatori che erano inseritisu questo colle che nonpresentava alcuna architetturaper raggiungere i suddettipalazzi. Quest’intervento di migliorare il colleCampidoglio fu voluto da papa Paolo III, il qualeaveva nominato Carlo V (aveva fatto il sacco diRoma) protettore della Chiesa. Carlo che dovevarecarsi a Roma per una cerimonia che si sarebbepoi conclusa proprio sul Campidoglio. Per tanto
il papa nel 1538 obbligò Michelangelo a rivisitare il sito delCampidoglio per renderlo più adeguato a tale cerimonia. Inoltre egliobbligò lo spostamento della statua del Marco Aurelio proprio al centrodel colle e che avrebbe rappresentato il fulcro di partenza per lacostruzione della piazza (il tutto doveva essere emanazione dellastatua). Questa era l’unica statua bronzea antica sopravvissuta e che sipensava rappresentasse Costantino ed era inoltre la statua sotto la qualevenivano svolte le esecuzioni da parte della Chiesa. Questo sottolinea ilsignificato simbolico dello spostamento di questa statua a celebrare ilcristianesimo in un luogo per natura laico. Il progetto prevedeva lacostruzione di una grande scalinata cordonata d’accesso al colle, ed unascalinata monumentale d’ingresso al palazzo senatorio andando a creare unasse principale ed anche prospettico che va dalla scalinata e si chiudecon la torre campanaria del palazzo senatorio. Per progettare la piazzaMichelangelo si trovò di fronte la difficoltà di non avere un angoloretto tra palazzo senatorio e dei conservatori, per tanto cercò di
3
sopperire a questo disagio andando a creare un corrispettivo angolo nellaparte opposta andando a creare una pianta trapezoidale che è resaomogenea grazie all’ellisse della pavimentazione della piazza. Per quantoriguarda disegni, piante, e progetti pervenutici, essi non risultanoessere diretta testimonianza di Michelangelo (sappiamo già da San Pietroche non lasciava disegni), bensì rappresentazioni di un pittore Franceseche conosceva molto bene il progetto e l’idea di Michelangelo. Per quantoriguarda l’ovale centrale della piazza, si nota come Michelangelo lo vadaa modellare dandogli un aspetto plastico per sottolineare che anch’esso èparte dell’architettura (è introdotto da tre gradini ed è più rigonfioverso il centro). Tuttavia bisogna affermare che Michelangelo non riuscìa portare a termine la sua idea iniziata nel 1562 (solo scalinata ecampata di destra del palazzo dei conservatori) e che fu continuata daDella Porta anche se palazzo nuovo sarà costruito soltanto nel 1642 daRainaldo. Inoltre bisogna dire che la pavimentazione fu realizzata nel1929 ad opera di Munoz il quale basandosi sui disegni di Dupèrac, capìche l’unica soluzione era quella di Michelangelo. Per quanto riguardapalazzo senatorio vi è una curiosità riguardante le statue poste allebasi delle due rampe della scalinata monumentale. Di fatti esse eranostatue rappresentanti i fiumi Tigri ed Eufrate, fiumi che tuttavia pocosi addicevano alla città di Roma. Per tanto esse furono rimodellate acreare il Tevere ed il Nilo. Ma perché creare questa scala monumentale?Bisogna dire che palazzo senatorio era una prigione e nel pianterrenopresentava ancora questa funzione. Per tanto vi era bisogno di creare unaccesso diretto che portasse al piano nobile e che allo stesso temponascondesse le prigioni. Motivo per il quale al pian terreno venneutilizzato un bugnato compatto senza aperture, mentre per il piano nobileviene utilizzato l’ordine gigante di paraste. Per il prospetto delpalazzo dei conservatori, invece bisognava creare una seconda faccia inquanto il palazzo doveva continuare a funzionare, mentre per il palazzonuovo, essendo ridotta la porzione di spazio si creò un piccolo palazzocon facciata uguale ma profilo ristretto. Inoltre Della Porta per quantoriguarda il prospetto di palazzo senatorio andò a creare una nicchia aipiedi della scalinata dove inserì la statua di Minerva sebbene forseMichelangelo pensava all’inserimento della statua di Giove. Per quantoriguarda la nuova facciata del palazzo dei conservatori, si notal’utilizzo dell’ordine gigante contrapposto ad un ordine minore dicolonne ioniche al pian terreno. La nuova facciata si doveva legareall’edificio tramite una serie di solai e travi in travertino. Per quantoriguarda l’ordine gigante si nota la presenza di grandi pilastri conparaste addossate. Tuttavia, esse non sono semplici paraste attaccate alpilastro, bensì sono i pilastri stessi che nell’idea di Michelangelodovevano essere modellati a creare una parasta. Tuttavia i lati delpilastro non facenti parte della parasta non potevano toccare latrabeazione, perciò Michelangelo trovò una soluzione nel curvare questiframmenti di 90° per inquadrare ogni singola campata. Inoltre si nota unamonumentale cornice che è sormontata da una balaustra di pilastrini sopra
4
la quale si instaurano statue che seguono l’allineamento dei pilastrisottostanti. Questa grande verticalità serve ad equilibrare la notevoleorizzontalità dell’edificio. Inoltre si nota una differenziazione dimateriali ce vede l’utilizzo della pietra per gli elementi verticali edorizzontali, mentre il laterizio per le sezioni di tamponamento.
PALAZZO FARNESE: questo palazzo didimensioni monumentali (60x30x75) fuvoluto ed iniziato da Alessandro Farnesecome residenza per i suoi due figli. Lamonumentalità dell’edificio porta allacostruzione per settori ed ad opera divarie squadre di lavoro. Il progetto fuaffidato a San Gallo il Giovane, il qualeintroduce elementi che furono tipici delsuo palazzo Baldassini. Inoltre fucostruita una piazza antistante nellaquale venivano effettuati spettacoli e giochi così da
sottolineare lo spazio urbano che diventa parte integrante dell’edificio.La planimetria vede la presenta del solito schema della domus convestibolo, atrio e cortile, uno schema che si raddoppia nella parteposteriore verso via Giulia. Scompaiono le botteghe del tipico palazzoromano (non ve n’era bisogno) e come per Palazzo Baldassini, scomparel’ordine architettonico ed il bugnato utilizzato soltanto per lesoluzioni ad angolo con l’utilizzo del laterizio in facciata che presentaanche dei giochi policromi forse da coprire a calce (molto probabilmenteuna gara tra le varie squadre) e la pietra per la cornice e le edicoledelle finestre. San Gallo tuttavia arriverà ad iniziare il terzo pianoconcluso poi da Michelangelo il quale fu succeduto da Della Porta eVignola per la conclusione della facciata posteriore. L’incarico fuaffidato a Michelangelo grazie alla presentazione in scala 1:1 dellagrande cornice monumentale che gli valse l’incarico. Nelle idee diMichelangelo non vi era solo la volontà di chiudere la facciata eterminare il terzo livello del cubo del cortile, ma anche modificarealcuni elementi sangalleschi. Egli rilavora la finestra centrale di SanGallo, eliminando l’arco e creando un sistema trilitico con unatrabeazione che collega le finestre adiacenti ed una serie di elementiverticali tra cui due colonne in marmo verde. Il tutto è sormontato dallostemma papale con lo scopo di coprire le tracce dell’arco sangallesco.Inoltre va a modellare anche il portale d’ingresso con un bugnato intravertino così da andare a creare un unico elemento portale – finestra -stemma. Inoltre particolarità di questo palazzo è la presenza di unapanca continua (unico palazzo a Roma). Per creare la grande cornice dichiusura deve allungare il terzo livello, nel quale si nota anche lapresenza di finestre con timpano spezzato invaso dalla finestra stessa.Anche per il cortile, Michelangelo intervenne nel terzo livello andando areinterpretare totalmente quella che era l’idea di San Gallo di tre
5
ordini sovrapposti di arcate su colonne. Michelangelo nelsuo ultimo livello, invece inserisce paraste corinzie cheinquadrano le aperture delle finestre.
SAN GIOVANNI DEI FIORENTINI: per la costruzione di questa chiesa,molteplici furono le difficoltà, soprattutto riguardanti le problematichedelle fondazioni. In particolare Michelangelo fu chiamato per laprogettazione planimetrica dell’impianto, che il maestro vedeva come unimpianto centrico.
PORTA PIA: sulla via Pia che collegava la città con viaNomentana. Una zona ancora non molto edificata, ma già sipensava ad un ampliamento della città su questadirettrice. Sicura risulta essere la mano di Michelangelonella parte centrale, meno in quella laterale.Un’architettura questa che sembra già quasi avvicinarsi al
barocco soprattutto nell’utilizzo del doppio timpano. Si nota l’utilizzodi bugne che caratterizzano in portale (come palazzo farnese) inquadratoda paraste. Inoltre si nota un cambiamento per quelli che sono glielementi che compongono l’ordine (parasta) dalle scanalature al capitelloche diventa una sorta di piedistallo.
VIGNOLA: Vignola arriva a Roma dopo che la sua formazione di pittore prospetticosi era mutata in architettura già nel San Petronio di Bologna. A Roma sitroverà a lavorare in contesti già avviati in particolare affianco aDella Porta per concludere molti dei lavori di Michelangelo. Ma a Romamolta fiducia gli sarà data da Giulio III del Monte che sarà suocommittente.
VILLA DI GIULIO III SU VIA FLAMINIA: Villa Giulia è uno degli esempi piùraffinati e rappresentativi dell'architettura del Manierismo a Roma. Fucostruita da papa Giulio III Ciocchi Del Monte (1550-55)per farne la sua residenza sulla via Flaminia, poco oltrele mura urbane di Roma.Fu dato incarico per il progetto ai più importantiarchitetti dell’epoca: il celebre Giorgio Vasari,Bartolomeo Ammanati ed infine Jacopo Barozzi detto ilVignola. Secondo quanto dice il Vasari, fu Michelangelo arevisionare il primo progetto. La facciata del Vignola, presenta duepiani della stessa altezza. Al piano terreno si apre un portaleaffiancato da due nicchie, inseriti in un triplice arco bugnato. Ilmotivo del triplice arco si ripete al primo piano. La facciata è chiusaad ogni estremità da un pilastro di ordine dorico. La facciata posteriorepresenta la grande esedra porticata semicircolare ideata dall'Ammanati,autentica innovazione architettonica, aperta su un prato piano che aprepoi sul retrostante ninfeo utilizzato nelle stagioni estive per ospitare
6
convivi. Il Ninfeo, costruito intorno alla Fontana dell'Acqua Vergineprogettata e scolpita da Vasari e da Ammannati, ha tre piani di loggecoperte e decorate con statue di marmo. Si nota inoltre come in facciatanelle sezioni di tamponamento in laterizio siano presenti alcuni giochipolicromi proprio come in palazzo Farnese. Vi è poi la presenza dimodanatura e decorazione a livello di architrave delle edicole dellefinestre in facciata. Un complesso che Vignola progetta come un corpocentrale in stile puramente palazzo con due ali arretrate che dovevanoarrivare fino alle pendici del colle. CHIESA DEL GESU’: La Chiesa del Gesù (il suo nome completo è Chiesa delSantissimo Nome di Gesù all'Argentina) è la Chiesa madre della Compagniadi Gesù a Roma ed è, infatti, sede del Padre Generale dei Gesuiti. Inessa si conserva la tomba del suo Fondatore, Sant'Ignazio di Loyola. Almomento della sua consacrazione nel 1584, la chiesa era la più grande ela prima completamente nuova costruita a Roma dopo il "Sacco" del 1527.
Costruire una nuova chiesa era sempre stato, fin dal 1551,un desiderio di Ignazio di Loyola. Papa Paolo III nel 1540aveva autorizzato la costituzione della Compagnia di Gesù eaveva intanto subito offerto ai primi gesuiti una cappella,vicina alla sua residenza, all'epoca Palazzo Venezia, che sitrovava sull'attuale sito della chiesa. Nel 1551Sant'Ignazio di Loyola aveva commissionato all'architettofiorentino Nanni di Baccio Biggio il disegno di una Chiesaper la Compagnia di Gesù. Il progetto, che non ebbe seguito,presentava una Chiesa con una unica navata, cappellelaterali e un'abside poco profonda; la chiesa venne ancheridisegnata nel 1554 da Michelangelo, ma anche questoprogetto rimase sulla carta e per mancanza di mezzifinanziari i lavori della chiesa non furonoiniziati durante la vita di Ignazio. Solo nel 1561
il cardinale Alessandro Farnese, forse il più noto mecenatedelle arti del periodo, fornì il finanziamento per l’opera edincaricò Jacopo Barozzi, detto "Il Vignola"(1507-1573), unodei suoi architetti preferiti, della progettazione erealizzazione della chiesa del Gesù di Roma. Gli architettigesuiti Giovanni Tristano e Giovanni de Rosis furono attivicollaboratori dei progetti interni e diressero l'attualecostruzione. Il Vignola progettò una chiesa longitudinale di stile acroce latina, con un soffitto a volta, con un interno completamenteaperto, senza colonne interne, e nessuna altra struttura che dividesse lospazio centrale della navata, per non distrarre i fedeli e per nonsepararli dal pulpito e dall’altare. La navata fu scandita da archi atutto sesto e da due paraste che sorreggevano l’architrave decorato conun fregio continuo.Sopra il transetto, quasi inesistente a sottolineare la compattezza dellospazio, la cupola creò uno stacco tra il presbiterio e la navata,
7
illuminata solamente da finestre, facendo concentrare lo sguardo delfedele sull’altare.Un’attenzione particolare fu rivolta all’acustica, fondamentale perascoltare con attenzione le parole del sacerdote e la musica dell’organo.I lavori furono diretti dal Vignola dal 1568 fino alla sua morte nel1573. Dopo la morte del Vignola il cantiere passò sotto la direzione diGiacomo Della Porta fino al 1580. Il Della Porta rielaborò il disegnodella movimentata facciata e progettò la cupola. Aderendo all’Arte della Controriforma, la chiesa presenta una piantalongitudinale con una sola navata (secondo i dettami tridentini) copertada una volta a botte, affiancata da tre cappelle per lato, unpresbiterio, sormontato da una cupola sull'incrocio del transetto (i cuibracci furono contratti sino a trasformarsi in due cappelle). Con questoprogetto, il Vignola volle favorire la meditazione individuale e lapredicazione. La cupola, a tamburo ottagonale, è opera del Della Portache disegnò anche la facciata sovrastata da un timpano triangolare, conil quale la larga fascia inferiore è divisa da quattro coppie di parastee chiusa in alto da ampie volute che conchiudono il tetto. La facciata sipresenta monumentale ed imponente. Questo effetto è dovuto allo slancioverticale enfatizzato da numerosi elementi classici: le colonne e ipilastri raddoppiati, così come la “timpanatura” del portale d’accesso,punto focale dell’intera facciata. Inoltre la conformazione dellafacciata anticipa anche quello che è la tematica dell’interno annunciandogià il dislivello tra la navata centrale e le cappelle laterali.
MADERNO: nasce a Capolago in Lombardia ed ha parentela con Fontanacon il quale dirigerà un impresa edilizia che passò a lui dopo che pagò idebiti dello zio. Questo evento gli diede la cittadinanza romana moltoambita da Maderno e che gli permise di ottenere importanti incarichi tracui architetto della fabrica di San Pietro, architetto dei sacri palazzi,architetto del Tevere, del popolo romano, della camera apostolica.Inoltre bisogna sottolineare che partecipò agli spostamenti degliobelischi a Roma e sempre su questo insegnamento spostò l’ultima colonnadella basilica di Massenzio in Santa Maria Maggiore.
SANTA SUSANNA: il primo incarico architettonico diMaderno fu quello di affiancare Fontana nellafacciata di Santa Susanna, la quale risulta essere ilmanifesto del Barocco romano, nella quale siidentificano elementi tipici di questo movimento edin particolare l’aggetto verso lo spazio urbano perdonare molta più plasticità al profilo dellafacciata. La facciata non è un blocco isolato, marisulta essere annessa ad una cortina laterizia delconvento. Si nota come si sviluppi in due registriche aggettano progressivamente verso l’interno. Nel
8
primo registro si nota una parasta che si pone da limite tra la facciatae la cortina, poi una ¾ di colonna che aggetta, ed infine il portale cheè racchiuso da due coppie di ¾ di colonna. Per il secondo registro,invece, si nota l’utilizzo di paraste con quelle esterne modellate avoluta, il tutto seguendo l’aggetto del registro inferiore. Il tutto èchiuso da un timpano sormontato da una balaustra che funge da tramite trala pesantezza del travertino e la leggerezza dell’aria.
PALAZZO MATTEI: l’intervento di Mattei su questo palazzo, più che nelleforme estetiche, riguarda la planimetria che doveva rispondere anecessità ben specifiche. Per quanto riguarda l’esterno riscontriamo untipico stile San gallesco, con l’assenza di ordine, cornice marcadavanzale e bugnato nel cantonale. La novità sta nella decorazione delcortile interno dove si riscontra una ricca decorazione in basso e altorilievi e busti di personaggi illustri. Inoltre si nota una progressivachiusura sul fronte dell’atrio dove nel primo livello c’è la presenza diaperture ad arco, nel secondo livello archi all’interno di campata chiusaed infine nell’ultimo livello una campata chiusa con finestre. Vi èquindi una sovrapposizione di ordini che prevede uno ionico in stilemichelangiolesco. Ma come detto l’intervento di maggiore rilevanza eraquello a livello di planimetria rimodellata su due percorsi. Uno eraquello carrabile da via dei Funari, l’altro pedonale da via dei Caetanei.Il primo prevedeva un grande ingresso con vestibolo, atrio, cortile edinfine un altro cortile adibito a stalla. Questo perché le nobilifamiglie del tempo possedevano carrozze e per tanto il palazzonecessitava un cortile per i cavalli e per le manovre. L’altro ingresso,invece, molto più classico prevedeva un vestibolo, un atrio checoncludeva nella visione dello scalone cerimoniale.
COMPLETAMENTO DI SAN PIETRO: alla morte di Della Porta, nel 1603 Madernodiviene architetto della fabbrica di San Pietro e subito si trova difronte alla questione della chiusura del quarto braccio.Inizia così un dibattito se chiudere in manieraMichelangiolesca, o se continuare in uno sviluppolongitudinale. Dopo un po’ si decide nella demolizione dellenavate costantiniane per creare un prolungamento acannocchiale che abbia come snodo due cappelle, il tuttoanche con lo scopo di sottolineare la soluzione diMichelangelo ( cosa che fa a livello di volta inserendo unacornice: lo voleva fare anche con un gradino sul pavimento,ma gli fu impedito). Il progetto piace a Paolo V e la primapietra viene posata. A questo punto a San Pietro lavorano ben trecantieri in simultanea, ma la questione che più premeva il papa era lafacciata che voleva più larga per un inserimento di due campanili. Questasoluzione non convinceva molto Maderno che così facendo oscurava leabsidi di Michelangelo, ma tuttavia diede inizio ai lavori. Il primo
9
campanile fu iniziato, ma ben presto dovette essere smantellato a causadella presenza di acqua sottoterra. A questo punto il papa si convincedell’assenza di campanili, ma tuttavia vuole mantenere questoallargamento della facciata creando una disarmonia di proporzioni. Perquesta facciata egli decide di utilizzare la soluzione di palazzo deiconservatori con un ordine gigante corinzio ed un ordine ionico minore,il tutto unito al modello d’aggetto di Santa Susanna.
PIETRO BERRETTINI DA CORTONA: si ritrova a Roma intorno al1612 per entrare poi nella bottega di Boccio e successivamente a contattocon i Sacchetti, grazie ai quali sarà in contatto con il papa. La sua èuna formazione pittorica fondata sull’importanza della luce che faràpropria anche in ambito architettonico attraverso l’utilizzo del luminosobianco del travertino e del marmo. Il crocevia tra pittura edarchitettura sta nella costruzione, da parte sua, di scenografie perdeterminati eventi. Il primo intervento in ambito architettonico la si ha con la VillaSacchetti al Pigneto di cui rimane soltanto il ninfeo che fu il fulcrodella costruzione di Cortona. Vari sono i modelli per questa costruzionecome il cortile del bel vedere di Bramante ( terminazione in esedra) e ilSantuario di Preneste. Tuttavia, breve fu la fortuna di questo edificiotanto che già agli inizi del 1700 risulta essere in rovina a causadell’epidemia di malaria, ed a causa di cedimenti dovuti all’instabilitàdel terreno. Questo edificio presenta due ali laterali per sottolineareil corpo centrale ed inoltre risultava essere limitato nelle proporzionitant’è che Bernini criticò molto quest’opera.
CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA AL FORO ROMANO: questa fu una chiesamolto cara a Cortona e che lui non riteneva abbastanza nobile per ilrango dei santi a cui è dedicata. San Luca era infatti il santodell’accademia, mentre per quanto riguarda Martina si pensa che Cortonaavesse una devozione particolare nei confronti di questa santa. Così dopoessere stato nominato principe dell’accademia nel 1634, riesce aconvincere gli accademici a creare all’interno della chiesa ed a suespese, la sua sepoltura. Durante i lavori, vengono trovate delle spogliee la Chiesa decide di sovvenzionare Cortona. Questo è un evento assaiambiguo, inquanto l’epigrafe non risulta originale, ma sarebbe stato unabile ingegno di Cortona il quale prese spunto da un evento similedurante dei lavori di Bernini. La chiesa risulta avere una croce grecacoperta a cupola su due livelli. Il livello superiore dedicato a San Lucae la chiesa inferiore (più una cripta) dedicata a Martina. Si nota comevi sia un allineamento verticale delle due chiese nel quale all’altarecorrisponde l’altare ed alla cupola corrisponde la volta. Per quantoriguarda gli interni si nota l’utilizzo unico di travertino ed intonacobianco all’interno del quale l’unica nota di colore risulta esserel’altare. La fascia della trabeazione e del basamento risulta essere
10
unica, mentre i quattro piloni sono orientati al centro e affiancati dadue colonne libere. Per quanto riguarda la facciata si pensa che sidovesse chiudere a timpano, ma la cosa risulterebbe essere assai dubbia.
FACCIATA SANTA MARIA DELLA PACE: questa chiesa fu costruita nel ‘400,ricostruita nel ‘500 e nel ‘600 ospitò le cappelle dei Chigi. Perriqualificare la facciata di questa Chiesa (frequentata da personaggi dialto rango), non si adopera soltanto sulla chiesa, ma anche sullo spaziourbano in modo da creare una quinta scenografica nella quale si inserissela chiesa. Per fare ciò bisognava creare una piazza, perciò bisognavaespropriare e demolire le abitazioni. Compito facile per il papa, senonché gli unici a resistere furono i Gambirasiai quali fu espropriato il palazzo a seguito diun moto proprio del papa con il quale modificavail prospetto del palazzo e risarciva la famigliaGambirasi. Il corpo della facciata aggetta nellapiazza con un pronao semiellittico (semicircolareoccupava troppo) con ordine dorico ma fregioionico con iscrizione. La facciata si articola sudue registri: il primo del pronao strutturato come una sequenza dicolonne binate la cui colonna finale esterna risulta essere sul primogradino e un po’ staccata dalla linea del pronao per decretare unacontinuità con la piazza. Cosa questa, che si ripete anche nel registrosuperiore dove anziche esserci colonne, vi sono paraste, ma tuttavia ledue finali risultano essere sempre colonne. Come detto Cortona era amantedella luminosità, e si nota come forti siano i contrasti chiaroscuralidati dal bianco del travertino e dal nero del vuoto del pronao. Inoltrecaratteristica decorativa della facciata sono le sezioni piene che vedonol’utilizzo del travertino a macchia aperta. Timpano interno a vite chesegue la convessità del pronao e taglia la trabeazione del secondoregistro.
BERNINI: la sua carriera inizia giovanissima asoli 14 anni come scultore. Figlio di un uomo giàinserito nell’ambito artistico romano, non sarà perlui difficile inserirsi tant’è che già nel 1621diventa principe dell’accademia di San Luca. Nel 23direttore della fonderia di Castel Sant’angelo chegli permise di prendere il bronzo del Pantheon percreare il baldacchino di San Pietro succedendo aMaderno. Con l’elezione a papato di Innocenzo XPamphilj, viene leggermente surclassato da Borromini,ma subito dopo gli fu affidato la fontana dei 4fiumi. Poi nel 1655 con elezione di Alessandro VIIChigi, crea il colonnato di San Pietro. Ma la sua fama è ancheinternazionale tant’è che è chiamato per progettare il Louvre, anche se
11
il suo progetto non fu apprezzato dai nazionalisti francesi. Morì nel1680 e sepolto in Santa Maria Maggiore.
BALDACCHINO DI SAN PIETRO: per quest’opera bisogna innanzitutto affermareche non è una sua idea, tuttavia egli riesce a prende spunto da ideealtrui per poi modificarle e darne una propria originalità. L’idea delbaldacchino fu infatti quella di Maderno il quale voleva creare unelemento che mettesse in comunicazione la tomba di Pietro con tutto ciòche era stato costruito sopra e più in particolare la cupola (cielo).Ecco che quindi pensa ad una fusione tra il baldacchino (per naturastruttura mobile) con il ciborio (struttura fissa costruita). Anche lecolonne tortili in stile sepolcro di Gerusalemme e la copertura abaldacchino sorretta da angeli è idea di Maderno. Il progetto di Madernoprevedeva la presenza di archi intrecciati, ma quello odierno, anchegrazie alla collaborazione di Borromini, vede la presenza di volute aschiena di delfino che sorreggono la croce, mentre la copertura è rettada angeli. La copertura è lignea ricoperta di oro e bronzo (quello delPantheon). Le colonne tortili sono ottenute grazie alla tecnica dellacera persa che permise la creazione di queste colonne cave all’interno eriempite successivamente da conglomerati. La legenda vuole cheall’interno di una di esse vi sia la dodicesima colonna dell’iconostasidella basilica costantiniana. Curiose risultano essere le variedecorazioni naturalistiche come api ed alloro a simboleggiare lacommittenza dei Barberini. I quattro piloni che reggono la cupolaguardano verso il baldacchino ed ognuno di essi custodisce la reliquia diun santo che è esplicitato da una statua rappresentativa all’interno diun’ edicola del pilone. I santi sono: Elena, Longino, Veronica e Andrea.
FONTANA DEI QUATRO FIUMI: la fontana è situata in piazza Navona (anticostadio di Domiziano). L’incarico fu inizialmente affidato a Borromini(architetto dei Pamphilj), il quale prepara i lavoriidraulici e fa un progetto per la fontana che prevedevail montaggio di un obelisco all’antica da cui uscisseacqua. Tuttavia, Donna Olimpia, cognata del papapreferiva Bernini, così con lavoro d’astuzia, informòil maestro di tale incarico. Bernini crea un modello inscala d’argento del suo progetto e lo fa trovare sultavolo del papa. Di fronte a tale bellezza il papa nonpuò che incaricare Bernini dell’opera. La vasca vienemodellata in forma ovale ed il basamento dell’obeliscolavorato come se fosse uno scoglio marittimo con lapresenza anche di spazi vuoti. Nella costruzione Bernini volle chiudereil cantiere per creare maggiore stupore durante l’inaugurazione.Simpatica e stupefacente risulta essere la cerimonia d’inaugurazionedurante la quale il papa si trova di fronte al cantiere ancora chiuso ementre sta per andarsene, Bernini da l’ordine di aprire tutto lasciando abocca aperta tutti coloro che erano intervenuti. Inoltre in modo
12
sarcastico, Bernini legò l’obelisco a sottili funi con lo scopo dismontare le critiche che gli vennero fatte sulla stabilità della suaopera. Inoltre molte sono le leggende intorno questa fontana come adesempio il Rio che si protegge dalla chiesa del Borromini. Bisognainoltre dire che i geroglifici non sono autentici, bensì furono scolpitisecondo i dettami di un esperto egittologo su un obelisco liscio che furimontato perché trovato spezzato. Infine a chiudere l’opera vi è unacolomba con un ramo d’ulivo simbolo dei Pamphilj.
PIAZZA SAN PIETRO: la volontà di creare una piazza difronte alla nuova basilica fu quella di Alessandro VII,con lo scopo di ampliare lo spazio sacro destinato ad unluogo di così grande importanza. L’idea era quella dicreare due piazze, una ovale con i due fuochiidentificati nelle due fontane, ed una piazza (piazzarecta) con le braccia laterali oblique per limitarel’orizzontalità della facciata della basilica. La volontàdi creare questa piazza tuttavia ha anche un aspettourbano: cioè si voleva creare un unicum con lo spazio urbano circostantealla basilica. Tutto ciò ha però ulteriormente un significato allegoricoossia l’abbraccio che la Chiesa Cattolica dona a tutti i suoi fedeli. Alcentro della piazza ovale si instaura un obelisco che seppur in modosottilissimo non risulta essere in asse con il centro della facciatadella basilica, ma bensì con la sepoltura di Pietro. Questo disassamentoè alleggerito e in un certo senso annullato dalle due fontane che sono inasse con l’obelisco. Bisogna inoltre affermare che la piazza ovale èvista come un filtro dallo spazio sacro e lo spazio urbano, tant’è cheBernini decise di modellare il portico su quattro file di colonne così dacreare tre percorsi coperti (due pedonali|copertura cassetto nata piana|ed uno carrabile|copertura a volta a botte|). Il portico è diviso in 8settori delimitati da 8 raggi, i quali si diramano dall’obelisco posto alcentro della piazza. Si nota come sulle frazioni di porticato che sitrovano lungo l’asse maggiore della piazza si inseriscano delle aperturea portale delimitate da colonne binate: queste sono le aperture checollegano la piazza con lo spazio urbano circostante. Bisogna inoltreaffermare che vi era l’idea di inserire un ulteriore braccio di chiusura,cosa che non fu poi approvata, fino a che alla fine in periodo fascistafu creata Via della Conciliazione che collega Piazza San Pietro a PonteSant’Angelo. Una particolarità della piazza è la grande simmetria,dinamismo e soprattutto illusioni ottiche che Bernini utilizza per lacostruzione del porticato, tant’è che in punti ben specifici dellapiazza, sembra che il porticato sia formato da una sola fila di colonne.Per la costruzione del colonnato, Filippo è affiancato dal fratelloLuigi, abile tecnico che sì ingegnò all’invenzione di una nuova macchinache permettesse di montare tre colonne nello stesso momento. Colonne che,tra l’altro, non risultavano essere monolitiche e pregiate, ma bensìassemblate con travertino di Monterotondo ben più economico. Per quanto
13
riguarda la decorazione di questo porticato si nota come molta sia lalibertà architettonica utilizzata da Bernini. Una libertà che glipermette di inserire un ordine dorico con un fregio ionico allo scopo diarmonizzare il complesso e non con lo scopo di canonizzare l’ordine. Aldi sopra della trabeazione si riscontra ormai la tradizionale balaustradi colonnine intermezzata, a livello delle colonne sottostanti, dapiedistalli su cui poggiano delle statue. Gli snodi di terminazione e diallaccio con i bracci rettilinei della piazza retta, vanno a creare deiveri e propri corpi autonomi, tant’è che sono siglati dallo scudo papale.
SCALA REGIA: all’interno del Vaticano,Bernini si adoperò anche per la costruzionedella scala regia, per la cui costruzioneegli si adopera in principi di illusioneottica e prospettiva già applicati inprecedenza da Borromini per la galleria diPalazzo Spada. Questa scala rappresentaval’accesso principale all’aula regia (da cuiprende il nome) e per tanto risultava essereun incarico molto importante e di granderesponsabilità dal momento che doveva demolire e ricostruire incorrispondenza della Cappella Sistina (luogo più sacro). La scala èintrodotta da un imponente tema ad arco trionfale da cui entrando si notaquesta illusione prospettica dovuta ad una differenziazione delle altezzedelle colonne. La scala presenta due zone di sosta: una in corrispondenzadell’edicola contenete la statua di Costantino a cavallo, ed una secondaa livello del pianerottolo intermedio da cui si dirama la seconda scalaminore per accedere all’aula regia.
SANT’ANDREA AL QUIRINALE: La chiesa diSant'Andrea al Quirinale, detta ancheSant'Andrea a Monte Cavallo, si trova allasinistra di Via del Quirinale, di frontealla Manica Lunga del Palazzo del Quirinale.L'edificio, un capolavoro di architetturabarocca costruito sul luogo di una chiesadel Cinquecento per il Noviziato deiGesuiti, venne commissionato nel 1658 dalcardinale Camillo Pamphilj, per volontà del
Papa Alessandro VII Chigi, aGian Lorenzo Bernini che la considerò la sua miglioreopera. Il progetto di Bernini prevedeva una pianta ovalecon asse privilegiato quello minore. Come fare a crearequest’asse privilegiato. Con un grande ingegno, Berniniriesce a far diventare l’asse minore, un asse maggiore elo fa creando una nicchia profonda dove sarà inseritol’altare e con il pronao d’ingresso. Altresì andrà ad
14
accorciare l’asse maggiore con la creazione di cappelle lateralirettangolari e ovali alternate (CURIOSITA’: l’unione delle cappelle ovalie rettangolari formano le 2 croci di Sant’Andrea). Per tanto si nota comeinserisca due vuoti sull’asse minore e due pieni nell’asse maggiore. Per quanto riguarda gli interni si nota come la nicchia dell’altare siaracchiusa tra due coppie di colonne binate che sorreggono un architravesopra la quale è posizionato un timpano curvo spezzato con al centro unastatua. Particolare risulta essere l’effetto di luce nascosta internoalla nicchia. Per quanto riguarda la cupola, anch’essa assume una formaovale all’interno della quale Bernini avvicenda le costole alcassettonato. La cupola è forata da molte aperture a livello d’imposta eanche gli stessi costoloni non arrivano all’imposta ma si fermano alivello delle finestre e sono rilegati da dei festoni. Ciò dà un effettodi levitazione della cupola. In ingresso si nota come sia ripreso il tema del tempio con questotimpano sorretto da un ordine gigante di paraste corinzie che racchiudonol’intera facciata. Il pronao a forma semi circolare è sorretto da duecolonne ioniche ruotate di 45° e sopra di esso si apre una finestratermale che da la forma anche al timpano ricurvo.
PALAZZO BARBERINI: Pochi palazzi a Roma possono vantare di aver visto all' opera architetti
e pittori del calibro del Maderno, Bernini, Borromini e del Cortona. Infatti, appena eletto papa, Maffeo Barberini, pontefice con il nome di Urbano VIII, non trovando adeguato alle nuove necessità il vecchio palazzo dei Giubbonari, acquista dagli Sforza una vigna con annessa una villa, che sarà poi inglobata dal Maderno nella parte di sinistra del palazzo. I lavori iniziarono nel 1625 e furono condotti fino al 1629, anno della
sua morte da Carlo Maderno. L’architetto, coadiuvato dal Borromini, in origine aveva previsto un edificio a blocco, sul modello di palazzo Farnese. Per la sua posizione decentrata dal cuore della città ed avendo molto spazio a disposizione, - anche se numerosi furono i lavori di sterro e riporto per pianeggiare il terreno visto che il palazzo sorge suun ripido costone del colle del Quirinale -, Bernini, subentrato al Maderno, ideò una costruzione che facesse da palazzo e da villa extraurbana, creando una particolare planimetria aperta. Al blocco quadrato chiuso del Maderno, Bernini contrappose una pianta ad H schematizzata, aperta sulla facciata e sul giardino posteriore e priva dicortile. La solenne facciata, composta da una ben riuscita successione ditre ordini d' arcate dorico, ionico e corinzio con finestroni strombati. Un immenso androne – vestibolo composto da una selva di pilastri con volte, conduce a sinistra alla elegante e maestosa scala a pozzo quadratodel Bernini; sulla destra invece si trova la famosa scala a lumaca realizzata dal Borromini(forse su idea di Bernini), semplice ed
15
armoniosa. Proseguendo, oltrepassati uno spazio ovale con rampe simmetriche al lati, e passando sotto uno dei due ponti, salendo per la rampa si giunge al livello dei giardini da dove si ammira la facciata posteriore, opera del Maderno, e del piano nobile . Questo si compone di un numero impressionante di sale ed ambienti, stupendamente decorate con fregi, affreschi, volte a stucco. Spiccano la Sala Ovale, progettata dal Bernini secondo schemi già ripetuti nella vicina chiesa in S. Andrea, conasse maggiore parallelo alla facciata; la Sala del Trionfo della Divina Provvidenza, tra le più grandi di Roma, a doppia altezza, affrescata mirabilmente da Pietro da Cortona che vi lavorò in affresco dal 1633 al 1639; la Sala dei Fasti Barberiniani, con vedute delle proprietà Barberini fuori porta; il Salone di Rappresentanza o delle Battaglie; gliAppartamenti settecenteschi di Costanza Barberini e la saletta dell'Alcova. Da un ponticello, detto ruinante, si accede al giardino del palazzo, una volta ornato con disegni geometrici all'italiana e ora sensibilmente compromesso. Per le dimensioni, la particolare pianta, per le decorazioni e la ricchezza di materiali , palazzo Barberini é tra i maggiori edifici civili italiani d'ogni tempo.
BORROMINI: proveniente dalla zona del Canton Ticino, parente diMaderno, inizia la sua formazione come scalpellino cosa che lo porterà adavere un approccio molto pratico con l’architettura che lui fonderà sulprincipio della modellazione dello spazio. È un architetto molto eretico,innovativo che pensa di poter procedere indipendentemente dalle regoledegli ordini. La sua carriera come detto parte a Milano, fino poiarrivare a Roma dove inizialmente affiancherà Maderno e dal qualeimparerà molto riguardo l’architettura romana antica e di quel periodo.Ma alla morte di Maderno entrerà nello studio di Bernini con il qualeavrà delle divergenze teoriche soprattutto riguardanti i materiali.Borromini infatti disprezzò materiali nobili affermando chel’architettura poteva essere fatta anche con mattoni e stucco perchél’opera d’arte sta nella modellazione dello spazio e non nel materialeutilizzato. Da queste piccole divergenze scaturirà poi una grandeinimicizia tra i due che caratterizzerà l’architettura seicentesca aRoma.
SAN CARLINO ALLE QUATTRO FONTANE: La chiesa di San Carloalle Quattro Fontane, dedicata a San Carlo Borromeo,arcivescovo di Milano, fu soprannominata anche SanCarlino per le sue ridotte dimensioni, basate sia sulpiccolo e irregolare sito sia sulle dimensioniparagonabili ad uno dei quattro pilastri che sopportavanola cupola della Basilica di San Pietro in Vaticano. Inquesto complesso di dimensioni ridotte, in una posizioneurbanisticamente anomala, Borromini cancellò con undeciso colpo di spugna la sintassi dell'architetturarinascimentale e risolse le latenti istanze della cultura
16
del suo tempo con soluzioni geniali e rivoluzionarie, applicate alparticolare ed al tutto: definì una spazialità continua, senza angoli néstacchi né arresti, raccordando le pareti con elementi curvi, concavi econvessi, in pianta ed in alzato, muovendole secondo una equilibrataalternanza di linee che compressero o dilatarono lo spazio sotto laspinta di una potente dinamicità, alternativamente centripeta ecentrifuga. L'interno della chiesa fu ripartito da colonne di ordinecomposito con interassi che racchiudono con sequenza alternata un settorepiù ampio, occupato da una porta e una nicchia, e uno più strettooccupato da una nicchia più piccola. La trabeazione percorse per l'interoperimetro interno flettendosi in corrispondenza dell'abside e dei settorilaterali curvilinei e conferendo una grande continuità formale al piccoloambiente. Al di sopra della trabeazione la forma della chiesa siricompose nell'ovale della volta caratterizzato dall'originale disegnodei cassettoni ottagonali e cruciformi, aperta su un lanterninoottagonale con finestre su ciascun lato, che esaltò la luminositàprodotta dall'uniforme colorazione bianca della sala. Nella versionedefinitiva il Borromini realizzò una facciata del tutto particolare, intravertino, con linee ondulate concave e convesse, a due ordini,ripartita da colonne. Sopra il portale fu collocata nella nicchia lastatua di S. Carlo, realizzata da Ercole Antonio Raggi, mentre nellabalaustra due angeli sorressero il medaglione ovale. La parte inferioredella facciata incluse tre sezioni, le due esterne concave e quellainterna convessa. La parte superiore della facciata include tre sezioniconcave. Mentre le sezioni inferiori furono unite da una trabeazionecontinua, la parte superiore contiene trabeazioni divise in sezioni,quella centrale con un medaglione ovale, inclinato in avanti verso lastrada. Angeli, asimmetricamente piazzati sulla facciata, sembra chesorreggano il medaglione al centro della medesima, sulla parte superiore,che sembra una corona a forma di cipolla.
ORATORIO DEI FILIPPINI:La costruzione della nuova sede dell’Oratorio fu decisa nel 1611, ma ilavori ebbero inizio solo nel 1621 con la costruzione delle fondamentadella sagrestia, sul lato occidentale della chiesa, su progetto di MarcoAntonio. Ben presto, nel 1623, subentrò Paolo Maruscelli che rimase aservizio della Congregazione per circa quattordici anni, cioè fino al1637, realizzando il progetto planimetrico preliminare di tutto ilconvento e la costruzione della sagrestia che prevedeva una coerentesistemazione per tutta l’area con lunghe assi e una chiara e logicadisposizione della sacrestia e dei cortili. La Congregazione infine bandí un concorso che il Borromini vinse nelmaggio 1637 e tenne l’ufficio per i successivi quattordici anni. Perseguire le direttive di Filippo Neri, quando eraancora in vita, la congregazione richiese che némarmi pregiati né travertino venissero utilizzatiper la decorazione di quelle strutture ma comunque,
17
al Borromini fu richiesto di dare un’apparenza imponente alla facciataprincipale del nuovo edificio. Quindi per la facciata, sia permotivazioni economiche, sia per non creare una competitività con lafacciata della chiesa adiacente, non fu permesso di utilizzare il marmood il travertino, ma il maestro riuscì a creare questa maestosa facciatautilizzando il mattone che in alcuni casi si faceva creare in modoparticolare per alcune necessità. Si nota come la facciata riveli unandamento curvilineo concavo al centro che si allunga verso l’esterno. Lafacciata vede la presenza di due registri entrambi divisi in 5 settoritramite l’utilizzo di pilastri e paraste dove nel primo registro utilizzaun ordine gigante su due livelli. Vivace risulta il gioco dialettico frala parte centrale del primo ordine, curva verso l'esterno, e laprofondità della nicchia con catino a finti cassetti al centro del qualesi inserisce la colomba dello spirito santo dell'ordine superiore. Laforma del timpano, realizzata per la prima volta con una sagomamistilinea, genera un movimento curvilineo e angolare. La facciata siispira al corpo umano con le braccia aperte, quasi ad abbracciare ifedeli. Per quanto riguarda il portale d’ingresso che è decentratorispetto l’asse centrale dell’intero corpo facciata, esso risulta essereinquadrato in un ordine di colonne sormontate d un timpano.
SANT’IVO ALLA SAPIENZA: la chiesa di Sant’Ivo sorge sullaculminazione ad esedra del cortile di Palazzo della Sapienzaideato su un doppio ordine di arcate ad opera di Giacomo dellaPorta. La stessa esedra che segue l’andamento del cortileandrà poi a formare la facciata della chiesa stessa sempreseguendo l’andamento di una sovrapposizione di arcate e con unattico terminale. Per la planimetria di questa chiesa chepredilige sottoforma centrale, egli scarta il tipico impiantoottogonale o a croce greca, per creare un impianto centralestellare e mistilineo che trae origine dall’incastro di duetriangoli equilateri. Il tutto crea un forte dinamismo all’interastruttura basato sulla ormai sua tipica tematica dell’alternanza di muriconcavi e convessi. Si nota inoltre una grande unità dello spazio dovutoall’assenza di cesure spaziali e dalla continuità delle pareti scanditeda grandi lesene angolari ed anche dal prorompente cornicioneininterrotto che ripropone lo stesso disegno planimetrico. La luminositàinterna è dovuta alla forte illuminazione derivante dalle 6 finestredisposte tra le vele che vanno a creare l’interno della cupola. Si notainoltre come vi sia l’assenza di un tamburo e quindi la cupola sidimensiona sfruttando i 6 pilastri degli interni della chiesa.Esternamente si nota la grandiosità artistica rappresentata dallalanterna culminale che va a sormontare la cupola e che assume un aspettospiraliforme.
ARCHITETTURA TRA XVIII E XIX SEC:
18
questi sono i secoli dell’illuminismo, di una presa di coscienza da partedell’uomo che capisce di poter dominare soprattutto dopo la nascita delleindustrie e dopo le grandi scoperte anche di ambito edilizio. Nasce lanuova borghesia che influenza anche l’ambito urbanistico e di conseguenzal’architettura. Sono infatti questi gli anni dell’introduzione delcemento armato, ma anche gli anni della necessità di rispondere a nuovitipi edilizi che non avevano alcuna tradizione e quindi potevano esseretipologie per le nuove invenzioni e tecniche edilizie. Tra l’altro unruolo molo importante e di rilevanza sarà rappresentato dagli Usa, iquali non avendo alcuna tradizione rappresenteranno luogo disperimentazione edilizia in particolar modo dopo l’incendio di Chicago. Èanche il periodo di dibattito tra chi prediligeva la tradizione greca echi quella romana cosa che porta poi alla nascita dei gran tour che nonsi limitavano soltanto a Roma o Atene, ma in tutto il territorio perandare a scovare l’evoluzione delle tipologie edilizie. Nasce la distinzione tra architettura ed ingegneria artistica per laquale la prima si dedica di più all’aspetto artistico, mentre la secondamolto più all’aspetto costruttivo. Si assiste alla perdita dell’utilizzodell’ordine ed al grande utilizzo del ferro che permette l’apertura digrandi luci che possono essere tamponate a vetrate, che aprono gli spazie che trasformano i massicci pilastri in pietra in snelli sostegni. In un contesto del genere molto controverso tra tradizione edinnovazione, tuttavia vi sono realtà che rimangono ancoratiall’architettura più neoclassica come ad esempio in Inghilterra dovemolto seguito è il palladianesimo che sarà imitato e rielaborato anchenella costruzione di edifici importanti nelle colonie. Inoltre un altromodello classico ripreso è quello del piano di pergamena bramantesco, cheSir Cristopher Wren adotta per la progettazione della sua San Paul aLondra. Un’architettura quella inglese che si fonda sui concetti dilibertà e proprietà soprattutto dopo la rivoluzione della monarchia e chevede nell’architettura dei giardini, la metafora della libertàbritannica. Viceversa realtà come quella francese che respira ancora l’ariarivoluzionaria, si spinge oltre nella ricerca di nuove soluzioni e lo fasoprattutto attraverso l’utilizzo del ferro per la costruzione distrutture stabili.
Si noti ad esempio la BIBLIOTECA DI SAINT GENEVIEVEa Parigi di Labrouste. Questa struttura risultaavere un telaio completamente in ferro e ghisa,sebbene esternamente risulta mantenere ancora unamuratura. Questa fu una scelta dettata quasi dallapaura di creare un edificio che non rispecchiava icanoni tradizionali. Tuttavia, sebbene esternamenteessa risulta ancora un tipico palazzo del 700, internamente ci si ritrovain un ambito del tutto nuovo, nel quale vi è la presenza di enormi spazivuoti grazie all’utilizzo del ferro. Una delle sale lettura vede la
19
presenza di due volte a botte con archi di sostegno, il tutto sorretto daesili sostegni in ferro e ghisa modellati a mò di colonna e perciò conuna propria base, un plinto, un fusto ed un accenno di capitello. Nellasala principale, invece, si nota come la copertura sia trattata sottoforma di campate coperte a volta, la quale è trattata come fosse unacupola schiacciata con un’apertura che permette l’entrata da luce,necessaria per un luogo come la biblioteca. Ma molto interessante risultaessere la cura nei dettagli che è fortemente permessa dalla possibilitàdi modellazione del ferro.
O ancora il Crystal Palace a Londra progettato da Paxton, un espertoingegnere di serre in ferro e vetro, il quale progettò questo edificio inoccasione dell’esposizione universale di Londra. Gli fu affidato taleprogetto con l’unico vincolo di inserirvi all’interno un albero che eragià presente nel luogo della costruzione. Ciò porta alla formazione di unedificio enorme simmetrico in ferro e vetro con un corpo centrale copertocon un’enorme volta a botte in vetro cemento. Tuttavia la creazione diquesto edificio totalmente in ferro e vetro crea grandi problematiche alivello d’insolazione tant’è che gli espositori erano costretti a montaredei tendaggi di protezione. Problematica questa che fu successivamenterisolta con efficienti condizionamenti d’aria. Dopo l’esposizione fusmontato e rimontato su un’altra collina fino a che un incendio non nedecretò il definitivo crollo.
Altro esempio di struttura in ferro è senza dubbio la Tour Eiffel aParigi, il cui progettista era esperto di ponti in ferro. Anch’essa fuun’opera per l’esposizione universale di Parigi che vede una costruzionedi notevole velocità tant’è che nel giro di un anno essa presentava giàun’altezza di 200 metri.
USA: la realtà statunitense, era una realtà assai particolare, la qualenon presentando alcuna tradizione dal punto di vista architettonico,rappresentava un luogo di enorme sperimentazione edilizia. L’occasione siebbe con l’incendio di Chicago che rase al suolo gran parte della città.A questo punto si necessitava di una ricostruzione di edifici che fosserostati resistenti al fuoco. La nuova città prevedeva una planimetria ascacchiera come le antiche città derivanti dalla tradizione romana e lapresenza di skyscraper per uffici e magazzini. L’altezza straordinaria diquesti edifici (per quel tempo) era garantita da strutture portanti inferro e cemento armato che permettevano la tamponatura in vetro o setti.Tuttavia bisognava rendere isolante questa struttura e per far ciò, lastruttura veniva ricoperta in muratura decorata all’antica con un propriobasamento ed una propria cornice terminale (con lo scopo di nascondere lanovità strutturale). Sono questi anche gli anni dell’inserimento degliascensori in questi edifici.
20
FIRST LEITER BUILDING (William le Baron Jenney): questo risulta essere unedificio commerciale dove l’estetica è data proprio dagli elementistrutturali verticali ed orizzontali con ampie vetrate e questa corniceterminale. Come precedentemente detto, si nota la copertura in muraturaper proteggere la struttura da eventuali incendi. Particolarmente si notacome la zona angolare sia attentamente protetta con questo grandecantonale in pietra.
MARSHALL FIELD WHOLESALE STORE ( Richardson).Commissionato a Richardson dal mercante Marshall,questo edificio di grande innovazione strutturale,camuffa all’ennesima potenza la sua essenza,mostrando altresì un rivestimento ben piùtradizionale e compatto che ben diverge da ciò chein realtà è. Vediamo quindi un cantonalemassiccio, una cornice aggettante di grandi dimensioni, come aggettanterisulta essere il piano di base. Si nota inoltre la presenza di ampiearcate che inquadrano vetrate anche su tre livelli.
AUDITORIUM DI CHICAGO (Sullivan e Adler): questorisulta essere un edificio molto ampio che vede alsuo interno l’inserimento di un teatro, di unalbergo e di uffici. La sua enorme maestosità siadal punto di vista formale che dimensionale è voltoa nobilitare la civiltà industriale. Si notainoltre la presenza di una torretta (vi eral’ufficio dei due progettisti) come trasposizionedell’antico palazzo medievale. Di fatti l’aspettomassiccio, seppur innovativo della struttura, ben ricordaquelli che erano i palazzi nobiliari del 400 italiano. Lastruttura è in ferro e ghisa ed incorpora un importante efunzionante sistema di riscaldamento e ventilazioneinterna ed un ascensore.
MONADNOCK BUILDING (Root e Burnham): questo edificio di stampocommerciale, con i sui 16 piani risulta essere uno dei più alti edificidella Chicago del tempo. Caratteristica fondamentale di questograttacielo è la presenza di Bauwindows, ossia un aggetto di finestre chevanno a creare una vera e propria decorazione del prospetto stessodell’edificio. Prospetto che inoltre risulta essere molto compatto conuna chiusura a cornice molto decisa
RELIACE BUILDING ( Root, Burnham e Atwood):Questo edificio come il monadnock vede la presenza di bauwindows ma a differenza del precedente si nota anche
21
un’esplicitazione del telaio in ferro ed alluminio andando a creare unacurtain wall che non prevede un rivestimento esterno in pietra della struttura.
GUARANTY BUILDING (Sullivan): questo edificio risultaessere molto simile al Marshall Field tant’è che perquesta costruzione si rifà a quel modello. La strutturaportante in ferro è rivestita in terracotta decorataanche con motivi naturalistici. La struttura presentauna grande verticalità data da questi esili pilastriconnessi uno all’altro alla sommità da delle arcate. Sinota inoltre come Sullivan dia un taglio netto alle treparti componenti l’edificio per cui una distinzione tra partebasamentale, parte intermedia ed attico che vede una chiusura netta inuna cornice aggettante .
CARSON PIRIE SCOTT STORE (Sullivan):in questo edificio, ben diverso da quelli precedenti, sinota la volontà del progettista, di dare un aspetto piùtendente all’orizzontalità anziché alla verticalità. Cosaquesta che si nota bene dalla forma che assumono le magliestrutturali in ferro. Tuttavia quest’edificio si differenziaanche perché risulta essere un edificio ad angolo e che faproprio di esso il suo elemento caratterizzante e piùimportante. L’angolo assume una forma sferica e la sua ricca decorazionesoprattutto a livello basamentale fa si che esso sia identificato comeingresso principale alla struttura (cosa che avviene per la prima volta).
ART NOUVEAU: nasce in Belgio per poi diffondersi fortemente anche inFrancia, con lo scopo di ricercare modelli e rielaborazioni che dianovita a forme d’arte ed architettura particolari, il tutto attraversol’utilizzo dei nuovi materiali e delle nuove tecniche architettoniche. Inparticolar modo si nota come questa ricerca di nuovi modelli fosse assaitendente ad elementi naturalistici. Modelli che potevano essere benrappresentati grazie alla malleabilità del ferro. Uno dei grandiesponenti dell’art nouveau fu il belga Victor Horta.
HOTEL TASSEL: in quest’hotel per Tassel, Horta differenzia in modosorprendente un esterno in pietra più tradizionale con la presenza di bauwindows con un interno totalmente innovativo nel quale si assiste allasintesi tra arte decorativa ed architettura. Forte è l’utilizzo delmetallo che oltre ad essere materiale strutturale diventa materiale di
22
decorazione come ad esempio nel corrimano delle scale. Il modellod’ispirazione degli interni è senza dubbio la natura ed è un motivoripreso non soltanto nelle decorazioni in ferro, ma anche nella carta daparati, nelle finestre e nei mosaici. La copertura della struttura è invetro cemento.
PANORAMICA SUL CEMENTO ARMATO:nella prima metà dell’800 il grande sviluppo industrialeaveva portato ad una ricca produzione di cemento e ferro,la cui combinazione, ben presto avrebbe portatoun’innovazione importantissima in campo edilizio con laformazione del cemento armato. Si scoprì infatti cheunendo i due materiali si sarebbe riuscito a creare strutture portantibasati su pilastri e travi resistenti acompressione (cemento) ed a trazione (ferro). Iltutto avrebbe permesso una maggiore liberta alivello di setti murari che ormai sarebbero statisoltanto di tamponamento ( anche pareti in vetro).Inoltre questa nuova tecnica permetteva anche unagrande plasticità delle forme costruite.Il primo esempio di cemento armato lo ritroviamo nella BARCA DI LAMBOTnell’esposizione universale di Parigi, nella quale egli costruisce unamaglia in ferro ricoperta da una gettata di calcestruzzo. Il tutto va acreare una struttura sottile ma molto resistente. Un altro sperimentatore del calcestruzzo armato è Monier, un giardinieredi Versailles che utilizzò il calcestruzzo per creare vasi moltoresistenti. Egli capì che per utilizzare questo nuovo materiale bisognavaconoscere le caratteristiche di entrambi i materiali per sfruttare almeglio la loro potenzialità. Bisognava dunque adottare una teoria dicalcolo (che ancora non si conosceva) in base alla funzione che ilcemento armato deve ricoprire.Ma la vera rivoluzione per quanto riguarda il cemento armato va data aHennebique, il quale capì come i due materiali dovevano essereutilizzati, andando a creare un brevetto che attraverso le sueconcessionarie fu diffuso in tutto il mondo( in Italia 5, la più famosaPorcheddu). Egli conoscendo le capacità del cemento e del ferro, capì cheil cemento doveva stare nella parte superiore della trave, mentre ilferro nella parte inferiore, cosa che si sarebbe invertita a livello dipilastro dove nell’intersezione tra trave e pilastro il ferro subisce icosiddetti momenti di rotazione andandosi a posizionare nella parte piùesterna. Inoltre furono introdotte le staffe ad U con la funzione diconnettere i filari in ferro, ma soprattutto per favorire lacollaborazione tra ferro e cemento. Per tanto si limitava l’utilizzo delcostoso ferro solo li dove era realmente necessario (motivazione
23
economica). Inoltre la grande fama del cemento armato sta anche nella suaelasticità che gli permette di essere ben più saldo durante i terremoti.La teoria di calcolo di cui accennava Monier fu ben presto trovata daCognet e de Tedesco, i quali arrivarono a calcolare la SEZIONE IDEALEOMOGENEA attraverso cui donavano ad entrambi i materiali le stessecaratteristiche, così da poterli utilizzare in egual modo. Ma come fare?Per portare il ferro a livello di cemento, bisognamoltiplicare le qualità del ferro per un certo numero “n”.Bisogna inoltre conoscere quanto cemento inserire in baseall’ambiente esterno poiché se per erosione esce il cemento,a quel punto la struttura è altamente a rischio di cedimento
AUGUSTE PERRET: inizialmente architetto poi anche grazie alnuovo cemento armato diventa imprenditore. Una delle primesperimentazioni del cemento armato in campo residenziale èil palazzo di Rue Franklin nel quale utilizza una strutturaa telaio in cemento armato. Il tutto gli permette di creare unaplanimetria quasi libera ( differenziazione delle planimetrie nei varipiani) e di aprire ampie vetrate in facciata, che tra l’altro assume unaforma molto particolare con queste due sorte di torri che aggettanolasciando uno spazio vuoto centrale. Particolare risulta esserel’utilizzo del vetro cemento per rivestire le scale ed allo stesso tempoilluminarle. Vetro cemento molto resistente che può essere anchecalpestabile.
NOTRE DAME DE LA CONSOLATION: questa strutturarisulta essere molto particolare nella ripresa diuno stile simil gotico realizzato attraverso lanuova tecnica del cemento armato sia esternamenteche internamente. Esternamente si notaquest’elevazione del campanile centrale come sefosse una guglia. Il tutto in cemento armato comegli interni dove si riconoscono tre navate di cuiquella centrale è coperta da un’unica volta a botte, mentre quellelaterali da più volte a botte ruotate di 90° con lo scopo di reggere lespinte di quella centrale. Le colonne in pietra diventano snelli pilastrimodellati a fascio con diametro alla base di 43 cm ed alti 11.
ANTONI GAUDI:la sua architettura si ispira molto a quella che è la cultura catalana,contaminata dalla cultura araba ma anche gotica per quanto riguardaquest’innalzamento al cielo. La sua è un’architettura molto particolareche smonta quelli che sono i canoni classici per ricercare l’impossibile,ossia forme quasi naturalistiche che ben poco centrano con larigidità della tradizione. La sua grande amicizia con EusebiGuell lo porterà a creare molte opere.
24
CASA VICENNES: è la prima vera opera architettonica di Gaudì sotto lacommissione di un produttore di piastrelle. Proprio questo spiega ilcostante utilizzo di questo materiale mescolato anche all’utilizzo dimattone grezzo andando a creare motivi che ricordano la tradizione araba(scacchiera).
PALAZZO GUELL: sotto la commissione di Guell, Gaudìopera per la costruzione di questo palazzo a Barcellona,nel quale ad un esterno molto più tradizionale quasigotico, contrappone un interno molto elaborato nonsoltanto architettonicamente ma anche dal punto di vistadell’arredo che diventa parte integrantedell’architettura. L’esterno non presenta alcunedecorazioni se non i due portali parabolici (derivantidallo studio delle catenarie) e la loggia al primopiano. Si nota come egli, per le decorazioni ferree si rifaccia all’artnouveau in particolar modo nella decorazione del drago tra i due portali.Internamente, anziché inserire il tipico cortile esterno, inserisce unampio salone alto tre piani e coperto da una volta forellata a simularela sfera celeste. Egli inoltre nell’architettura interna decide diutilizzare l’illusione ottica per donare ulteriore monumentalità alpalazzo. Ulteriore particolarità di questo palazzo è il magnifico tettosul quale inserisce camini in pietra levigata e rivestita da maioliche ecreando uno spazio nel quale allontanarsi da tutto ciò che è umano emortale. Questo palazzo fu molto importante per Gaudì poiché fu uno deiprimi luoghi dove egli potette sperimentare le proprie idee anche se nonfu molto apprezzato poiché troppo tradizionale.
PARCO GUELL: Commissionato da Eusebi Guell Bacigalupi nel 1903 ilparco nasce dall'idea del committente di realizzareuna città-giardino, cioè centri abitati dove siapossibile unire le case agli elementinaturali del luogo. Delle 60 case costruite,però, solo due sono state abitate (in una si
trasferì Gaudì con la famiglia), e il progetto venneabbandonato nel 1914. Nello stesso anno il comune diBarcellona decide di cambiare il progetto, e di affidare aGaudì la trasformazione della città-giardino in parcopubblico. Nell'area destinata alle case non fu costruitonulla; si costruì solo nella parte destinata al tempo libero,che, una volta ultimata, riscosse un grande successo. Gaudìrealizzò quest'opera dando libero sfogo alla propria fantasia, ricalcandola struttura di un paesaggio naturale: si possono trovare, infatti,fontane, grotte, colonne-albero e arcate artificiali in cemento armato.Il tutto fu permesso dai tanti studi che Gaudì fece riguardo le forze dispinta che agiscono sugli archi, così da permettergli di creare forme
25
assai ambigue ma con una forte capacità strutturale di supporto. Le muradi cinta seguono il profilo sinuoso della montagna su cui è costruito ilparco, e sono ricoperte con frammenti di ceramica rossa e bianca, che halo scopo di decorare, ma ha anche una funzione protettiva, in quanto unmuro completamente liscio è molto difficile da scalare. L'entrata èsituata tra due padiglioni, anch'essi decorati da ceramiche colorate.Subito dopo si trova una scalinata adorna di fontane ed elementidecorativi, che porta al grande tempio in stile dorico-floreale, la cuiparte superiore è ornata da un motivo rosso che diventa una lunga seriedi sedili decorati da ceramiche policrome che fanno da limite alla grandepiazza destinata al mercato. Gaudì inserisce poi numerosi elementiarchitettonici che si confondono con il verde del paesaggio, e che hannolo scopo di unire l'opera umana a quella della natura.
SAGRADA FAMILIA: il cantiere per la realizzazione diquest’opera (ancora non chiuso) non fu avviato daGaudì, il quale utilizza il cantiere come unlaboratorio per sperimentare le sue idee e rimodellarein opera. Sempre seguendo quella che è la verticalità
del gotico, egli decide di creare delleforme stravaganti attraverso lo studio delle catenarie chegli permette di creare strutture geometricamente nonperfette ma allo stesso tempo resistenti a compressione.Proprio per questo motivo l’unico materiale che gli avessepermesso ciò era il cemento armato. Il cantiere eterno,ormai risulta essere una vera e propria attrazione per lacittà e sembra quasi che non si voglia finire quest’operache ormai va avanti da più di 100 anni. Nel suo progetto
iniziale, Gaudì aveva previsto la realizzazione di tre facciate, dedicaterispettivamente alla nascita, crocifissione e resurrezione di Gesù, settenavate e diciotto torri che dovevano rappresentare Cristo, i dodiciApostoli, i quattro Evangelisti e la Vergine Maria. Internamente si notacome gli snelli pilastri in cemento armato si diramino assumendo la formanaturalistica di fusti di albero, quasi con la volontà di ricreare unaforesta. Proprio per questa sintesi di architettura e natura, Gaudì puòessere identificato come il precursore della futura architettura organicache sarà caratteristica fondamentale di Wright.
CASA BATTLO’: situata in una delle vie principali diBarcellona, casa Battlò vuole discostarsi totalmentedall’andamento delle case circostanti andando a creare ununicum in un contesto edilizio assai tradizionale. Lapianta risulta essere stretta e lunga. Fantastica è lafacciata principale nella quale utilizza maiolicheaffiancate a pietra e vetro, il tutto con lo scopo diandare a creare una superficie quasi liquida che riprendaper colore e luminosità la superficie del mare. E proprio
26
il mare sembra essere l’elemento fondante della facciata per cuiritroviamo questi balconi che sembrano rappresentare lische di pesci oancora delle maschere, un tetto a schiena di dinosauro in tegole cherassomiglia alle squame dei pesci e ancora ‘utilizzo della pietra nellazona basamentale somigliante a fossili. Totalmente diverso risulta inveceessere la facciata interna, molto più tradizionale e funzionale conaffacci continui. Come per palazzo Guell, la sua opera non si limitasoltanto nell’architettura, ma anche negli arredi che devono andare acreare un tutt’uno con la struttura.
CASA MILA’: nella stessa via di casa Battlò vi è casa Milà. Questa nonrisulta essere intesa come unica residenza ma comeresidenza ad appartamenti. La sua forma cosìstravagante è dovuta alla volontà di Gaudì di imitareil Montserrat che domina la città di Barcellona, tantoche è anche chiamata la Pedrera. L’edificio sembra unenorme masso di pietra scolpito in opera e si componedi un pianterreno ben scandito, una serie di pianiorizzontali ed infine una chiusura con aggetto minoreai piani. La struttura in ferro risulta essere ben coperta dalla pietra,mentre gli elementi ornamentali in ferro si strutturanonaturalisticamente per avere una vicinanza alla pietra. Particolaredell’edificio risultano essere i cosiddetti carabinieros, una sorta dicomignoli fuori scala posti sul tetto che con l’aspetto severo dominanola città.
INIZI ‘900: dall’eclettismo di fine ‘800 si passa ad un rifiuto di questo variare emescolare stili ripresi dall’intera storia dell’architettura, al fine diproporre una nuova architettura che, seguendo quelle che sono le nuovepolitiche socialiste, rifiuta il passato per creare opere che seguano inuovi valori democratici.
SCOZIA:Charles MackintoshQuest’architetto insieme ad altri tre andrà a formare il cosiddettogruppo dei quattro di Glasgow, i quali ottennero un discreto successonell’esposizione di arti a Londra. L’architettura per loro si basa suforme nuove guardando tuttavia al passato scozzese, andando alla ricercadi un maggiore rigore di linea ma tuttavia senza rinunciare ad una certadinamicità. Inoltre per questi architetti, come per molti altri deltempo, anche l’arredo diventa parte fondamentale dell’opera poiché nerisalta la monumentalità e poiché deve essere in linea con l’idea diforme adottata per la struttura. Una delle opere sicuramente più significativedell’architettura scozzese del tempo è senza dubbio
la scuola d’arte di Glasgow, cheMackintosh realizzò con la
27
collaborazione dei componenti dei “quattro”. L’edificio nasce su unaripida discesa e si nota in facciata come gli autori avessero volutorifarsi alla tradizione scozzese attraverso l’utilizzo di questo granitoscuro tipico del luogo. Granito che va a coprire la struttura portante incemento armato e ferro che permette di creare grandi aperture coperte avetrate. Si nota inoltre la presenza di bau windows in facciata con loscopo di creare una scansione verticale su un edificio che tende per lopiù all’orizzontalità. L’impianto segue l’andamento della lettera E.all’interno della struttura sono incorporati ingegnosi impianti dicontrollo ambientale ( riscaldamento, ventilazione forzata) tuttorafunzionali. Per quanto riguarda gli interni si nota come ampi siano glispazi vuoti e come grande attenzione si da all’arredo che come dettodiventa uno degli elementi fondamentali dell’architettura. Moltoimportanti diventano quindi gli elementi decorativi e tra questi siinserisce anche la grafica che deve essere capace di identificare undeterminato movimento artistico-architettonico.
SECESSIONE VIENNESE: questo movimento architettonico e artistico vedesoprattutto la necessità di creare una secessione rispetto al passato permanifestare architettonicamente e artisticamente la nuova Austria libera.
PALAZZO DELLA SECESSIONE: progettato dal giovane architetto austriacoOlbrich, allievo del già affermato Otto Wagner, il palazzo rappresenta ilmanifesto della secessione che doveva essere destinato a padiglioneespositivo. Rifacendosi ad un disegno del pittoreKlimt, egli crea questo edificio come unacomposizione di volumi senza alcuna decorazioneintonacati di bianco. La parte più particolaredell’edificio risulta essere l’entrata incastonata daquesti due volumi bianchi ed arretrata rispetto adessi. Qui si apre l’entrata come a voler attrarre lo spettatore adentrare. Essa risulta essere anche una delle poche parti decoratedell’edificio dove si inserisce un fregio continuo decorato in oro. Soprail portale si istaurano tre facce femminili raffiguranti l’artedell’architettura, della pittura e della scultura. Ma l’elemento chesicuramente risulta essere di maggiore impatto visivo è la novità dellacupola traforata quasi sferica decorata in foglie di lauro. La strutturarisulta essere in rame rivestita da lamine d’oro e la foratura permettel’illuminazione anche degli interni. Questo elemento di novitàsimboleggia il fatto che ormai l’arte deve essere espressione della nuovacittadinanza libera. OTTO WAGNER: insegnante d’architettura, inizialmente seguiva quellache era la tradizione, ma successivamente affascinato dal nuovo fervoresecessionista si appassiona a questa nuova visione dell’architetturatanto da diventare maestro dei maggiori esponenti dell’architettura del‘900 come Wright. Tuttavia sebbene segue questa nuova visione,
28
razionalmente non rinuncia a quei principi tradizionali fondamentali chela nuova architettura deve seguire ( principi per lo più proporzionali).
UFFICIO POSTALE DELLA BANCA DI RISPARMIO DI VIENNA: notevole risulta essere la novità sia esternamente che internamente. Lafacciata, sebbene mantiene elementi della tradizione,risulta mostrare elementi di straordinaria novità. Sinota come la facciata sia composta da un corpo
centrale e due avancorpi li dovela struttura si curva. InoltreWagner non disdegna il passato,ma anzi omaggia l’Austriaimperiale ponendo delle statue a livello degliavancorpi. Ma la straordinaria abilità di Wagner fuquella di riuscire a creare una “gigantesca scatola
di metallo” attraverso l’utilizzo di lastree di marmo lucido fissate infacciata da dei rivetti che simulano dei bulloni. Si nota inoltre comel’ingresso, su due livelli, aggetti in una pensilina sorretta dapilastrini di ferro filettati a mo di vite. Grande novità la si riscontraanche internamente dove si assiste a questa monumentale apertura di spazipermessa dall’utilizzo del cemento armato e rivestito spesso in modo daricordare il motivo in facciata. Il grande spazio interno è coperto dauna grande volta a botte in vetro cemento che permette un ampiailluminazione interna. Vetro cemento che è utilizzato anche a livello dipavimentazione.
HOFFMANN: SANATORIO DI PURKERDORF: la struttura risulta avere una planimetria simmetricae l’edificio risulta essere una composizione divolumi differenti. La struttura in cemento armatopermette ad Hoffmann di avere un’ampia libertà nelcreare spazi interni così come nel rivestimentoesterno le finestre non risultano avere un asseportante bensì sono disposte in base allafunzionalità. Gli esterni risultano essere semplicemente intonacati dibianco e l’unica forma di decorazione sono le ceramiche ed i metalliposizionati ad angolo per sottolineare i profili dei vari volumi. Altracaratteristica del sanatorio è la scomparsa del tetto a favore di unsolaio in cemento armato.
PALAZZO STOCLET A BRUXELLES: commissionato da una ricca famiglia, questo palazzorisulta essere un banco di prova per Hoffmann chesi ritrova a lavorare in completa libertà.
29
L’edificio è composto da un grande corpo principale, una torre compostadi tanti volumi affiancati ed infine un corpo più basso. Come per ilsanatorio si nota la decorazione a spigolo per sottolineare i volumi.Come è ben comprensibile l’elemento di maggiore spicco risulta essere latorre che con questo avvicendarsi di volumi tende ad assottigliarsi inverticale fino a culminare in una sorta di cupola floreale (simile aquella del palazzo della secessione di Olbrich) affiancata da quattrostatue erculee. Gli interni sono molto ricchi in marmo e vantano mosaicie dipinti di Klimt e Moser. Inoltre tutto ciò che si trova all’interno èfrutto di uno studio di Hoffmann che non si limita soltanto allastruttura ed alla forma del palazzo, ma anche a tutti gli elementipresenti all’interno: dalle sedie ai tavoli, dai pettini alle stoviglie.Una particolarità del palazzo e che identifica il pensiero di Hoffmann èla fontana posta nel giardino del palazzo. Questa è composta da unastatua dorica a simboleggiare che ormai l’architettura classica e nellaspecifico l’ordine architettonico, risulta essere soltanto ornamentodell’architettura.
ADOLF LOOS: egli inizialmente aderisce a quella che è la secessioneviennese per poi distaccarsene accusando quest’ultima di troppaattenzione per quella che è la decorazione dell’involucro. Egli infattiguarda alla semplicità tanto da considerare la casa privata una scatolarettangolare forata da aperture dalle linee essenziali ed impreziosita dainterni più elaborati. Questo pensiero deriva dalla sua consapevolezzache l’architetto deve combinare gli spazi in modo che tutto sia armonico,proprio perché l’architettura è spazio. E proprio questa sarà la sualinea di pensiero che lo accompagnerà nelle sue opere e che diffonderàsottoforma di vari scritti.
CASA STAINER: proprio in linea con il suo pensiero,Loos progetta e crea questa casa come un involucrobianco con delle aperture il tutto molto minimalista emassiccio. L’unica nota di particolarità per quantoriguarda l’esterno è la copertura sul fronte pubblicoche subisce una curvatura e risulta rivestito da unmateriale differente dall’intonaco (per necessità). Tuttavia a questoesterno così essenziale, contrasta un interno assai ricco , impreziositodall’utilizzo di pregiati materiali. Tutto ciò fa si che questa casarisulti il manifesto dell’architettura di Loos.
RAIFFEISENBANK (MICHAELER PLATZ) VIENNA: questo edificio destinato alla presenza di unabanca, vede la presenza di una superficie compattaintonacata con le sole aperture delle finestre.Molta più attenzione viene invece data al basamentosu due livelli in granito scuro. Inoltre si nota
30
come all’ingresso vi sia la presenza di quattro colonne doriche. Nelcomplesso del basamento, sembra che Loos sia andato contro ciò che inveceandava a declamare: l’assenza di decorazione. Effettivamente sembraproprio così se non fosse che la decorazione in questo caso servesoltanto per evidenziare la funzione del basamento (ingresso).
PETER BEHRENS (STILE MODERNO): in questo periodo e soprattutto con questoarchitetto si cerca di lavorare su un nuovo frontenel quale l’industria si mette a servizio dell’arte.Ecco che quindi si iniziano a progettare edificiindustriali sottoforma di architettura artistica diturbine per creare luoghi nei quali l’architetturaincontra l’arte. Ed uno dei primi a sperimentaretale architettura fu proprio Peter Behrens con laprogettazione e costruzione della fabbrica di turbine AEG (lampadineelettriche). Esso consiste in un lungo corpo cavo coperto a bottesfaccettata con una so struttura di pilastri che permettono l’apertura digrandi vetrate sia in facciata che nei lati lunghi. In facciata si notacome timpano e vetrata sembrano formare una sorta di vite quasi a voleromaggiare attraverso l’arte l’industria con lo scopo di sottolineare lapossibilità di collaborazione tra arte ed industria.
BAUHAUS: derivante dal termine tedesco Bauhutte (loggia deimuratori), questo movimento fu ideato dall’architetto Gropius conl’intento di sperimentare nuove tecniche e forme, seguendo quelle cheerano le nuove idee socialiste tedesche seppur in un contesto nel qualesi stava sempre più affermando il nazismo (ecco perché sarà chiuso). Laprima sede del Bauhaus si trova a Weimar. L’emblema del Bauhaus è unacattedrale del futuro proprio a simboleggiare la volontà di proiettarsial futuro attraverso l’arte. Qui Gropius ha l’intento di formareARTIGIANI ( non c’era distinzione classista di mestieri) in tutti i campidell’arte. Ecco che quindi si dovrà circondare diartisti – maestri affermati. Ad esempio in pitturaaffiderà l’insegnamento ad Itten un pittore moltoaffascinato del mondo orientale e che vedeva lapittura come una fusione di materiali e forme (proprionello stile di Kandiskj infatti i due si conoscono).Ma con il tempo i rapporti tra Gropius e Itten sisfaldano fino a che il pittore non decide di abbandonare la scuola afavore di Moholy Nagy, un pittore ungherese molto più in sintonia conl’idea elementarista ed essenzialista di Gropius. Dalla collaborazionedei due si definisce inoltre il carattere tipografico del Bauhaus.Nell’esposizione del 1923 viene presentata la casa ideale chesintetizzasse lo spirito del Bauhaus. In questa casa esternamenteintonacata in bianco con aperture di finestre, si riscontra la tipicaplanimetria della domus romana con un atrio centrale e gli ambienticircostanti ad esso. Tuttavia bisogna affermare che non si tratta più di
31
un atrio aperto bensì di un salone, luogo più importante nella gerarchiadella casa dove la famiglia si riunisce. Inoltre per la prima volta siassiste alla presenza di termosifoni a vista e non più nascosti. Nello stesso anno, il Bauhaus è costretto a spostarsi a Dessau a causadel nazismo. Inizia così la fase del trasferimento e si assiste anche aduna industrializzazione del Bauhaus che vede i suoi brevetti prodottiindustrialmente e venduti. Tuttavia bisogna affermare che Gropius sidistacca da questa logica commerciale in quanto afferma che l’eccessivadivulgazione di questi brevetti rischia di screditare l’aspetto artisticodi tali opere. Successivamente questo distacco sempre maggiore porteràGropius a dimettersi nel 1928 a favore di Meyer e successivamente nel1930 interverrà Mies Van der Rohe che assisterà alla chiusura ufficialedel Bauhaus in un magazzino di Berlino nel 1933.
EDIFICIO BAUHAUS A DESSAU: questo complesso si compone di una serie diedifici disposti a girandola, edifici che risultano essere volumiautonomi collegati da corridoi e che hanno funzioni diverse. Vediamo
quindi come vi sia la presenza di un edificio per ilaboratori, una torre per gli alloggi, leaule e corridoi. Ogni singolo volumepresenta caratteristiche proprie anche senel complesso tutti giocano su uncontrasto di chiari e scuri. Iniziando dalfatto che tutti gli edifici sono costruiti in cemento
armato, si nnota come ad esempio nell’edificio dei laboratori si apranoampie vetrate su tutto il lato. Vetrate che sembrano quasi levitare inaria. Questo effetto è dato da un arretramento del piano basamentale cherisulta essere nascosto. La torre degli alloggi, invece, vede lacaratteristica di piccoli balconi su mensole ricurve con corrimano inferro. Come per i laboratori anche qui c’è una distinzione tra basamentoed edificio, un basamento che è intonacato scuro. A questo punto siassiste ad un’inversione di pensiero per cui il basamento perde la suaimportanza che gli era stata affidata in passato. Distaccati dalcomplesso della scuola vi sono poi gli edifici per gli insegnanti cherisultano essere una serie di casette progettate come composizione divolumi che vedono la presenza di un piccoli giardino esterno.
PROGETTO PER IL TOTAL THEATRE per Irwin Piscator:Per questo progetto Gropius voleva creare un edificioteatrale globale che avrebbe avuto la facoltà dimodificare il suo assetto in base allerappresentazioni teatrali che vi si dovevano svolgere.Il tutto ponendo dei dispositivi meccanici che sarebbero dovuti essereposti soprattutto nella zona del palcoscenico.
32
FRANK LLOYD WRIGHT:andando ad analizzare la sua architettura, bisogna identificarla comearchitettura organica, ossia un’architettura che nel totale rispettodella natura vuole inserirsi in essa anche attraverso l’utilizzo dimateriali naturali. Un’architettura che rifiuta l’eccesso che contraddicela natura e che non avendo alcuna tradizione è molto aperta alle varieetnie che si stanno istaurando in america, in particolar modo il mondogiapponese che affascinerà molto Wright. Per quanto riguarda lecaratteristiche compositive della sua architettura, essi possono essereesemplificati nei quattro punti della CASA DELLA PRATERIA, essenziali inogni sua opera architettonica (anche se inizialmente lavorando conSullivan ed Adler non produrrà al massimo le sue idee, ma rimarràancorato alla tipologia di Sullivan):
- FOCOLARE: il camino come fulcro dell’abitazione dal qualescaturiscono tutti gli ambienti circostanti.
- SOSTRUZIONE: strutture orizzontali che seguono la linea del terreno(Wright vuole dare alle sue residenze una forte orizzontalità datadalla composizione di questi volumi in orizzontale)
- RECINTO: una delimitazione della residenza ma che in realtà nonrappresenta una protezione vera e propria.
- TETTO: tetto a falde molto pronunciato e che spesso risulta essereanche molto sporgente.
Il tutto va applicato su planimetrie molto ampie (tipico delle campagneamericane) che non sono mai simmetriche per arrivare piano piano a quellache sarà la tipologia della pianta libera che in questi anni si andavamolto ricercando e che sarà finalmente dominata da Le Corbusieur. Eccoche quindi si passa ad un’architettura funzionale che non segue piùgeometrie precostituite, ma anzi avviene che la casa deve piegarsi allenecessità dell’uomo e non più il contrario.Tuttavia per mettere in atto tutti questi punti, sono necessarie dellecondizioni di architettura:
- Disponibilità economica del committente - Ampi spazi- Volontà del committente a collaborare e scegliere
quest’architettura e lasciare ampia libertà all’architetto che deveesprimere le proprie idee.
CASA STUDIO: nel periodo in cui studia sotto lasupervisione di Sullivan ed Adler, Wright prende inprestito dallo studio Sullivan 5000 dollari percomprare questo appezzamento di terra in Illinoisdove poi portò a termine la costruzione di questa suaprima casa studio. Si nota come l’architetto inizia a
33
mettere a punto i suoi punti fondamentali e ciò lo si nota soprattuttocon questa composizione in orizzontale, questa sorta di recinto e questomolto spiovente tetto a falde.
CASA CHARLEY: per conto dello studio Sullivan Adler,Wright si adopera per edificare questa residenza chenon presenza le idee fondamentali di Wright ma bensìlinee più tradizionali. Si ritrova infatti unasimmetria planimetrica, una loggia quasi arappresentare un piano nobile, una cornice terminaleed un basamento con un monumentale ingresso tutto intravertino. Tuttavia però possiamo riscontrare elementi nuovi delladialettica di Wright come ad esempio l’utilizzo frequente di lineeorizzontali in travertino proprio a simboleggiare la composizione divolumi orizzontali tanto seguita da Wright.
WINSCOW HOUSE A RIVER FOREST: Rispecchiando quelli che sono i punti di Wright,questa abitazione risulta essere una delle prime verecase Wrightiane. Si nota di fatti il grande tetto afalde, orizzontalità dell’edificio, un camino centralecome fulcro della casa. Si notano inoltre delle cesurenette orizzontali in particolare quella che divide ilmattone chiaro dal mattone scuro. Questa differenziazione di materiale,sembra far levitare il tetto se non fosse che si notano le aperture dellefinestre. Tuttavia seppure il fronte pubblico risulti massiccio e severo,ne la pianta ne il fronte privato con loggia vetrata lo rispettano.
DANA HOUSE A SRINGFIELD: riprendendol’affascinante mondo orientale ed in particolaregiapponese, Wright decide di edificare questa casacome una composizione di volumi con una piantasempre più articolata e con un aspetto chetendesse a richiamare il tanto amato mondo orientale. Cosa questa che sinota in particolar modo nella conformazione del tetto a falde.
LARKIN COMPANY: questa struttura industriale fucommissionata a Wright da Martin (lo stesso della MartinHouse che come caratteristiche vede bassi tetti a faldema con spiovente pronunciato ed impianto di riscaldamentonei quattro piloni principali). In questo edificio eglicrea un grande vano vuoto centrale (con la stessafunzione del focolare nell’abitazione), circondato daaltri ambienti. I pilastri che racchiudono questo vano ricordanovagamente delle paraste con un accenno di capitello. Esternamente siassiste ad una aggregazione di volumi che rendono chiuso e compatto
34
l’esterno. Questo è possibile in quanto internamente la luce deriva dallagrande botte costruita in vetrocemento.
ROBIE HOUSE: questa abitazione rappresenta una delle più famose operedell’architetto che rispecchia alla grande i punti fondamentali dellacasa della prateria, tanto da rappresentare uno degli apicidell’architettura di Wright. Strutturalmente questa casa è quella che osadi più, come si può ben vedere nel notevole aggetto della copertura. Lapianta va sempre più allungandosi ed al centro vi è sempre il camino chein questo caso diventa un setto murario che separa due zone dello stessoambiente. Inoltre si nota come gli spazi ed i volumi interni sianotrattati come la struttura esterna e si cerca diaprire gli spazi senza creare una chiusura tra levarie stanze. Risulta inoltre essere unaprogettazione globale quella di Wright che non sioccupa soltanto della struttura ma anche degliarredi che devono ben integrarsi nella suastruttura. Si può inoltre notare, esternamente lagrande attenzione che Wright da alla composizionedi volumi orizzontali con queste sorte di recinti che mentre da una parteproteggono da occhi indiscreti del vicinato, dall’altro permettono unapanoramica completa del vicinato urbano da parte del proprietario(espressa richiesta del committente).
TALIESIN E TALIESIN WEST: bisogna innanzi tutto distinguere i duecomplessi creati da Wright che tuttavia mantengono lastessa funzione di casa-studio-scuola. Questo suo progettoviene messo in atto dopo che l’architetto fuggì con ladonna di un suo committente e decise di creare questocomplesso di Taliesin che permettesse di accogliere questasua famiglia allargata e tutti gli studenti che sitrovavano ad apprendere sotto Wright. Il tutto segue semprei punti fondamentali della casa nella prateria seguendo quella che è lasua architettura organica. La prima Taliesin andò bruciata a seguito diun incendio provocato da un servitore licenziato che preso dalla folliabruciò il complesso e uccise sette degli abitanti presenti nella casa.Cosa questa che segnò molto l’animo di Wright che decise di trasferirsiin Giappone qualche anno durante i quali costruì l’Imperial Hotel aTokyo. Più caratteristico risulta essere invece la Taliesin West, più unaresidenza estiva che rappresenta molto l’ideale di architettura organicadi Wright. Ciò lo si vede ad esempio nel costante utilizzo della pietralocale sia dal punto di vista strutturale che decorativo. Unaparticolarità di questo complesso sta negli alloggi studenti che dovevanoessere creati dagli stessi studenti. Vedendo da un punto di vista piùcritico si nota come questa doppia costruzione sia proprio un espedientearchitettonico di Wright che costruisce non solo in base alla natura ma
35
anche in base al clima ed alla temperatura del luogo (cosa questa che èparte integrante dell’architettura organica).
IMPERIAL HOTEL : commissionato dalla famiglia imperialegiapponese per accogliere ospiti e dignitari, questo hotelfu commissionato a Wright, il quale tenendo conto dellacultura locale, mantiene tuttavia i suoi elementicaratterizzanti. Si nota una simmetria (assai lontana dalsuo stile) assiale dell’intero complesso che nella sua veduta aerea va aformare la forma di una sorta di H. una simmetria che tral’altro è ulteriormente accentuata dagli elementi decorativiesterni, anch’essi disposti simmetricamente.
PRINCE TOWER (palazzo residenziale): avvicinatosi alla nuovatecnica del cemento armato, Wright si cimenta anche nellaprogettazione di grattacieli, portando alla fine a termine laPrince Tower, un palazzo residenziale. In questo edificio diappartamenti, egli vuole sperimentare la sua nuova struttura avassoi, che vede la successione in verticale di volumi orizzontali. Sinota inoltre come l’edificio presenti una costante curtain wall.
JOHNSON WAX BUILDING: sempre attraverso l’utilizzo del cementoarmato, decide poi di approdare nel campo industrialeprogettando e costruendo questo edificio di uffici. Si notacome, sempre nel suo stile, siano molto marcate le linee
orizzontali, alle quali tuttavia si contrappongonodelle linee circolari che riutilizzerà poisuccessivamente nel Guggenheim museum. Su un latodel complesso si eleva una torre che con questadecorazione in orizzontale va a rappresentare la struttura a
vassoi. Internamente i pilastri prendono forma di fungo, che sorreggonouna copertura in vetrocemento opaco che permette l’entrata di luce.L’effetto è straordinario quasi a creare un ninfeo interno allastruttura. All’interno di questi ambigui pilastri sono inseriti impiantidi ventilazione e riscaldamento.
CASA KAUFMANN: questo edificio si stanzia sulle sponde diun torrente sempre con la logica di creareun’architettura organica alla massima potenza. Tuttoquesto è possibile grazie alla grande libertà che ilcommittente della casa diede a Wright (unica divergenzasulla tonalità dell’intonaco che Wright voleva dorato peresaltare gli effetti di luce soprattutto durantel’autunno. Infine si accordano sul colore albicocca). Vari sono i modellisu cui l’architetto si basa per questa costruzione come ad esempio iquadri di Mondrian. Di fatti l’edificio si articola come una composizione
36
di volumi orizzontali che seguono una geometria proprio come nei quadridi Mondrian. Inoltre sempre seguendo la logica di architettura organicava ad utilizzare la pietra locale sia a livello si struttura esterna cheinterna. Si noti ad esempio l’utilizzo della roccia a creare delle seduteintorno al camino (la natura entra all’interno della casa). A livello dicantiere bisogna inoltre affermare le grandi difficoltà a cui si andavain contro in quanto ancora non si conosceva bene la cantieristica per ilcemento armato soprattutto in condizioni estreme come questa.
SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM: per la costruzione diquesto edificio, egli sostituisce i suoi tradizionalipiani orizzontali a favore di forme più circolari.Molti sono i progetti fatti da Wright che vanno da unedificio a parallelepipedo, ad una struttura a conofino alla definitiva struttura a cono rovesciato.Tutto questo perché Wright aveva l’intento di renderel’edificio parte integrante del percorso museale. Proprio per questomotivo opta per una struttura a cono rovesciato, come rovesciato risultaessere anche il percorso che va dall’alto verso il basso. Esternamente sinota come questo cono sia ricucito da un basamento compatto e continuo diforma quadrangolare. Una struttura che nel suo contesto rappresenta unacesura netta con l’ambiente urbano circostante. Inoltre si nota comeinternamente la luce sia donata da una grande lucernario centrale, la cuiforma fu poi ripreso anche nel vaticano.
MIES VAN DER ROHE:la sua carriera inizia come scalpellino, professione che con il tempo loavvicinerà all’architettura in modo molto pratico fino a che nel 30arriverà a capo del Bauhaus. La sua visione artistica prevedeva unarazionalizzazione dell’arte che doveva essere trattata proprio come sefosse una scienza con delle regole fisse, prima fra tutte illimitatissimo utilizzo di decorazioni ed orpelli poiché nella suavisione, l’architettura in se e per se era già arte.Dopo la guerra predilige una geometrizzazione delle forme in puro stileWrightiano, con un forte uso di volumi e piani nitidi e con un costanteuso di curtain wall ed involucri di fasce orizzontali piene e vetratealternate. Si cimenta poi anche nel tema del grattacielo progettandone uno per gliuffici della stazione di Friedrichstrasse che prevedeva una formaprismatica che seguisse l’andamento triangolare della piazza antistante.Il progetto prevedeva un rivestimento totalmente in vetro con l’intento,non di creare effetti di luci ed ombra, ma bensì riflessi luminosi.
PADIGLIONE DI BARCELLONA: questo edificio costruito come padiglioneespositivo della Germania per l’esposizione diBarcellona, risulta essere uno dei capolavori diMies Van der Rohe. La struttura è organizzata
37
spazialmente in modo centrifugo come se ci fosse un’espansione dal centroverso l’esterno. La struttura che risulta essere rialzata su un podioalto 8 gradini, si basa su 8 pilastri cruciformi sottili in ferro chereggono un solaio piano che si trova in corrispondenza con altrecoperture. Questa struttura su pilastri fa si che ci sia una grandeapertura di spazi ed un rivestimento esterno tutto in vetrate che sono iprotagonisti principi di questa suggestiva organizzazione centrifuga.Sono inoltre presenti due vasche: una antistante all’entrata dellastruttura ed una nascosta sul retro. Entrambe hanno la funzione diriflettere, la prima riflette la struttura, la seconda nascosta rifletteuna statua di una danzatrice. All’interno ed anche all’esterno dellastruttura, a dividere gli spazi sono presenti dei setti in marmo a facciavista ( definiscono anche l’aspetto decorativo) che hanno una sezioneassai sottile a rappresentare che non sono veri e propri setti. Inoltreper quanto riguarda il materiale utilizzato, si nota come lapavimentazione esterna non sia in marmo lucido, bensì in marmo opaco nonriflettente proprio perché questa funzione era destinata alla vasca.(crea la nota sedia Barcellona).
CASA TUGENDHAT A BRNO: ricalcando molto quelle che erano le concezionispaziali soprattutto di vuoti e setti semi divisori non portanti delpadiglione di Barcellona, Mies da vita a questa villa su tre piani.Ritornano inoltre i pilastri cruciformi cromati ed insieme alledecorazioni date dal marmo, si unisce un grande e suggestivo uso di legnodi ebano in particolar modo nella parete in ebano curva che racchiude iltavolo da pranzo con una veduta suggestiva sul centro città.
FANSWORTH HOUSE: immersa totalmente nella naturadell’Illinois, questa casa rappresenta uno degliapici dell’architettura organica tanto ricercataanche da Wright. L’edificio si trova nellevicinanze di un fiume e proprio per questo motivorisulta essere rialzata . la composizione risultaessere in orizzontale cosi come lo è anche ilvolume d’ingresso. La struttura è in cemento e ferro tuttavia tuttointonacato in bianco per esaltare le linee. La casa presenta paramentitotalmente vetrati che proiettano la casa all’esterno sempre secondoquell’organizzazione centrifuga tipica anche del padiglione. Tuttaviaquesta totale vetratura dei paramenti comporta anche un eccesso diinsolazione, cosa che doveva essere risulta con un efficace sistema diventilazione e di tendaggi.
SEAGRAM BUILDING: il luogo d’edificazione è New York e come si sa, lacittà risulta essere un agglomerato di grattacieli proprio perché si hal’intento di costruire in verticale per risparmiare spazio. Detto ciò,consideriamo il fatto che per l’edificazione di questo grattacielo, MiesVan Der Rohe, decise di non utilizzare tutto lo spazio a lui fornito, ma
38
soltanto una parte, con l’intento di creare una piccola piazza con duevasche antistanti all’edificio. Cosa questa che destò molto scalpore perl’inutilizzo di spazio costruibile ma che l’architetto riesce a farapprovare. L’edificio si basa sul curtainwall che vuole modellaresull’abbinamento di bronzo e vetro anziché acciaio e vetro.
LE CORBUSIER:architetto svizzero che decide di affibbiarsi questo pseudonimo peressere immediatamente riconoscibile in ambito architettonico. Sarà ancheuna delle prime archistar e per questo sarà declamato non soltanto per lesue opere progettate e costruite, ma anche per i suoi scritti. Si formaalla scuola d’arte della sua città natale, ma capendo che doveva ampliarei suoi orizzonti, decide di trasferirsi a Parigi dove alla scuola d’arte,preferisce lo studio di Perret grazie al quale entrerà in contatto con lenuove tecniche in ferro e cemento armato. Ma prima di recarsi a Parigi,porta a termine vari Gran tour per studiare l’architettura in Italia edin Asia minore dove disegnerà varie opere che saranno fondamentali percomprendere i modelli a cui si rifà. Prima della guerra entra in contatto con Berhens grazie al qualeconoscerà l’importanza della fusione industria architettura e soprattuttol’importanza della macchina che sarà uno degli elementi fondamentalinelle sue opere architettoniche. Successivamente la guerra lo costringeràa tornare nel suo paese natale dove insegnerà nella sua vecchia scuolaper poi tornare a Parigi nel 1920, anno in cui fonderà l’Espirit Nouveaugrazie al quale divulgherà la sua teoria sull’utilizzo del cemento armatocon il suo sistema DOMINO che poi sarà alla base dei 5 punti fondamentalidell’architettura. Questo sistema vede l’edificio come una scatola dove ipilastri anziché trovarsi sugli esterni, si trovano interni portando allaformazione di una facciata libera che può essere modellata a secondadelle proprie necessità. Questo è un grande passo che porta allastruttura a pianta libera che permette di modellare gli interni comemeglio si vuole ed in base alle necessità del committente. Inoltre si vaa svuotare il piano basamentale mentre si apriranno terrazze giardino(avviene il contrario della tradizione). Da qui quindi bisognanecessariamente elencare i 5 punti fondamentali dell’architettura chespiegano anche meglio questo sistema domino:
1) PILOTIS: elemento base necessario per gli altri punti. Consistonoin pilasti che sollevano l’edificio da terra andando a creare unvuoto dove sia possibile favorire il passaggio di vetture (nasconoanche i garage)
2) PIANTA LIBERA: ottenuto grazie alla separazione di pilastriportanti dai muri che suddividono lo spazio ed anche i muriperimetrali
3) FACCIATA LIBERA: stesso concetto della pianta libera ma inverticale
4) FINESTRA A NASTRO: utilizzo di fasce vetrate orizzontali.
39
5) TETTO GIARDINO: sopperisce alla mancanza del piano basamentale conl’apertura di ampie terrazze adibito a spazio comune, di ritrovo.
MAISON CITROHAN: Nel 1921 Le Corbusier progettò la Maison Citrohan, che, se alzata su pilotis, sembrava anticipare i 5 punti della nuova architettura. Il nome "Citrohan" era un po' un gioco di parole sul marchio della già famosa industria automobilistica, per indicare che tale"Maison" sarebbe stata prodotta in serie, proprio come un'automobile. Si tratta di una casa progettata come un'automobile, concepita e disposta per soddisfare al meglio le esigenze dell'uomo che la avrebbe dovuta abitare. Sembra un po' una rivoluzione contro il vecchio modello di casa borghese che utilizzava lo spazio in modo indifferenterispetto alle diverse funzioni, rendendo l’alloggio unorganismo poco adatto a soddisfare le reali esigenzeabitative dell’uomo.Fino a quel momento la casa era stata un agglomerato pococoerente di molte grandi stanze; in ogni stanza c'erasempre dello spazio in eccesso o dello spazio mancante.Nasce così la casa economica funzionale che soddisfi leesigenze dell’uomo.
MAISON AMEDEE OZENFANT: questo edifico è una casa studio per un pittore. Questo porta L.C. a creare un edificio particolare ricco di luce che potesse ospitare anche una sala espositiva delle opere del pittore. La casa si articola su tre livelli con i primi due destinati ai servizi ed alla sala da pranzo, mentre un terzo piano su due livelli destinato a laboratorio del pittore. Questo comporta quindi un’ampia vetrata su due prospetti e su due livelli che dona una ricca luminosità all’ambiente. Inoltre in quest’ambiente è presente un soppalco che il pittore utilizzava come magazzino.
CASA LA ROCHE – JEANNERET: questo edificio risulta essere una residenzabifamigliare, una per il fratello ed una casastudio per l’atelier di La Roche. Si nota come ledue abitazioni siano ben differenziate anche alivello planimetrico. Nella zona del fratello sinota una planimetria funzionale alla vita quotidianadella famiglia, mentre nella porzione destinata a LaRoche, ben più ampia si nota una distinzione tra la zona abitazione (ben ristretta) e la zona atelier. Il tutto è elaborato come una passeggiata architettonica (un po’ come Guggenenheim) dove gli spazi sono collegati in serie per permettere l’esposizione all’interno. Particolare risulta essere il prospetto dell’atelier che assume una forma concava che ben contrasta con la forma quadrangolare del resto dell’edificio. Internamente inoltre vediamo una serie di affacci, ambienti a doppie
40
altezze, il tutto sempre secondo la teoria della pianta libera che permette tutto ciò.
VILLA STEIN – DE MONZIE A GARCHES: per questo complesso, L.C. ha a disposizione un lotto lungo e stretto all’interno delquale egli decide di costruire l’edificiotrasversalmente così da creare un giardino sul frontepubblico ed un giardino sul fronte privato. Si notacome vi sia una grande strada d’accesso (simboleggia lamacchina che entra in architettura) poiché al pianterreno è presente un’apertura che permettel’inserimento dell’auto all’interno dell’abitazione. Questo risulta essere un grande traguardo per l’architettura moderna. sulla facciata pubblica si nota come vi siano due entrate. Una minore a sinistra per la servitù ed una principale con sopra una pronunciata pensilina sostenuta da pilastri in ferro per i proprietari. Si nota inoltre come in mezzeria non ci sia quindi più l’entrata ma bensì una grande vetrata che simboleggia la presenza di un ambiente importante proprio in quel punto. Viceversa in mezzeria è presente un balcone in sommità che annuncia la presenza di una terrazza giardino. A questo prospetto compatto e massiccio, contrasta invece il prospetto del fronte privato che annuncia esplicitamente la presenza della terrazza e vede la presenza di più ampievetrate a nastro.
VILLA SAVOYE A POISSY: il lotto è isolato nella natura sebbene adiacenteal contesto urbano. Con questo edificio egli vuole creare un effetto dilevitazione della struttura principale nascondendo conun gioco di ombre il piano sottostante destinato allaservitù ed ai posti auto. Con questo quindi siriconferma la logica dell’architetto di inserire l’autodentro l’abitazione. Si notano i pilotis che svuotanoil pian terreno permettendo il passaggio auto (c’è unvero e proprio percorso d’entrata e d’uscita).All’interno del vuoto del pian terreno, come detto è nascosto un corpo difabbrica a forma di U con perimetrali vetrati. Il corpo principale èintonacato in bianco per risaltare le forme e si nota la presenza delletipiche finestre a nastro e di aperture a livello di terrazza che seguonol’andamento delle finestre. Si nota inoltre la presenza di un doppioterrazzamento, quello superiore che si articola in forme circolari ecollegati da serie di rampe. Rampa che è presente anche nel livellobasamentale per collegare i “garage” con il piano nobile (rampa destinataai proprietari), mentre a lato è presente una scala a chioccioladestinata al passaggio della servitù. Particolare risulta essere lapresenza di un lavandino dietro la colonna posto all’entrata di fronte igarage. Un lavandino che fondamentalmente non servirebbe in quanto c’è lapresenza di un bagno di servizio. Con ciò L.C. vuole sottolineare che
41
l’auto diventa parte integrante dell’architettura che deve risponde anchealle necessità di quest’ultima.
IMMEUBLE VILLA: anticipando quella che sarà poi l’unitè d’habitation diMarsiglia, L.C. inizia a progettare una tipologia di complesso edilizioche rappresentasse una città all’interno di una città. Egli per questasua idea prevedeva la creazione di un immenso complesso edilizioautosufficiente all’interno del quale fosse stato presente tutto ilnecessario per la vita quotidiana.Da qui si passa quindi a parlare della realizzazione in un certo modolimitato per dimensioni ( immaginava un complesso ancora più ampio) dellasua idea con l’UNITE’ D’HABITATION. Questo risulta essere un complesso di dimensionistraordinarie (165x56x24) sviluppato su 17 piani e con 337alloggi di 23 tagli differenti. Un complesso edilizio chesvetta in quello che è il contesto urbano di Marsiglia eall’interno del quale sono presenti i servizi necessarialla vita quotidiano. In questo complesso riscontriamotutti quelli che sono i 5 punti di L.C.. primo fra tuttied indispensabile la presenza di grandi pilastri portantiche permettono lo svuotamento a terra. Da ciò deriva lafacciata libera dell’edificio che poi viene decorata con dellecolorazioni che ne caratterizzano il prospetto. Vi è poi la presenzadella pianta libera che spiega anche meglio la presenza di 23 taglidifferenti per gli alloggi. Vi è infine la presenza di enorme tettogiardino all’interno del quale sono presenti moltissime attività dallapalestra all’asilo nido. Guardando bene il lato lungo, si nota lapresenza di Brie – soleil (sorte di schermature in cemento) chepermettono il minor irraggiamento solare. Questo ci dice che in quelpunto non sono presenti alloggi bensì quei servizi necessari che L.C.aveva previsto per l’unitè d’habitation. Ritroviamo quindi ristoranti,negozi, farmacia ecc… per quanto riguarda la composizione degli alloggisi nota come egli utilizzi il sistema duplex per cui gli alloggi erano adoppia altezza incastrati tra loro ed all’interno di questa intersezioneera presente il corridoio d’accesso proprio come fossero delle strade dicollegamento ma all’interno di un edificio.
NOTRE DAME DU HAUTE: è senza dubbio uno dei capolavoridell’architettura religiosa moderna. la chiesa nasce su unacollina e decide di progettare e strutturare questo edificioseguendo forme e linee meno rigorose. Ecco che quindi sinota la presenza di una grande tettoia a forma di scafo. Unoscafo leggero che sembra quasi levitare in aria poichépoggiato non direttamente sui muri perimetrali, ma supilastri in ferro inseriti all’interno di essi (se si vededall’interno si nota una striscia di luce). La struttura non è costruitatotalmente in cemento armato ma in muratura con pietre locali e soltanto
42
con alcune sezioni in cemento armato. Il tutto è rivestito grezzamente daun intonaco bianco. Sui muri perimetrali si notano delle aperture dalleforme più disparate che tagliando l’intero spessore del muro creanoeffetti di luce suggestivi all’interno della chiesa. Da notare è inoltrela presenza di un secondo altare esterno che risulta molto funzionale perle cerimonie che venivano svolte all’aperto.
TERRAGNI: il periodo fascista è sempre stato in un certo sensooscurato in tutti i suoi aspetti compresi quelli artisticiarchitettonici. Un occultamento che in un certo periodo fu necessarioabolire in quanto molti edifici costruiti in questo periodo necessitavanodi restaurazione. Ciò porta gli architetti a studiare la storia di questiedifici ed i materiali di cui sono composti, portando alla riscoperta diuna fase architettonica che nonostante il periodo in cui è collocatarisulta essere molto importante. In Italia in questo periodo si istaurail fascismo che per natura vuole riportare l’Italia agli antichisplendori seguendo quella che è la tradizione classicista in particolarmodo attraverso architetti come Piacentini. Tuttavia alcuni architetti,tentarono di lanciare l’Italia nel nuovo contesto europeo. Sono gli annidel GRUPPO 7, un gruppo di 7 architetti tra cui Terragni che seguendo unanuova ricerca architettonica volevano adattare la tradizione classicistaitaliana al contesto europeo moderno. Non avviene quindi un’imitazionepura di quelli che erano i temi di Le Corbusier ad esempio, ma siricercava la modernità ma con i piedi ancorati al passato. Uno dei primi edifici italiani in stile “moderno” del tempo fu ilNOVOCOMUM a Como di Terragni. Questo risulta essere un edificio d’appartamenti. Per l’edificazione diquesto edificio, Terragni propose un progetto moltoaulico, classicheggiante che fu ben accettato, madurante i lavori stravolse il suo progetto e necostruì un altro molto più all’avanguardia e che loportò di fronte a molte accuse e cause legali chetuttavia l’architetto vinse. Si nota comel’edificio abbia un impianto ad E e presenti dellesbordature angolari che sono ricompattateall’ultimo livello da un corpo angolare confinestre a nastro (inizialmente prevedeva un corpostondato centrale dove inserire le scale. Si nota inoltre la presenza diuna terrazza sul modello di Le Corbusier. Tuttavia questa apertura, adifferenza di quelle degli edifici di L.C. non doveva rimediare ad alcunvuoto basamentale. Per quanto riguarda le scale, vediamo come esseassumano una forma triangolare e siano poste sul corrispondente dellacurvatura angolare li dove i diversi corpi di fabbrica si vanno ad unire.Una scalinata che esternamente è annunciata da una vetrata invetrocemento. Si nota inoltre come il corpo aggetti rispetto al pianobasamentale. Per quanto riguarda gli ambienti interni, essi sono filtratida vetrate per creare un continuo tra essi e con l’esterno.
43
Dopo questa prima esperienza avanguardista, nel 1930 si fonda ilmovimento italiano per l’architettura razionale. Un movimento questo cheinizialmente non fu ben visto dal regime in quanto contrastava con l’ariaclassicheggiante che si respirava in Italia. Motivo questo che con loscritto RAPPORTO SULL’ARCHITETTURA (PER MUSSOLINI) cercarono diingraziarsi il duce affermando che con la loro architettura potevanorappresentare bene i principi del regime. Tuttaviacontro il MIAR andrà anche il sindacato degliarchitetti che con Piacentini non riconoscevano escreditavano questa tipologia di architettura.Un’architettura che tuttavia fu apprezzata dalregime che così poteva affacciarsi maggiormente nelcontesto europeo tanto che allo stesso Terragni fuaffidata la costruzione della casa del fascio aComo.CASA DEL FASCIO: questo edificio si trovava di fronte alla ex Piazzadell’Impero a Como nel centro città e doveva rappresentare un luogo diriunione e di potere del regime fascista. L’edificio presenta uninscatolato cubico con facciate l’una diversa dall’altra. L’intento diTerragni per questo edificio era quello di aggettare l’edificio sullapiazza attraverso dei congegni meccanici di apertura e chiusura dellevetrate così da rendere lo spazio urbano a disposizione dell’edificio.L’edificio denuncia la sua monumentalità anche grazie al rialzo di tregradini rispetto al piano stradale come stesse su un podio. Al centro èpresente un atrio coperto in vetro cemento. Una struttura questa chericorda l’antico palazzo rivisitato in chiave moderna. si nota inoltreche non vi è la presenza di pilotis ma di una maglia strutturaleperimetrale che diventa parte integrante della facciata andando a crearedei vuoti. Come per il novocomum vi è la presenza di filtri in vetroproprio per creare un continuo tra interno ed esterno. Su un prospetto sinota come vi sia una parte strutturale a vista ed una superficie piena inlastre di marmo sopra la quale vennero scolpiti bassorilievi e iscrizioniinerenti al fascismo.--