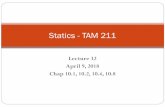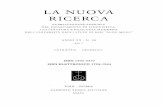Pro tam magna sui confidentia.
Transcript of Pro tam magna sui confidentia.
I diritti degli altri in Grecia e a Roma
a cura di Alberto Maffi e Lorenzo Gagliardi
Academia Verlag Sankt Augustin
Volume stampato con il contributo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del progetto Prin 2007 “I diritti degli altri in Grecia e a Roma”
(Coordinatore nazionale Prof. Alberto Maffi) e dell’Università degli Studi di Milano.
Alberto Maffi ha curato la sezione I; Lorenzo Gagliardi le sezioni II-V.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 978-3-89665-557-8
1. Auflage 2011
© Academia Verlag Bahnstraße 7, D-53757 Sankt Augustin
Internet: www.academia-verlag.de E-Mail: [email protected]
Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten
Ohne schriftliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Werk unter Verwendung mechanischer, elektronischer und anderer Systeme in
irgendeiner Weise zu verarbeiten und zu verbreiten. Insbesondere vorbehalten sind die Rechte der Vervielfältigung – auch von Teilen des Werkes –
auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege, der tontechnischen Wiedergabe, des Vortrags, der Funk- und Fernsehsendung, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, der Übersetzung und der literarischen
und anderweitigen Bearbeitung.
Giovanna Mancini
Pro tam magna sui confidentia
Nella storia degli ordinamenti giuridici romani, la presenza degli ‘altri’ si manifesta sia in termini di opposizione tra chi è parte del populus e chi, i pere-grini, non lo è, sia, nell’ambito del popolo stesso, in termini di esclusione perpe-tua dal novero di quanti hanno pienezza di diritti.
Le ragioni di questa condizione di minorità sono molteplici. Una di queste è legata all’infirmitas sexus.
È, però, quella delle donne, una strana infirmitas. Si tratta, intanto, di una condizione che solo in alcuni – anche se lunghissimi – periodi è considerata ‘patologica’; i cui sintomi – per meglio dire – non sono riferiti nell’esperienza romana, in maniera ininterrotta, alla donna in quanto tale: nell’età dell’espansio-ne romana, nelle vicende pratiche della vita, nelle norme giuridiche, nella consi-derazione sociale e culturale, le donne, almeno le donne romane, sembrano es-serne esenti1. È, soprattutto, un male che, quando è diagnosticato, si trova a giu-stificare – anche contemporaneamente – l’adozione di misure ‘profilattiche’ e ‘terapeutiche’ opposte.
Alcune di queste, pure segnate da apparente contraddittorietà, sono in alcune costituzioni emanate da Costantino tra gli anni ’20 e gli anni ’30 del IV secolo.
1. Il ratto prima di Costantino. Iniziamo da una costituzione ben nota, CTh.9.24.1, che reca la – nuova –
disciplina costantiniana sul ratto, che negli ultimi anni è stata oggetto di rinnova---------------------------------------------
1 Nettissima è la testimonianza di Paolo, D.5.1.12.2 (17 ad ed.): Non autem omnes iudices dari possunt ab his qui iudicis dandi ius habent: quidam enim lege impediuntur ne iudices sint, quidam natura, quidam moribus. Natura, ut surdus mutus: et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent. lege impeditur, qui senatu motus est. moribus feminae et servi, non quia non habent iudicium, sed quia receptum est, ut civilibus officiis non fungantur. Non la natura, ma esclusivamente i mores escludono la donna da uno dei compiti intellettualmente ed emotivamente più delicati, quello di giudicare in un processo.
Sulla condizione della donna la letteratura è amplissima, v., per tutti, E. CANTARELLA, Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, Milano 1996 e, anche in riferimento alla capacità patrimoniale delle donne romane, L. PEPPE, Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana, Milano 1984, passim. Un quadro del modello di debolezza femminile nelle fonti latine, ora in G. RIZZELLI, “In has servandae integritatis custodias nulla libido inrumpet” (Sen. contr. 2.7.3). Donne, passione, violenza, in F. LUCREZI, F. BOTTA, G. RIZZELLI, Violenza sessuale e società antiche, Lecce 2003, passim, ove in nt. 3 ulteriori riferimenti bibliografici. Sull’infirmi-tas/fragilitas, si veda anche, con argomentazioni e conclusioni non tutte condivisibili sul cambiamen-to di prospettiva dall’età classica al tardoantico, J. BEAUCHAMP, La faiblesse féminine dans les textes juridiques, in TJD 54 (1976), 485 ss.
Pro tam magna sui confidentia 153
153
ta attenzione, in ambiti di interesse diversi, da parte di Salvatore Puliatti, Giunio Rizzelli e Fabio Botta2, Autori che, tutti, finiscono col convergere nel ricondurre – almeno per l’età immediatamente precedente a quella costantiniana – la perse-guibilità del ratto al crimen vis.
Il Puliatti, in particolare, la riferisce alla lex Iulia de vi, pur sottolineando il fatto che la pena per esso irrogata non era quella originariamente prevista in tale legge – la deportatio – ma quella di morte3.
Dell’irrogazione della pena di morte al rapitore, ben prima della costituzione costantiniana, il Puliatti – come già la Desanti – porta a testimonianza un passo delle Institutiones4 di Marciano in cui è detto che qui … rapuit … ultimo suppli-cio punitur. Nello stesso passo, il giurista severiano, negando che al ratto possa applicarsi la lex Iulia de adulteriis coercendis, afferma anche che – se pure vi sia stata remissione dell’iniuria al colpevole da parte del pater della donna – l’accusa per il crimine resti comunque aperta a qualunque estraneo e senza ter-mini di prescrizione.
Dal passo è stata, dunque, tratta anche conferma5 dell’esistenza di una prassi – se non regolamentata, almeno tollerata, prima di Marciano – di un accordo con la vittima e il padre di lei, relativo a un susseguente matrimonio, che avrebbe dato al reo la possibilità di sottrarsi alla pena di morte; soluzione negata, nella
-------------------------------------------- 2 Il ratto di una donna, la sua sottrazione e sequestro, può assumere connotazioni diverse, penal-
mente rilevanti, a seconda della condizione di quella e delle circostanze che lo accompagnano. Entra-no, perciò, in campo possibili sovrapposizioni di ipotesi di reato previste dalle leggi precostantiniane e da loro estensioni applicative extra ordinem dovute, presumibilmente, all’opera della giurispruden-za imperiale: dalla lex Iulia de adulteriis – in caso di stuprum/adulterium violento susseguente al ratto, ove la violenza costituisce eventuale scriminante per la donna – a quella de vi, all’actio iniuria-rum. Si vedano, per il quadro più recente della dottrina: S. PULIATTI, La dicotomia “vir-mulier” e la disciplina del ratto nelle fonti legislative tardo-imperiali, in SDHI 61 (1995), 471-529, ove 480-481 un sintentico quadro del regime precostantiniano, G. RIZZELLI, La “lex Iulia de adulteriis”. Studi sulla disciplina di “adulterium”, “lenocinium” e “stuprum”, Lecce 1997, 249 ss., F. BOTTA, “Per vim inferre”. Studi su “stuprum” violento e “raptus” nel diritto romano e bizantino, Cagliari 2004, in partic. 81-91, con ampia discussione della precedente dottrina. Lo stesso tema era stato già oggetto di studio specifico da parte della L. DESANTI, Costantino il ratto e il matrimonio riparatore, in SDHI 52 (1986), 195-217 e di J. EVANS GRUBBS, Abduction Marriage in Antiquity: a Law of Constantine (CTh.9.24.1) and its Social Context, in JRS 79 (1989), 59-83, che identifica, come la DESANTI, il comportamento represso con il ratto a fini matrimoniali, utilizzando anche risultati di studi antropo-logici, e definisce l’editto “one of the Constantine’s crueller and more irrational laws” (60).
3 Sulle difficoltà di dare un quadro certo del regime giuridico del ratto prima del IV secolo e sullo stato della discussione in dottrina, si veda S. PULIATTI, La dicotomia “vir-mulier”, cit., 474 ss. e nt. 11; cfr. F. BOTTA, “Per vim inferre” loc. ult. cit. Un’ampia disamina delle posizioni dottrinali sul possibile inquadramento del crimen già in F. GORIA, s.v. Ratto, in ED 38 (1987), 707-724.
4 D.48.6.5.2 (Marcian. 14 inst.) Qui vacantem mulierem rapuit vel nuptam, ultimo supplicio puni-tur et, si pater iniuriam suam precibus exoratus remiserit, tamen extraneus sine quinquennii prae-scriptione reum postulare poterit, cum raptus crimen legis Iuliae de adulteris potestatem excedit.
5 L. DESANTI , Costantino il ratto e il matrimonio, cit., 208 ss.
154 Giovanna Mancini
sostanza, da Marciano, ma che troveremo di nuovo, secoli più tardi, nelle formu-le merovingie6.
Al di là dei sospetti di interpolazione, che pure sono stati avanzati7, è inne-gabile che, in fonti letterarie già del I secolo8, esistano richiami sia all’applica-zione della pena di morte al rapitore, sia alla possibilità di evitarla con la compo-sizione.
È, d’altronde, lo stesso Costantino a delineare quello ius vetus che sta abro-gando come caratterizzato da una pena di morte, che poteva, però, essere evitata se la rapita avesse acconsentito al matrimonio (patrocinium ex eius responsione sperans), con l’accordo dei parenti9.
Ma di quale crimen era chiamato a rispondere il rapitore? Se l’iniuria perdonata dal pater non può ovviamente riferirsi all’actio iniu-
riarum civile, le qualificazioni possibili, che le fonti giuridiche antecedenti a CTh. 9.24.1 suggeriscono, sono quelle riconducibili alle leges Iuliae all’epoca vigenti: quella de adulteriis – se si ritiene che essa già punisca come stuprum non solo l’adulterium, ma qualunque unione sessuale fuori del matrimonio con una donna onorata10 e che l’accusa riguardi, appunto, lo stuprum susseguente al ratto – o quella de vi, che punisce la violenza. Anche a non voler tener conto dell’esclusione fatta da Marciano dell’applicabilità della prima, la pena prevista per stuprum/adulterium è ancora quella della relegatio11, mentre lo stupro vio-
-------------------------------------------- 6 Si vedano in MGH, Formulae Merowingici et Karolini aevi, K. ZEWMER (ed.), Hannover 1886,
le Formulae Turonenses (VIII sec.) n.16 – recante un contratto di espiazione per il ratto, 143-144 – e n.32, relativa al ratto di consenziente con successivo matrimonio, per il quale è possibile la composi-zione ed è prevista la prescizione nel quinquennio dell’azione, anche se secundum legem Romanam pro hac culpa ambo pariter vitae periculum incurrissent, 154-155. Sul permanere della prassi e sul concorde orientamento della stessa chiesa, v. sotto. Par. 4.4.
7 V. index itp.; cfr. L. DESANTI, Costantino il ratto e il matrimonio, cit., 208 e nt. 54; sull’inquadramento della disciplina ricavabile dal passo di Marciano, v. S. PULIATTI, La dicotomia “vir-mulier”, cit., 457 ss. e, da altro punto di vista, F. BOTTA, “Per vim inferre” loc. ult. cit.
8 Sen. contr. 1.5, 3.5, 7.8; Calp. decl. 16, 25. 34, 41, 49; Quint. decl. 247, 252, 262, 270, 280, 286, 301, 368 e inst. 9.2.90, su cui, in particolare J. EVANS GRUBBS, Abduction Marriage, cit., 68 ss.
9 Nello stesso senso, L. DESANTI, Costantino il ratto e il matrimonio, cit., 209-211, che individua, giustamente, nella responsio la risposta data in sede processuale. Tale ricostruzione, che si condivi-de, getta, però, ulteriori ombre sulla genuinità del testo di Marciano, ove non si voglia considerare la sua una posizione isolata e anticipatrice, nell’ambito di uno ius ancora controversum.
10 Avanza motivati dubbi G. RIZZELLI, La “lex Iulia de adulteriis”, cit., 212 ss. Anche a non voler accogliere l’idea che la lex sanzionasse in origine esclusivamente adulterio e – forse – incesto, non qualunque unione sessuale, fuori del matrimonio, è generale convinzione che, comunque, in essa fossero assenti norme relative all’unione sessuale violenta: cfr. in tal senso S. PULIATTI, La dicotomia “vir-mulier”, cit., 478.
11 Paul. sent. 2.26.14: Adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam placuit coerceri: adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas insulas relegentur. La pena, più grave, della deporta-tio, non della morte, è comminata, secondo Marciano – D.48.18.5 (Marcian. 2 inst.) – quando all’adulterium vel stuprum si cumuli l’incestum.
Pro tam magna sui confidentia 155
155
lento pare essere assorbito nella disciplina della lex de vi12 in testimonianze la cui attendibilità è rafforzata dalla concessione, da parte di Adriano13, di una legittima difesa che può arrivare fino all’uccisione dello stupratore per vim da parte della vittima o dei suoi parenti; vi è, infine, una costituzione di Diocleziano del 29314, che riconduce il ratto alla stessa legge. La pena che appare applicata è, però, come abbiamo visto, differente da quella generalmente testimoniata, per l’epoca, per il crimen vis15. Il rapitore violento è, infatti, già nelle fonti letterarie del I-II secolo16, soggetto alla pena di morte, se la rapita non acconsenta alle nozze. Potremmo perciò pensare a una forma di repressione extra ordinem del crimen vis medesimo17.
Se l’ambito di applicazione della lex de vi si è evidentemente ampliato, la violenza non può, però, non essere elemento qualificativo essenziale dell’atto criminoso18. Deve, perciò, trattarsi di un rapere, un portare via con la forza con-
-------------------------------------------- 12 D.48.5.30.9 (Ulp. 4 de adult.) Eum autem, qui per vim stuprum intulit vel mari vel feminae, sine
praefinitione huius temporis accusari posse dubium non est, cum eum publicam vim committere nulla dubitatio est; D.48.6.3.4 (Marcian. 14 inst.) Praeterea punitur huius legis [la lex Iulia de vi] poena, qui puerum vel feminam vel quemquam per vim stupraverit. Sulla forme di repressione specifica dello stuprum come congiunzione carnale violenta, v. F. BOTTA, “Stuprum per vim illatum”, in F. LUCREZI, F. BOTTA, G. RIZZELLI, Violenza sessuale, cit., 55-104, nonché ID., “Per vim inferre”. Studi su “stuprum” violento e “raptus” nel diritto romano e bizantino, Cagliari 2004, in partic. 81-91. Sulla repressione come crimen vis dello stuprum violento e del ratto, v. G. Rizzelli, “La lex Iulia de adulteriis”, cit., 249 ss.; in entrambi gli A. ampia discussione della precedente dottrina.
13 D.48.8.1.4 (Marcian. 14 inst.) Item divus Hadrianus rescripsit eum, qui stuprum sibi vel suis per vim inferentem occidit, dimittendum.
14 C.9.12.3, Si confidis sponsam filii tui raptam esse vel filium tuum inclusum, instituere sollemni more legis Iuliae de vi accusationem apud praesidem provinciae non prohiberis. DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. BIANORI PP.VII K.MAI. VERONAE AA. CONSS. Sul rescritto avanza sospetti d’interpolazione, a mio avviso infondati, S. SOLAZZI, Costituzioni glossate o interpolate nel “Codex Justinianus”, in SDHI 24 (1958), 1-79.
15 La pena per il crimen vis era, per le fattispecie elencate nelle Paul. sent., la deportatio o la rele-gatio, per gli honestiores e la morte o la damnatio in metalla per gli humiliores, a seconda che si trattasse di vis publica o privata: Paul. sent. 5.26.1 e 3, cfr. B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano 19982, 261.
16 Quint. decl. 280; Sen. contr. 1.5 (la controversia è relativa al caso di un rapitore di due donne in una sola notte, una delle quali sceglie di sposarlo, l’altra di farlo mettere a morte), 3.5 (RAPTA RAPTORIS AVT MORTEM AVT INDOTATAS NVPTIAS OPTET Raptor postulat, ut rapta educatur. pater non vult), 7.8. (RAPTA RAPTORIS AVT MORTEM AVT INDOTATAS NVPTIAS OPTET. Rapta producta nuptias optavit. qui dicebatur raptor negavit se rapuisse. iudicio victus vult ducere; illa optionem petit); Calp. decl. 25 (Lex dicit: raptor aut pereat aut ducat. Ergo raptori si poena dimittitur, rapta[e] debetur).
17 In questo senso sembra orientato anche F. GORIA, s.v. Ratto, cit., 712 nt.30, ove, 708-714 essen-ziale ricostruzione della discussione in dottrina sulla collocazione sistematica del crimine (actio iniuriarum, vis, ex lege Iulia de adulteriis) a partire dall’articolata ipotesi ricostruttiva di J. COROI, La violence en droit criminel romain, Paris 1915, 209 e nt.4. Sulla trasformazione del raptus da crimen unilaterale vis a crimen commune autonomo, ma solo, appunto, con Costantino, v. F. BOTTA, “Per vim inferre”, cit., in partic. 81 ss., il quale pure propende per una “sussunzione extra ordinem del crimen sotto il regime della lex Iulia de vi” (78).
18 Cfr. D.47.9.3.5 (Ulp.56 ad ed.) Aliud esse autem rapi, aliud amoveri palam est, si quidem amo-veri aliquid etiam sine vi possit: rapi autem sine vi non potest, come rileva F. GORIA, s.v. Ratto, cit.,
156 Giovanna Mancini
tro la volontà, anche, della donna: se c’è consenso, non c’è ‘violenza’, anzi, anche un consenso ottenuto successivamente – è Costantino stesso a dirlo – avrebbe escluso, prima della sua riforma, la stessa punibilità dell’atto19.
2. L’editto di Costantino sulla repressione del ‘raptus’: CTh. 9.24.1.
Nella primavera del 32620 Costantino emana una costituzione che innova ra-dicalmente anche in questo campo.
Vediamone il testo: IMP. CONSTANTINUS A. AD POPULUM.
Si quis nihil cum parentibus puellae ante depectus invitam eam rapuerit vel volentem abduxerit, patrocinium ex eius responsione sperans, quam propter vitium levitatis et sexus mobilitatem atque consilii a postulationibus et testimoniis omnibusque rebus iudiciariis antiqui penitus arcuerunt, nihil ei secundum ius vetus prosit puellae responsio, sed ipsa puella potius socie-tate criminis obligetur. 1. Et quoniam parentum saepe custodiae nutricum fabulis et pravis suasionibus deluduntur, his primum, quarum detestabile ministerium fuisse arguitur redemptique discursus, poena immineat, ut eis meatus oris et faucium, qui nefaria hortamenta protulerit, liquentis plumbi ingestione claudatur. 2. Et si voluntatis assensio detegitur in virgine, eadem, qua raptor, severitate plectatur, quum neque his impunitas praestanda sit, quae rapiuntur invitae, quum et domi se usque ad coniunctionis diem serva-re potuerint et, si fores raptoris frangerentur audacia, vicinorum opem cla-moribus quaerere seque omnibus tueri conatibus. Sed his poenam leviorem imponimus solamque eis parentum negari successionem praecipimus. 3. Raptor autem indubitate convictus si appellare voluerit, minime audiatur. 4. Si quis vero servus raptus facinus dissimulatione praeteritum aut pactione transmissum detulerit in publicum, Latinitate donetur, aut, si Latinus sit, ci-vis fiat Romanus: parentibus, quorum maxime vindicta intererat, si patien-
-------------------------------------------- 713, nt.32.
19 L’astratta possibilità di leggere in queste parole di Costantino un riferimento non al consenso successivo al ratto, escludendo un significato processuale a patrocimium … responsione, ma a quello prestato dalla stessa abducta, è, a mio avviso, contraddetta sia dall’immediato successivo riferimento a funzioni processuali della mulier, sia dal secondo paragrafo dell’editto, che differenzia la posizione della rapta invita che presti successivamente l’assensio, da quella dell’abducta volens. Gli scenari presupposti dall’editto erano, dunque, tre.
20 Datazione incerta, ma, nell’ambito delle date possibili, sostanzialmente ininfluente ai fini dell’esame che ci proponiamo di farne. Quelle proposte vanno dal 318 (P. BRUUN, Studies in Con-stantinian Chronology, New York 1961, 42 e 44), al 320 (TH. MOMMSEN nell’edizione del Teodo-siano ad h.t.), al 326 (O. SEEK, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 276 n. Chr., Suttgart 1919, 61, 63, 176).
Pro tam magna sui confidentia 157
157
tiam praebuerint ac dolorem compresserint, deportatione plectendis. 5. Par-ticipes etiam et ministros raptoris citra discretionem sexus eadem poena praecipimus subiugari, et si quis inter haec ministeria servilis condicionis fuerit deprehensus, citra sexus discretionem eum concremari iubemus. DAT. KAL. APRIL. AQUILEIA, CONSTANTINO A. VI ET CONSTANTINO C. COSS.21 Il ratto costituisce, con essa, una fattispecie tipica di reato22, che si realizza
sia nello strappare con violenza dalla sua casa una fanciulla che non lo voglia, sia nel portarne via una che voglia seguire l’agente (invitam eam rapuerit vel volen-tem abduxerit); soggetto attivo del crimine non è più solo il rapitore23, ma anche la rapita, se consenziente. E lo è, anche se, rapta invita, abbia successivamente acconsentito alle nozze (nihil ei secundum ius vetus prosit puellae responsio, sed ipsa puella potius societate criminis obligetur).
Ogni possibilità di composizione, con susseguente matrimonio, è vietata, e anzi sono previsti premi per chi ne denunci l’esistenza; sui familiari incombe l’obbligo di denuncia, pena la deportazione. La rapta invita può anch’essa essere punita, ma con una pena minore – la perdita dei diritti successori familiari24 – ogni qual volta non sia riuscita a impedire il rapimento, o non restando al sicuro della casa fino al giorno del matrimonio (quum et domi se usque ad coniunctionis
-------------------------------------------- 21 Riporto anche il testo dell’INTERPRETATIO. Si cum parentibus puellae nihil quisquam ante
definiat, ut eam suo debeat coniugio sociare, et eam vel invitam rapuerit vel volentem, si raptori puella consentiat, pariter puniantur. Si quis vero ex amicis aut familia aut fortasse nutrices puellae consilium raptus dederint aut opportunitatem praebuerint rapiendi, liquefactum plumbum in ore et in faucibus suscipiant, ut merito illa pars corporis concludatur, de qua hortamenta sceleris ministrata noscuntur. Illae vero, quae rapiuntur invitae, quae non vocibus suis de raptore clamaverint, ut vicinorum vel parentum solatio adiutae liberari possent, parentum suorum eis successio denegetur. Raptori convicto appellare non liceat, sed statim inter ipsa discussionis initia a iudice puniatur. Quod si fortasse raptor cum parentibus puellae paciscatur, et raptus ultio parentum silentio fuerit praetermissa, si servus ista detulerit, latinam percipiat libertatem, si latinus fuerit, civis fiat roma-nus. Parentes vero, qui raptori in ea parte consenserint, exsilio deputentur. Qui vero raptori solatia praebuerint, sive viri sive feminae sint, ignibus concrementur. [Brev.9.19.1]
Le altre due costituzioni contenute nello stesso titolo, 9.24.2. e 9.24.3 sono, rispettivamente del figlio di Costantino, Costante e di Valente, Graziano e Valentiniano. Ce ne occuperemo più avanti.
22 Nello stesso senso, F. BOTTA cit. sopra nt. 17. Secondo C. DUPONT, Les constitutions de Cons-tantin et le droit privé au début du IVe siècle, Lille 1937 (rist. anast. Roma 1968), il ratto non confi-gurerebbe, nella normativa costantiniana, un delitto pubblico, perché il testo non dà a tutti la “copiam accusandi” (97), mi pare, però, che l’A. sottovaluti l’espressa possibilità di delazione da parte di schiavi e liberti.
Oggetto della repressione è, inoltre, il ratto in quanto tale, non lo stuprum ad esso presumibilmente ma non necessariamente conseguente, per il quale il raptor avrebbe potuto essere perseguito ex lege Iulia de adulteriis o de vi, mentre per la semplice abductio il pater avrebbe potuto agire, prima della riforma costantiniana, esclusivamente con l’actio iniuriarum.
23 Come sarà, nuovamente, nel regime giustinianeo (C.9.13). 24 Sul punto, v. P. VOCI, Il diritto ereditario romano nell’età del tardo impero, I, Il IV secolo.
Prima parte, in Iura 29 (1978), 17-113, 43 ss.
158 Giovanna Mancini
diem servare potuerint)25, oppure perché, pur se rapita in casa, dopo l’effrazione non abbia invocato con le grida l’aiuto dei vicini (vicinorum opem clamoribus quaerere) e non abbia fatto ogni tentativo di salvarsi (seque omnibus tueri cona-tibus).
Le pene, per gli autori del crimine e per i loro complici sono tutte capitis e atroci, come possiamo inferire da una successiva costituzione del figlio di Co-stantino26, che, una ventina d’anni dopo, ristabilisce la ‘semplice’ pena capitale, conservando la vivicrematio solo per gli schiavi, con la motivazione che l’atrocità del giudizio poteva costituire – ed evidentemente aveva costituito – un motivo di freno all’applicazione effettiva della legge.
L’emanazione di questa seconda costituzione ha fatto sì che nel testo della prima, riportato nel Teodosiano, cadesse la parte non più vigente; non conoscia-mo perciò la natura del particolare tipo di esecuzione capitale riservata agli autori del reato, anche se è rimasta l’indicazione di quella, particolarissima, riservata alla nutrice, che con fabulae27 e cattivi consigli fosse venuta meno al dovere di custodia: la forma di esecuzione sarà – in contrappasso – il chiudere quella bocca e quella gola da cui sono uscite esortazioni nefaste, con l’ingestione di piombo fuso28.
La legge trova, infine, applicazione esclusivamente nel caso in cui il rapitore non abbia, prima del ratto, concluso nessun accordo con i parenti (nihil cum parentibus puellae ante depectus). --------------------------------------------
25 Col non restare chiusa in casa fino al momento delle nozze, la puella sarebbe venuta meno a uno dei canoni di comportamento imposti alle donne honestae, a tutela della loro pudicitia istigando, per tale via, allo stesso rapimento; cfr. G. RIZZELLI, “In has servandae integritatis custodias”, cit., 125-126.
26 CTh. 9.24.2, IMP. CONSTANTIUS A. AD TATIANUM. Quamvis legis prioris extet auctoritas, qua inclytus pater noster contra raptores atrocissime iusserat vindicari, tamen nos tantummodo capi-talem poenam constituimus, videlicet ne sub specie atrocioris iudicii aliqua in ulciscendo crimine dilatio nasceretur. In audaciam vero servilem dispari supplicio mensura legum impendenda est, ut perurendi subiciantur ignibus, nisi a tanto facinore saltem poenarum acerbitate revocentur. DAT. II ID. NOV. LIMENIO ET CATULLINO CONSS. (12 nov. 349). Se si dovesse intendere l’espressione poena capitalis nel senso più esatto, quello non della morte fisica, ma di quella civile, la deportatio o, eventualmente, la damnatio in metalla – cfr. E. LEVY, Die römische Kapitalstrafe (1930-1931), in Gesammelte Scriften, II, Köln-Graz 1963, 356 ss. –, si potrebbe pensare alla irrogazione, da parte di Costantino, della semplice pena di morte a rapitore, puella volens e complici. A ciò mi pare ostare, però, la considerazione che l’intervento di Costanzo avrebbe, così, comminato al raptor una pena più lieve di quella attestata per l’età precedente a Costantino. Sull’identificazione della pena v. R. BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, Milano 19902, 170 nt. 8, 179 nt. 30 e 180 nt. 33; individua la pena costantiniana nella vivicrematio C. DUPONT, Le droit criminel dans les constitutions de Con-stantin, I, Le infractions, Lille 1953, 48 e D. GRODZYNSKI, Ravies et coupables: un essai d’interpretation de la loi IX.24.1 du Code Théodosien, in MEFRA 96 (1984), 712.
27 La traduzione più appropriata – pur nel suo anacronismo – di fabulae mi pare essere ‘storie ro-mantiche’.
28 CTh. 9.24.1: Et quoniam parentum saepe custodiae nutricum fabulis et pravis suasionibus delu-duntur, his primum, quarum detestabile ministerium fuisse arguitur redemptique discursus, poena immineat, ut eis meatus oris et faucium, qui nefaria hortamenta protulerit, liquentis plumbi ingestio-ne claudatur.
Pro tam magna sui confidentia 159
159
3. Cenni sugli sviluppi della disciplina costantiniana. L’adesione alle nuove regole deve essere stata, però, tutt’altro che immediata
e diffusa – come dimostrano i successivi interventi imperiali che fanno intrave-dere la persistenza di matrimoni conseguenti a ratti29 – e la loro stessa applica-zione in sede repressiva insufficiente, forse per la sproporzione avvertita tra crimine e punizione, come traspare dalla costituzione di Costanzo.
Il ratto sarà oggetto, due secoli più tardi, di una riforma organica da parte di Giustiniano, che eliminerà proprio quelli che appaiono essere i principali ele-menti di novità della normativa costantiniana. Sarà l’atto violento (per vim rape-re) in sé a far sussistere il reato, non trovando più rilevanza gli accordi con i parentes, né sarà più punibile la donna consenziente, non, però, perché la sua volontà abbia rilevanza, ma – al contrario – perché quello della donna è un con-senso ineluttabilmente viziato: l’infirmitas sexus non le dà il giudizio sufficiente a resistere alla circonvenzione del rapitore30.
Cinque sono gli aspetti particolarmente singolari in CTh. 9.24.1 L’esclusione di punibilità per il depectus, l’atrocità simbolica di una delle pene, il premio alla delazione, e, a considerare il ratto – come nell’ordinamento preesistente e in quelli che seguiranno, un crimen vis – la sua punibilità anche quando la puella fosse stata portata via senza l’uso della violenza (abducta). Vi è infine – ma l’ordinamento romano conosceva già un caso, l’adulterio, in cui la stessa parte lesa era sanzionata per la mancata accusa – l’onere imposto ai parentes di de-nunciare l’avvenuto rapimento e, sopratutto, di non consentire una composizio-ne.
-------------------------------------------- 29 Se la maggior parte di essi hanno come obiettivo l’ampliamento delle fattispecie, relative alle
religiose, ricadenti nel crimine, si arriverà, tuttavia, con Valentiniano e Valente CTh. 9.24.3 [=Brev. 9.19.2] a prevedere la prescrizione quinquennale dell’azione relativa, con conseguente sanatoria del rapporto matrimoniale instaurato: Qui coniugium raptus scelere contractum voluerit accusare, sive propriae familiae dedecus eum moverit seu commune odium delictorum, inter ipsa statim exordia insignem recenti flagitio vexet audaciam. Sed si quo casu quis vel accusationem differat vel reatum, et opprimi e vestigio atrociter commissa nequiverint, ad persecutionem criminis ex die sceleris admissi quinquennii tribuimus facultatem. Quo sine metu interpellationis et complemento accusatio-nis exacto, nulli deinceps copia patebit arguendi, nec de coniugio aut sobole disputandi. Dat. XVIII. Kal. Dec. Gratiano A. III. et Equitio coss. Sul diverso impianto di politica legislativa, in materia, degli imperatori del V secolo, v. sotto par. 9.
30 C.9.13.1.3B. Si enim ipsi raptores metu atrocitatis poenae ab huiusmodi facinore temptaverint se, nulli mulieri sive volenti sive nolenti peccandi locus relinquetur, quia hoc ipsum velle mulieri ab insidiis nequissimi hominis qui meditatur rapinam inducitur. Nisi etenim eam sollicitaverit, nisi odiosis artibus circumvenerit, non facit eam velle in tantum dedecus sese prodere. Sulle novità della disciplina giustinianea, v. F. BOTTA, “Per vim inferre”, cit., 153 ss.
160 Giovanna Mancini
4. Il bene protetto e il contesto normativo. Costantino avrebbe emanato la legge per la “accresciuta frequenza e diffu-
sione del fenomeno e [al]la inadeguatezza della precedente regolamentazione”31; motivazione che non spiega, però, le peculiarità sopra evidenziate, che divengo-no, inoltre, ancora più evidenti se leggiamo CTh. 9.24.1 in parallelo con costitu-zioni a cavallo degli stessi anni e di argomento affine32.
Quello che, soprattutto, non mi pare sufficientemente definito – dietro il ve-lamen del termine raptus – è il bene tutelato con la repressione criminale.
4.1. È difficile pensare che oggetto della repressione sia l’attentato alla pudi-citia della fanciulla: una costituzione, sempre di Costantino e presumibilmente contemporanea alla nostra, punisce, infatti, il tutore che abbia abusato della pu-pilla con la semplice deportazione e con la confisca dei beni, anche se, è la stessa costituzione a dirlo, dovrebbe essere sottoposto alla stessa pena che le leggi im-pongono ai rapitori.33
-------------------------------------------- 31 L. DESANTI, Costantino il ratto, cit., 204, cui aderisce S. PULIATTI, La dicotomia “vir-mulier”,
cit., 483 nt. 33 e 494 nt.60, con riferimento all’idea della C. DUPONT, Le droit criminel, cit., 49, che la persecuzione costantiniana del ratto trovi ragioni nell’estensione del fenomeno e nelle preoccupa-zioni della chiesa in proposito. Sul punto v. sotto par. 4.4.
32 Utilizzeremo essenzialmente la produzione normativa di Costantino, limitandoci, solo quando questo sia indispensabile per meglio intenderne la peculiarità, a qualche riferimento a quella succes-siva.
33 CTh. 9.8.1 [=Brev. 9.5.1], IMP. CONSTANTINUS A. AD BASSUM VICARIUM ITALIAE. Post alia: Ubi puellae ad annos adultae aetatis accesserint et adspirare ad nuptias coeperint, tutores necesse habeant comprobare, quod puellae sit intemerata virginitas, cuius coniunctio postulatur. Quod ne latius porrigatur, hic solus debet tutorem nexus adstringere, ut se ipsum probet ab iniuria laesi pudoris immunem. Quod ubi constiterit, omni metu liber optata coniunctione frui debebit; officio servaturo, ut, si violatae castitatis apud ipsum facinus haereat, deportatione plectatur, atque univer-sae eius facultates fisci viribus vindicentur, quamvis eam poenam debuerit sustinere, quam raptori leges imponunt. DAT. PRID. NON. APRIL. AQUILEIA, CONSTANTINO A. VI ET CONSTANTINO C. COSS.
R. ASTOLFI, Il fidanzamento in diritto romano, Padova 19943, 106, istituisce un rapporto tra le due costituzioni, valorizza l’identica sanzione di invalidità del matrimonio, ma nota pure la diversità della pena, non se ne chiede, però, il perché. Analogamente P. VOCI, Il diritto ereditario romano, cit., 17-113, 43-44 – richiamando O. SEECK, Regesten der Kaiser und Papste fur die Jahre 311 bis 476 n. Chr.: Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit, rist. Frankfürt 1984 (Stuttgart 1919) – sottolinea la contemporaneità delle due costituzioni, ma ascrive la ratio di entrambe alla “difesa dei costumi”. L. DESANTI, Costantino e il matrimonio tutore-pupilla, in BIDR 99 (1986), 443-463, valorizzando le diverse lezioni del testo nel Teodosiano e nel Codice (9.10.1), ritiene che la fattispecie prevista sia quella del tutore (impuberum) che, a fini di matrimonio avrebbe sedotto la pupilla per indurla a consentire alle nozze, giustificando in questo modo il richiamo alla pena per il ratto, che per la stessa A. è configurato come “sottrazione che si traduce in matrimonio o, se voglia-mo, il matrimonio estorto mediante la violenza e il ricatto” (448); medesimo sarebbe il fine persegui-to, il matrimonio, diversi gli strumenti dell’estorsione del consenso: seduzione e violenza. La rico-struzione presuppone una, indimostrata, maggiore affidabilità del Breviarium (9.5.1.) e, comunque anche nel testo di quest’ultimo, se a volere le nozze oggetto della previsione fosse stato ‘il’ tutore, il richiamo ‘ai’ tutores non avrebbe senso alcuno; cfr., infine J. EVANS GRUBBS, Law and Family in Late Antiquity. The emperor Constantine, Oxford 1999, 193 ss.
Pro tam magna sui confidentia 161
161
Se l’intento di Costantino fosse stato quello di salvaguardare la virgo anche da se stessa, la condanna per chi, avendo la responsabilità della sua protezione, l’avesse sedotta, avrebbe dovuto certamente essere più grave. Il tutore è, invece, sottoposto alla pena capitale più lieve, la deportatio; gli amanti fuggitivi alla morte, irrogata, presumibilmente, in forma atroce.
Sempre nello stesso anno – e sempre promettendo un premio al delatore – l’imperatore irroga, invece, la pena di morte all’ingenua che mantiene una rela-zione con il proprio schiavo. La legge si applica retroattivamente – anche se con la pena della relegatio dalla provincia34 – riduce i figli nati dall’unione in una condizione di nuda libertas, privandoli di ogni dignitas, li esclude, infine, da ogni forma di successione ereditaria alla madre, chiamando alla sua successione intestata eventuali figli legittimi, o i parenti35.
Anche le sanzioni del SC Claudianum sono aggravate: la donna che si sia unita a uno schiavo altrui è ridotta – anche in mancanza delle denuntiationes del proprietario – allo stato servile e i figli nascono schiavi36. In questo quadro, sin-golare appare il fatto che Costantino faccia, invece, eccezione per le unioni con gli schiavi del fisco: la madre resterà libera, anche se i figli nasceranno latini Iuniani. Non solo: nella stessa costituzione dispone, anche, l’esenzione, in questa
-------------------------------------------- 34 CTh. 9.9.1. [=Brev. 9.6.1] IMP. CONSTANTINUS A. AD POPULUM. Si qua cum servo occulte rem
habere detegitur, capitali sententiae subiugetur, tradendo ignibus verberone, sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, quum falsae accusationi poena immineat. 1. Ante legem nupta tali consortio segregetur, non solum domo, verum etiam provinciae communione privata, amati abscessum defleat relegati. 2. Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuerit, exuti omnibus dignitatis insignibus, in nuda maneant libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris. 3. Successio autem mulieris ab intestato vel filiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit, ita ut et quod ille, qui quondam amatus est, et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videntur habuisse substantia, dominio mulieris sociatum a memoratis successoribus vindicetur. 4. His ita omnibus observandis, et si ante legem decessit mulier vel amatus, quoniam vel unus auctor vitii censurae occurrit. 5. Sin vero iam uterque decessit, soboli parcimus, ne defunctorum parentum vitiis praegravetur; sint filii, sint potiores fratribus, proximis atque cognatis, sint relictae successionis heredes. 6. Post legem enim hoc committentes morte punimus. Qui vero ex lege disiuncti clam denuo convenerint, congressus vetitos renovantes, hi servorum indicio vel speculantis officii vel etiam proximorum delatione convicti poenam similem sustinebunt. DAT. IV. KAL. IUN. SERDICAE, CONSTANTINO A .VII ET CONSTANTIO C. COSS. Sulla norma transitoria in materia di successione dei figli, v. P. VOCI, Il diritto ereditario romano, cit., 28-29.
35 La legge sembra colmare un vuoto legislativo, cfr. da ultimo G. RIZZELLI, La “lex Iulia de adul-teriis”, cit., 228-230, applicandosi il SC Claudianum esclusivamente alle unioni con servi altrui. Le finalità sono, tuttavia, diverse: il SC tutelava i diritti del dominus, le due constitutiones costantiniane reprimono le unioni ineguali. Sulla costituzione costantiniana, v. M.L. NAVARRA, A proposito delle unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana, in Atti Accademia Romanistica Costanti-niana, VIII, Napoli 1990, 429 ss., S. PIETRINI, Sull’iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo), Milano 1996, 69 e nt. 94, J. EVANS GRUBBS, Law and Family, cit., 273 ss.
36 CTh. 4.12.1., del 314 e CTh. 4.12.4, del 331; cfr J. EVANS GRUBBS, Law and Family, cit., 264 ss. Il regime del Claudiano sarà ripristinato da Giuliano nel 362 (CTh. 4.12.5), che manterrà il privi-legio per le unioni con servi fiscales.
162 Giovanna Mancini
ipotesi, da ogni sanzione per error improvidus vel simplex ignorantia vel aetatis infirmae lapsus, circostanze che, tutte, in particolare l’ultima, non hanno nessuna rilevanza negli altri casi, in primo luogo nel raptus/abductio.
4.2. Ugualmente difficile è individuare nella difesa della ‘onorabilità’ della donna e della famiglia la finalità perseguita: quando è questa preoccupazione a guidarlo, Costantino – presumibilmente a pochi giorni di distanza – sottrae all’accusa popolare l’adulterio, “perché non sia lecito a chiunque disonorare i matrimoni”, riservandola, oltre che al marito, ai familiari più stretti (ne volenti-bus temere liceat foedare connubia, proximis necessariisque personis solummo-do placet deferri copiam accusandi)37. Ancor più significativa della determina-zione imperiale di assicurare con tutti i mezzi efficacia all’edictum, mi pare, in questo quadro, la sollecitazione della delazione di persone di bassissimo ceto, schiavi e liberti, presumibilmente Iuniani38.
4.3. Oggetto di una repressione così feroce non è, neanche, l’uso della vio-lenza in sé considerata: la fuga consensuale, cui è estranea ogni forma di coazio-ne, è pienamente equiparata al ratto e anzi è proprio in relazione ad essa che è comminata la pena più emblematica.
4.4. Ancor meno si può, in questo caso, pensare a un qualche influsso della morale cristiana.
La chiesa non aveva mai proibito il matrimonio tra rapitore e vittima. Le prime statuizioni in questo senso sono, è vero, successive a Costantino39, con il riferimento usuale sia al richiamo contenuto nel Decretum Gratiani ad Ambro-gio40, sia a Basilio Magno41. Si potrebbe, dunque, pensare a una successiva mo-dificazione nell’orientamento dei padri – inizialmente consonante con quello di
-------------------------------------------- 37 CTh. 9.7.2 [=Brev. 9.4.2]. 38 Così come anche in CTh. 9.9.1 pr., la deduncia è aperta ai servi, come nota anche J. EVANS
GRUBBS, Abduction Marriage, cit., 61 e nt. 4. 39 Unico intervento in materia di ratto era stato quello, nel 314, col canone 11 del concilio di An-
cyra – C.J. HEFELE, Histoire des conciles, I (1855), trad. fr. H. LECLERCQ, Paris 1907, rist. anast. Hildesheim-New York 1973, 313 –, che si era limitato a obbligare il rapitore a restituire al suo fidan-zato la promessa sposa, anche se violentata, cfr. J. GAUDEMET, L’église dans l’empire romain (IVe-Ve siècles), Paris 1958, 524, mentre la prima sistemazione complessiva sarà data, sul finire del secolo, da Basilio Magno. Sulla contraddzione tra orientamenti cristiani coevi e la normativa costantiniana, v. anche C. CASTELLO, Legislazione costantiniana e conciliare in tema di scioglimento degli sponsali e di ratto, in Atti Accademia Romanistica Costantiniana, VIII, Napoli 1990, 391.
40 Ambr. apol. Dav. 42, in Decr. Grat. C.36, qu.2, c.9: Cum uoluntate parentum raptas in coniu-gium habere permittitur. Item Ambrosius in Apologia Dauid. [c. 8.] Denique et puellae illius pater, que uim concubitus nulli desponsata pertulerit, quinquaginta drachmas argenteas accipiet; ipsa autem in coniugio permanebit.
41 Basil. Ep. 199.30 e 38. La mancanza di proibizione del matrimonio tra rapitore e vittima è rile-vata da J. GAUDEMET, L’église, cit., 529 e nt. 3.
Il canone 14 del concilio di Elvira (tenutosi intorno all’anno 300) – v. il testo in C.J. HEFELE, Hi-stoire des conciles, cit., 214 – non fa cenno al ratto – né all’abductio – ma alla semplice unione sessuale prematrimoniale: il successivo matrimonio tra i due ne è considerata normale e auspicata conseguenza, che determina, anzi, una riduzione della pena per la moechata.
Pro tam magna sui confidentia 163
163
Costantino – se non fosse lo stesso Basilio a informarci, prima di esporre la sua opinione42, della mancanza di regole precedenti sul ratto43: Perˆ tîn ¢rpazÒntwn kanÒna mûn palaiÕn oÙk ücomen, „d…an dû gnèmhn ™poihs£meqa. La pena da lui indicata è, per rapitore e complici, di tre anni di esclusione dalle preghiere dei fedeli; se, però, non ha agito con violenza (biaˆwj), e non ci sono stati né stuprum (fqor¦), né furtum (klop»44) non deve essere punito. La vedova è indipendente e può decidere, mentre la fanciulla che ha seguito il rapitore contro la volontà del padre è colpevole di fornicazione, ma può essere perdonata, sottostando comunque alla pena di tre anni di astensione dai sacramenti.45
Il responsabile di stuprum – colpa diversa e indipendente dal ratto – è sotto-posto alla pena per questo, ma può sposare la donna (25. `O t¾n diefqarmšnhn Øf'˜autoà eˆj guna‹ka katšcwn tÕ mûn ™pˆ tª fqor> ™pit…mion Ø-post»setai, t¾n dû guna‹ka œcein sugcwrhq¹setai). La traduzione latina porta ‘stupratam’, ma non si tratta di uno stupro per vim: il termine greco equi-vale semplicemente a ‘sedotta, corrotta’ così come lo ‘stupratore’ è, propriamen-te, ‘seduttore, corruttore’.
La violenza, nei testi basiliani, è elemento eventuale e aggiuntivo, fonte di sanzione propria, mentre oggetto dell’insieme delle pene ecclesiali è la fornica-zione e, dunque, la corruzione, che implica consenso all’atto. D’altronde, sia fqor¦ sia stuprum non hanno il significato di unione sessuale violenta, contro la volontà della donna, ma semplicemente quello di ‘guasto, corruzione’ o ‘onta, disonore’ e quindi ‘seduzione, unione sessuale vietata’.
In insanabile contrasto con la disciplina costantiniana è, inoltre, il canone 22 della stessa epistola. Chi tiene presso di sé una donna a seguito di ratto (™x ¢rpagÁj) per essere riammesso alla comunità ecclesiale deve, se si tratta di una fidanzata, restituirla alla potestà di colui al quale era promessa, perché questi possa decidere se prendere la donna o lasciarla. Se la donna non era fidanzata,
-------------------------------------------- 42 Basil. Ep. 199.30 43 F. GORIA, s.v. Ratto, cit., 718-719 riferisce la discordanza dell’orientamento di Basilio alle –
eventuali – vicende di vigenza delle costituzioni costantiniane nella parte orientale, legate a una datazione antecedente al 326. A prescindere dal fatto che l’edictum generale difficilmente nei 50 anni successivi avrebbe potuto non essere conosciuto anche nella parte orientale, quello che qui rileva è l’inesistenza, in età coeva, di un consolidato orientamento ecclesiastico che avrebbe potuto condizio-nare l’imperatore.
44 La traduzione latina è furtum, ma il termine greco può indicare anche un comportamento clan-destino, furtivo, appunto.
45 Ep. 199.38. Singolare è che mentre Basilio riconosce piena autonomia di scelta, senza limiti di età, alla vedova (Ep. 199.30 AÙtexous…a dû ¼ c»ra, kaˆ ™p'aÙt? tÕ ¢kolouqÁsai) Valentiniano e Valente quattro anni prima avevano subordinato le seconde nozze delle minori di 25 anni all’approvazione del pater (C.5.4.18pr. Viduae intra quintum et vicesimum annum degentes, etiam si emancipationis libertate gaudent, tamen in secundas nuptias sine patris sententia non conveniant. VALENTIN. VALENS ET GRAT. AAA. AD SENATUM. D. XVII K. AUG. GRATIANO A. II ET PROBO CONSS. [a. 371]).
164 Giovanna Mancini
deve restituirla ai familiari46 e rimettersi alla loro volontà – siano essi i parentes o i fratelli o chiunque altro sia a capo di lei – per sposarla o no. Se questi scelgo-no di consegnargliela è istituito il matrimonio, se rifiutano deve astenersi da ogni violenza. Chi, comunque, ha una donna a seguito di corruzione (™k diafqor©j) nascosta o più violenta è colpevole di fornicazione (porne…a) e soggiace alla pena per essa dell’esclusione dalla comunità ecclesiale, articolata in quattro stadi annuali differenti.
Il rapitore, dunque, ha l’obbligo di porre fine al comportamento vietato, di sottrazione della donna alla disposizione di fidanzato o parenti, ma quella che gli è comminata per questo – e solo se abbia agito con violenza o in maniera furtiva o se ci sia stato stuprum – è una pena più lieve di quella prevista per la fornica-zione in quanto tale e l’avvenuto rapimento non gli impedisce – se tale è la vo-lontà di quanti hanno il potere di decisione in merito – le nozze con la rapta.47
4.5. Di recente, Fabio Botta ha giustamente identificato l’oggetto della vis e-sercitata dal raptor non nella donna, né in altre persone o cose, ma nel consenso del titolare del potere di disporre a fini matrimoniali della donna48.
-------------------------------------------- 46 Ep. 199.22. ToÝj ™x ¢rpagÁj œcontaj guna‹kas, ™i mûn ¨lloij promemnhsteumšnaj e|en
¢ferhmšnoi, oÙ prÒteron cr¾ paradšcesqai, prˆn ¢felšsqai aÙtîn, kaˆ ™p'™xousˆv tîn ™x'¢rcÁj mnhsteusamšuwn poiÁsai, e‡te boÝlointo labe‹v aÙt¦j, e‡te ¢postÁnai: ™i dû scol¦zous£n tij l£boi, ¢fairesqai mûn de‹, kaˆ to‹j o„ke…oij ¢poka…qist´n, ™pitršpein dû tÁ gnîmh tîn o„ke…wn, eŠte gone‹j eŠen, eŠte ¢delfoˆ, eŠte o„tinesoàn proestîtej tÁj kÕrhj: k¥n mûn ülwntai aut^ paradoànai, Šstasqai tÕ sunoikšsion: ™¦n dû ¢naneÝswsi, m¾ bi£zes£qai. TÕn mûntoi ™k diafqor©j eŠte laqraˆaj eŠte biaiotšraj guna‹ka ›konta ¢n£gnh tÕ tÁj porne…aj ™pignînai ™pit…mion. Üsti dû ™n tšssarsin ütesin èrismšnh to‹j porneÚosin ¹ ™pitˆmhsij. Segue la specificazione delle esclusioni imposte in ciascuno dei quattro anni.
Sul matrimonio come normale conseguenza del ratto nel Vecchio Testamento, ma anche negli apo-logisti e padri della chiesa, si veda – nell’ambito di una interessante ricerca sull’età minima matrimo-niale delle donne – D.A. MUSCA, La donna nel mondo pagano e nel mondo cristiano: le punte mini-me dell’età matrimoniale attraverso il materiale epigrafico (urbs Roma), in Atti Accademia Romani-stica Costantiniana, VIII, Napoli 1990, 178-179.
47 Quello che mi pare accomunare Costantino e Basilio è, invece, la sostanziale irrilevanza dell’espressione di volontà della puella. Se, infatti, per il secondo, il suo consenso all’allontanamento dalla casa è un elemento necessario, ma di per sé non sufficiente, ad escludere la violenza – e quindi, in assenza delle altre circostanze, la punibilità – anche in Basilio la puella è – che sia stata o meno consenziente al ratto – ‘oggetto’ di ‘restituzione’ e di, eventuale, ‘riconsegna’ ai fini matrimoniali. In ciò si va oltre la statuizione generale della necessità del consenso degli aventi potestà per l’esistenza del matrimonio – e dunque per la legittimità dell’unione sessuale (Ep. 199.42: Oi §neu tîn krato-Úntwn g£moi porne‹a… e„sin. OÜte oÏn patrÕj zîntoj, oÜte despÒtou, oi suniÒntej ¢neÚquno… e„sin. èj, ™£n ™pineÚswsin o„ kÚrioi t¾n suno…khsin, tÒte lamb£nei tÕ toà g£mou bûbaion). La vidua gode, certamente, di una posizione particolare: può disporre di sé. Ciò induce F. GORIA, s.v. Ratto, cit., 718-719, a ritenere che Basilio imposti “la problematica del matri-monio fra rapitore e rapita essenzialmente come una questione di libertà di consenso”, all’interno della quale, per la puella, sarebbe solo “dato un particolare peso all’assenso dei familiari”; mi sembra però che le parole di Basilio configurino quello dei familiari più che come consenso, aggiuntivo, come vero e proprio potere, esclusivo, di disposizione. Sottolinea come la soluzione di Basilio relati-va alla validità del matrimonio susseguente al ratto sia in radicale contrasto con il dettato costantinia-no J. EVANS GRUBBS, Abduction Marriage, cit., 73 ss.
48 F. BOTTA, “Per vim inferre”, cit., in particolare 153 ss.
Pro tam magna sui confidentia 165
165
Il bene protetto dalla repressione criminale costaniniana non può, tuttavia, es-sere la patria potestas in quanto tale, nel suo profilo privatistico: la contestuale sanzione della sua indisponibilità, mostra come essa abbia rilevanza in quanto strumentale alla tutela di un altro bene, di un interesse non generalmente ma propriamente pubblico49.
Un interesse che può trovare realizzazione, se si vuole mediata, proprio at-traverso la repressione di comportamenti in precedenza irrilevanti come cause d’imputazione di un crimine: l’abductio della puella volens, l’assenso della ra-gazza all’abductio, il consenso dei parentes al matrimonio eventualmente conse-guente, la “complicità” – nel senso di ‘partecipazione’ – di una nutrice nelle pene d’amore della fanciulla affidata alle sue cure.
Sono questi – non il ratto violento già, da oltre un secolo, sanzionato con la morte – i comportamenti che Costantino vuole cancellare dalla società dell’impero, utilizzando a questo scopo un apparato sanzionatorio terrificante.
C’è da chiedersi il perché. Nella visione di Costantino, la pena è dovuta, essenziale alla correzione de-
gli errori; deve essere perciò esemplare, per evitare che questi si ripetano50. Pro-prio, però, per la sua funzione pedagogica, la sua natura può darci elementi per individuare i principali obiettivi del legislatore; ancora più interessanti delle disposizioni sono forse, in questo quadro, le motivazioni, esplicite o implicite delle sanzioni stesse.
5. La virgo volens e la sua nutrice. L’esecuzione della nutrice, abbiamo visto, deve aver luogo per ingestione di
piombo fuso, perché la bocca, che ha pronunciato parole che hanno incoraggiato sogni e rafforzato volontà, non possa più parlare.
È punita, in questo modo, proprio in quanto consigliera, perché col suo agire – o meglio col suo parlare – ha reso possibile o facilitato la formazione della volontà di fuga della puella.
La virgo, afferma Costantino, è una mulier e, in quanto tale, così come è sta-ta esclusa, ab antiquo, da ogni funzione processuale perché incapace di un giudi-zio equilibrato, non può giudicare quanto è meglio, decidere, neppure per sé51. La sua volontà è naturalmente viziata.
Perché punirla, allora? Perché in queste costituzioni non c’è neppure quella,
-------------------------------------------- 49 Anche la L. DESANTI, Costantino, il ratto e il matrimonio, cit., 216, fa riferimento a interessi
pubblicistici, la cui lesione sarebbe, però, immediatamente perseguita da Costantino; li identifica, quindi con la necessità di moralizzazione dei costumi.
50 Sulla derivazione dal Lattanzio del de ira di questa impostazione che segna tutta la legislazione penale di Costantino, v. F. AMARELLI, “Vetustas – innovatio”. Un’antitesi apparente nella legisla-zione di Costantino, Napoli 1978, 127 ss.
51 Considerazione analoga in J. EVANS GRUBBS, Abduction Marriage, cit., 64.
166 Giovanna Mancini
pur usuale, variazione della pena legata al sesso, che tiene conto della – pure contestualmente proclamata – ‘parziale incapacità di intendere e volere della donna’52?
Il riferimento di Costantino al vitium levitatis et sexus mobilitatem atque consilii non è, forse, funzionale soltanto a giustificare l’abrogazione di una prassi che sottraeva il rapitore alla morte, proprio attraverso la responsio in giudizio della rapita. È, mi pare, un’affermazione nella quale è implicito il modello di comportamento che si vuole imporre e la sua motivazione ideologica. Una vo-lontà viziata deve essere ininfluente, non deve esprimersi. L’essere che è segnato naturalmente da tale limite non può, mai, decidere; deve essere oggetto, non soggetto di decisione. La donna che ‘vuole’ seguire il ‘rapitore’ compie, proprio per il suo agire affidandosi al proprio giudizio, seguendo la propria volontà, un atto che turba il nuovo ordine sociale che l’imperatore intende instaurare.
Quello che Costantino punisce con la morte – e, presumibilmente, con una morte atroce – è, in quanto tale, l’atto di autonomia della donna. Per questa ra-gione l’assenso successivo dei parentes non è più utile a modificare la situazione del correo, perché non è idoneo a intervenire sulla norma fondamentale dell’editto: che la donna sia esclusa da ogni decisione relativa a se stessa.
A essere sanzionata è non l’insubordinazione, che può essere successiva-mente perdonata, ma l’idea stessa che sia possibile una non subordinazione.
Tant’è che se, invece, la puella lo segue dopo che altri – avendo preso ac-cordi con chi la porta via – hanno già deciso per lei, il suo comportamento di allontanamento informale dalla casa paterna e quello – anche se violento – del rapitore sono penalmente irrilevanti: la donna, oggetto di accordo, può essere presa, anche contro la sua volontà, in esecuzione dell’accordo stesso.
La nutrice è, certamente, punita più severamente di ogni altro perché a lei i parentes avevano affidato la ragazza, proprio perché la custodisse. La forma stessa dell’esecuzione dice, tuttavia, qualcosa di più: che la punizione vuole colpire lo strumento – la parola – della sua partecipazione alla formazione di quell’autonoma volontà e di quella conseguente determinazione ad agire, la cui repressione esemplare è obiettivo dell’editto.
La donna stessa deve farsi guardiana dell’applicazione di questa norma che affida ogni decisione sulla sua vita alla famiglia: non solo astenendosi da ogni atto di volontà, ma anche impedendo, con ogni mezzo, che altri la violi. Se non agisce in maniera conseguente, deve essere comunque punita, anche se in manie-ra più lieve, per non aver evitato il fatto.
-------------------------------------------- 52 E che già in Costantino esclude la punibilità delle sanctimoniales – e di quante si uniscono agli
schiavi fisci – e che porterà Giustiniano a considerare la donna esclusivamente come possibile ogget-to del ratto. L’assenza di ogni diversificazione pro qualitate personarum, pur se non costituisce un caso unico, assume certamente una significativa rilevanza nella costituzione costantiniana, cfr. S. PULIATTI, La dicotomia “vir-mulier”, cit., passim.
Pro tam magna sui confidentia 167
167
Il nuovo ordine non ammette deroghe: neppure da parte degli stessi familiari, pure investiti della potestà decisionale sulla donna, potestà il cui esercizio è, però, divenuto indisponibile.
L’editto, inoltre, prima ancora che strumento di repressione, è – vuole essere – canale di imposizione di un modello culturale.
Un’eco dello stesso messaggio troviamo nella constitutio di riforma del re-pudium53. Quanto qui rileva non sono né la diversa gravità delle cause che lo legittimano da parte del marito e della moglie, né l’evidente intento di limitare il ricorso a esso, ma due incisi, dai quali emerge il modello negativo di mulier. Il primo è il riferimento – assente per il marito – ai depravati desideri54 (propter suas pravas cupiditates) che – fatti salvi i casi di marito omicida, preparatore di veleni o violatore di sepolcri – riassumono ogni possibile ragione di repudium. Il secondo, molto più interessante, è nella motivazione della pena.
Qui torna a intervenire – con l’intermittenza che abbiamo sottolineato all’inizio – una diversificazione delle sanzioni a seconda del sesso. A entrambi i coniugi sono imposte pene patrimoniali in favore dell’altro; il marito deve resti-tuire la dote e non può sposarsi con un’altra; se lo fa, la moglie può appropriarsi anche della dote di quest’ultima. Non è soggetto, però, a pene afflittive. La mo-glie, invece, non solo deve lasciare tutti i suoi beni, fino all’ultima forcina, nella casa del marito, ma anche essere deportata in un’isola, in conseguenza della sua tanto grande sicurezza di sé (et pro tam magna sui confidentia in insulam depor-tari). Sono la sui confidentia, l’osare di venir meno alle regole, l’affermazione di --------------------------------------------
53 Per il marito sono giuste cause l’adulterio, la stregoneria, il fare la mezzana. Il testo della costi-tuzione è il seguente: CTh. 3.16.1 [=Brev. 3.16.1] IMP. CONSTANTINUS A. AD ABLAVIUM PF. P. Placet, mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mittere exquisita causa, velut ebrioso aut aleatori aut mulierculario, nec vero maritis per quascumque occasiones uxores suas dimittere, sed in repudio mittendo a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam vel medi-camentarium vel sepulcrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit, ut ita demum laudata omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repudium marito miserit, oportet eam usque ad acuculam capitis in domo mariti deponere, et pro tam magna sui confidentia in insulam deportari. In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerit. Nam si ab his criminibus liberam eiece-rit, omnem dotem restituere debet et aliam non ducere. Quod si fecerit, priori coniugi facultas dabi-tur, domum eius invadere et omnem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi illata. DAT. III. NON. MAI. BASSO ET ABLAVIO COSS. Sulla constitutio, si vedano H.J. WOLFF, Doctrinal Trends in Postclassical Roman Marriage Law, in ZSS 67 (1950), 261-319; F. DELPINI, Divorzio e separazione dei coniugi nel diritto romano e nella dottrina della chiesa fino al secolo V, Torino 1956; E. VOLTERRA, Intorno ad alcune costituzioni di Costantino, in Rend. Acc. Naz. Lincei, Cl. Sc. morali stor. e filol., sez. 8, vol. 13 (1958), 61-89; F. DE MARTINO, Chiesa e Stato di fronte al divorzio nell'età romana, in Festschrift Flume zum 70, Köln 1978, 137-151; A. MONTAN, La legisla-zione romana sul divorzio: Aspetti evolutivi e influssi cristiani, in Apollinaris 53 (1980), 167-194; O. VANNUCCHI FORZIERI, La legislazione imperiale del IV-V secolo in tema di divorzio, in SDHI 48 (1982), 289-317; C. CASTELLO, Assenza di ispirazione cristiana in CTh. 3.16.1, in Religion, société et politique. Mél. Ellul., Paris 1983, 203-212; J. EVANS GRUBBS, “Munita coniugia”: The Emperor Constantine's Legislation on Marriage and the Family, Ann Arbor 1987, 183 ss.
54 Sui ‘depravati desideri’ come elemento caratterizzante la psiche femminile, v. G. RIZZELLI, “In has servandae integritatis custodias”, cit., passim.
168 Giovanna Mancini
sé, la decisione di dare ascolto ai depravati desideri, a essere sanzionati con la deportazione.
Carlo Venturini ha sottolineato55, come il testo sembri caratterizzato da una “sciattezza espositiva”, dal “ricorso a esemplificazioni collegabili all’esperienza comune e configurate con linguaggio lontano da quello ufficiale”, dalla “tenden-za … a giustificare le norme su un piano moraleggiante (propter sua pravas cupiditates) ovvero su quello dei principi propri di una giustizia elementare … (pro tam magna sui confidentia; pro iniuria sibi inlata)”56. L’Autore riconduce queste caratteristiche a una rielaborazione di origine ecclesiastica di una norma-tiva di ben altro tenore formale57, anche se riconosce che il provvedimento, nella sua ipotizzata forma originaria, “aveva l’effetto di sottrarre, di fatto, alla donna la facoltà di sciogliere il vincolo per propria autonoma scelta”58, elevando a reato il comportamento contrario.
Si tratta di un’innovazione radicale, dal punto di vista ideologico ancor pri-ma che normativo: l’ingenua, in quanto donna, viene a trovarsi, pur se solo di fatto, nella stessa condizione in cui si era trovata, di diritto – ma nei soli confron-ti del suo ex dominus e con conseguenze unicamente sul piano civile, non penale – la liberta.59
Per contro, i canoni ecclesiastici relativi a divorzio e repudium erano ancora in via di formazione e, all’epoca, si connotavano nel senso di un rifiuto totale – fatto salvo il caso di adulterio – della legittimità del repudium stesso60;
-------------------------------------------- 55 C. VENTURINI, La ripudianda (in margine a CTh. 3.16.1), in BIDR 91 (1988), 253-276, con es-
senziale disamina alle nt. 4, 5 e 6 delle precedenti posizioni dottrinali sulla questione dell’ispirazione cristiana della costituzione stessa.
56 C. VENTURINI, La ripudianda, cit., 256-257. Sottolinea, invece, la consonanza del giudizio sulla natura della donna in questa costituzione e in CTh. 9.24.1, J. EVANS GRUBBS, Law and Family, cit., 230.
Significative della volontà imperiale sono anche le costituzioni che, in apparente tutela del pudor delle donne, ne sanciscono l’invisibilità, togliendo loro la possibilità di autonomo intervento in sede processuale, anche col conferire ai mariti la rappresentanza processuale delle mogli: C.2.12.21pr. (a.315), C.2.44.2.1 [CTh. 2.17.1.1] (a.321), C.5.37.22; sul punto si veda J. EVANS GRUBBS, Law and Family, cit., 327 ss.
57 Cfr. anche E. VOLTERRA, s.v. Matrimonio (diritto romano), in ED 25, Milano 1975, 791 ss., ove – nt. 148 e 149 – rinvio anche ai suoi precedenti articoli sul tema.
58 C. VENTURINI, La ripudianda, cit., 261-262. 59 C. VENTURINI, La ripudianda, cit., 262-263 legge in questo un compromesso tra orientamento
cristiano e società laica, che avrebbe impedito di utilizzare il precedente della nullità del divorzio unilaterale della liberta per sancire la nullità del repudium. La lex Iulia aveva sottratto alla liberta sposata dal suo patronus la facoltà di sciogliere il matrimonio: divortii faciendi potestas libertae, quae nupta est patrono, ne esto (D.24.2.11pr., Ulp. 3 ad legem Iuliam et Papiam), cfr. D.24.2.10 (Mod. 1 reg.).
60 Matth. 5.31-32, Luc. 16.26, Matth. 19.9, Paul. Ep. I Cor. 7.10-11, richiamati, alla fine del seco-lo, in Basil. Moralia, Reg.73 c.1. Giustamente, a mio avviso, sottolinea la sostanziale estraneità all’ispirazione cristiana della costituzione, in conseguenza del permanere del carattere della risolubi-lità consensuale del matrimonio, O. VANNUCCHI FORZIERI, La legislazione imperiale, cit., 289-317, 293-294 e 298. Sulla concezione cristana coeva del matrimonio, v. A. MONTAN, La legislazione
Pro tam magna sui confidentia 169
169
l’ingegnosa ipotesi di un lavorio su un testo – che si sarebbe dovuto, peraltro, sostituire a quello ufficiale per transitare nel Teodosiano – mi pare perciò poco convincente61.
Non mi sembra, invece, impossibile – diversamente da Venturini – ricondur-ne il singolare tenore a una consapevole scelta stilistica della stessa cancelleria imperiale.
In alcune leggi, alla funzione disciplinare propria può affiancarsi quella di indicare nuovi modelli ai quali gli individui dovranno conformare i loro compor-tamenti. In questi casi, destinatario privilegiato della comunicazione è il suddito, la persona comune, chiamato non solo a conoscere la sanzione, ma soprattutto a far proprio il nuovo quadro assiologico, sostituendolo al vecchio e interiorizzan-dolo. Ciò è tanto più vero, quanto più la norma rompe col passato e il raggiungi-mento del fine che si prefigge è tale da non poter fare a meno della sua costante, generale, operativa condivisione, per ottenere la quale non è sufficiente il timore della sanzione.
Il linguaggio deve allora adeguarsi, da tecnico deve farsi anche pedagogico, colorarsi di giudizi morali per sollecitare l’adesione ai nuovi valori62.
Nel nostro caso, il modello indicato alla donna è quello di un atteggiamento nel quale deve sempre essere assente ogni forma di sicurezza di sé, del proprio giudizio, della propria autonoma volontà, della sui confidentia.
-------------------------------------------- romana sul divorzio, cit., 167-194, 179 ss.: secondo l’A. la dottrina cristiana sull’indissolubità non sarebbe, in quest’età rigidamente definita e, nella prassi, non sempre applicata; nello stesso senso, già J. GAUDEMET, L’interprétation du principe d’indissolubilité du mariage chrétien au cours du pre-mier Millénaire, in BIDR 81 (1978), 11-70. In quest’ultimo quadro, un lavorio di parte cristiana sui testi imperiali, sarebbe ancora più incomprensibile.
61 Secondo C. VENTURINI, La ripudianda, cit., passim, la constitutio come riportata nel Teodosia-no sarebbe, in realtà, un testo messo insieme “associando alle disposizioni di carattere generale sanzionatrici del divortium attuato per iniziativa unilaterale altre più specifiche norme, prospettate come altrettante deroghe al divieto … mirante a stimolare l’accusa anche tra coniugi allo scopo di favorire la repressione di particolari reati”(270).
62 Il ricorso a stilemi moraleggianti e a un linguaggio atecnico lo ritroviamo anche in altri edicta in relazione ai quali è ipotizzabile un’analoga funzione ‘pedagogica’; si pensi ai destinatari delle san-zioni per i caelibes della lex Iulia et Papia, perché inminentibus legum terroribus liberentur (CTh. 8.16.1pr.); alla celeberrima CTh. 8.16.1pr., sull’omosessualità, che utilizza un linguaggio certamente più atecnico ed evocativo della nostra: (… ubi venus mutatur in alteram formam, ubi amor quaeritur nec videtur, iubemus insurgere leges, armari iura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infa-mes, qui sunt vel qui futuri sunt rei); il civis che non ottempera alla norma è, in altri luoghi ingratus et degener (CTh. 11.1.18), e la sua temeritas ad tantum eruperit (CTh. 14.17.5); la libertà di testare è così motivata in CTh. 16.2.4: nihil est, quod magis hominibus debetur, quam ut supremae voluntatis, post quam aliud iam velle non possunt, liber sit stilus et licens, quod iterum non redit, arbitrium; per finire con CTh. 10.10.2, che vieta la delazione fiscale – un tema non di interesse precipuo per la morale cristiana – nella quale crimine e sanzione sono così descritte: “Comprimatur unum maximum humanae vitae malum, delatorum exsecranda pernicies, et inter primos conatus in ipsis faucibus stranguletur, et amputata radicitus invidiae lingua vellatur, ita ut iudices nec calumniam nec vocem prorsus deferentis admittant; sed si qui delator exstiterit, capitali sententiae subiugetur”.
170 Giovanna Mancini
6. Il contesto storico. Su un altro versante, quanto Costantino impone con CTh. 9.24.1, è, come
abbiamo visto, la necessità, assoluta della totale subordinazione della donna alle scelte matrimoniali che la famiglia fa per lei, in un quadro, più generale, di nega-zione della sua legittimazione ad assumere decisioni autonome.
Dobbiamo ora cercare di individuare quell’interesse propriamente pubblico che, nella sua età, potesse giovarsi di tale assoluta dipendenza della donna dal volere dei familiari, in uno scenario in cui, come vedremo, agli stessi uomini, almeno a quelli appartenenti a un determinato ceto sociale, viene sostanzialmente sottratta la libertà di scegliere rapporti di convivenza fino allora leciti.
Mi pare, innanzitutto, necessaria una puntualizzazione, pur se ovvia. Tra la disciplina ‘classica’ del ratto e quella costantiniana, non si interpon-
gono solo più di cent’anni, la crisi del III secolo63, il cambiamento di regime (fattori, come vedremo, tutt’altro che irrilevanti anche a questo proposito); si interpone, anche, la constitutio Antoniniana64. Le donne – e gli uomini – la cui vita è regolata dalle norme degli imperatori tardoantichi non sono più le donne parte di un popolo che vive gestendo le ricchezze conquistate. Altro è disciplina-re i rapporti matrimoniali, più in generale sociali, di un’élite che, oltre ad anti-chissima comunanza di diritto, ha comunanza di interessi, spesso contrapposti a quelli dei provinciali, altro è farlo in riferimento a tutta la popolazione dell’impero. E non è solo – e tanto – un problema di omogeneizzazione di radi-cate usanze, in particolari quelle familiari e successorie, diverse, non è solo il problema della ‘volgarizzazione’ del diritto che a quella consegue; è, soprattutto, il problema della riorganizzazione di una società in cui non ci sono più Romani-dominatori e peregrini-dominati, ma in cui si è tutti sudditi, con funzioni e posi-zioni diverse. Di una società che non si espande più.
Le donne, romane, dell’età imperiale erano state, quasi di necessità, coinvol-te attivamente nella gestione di un’economia che viveva – anche, se non soprat-tutto – delle ricchezze che affluivano dalle guerre di conquista e dei gettiti delle imposte delle province, avevano vissuto – nel mare dell’impero – in un’isola di società, sufficientemente ricca, mobile e aperta65.
Il matrimonio era sempre stato un affare di ‘famiglie’ piuttosto che dei nu-bendi; questo non aveva però impedito che in esso – in quel quadro – la volontà di entrambi i coniugi fosse essenziale, tanto che il venir meno in uno qualunque di essi di tale affectio lo faceva cessare.
-------------------------------------------- 63 Cfr. M. MAZZA, Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo, Roma-Bari 1973, pas-
sim. Sulle radici della crisi nel secolo precedente, v. L. DE GIOVANNI, Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico, Roma 2007, 40ss.
64 Un aggiornato ragguaglio dottrinale e bibliografico in L. DE GIOVANNI, Istituzioni, cit., 67 ss. e, in particolare le nt. 102, 112, 114, 117.
65 L. PEPPE, Posizione giuridica e ruolo sociale della donna, cit., passim.
Pro tam magna sui confidentia 171
171
Né si poteva considerare, più generalmente, irrilevante la volontà – la capa-cità di decidere per sé – di persone, pur se di sesso femminile, che dopo il terzo figlio erano automaticamente liberate dalla tutela o che, di fatto, sceglievano il proprio tutore66.
Tutto questo era stato, per un periodo breve, ma non insignificante, possibi-le.
Ora, era tutta la società a dover assumere una conformazione diversa; tutti i ruoli dovevano essere ridefiniti.
7. I destinatari dell’edictum. Il nuovo diritto, l’abbiamo detto, ha come destinatari tutti i sudditi e, anzi,
dal punto di vista formale, le norme sul ratto sono contenute in un edictum, in una legge generale.
C’è da chiedersi, però, se quella necessità così stringente di assicurare il con-trollo delle donne e di mettere innanzi a tutto l’accordo coi parentes relativo al matrimonio della puella, riguardasse tutti i sudditi; se, dunque, tutti ne fossero i destinatari effettivi o se quelli che all’imperatore interessava regolamentare era-no i rapporti di una parte precisa della società, di specifici ceti sociali, salva restando l’ovvia, astratta, generale sottoposizione alla legge stessa.
Dal testo della costituzione emerge che quella alla quale Costantino si riferi-sce è una realtà urbana, in cui i vicini possono sentire le grida, da una casa in cui c’è – usualmente – una nutrice ad accudire una puella, già ormai in età da marito. Una realtà cittadina e agiata67.
Anche il tipo di condanna comminata ai parentes, la deportazione, è indica-tiva – anche se non concludente68 – dei soggetti cui si rivolge l’imperatore: gli --------------------------------------------
66 G.1.190: Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur. Nam quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera mulieres enim quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam; saepe etiam invitus auctor fieri a praetore cogitur. Ma v. già per il I a.C. la testimonianza di Cicerone, Mur. 12.27, su cui v. S. DIXON, Infirmitas Sexus: Womanly Weakness in Roman Law, in RHDFE 52 (1984), 343 ss. – che legge la dottrina dell’infirmitas sexus come riflesso della supposta funzione protettrice della tutela – e, per il secolo successivo, l’abolizione della tutela legitima da parte di Claudio, Gai 1.171.
67 Giunge a conclusioni opposte, proponendo come destinatarie le più remote comunità rurali, in una interpretazione della ratio della costituzione fortemente ancorata sulla comparazione entografica con gli usi moderni in area mediterranea, J. EVANS GRUBBS, Abduction Marriage, cit., 82. Per dare ragione del singolare tenore della costituzione, deve però ricorrere a ipotizzare un qualche – scono-sciuto – caso di straordinaria gravità che ne sarebbe stato all’origine. L’ipotesi non mi pare convin-cente, oltre che per le altre ragioni da me addotte, soprattutto perché nel contesto proposto dalla EVANS GRUBBS difficilmente trova spiegazione il rilievo dato alla figura della nutrice.
68 Un quadro del regime delle pene per honestiore e humiliores in B. SANTALUCIA, Diritto e pro-cesso penale, cit., 249 ss.e P. GARNSEY, Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire, Oxford 1970, in partic. 103 ss.; F.M. DE ROBERTIS, La variazione della pena nel diritto romano, Bari 1954 (= Scritti varii di diritto romano, III, Bari 1987, 488 ss.).
172 Giovanna Mancini
honestiores, gli appartenenti ai ceti di governo, in senso lato, dell’impero. La rilevanza ai fini penali della distinzione tra honestiores e humiliores era emersa già con Adriano69. Per i primi, se la pena prevista era quella capitis, normalmente l’esecuzione non prevedeva il ricorso a forme ‘atroci’, se non in casi eccezionali; le poenae capitales, la damnatio ad metalla e la deportatio, anche per le spese che quest’ultima comportava, erano, invece, peculiari rispettivamente del secon-do e del primo dei due status70.
La mancanza di un’indicazione binaria71 per la pena cui devono essere sotto-posti i parentes, può essere un ulteriore indizio della volontà imperiale relativa ai destinatari.
Una parte numericamente rilevante degli honestiores era costituita dai curia-les.
Tali privilegi riguardavano non solo i membri delle curiae, ma le loro fami-glie72, figlie comprese73 e furono estesi ai figli dei veterani74.
Negli stessi anni – con una costituzione del 319 – Costantino era intervenuto anche a vietare i rapporti tra decurioni e schiave altrui75. La pena per la donna era --------------------------------------------
69 D.48.19.9 (Ulp. 10 de off. proc.) 11. Istae fere sunt poenae quae iniungi solent. Sed enim scien-dum est discrimina esse poenarum neque omnes eadem poena adfici posse. Nam in primis decuriones in metallum damnari non possunt nec in opus metalli, nec furcae subici vel vivi exuri. Et si forte huiusmodi sententia fuerint affecti, liberandi erunt: sed hoc non potest efficere qui sententiam dixit, verum referre ad principem debet, ut ex auctoritate eius poena aut permutetur aut liberaretur. Da leggere in connessione con: D.48.19.28pr. (Call. 6 de cogn.), nonché D.48.19.15 (Ven. Sat. 1 de off. proc.) Divus Hadrianus eos, qui in numero decurionum essent, capite puniri prohibuit, nisi si qui parentem occidissent: verum poena legis Corneliae puniendos mandatis plenissime cautum est e D.48.19.27.1 (Call. 5 de cogn.) De decurionibus et principalibus civitatium, qui capitale admiserunt, mandatis cavetur, ut, si quis id admisisse videatur, propter quod relegandus extra provinciam in insulam sit, imperatori scribatur adiecta sententia a praeside e D.47.14.1.3 (Ulp. 8 de off. Proc.), Coll. 11.8.3 (Ulp. 8 de off. proc.), D.48.13.7 (Ulp. 7 de off. proc.) cfr. anche Paul. sent. 5.4.10. Altri esempi di variazione della pena pro qualitate personae in D.48.19.38.3 e 5 (Paul. 5 sent.).
70 P. GARNSEY, Social Status, cit., passim. 71 La damnatio ad metalla, per i parentes humiliores: C.9.47.11 (Gord. A. Attiano) Metalli sup-
plicium tam ad personas liberas quam etiam ad serviles pertinet condiciones. 72 D.48.19.9 (Ulp. 10 de off. proc.) 12. Parentes quoque et liberi decurionum in eadem causa sunt.
13. Liberos non tantum filios accipere debemus, verum omnes liberos. 14. Sed utrum hi soli, qui post decurionatum suscepti sunt, his poenis non adficiantur, an vero omnes omnino liberi, etiam in ple-beia familia suscepti, videndum est: et magis puto omnibus prodesse debere. 15. Plane si parens decurio esse desierit, si quidem iam decurione fuerit editus, proderit ei, ne adficiatur: enimvero si posteaquam plebeius factus est tunc suscipiat filium, quasi plebeio editus ita erit plectendus
C.9.47.3 (Ant. A. Geminio) Decurionem in opus publicum dari non oportere manifestum est. C.9.47.12 (Diocl./Maxim.) Decurionum filii non debent bestiis subici. Nec enim vocibus eorum
credi oportet, quando aut obnoxium crimine absolvi aut innocentem condemnari desideraverint. 73 C.9.47.9 (ALEX. A. DEMETRIANO) Si matrem tuam decurionis filiam fuisse probatum fuerit,
apparebit eam non oportuisse in ministerium metallicorum nec in opus metalli dari. 74 C.9.47.5 (ANT. A. SENECIONI) Honor veteranis etiam in eo habitus est, ut liberi eorum usque ad
primum dumtaxat gradum poena metalli vel operis publici non adficiantur, sed in insulam relegen-tur.
75 CTh. 12.1.6 Patroclo. Nulla praeditos dignitate ad sordida descendere conubia servularum etsi videtur indignum, minime tamen legibus prohibetur; sed neque conubium cum personis potest esse
Pro tam magna sui confidentia 173
173
la condanna ad metalla, per il curiale la deportazione e, se sui iuris e senza eredi legittimi (necessariamente curiales anch’essi), la confisca del patrimonio, com-minata, in parte, anche al proprietario della schiava, se consapevole del fatto. È un testo di difficile inquadramento, anche per il riferimento alle potentissimae domus76. Tra le motivazioni che spingono l’imperatore ad adottarla, non è, però, certo assente quella di assicurare continuità ereditaria alla carica: è Costantino stesso a sottolineare che non c’è conubium et ex huiusmodi contubernio servi nascuntur. I figli nati da una tale unione, diversamente dagli spurii nati da madre libera77, non avrebbero mai potuto entrare a far parte dell’ordo78. -------------------------------------------- servilibus et ex huiusmodi contubernio servi nascuntur. Praecipimus itaque, ne decuriones in gremia potentissimarum domorum libidine ducente confugiant. Si enim decurio clam actoribus atque procu-ratoribus nescientibus alienae fuerit servae coniunctus, et mulierem in metallum trudi per sententiam iudicis iubemus et ipsum decurionem in insulam deportari, bonis eius mobilibus et urbanis mancipiis confiscandis, praediis vero et rusticis mancipiis civitati, cuius curialis fuerat, mancipandis, si patria potestate fuerit liberatus nullosque habeat liberos vel parentes vel etiam propinquos, qui secundum legum ordinem ad eius successionem vocantur. Quod si actores vel procuratores loci, in quo flagi-tium admissum est, fuerunt conscii vel compertum facinus prodere noluerunt, metallo eos convenit implicari. Si vero dominus hoc fieri permisit vel postea cognitum celavit, si quidem in agro id factum est, fundus cum mancipiis et pecoribus ceterisque rebus, quae cultui rustico sustinentur, fisci viribus vindicetur; si vero in civitate id factum est, dimidiam bonorum omnium partem praecipimus confi-scari, poenam augentes, quoniam intra domesticos parietes scelus admissum est, quod noluit mox cognitum publicare. Igitur si legis latae die repperietur quisquam patrimonium suum alienasse atque in dominum servulae contulisse, ordini liceat diligenter inquirere, ut ita rei publicae civitatis quod de facultatibus supra dicti fuerit deminutum, in pecunia sarciatur. DAT. KAL. IUL. AQUILEIAE CONSTANTINO A. V ET LICINIO C. CONSS. (1 iul. 319). Su questa costituzione e sui motivi della diversità di testo e collocazione sistematica nel Codex Iustinianus (C.5.5.3) si sofferma – con consi-derazioni analoghe alle mie, ma focalizzando essenzialmente sull’aspetto patrimoniale – J. GAUDEMET, Constantin et les curies municipales, in Iura 2 (1951), 74-75. P. VOCI, Il diritto eredita-rio romano, cit., 28, legge nella costituzione una spia della fuga dalle curie anche a prezzo di “rinun-ciare ad aver famiglia, figli legittimi e beni propri, e sottostare a un potente”. C. DUPONT, Les consti-tutions de Constantin, cit., 100-101, ritiene, con una deduzione che non riesco a spiegarmi, la norma dettata dalla volontà imperiale di evitare un “abuso di influenza da parte del decurio”; v. anche J. GAUDEMET, “Justum matrimonium”, in RIDA 3 (1950), 309-366, 351 ss.
Anche questo intervento di Costantino non dové, però, avere l’effetto voluto, se oltre cent’anni dopo – ma con retroattività di trent’anni – Maiorano obbliga i potentiores presso i quali dei curiali si siano stabiliti, prendendovi moglie, a restituirli alle curie entro un anno (Novell. Maior. 7.1,2,4), pena la confisca patrimoniale per il dominus sciens e pene afflittive per l’actor o il procurator. Il fenomeno delle unioni ineguali, sia dal punto vista normativo, sia da quello delle radici sociali e, anche religiose, è oggetto di disamina da parte di J. EVANS GRUBBS, Law and Family, cit., 261-316, che, ovviamente, prende in considerazione anche questa costituzione (279 ss.).
76 Il riferimento ai potentiores è già in una costituzione di Diocleziano e Massimino del 293 (C.2.13.1). Alla distinzione tra potentes e tenuiores fa riferimento l’anomimo autore del de rebus bellicis. 2.3 (IV sec) e i potentes appariranno anche nella riforma delle norme sul ratto di Giustinia-no, C.1.3.53.2, come possibile rifugio del rapitore.
Per sottrarsi ai munera, quando non sia possibile far ricorso a mezzi legali, i decuriones sembrano ricorrere alla protezione di fatto dei potentes; di qualche anno successiva è CTh. 12.1.50.2. (IULIANUS A. SECUNDO PRAEFECTO PRAETORIO) Et quoniam ad potentium domus confugisse quo-sdam relatum est curiales, ut tam foeda perfugia prohibeantur, multam statuimus, ut per singula capita singulos solidos dependat, qui ad potentis domum confugerit et tantundem qui receperit multae nomine inferat. Nam si servus inscio domino susceperit, capite punietur, et ingenuus, qui invito patrono hoc fecerit, deportabitur. (13 mart. 362); cfr. anche CTh. 12.1.146 (a. 395).
174 Giovanna Mancini
L’imperatore – analogamente a quanto farà nell’editto sul raptus – interviene sulla libertà di scelta ‘matrimoniale’, in questo caso degli uomini, rendendo pe-nalmente rilevante un comportamento, il concubinato, prima lecito e, in alcuni casi, visto come male minore dalla stessa chiesa.
Mi pare, dunque, opportuno verificare se sia possibile ricondurre nell’alveo di un’unica politica legislativa l’insieme di norme, duramente repressive, che abbiamo fin qui esaminato e che paiono accomunate dall’estraneità alla coeva morale cristiana e da singolari consonanze quanto a oggetto e destinatari.
8. L’ordo decurionum e le sue funzioni nel IV secolo. Per la conservazione e per la gestione dell’impero erano essenziali due fun-
zioni che furono cristallizzate in due gruppi sociali: quello dei milites, per il controllo dei confini e per mantenere l’ordine pubblico e quello dei decurioni79,
-------------------------------------------- 77 Esplicitamente, per i vulgo quaesiti nati da padre schiavo si era pronunciato Settimio Severo:
D.50.2.9pr. (Paul. 1 decret.) Severus Augustus dixit: ‘etsi probaretur Titius in servitute patris sui natus, tamen, cum ex libera muliere sit procreatus, non prohibetur decurio fieri in sua civitate’, dopo che la possibilità di ammettere all’ordo, in generale, gli spurii era stata sancita da Marco Aurelio e Vero D.50.2.3.2 (Ulp. 3 de off. proc.) Spurios posse in ordinem allegi nulla dubitatio est: sed si habeat competitorem legitime quaesitum, praeferri eum oportet, divi fratres Lolliano Avito Bithyniae praesidi rescripserunt. cessantibus vero his etiam spurii ad decurionatum et re et vita honesta reci-pientur: quod utique non sordi erit ordini, cum ex utilitate eius sit semper ordinem plenum habere. Per i figli nati da incesto, si veda D.50.2.6pr. (Pap. 1 resp.).
78 C.10.33.1 (DIOCL. ET MAXIM. AA. SATURNINO) Si libertus vel ius aureorum anulorum adeptus non est vel natalibus suis non restitutus, praeses provinciae non tantum curiae participare non permittet, sed iuxta legis severitatem congruenti poena ulciscetur; C.10.33.2 (DIOCL. ET MAXIM. AA. ORCINAE) Praeses provinciae, si eum qui aedilitate fungitur servum tuum esse cognoverit, si quidem non ignarum condicionis suae ad aedilitatem adspirasse perspexerit, ob violatam servili macula curiae dignitatem congruenti poena adficiet: si vero, cum opinione publica mater eius pro libera haberetur, ex decurione procreatus ad capessendum honorem errore lapsus processit, dominio tuo eum subiugabit.; C.6.55.6 (DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. POSIDONIO) Ex libera conceptus et servo velut spurius habetur nec ut decurionis filius, quamvis pater eius naturalis manumissus et natalibus suis restitutus hunc fuit adeptus honorem, defendi potest. (a. 294), cui può aggiungersi, a conferma della continuità della normativa, C.10.32.29 (VALENTIN. ET VALENS AA. GERMANIANO PP. GALLIARUM) Nati ex inquilinarum nostrae domus matrimonio et patre decurione non patrum suorum, verum matrum condicionem sequantur (a. 365).
79 L’espressione ordo decurionum individua, come noto, due realtà profondamente diverse nell’età repubblicana e del primo principato e in quelle successive. Ordo decurionum – insieme a senatus – designa, nelle leggi del primo periodo un organo, composto di un numero predeterminato di compo-nenti – pur se variabile da città a città – cui si accede, di norma, dopo aver rivestito una magistratura, analogamente a quanto avveniva per il senato romano repubblicano. Dalla fine del II secolo, il rap-porto tra magistrature e ordo si inverte: D.50.2.7.2 (Paul. 1 sent.) Is, qui non sit decurio, duumviratu vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohibentur e si fa evidente – e oggetto di misure coercitive – il fenomeno della fuga dalle curie: D.50.2.1 (Ulp. 2 opin.). Decuriones, quos sedibus civitatis, ad quam pertinent, relictis in alia loca transmigrasse probabitur, praeses provinciae in patrium solum revocare et muneribus congruentibus fungi curet.). Si passa così dall’ordo-organo all’ordo-gruppo sociale, dotato di un particolare status.
Pro tam magna sui confidentia 175
175
per assicurare la gestione delle città e la riscossione delle imposte; gruppi tra i quali – non a caso – le costituzioni stabiliscono un interscambio funzionale80.
Sulle curiae ricadevano compiti essenziali alla sopravvivenza stessa delle città – quali la legatio, la difesa in giudizio, tutte le opere e tutti i servizi pubbli-ci, l’amministrazione e l’approvvigionamento dell’annona locale – compiti la cui realizzazione doveva essere assicurata sia utilizzando le entrate cittadine, sia attraverso l’assegnazione di munera a municipes e incolae81, ma, sempre, con l’attribuzione, in ultima istanza, dell’attività – e della spesa relativa – ai compo-nenti la curia stessa82.
Dopo la riforma fiscale di Diocleziano83 pesò, inoltre, sull’ordo l’attività e la responsabilità sia delle professiones84, sia della ripartizione delle imposte85, sia della nomina degli exactores che avrebbero dovuto riscuoterle, eletti – fino al 365 – tra principales e decurioni; tutta la curia era, però, solidarmente responsa-bile86. Accanto a queste ultime, ulteriori, attribuzioni, continuavano a competere alle curie: la cura del cursus publicus, il reclutamento dei soldati (almeno in età costantiniana)87 e, in caso di necessità, il trasporto marittimo.
-------------------------------------------- 80 CTh. 12.1.10; CTh. 12.1.11; CTh. 12.1.13; CTh. 12.1.18.1; CTh. 12.1.19; CTh. 12.1.22;
C.10.32.17. 81 C.10.32.2 (Diocl. et Maxim. AA.) Observare magistratus oportebit, ut decurionibus sollemniter
in curiam convocatis nominationem ad certa munera faciant eamque statim in notitiam eius qui fuerit nominatus per officialem publicum perferre curent, habituro appellandi, si voluerit, atque agendi facultatem apud praesidem causam suam iure consueto: quem si constiterit nominari minime de-buisse, sumptus litis eidem a nominatore restitui oportebit; cfr. R. GANGHOFFER R., L’évolution des institutions municipales en occident et en orient au bas-empire, Paris 1962, 206 ss.
82 Cfr. F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, V, Napoli 1975, 509 ss.; ID., Storia della costituzione romana, IV.2, Napoli 1975, 733; A.H.M. JONES, The Later Roman Empire 284-602: a Social Economic and Administrative Survey, I, Oxford 1964, 456 ss. (su cui v. però, F. DE MARTINO, Storia, IV.2, cit., 736 ss.); R. GANGHOFFER, L’évolution des institutions municipales, cit. passim; W. LANGHAMMER, Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus municipales und der Decuriones in der Ubergangsphase der Stadte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzu-gsorganen des spatantiken Zwangsstaates: 2.-4. Jahrhundert der romischen Kaiserzeit, Wiesbaden 1973, 188 ss. Sull’organizzazione interna delle curiae, v. J. GAUDEMET, Constantin et les curies, cit., 68 ss.
83 V. da ultimo L. DE GIOVANNI, Istituzioni, cit.,142-148. 84 Sulle dichiarazioni per la capitatio v. C.11.58.1 (a. 313). 85 I principales o decuriones stabiliscono la forma distributionum: CTh. 11.16.4 (a. 328). 86 CTh. 12.6.1 (a. 321): IMP. CONSTANTINUS A. AD EDICTUM. Si quem susceptorem evertisse con-
stiterit rationem et ad solvendum non esse idoneum, creator eius hac necessitate teneatur, ut, quid-quid ille dilapidavit, ipse de propriis rebus instauret compellaturque damnum omne sarcire, quod non esset illatum, si in idoneis nominandis competens adhibitum esset examen; cfr. R. GANGHOFFER, L’évolution, cit., 146 ss. Si veda, in senso diverso, CTh. 11.7.2, del 319, che è, però, indirizzata al vicarium Britaniarum. In una costituzione del 365 o 368 (CTh. 12.6.9), Valentiniano e Valente riportano alla responsabilità di reintegra di quanto sia andato in malora per negligenza o per dolo dei susceptores dell’ordo che li ha nominati (de curia dati), richiamando un uso consolidato (sicuti moris est).
87 Cfr. F. DE MARTINO, Storia, V, cit., 452 ss.
176 Giovanna Mancini
Si trattava di funzioni tutte vitali per lo stato, il cui espletamento doveva es-sere necessariamente assicurato, nonostante il complessivo – anche se non gene-rale – impoverimento dell’impero e, anche, delle élites locali e le sottrazioni sempre più frequenti di beni alle città, fatti confluire dai principes nella res pri-vata o donati a privati cittadini o alla stessa chiesa88.
Uomini – e patrimoni – sufficienti dovevano essere, se necessario, vincolati all’espletamento di quei compiti89.
È un processo già avviato nel III secolo90, che ha una brusca accelerazione agli inizi del IV.
Col passaggio dell’elezione dei magistrati cittadini dal popolo al senato, re-clutato per cooptazione, i curiali erano divenuti già dal III secolo un ordine eredi-tario di honestiores91, che godeva dei privilegi cui abbiamo accennato, per il quale si iniziavano ad avvertire, però, difficoltà di ricambio, tali da indurre gli imperatori ad aprirne, come abbiamo visto, l’accesso anche agli spurii92 e a dare inizio a quelle misure di vincolo del decurione alla curia della sua città93, che vedono un inasprimento agli inizi del IV secolo.
In età costantiniana, si fa parte dell’ordo per il ricorrere di requisiti prede-terminati: discendenza da una famiglia curiale o comunque status di possessor fondiario94, anche se l’entità del patrimonio varia per luoghi e tempi95. Il vincolo
-------------------------------------------- 88 Sulla sottrazione alla disponibilità delle città delle proprie entrate in favore dell’aerarium impe-
riale, v. R. DELMAIRE, Largesses sacrèes et res privata. L’aerarium impérial et son addministration du IVe au VI e siècle, Roma 1989, in particolare 648 ss. Costantino (Sozomen Hist. Eccl. 1.8.10, Cassiod. Hist. trip. 1.9.10, Euseb. Vita Const. 4.28) aveva attribuito parte delle terre cittadine alla chiesa, che nel 362 Giuliano restituirà assieme ai beni espropriati dai suoi predecessori, come sotto-linea Ammian. 25.6.15: Vectigalia civitatibus restituta cum fundis, quei vectigalia che avevano costituito la principale entrata delle casse cittadine, cfr. R. DELMAIRE, Largesses, cit., 276 ss., nonché A. CHASTAGNOL, La législation sur les biens des villes au Ire siècle à la lumiere d’une inscription d’Éphèse”, in Aspects de l’antiquité tardive, Roma 1994, 143-170 e C. LEPELLEY, Les cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire, 2 voll., Paris 1979-1981, 69 nt.41.
89 J. GAUDEMET, Constantin et les curies, cit., passim. 90 Fra i testi del Digesto che, oltre alla costituzione di Diocleziano (C.10.32.13), documentano
l’esistenza e l’estensione del fenomeno di fuga dalle curie e di ricerca di cause scusanti per sottrarsi all’esercizio della funzione, contrastati da interventi imperiali, si vedano D.50.5.1.2, (Ulp. 2 opin.), D.50.5.2.1 (Ulp. 3 opin.), D.50.2.1 (Ulp. 2 opin.), D.50.2.2.8 (Ulp. 1 disputat.).
91 D.50.2.7.2 (Paul. 1 sent.) Is, qui non sit decurio, duumviratu vel aliis honoribus fungi non po-test, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohibentur, cui si aggiunga la catena D.50.2.2.2-7 (Ulp. 1 disputat.); in particolare il primo frammento, in cui è esplicito il riferimento allo status e non all’appartenenza alla curia: D.50.2.2.2 (Ulp. 1 disputat.)
92 D.50.2.3.2 (Ulp. 3 de off. proc.) v. testo alla nt. 77; D.50.2.6pr. (Pap. 1 respons.) Spurii decu-riones fiunt: et ideo fieri poterit ex incesto quoque natus: non enim impedienda est dignitas eius qui nihil admisit.
93 C.10.32.13 (DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. PROTO). Il processo è già avviato in età severiana: D.50.2.1 (Ulp. 2 opin.); D.50.2.2.8 (Ulp. 1 disputat.); D.50.5.1.2 (Ulp. 2 opin.). Già in Ulpiano, l’età sembra, comunque, liberare solo dai munera civilia, non da quelli connessi agli honores: D.50.5.2.1 (Ulp. 3 opin.), cfr. D.50.5.8pr. (Pap. 1 resp.).
94 Secondo R. DELMAIRE, Largesses sacrées, cit., 41 ss. il termine possessores individuerebbe, invece, una forma di proprietà eminente sulle terre di quei curiali sui quali ricadeva la responsabilità
Pro tam magna sui confidentia 177
177
con la curia della civitas è determinato dall’origo, ma, già con Costantino anche dal domicilium96.
La difficile situazione economica delle città e le esigenze finanziarie dell’impero, aggravate dalla politica premiale di Costantino nei confronti dei veterani, avevano indotto, come noto, l’imperatore ad adottare una serie di misu-re sulle curie municipali – delle quali ci è rimasta testimonianza in una quaranti-na di frammenti di costituzioni inserite nel Codex Theodosianus97, alcune delle quali a cavallo del 326, lo stesso anno in cui è presumibile sia stata emanata la stessa CTh. 9.24.1 – con la finalità, appunto, di assicurare alle curie un’adeguata dotazione di uomini e mezzi98. Sulle questioni della ereditarietà delle cariche, del divieto di sottrarsi a esse, della restituzione alle curie stesse di quanti ne siano sfuggiti, Costantino interviene, infatti, a più riprese99, arrivando ad aprire alla piena partecipazione anche ai lavori dell’ordo ai minori di venticinque anni, fatti decurioni, che in precedenza ne erano esclusi100.
La letteratura degli ultimi anni ha messo, giustamente, in risalto la disomo-geneità del fenomeno di decadenza delle curie, legata alle specifiche condizioni delle diverse aree dell’impero101.
Condivido l’idea della necessità di tentare di ricostruire il quadro complessi-vo utilizzando tutte le fonti, non solo quelle giuridiche, attraverso l’analisi, per quanto possibile puntuale, delle diverse realtà cittadine. Mi sembra, tuttavia, innegabile come il segno generale, dell’economia e della società che escono dalla crisi del III secolo, sia quello di uno sfaldamento complessivo, nel quale si sal--------------------------------------------- fiscale di una porzione del territorio della città e legge in questo senso CTh. 10.3.4 “il legislatore precisa bene che lo statuto di possessor costituisce un tratto specifico del curiale, perché stabilisce una quasi-equivalenza tra i due termini” (47).
95 I patrimoni mobiliari saranno presi in considerazione solo dal 393 (Onorio CTh. 12.1.133, CTh. 12.1.72).
96 CTh. 12.1.5. (Constantinus ad Bithynos) (21 luglio 317). Origo e domicilium diversi arrivano a comportare un doppio vincolo: CTh. 12.1.12 [=Brev. 12.1.2].
97 J. GAUDEMET, Constantin et les curies, cit., 45; D. LIEBS, Privilegen und Ständezwang in den Gesetzen Konstantins, in RIDA III s. 24 (1977), 297-351, 337-348.
98 Sulle norme per tenere i decurioni legati alle curie: A.H.M. JONES, The Later Roman Empire, cit., 737-755 e sulle motivazioni e forme di fuga dalle curie, v. W. LIEBESCHUETZ, The End of the Ancient City, in J. RICH (ed.), The City in Late Antiquity, London 1992, 7-8.
99 CTh. 12.1.18.1 I figli dei militari, che a 25 anni non abbiano scelto la carriera militare, sono assegnati alle curie; ribadita nel 327 (CTh. 12.1.15) “veteranorum filios curalibus muniis innec-tandos”, anche se abbiano ottenuto la posizione di perfectissimi.
100 D.50.2.6.1 (Pap. 1 respons.) Minores viginti quinque annorum decuriones facti sportulas decu-rionum accipiunt: sed interim suffragium inter ceteros ferre non possunt.
101 Dopo la pubblicazione dell’opera di C. LEPELLEY, Les cités, cit., anche grazie a ulteriori analisi mirate a realtà locali, il quadro uniforme della decadenza della vita cittadina, e quindi delle curie, si è incrinato, per l’emergere, soprattutto grazie alla valorizzazione degli studi archeologici, di isole di tenuta, se non di sviluppo delle città. A conclusioni analoghe giunge, tra gli ultimi, G.A. CECCONI, Governo imperiale e élites dirigenti nell’Italia tardoantica, Como 1994, in partic. 171-191, con ampio ragguaglio bibliografico. LEPELLEY ha ribadito le sue conclusioni in The Survival and Fall of the Classical City in Late Roman Africa, in J. RICH (ed.), The City, cit., 50-76.
178 Giovanna Mancini
vano isole quali quali alcuni capoluoghi dell’oriente greco o città dell’Africa settentrionale, mentre altrove esso si manifesta ovunque, anche se in forme più o meno annientatrici della vita cittadina102.
Nella prima metà degli anni ’20, i tentativi dei decurioni di sottrarsi ai loro obblighi devono essere stati particolarmente estesi, a giudicare dal numero delle costituzioni che l’imperatore emana per arginarli103. Vivissima deve essere, per-ciò, stata la sua preoccupazione di garantire il più possibile la coesione e la tenu-ta del ceto decurionale. Lo stesso reclutamento delle curie è evidentemente insuf-ficiente, tanto che Costantino cerca di contrastarne l’indebolimento con l’inseri-
-------------------------------------------- 102 In questo senso si veda, W. LIEBESCHUETZ, The End, cit., 7 ss., scritto che apre la raccolta J.
RICH (ed), The City, cit. L’A., pure attento alla costruzione di storie locali – a partire dalla pubblica-zione di W. LIEBESCHUETZ, Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman Empire, Oxford 1972 – sottolinea come le scelte fiscali e amministrative di Diocelziano, con la formazione di province più piccole, che rendevano più stringente il controllo del governatore sui decuriones, l’aumento dei funzionari imperiali, avessero determinato un generale impoverimento della classe curiale e la fine dell’evergetismo (riprendendo le conclusione di P. BROWN, The Making of Late Antiquity, Cambridge 1978, 27-53). A pesare era soprattutto l’esazione delle imposte, che comporta-va non solo responsabilità patrimoniale, ma anche dispendio di tempo per organizzarla, eseguirla e trasferirla alle casse imperiali (in questo senso già A.H.M. JONES, The Later Roman Empire, cit., 448-462 e 714-743). Molto acuta è, inoltre, l’osservazione di LIEBESCHUETZ sullo svuotamento di popolazione e funzioni delle città a causa della formazione di piccoli centri satellite (10-11), che vedo in possibile connessione, anche, con l’insediamento di potentiores.
Un interessante quadro analitico, anche se non tutto condivisibile, della riforma fiscale dioclezia-nea e delle forme di riscossione delle imposte è fatto da J. DURLIAT, Les rentiers de l’impôt. Recher-ches sur les finances municipales dans la pars orientis au IVe siècle, Wien 1993, passim, che – come già H.J. HORSTKOTTE, Die Theorie von spätantiken “Zwangsstaat” und das Problem der Steuerhaf-tung, in Beiträge zum klassischen Philologie 159 (1984), 74-80 – ne minimizza, tuttavia, gli effetti sulla decadenza (41-47). L’intento dichiarato di DURLIAT è quello di descrivere la creazione di un sistema durevole in cui la città ha la funzione di intermediaria nella riscossione delle imposte, e, in questo quadro, pur identificando nei curiales “persone private investite di un incarico pubblico” (31), ritiene la distinzione tra principales e semplici curiales rilevante anche per la riscossione delle impo-ste (32) e che, comunque, la responsabilità del versamento dell’intero ammontare dovuto non rica-desse sui loro patrimoni. Di qui la conclusione dell’estraneità dell’esercizio della funzione fiscale alla crisi delle curie: “Les curies n’ont pas été écrassées par le poids des impayées que leurs membres auraient dû compenser sur leur fortune”. La conclusione si basa su CTh. 11.7.16 (nt. 399); si tratta, però, di una costituzione di Onorio e Arcadio, che può, invece, risentire dei nuovi orientamenti in materia di levata e riscossione, che tendono a trasferire nuovamente la funzione impositiva alla burocrazia imperiale, proprio per il fallimento del sistema precedente.
Sulle riforme fiscali, v. oltre a R. DELMAIRE, Largesses sacrées, cit., passim, A. CHASTAGNOL, “Problèmes fiscaux au Bas-Empire”, in Aspects de l’antiquité tardive, Roma 1994, 331-348, con rinvii alla letteratura precedente, nonché, per le questioni di inquadramento generale, F. GRELLE, Le categorie dell’amministrazione tardoantica: “officia”, “munera”, “honores”, in A. GIARDINA (ed.) Società romana e impero tardonatico, I, Roma-Bari 1986, 37-56.
103 Tutto il I titolo del libro XII del Teodosiano è pieno di riferimenti in proposito; si vedano, in particolare, CTh. 12.1.10, CTh. 12.1.11, CTh. 12.1.12, CTh. 12.1.13, CTh. 12.1.14, CTh. 12.1.16, CTh. 12.1.17, CTh. 12.1.20. L’ultima costituzione di Costantino in proposito è del 336: CTh. 12.1.22. Qualche anno dopo il figlio di Costantino dovrà nuovamente intervenire contro quanti acquistano cariche per sfuggire alle curie: CTh. 12.1.25. (Quoniam emptae dignitatis obtentu curias vacuefactas esse non dubium est … ) e i reiterati, quanto inutili, interventi suoi e dei successori mostrano che le difficoltà erano insuperabili: tutto il titolo è un susseguirsi di costituzioni dello stesso tenore.
Pro tam magna sui confidentia 179
179
mento, coatto, dei figli dei veterani104 e con le misure – reiterate anche dai suc-cessori – di abbassamento dell’età di inserimento nell’ordo dei figli dei curiali105, cui abbiamo già accennato; nel 326 promulga, infine, un editto al praefectus praetorio, che ci è giunto frammentato, contenente una serie di misure per assi-curare un numero sufficiente di decurioni106, sancendo definitivamente la regola dell’ereditarietà, nonché l’inammissibilità dell’excusatio.107. Accanto a quelle coercitive, l’imperatore utilizza misure premiali per il numero dei figli, uno al-meno dei quali potrà sostituire il padre108.
È proprio in relazione alle curie – e all’esercito – che si afferma così, per la prima volta, quel principio di ereditarietà coatta delle funzioni essenziali per la collettività, di quelle politiche prima ancora che economiche, che segnerà tutta l’organizzazione sociale e giuridica del tardoantico, e oltre109.
Nella stessa età emerge la tendenza a vincolare il patrimonio degli apparte-nenti all’ordo: in caso di morte di un decurione senza figli e intestato, a succede-re è la curia110, mentre se il duoviro nominato fugge, il possesso dei suoi beni andrà a chi lo sostituisce111.
-------------------------------------------- 104 CTh. 12.1.15, CTh. 12.1.18.1, CTh. 12.1.19. 105 Fino al 320 Costantino mantiene fermo il limite dei 25 anni per l’accesso alla curia, ma in
quell’anno – anche se per la provincia d’Africa – lo abbassa ai 18 anni, ribadendo nel 331 – e questa volta con un editto generale – che si tratta dell’età minima (CTh. 12.1.19); dopo di lui, nel 343, l’età sarà abbassata a 16 anni. Sulla, discussa, datazione della prima delle due costituzioni, v. J. GAUDEMET, Constantin et les curies, cit., 47 ss.
106 Se ne veda la puntuale ricostruzione in J. GAUDEMET, Constantin et les curie, cit., 60 ss. 107 CTh. 12.1.1. 108 CTh. 12.17.1pr. (CONSTANTINUS A. DALMATIO) (19 giugno 324). 109 Le parallele disposizioni di Costantino sulle corporazioni professionali erano tese – come nota
F. DE MARTINO, Storia economica di Roma antica, II, Firenze 1979, 425 ss. – a vincolare più che le persone, i patrimoni. Si vedano per i navicularii CTh. 13.5.3 (a. 319 o 315) e per i suarii CTh.14.4.1 (a. 334). In entrambe, se si nega, in linea di principio la possibilità di esonero, si aggiunge però, per i primi “Sed et si quis patrimonium naviculario muneri obnoxium possidet, licet altioris sit dignitatis, nihil ei honoris privilegia, in hac parte dumtaxat, opitulentur, sed sive pro solido sive pro portione huic muneri teneatur. Nec enim aequum est, ut patrimonio huic functioni obnoxio excusato commune onus non omnes pro virili sustineant portione.” (CTh. 13.5.3.1), per i secondi “Itaque dinoscant facultates proprias suariorum esse obnoxias muneri ac de duobus alterum eligant; aut retineant bona quae suariae functioni destricta sunt ipsique suario teneantur obsequio aut idoneos quos volunt nominent, qui necessitati idem satisfaciant.” (CTh. 14.4.1). Quella che, soprattutto, è assente è la previsione del vincolo ereditario alla funzione, già imposto, invece, ai figli di decuriones e milites. Sulla questione della estensione e pervasività dei collegia nell’economia tardoantica, un quadro in F. DE MARTINO, Storia economica, cit., 426 ss.; sulla politica normativa costantiniana v. anche D. LIEBS, Privilegien und Ständezwang, cit., 297-351 e, da ultimo, L. DE GIOVANNI, Istituzioni, cit., 195-199, con aggiornata bibliografia in nota.
110 CTh. 5.2.1 (CONSTANTINUS A. RUFINO PF. P. [a. 318]). La costituzione è, però riferita a Co-stanzo – e quindi all’anno 352 – da P. VOCI, Il diritto ereditario romano, cit., 26.
111 CTh. 12.1.16 (a. 329).
180 Giovanna Mancini
9. Uomini, donne e patrimoni. Così come il curiale non può sottrarsi al suo ufficio, il suo patrimonio non
può mai essere sottratto alla finalità di sostenere – in perpetuo – gli oneri della città112. La soluzione più naturale è quella di una trasmissione di funzione e pa-trimonio, insieme, a uno – o più – eredi, ovviamente maschi.
Ove, alla sua morte, questo non sia possibile, oppure, in vita, egli ponga in essere atti che potrebbero pregiudicare un tal esito, intervengono norme che recuperano alla funzione predestinata almeno i suoi beni, anche se è fatta salva – almeno in età costantiniana – la libertà di testare e la successione legittima dei parenti prossimi113.
Solo un secolo più tardi, Teodosio e Valentiniano introdurranno norme spe-ciali per la successione ai curiali. Quando l’erede non è un figlio, che occuperà il posto del padre anche nell’ordo, un quarto dell’eredità va alla curia114. Alla rego-la vi sono però eccezioni: prendono per intero l’eredità non solo l’extraneus che sia obnoxium curiae eiusdem civitatis115 e i maschi della famiglia agnatizia anche se alieni curia116, ma anche le figlie, nipoti, pronipoti – così come la madre e la nonna117 – che siano già sposate118 a un curiale della stessa città e quelle che al momento della successione siano nubili, vedove o impuberi, se lo faranno entro tre anni119. La norma trova applicazione non solo per i figli e le figlie legittime, ma anche per quelli naturali120. Lo stesso Teodosio era intervenuto in materia di successione dei figli illegittimi121 nell’ordo e nel patrimonio, ribadendo la pre-
-------------------------------------------- 112 Già Diocleziano (C.10.40.4) aveva dovuto ribadire – evidentemente contro una prassi interpre-
tativa di segno diverso – che il patrimonio non era di per sé vincolato alla curia; con Costantino (cfr. CTh. 5.2.1 a. 319) l’orientamento opposto è ormai consolidato.
113 CTh. 5.2.1 “ … sine liberis intestatus diem vitae solverit, cui neque voluntas postrema legibus fulta, neque alio iure gradu proximo heres exstiterit”.
114 C.10.35.1 (THEODOS. ET VALENTIN. AA. FLORENTIO PP.) Si decurionum consortio sit alienus qui curiali successit, competentis eidem iuris (sive ex asse sive ex parte heres sit bonorumve posses-sor) partem quartam iure optimo a curia peti decernimus. (a. 428).
115 Nov.Th. 22.2.10. 116 Nov.Th. 22.2.6. 117 Nov.Th. 22.2.9. 118 Nov.Th. 22.2.7. 119 Nov.Th. 22.2.8. 120 Nov.Th. 22.2.11: Femineo vero sexui non hac tantum provisione, sed illa insuper iuris adiec-
tione consulimus. Praecipimus namque, ut ad similitudinem naturalium filiorum, quos decurionatus sorti paterna sententia dedicavit, filia quoque naturalis in matrimonium curialis adscita, si tamen nulla patri eius suppetat legitima soboles, idque paternae visum fuerit voluntati, et omnes res patrias donationis titulo consequatur, et heres scribatur ex integro: ita tamen, ut et parentum, quibus quarta pars patrimonii relinquenda est, et locorum, unde gener eligitur principalis, ad formam nuper emis-sae constitutionis ratio conservetur. Quid enim interest, utrum per filios, an per generos civitatum commoditatibus consulatur? Et utrum novos lex faciat curiales, an foveat, quos invenit? Tutte le disposizioni sono sostanzialmente confermate da Giustiniano. C.10.35.3.1, C.10.35.3.3.
121 C.5.27.3pr.(Theod./Valent. a. 443), estrapolata, con modifiche testuali da Nov.Th. 22.1.5.
Pro tam magna sui confidentia 181
181
minenza dei legittimi122, ma regolando, nell’ipotesi di loro mancanza, la condi-zione degli illegittimi, per venire incontro, insieme, alla loro condizione e all’utilità delle curie, individuata nella auctiorem multitudinem della decurionum nobilitas123. Al padre è data facoltà di destinarli alla curia e di farli eredi124, men-tre agli altri parenti legittimi deve essere lasciata quella quarta parte dell’eredità che avrebbero avuto titolo a richiedere con la querella inofficiosi testamenti125.
Nella legge di Teodosio, come si vede, non c’è soltanto la difesa del patri-monio, complessivo, dell’ordo decurionum della città: per quella sarebbe stato strumento sufficiente la destinazione della quarta parte – se non dei tre quarti – dell’eredità, comunque, alla curia. C’è anche la preoccupazione di garantire l’auctiorem multitudinem dell’ordo. La res publica ha bisogno non solo di pa-trimoni, ma di uomini. Di qui la misura premiale per le stesse figlie, legittime e no, per incentivarle a sposare curiali126.
Dal complesso della normativa traspare, inoltre, accanto alla durevolezza dei principi del diritto ereditario romano, una presenza della filiazione naturale nella casta dei curiali non trascurabile, anzi di consistenza tale da giustificare l’emanazione delle norme stesse, che sono ulteriore indizio, anche, della crisi della natalità all’interno di iusta matrimonia.
Più difficile è dare una spiegazione soddisfacente del fenomeno, in quell’estensione, delle unioni iniustae del ceto decurionale, anche se si può pen-sare all’intervento di più fattori, quali gli effetti del venir meno di incentivi al matrimonium iustum con l’abrogazione, da parte di Costantino, delle disposizioni caducarie di Augusto e della subordinazione, come abbiamo visto, da parte dello stesso imperatore, del repudium a cause particolari, tra cui non c’era la sterilità della moglie. Abbiamo anche visto come talora i decuriones si rifugiassero, pro-prio per sottrarsi alla curia, presso i potentiores (e in molte costituzioni traspare il conflitto tra questi ultimi e amministrazione imperiale127), stabilendo rapporti di stabile convivenza con le loro ancillae e colonae, così come sembrano fare le loro figlie, almeno nel V secolo; la stessa ampia diffusione del cristianesimo
-------------------------------------------- 122 Nov.Th. 22.1.4. 123 Nov.Th. 22.1.3. “ … Sed nos, a quibus solet in hominum genus semper aliquid procedere, quo
iuventur, una eademque saluberrima sanctione et horum condicioni et curiarum commoditati subve-niendum esse perspeximus, ut, quum et naturalium liberorum vilitas splendidiorem fortunam et decurionum nobilitas multitudinem desideret auctiorem, utriusque generis utilitatibus in commune perpensis, ab altero commodetur, quod alteri deficit, lexque undique temperatissima collocetur, quae et naturae vitium dignitatis impertitione soletur, et ordinum dignitatem a corporum exiguitate defen-dat”.
124 Nov.Th. 22.1.5. 125 Nov.Th. 22.1.6. 126 Nov.Th. 22.2.8-11. 127 R. GANGHOFFER, L’évolution, cit., 200 ss.
182 Giovanna Mancini
poteva, infine, favorire le unioni ineguali se tra fedeli128. Quanto, comunque, si delinea anche attraverso quegli interventi è, in una so-
cietà generalmente segnata da una crisi demografica, un quadro oggettivo di impoverimento – per mezzi e uomini – dell’ordo, che l’imperatore tenta di con-trastare, su entrambi i versanti, intervenendo, anche – con incentivi – a tutela di una endogamia di classe.
Era, questo, uno scenario già presente agli inizi del IV secolo? Alla difficoltà delle curie nell’età di Costantino e ai suoi interventi per supe-
rarle abbiamo già accennato, così come al fatto che già agli inizi del IV secolo i decuriones instaurassero rapporti di convivenza privi di conubium129. Indizio della diffusione e resistenza del fenomeno è la stessa produzione imperiale in materia nei due secoli ed è evidente l’identico interesse pubblico che con essa si vuole tutelare. All’identità del fine perseguito, non mi sembra però corrispondere quella della politica legislativa.
In primo luogo, il disfavore di Costantino per la filiazione naturale emerge anche dalle disposizioni da lui dettate che costituiscono nei figli naturali una generale incapacità successoria nei confronti del loro pater, del quale viene limi-tata, a questo fine, sia la libertà di disposizione in loro favore mortis causa e inter vivos130, sia quella di legittimarli, per adozione o per rescritto imperiale. In questi ultimi casi, oltre alla nullità dell’atto, scattano, anche, sanzioni penali, sia per il pater, sia per il figlio131.
Dal complesso della normativa del V secolo, relativa e ai figli naturali e alle unioni dalle quali questi nascevano, si ricava, invece, l’impressione che il potere imperiale, preso ormai atto di un fenomeno sostanzialmente incontrastabile, tenti conseguentemente di garantire, nel contesto dato, uomini e patrimoni necessari alla sopravvivenza stessa delle civitates.
Ulteriori indicazioni in questo senso, possono trarsi, anche, dalla Novella 7 di Maiorano, di poco successiva, che, nel dettare una serie di norme sui curiali – nervos rei publicae ac viscera civitatum – interviene a contrastare, con retroatti-vità trentennale, il fenomeno dei multi patrias deserentes, natalium splendore neglecto, che non solo occultas latebras et habitationem elegerint iuris alieni, ma anche colonarum se ancillarumque coniunctione polluerint132. Alle sanzioni, --------------------------------------------
128 Su dimensioni e motivazioni del fenomeno delle nozze ineguali, v. J. EVANS GRUBBS, Law and Family, cit., 261 ss.
129 CTh. 12.1.6 sopra nt. 74. 130 CTh. 4.6.2. Che si trattasse di norme generali, P. VOCI, Il diritto ereditario romano, cit., 44-46
lo desume, giustamente, dallo stesso tenore delle innovazioni di Valentiniano (CTh. 4.6.4). 131 CTh. 4.6.3 Entrambe le costituzioni sono del 336 e non si può certo pensare a un influsso della
chiesa che – a partire dalla decisione di Papa Callisto (217-222) – tollera, se non suggerisce, il con-cubinato in quanto permette unioni ineguali sul piano sociale, ma all’interno della stessa comunità di fede; cfr. C. MUNIER, L’église dans l’empire romain (IIe-IIIe siècles), Paris 1979, 27 ss. e già J. GAUDEMET, L’église, cit., 525 ss.
132 Novell. Maior. 7.pr.
Pro tam magna sui confidentia 183
183
contro il curiale e il dominus che l’ha accolto, seguono, tuttavia, anche disposi-zioni concernenti la prole, di segno opposto a quelle di Costantino: se le figlie restano al dominus, i figli, invece, si ex colonabus nati sint, curiae inserantur, si ex ancillis editi, collegiis deputentur133. Maiorano regola, inoltre, la sorte della figlia di un curiale che sia stata unita, dal padre, a un servus, actor o procurator: la donna deve essere restituita alla curia ed è ammessa alla successione ab inte-stato del padre, quia per eius quoque progeniem ordo reparandus est134. Nel caso in cui, invece, sia andata sposa in un’altra città, deve trasferire un quarto del suo patrimonio all’ordo a quo se alienare desiderat135; alle figlie, infine, di quan-ti si siano sottratti al decurionato rifugiandosi in funzioni ecclesiali, a partire dal diaconato, è attribuita parte del patrimonio paterno si tamen curialium connubiis copulentur136.
L’intervento di Costantino in materia di unione del decurio con una serva al-trui si muove, invece, in un’ottica diversa: quel comportamento è oggetto, esclu-sivamente, di repressione con l’allontanamento del colpevole dalla curia e l’acquisizione a essa del suo patrimonio; non vi è spazio per alcuna forma di sanatoria in relazione agli effetti dell’unione vietata, così come non vi è traccia di disposizioni analoghe a quelle di Maiorano relative a unioni matrimoniali illecite o semplicemente inopportune delle figlie di decurioni.
I problemi, l’abbiamo visto, erano però analoghi; dobbiamo, dunque, pensa-re a una differente politica legislativa costantiniana, ugualmente capace, almeno nelle intenzioni, di dar loro risposta.
10. Il raptor depectus. Abbiamo già sottolineato come l’ipotesi criminosa perseguita con l’editto si
configuri per l’agente nihil cum parentibus puellae ante depectus. Il riferimento è stato generalmente inteso come relativo ad accordi concer-
nenti il matrimonio con la puella137. L’utilizzazione di un termine inusuale138 può
-------------------------------------------- 133 Novell. Maior. 7.2. 134 Novell. Maior. 7.5. 135 Novell. Maior. 7.6. 136 Novell. Maior. 7.7. 137 Leggevano in questo senso la norma sia Papa Gelasio – v. Decret. Grat., Pars II, C. 27, Q.2, C.
48-49 (Raptam uero talem dici prohibet Gelasius Papa, ita dicens: C. XLIX. Ibi raptus admittitur, ubi puella abducitur, de cuius ante nuptiis nichil actum probatur. Lex illa preteritorum principum ibi raptum dixit esse conmissum, ubi puella, de cuius ante nuptiis nichil actum fuerit, uideatur abducta) – sia l’Interpretatio (v. sopra nt. 21). Giustiniano sottopone, invece, nel caso di violenza, lo stesso sponsus alla pena del ratto: C.9.13.1.1B (Iustinianus) Quibus connumerabimus etiam eum, qui saltem sponsam suam per vim rapere ausus fueri (a. 533).
138 Se il Thesaurus L.L., V, s.v. “Depeciscor”, 562, riporta anche luoghi in cui il verbo è utilizzato con valore neutro, nel linguaggio costantiniano, il termine non sembra aver perso, il senso negativo che aveva in D.3.6.3.2 (Ulp. 10 ad ed.) Hoc edicto [de calumniatoribus] tenetur etiam is qui depec-tus est: depectus autem dicitur turpiter pactus; v. C.9.42.2.1, CTh. 2.10.4 [=Brev. 2.10.1], CTh.
184 Giovanna Mancini
spiegarsi con la mera consensualità139 – e proprio per questo con la possibilità che esso si cali in qualunque forma – del fidanzamento fino allora vigente tra i cives Romani e, dunque, con l’opportunità di far uso di un termine, più neutro di sponsio, nel quale potessero confluire eventuali diverse usanze locali. Nel lin-guaggio costantiniano, il termine non sembra, però, aver perso il senso negativo che aveva nel secolo precedente, quello di turpiter pactus140. Il contesto potreb-be far pensare alla sua utilizzazione per indicare un accordo di fidanzamento che comportasse l’autorizzazione a portar via la puella anche nolentem141 – proprio per forzarla al matrimonio – e, per questo, turpe.
Nel diritto del secolo precedente, il fidanzamento, la promessa di un futuro matrimonio tra un uomo e una donna, non ancora necessariamente in età pubere, impegnava le parti a porre in essere le nozze e produceva una serie di effetti giuridici142; le parti restavano, tuttavia, libere di sciogliersi dalla promessa, senza che questo determinasse alcuna conseguenza, neppure di carattere patrimoniale.
Secondo la regola enunciata da Paolo143, all’accordo relativo a un successivo matrimonio dovevano partecipare gli stessi il cui consenso era richiesto per il matrimonio: nubendi ed – eventualmente – aventi potestà su di loro.
Nel II secolo144 la tendenza sembra essere stata quella di valorizzare la vo-lontà dei fidanzati rispetto a quella del rispettivo pater, il cui consenso è presun-to, se non vi sia aperta opposizione; tendenza che si invertirebbe nel secolo suc--------------------------------------------- 9.37.1 [=Brev. 9.27.1].
139 D.23.1.4pr. (Ulp. 35 ad Sab.) Sufficit nudus consensus ad constituenda sponsalia. 140 D.3.6.3.2 (Ulp. 10 ad ed.) Hoc edicto [de calumniatoribus] tenetur etiam is qui depectus est:
depectus autem dicitur turpiter pactus; v. C.9.42.2.1, CTh. 2.10.4 [=Brev. 2.10.1], CTh. 9.37.1 [=Brev. 9.27.1].
141 F. GORIA, s.v. Ratto, cit., 714 nt. 43, sembra, viceversa ritenere che, in caso di accordo matri-moniale preesistente, fosse comunque necessaria la responsio puellae raptae, argomentando da Ed.Th. 92 e dal fatto che, anche successivamente alla costituzione costantiniana, la pratica della responsio sarebbe attestata in CTh. 9.25.1. Mi sembra, però, che se la la prima fonte, successiva di quasi due secoli, sia sostanzialmente inidonea a dare un’interpretazione autentica di CTh. 9.24.1, la seconda si limiti, di per sé, a negare ogni utilità alla responsio, anche per le sacrosanctae e viduae, confermando la ratio della costituzione costantiniana relativa alle puellae. Non riesco a vedere come si possa argomentare dal persistere della pratica dell’assenso della donna – che questa fosse stata o meno la sua volontà iniziale – a un matrimonio successivo al ratto, la necessità del consenso all’abduzione dell’oggetto del patto tra parentes e raptor per escludere la punibilità di quest’ultimo.
142 Già una costituzione di Alessandro Severo pare equiparare la sponsa alla moglie ai fini dell’esercizio dell’azione ex lege Iulia de adulteriis (ma qui non si parla di ratto ma di stuprum): C.9.9.7pr. ( ALEX. A. HERCULANO) Propter violatam virginem adultam qui postea maritus esse coepit accusator iustus non est et ideo iure mariti crimen exercere non potest, nisi puella violata sponsa eius fuerit (a. 223). Ma, contra, Coll. 4.6.1, Paul. Adult. In uxorem adulterium vindicatur iure mariti, non etiam sponsam. Severus quoque et Antoninus ita rescripserunt. Quadro in R. ASTOLFI, Il fidanzamento, cit., 111 ss.; cfr. già J. GAUDEMET, L’originalité des fiançailles romaines, in Iura 6 (1955) 43-77, 53-54.
143 D.23.1.71 (Paul. 35 ad ed.) In sponsalibus etiam consensus eorum exigendus est, quorum in nuptiis desideratur. Intellegi tamen semper filiae patrem consentire, nisi evidenter dissentiat, Iulia-nus scribit.
144 In particolare in Giuliano, v. R. ASTOLFI, Il fidanzamento, cit., 70-73.
Pro tam magna sui confidentia 185
185
cessivo145. Per Ulpiano146, infatti, è il consenso della figlia alla scelta del padre a essere presunto147 e può, inoltre, essere negato solo in casi particolari148.
Il fidanzamento, soprattutto, può essere istituito anche in assenza di una del-le parti che devono consentire149, nulla può quindi impedire al pater di accordarsi sulle nozze della figlia senza la sua partecipazione e tale accordo sarà ritenuto, fino a prova contraria, condiviso dalla figlia stessa150.
Questa prassi appare usuale in età costantiniana, come attesta CTh. 3.5.5, che ci mostra la puella desponsata, semplice oggetto delle pattuizioni matrimoniali, da parte del padre, del tutore o del curatore151.
È, infine, proprio con Costantino che si delinea la volontà normativa di ren-dere definitivi gli effetti del fidanzamento152, sancendo, in caso di rottura, san-zioni civili e, in qualche caso, penali.
-------------------------------------------- 145 Nettamente in questo senso, anche se nella consapevolezza dei dubbi di autenticità di
D.23.1.12, R. ASTOLFI, Il fidanzamento, cit., 73 ss. Sempre del III secolo è la testimonianza di Mode-stino (D.23.1.14, 4 different.): In sponsalibus contrahendis aetas contrahentium definita non est ut in matrimoniis. Quapropter et a primordio aetatis sponsalia effici possunt, si modo id fieri ab utraque persona intellegatur …”; essa – tanto più se l’indicazione dell’età minina in sette anni è frutto di interpolazione, legata alla fissazione del termine ‘legale’ di uscita dall’infanzia dovuta a Costanzo (CTh. 8.18.8 a. 407) – getta ulteriore luce sulla natura del consenso al fidanzamento: per la sua formazione è sufficiente comprendere il significato dell’atto, non dei suoi effetti; cfr. R. ASTOLFI, Il fidanzamento, cit., 58-60e nt.5 ss. Anche in vigenza della lex Papia, infatti, un fidanzamento con una bambina di età minore sarebbe stato irrilevante solo ai fini della stessa legge, ma non per questo invalido.
146 Almeno nel testo riportato nel Digesto, ritenuto, però, dai più, interpolato (cfr: R. ASTOLFI, Il fidanzamento, cit., 73), anche se mi pare innegabile che la stessa possibilità generalmente ammessa (D.23.1.18, v. testo alla nt. 149) della stipula di accordi matrimoniali per altri non potesse non inci-dere sulla natura stessa del consenso – della ratifica – che la “sponsa” avrebbe dovuto dare agli sponsalia intercorsi tra il futuro marito e non un estraneo, ma il proprio pater.
147 D.23.1.12pr. (Ulp. sing. de spons.) Sed quae patris voluntati non repugnat, consentire intelle-gitur.
148 D.23.1.12.1 (Ulp. sing. de spons.) Tunc autem solum dissentiendi a patre licentia filiae conce-ditur, si indignum moribus vel turpem sponsum ei pater eligat, mentre il figlio non è limitato nelle ragioni di dissenso: D.23.1.13 (Paul. 5 ad ed.) Filio familias dissentiente sponsalia nomine eius fieri non possunt.
149 D.23.1.18 (Ulp. 6 ad ed.) In sponsalibus constituendis parvi refert, per se (et coram an per in-ternuntium vel per epistulam) an per alium hoc factum est: et fere plerumque condiciones interpositis personis expediuntur.Adde D.23.1.4.1. (Ulp. 35 ad Sab.)
150 Questa, anzi, come giustamente nota R. ASTOLFI, Il fidanzamento, cit., 74-75, doveva essere la prassi abituale.
151 CTh. 3.5.5 [=Brev. 3.5.4] [CONSTANTINUS] A. AD PACATIANUM P.U. Patri puellae aut tutori aut curatori aut cuilibet eius affini non liceat, quum prius militi puellam desponderit, eandem alii in matrimonium tradere. Quod si intra biennium, ut perfidiae reus in insulam relegetur. Quod si pactis nuptiis, transcurso biennio, qui puellam desponderit, alteri eandem sociaverit, in culpam sponsi potius quam puellae referatur, nec quicquam noceat ei, qui post biennium puellam marito alteri tradidit.
152 Così R. ASTOLFI, Il fidanzamento, cit., 172 ss. che valorizza, in questo senso: CTh. 3.5.2 [CONSTANTINUS] A. AD MAXIMUM P.U. Quum veterum sententia displiceat, quae donationes in sponsam nuptiis quoque non secutis decrevit valere, ea, quae largiendi animo inter sponsos et spon-sas iure celebrantur, redigi ad huiusmodi condiciones iubemus, ut, sive in potestate patris degere
186 Giovanna Mancini
Un riflesso di questa impostazione potremmo vederlo proprio nel nostro e-dictum: una volta stipulato l’accordo concernente il matrimonio – che, sussisten-do i requisiti, inizia, di norma, con la ductio nella casa del marito153 – l’uomo con cui i parentes abbiano pattuito sembra autorizzato a dar inizio alla convivenza, con o contro la volontà della donna oggetto del patto. Una volta portata via la donna, anche non consenziente, nella casa del raptor, si sarebbe determinata
-------------------------------------------- sive ullo modo proprii videantur esse iuris, et tanquam futuri causa matrimonii aliquid sibi ipsi vel consensu parentum mutuo largiantur, siquidem sponte vir sortiri noluerit uxorem, id, quod ab eo donatum fuerit, nec repetatur traditum, et si quid apud donatorem resedit, ad sponsam summotis ambagibus transferatur. 1. Quod si matrimonii non contrahendi causa ab sponsa, vel in cuius agit potestate, detegatur exstitisse, tunc sponso eiusque heredibus sine aliqua deminutione redhibeatur. 2. Quae similiter observari oportet, et si ex parte sponsae in sponsum donatio facta sit; nullis causis ulterius requirendis, ne forte mores aut origo dicatur, vel quicquam aliud opponatur, quod sibi quisquam non convenire existimat, quum longe ante, quam sponsalia contrahantur, haec cuncta prospici debuerint. Sola igitur indagetur voluntas, et mutata animi sententia ad restitutionem seu repetitionem rerum donaturum sufficiat, quum universis cautionibus pulsis, nihil amplius constare debeat, nisi ut appareat, qui sibi contrahendum matrimonium dixerit displicere. 3. Et quoniam fieri potest, ut moriatur alter adhuc incolumi voluntate prius, quam nuptiae contrahantur, congruum duximus, eo, in quem fuerat facta donatio, ante matrimonii diem functo, quae sponsaliorum titulo vel data vel ullo genere donata sunt, ad eum, qui donaverat, revocari: eo etiam, qui donaverat, ante nuptias mortuo, mox infirmari donationem, et ad eius heredes sine aliqua difficultate retrahi res donatas. 4. Quod beneficium usque ad personam patris aut matris, filiorum etiam, si qui de priore matrimonio fuerint, stare decernimus, si quocumque modo ex his persona aliqua defuncto successe-rit. Quod si ex his nulla persona defuncti heres habetur, sed ex reliquis gradibus quisquam succedat, donationes convenit etiam non insecutis ex causa mortis nuptiis convalescere, quoniam illis tantum personis credimus consulendum; cfr. C. DUPONT, Peine et relations pécuniaires entre fiancés et conjoints dans les constitutions rendues de 312 à 565 après Jésus-Christ, in RIDA III s. 23 (1976), 119 ss.
153 La ductio non era certo sufficiente a costituire il rapporto matrimoniale; essenziale, nel presup-posto che esistessero consenso e conubium, era l’età: D.48.5.14.8 (Ulp. 2 de adult.) Si minor duode-cim annis in domum deducta adulterium commiserit, mox apud eum aetatem excesserit coeperitque esse uxor, non poterit iure viri accusari ex eo adulterio, quod ante aetatem nupta commisit, sed vel quasi sponsa poterit accusari ex rescripto divi Severi, quod supra relatum est; D.23.1.9 (Ulp. 35 ad ed.) Quaesitum est apud Iulianum, an sponsalia sint, ante duodecimum annum si fuerint nuptiae collatae. et semper Labeonis sententiam probavi existimantis, si quidem praecesserint sponsalia, durare ea, quamvis in domo loco nuptae esse coeperit: si vero non praecesserint, hoc ipso quod in domum deducta est non videri sponsalia facta. quam sententiam Papinianus quoque probat.
Siamo, con Ulpiano, ancora in un periodo in cui il consenso della donna è indispensabile, non solo ai fini del matrimonio, ma anche (con i limiti visti) ai fini del fidanzamento: la sponsa può, da sola, liberamente recedere da esso, senza alcuna conseguenza. Quale, però, potesse essere la libera volontà manifestata della sponsa-bambina e come potesse – già portata nella casa del promesso sposo – manifestarne una opposta è arduo concepire. Può, però, essere accusata di adulterio.
Teodosio vincolerà la donna alla volontà del padre che l’avesse fidanzata e fosse morto prima delle nozze: CTh. 3.5.12 [=Brev. 3.5.7] (IMPP. HONOR. ET THEODOS. AA. AD MARINIANUM P.P.) Post alia: si pater pactum de filiae nuptiis inierit et humana sorte consumptus ad vota non potuerit pervenire, id inter sponsos firmum ratumque permaneat, quod a patre docebitur definitum, nihilque permittatur habere momenti, quod cum defensore, ad quem minoris commoda pertinebunt, docebitur fuisse transactum. Periniquum est enim, ut contra patriam voluntatem redempti forsitan tutoris aut curato-ris admittatur arbitrium, quum plerumque etiam ipsius feminae adversus commoda propria invenia-tur laborare consilium etc.
Pro tam magna sui confidentia 187
187
quella “vera e propria presunzione che faceva considerare come matrimonio ogni convivenza con donna libera e ingenua”154.
Si sarebbe, però, costituito un vero e proprio matrimonium? Giustamente, buona parte della dottrina155, individua l’elemento essenziale del matrimonio romano nella volontà – perdurante – dei coniugi; in assenza di essa, dell’affectio, il matrimonio, semplicemente, non esiste.
Il ‘volere’ non presuppone, tuttavia, non necessariamente, l’iniziale libertà di scelta. Altro è, infatti, per ragioni di convenienza, per incapacità di reagire, ac-cettare – e quindi volere – come male minore, uno stato di fatto imposto, altro è aver voluto – e tuttora volere – liberamente la creazione di un rapporto matrimo-niale con una determinata persona.
Questa seconda forma di volontà non è, però, essenziale, già nei secoli pre-cedenti, alla costituzione di un rapporto matrimoniale neppure per i figli maschi, se in potestate156.
In assenza di atti estremi della donna, al ratto conseguirà dunque, nella gene-ralità dei casi, con la convivenza, quel matrimonium iustum concordato tra pa-rentes e raptor, in assenza di – se non contro – ogni iniziale volontà della donna.
-------------------------------------------- 154 D.23.2.24 (Mod. 1 regul.) In liberae mulieris consuetudine non concubinatus, sed nuptiae in-
tellegendae sunt, si non corpore quaestum fecerit. Le parole nel testo sono di R. ORESTANO, La struttura giuridica del matrimonio romano dal dirit-
to classico al diritto giustinianeo, I, Milano 1951, 303, il quale, pur non considerano la deductio elemento costitutivo del matrimonio, le riconosce la funzione di “rendere esteriormente e socialmente apprezzabile l’incontro delle due volontà” (301), poiché, con richiamo di Pomponio (5 ad Sab.), D.23.2.5, “far entrare la donna nella casa maritale doveva costituire la maniera più idonea, chiara, inequivocabile, semplice, affinché le parti manifestassero la loro volontà e la donna assumesse agli occhi di tutti la posizione di moglie”. Nello stesso senso, E. VOLTERRA, s.v. Matrimonio, cit., 740-744, e J. GAUDEMET, Originalité et destin du mariage romain, in “L’Europa e il diritto romano”, Studi in memoria di Paolo Koschaker, II, Milano 1954, 513-517, 516 ss, S. TREGGIARI, Roman Marriage. “Iusti Coniuges” from the Time of Cicero to the Time of Ulpian, Oxford 1991, 56.
155 A partire dalla serie di articoli di R. ORESTANO, apparsi in SDHI 47 (1940), 48 (1941), 55-56 (1952) e raccolti nel volume La struttura giuridica del matrimonio romano, cit.
Continua a ritenere il consenso iniziale sufficiente all’esistenza del matrimonio, salvo diversa e-spressione di volontà, tra gli ultimi O. ROBLEDA, Il consenso matrimoniale presso i romani, in G. CRIFÒ (ed.), Conferenze storico-giuridiche dell’Istituto di storia del diritto e filosofia del diritto (Perugia), Perugia 1980, 101-151.
156 E. VOLTERRA, s.v. Matrimonio, cit., 746 e nt. 41, nega che “il paterfamilias potesse costituire con la sua esclusiva volontà il matrimonio della filiafamilias”, affermazione vera, in astratto. Il punto è che, però, il passo di D.23.2.22 (Cels. 15 dig.) Si patre cogente ducit uxorem, quam non duceret, si sui arbitrii esset, contraxit tamen matrimonium, quod inter invitos non contrahitur: maluisse hoc videtur – su cui v. bibliografia essenziale nella nota 41 sopra citata – ci mostra come la volontà rilevante – anche per il figlio – non fosse quella libera, ma quella comunque formatasi, anche se solo con Onorio e Teodosio si arriverà a formulare la regola dell’irrilevanza della volontà della figlia (C.5.4.20).
Sull’elemento consensuale nel fidanzamento e nel matrimonio nella dottrina della chiesa, un qua-dro in J. GAUDEMET, L’église, cit., 511 ss.; sulla sostanziale ininfluenza del consenso della figlia a fidanzamento e matrimonio, v. C. CASTELLO, Legislazione costantiniana, cit., 390 e nt. 30.
188 Giovanna Mancini
Ma perché l’imperatore ritiene indispensabile porre sotto l’esclusivo control-lo delle famiglie le nozze delle figlie157?
11. Donne e patrimoni. Il matrimonio di una figlia aveva certamente conseguenze sul patrimonio
della sua famiglia e sui patrimoni, futuri, degli eredi del padre. Innanzi tutto, il costituirle una dote – già in Celso officium patris158– era di-
venuto un vero e proprio obbligo159 dopo la constitutio Severi et Antonini160, che aveva incaricato i proconsoli e i praesides perché costringessero i padri a prov-vedervi.
Il diritto ereditario vigente all’epoca, destinava, inoltre, ineluttabilmente, una parte del patrimonio del pater alla figlia, in postestate o sui iuris, nubile o nupta che fosse161. Come abbiamo visto, si dovrà attendere fino a Teodosio perché si creino norme eccezionali per la successione degli appartenenti alle famiglie curiali162 e l’imperatore motiverà l’ammissione alla successione delle stesse figlie naturali, a condizione che siano spose di curiali, con le parole: “quid enim interest, utrum per filios, an per generos civitatum commoditatibus consulatur? Et utrum novos lex faciat curiales, an foveat, quos invenit?”163.
-------------------------------------------- 157 Sottolinea il fatto che le disposizioni costantiniane “mostravano di voler tutelare la libera de-
terminazione della famiglia nelle scelte matrimoniali più che non quelle della donna stessa” F. GORIA, s.v. Ratto, cit, 715; cfr. anche, da ultimo, F. BOTTA, “Per vim inferre”, cit., in particolare 153 ss.
158 D.37.6.6 (Cels. 10 dig.) Dotem, quam dedit avus paternus, an post mortem avi mortua in ma-trimonio filia patri reddi oporteat, quaeritur. Occurrit aequitas rei, ut, quod pater meus propter me filiae meae nomine dedit, perinde sit atque ipse dederim: quippe officium avi circa neptem ex officio patris erga filium pendet et quia pater filiae, ideo avus propter filium nepti dotem dare debet. Quid si filius a patre exheredatus est? Existimo non absurde etiam in exheredato filio idem posse defendi, nec infavorabilis sententia est, ut hoc saltem habeat ex paternis, quod propter illum datum est.
159 In questo senso, cfr. R. ASTOLFI, La “lex Iulia et Papia”, Padova 19953, 152 ss. 160 D.23.2.19 (Marcian. 16 dig.) Capite trigesimo quinto legis Iuliae qui liberos quos habent in
potestate iniuria prohibuerint ducere uxores vel nubere, vel qui dotem dare non volunt ex constitu-tione divorum Severi et Antonini, per proconsules praesidesque provinciarum coguntur in matrimo-nium collocare et dotare. Prohibere autem videtur et qui condicionem non quaerit.
161 V. P. VOCI, Il diritto ereditario romano, cit., 23, sottolinea come Costantino innovi ben poco in materia di successione intestata, al contrario di quanto fa per quella testamentaria, unificando testamento civile e pretorio ed abolendo il formalismo delle disposizioni, v. 30 ss.
Sui limiti alla facoltà di disporre, VOCI, cit., 40 ss.; le innovazioni costantiniane riguardano solo i fratelli germani (CTh. 2.19.1 e 3) e (CTh. 2.19.2) la madre che può ora essere ammessa alla succes-sione ab intestato con la querella nei confronti del testamento del figlio solo se si sarà escluso che: an mater inhonestis factis atque indecentibus votis filium forte obsedit, insidiisque eum vel clandesti-nis vel manifestis appetiit, vel inimicis eius suas amicitias copulavit, atque in aliis sic versata est, ut inimica potius quam mater crederetur: hoc probato, invita etiam acquiescat filii voluntati.
162 Nov.Th. 22.2.1-2. 163 C.5.27.3.4 (THEOD./VALENT.) Et si filiam naturalem vel filias habuit et eam vel eas curiali vel
curialibus civitatis, ex qua oriundus est vel sub qua vicus vel possessio unde oritur consistit, vel eius civitatis, quae principatum totius provinciae tenet, matrimonio collocavit, haec eadem et in persona
Pro tam magna sui confidentia 189
189
Sarebbe certamente improprio anticipare all’età di Costantino l’esplicita mo-tivazione di Teodosio.
Il problema di provvedere in qualunque modo alle esigenze delle città e della res publica, gli si poneva, tuttavia, esattamente negli stessi termini164.
12. Rei publicae incommodum est curias hominum paucitate languescere165. Mantenere legati alle funzioni cittadine i decuriones, non era, l’abbiamo vi-
sto, sufficiente. Era necessario assicurarsi che, sempre, il loro numero fosse quel-lo necessario. Il che comportava la nascita dai decurioni di un numero di figli maschi166 tale da rendere certa la continuità della gestione delle cariche.
La situazione delle varie civitates era sempre stata – e continuò a essere – differenziata: in alcune di esse, come abbiamo accennato, la crisi economica generale pesava di meno e non impediva l’accesso di nuove famiglie nello stesso ceto dei curiali. Questa era però una condizione tutt’altro che generalizzata. Nel-le altre civitates il ricambio del ceto di governo non poteva che essere interno a esso; le aspettative medie di vita facevano però sì che anche con un numero relativamente elevato di figli, la speranza di sopravvivenza di uno di essi, ma-schio, al padre non fosse altissima167. Nella persistenza del sistema successorio, il rischio del venir meno non solo del decurio, ma anche del suo patrimonio, alla funzione assegnata poteva, perciò, essere scongiurato non solo con l’ereditarietà della carica, ma anche cristallizzando, di fatto, un’endogamia di ceto. Era, que--------------------------------------------- eius vel earum ad exemplum marium obtinebunt. 5. Quid enim interest, utrum per filios an per gen-eros commoditatibus civitatum consuletur, et utrum novos lex faciat curiales, an foveat quos invenit? (a. 443).
164 Cfr. in questo senso anche G. ALFÖLDY, Storia sociale dell’antica Roma (1975), trad. it. di A. ZAMBRINI, Bologna 1987, 227 ss. in partic. 242-244.
La costituzione di Costanzo e Costante, da cui è tratto il titolo del paragrafo, è solo di qualche an-no successiva a CTh. 9.24.1.
165 CTh. 12.1.32. IDEM AA. AD HILARIANUM. Militarium filios, qui gestandis armis idonei non esse dicuntur, curiis iam iamque tradi oportet. Nam rei publicae incommodum est curias hominum paucitate languescere. Dat. Xvi kal. Sept. Marcellino et Probino conss. (Costanzo e Costante a. 341).
166 Quanto all’appartenenza alla curia per discendenza unicamente femminile, l’unico accenno è in una costituzione di Giuliano del 362, relativa, però alla sola curia di Antiochia, CTh. 12.1.51. Liba-nius, Orationes 48.15 si lamenta, 26 anni dopo, della sua disapplicazione. La possibilità è, successi-vamente, esplicitamente esclusa, in via generale, da CTh. 12.1.137.1, del 393. Si veda, tuttavia l’accenno in Novell. Maior. 7.5, alla figlia del curiale ricondotta alla curia perché per eius quoque progeniem ordo reparandus est. e (Novell. Maior. 7.6) a quella che, sposatasi al di fuori della sua citta, illi urbi, ad quam migraverit, curialis sine dubitatione paritura. L’interpretatio riferisce quest’ultima affermazione, così come l’inciso di 7.5 all’ipotesi in cui la donna se curiali iunxerit, condizione alla quale nel testo non è fatto, però, riferimento alcuno, ad eccezione del successivo 7.7. Su Libanio – e Antiochia – v. W. LIEBESCHUETZ, Antioch, cit., passim.
167 J. GOODY, Production and Reproduction, Cambridge 1976, 133-134; cfr. R. SALLER, I rappor-ti di parentela e l’organizzazione familiare, in E. GABBA – A. SCHIAVONE (curr.), Storia di Roma, IV, Torino 1989, 5151-556.
190 Giovanna Mancini
sta, una condizione essenziale per assicurare la permanenza all’interno dell’ordo del complessivo patrimonio dei curiali e, a questo fine, era necessario limitare la facoltà di scelta anche dei soggetti non immediatamente coinvolti nella gestione dei munera.
Un intervento immediatamente ablativo del conubium tra curiali ed estranei all’ordo non solo sarebbe stato, forse, troppo dirompente168, ma non sarebbe neppure stato sufficiente a garantire il necessario numero di matrimonia iusta da cui nascessero nuovi curiali dotati di patrimoni adeguati alle funzioni.
Al dovere del decurione di assicurare, con i suoi figli, continuità alla curia, non poteva non corrispondere il dovere delle donne di famiglia curiale di rendere possibili matrimonia che, per la condizione della moglie, rendessero più lieve il peso stesso dei munera.
Se il figlio del decurione non avrebbe potuto evitare di subentrare al padre – e avrebbe, anche per questo, cercato una moglie della sua stessa classe e, comun-que, dotata di un patrimonio adeguato – alla figlia doveva essere negata sia la possibilità di sottrarre il patrimonio paterno – o parte del patrimonio paterno – alla stessa funzione, scegliendo un marito al di fuori del suo ceto, sia quella di sottrarre se stessa alla funzione di riproduzione di curiali. Non mi pare un caso che una costante nelle costituzioni in materia sia data – oltre che dai riferimenti alla dignitas – dalla confisca patrimoniale, spesso a favore della curia, e dall’esclusione dei soggetti che ne avevano violato le norme proprio dalla suc-cessione familiare.
Attribuire ogni scelta matrimoniale relativa alla donna esclusivamente ai pa-rentes poteva, in linea di massima, scongiurare – o almeno diminuire – il perico-lo che ella potesse sottrarsi a questo dovere: il reciproco interesse ad analoghi scambi matrimoniali avrebbe favorito – se non assicurato – la scelta di un appar-tenente allo stesso ordo.
Si trattava, inoltre, di una linea di politica legislativa che si poneva in conti-nuità con una tradizione romana – culturale, ma anche giuridica – che neppure nei secoli precedenti si era completamente spenta, che trovava sintonia con la mentalità della maggioranza delle popolazioni orientali e poteva avere sostegno nel modello che la patristica più autorevole prescriveva alle donne.
Una scelta facile, anche se – come dimostrano gli interventi imperiali suc-cessivi – tutt’altro che risolutiva.
Per le puellae – anche per le poche che avevano potuto conoscerlo – il tempo delle fabulae era, intanto, finito per sempre.
-------------------------------------------- 168 E avrebbe anche potuto ridurre gli effetti positivi che quel minimo di mobilità sociale ancora
esistente poteva dare per contribuire a frenare la decadenza economica dell’ordo.