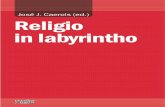Motivi leggendari nel teatro religioso medievale: "Il seminatore del grano"
Transcript of Motivi leggendari nel teatro religioso medievale: "Il seminatore del grano"
MARCO PICCAT
MOTIVI LEGGENDARI NEL TEATRO RELIGIOSO MEDIEVALE: «IL SEMINATORE DEL GRANO»
È già stato ampiamente rilevato che il teatro medievale in genere ha utilizzato, rielaborandoli, o ha prodotto testi al massimo comunicabili, servendosi per questo di tutti i possibili documenti o fonti, spesso attraverso la fusione di differenti e a volte contrastanti tradizioni. Essendo obiettivo della messa in scena quello di rendere la vicenda comprensibile e popolare, indipendentemente dalla sua natura, con una ricerca capillare di tutti gli espedienti atti a mantenere desto e costante l'interesse del pubblico anche durante i momenti di stasi o di calo dell'azione dram-
matica. Valgono pure per il teatro religioso di quel periodo, a mio avviso, le esigenze di localizzazione (tramite la divisione ed illustrazione delle «Vite» dei protagonisti in età particolari, come infanzia o maturità ... ), e di schematizzazione (grazie alla costruzione di repertori similari); gli esiti tuttavia sono molto vari in considerazione dell'innestarsi della tradizione leggendaria, di origine recente, su quella apocrifa, ricca da sempre di spunti originali, fantastici ed estremamente graditi ormai anche al pub-
blico dei paesi occidentali. I compilatori dei testi, a questo proposito, dovendo impostare ca-
novacci di azioni sceniche, operavano scelte per accogliere indicazioni o motivi spesso estranei al testo di fonte: la vitalità di tradizioni orali, la fortuna di leggende originarie di altri paesi, i temi della predicazione popolare, lo svilupparsi di credenze locali, gli interventi dei gruppi religiosi o laici fungevano da pressanti stimoli alla compilazione dei repertori.
305
L'apparato iconografico collaborava alla fissazione dei generi illustrando precise sequenze e condizionando la ripetitività dei tipi. Le botteghe si servivano di cartoni modello per impostare gli sviluppi delle vicende e le didascalie abbinate alle singole scene costituivano le essenziali informazioni scenografiche.
Il teatro aveva pertanto a propria disposizione differenti canali di rinvenimento di materiali inediti per l'allestimento delle scene e per la strutturazione delle vicende, materiali di cui oggi si è perso, in parte, il significato.
Un esempio che può servire a documentare la fortuna di un motivo leggendario, estraneo per quanto si conosce oggi all'ambito della produzione letteraria, ma riconducibile a fonti apocrife, diffuso nell'iconografia e nel teatro dal XIII secolo, è quello del seminatore partecipe alla fuga in Egitto della Sacra Famiglia (1).
La raffigurazione diffusa in epoca medioevale del passo di Matteo (2), che dà modo di vedere Giuseppe, alla guida dell'asina che trasporta Maria ed il Figlio, sovente rivolto indietro a scrutare l'orizzonte per paura degli inseguitori o accompagnato da un angelo, attraverso un paesaggio vario con la costante presenza di un albero di palma (oggetto peraltro di un diverso prodigio), è arricchita di un nuovo sviluppo. Compare infatti in scena un contadino, intento a seminare del grano, a colloquio alternativamente o con i membri della Famiglia o con la soldataglia di Erode appena sopraggiunta. Il grano che al momento del primo incontro è appena seminato, cresce improvvisamente all'arrivo dei gendarmi a coprire quasi la direzione della fuga e soprattutto a celarne l'immediatezza. Le illustrazioni dell'episodio presentano a volte l'intera vicenda senza soluzione di continuità e ciò ha comportato alcune difficoltà interpretative.
Il primo studioso che ha sottolineato la particolarità della raffigurazione è stato il Male nel 1908. Il motivo è stato rapportato al testo
l) Cfr. Matteo, 2,13-19.
2) L'iconografia del passo in esame fu peraltro fortemente influenzata anche dalla tradizione risalente all'apocrifo Pseudo Matteo, c.XVII e sgg. La narrazione del viaggio viene qui ampliata con l'incontro tra la famiglia in fuga e gli animali selvaggi, l'episodio noto come miracolo della palma e l'ingresso nel tempio egiziano. Il carattere avventuroso che contraddistingue il percorso alla volta dell'Egitto è implicito già nel consiglio fornito dall'angelo a Giuseppe: «Tolle Mariam et infantem, et per viam eremi perge in Aegyptum ». Cfr. C. TISCHENDORF, Evangelia Apocrypha, Lipsiae 1832, (ora Hildesheim 1966) pp. 51-112; E. AMAN, Le Protévangile de ]acques et ses remaniements latins, Paris 1910, pp. 272-339. Un'ulteriore elaborazione del motivo in M. DOUHET, Dictionnaire des Légendes du Christianisme ou collection d'histoires apocryphes et merveilleuses, in « Encvclooédie Théologique >>. t. XIV, Paris 1855, dal testo di una «Vita Christi » del XV secoio << Ils passèrent par bois, par forets, par montagnes, et par les déserts, camme gens qui avoient grand peur », col 886.
306
di un incunabolo del XV secolo, stampato a Lione, di cui un esemplare
si trova alla Biblioteca N azionale di Parigi ( 3). Si conoscono oggi numerose illustrazioni della vicenda, a partire dal
XIII secolo e relativamente alle regioni francesi di centro ovest: Rougemont (Còte d'Or), Saint Julien du Sault (Yonne), Saint Maurice sur Loire (Loire), con una successiva diffusione nelle regioni centro-meridionali: Avioth (Meuse), Bourges (Loir et Cher), Grézillé (Maine et Loire), Bessans e Lanslevillard (Savoia), Luceram e Brigue (Hautes Alpes). Il motivo è rappresentato in sculture, affreschi e vetrate (4). Per quanto riguarda la sua diffusione in Italia, occorre osservare che è affidata a pitture ad affresco ed è quasi contemporanea all'ultima diramazione francese appena indicata. La zona interessata è qui relativa alla fascia dell'attuale confine o ad aree montane comunque in contatto con l'Oltralpe: Brossasco e Sampeyre in valle Varaita, Bastia nel Monregalese e nella Stura di Lanzo,
S. Maurizio Canavese (5). La scena veniva inoltre riprodotta variamente, come ornamento di
oggetti ( 6). Aveva iniziato a comparire, - e la sua fortuna in questo settore
sarà notevole - in miniature relative alla vita di Cristo indipendentemente
3) E. MALE, L'art religieux du XIII• siècle en France, Paris 1948, pp. 216 e sgg.; il motivo era stato però in precedenza già segnalato da X. BARBIER DE MoNTAULT, Traité d'iconographie chrétienne, Paris 1890, t. Il, c. XIX, La fuite en Egypte, pp. 123-124. L'incunabolo, ora alla Biblioteca di Parigi, è composto da 29 carte ed ha per titolo «De quelques miracles que l'Enfant Jésus fit en sa jeunesse ».
4) Per le segnalazioni del motivo in area francese, cfr., oltre a X. BARBIER DE MoNTAULT già citato, L. RÉAU, Iconographie de l'art chrétien, Paris 1957, t. II, Iconographie de la Bible, c. III, Le massacre des Innocents et la fuite en Egypte, coll. 267-288, (per Rougemont, Saint Julien du Sault, Avioth); M. RoQUES, Les peintures murales du sud-est de la France, Paris 1961, pp. 240-250 (Lanslevillard), pp. 286-289 (Luceram), pp. 255-262 (Bessans), pp. 341-352 (La Brigue); le indicazioni relative a Saint Maurice sur Loire, Bourges e Grézillé sono tratte invece da J. VENDRYES, Le miracle de la moisson en Galles, in « Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions », Paris
1948, pp. 64-76. 5) Cfr. per Brossasco, M. PEROTTI, Natale a Brossasco, in «Cuneo Provincia Granda» XIX (1970), pp. 41-46; per Sampeyre, G. GALANTE GARRONE-M. LEONE, Cuneo, in « Geografia culturale e atlante figurativo di una regione di frontiera: il Piemonte », Ricerche di Storia dell'arte, IX (1978/79), pp. 77-84; per Bastia, A. GRISERI-G. RAINERI, San Fiorenzo di Bastia, Bastia Mondovì 1975; per San Maurizio Canavese, cfr. A. CAVALLARI MuRA T, Lungo la Stura di Lanzo, Torino 1972, pp. 96-97. L'esame delle differenti impostazioni scenografiche che i pittori hanno riservato al tema merita un pertinente commento che non mi è possibile tuttavia elaborare in questa sede.
6) Per un esemplare in decorazione di una scatoletta in avorio, proveniente dall'abbazia di Citaux, ora al Museo di Dijon, risalente al XIV secolo, cfr. L. RÉAU, Iconographie de l'art ... cit., col. 277; per uno su tessuto, nel piviale della Vergine, ora al Museo di Anagni, in opus anglicanum del XIII secolo, cfr. A. MoNTERINI, Anagni: il nuovo Museo del Tesoro del Duomo, Anagni 1975. Per uno su vetro infine, nella vetrata proveniente dal castello di Issogne, in val d'Aosta, ora esposta nel Museo di Palazzo Madama a Torino, cfr. M. BERNARDI, Capolavori d'arte in Piemonte, Torino
1961, pp. 104-105.
307
dalla presenza, nel capitolo sulla fuga in Egitto, del particolare o in Libri d'Ore: Heures di Jeanne d'Evreaux (c. 1325) ora al Metropolitan dt New York; manoscritto fr. 177 della Biblioteca Nazionale di Parigi, risalente al XV secolo, con una «De vita Christi » di Ludolfo di Sassonia. Si trova, infine, a partire dai primi anni del XVI secolo, in xilografìe di edizioni a stampa francesi (7).
Dalla distribuzione delle raffigurazioni in esame è giustificata l'ipotesi della conoscenza, da parte dei vari autori, di una specifica tradizione, non potendo più chiaramente reggere la teoria che relegava in ambito locale la genesi dei temi. Inoltre il riscontro proposto dal Male, benché pertinente, non può oggi essere accolto per la datazione troppo tarda dell'incunabolo rispetto alle prime illustrazioni.
Per quanto riguarda le sacre rappresentazioni, il primo testo teatrale a presentare la scena è «Le Geu des Trois Roys », contenuto nel noto manoscritto della biblioteca di Sainte-Geneviève (8). È opportuno ricordare, ai fini del nostro discorso, come il codice, più volte pubblicato, sia composto da testi di differente epoca di composizione. In particolare, secondo alcuni studiosi « Le Geu » è stato composto nel secondo quarto del XIV secolo, in regione vicina alla capitale.
Il seminatore compare in scena subito dopo la partenza dei Magi; nel suo ingresso sembra voler riprendere le fortunate formule utilizzate per il « Dit au villan ». Recita infatti:
« Grant temps a que je oy dire .i. proverbe a .i. grant sire,
et sy disoit, bien m'en souvient ... » (9).
Il modo dell'entrata vuole essere un'occasione per giustificare la presenza di un personaggio inatteso, per divertire e rilassare un po' il pubblico, preso dal timore tra il viaggio precipitoso dei Magi e la furia
7) Per un commento all'iconografia relativa al « Rest on the Flight to Egipt » del Memling, Patinier o del Maestro di Anversa, con un'attenzione particolare al motivo del seminatore, cfr. A. HORTON, The Child ]esus, London-New York 1975, pp. 109-112. Desidero a questo proposito ringraziare il prof. Horton per le interessanti segnalazioni che mi ha inviato, a proposito di questa ricerca, che intendo prossimamente utilizzare. Per un'illustrazione del «Riposo in Egitto» nella pinacoteca del Comune di Viterbo si veda l'omonima tela di Giovanni Francesco Romanelli (1610-1662). Una xilografia che contiene il motivo del seminatore è in }EAN DROUYN, La Vie des Trois Maries, Rouen 1511, c. XXXIX, « Comment l'Enfant, sa mere et Ioseph passerent en Egipte pour la paour de Herode qui fist occire les innocens », ora alla Biblioteca Nazionale di Parigi, Rés. y2 763. 8) Cfr. A. }UBINAL, Mystères inédits du quinzième siècle, Paris 1837, t. II, pp:
117-131. Per un intervento aggiornato e completo sulla storia, fonti e vicende del manoscritto, cfr. G. A. RuNNALLS, Le Mystère de la Passion Nostrè Seignèur du manuscrit 1131 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Genève-Paris 1974, pp. 13-92. 9) Cfr. A. }UBINAL, Mystères inédits ... cit., p. 117.
308
~
incalzante di Erode. Costui infatti, appena il seminatore ha terminato il suo monologo ed è in « semblant de labourer », interviene direttamente
per inviare i suoi sbirri alla ricerca dei tre re in fuga. Appena i soldati smettono di parlare gli si avvicinano; la didascalia
suggerisce « facent semblant de aler garder jusque le semeur ait parlé }>;
l'uomo allora riprende il proprio monologo, noncurante della loro presenza, a commento del detto « Qui non laboras non manduces }>.
Subito dopo, mentre l'ira del re si sta per riversare sui bambini minori di due anni, Giuseppe è avvertito da un angelo di fuggire in Egitto ma viene a trovarsi in difficoltà ignorando la direzione da pren-
dere per sfuggire agli inseguitori. Torna allora nuovamente in scena il seminatore che, dopo aver
indirizzato la Sacra Famiglia verso un itinerario nascosto e sicuro, tace agli sbirri il recente incontro, limitandosi ad asserire come non abbia visto
delle persone dopo il momento della semina:
« Certes, seigneurs, je vous convant c'onques puisque mon ble semay personne veu venir n'aler n'ay, ne creature petit ne grant }> (10).
Il grano infatti, per prodigio, è improvvisamente cresciuto, le spighe
sono già maturate ed il contadino deve accingersi a mietere:
«Or vueil saier mon ble errant, certainement plus n'atendray >} ( 11).
Questo particolare è facilmente osservabile negli affreschi che, solitamente, raffigurano lo straordinario sviluppo delle pianticelle, ponendo in primo piano le foglioline appena verdi e completando la scena con le
messi mature e dorate. Una prima menzione della rappresentazione pubblica della leggenda
del seminatore data al 1431 (12).
10) Cfr. ibidem, p. 131. 11) Cfr. ibidem, p. 131. 12) Cfr. L. PETIT DE Juu.EVILLE, Histoire du théatre en France. Les Mystères, Paris 1880, t. Il, p. 388-389. A proposito del seminatore, lo Julleville spiegava: <<Ce role épisodique n'eut pas été compris dans une représentation muette s'il n'avait été déjà mis à la scène et vulgarisé parmi le peuple de Paris. li [aut dane croire, ou que notre mystère est antérieur à 1431 ( ... ) ou qu' un autre texte plus ancien, et inconnu de nous, renfermait le meme personnage du <<bon homme qui semoit son
bled ».
309
In occasione infatti dell'entrata di Enrico VI, oppositore di Carlo VII, a Parigi, tra le varie azioni mimate allestite. per celebrare il momento, è registrato nella cronaca di Enguerrand de Monstrelet: « Avoit personnages sans parler de la nativité Notre Dame, de son mariage e de l'adoration des trois Rois, des Innocents, et du han hamme qui semait san hled ».
L'episodio risulta, a quanto mi consta, estraneo ai testi delle famose Passioni francesi e provenzali dei secoli XV e XVI. Doveva tuttavia essere diffuso a livello popolare ed in altra forma, in quanto lo ritroviamo nel testo della Passione di Revello (1492 ca.), sacra rappresentazione quattrocentesca di ignoto piemontese (13), benché privo di una parte.
Il seminatore compare qui durante lo svolgimento della prima giornata.
I Magi hanno già lasciato le terre degli Ebrei ed Erode ha ordinato la strage degli Innocenti. Giuseppe sta portando Maria ed il Bambino verso il vicino Egitto.
I soldati mandati dal re Erode alla ricerca dei fuggitivi « incontreno Gileto bovaro chi ara la terra». Con questi è presente «un altro qui semena di grano » ( 14).
Anche in questo caso il personaggio inizia il suo discorso con una nota comica, non riconoscendo dapptima le persone appena sopraggiunte:
«Che dyavolo vo-tu? Or my lassa gire »,
e subito dopo scusandosi e giustificando la reazione avuta:
« Perdonemy, ty prego, ch'eo questi doy boveti certo voglo domare ancoy. Non gli posso far andare a dritto, imperò, ti prego, non ahi a dispecto s'i ò risposo un poco su el brusco» (15).
La domanda del soldato, relativa all'incontro con «un puto che Ihesu figlio di Ioseph se chyama » ottiene una risposta simile a quella
13) Cfr. La Passione di Revello, sacra rappresentazione quattrocentesca di ignoto piemontese, a cura di ANNA CoRNAGLIOTTI, Torino 1976. La vicenda è narrata ai versi 3338-3361 della Prima Giornata.
14) Entrambe le espressioni sono tratte dalla didascalia che precede e spiega il modo dell'incontro.
15) Cfr. La Passione di Revello ... cit., vv. 3345-3349.
310
che abbiamo ritrovato ne « Le Geu »:
« Bruneto myo, per questa arma, poy che isto grano ò fatto seminare, ti prometto nonn ò veduto passare altro che te, per Dio verace » (16).
L'importanza che il testo della Passione di Revello riveste è dovuta proprio alla particolare libertà con cui l'autore ha elaborato l'episodio. La sua interpretazione può lasciar presupporre la conoscenza, da parte degli spettatori, del precedente incontro tra Gileto e la Famiglia in fuga, che però non compare nel testo; anche nelle battute finali del contadino non è evidente il verificarsi del prodigio, forse però attuato grazie a qual
che stratagemma di scenotecnica o attraverso raffigurazioni. Il motivo, cosl caratteristico e particolare per il modo di svolgi
mento, non sembra risalire ad una fonte individuata, ma può essere opportunamente affiancato, come è stato proposto, alla narrazione del Vangelo dello Pseudo Tommaso, in versione greca (V-VI secolo), che registra, in una serie di strani prodigi compiuti dal Bambino, anche una straordinaria e subitanea maturazione di spighe di grano appena seminato (17).
Non è stato ancora segnalato invece - e mi pare il caso - come il medesimo episodio ripreso nella versione in latino e slegato dal gruppo dei miracoli dell'infanzie, \18), venga collegato in modo più diretto alla fuga in Egitto, in quanto narrato subito dopo l'arrivo in quel paese.
Anche nel testo del Vangelo dello Pseudo Matteo (VIII secolo) (19) è inoltre possibile leggere un similare episodio, accaduto a Nazaret ed
avendo Gesù già più di sei anni. Suggerita la possibile genesi del motivo all'interno della letteratura
apocrifa, gli studiosi che si sono interessati della vicenda hanno cercato di riscontrarne la vitalità e la diffusione in epoca medioevale.
Una completa sintesi dei tentativi sino ad allora fatti è stata tentata, nel 1948, da Joseph Vendryes in uno specifico intervento all'Académie des Inscriptions di Parigi. L'autore segnalava peraltro il rinvenimento di
16) Cfr. ibidem, vv. 3356-3359. 17) Cfr. la versione greca del vangelo dello Pseudo Tommaso in C. TISCHENDORF, Evangelia Apocrypha, Lipsiae 1832, c. XII, p. 151. 18) Cfr. ibidem, per la versione latina, c. I, p. 164. 19) Cfr. ibidem, c. XXXIV, p. 104.
311
un poema gallese, in prosa, risalente alla fine del XII o all'inizio del XIII secolo, con un preciso riscontro per la leggenda (20):
« ... Il y avait un laboureur Iabourant sa terre et travaillant commc il convient; la Trinité céleste, lui et sa mère sans t:khe aux nobles dons lui dit: Brave homme ... »
Lo sviluppo dei rapporti è identico a quello già notato nei due esemplari esaminati. Il dialogo tra il seminatore e la Famiglia, o tra Io stesso ed i soldati, si snoda con un'analoga fraseologi::<. Anche l'asserzione conclusiva del discorso « Je les ai vus quand j'étais à herser ce champ de beauté (sic) que vous me voyez moissonner » si mostra del medesimo tenore.
La vicenda era, in quel medesimo periodo, anche nota sul continente. Infatti nel manoscritto fr. 1533, della Biblioteca Nazionale di Parigi, risalente al XIII secolo, ma comprendente motivi e leggende chiaramente anteriori, che riporta una « Vie Notte Dame » ricca di spunti e tradizioni originali, l'incontro tra la Famiglia in fuga ed il seminatore avviene nel solito modo:
« Notre Dame s'en est tornee qui mult estoit espovantee et vers Egypte s'en aloit et saint Joseph la cunduisoit; vers .j. predome sont venu qui semoit ble en .j. heru >> (21)
ma a quest'ultimo è dato maggiore spazio in quanto troviamo sulla sua bocca una dettagliata descrizione della strada che consiglia ai fuggitivi:
20) Cfr. ]. VENDRYES, Le miracle de la moisson en Galles ... cit., pp. 64 e sgg. (Le miracle) «il est contenu dans le Livre Noir de Carmarthen, qui est le manuscrit gallois le plus ancien. C'est un recueil composite et disparate, une sorte de cahier de brouillon ( ... ) On semblait d'accorci pour en fixer la date à la fin du XJie ou au commencement du xrrre siècle ».
L'autore, dopo averne fornita una precisa bibliografia, commenta le vicende narrate anteriormente a quella del seminatore, prive di alcun legame con essa, pur affermando l'antichità della tradizione: << La tradition en est ancienne en Galles, puisque le miracle y était déjà connu au xiiie siècle. Ce n'est pas le Iieu de discuter le texte du poème gallois, qui présente certaines difficultés ( ... ). II suffira de donner ici l'essen. tiel de la traduction, en laissant de c6té quelques mots énigmatiques ou cles chevilles sans importance >>.
21) II codice, indicato dal Roy come « Roman de l'anonciation Notre Dame» è in realtà importante testimone della diffusione, in area francese, dell'amalgama di leggende note col nome di «Vita Virginis Mariae et Salvatoris Infamia », rimaneggiamento medioevale di più fonti sacre ed apocrife. Risulta parzialmente edito nel 1879; il Roy affermava di conoscere altri esemplari della medesima tradizione, senza tuttavia darne indicazione precisa. La vicenda del seminatore è narrata tra le carte 13 r.- 14 v.
312
;o
« Vos en irez donc le chemin quant vos irez a l'aubespin le chemin tornerez a destre le sentier levez a senestre. Le chemin n'est pas mult usez ne de male gent point hantez. Puis costoierez le boscage, ne trouverez qui mal vos face aprés troverez .i. vaiscel et tres parmi cort .i. ruisel, c'est .i. des fluns de Paradis ... » (22).
Giuseppe e Maria ascoltano i consigli del contadino e riescono così a mettersi in salvo mentre, al sopraggiungere delle guardie, si ripete la scena ormai solita, con l'interrogatorio e le relative risposte.
Il seminatore rimane così colpito dal verificarsi del prodigio della maturazione delle spighe che « prist ses crespe et son bordon, si a guerpie sa viellon, sa fame et sa hergerie, et ses enfans et sa mesire », e decide di inseguire egli stesso la Famiglia per offirle i propri servizi.
La V ergine accetta di buon grado l'offerta ciel seminato re e decide di tenerlo da quel momento con sé, affidandogli un incarico che risulta
chiaramente anacronistico:
« car il li fist messe chanter et son saintisme cors sacrer tout pour l'amor a la pucele que il monde prie et apele, messe li chante chascun jor » (23).
Prima di ultimare la vicenda il testo del manoscritto riporta anche, motivandolo con gli avvenimenti appena accennati, il nome del contadi-
no: « saint Amador » (24).
22) Cfr. ibidem, c. 14 v. 23) Cfr. ibidem c. 14 v. 24) Cfr. E. ALBE, Roe- Amadour, Doeuments pour servir à l'Histoire du Pèll'~:,,age, Brive 1926, pp. 19-21 «Saint Amadour y est le héros d'une légende qu'on croirait empruntée aux Evangiles apocryphes et don t on ne connait pas l'origine». L'autorprova l'esistenza della leggenda rifacendosi alla documentazione fornita dal JV~Jc ed al testo di Geoffroi de Paris, Per altre indicazioni, cfr. M, BoURRIÈRES, Es-:;; sur l'origine de Roeamadour et la sainte Coiffe, Cahors 1888; L. DE VALON, Les Pèlerinages expiatores et ;udiciaires de la Belgique à Roe Amadour au moyen age, Marseille
313
La stessa vicenda è ancora riferita in « La Bible qui est compilée des .VII. estaz du monde » (25) di Greoffroi de Paris, nel m. fr. 1526 della Biblioteca Nazioale di Parigi, risalente esso pure al XIII secolo. Il discorso relativo al migliore itinerario di fuga è in questo caso molto semplificato rispetto al precedente. La risposta del seminatore alle guardie:
« Seingneurs - dist-il - par verité, puisque l'eure que semai se ble, ne vi passer, foi que doi m'ame per cest chemin homme ne fame ... ».
Geoffroi, prima di concludere l'episodio, dà poi modo di renderei conto del culto già allora attribuito a « saint Amador » ed al suo rapporto con l'importante santuario francese:
«le benedit saint Amadour son cors, ce set-on tout de fi, est entier, c' onques ne porri: encor le voient mainte gent a Rochemador voirement ... là où il gist, bien le set-on » (26).
Nella segnalazione dei testi che presentano la leggenda del seminatore si è data la precedenza alle compilazioni dei manoscritti fr. 1526 e 1533 sia per motivi di ordine cronologico, sia per il modo con cui entrambi presentano la vicenda. La parte dialogata pare infatti piuttosto vivace e decisamente coinvolgente l'uditorio; la possibilit~ di un suo utilizzo in rappresentazioni popolari, direttamente o come modello, era pertanto chiaramente possibile.
La leggenda è comunque presentata in testi ancora posteriori, in pro-
1935; ]. BRUN, Rocamadour historique, description, excursions, Saint Céré 1848; P. DE GORSSE, Roc-Amadour roche inspirée, un haut lieu et sa couronne, Toulouse 1955; .T. GoniN, Rocamadour, Rocamadour 1977. Sull'identificazione di «saint Amadour » sono state avanzate differenti proposte e la questione è ancora controversa. Ringrazio l'attuale rettore del santuario, canonico M. Lherm, per precise indicazioni e la collaborazione che mi ha fornito.
25) La « Bible qui est compilée des. VII. estaz du monde », attualmente ancora, a quanto mi risulta, inedita, è una complessa narrazione che unisce motivi biblici ad eventi posteriori, parafrasando in ampia misura le vicende di Cristo e della madre. La vicenda del seminatore è contenuta alle carte 46 v.-47 r. 26) Cfr. ibi.!em, c. 46 v. L'ABBÉ PÉTIN, Dictionnaire Hagiographique ou Vies des Saints et des Bienheureux in << Encydopédie Théologique » t. XLV, Paris 1851, col. 125 dopo aver ricordato come il santo <<morout en récitant la Salutation Angélique», riporta il noto proverbio «En chair et en os comme saint Amadout».
314
~
sa, che riprendono il motivo senza però saperne elaborare alcun nuovo sviluppo.
In particolare, mentre il testo della « Cronique de Jean d'Outremeuse » (27), databile al 1330-1390, riassume in breve la lezione del codice 1533, quello della «Vie de Nostre Benoit Sauver Jhesu Crist ... translatée a la requeste de tre hault et puissant prince Jehan de Berry » del 1380 (28) racconta in un breve capitolo l'intero episodio. Di questo testo esistono diverse edizioni incunabole; una è quella citata dal Male a suo tempo come antico documento della tradizione relativa al seminatore.
La stessa versione è ancora utilizzata per l'edizione de «La Vie des Trois Maries » di Jean Drouyn (29), stampata a Rouen nel 1511 ed arricchita da interessanti xilografie.
27) Cfr. ]EAN d'OUTREMEUSE (Jean des Preis), Myreur des Histors ou Chronique, in Collection des Chroniques belges inédites, a cura di BoRGNET-BORMANs, Bruxelles (1864), t .l. pp. 356-357. «Et Nostre-Damme s'en alloit tendant vers Egypte mult espawentée, et Joseph le conduisoit. Si ont tant alleit, que ilh vinrent passant deleis I proidhons qui des bleis semoit; Marie le saluat et li demandat le chemin vers Egypte, et li proidhons li dest mult douchement: « Vos en yreis toudis le chemin que vos aleis, tant que vos trovereis une arbrespine; puis tenreis le chemien à diestre, en costiant les boscaiges; apres trovereis une riweseal, qui est de fluis de Paradis terrestre. Quant vos sereis passeis celle aighe, se sereis à <egure, car muls larons n'y oise habiteir ». Cfr. inoltre A. MoLINIER, Les sources de l'histoire de France, Paris 1904, t. IV, n. 3464, p. 91; B. WoLEDGE, Bibliographie des romans et nouvelles en prose française antérieurs à 1500, Genève 1975, n. 88, p. 65. 28) Il testo, contenuto nel ms. 1699 (anc. 18) della Biblioteca di Darmstadt, riporta una versione abbreviata (56 capitoli) della traduzione delle « Meditationes Vitae Christi » dello Pseudo Bonaventura;; la versione maggiore è invece riportata dai mss. fr. 992 dalla Biblioteca Nazionale di Parigi e 28 della Biblioteca Municipale di Carpentras. In entrambe le versioni è presente il particolare dell'incontro il seminatore. La narrazione contenuta nel ms. 1699 di Darmstad venne stampata a Lione nel 1480 e risulta come l'unica nota al Male. Il capitolo del seminatore è alle cc. 43-45: « Ainsi après que Notre Dame cheminoit, ils vont trouver un laboureur qui serninoit du blé. L'enfant lhesus mist la main au sac et getta son plein poin de blé au chernin; inconlinant le blé fust si grand et si meur que s'il eult demeuré ung an à croistre, et quant les gens d'armes de Herodes qui queroient l'enfant pour occire vindrent à cellui laboureur qui cuilloyt son blé, si vont lui demander s'il avoit point veu une femme qui portoit ung enfat. « Oy-disdl, quand je semoie ce blé ». Lors les murtriers si se penserent qu'il ne savoit qu'il faisoit, car il avoit presque d'un an que cellui blé avoit été semé, si s'en retournerent ardere». Per un'edizione recente, cfr. M. MEISs-E. BEATSON, La Vie de Nostre Benoit Sauveur Jhesu Crist et la Saincte Vie de Nostre Dame translatee a la reqt;este de tres hault et puiss:mt prince Jeahn de Berry, New York 1979. Il testo dell'edizione di Lione compariva già in M. DouGHET, Dictionnaire des Legéndes ... cit., coli. 375-385. 29) Cfr. ]EAN DROUYN, La vie des Trois Maries, Rouen 1511, esemplare della Biblioteca Nazionale di Parigi, Rés. yz 763; la medesima biblioteca possiede inoltre una copia dell'edizione di Lione del 1519, Rés. Y2 764 ed altre due, Parigi Rés. yz 762 e Troyes H 19995, nun datate. Il capitolo che riporta l'episodio è il XXXIX ed ha per titolo «Comment l'Enfant, sa mere et Ioseph passerent en Egypte pour la paour de Herode qui fist occire les innocens». Il testo riporta la versione del precedente: «Et camme ilz cheminoyent, ilz trouverent ung laboureur qui semoit du ble. L'enfant Jhesus mist la main au sac et getta plain son poing de bled au chemin ... ».
315
Esistevano quindi differenti canali attraverso cui la vicenda del seminatore veniva diffusa a livello popolare, durante i secoli XV e XVI, all'interno della regione francese e nella cisalpina. Le raffigurazioni iconografiche aiutavano a fissare la memoria della storia e alcune rappresentazioni popolari diffondevano ulteriormente la fortuna del motivo, legato principalmente alla compilazione delle « Vite » di Cristo e Maria ..
A partire dalle edizioni francesi dell'inizio del Cinquecento la leggenda inizia a scomparire sia dal repertorio letterario che da quello iconografico, mentre fa il suo ingresso in quello folcloristico e dei canti popolari in quasi tutti i paesi del mondo occidentale.
È proprio a quest'ultimo che il tema deve la sua più recente sopravvivenza. La vicenda è entrata infatti nel repertorio dei canti che dovevano accompagnare dapprima le liturgie natalizie, o « Bible de nods », per passare in un secondo tempo nel canovaccio della vera e propria canzone popolare (30).
Per la regione francese e provenzale, gli interventi di D. Arbaud e V. Smith (31) ne hanno registrate alcune antiche versioni. Il modulo narrativo dei canti è al massimo semplificato rispetto allo svolgimento normale della storia e reso in forma ulteriormente popolare. Di solito è Maria a chiedere la protezione o l'aiuto del seminatore, come nel caso di queste due versioni provenzali:
« La Vi ergi s'es an ado Eme soun enfant au bras; D'eica ven brav'homme, Ven de samenar so un blad; - Ount'anatz, ma belo Damo, Qu'un tant bel enfant pourtatz? - Oh! digo, bouyer brav'homme, Lou voudries-tu counservar? » (32).
30) Cfr. V. SMITH, Chants populaires- Noels du Velay et du Forez, in «Romania», VIII (1879), pp. 410-421, « En 1585, le forézien Duverdier, parlant des noels, écrivait: «Il y en a plusieurs livres imprimés et de maintes sortes, et infinis autres qui onques ne furent imprimés et desquels les auteurs sont en grand nombre: car n'y a en France presque paroisse où l'on n'en fasse pour les chanter tous les ans aux fetes de Noel. » L'usage que constatait Duverdier n'a guère cessé que vers la fin du XVIIIe siècle. Qu'on juge de la quantité de noels que chanta chaque province de France!».
31) Cfr. D. ARBAUD, Chants populaires et historiques de la Provence, Aix 1862-64; V. SMITH, Chants populaires ... cit.; inoltre, E. MULLER, Chansons de mon village, in «Le Mémoria1 de la Loire », 23 septembre 1867; Abbé CARNEL, Noets dramatiques des Flamands de France, in « Dridon, Annales archéologiques ». Paris XVI (1856), pp. 315.
32) Cfr. D. ARBAUD, La fuito en Egypto, in « Chants populaires et ... cit. », t.l., pp. 33-36.
116
«- Digo-me, bouyer brav'homme, Tu que samenes toun blad, Fai la reg' un pau plus grande Per pousque me l'y acclapar ... » (33),
o in quello di una variante dello stesso, registrata nelle regioni del V elay
e del Forez:
« Obé, obé, bouyer, brave ome, Chi me le pouia sounva, Jésus, Jésus! Chi me le pouia sounva, Jesus, Maria!
Obé, obé, ma bravo dàmo, Bouta-lou sou moun mantela, Jésus, Jésus! Bouta-lou sou moun mantela, Jésus, Maria! » (34).
Col compimento dell'azione generosa da parte del seminatore si verifica l'istantanea maturazione del grano; all'arrivo dei soldati di Erode l'uomo può rispondere, senza timore di cadere in contraddizione, nel
modo prima richiamato:
«- Ant passat quand samenave, Quand samenave moun blad ... »
o ancora, con un sottile suggerimento
« - Se les faus judious passavoun
Digo li la verita. N'en fogueut pas un quart d'houro Les faus judious ant passat: - N'as pas vist passar Mario Eme soun enfant au bras? - Quand Mario n'en passavo Samenav'encar' moun blad » (35)
33) Cfr. D. ARBAUD, La fuito en Egypto; in << Chants populaires et ... cit. », t. XII, pp.
235-240. 34) Cfr. V. SMITH, Le Noel des Laboureurs in «Chants populaires -Noels du Velay ...
cit »., pp. 420-421. 35) Cfr. D. ARBAUD, La fuito en Egypto, in << Chants populaires et cit. », t. I p. 36 e
t. II p. 237.
317
mentre nella tradizione dei Noels (36) la risposta del contadino riprende la spiegazione della precedente:
« Deguien le temps que ne passavo, Iéu sèmenavou moun bla, Jésus, Jésus! Adinro in flouri, amain grana - Jésus, Maria! (37).
Nell'originale ballata inglese « The Carnai and the Crane » (38), pubblicata da ].F. Child, è lo stesso Bambino a rivolgersi al seminatore mentre si compie il prodigio della maturazione:
« God speed thee, man, - said Jesus, -«Go fetch thy ox and wain, And carry home thy corn again Which thou this day hast sown ».
La risposta dell'uomo è in questo caso collegata, com'è ovvio peraltro, alla presenza di Gesù:
« Why, the truth it must be spoke, And the truth it must be known; Por }esus passed by this way · When my sees was sown » (39).
Esistono numerose altre canzoni relative all'incontro tra la famiglia in fuga ed il seminatore, già segnalate per le regioni catalana, fiamminga, olandese e tedesca, che non è tuttavia possibile esaminare in dettaglio in questa sede ( 40). L'episodio in questione doveva riscuotere notevole successo, a giudicare dalla frequenza con cui è possibile riscontrarne la presenza nelle raccolte di canzoni che vanno dal XVI al nostro secolo. La semplicità della vicenda, la genuinità del personaggio, la soddisfazione
36) Cfr. D. ARBAUD, La /uito en Egypto, in « Chants populaires et... cit »., t. II, p. 236. 37) Cfr. V. SMITH, Le Noel des Laboureurs, in « Chants populaires - Noels du Velay ... cit. », p. 420.
38) Cfr. ]. F. CHILO, The Carnal and the Crane, in « The English and Scottish PopuIard Ballads », Boston 1857, (ora New York 1965), t. II, pp. 7-10, con richiami a p. 509-510.
40) Cfr. M. MrLÀ Y FoNTANALS, Herodes, in « Romancerillo catalan », Barcelona 1882, n. 10. pp. 6-9; A. LooTENs-T. M. E, FEYS, De Vlucht naar Egypten, in << Chants populaires flamands », Bruges 1879, pp. 32-34, n. 20; E. HoFFMANN FALLERSLEBEN, Horae Belgicae 1836, pars X, in « Niederliindische Geistliche Lieder des XV Jahrhunderts », pp. 22-23, n. 4.
318
per la positiva conclusione dell'episodio, erano indispensabili ingredienti
per la confezione del motivo. I compilatori dei testi delle canzoni riuscirono a volte però a sle-
garsi dal filone divenuto tradizionale, per apportare ancora nuove varianti, aprendo la partecipazione alla storia anche a piante od animali. Il comportamento di queste ultime a protezione o denuncia dei fuggitivi venne assunto come sintomatico dei tipi ed indicato come motivante determinate
caratteristiche delle specie. In alcune canzoni catalane ( 41) sono una pernice ed una pianta di
menta a scoprire dove si sia nascosta la Vergine per sfuggire ai soldati di Erode e per questa indiscrezione vennero condannate la prima « malehit sera 'l teu cap ... » a non avere la testa mangiata, e la seconda « que n'ets menta y mentiras », a non portare alcun seme. Anche in area provenzale si ritrovano le medesime credenze; in particolare, mentre viene riconfermato il giudizio sulla pernice « Maudich sie toun bavardage. Ta testo lou pagara » (42), e similmente avviene per la menta che, in questo caso, ha addirittura lasciato cadere le sue foglie per far scoprire i fuggitivi, per cui «La mento flouris mai noun grano. La Viergi en acot la coundamno »; alla salvia invece che «De dous pans s'es aloungat » per coprire meglio Giuseppe e Maria, sono riservati particolari priviìegi ricordati pe-
raltro dal proverbio:
«Qui ves de sauvi noun n'en prend De la Viergi noun se souven » ( 4 3).
In altre versioni, a svolgere il ruolo di elemento mimetizzatore dei fuggiaschi sono le piante del prezzemolo o del ginestra, mentre a denunciare la presenza della Faniglia e contemporaneamente la falsità della risposta del seminatore è, cun notevole frequenza, uno scorpione nascosto tra le pietre del sentiero percorso dai fuggitivi; per questo misfatto « il est décidé.que ceux qui l'écraseront avec le pouce de la main droite seront considérés r"mme des bienfaiteurs de l'humanité et que les sept péchés
capitaux leur seront remis » ( 44).
-------41) Cfr. M. MILÀ Y FoNTANALS, Romancerillo catalan ... cit., p. 131. 42) Cfr. D. ARBAUD, Chants populaires et ... cit., t. II, p. 245. 43) Cfr. ibidem, p. 246-247; J. LEITE DE VAscoNCELLOS, Tradiçoes populares de Por-
tugal, Porto 1882, pp. 105-106. 44) Cfr. E. RoLLAND, Les reptiles, les poissons, les mollusques, les crustac'és et les insectes, noms vulgaires, dictons, proverbes, légendes, contes et superstitions in «Faune populaire de la France», Paris 1881, t. III, p. 325; E. AnAMS, On the names of Ants, Earwigs and Beetles, in « Transactions of the London Philological Society , . 1959,
p. 94.
319
Così, modificato per la presenza di caratteristiche e nuove varianti, all'interno di un canone di trasmissione estremamente popolare e vario, ma ancora strutturato intorno all'originario nucleo centrale, il motivo è giunto sino a noi.
Alcune delle questioni legate al suo sviluppo, alla sua presenza nelle raffigurazioni iconografiche di Francia e Piemonte, alla sua comparsa nelle rappresentazioni teatrali del XV secolo, alla sua fortuna nel genere del canto popolare e folclorico, ci sembrano chiaramente impostate anche se non ancora totalmente risolte.
Sul collegamento tra questo ed altri similari motivi che l'epoca medioevale ha mediato da fonti precedenti per rielaborarli secondo specifici interessi, contiamo di tornare presto e con nuovi interventi.
Per quanto riguarda l'attuale riteniamo di averne proposta una soddisfacente ipotesi di lettura ed indicato i differenti campi di indagine in cui è necessario muoversi per una sua almeno discreta comprensione.
Desidero ringraziare sentitamente, per la preziosa collaborazione nella ricerca e nella riproduzione del materiale iconografico inerente alla leggenda oggetto della nota, Miss Vera Kaden del Victoria and Albert Museum di Londra, Miss Maureen Pemberton della Bodleian Library di Oxford, il prof. E. Sauvageot di Montbard (France), padre G. Guido di Anagni, l'amico prof. G. Raineri di Mondovì.
320
FIG. l : Rougemont, N arre Dame, portale, Xlii sec .
...:
FIG. 2: Rougemont, Norre Dame, portale, Xl11 sec.
321
w N 0\
FIG. 7: Victoria and Albert Museum London, ms. Salting 1222, miniatura, XV sec. FIG. 8: University Library Cambridge,
ms. Horae 351, miniatura, XV sec.
,, ' l
•;
!
FIG. 10: Bastia tiondovi, S. Fiorenzo, affresco, 1472
FIG. 9: Sampeyre, parrocchiale,
, affresco, 1460 ca.
327