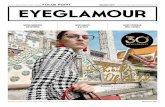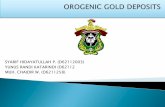MINERALIZZAZIONI AURIFERE E SILICIZZAZIONI (LISTWAENITI) NEL GRUPPO DI VOLTRI (Gold...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of MINERALIZZAZIONI AURIFERE E SILICIZZAZIONI (LISTWAENITI) NEL GRUPPO DI VOLTRI (Gold...
Giuseppe PipinoMuseo Storico dell’oro Italiano
MINERALIZZAZIONI AURIFERE E SILICIZZAZIONI(LISTWAENITI) NEL GRUPPO DI VOLTRI
Abstract The “Voltri Group” is the largest meta-ophiolites and calcschists complex in the westernItalian Alps. The units suffered intense Alpine metamorphism wich often make it difficult torecognize the original rocks. The principal lithotypes are: serpentinized ultramafics,metagabbros, metabasites (prasinites, glaucophane schists, amphibolites), paraschistsand shales (calcschists, calc-micaschists, quarzites, quartzschists), limestone anddolostone. Acid crystalline schist are exposed along the western margin, and smallsections of a transgressive sedimentary cover are locally present.
The complex was interested by many tectonic events, from sub-horizontals thrusting toshear zones with relevant longitudinal and vertical displacements, to tension faulting andfracturing. The main vertical displacement, can be grouped in two groups; the mostimportant, aged from Lower to Middle Oligocene, varies from NNE-SSW to ENE-WSW;locally it is interrupted ad displace, by more recent, less developed, E-W faults andfractures.
The presence of ore deposits is know from very ancient times; the outcroppingmineralization and its surface enrichment in Fe, Cu, Au were artisanny exploited. Themineralization structurally and paragenetically differ according the host rocks.
In the ultramafic there are: a) disseminated magnetite, sulphides and native gold; b)massive Cu-pyrrotite and magnetit, with amount of pyrite, chalcopyrite and local valleriite;c) stockwork deposits of quatz and carbonates with gold and sulphides, forminghydrothermalites (listwaenites) lenses.
Gabbros and metagabbros only contain poor disseminated pyrite-chalcopyrite andstock-work type deposits of zeolites. Amphibolic eclogites and amphibolites, probablyderived from Fe-gabbroic rocks, are more interesting: the former are rich in rutile andminor ilmenite, for a content of 2-12% TiO2; the latter can have some disseminated andmassive bodies of magnetite. Some kind of amphibolites are rich in apatite, to thetectonic contact with serpentinites.
The boudinate lenses of granatite, a kind of Alpine-type metamorphosed rodingite, alsoderive from gabbro levels or dykes content in ultramafics: they have local enrichment inmetallic minerals and show very beatiful and required crystals in lithoclases, expeciallygrossular-andradid garnets.
Prasinites, likely derived from basalts, contain metamorphic concordant pyrite-chalcopyrite bands, with local enrichment in Co, Ag and other, at the tectonic contact withmatagabbros or serpentinites.
Quartz-shistes, derived from cherts, show very low content of Mn oxides.
The ores, in Voltri Group, cannot be very extended, because the tectonic events, but these,and the consequent hydrothermal activities, had fundamental importance for the genesisof shear zones mineralized listwaenites, locally know, from ancient times, as“idrotermaliti”, that constitute the sources of the residual and alluvial gold in the area and in the far valley of the Orba river.
IL GRUPPO DI VOLTRIBenché sia geograficamente inserito nell’Appennino Ligure, dal
punto di vista geologico il Gruppo di Voltri fa parte delle Alpi(occidentali) e tipicamente alpine (e piemontesi) sonol’associazione litologica e i lineamenti tettonici che lointeressano: esso è, anzi, il maggior complesso unitario alpino dicalcescisti e scisti verdi (PIPINO 1975, 1976). Si estende su unavasta area che occupa la quasi totalità del Foglio Genova (82° dellaCarta Geologica d’Italia) e il margine orientale del Foglio Ceva (81°ibid.); è compreso in gran parte nelle province di Genova eSavona, salvo una striscia settentrionale (Ovadese e Acquese),compresa nella Provincia di Alessandria (dal 1859).
Secondo gli autori, esso è costituito da unità tettonichesovrapposte per estesi fenomeni di sovrascorrimento (CHIESA et AL.1975). I contatti visibili tra i diversi tipi di rocce sono perògeneralmente subverticali, e le dislocazioni orizzontali sonoosservabili soltanto nelle unità più superficiali e menometamorfosate, in particolare nell’unità ultramafica “Erro-Tobbio”, considerata parte di mantello subcontinentale sovrascorsosul margine continentale e costituita da lherzoliti tettonitichepassanti a serpentiniti a relitti (pirossenici), con livelli dipirosseniti e harzburgiti, bande di duniti, inclusioni dimetagabbri e filoni rodingitici.
Le masse lherzolitiche, che possono raggiungere la potenza dialcune centinaia di metri, presentano una struttura a bande bensviluppata, e un generale clivaggio sub-orizzontale in grossibanchi; strutture riferibili a grosse traslazioni orizzontali sonoparticolarmente evidenti nella sua parte inferiore, ove sisviluppano potenti livelli milonitici, localmente ricementati davene silicee, prevalentemente calcedoniose. Le dislocazioniverticali sono numerose e possono essere raggruppate in diversisistemi: il più importante assume direzione variabile da NNW-SSE aNNE-SSW, e mette spesso in contatto le ultramafiti con rocce
diverse; fratture e faglie distensive successive, meno sviluppate,assumono generalmente direzione variabile da ENE-WSW a E-W einteressano, localmente, anche i sedimenti oligo-miocenici chericoprono l’unità.
La serpentinizzazione, nelle lherzoliti, raggiunge soltanto unprimo stadio, a lizardite e magnetite, ma in corrispondenza dellezone tettonizzate è più accentuata, con sviluppo di antigorite ecrisotilo.
Al di sotto delle masse lherzolitiche sovrascorse si trovanoserpentiniti, calcescisti e associazioni di rocce ofioliticheinteressate da metamorfismo in facies scisti verdi e da marcatascistosità: può trattarsi di serpentiniti antigoritiche conmetagabbri eclogitici e prasiniti più o meno anfiboliche, o dirocce calcescistose con calcari dolomitici, quarziti,quarzoscisti, prasiniti anfiboliche e scisti glaucofanici: la piùestesa associazione di calcescisti con scisti verdi affioraestesamente in direzione N-S, da Rossiglione a Voltri, e dividein due l’intero Gruppo. Tutti i litotipi mostrano una scistositàmolto evidente, differenti stadi di deformazione meccanica,stiramenti, intricati melanges e diffuse trasformazionimineralogiche che rendono spesso difficile riconoscerel’originaria natura delle rocce: è possibile comunque, in lineagenerale, rapportarle alle sequenze vulcano-sedimentarieofiolitiche poco metamorfosate della Liguria orientale e dellaconfinante “Zona Sestri-Voltaggio”, questa separata dal Gruppo daun fascio di faglie e fratture con direzione N-S.
Localmente, sono presenti lembi isolati di calcari dolomitici,fratturati e leggermente scistosi, considerati parte residua diuna estesa “Falda di Montenotte”, di provenienza appenninica,sovrascorsa sul Gruppo.
Lungo il margine occidentale di questo sono presenti due lembidi scisti cristallini (Arenzano, Valosio), considerati parte di unmargine continentale sovrascorso da litosfera oceanica e mantellosubcontinentale: l’intero gruppo è poi delimitato, a ovest, dafasci di dislocazioni tettoniche, dirette grosso modo N-S, che lomettono in contatto con il “Massiccio Cristallino di Savona” e conla sua copertura sedimentaria di età carbonifero-triassica.
Carta geologica schematica del Gruppo di Voltri e della Zona Sestri-Voltaggio con ubicazione delle principalimineralizzazioni (da PIPINO 1986)
Secondo le più recenti teorie, il Gruppo si sarebbe formato aseguito della collisione, a partire da Cretaceo superiore, di duemargini continentali, con conseguente subduzione di parte dellacrosta oceanica e risalita di materiali oceanici, di piattaforma econtinentali, spinti poi, in tempi cretacico-eocenici, indirezione nord e nord-est a costituire le Alpi occidentali:successivi movimenti distensivi avrebbero dato origine al sistemadi faglie verticali responsabili dell’assetto caotico checaratterizza il Gruppo (PIPINO 1975). Nel contempo, questo subivala trasgressione marina oligocenica, con formazione di potentibancate di conglomerati marini (“Formazione di Molare”), a cuiseguiva la deposizione di formazioni arenacee, marnose ecalcaree, di età Mio-Pliocene, il tutto a costituire il “BacinoTerziario Piemontese”.
LITOTIPI E MINERALIZZAZIONI CONTENUTE
Le ofioliti del Gruppo di Voltri contengono, come quelle dellaLiguria orientale, mineralizzazioni varie che assumonocaratteristiche paragenetiche e strutturali diverse a seconda deilitotipi ospitanti, ma la marcata trasformazione metamorfica diquelli costituenti il Gruppo si traduce in un più ampio ediversificato quadro metallogenico (PIPINO 1978, 1986).
Ultramafiti
Le ultramafiti poco serpentinizzate (lherzoliti e serpentinitia relitti) sono rocce massive e compatte, seppure moltofratturate, di colore nero o verde scuro alla frattura fresca, dagrigio a rossastro sulle superfici di alterazione: la stessaalterazione ne mette in evidenza la struttura tettonitica,evidenziata da sottili bande di pirosseni iso-orientati, e faassumere alla roccia un effetto estetico, e ricercato, a “pelle dielefante”. Le parti meno alterate (o serpentinizzate) sonocomposte prevalentemente da olivina (50-60%) e pirosseni di tipoenstatite e diopside-diallagio (20%), più o meno sostituiti daserpentino (15-20%) prevalentemente di tipo lizardite, conspinello più o meno cromifero, anfibolo orneblenda, scarsoplagioclasio più o meno saussuritizzato e diffusa presenza diminerali metallici. Questi sono rappresentati da disseminazionipovere di cromite, magnetite, pirrotite e pentlandite, cui possonolocalmente associarsi pirite, calcopirite e oro. Notevole è ladiffusione di quest’ultimo: sempre presente in significativeanomalie geochimiche (5 ppb), poco più alte della media di rocceanaloghe, in alcuni campioni di lherzoliti raggiunge 1,8 ppm, finoa 2 ppm in livelli di dunite. Questa, composta quasi
esclusivamente da olivina, è piuttosto frequente in alcune zone,in bande lenticolari più o meno spesse ed estese, ed è evidenziatadal colore più chiaro, verdolino o grigiastro, che contrasta conil colore scuro della massa ospitante: molto spesso è interessatada reticolati di fratture cementate da serpentino di colore verdeche le conferiscono il tipico aspetto a ranocchiaia.
Il contenuto d’oro può superare 100 ppm in bande milonitichedi frizione interessate da alterazione talco-carbonatica,accompagnate talora da grafite, che interessano livellisuperficiali e molto alterati di ultramafiti con bande dunitiche:l’oro si presenta in piccoli granelli o sottili scaglie, taloravisibili a occhio nudo e facilmente separabili dalla rocciasfatticcia che lo contiene. Ne sono stati riconosciuti, esfruttati, assieme ai suoli derivati, nella zona del Bric Paganella, anord del bacino artificiale dei Laghi di Lavagnina (e delleminiere d’oro del Gorzente), e al Monte Calvo di Tiglieto, confinantecol territorio comunale di Rossiglione. Secondo (ROVERETO 1939),nel torrente sottostante M. Calvo di Rossiglione (Gargassino?)sarerebbe stato trovato “un grano di platino”, ed è questa l’unicasegnalazione del metallo in tutto il Gruppo di Voltri.
Locali arricchimenti possono dar luogo a concentrazionimassive di magnetite e pirrotite, in bande o lenti concordanticon l’orientamento tessiturale della roccia incassante: puressendo poco estese, in qualche caso esse sono state oggetto diantiche attività estrattive, specie per quanto riguarda i prodottilimonitici di alterazione, nei pressi di Sassello, Voltri,Multedo: nei primi anni del Novecento fu coltivata, a Rocca di Premalòpresso Pontinvrea, una massa contenente circa il 20% di magnetiteed interessata da discreti arricchimenti in limonite e in ocreferruginose.
La magnetite detritica, proveniente da queste e altre roccedel Gruppo, da’ luogo ad arricchimenti alluvionali che, in qualchecaso, sono stati oggetto di ricerche e limitate coltivazioni: nelperiodo autarchico precedente la seconda guerra mondiale sonostate fatte ricerche, da parte della Breda, in tutto il litoraletirrenico; la ditta Perino, invece, separava magnetite e ilmenite,oltre che oro, dalle sabbie dell’Orba prodotte nell’impianto diPortanova di Casalcermelli e, nel contempo, impiantava una grossagriglia attraverso il torrente, appena a monte di Molare, perrecuperare gli stessi minerali
Nelle ultramafiti poco serpentinizzate sono anche note, elocalmente coltivate, limitate vene a solfuri massivi,prevalentemente cupriferi, in assenza o con scarsissimo quarzo. Al
passo di Piancastagna, verso Abbassi, è da tempo segnalata lapresenza di vene compatte di malachite entro serpentinitifratturate (CHABROL de VOLVIC 1824): ricerche recenti, effettuatedalla Falcon Bridge, vi hanno riconosciuto impregnazioni dicarbonati di rame in brecce milonitiche, composte da serpentinitecon scarsa clorite, magnetite e tracce d’oro (55 ppb), ma non nehanno individuato la fonte. Ad Arenzano, nell’alto versantedestro del Rio Luvea, si tratta di sottili e discontinue bande dipirrotite cuprifera, ematite, calcopirite e pirite, con tenoripercentuali di rame, elevati contenuti di cromo (fino a 4000 ppm)e tracce d’oro (fino a 1 ppm): la ganga è costituita da frammentimilonitici della roccia ospitante, rappresentata da unaserpentinite massiccia a relitti pirossenici, molto fratturata,con evidenti presenze di malachite. Dello stesso tipo dovevaessere la “miniera di rame” oggetto di coltivazione ai primi delSeicento alle origini del torrente Lerone, sul versante destro, inzona dove dominano i significativi toponimi M. Argentea e RoccaTurchina. Nella foresta demaniale Deiva, a sud ovest di Sassello,nelle fratture delle rocce ultramafiche che compongono le cime daibricchi Salmaceto, della Rama e delle Rocche Turchine, s’ insedianominerali secondari di rame che hanno dato il nome agli ultimi due;una mineralizzazione primaria si trova alle origini del Rio delleVerne, dove la roccia contiene visibili inclusi di dunite ed è pocopiù serpentinizzata, a causa dell’intensa laminazione, e in questasi insediano talco e minerali secondari di rame: lamineralizzazione primaria è costituita da noduli e lenti pocoestese di ossidi e solfuri massivi; uno studio minerografico haportato al riconoscimento di picotite, spinello cromifero,magnetite, ematite, ilmenite, pirrotite, calcopirite, pirite ebornite come minerali primari, covellite e digenite come secondari(ROLANDI 1974). In campioni da me raccolti è stata poiriconosciuta la presenza di tracce d’oro (fino a 50 ppb) incampioni ricchi di rame (37.600 ppm) e di cromo (2300 ppm). Lamineralizzazione è stata oggetto di prolungate ricerche e limitatecoltivazioni nell’Ottocento e per buona parte del Novecento,assieme ad altre presenti nel versante orientale, che si trovano,però, all’interno di rocce serpentinitiche sottostanti la massaultramafica poco serpentinizzata, visibilmente sovrascorsa indirezione nord o nord-ovest.
Lungo i piani di fratturazione delle ultramafiti pocoserpentinizzate, del Gruppo, sono spesso presenti, assieme alivelli milonitici di breccia serpentinitica, talora fibrosa, veneirregolari di calcite: in alcune zone, nelle parti piùmilonitizzate, è possibile la presenza di limitati reticolati divene di magnesite e di brucite. Raramente sono anche presenti
livelli sottili e poco sviluppati di serpentino nobile, di un belcolore verde pallido.
Quando non è presente un chiaro orizzonte di sovrascorrimento,è difficile riconoscere, sul terreno, il passaggio delle masselherzolitiche alle sottostanti serpentiniti. Queste, che sono lerocce maggiormente rappresentate nel Gruppo di Voltri, possonoavere tessitura più o meno massiccia e scistosità da appenaevidente a molto accentuata (serpentinoscisti): frequenti sono lemicropieghe di tipo king bands. Sono composte da serpentino (70-95%) prevalentemente, antigorite e crisotilo, in fibre allungatesecondo la scistosità, con relitti pirossenici molto alterati ecloritizzati, carbonati ferriferi e ossidi di ferro. La magnetiteè particolarmente abbondante (5-10%), disseminata o in localiconcentrazioni lentiformi e talora accompagnata da ematite. Sonoanche presenti sporadici solfuri di ferro e di nichel in individuidispersi.
Lungo le fratture si formano spesso sottili livelli diamianto, di tipo crisotilo ma anche bissolite, spesso associati atalco: in alcuni casi, nelle zone più tettonizzate, l’amiantoassume discreta abbondanza e ha dato luogo a limitatecoltivazioni, come a Rocca Zucchetta presso Rossiglione, alle faldeorientali del Bric Rocche Turchine presso Sassello, a Costa della Rondaninanell’alta valle Varenna e nei pressi di Pero e Alpicella sopraVarazze.
È anche nota, nelle serpentiniti, la presenza dimineralizzazioni cuprifere oggetto di antiche coltivazioni, oggidifficilmente verificabili a causa dell’intensa vegetazione cheattecchisce sulla roccia sfatticcia incassante e su eventualidiscariche prodotte dai lavori. A Sassello, lungo il Rio Bonuzzo chescende dalle falde orientali del Bric della Rama, si vedono ancoraimbocchi di gallerie, oggi inaccessibili: la mineralizzazionesarebbe costituita da filoni milonitici, con salbande talcose easbestose, contenenti noduli di calcopirite, bornite, azzurrite ealtri minerali secondari di rame; una mineralizzazione analoga, indiscrete masse, fu coltivata alle faldi orientali del Bric delleRocche Turchine, in prossimità della cava di amianto. Da notareche tra le due manifestazioni si insedia una fascia interessatada silicizzazione.
Nei pressi di Pontinvrea, nei ritani Bertona e CastelDelfino, sono segnalate due antiche “miniere” di pirite e marcasite nel serpentino. Presso la cascinaCosta, sopra Multedo, si parla, a metà dell’Ottocento, di “5 miniere dirame e una di ferro”, con contenuto di rame fino al 50%: secondo
l’ingegnere delle miniere si trattava di minerale cuprifero sparsoirregolarmente nella “serpentina”, assieme a molta magnetite.
Metagabbri e rocce derivate
I metagabbri sono presenti, nel Gruppo di Voltri, in ammassilenticolari e tabulari più o meno estesi e tettonizzati, inclusinelle ultramafiti con superfici nette. Il litotipo piùsignificativo è costituito da roccia massiccia a grana grossolana,di colore chiaro passante a scuro per locali concentrazioni dianfibolo. La paragenesi è molto variabile, a secondadell’intensità metamorfica e della disposizione in bande deisingoli componenti: i minerali principali sono plagioclasio ditipo albite, generalmente saussurizzato, pirosseno di tipodiopside-diallagio, olivina e anfibolo actinolite, con presenza dicromite e altri minerali metallici: minerali accessori sonotitanite, epidoto, granato e actinolite. Spesso l’actinolite,formatosi a spese del diallagio, si presenta nella varietà dicolore verde smeraldo, in vistose plaghe che danno un gradevoleaspetto estetico alla roccia risultante (gabbro a smaragdite). Agrana più fine, e maggiormente metamorfosato, è il più diffusometagabbro noto in letteratura col nome di “Prasinite di Monte Colma”,caratterizzato dall’evidenziazione, sulle superfici dialterazione, di granuli pluri-millimetrici di albite bianca chespiccano sulla massa verdolina di fondo.
I metagabbri contengono sempre disseminazioni povere di piritee calcopirite, talora in cristalli ben formati: alcuni depositisono stati oggetto di ricerca per rame (Ponzone, Morbello Valle) oper i solfati prodotti dall’alterazione della pirite (Grognardo).In quest’ultima località, appena a monte del ponte sul Visone, ilmetagabbro, molto brecciato, è ricementato da vene silicee ed èricoperto da spalmature di cristallini di quarzo di coloremielato. In alcuni corpi tettonizzati e alterati, presso ilcontatto con rocce ultramafiche, sono presenti mineralizzazionizeolitiche, costituite da reticolati di vene a prehnite,tobermorite, cabasite, etc.: ne sono segnalati, in particolare, alPian del Foco presso Olbicella e al Bric dei Ladri presso Capanne diMarcarolo (CORTESOGNO et AL, 1976 e 1976). In alcuni casi, comein Val Gorzente, possono essere interessati dalle manifestazioniidrotermali aurifere, con conseguenti alterazioni a zoisite,clinozoisite e clorite saussuritizzata.
Le rocce eclogitiche, derivate da Fe-gabbri, sono molto piùinteressanti. Costituiscono lenti e corpi inclusi neiserpentinoscisti e, talora, filoni incassati nei metagabbri. Laparagenesi consiste in omphacite-cloromelanite, granato, rutilo e
apatite, con numerosi altri minerali accessori, quali quarzo,glaucofane, orneblenda-actinolite, clorite, albite, mica bianca,epidoto, titanite, anatasio, talco, ossidi (ilmenite, magnetite) esolfuri metallici (pirite, calcopirite, pirrotite). Il contenutodi rutilo, sempre molto elevato (dal 2 al 10%), e quello diilmenite (fino al 2%), ne fanno potenziali giacimenti di titanioe, in effetti, sono stati oggetto di concessione mineraria nellazona del M. Beigua. La concessione fu accordata con troppaleggerezza, per quanto riguarda il possibile utilizzo economico:l’estrema durezza della roccia, l’alto potere abrasivo causatodall’abbondanza dei granati (25-30%) e l’estrema finezza delminerale utile rendono eccessivamente costosi i processi dinecessaria polverizzazione (a 200-300 mesh), a cui seguonodifficoltà di arricchimento; come se non bastasse, l’altocontenuto di CaO (8-10%) comporta altri problemi, di ordinechimico. È per questa ragione che la concessione non ha avutoseguito, a parte speculazioni borsistiche all’estero: i problemiambientali e le proteste di associazioni locali non hanno influitomolto, se non per fornire alibi, e probabili vantaggi, aiconcessionari.
Pure le anfiboliti, almeno buona parte di esse, sembranoderivare da Fe-gabbri e, spesso, è possibile osservare passaggitransizionali ad eclogiti. Le rocce che ci interessano sonocomposte da orneblenda, omphacite, apatite, magnetite e pirite.La magnetite è sempre piuttosto abbondante, anche in cristalliottaedrici disseminati, o in corpi massivi che possono assumeremodesta importanza, specie al contatto tettonico con serpentiniti,ma si tratta sempre di corpi di modesta estensione.
Le granatiti sono rocce ricche di granato incluse neiserpentinoscisti sotto forma di piccole lenti foderate da unabuccia cloridrica e, spesso, si presentano in allungamenti che siestendono per centinaia di metri e testimoniano fenomeni diboudinage subiti da originari livelli o filoni di rocce gabbricheo rodingitiche. Sono costituite da granato di tipo grossularia-andradite, a cui si associano epidoto-clinozoisite, diopside,clorite e minerali metallici, con, incidentalmente, vesuviana,titanite, apatite, calcite, prehnite, rutilo, perowskite: inalcune lenti il minerale prevalente può essere vesuviana oepidoto, a costituire litotipi indicati, nella vecchialetteratura, come vesuvianiti o epidotiti. Attualmente c’è latendenza a comprenderle tutte nelle rodingiti, di analogacomposizione chimica, trascurando la fondamentale differenza digrado metamorfico e l’assenza, in queste, delle litoclasicristallizzate (PIPINO 1981).
Le granatiti (rodingiti metamorfiche ?) sono, infatti,caratterizzate da cristallizzazioni di litoclase, prevalentementedi granato o, nei casi citati, di vesuviana o di epidoto, ai qualisi possono associare numerose altre specie mineralogiche bencristallizzate, quali clorite, titanite, apatite, perowskite,prenhite, rutilo, ecc.: sono ricercate da studiosi ecollezionisti, tanto che sono state oggetto di ricerca e dilimitate estrazioni minerarie (Passo del Faiallo, sopra Vara). Nellaroccia sono anche presenti ossidi e solfuri metalliferi: alcuneanalisi hanno rilevato discreti contenuti di piombo (1000-2000ppm), zinco (500-1000 ppm), nichel (100-200 ppm), rame (10-100ppm) e argento (5-10 ppm), oltre a discrete tracce d’oro (100-300ppb): in alcuni casi è stata anche osservata la presenza digranuli d’oro visibili a occhio nudo (PIPINO 1981, 1985).
Metabasiti (prasiniti scistose e anfiboliti)
Oltre alle cosiddette “Prasiniti del Monte Colma”, diprobabile origine gabbrica, se ne trova, nel Gruppo di Voltri, unaltro tipo, di probabile origine basaltica, indicato come“Prasiniti di Campo Ligure” nella vecchia letteratura. Sipresenta in livelli lenticolari di colore scuro, sempre abbastanzacontorti, inclusi o associati intimamente con i calcescisi. Lagrana è molto minuta, fino a milonitica, e la scistosità, semprepiuttosto marcata, è evidenziata da un marcato bandingcomposizionale, per prevalenza di alcuni minerali in bandediverse. La paragenesi è costituita da plagioclasio di tipoalbitico e anfibolo calcico, con epidoto clinozoisite, clorite,granato, titanite e minerali metallici.
Contengono spesso limitate concentrazioni di pirite ecalcopirite, cui si associano altri solfuri e ossidi. Lemanifestazioni più estese affiorano nell’alveo del torrente Orba,nelle località Ortiglieto e Marciazza, circa due chilometri di distanzal’una dall’altra (PIPINO 1985). Sono contenute, in concordanza,all’interno di metabasiti (prasiniti) presso il contatto tettonicocon metagabbri (Ortiglieto) o con serpentiniti (Marciazza), esembrano essere parte di uno stesso orizzonte. Sono costituite dadisseminazioni e locali concentrazioni massive di ossidi e solfuriassociati a livelli di scisti glaucofanici che fanno da matricealla mineralizzazione: i corpi massivi sono prevalentementecomposti da pirite granulare (fino all’80-90%), e sono taloratagliati da vene di calcopirite; ai due minerali si associanotracce di marcasite, magnetite, pirrotite, bornite, blendamackinawite, molibdenite, neodigenite, covellite, braunite,rutilo, ilmenite e linneite: Le analisi chimiche hanno rilevato,
oltre a discrete percentuali di rame e di zinco, elevati contenutidi cobalto (40-370 ppm) e consistenti tracce di argento (5-60ppm), arsenico (1-20 ppm), antimonio (1-10 ppm) e oro (fino a 0,2ppm).
Manifestazioni analoghe, ma più limitate, affiorano nell’alveodel Gorzente, presso la centrale elettrica (loc. Cravaria), nell’alveodel Piota sotto C. Testanera, nella valle dell’Erro di fronteall’abitato di Foi e nell’alta valle del Rio Berlino. Inquest’ultima località le prasiniti, in contatto con i calcescisti,sono molto alterate e le lenti mineralizzate quasi completamentetrasformate in ematite e limonite. Altra mineralizzazione di“pirite cuprifera” è stata oggetto di ricerche e di limitataestrazione, dal 1936 al 1941, in località Bricchetto, appena anord di Campo Ligure, sulla destra orografica del T. Stura; vifurono estratte 80 tonnellate di minerale, prima che una franaseppellisse completamente lo scavo: poco a nord dellamineralizzazione, alle falde meridionali del Bric Valcalda, sitrova un Bricco dell’Oro. Nelle località “Le Faie”, “S. Martino di Teglia” e“Casanova”, nel territorio di Varazze, sono stati oggetto diricerca corpi limonitici superficiali in corrispondenza dicomplicati contatti tra prasiniti anfiboliche e calcescisti conlivelli di quarziti e quarzoscisti, tanto che è impossibileattribuire la mineralizzazione ad uno specifico litotipo.
Le anfiboliti più coinvolte in strutture tettonizzate, oltreche in ossidi e solfuri si arricchiscono di clorite, di talco e diapatite. Nelle località “Pero”, “Alpicella” e “S. Pietro di Casanova”, interritorio di Varazze, sono state a più riprese eseguite ricercheper talco in corrispondenza dei contatti, molto tettonizzati, traprasiniti anfiboliche e calcescisti con quarziti e quarzoscisti.In un caso, alla Gola dello Sciguello presso il Beigua, l’apatite, nellavarietà fluoroapatite, diventa prevalente in alcune lenti dianfiboliti, dove si presenta anche in distinte cristallizzazioni(DE MICHELE e PIPINO 1981).
Calcescisti e Quarzoscisti
Sotto la denominazione di calcescisti vengono compreselitologie varie derivate dal metamorfismo di sequenze flyscioidi ecaratterizzate da scistosità molto accentuata e ricchezza dimiche, nelle varietà muscovite, paragonite e fengite: vi sipossono riconoscere, spesso con difficoltà, termini più o menocarbonatici, quarzosi o albitici; diffusissime sono le venecalcitiche, più o meno contorte e sviluppate. Nei termini piùtettonizzati, ai contatti con prasiniti o serpentinoscisti, si
trovano spesso diffusioni di pirite e concentrazioni di ossidi diferro. Presso la cascina Bonardo, nel versante sinistro dellaValle Berlino poco a monte della confluenza nella Stura, a metàdel Seicento è stato oggetto di ricerche un limitato giacimentoferrifero, che fece parlare molto di sé per la presunta accertatapresenza di discrete quantità di argento: a quanto è dato divedere, nell’incisione torrentizia ad est della cascina, ilcalcescisto presenta, al contatto con serpentiniti laminate,impregnazioni di ossidi di ferro con cristallini di magnetite benformati e diffusa alterazione limonitica.
Al contrario della Liguria Orrientale, dove la formazione deidiaspri ospita importanti giacimenti manganesiferi, neiquarzoscisti del Gruppo di Voltri, derivati dal metamorfismo didiaspri e rocce simili, non si hanno significativemineralizzazioni di manganese, se non scarse e localizzateimpregnazioni dendritiche di psilomelano. Possono però aversilocali concentrazioni di pirite e di ematite, specie presso ilcontatto con i calcescisti.
SILICIZZAZIONI E MINERALIZZAZIONI AURIFEREIn molte parti del Gruppo di Voltri le serpentiniti sono
interessate da vene quarzoso-carbonatiche che riempiono fratture eimpregnano la roccia fratturata, trasformandola profondamente. Ilfenomeno fu a suo tempo osservato nei corpi ofiolitici presentinell’Appennino Emiliano, e la roccia risultante fu definita“idrotermalite”, ad evidenziare il processo responsabile dellatrasformazione (GAZZI 1956). Rocce analoghe erano già stateosservate da ROSE (1837, 1842) negli Urali, presso il villaggio diListvenaya, e studiate da autori russi perché, grazie allagradevole, trasparente, colorazione verde, venivano utilizzatecome pietra ornamentale: dalla difficile trascrizione dalcirillico derivano i termini listvenite o, più correntemente, listwaenite,con i quali sono poi state indicate rocce simili presenti in tuttele parti del Mondo, oggetto di specifici studi grazie al lorocontenuto aurifero.
La “roccia”, metasomatica, è il risultatodell’alterazione idrotermale di ultramafiti più o menoserpentinizzate coinvolte in dislocazioni tettoniche, specie lungoestesi scorrimenti verticali (shear zones). Il metasomatismo puòportare a risultati diversi, a seconda delle rocce interessate,della loro posizione e grado di frantumazione, della natura deifluidi e delle condizioni di temperatura e pressione: il fenomeno
più diffuso è la carbonatizzazione (dei minerali originari dellaserpentinite), con formazioni di carbonati calcici e magnesiaci,spesso ricchi di ferro, fino a raggiungere e superare il 60% dellaroccia; segue la silicizzazione, con deposizione di calcedonio equarzo che possono raggiungere e superare il 40 % della roccia.Notevole, in entrambi i casi, è la formazione di talco e di altriprodotti d’alterazione: diffusa, ma molto irregolare è la presenzadi ossidi, di solfuri e di oro nativo. Generalmente, le fasi piùcarbonatizzate non contengono oro e solfuri metalliferi, o necontengono molto poco, al contrario delle fasi più silicizzate chene contengono quasi sempre e, per quanto riguarda l’oro, anche indiscreti tenori (1-10 g/T in media, con punte di alcune centinaiadi grammi). I livelli più ricchi contengono taloramicrodiffusioni di muscovite cromifera (fuchsite e/o mariposite)che danno colorazione verdastra al quarzo e caratterizzano le veree proprie listwaeniti, le quali sembrano diffuse soltanto neigiacimenti della Val Gorzente. La provenienza dei fluidi e dei minerali è ancora controversa:l’acqua potrebbe essere connata o di origine meteorica, mal’opinione prevalente è che fluidi e minerali di ganga provenganoda secrezione metamorfica delle rocce interessate. Da queste,secondo una delle teorie correnti, trarrebbero origine anche iminerali metallici, lisciviati dalle rocce, trasportate da fluidiricchi di solfuri di arsenico, antimonio e tellurio, quando non dafluidi ad aloidi, in particolare cloro, e depositati assieme alquarzo nelle fratture, in condizioni opportune. Da notare che ilcontenuto geochimico dell’oro è molto più elevato in rocce mafiche(o basiche) e ultramafiche (o ultrabasiche) che non in rocceacide: queste ne contengono, in media, 2,7 ppb, le ultrabasiti4,5, le rocce basiche 7,2 (BOYLE 1979). BUISSON e LEBLANC (1986)che, oltre a depositi del Marocco e dell’Arabia, analizzanodepositi a listwaeniti aurifere del Gruppo di Voltri, sulla scortadi mia precedente pubblicazione (PIPINO 1980) e di escursioni sulposto, da me guidate, giungono alla conclusione che l’oroproviene da ossidi e solfuri lisciviati durante laserpentinizzazione delle rocce ultramafiche: trasportato dafluidi complessi, solforosi e/o thio-arseniati, precipita poi,per reazione, in rocce carbonatizzate, assieme alla siliceprodotta durante la serpentinizzazione.
In effetti, la mineralizzazione nelle liswaeniti sicaratterizza per la diffusa presenza di minerali metallifericomponenti delle ultramafiti (magnetite, cromite, solfuri dinichel), e per gli alti valori di arsenico, nichel e cobalto, diprobabile analoga provenienza, rilevati nelle vene più
piritizzate. Anche le miche cromifere, secondo BOYLE (1979),sarebbero “generalmente ristrette all’alterazione delle rocce basiche e ultrabasicheincassanti depositi auriferi”: secondo altri autori, però, essederiverebbero da magmi granitici, e, d’altra parte, è stato taloraosservato che i fenomeni di carbonatizzazione e di silicizzazione,nelle rocce ultramafiche, sono molto spinti nelle vicinanze diintrusioni “granitiche”. Per quanto riguarda il Gruppo di Voltri,non occorre però uscire dal complesso ofiolitico per cercarel’origine della fuchsite: come già riconosciuto da ROVERETO(1939), il minerale è presente nelle “prasitinti” della ValCeresolo e del Monte Colma; lo stesso Autore segnala una lente di“scisto milonizzato a ortose cataclastico con epidoto, quarzo secondario e veli di fuchsite”nei pressi dell’Acquasanta, e una lente analoga è segnala, daCONTI (1941), presso il Deserto in Valle Arrestra, con “numeroselaminette di fuchsite di un bel colore verde smeraldo”. C’è poi da sottolinearela discreta abbondanza di metagabbri a smaragdite, l’anfiboloverde, derivato dal diallagio, che deve il colore alle tracce dicromo contenute. Da notare, inoltre, la riconosciuta presenza, daparte di mineralogisti liguri, di clinozoisite cromifera(tawamawite) nelle serpentiniti presso Veirera di Sassello e diclorite cromifera (kotschubeite) in una granatite alla Rocca dellaBiscia di Urbe.
Generalmente, si assume che le elevate temperature dei corpigranitici, nelle fasi di messa in posto, possono aver contribuitoa innescare o favorire fenomeni idrotermali responsabili dellaserpentinizzazione e di altre trasformazioni delle rocceultramafiche e mafiche, ma non pare che abbiano contribuito moltoa fornire oro e altri elementi metallici che, come abbiamo visto,sono diffusi nelle ultramafiti.
Nel Gruppo di Voltri è presente una grande varietà dilitotipi, spesso coesistenti, risultanti da diversi stadi dicarbonatizzazione e silicizzazione, da brecce a grossi clasti pocoalterati, e ben riconoscibili, di serpentiniti o altre rocceofiolitiche circondati e cementati da vene di calcite e/ocarbonati magnesiaci (oficalciti) a brecce quasi completamentecarbonatizzate (carbonatiti), da brecce a grossi elementi pocoalterati circondati e cementatati da vene siliceee (ofisilici) abande e filoni di silice compatta. È interessante notare, ai finigenetici, che le oficalciti, in qualche caso oggetto disfruttamento come “marmo verde” (Voltri, Pegli, Alpicella),costituiscono sempre piccoli corpi completamente avvolti dacalcescisti con prasiniti.
Le vere e proprie listwaeniti si collocano in grossedislocazioni tettoniche verticali e si dispongono, in genere, in
bande intervallate da serpentinite fratturata o brecciata, pococarbonatizzata e non silicizzata. I contatti con la rocciaincassante sono sempre netti, senza visibile alterazione dellesalbande, e sono talora mediati da un livelletto di serpentinofibroso, amiantifero, di colore scuro. I corpi rocciosi hannospessore variabile, da pochi decimetri a qualche diecina di metri,e possono estendersi per centinaia di metri in direzione eprofondità: hanno l’aspetto di filoni costituiti da reticolati divene silicee che circondano frammenti di roccia alterata, didiverse dimensioni, con occasionali bande, al massimodecimetriche, di silice compatta.
I corpi maggiormente liswaenizzati sono composti da ugualiquantità di carbonati e di silice, con lieve prevalenza dei primi,ai quali si accompagnano residui alterati di serpentino(antigorite e crisotilo) e minerali d’alterazione quali talco,clorite, sericite, grafite e prodotti argillosi, con diffusione,nel quarzo, di minerali metallici e di muscovite cromifera che dacolorazione verdastra alle vene più ricche. Il carbonato è sempremagnesiaco (dolomite e magnesite), localmente ferroso (ankeritee/o breunnerite): è presente come massa sostitutiva di originariminerali delle ultramafiti, ed è abbondante alle salbande dellevene e dei filoni più quarzosi, con tipico accrescimento di grossiindividui allungati normalmente alle pareti; in taluni casi formacristallini selliformi di dolomite o lenticelle trasparenti dimagnesite in piccole druse, con o senza cristallini di quarzo.Questo è chiaramente tardivo rispetto al carbonato e, assieme acalcedonio, si dispone al centro delle bande a carbonati sottoforma di elementi allungati di calcedonio, normali alle pareti, edi lenti centrali formate da un mosaico di quarzo che, spesso, siaprono in druse e geodi con cristallini ben formati. Localmente èpossibile osservare fenomeni di sostituzione di carbonati e diserpentino da parte del quarzo: in tal caso ogni strutturaprimaria viene completamente obliterata. Il calcedonio prevale inalcune vene o parti di vene, ed è soprattutto abbondante nellezone più alte dei “filoni” verticali, dove impregna la brecciamilonitica di contatto con le sovrastanti masse ultramafiche pocoserpentinizzate (Erro-Tobbio) e assume l’andamento sub-orizzontaledel contatto stesso.
La paragenesi metallifera utile è confinata alle vene diquarzo e ai contatti fra queste e la roccia alterata: è assaiscarsa, o assente, nei carbonati e nel calcedonio. Si tratta dimicro-diffusioni irregolari di ossidi, solfuri, solfosali e oronativo, raramente visibili a occhio nudo. Gli ossidi sonorappresentati da magnetite, ilmenite, cromite e rara ematite; i
solfuri da pirite, marcasite, calcopirite, pirrotite, millerite,blenda, galena, arsenopirite, antimonite; fra i solfosali è statariconosciuta la tetraedrite, ma gli alti contenuti di nichel,cobalto, arsenico e antimonio, rilevati dalle analisi chimiche,suggeriscono la presenza di altri. Abbondanti sono i prodottilimonitici di alterazione (goethite, lepidocrocite), menofrequenti, e poco sviluppati, quelli cupriferi (malachite,azzurrite). L’oro è presente, allo stato libero, sia nella gangaquarzosa che nel materiale limonitizzato delle vene e deicontatti, in plaghette che in genere non superano il millimetro,ma in alcune druse è possibile la formazione di cristallinimillimetrici e di aggregati dendritici che possono superare ilcentimetro; talora è contenuto, in individui più minuti,all’interno di pirite, calcopirite e tetraedrite.
I contenuti sono molto vari, da zero a oltre 200 ppm (o g/T): lamedia del minerale cernito, sottoposto a trattamento metallurgiconella seconda metà dell’Ottocento, raramente superava i duegrammi.
Alcune vene periferiche possono essere composte esclusivamenteda carbonati magnesiaci e contenere grosse paghe di blenda egalena, con piccole inclusioni di pirite e calcopirite: sono anchestate oggetto di antiche ricerche per argento, come nel torrentePiota in territorio di Lerrma e nel Rio Torto in territorio diRossiglione. In entrambi i casi, si collocano nei pressi delcontatto con grosse lenti di prasiniti scistose associate aicalcescisti.
Nei pochi casi osservati, in cui la listwaenizzazioneinteressa i contatti fra serpentiniti e rocce metagabbriche, ilprodotto finale è ricco di zoisite, clinozoisite clorite eplagioclasio alterato, minerali che diventano prevalenti, assiemea varie specie di zeoliti, nelle vene di alcune masse gabbriche dimaggiori dimensioni, nelle quali non è segnalata la presenzadell’oro.
Localmente, in assenza di grosse bancate di ultramafiti pocoserpentinizzate sovrascorse, la silicizzazione può interessare isedimenti oligo-miocenici di copertura, talora impregnando livelliarenacei e carbonatici: il fenomeno è stato osservato nella valledel Roboaro, e, più ancora, alla Rocca del Falco, sopra lemineralizzazioni di Toleto nell’alta valle del Visone, dove sipossono osservare anche lenti di roccia corallina completamentesilicizzate.
Le mineralizzazioni vanno indubbiamente collegate con le fasifinali dell’orogenesi alpina e con i relativi diversi eventitettono-metamorfici. La conseguente attività idrotermale hacertamente avuto un ruolo fondamentale nella concentrazione deidepositi, la cui potenzialità è condizionata dallo stretto legamecon le rocce incassanti e dall’estensione delle “trappole”tettoniche. La temperatura di formazione può essere valutataintorno ai 300°, la pressione intorno a 2 Kb. Il termalismo èancora attivo nella vicina città di Acqui Terme e, in misura moltominore, è testimoniato dalle numerose sorgenti solfuree cheinteressano il Gruppo di Voltri (PIPINO 1981). Non ci sono provedi relazioni fra l’attività idrotermale e la messa in posto deicorpi “granitici” presenti alla periferia del Gruppo: va quindicorretta una delle ipotesi da me sostenute su indicazione deirelatori della Tesi di Laurea (PIPINO 1975 e 1976).
I GIACIMENTI Fenomeni di silicizzazione sono presenti un po’ dovunque,
nelle serpentiniti del Gruppo di Voltri, e alcuni giacimenti, piùo meno estesi, sono stati oggetto di ricerche aurifere in diversiperiodi. Il più noto e importante è sicuramente quello della ValGorzente, oggetto della mia tesi di Laurea (PIPINO 1975) e disuccessive pubblicazioni: di altri mi ero occupato nell’ambito diuna ricerca scientifica eseguita per conto CNR presso la cattedradi Giacimenti Minerari di Milano (PIPINO 1976) e, poi, nel corsodi ricerche minerarie eseguite dalla Teknogeo Snc incollaborazione con alcune società minerarie canadesi (Noranda,Cominco, Cal Denver), grazie alle quali fu possibile eseguirenumerose indagini geochimiche. I dati riportati di seguito sonotratti da tali studi e ricerche.
Val Gorzente
Le mineralizzazioni aurifere che hanno dato luogo alle minieredella Val Gorzente (e Piota) sono contenute in una larga fascia discorrimento tettonico che si estende a sud del bacino artificialedei “Laghi della Lavagnina” nei comuni di Casaleggio Boiro, Lermae Mornese, fino a raggiungere la valle del Piota. La fascia, cheha tutte le caratteristiche di un corridoio strutturale (ofinestra tettonica) si sviluppa in direzione nord-sud per circatre chilometri e mezzo, con larghezza variabile da poco più di unoa circa due, limitata, ad ovest e ad est, dalle masselherzolitiche del Mond’Ovile e della Cresta Pancaldi-M. Tugello,visibilmente separate per intensi fenomeni di scorrimento (shearing)in senso verticale e longitudinale: sulla riva nord dei “laghi” èben evidente l’abbassamento, per alcune diecine di metri, di uncuneo di sedimenti terziari , sedimenti che dalle altre partidella faglia affiorano molto più in altro, sopra le ultramafiti.Anche la massa lherzolitica Cresta Pancaldi-M. Tugello appareribassata, di qualche diecina di metri, rispetto a quella diMond’Ovile.
All’interno del corridoio strutturale affioranoprevalentemente serpentiniti, sempre molto fratturate, fino acataclastiche, e più o meno scistose, accompagnate da radi corpidi metagabbri e metabasiti e, in posizione elevata, da limitaticorpi smembrati di lherzoliti e da un “klippe” di roccecarbonatiche. Piani di taglio suborizzontali sono diffusi e benvisibili nelle lherzoliti, oltre che nell’isola carbonatica, cosìcome è ben visibile la superfice di sovra-scorrimento sullesottostanti serpentiniti, evidenziata da potenti livelli, fino a 5metri, di breccia tettonica. Fratture e faglie verticali
interessano tutti i litotipi. Le dislocazioni più importantihanno direzione variabile da NNW-SSE a NNE-SSE, con inclinazioneche può vergere sia a ovest che ad est, e sono responsabilidella formazione di zone di scorrimento parallale (shearzones). Molto diffuse sono le successive faglie e fratturedistensive, con direzione W-E, le quali, in qualche caso, sonomolto sviluppate e determinano notevoli abbassamenti di uno deilati, generalmente quello a nord, e lasciano tratti beanti.
I corpi mineralizzati sono numerosi e più o meno estesi econtinui: i più importanti si collocano, o emergono, lungo iprincipali corsi d’acqua che, non a caso, scorrono in direzioneNNW. Il contenuto d’oro varia da zero a qualche grammo; contenutimaggiori, fin oltre 200 grammi per tonnellata, si riscontranosaltuariamente nelle vene dove maggiore è la diffusione dimuscovite cromifera. Il metallo si presenta libero, nel quarzo enel materiale limonitizzato alla periferia delle vene, o ècontenuto in pirite, calcopirite, tetraedrite e, probabilmente, inaltri solfuri e solfosali. Arsenopirite e antimonite sono statiosservati raramente, in microscopici individui, ma l’indaginegeochimica ha dimostrato la stretta correlazione tra il contenutod’oro e quello di arsenico e di antimonio nei suoli e nelle sabbietorrentizie che contengono, spesso, discreta quantità di minuscoleparticelle di oro libero. Interessante è anche l’indagine condottasu circa 500 campioni di “polpa” proveniente dai carotaggi,utilizzati per le prove di cianurazione: il loro pH varia da 9,6 a10,3, il contenuto d’oro da 0,02 a 27 ppm; l’argento è semprepresente in piccole percentuali, inferiori al 10% rispettoall’oro, contenuto compatibile con quello presente in lega e,quindi, senza apparenti apporti esterni; il rame è quasi semprepresente, talora in elevati contenuti (fino a 40 ppm con picco di432,5) non correlabili con quelli dell’oro. A parte pocheeccezioni, la percentuale di recupero di oro e argento, percianurazione, è molto alta (80-100%) e spesso è risultata maggiorerispetto ai contenuti rilevati dalle analisi, probabilmente perquestioni inerenti la quartatura dei campioni analizzati.
Come accennato, in zona periferica (alveo del torrente Piota),al contatto con metabasiti e calcescisti, sono presenti, inserpentiniti poco alterate, vene a esclusivi carbonati, convistosa presenza di blenda e galena, tracce di pirite ecalcopirite, assenza di oro.
Nella zona di alterazione superficiale delle mineralizzazionipiù elevate (Ferrere sup., C. Nebbia, Argion), costituite dalivelli metrici di vene alterate e di suoli di saprolitelateritica, è stata riconosciuta la diffusa presenza dell’oro, in
tenori variabili da 0,15 a 4,3 ppm, in alcuni corpi voluminosi(75.000-100.000 ton) considerati come possibili obiettivi dieventuale coltivazione economica con mezzi e sistemi moderni.
All’estremità sud del nostro corridoio, la fascia diserpentiniti mineralizzate scompare sotto la massa lherzoliticadel Bric Arpescella, ma, poco a sud, alle origini del Piota, inalcune profonde incisioni torrentizie affiorano masseserpentinitiche diffusamente silicizzate e oggetto dipassatericerche minerarie, in particolare nelle località Giasetto, LeRocche e Capanne (JERVIS 1873): nelle stesse incisioni è segnalatala presenza di sabbie aurifere. Alcune delle vene maggiori siaprono spesso in geodi e druse, in cui “limpidi cristallini di quarzo (max 1cm) ricoprono cristallini lenticolari di dolomite” (PIPINO 1982). Lungo lostesso prolungamento sud si colloca anche la non lontanamineralizzazione del Pian delle Mele (Masone) che vedremo inparticolare.
Carta geologica schematica della zona mineraria del Gorzente, con ubicazione degli antichi lavori minerari
(da PIPINO 1982): 1, lherzoliti; 2, serpentiniti e brecce serpentinitiche; 3, prasiniti e metagabbri;4, rocce carbonatiche; 5, lavori minerari; 6, sorgente solfurea, 7, ruderi degli stabilimenti metallurgici.
A sinistra: grosse plaghe d’oro (bianco) nel quarzo e, in elementi più minuti, nella goethite prodottadall’alterazione della pirite. A destra: associazione di tetraedrite (grossa plaga grigia), blenda (grigio scuro)
e calcopirite (grigio chiaro) con inclusione di oro (bianco). Micrografie di sezioni lucide, solo polarizzatore,circa 380 x
* * * * *
Sulle sponde alte del Gorzente, a valle dei Laghi diLavagnina, e su quelle del Piota, a valle della confluenza delGorzente, si trovano estesi cumuli di ciottoli, ordinati e benlavati, sicuri resti della coltivazione, in tempi romani e pre-romani, di originari terrazzi alluvionali auriferi. Si vorrebbeche i Romani avessero coltivato anche le più montane miniered’oro, ma di questo non ci sono prove.
Le prime notizie certe sui giacimenti auriferi della ValGorzente risalgono alla fine del Cinquecento, quando cominciaronoa interessarsene i duchi di Mantova, che avevano ereditato ilmarchesato di Monferrato, e che, per alcuni decenni, tentarono lacoltivazione delle miniere: i lavori furono abbandonati per lamorte di alcuni minatori, sepolti da una frana. Se ne ritornò aparlare, a livello ufficiale, nel 1825, a seguito dell’inchiestapromossa dal subentrato governo sardo, e la mineralizzazione fustudiata e segnalata dall’ing. Candido Baldracco del Corpo delleMiniere (BALDRACCO 1839). Nel 1843 furono concesse le prime dueminiere, “Moglia Ferraio” e “Alcione e Maggetta”, a PanfiloGiuseppe Donati nipote di Baldracco, ma passarono presto in mano aspeculatori francesi che costituirono a Marsiglia una prima“Societé des Mines d’Or del Corsente” e iniziarono ad emetteretitoli azionari al portatore. Dopo vari litigi e passaggi di
proprietà, la società si aggiudicò, nel 1871, anche la concessione“Cassinotto”, mentre un’altra compagnia otteneva, nel 1872, laconfinante concessione “Frasconi” ed emetteva, a sua volta, titoliazionari.
La prima società costruì uno stabilimento metallurgico vicinoalla vecchia cascina della Lavagnina, in sostituzione di altrocostruito da Donati in località Alcione e abbandonato per la carenzad’acqua nei periodi estivi; per l’alimentazione del nuovoopificio, ottenne specifiche autorizzazioni per la derivazionedelle acque dal torrente Gorzente.
Titolo azionario emesso nel 1848 dalla “Societé des Mines d’Or del Corsente”
La prima società costruì uno stabilimento metallurgico vicinoalla vecchia cascina della Lavagnina, in sostituzione di altrocostruito da Donati in località Alcione e abbandonato per la carenzad’acqua nei periodi estivi; per l’alimentazione del nuovoopificio, ottenne specifiche autorizzazioni per la derivazionedelle acque dal torrente Gorzente. Nello stabilimento dellaLavagnina veniva portato il quarzo aurifero estratto nelle vicinecolline, per essere pestato e amalgamato con mercurio, erecuperarne l’oro: data l’assenza, in zona, del granito necessario
alla costruzione delle mole, queste furono importate dal MonteRosa. Per il trasporto del materiale estratto, furono collocati1500 metri di primitivi binari in ferro, di cui buona parte ingalleria. I lavori si protrassero, molto saltuariamente, fino al1897 e, nel 1904, le tre concessioni furono formalmente revocate.Nel contempo iniziavano i lavori di costruzione del bacinoartificiale che, terminato nel 1917, sommerse completamente lacascina, lo stabilimento metallurgico e i cantieri più bassi. Nelcontempo venivano recuperate tutte le strutture in ferro residue,compreso i binari: di questi se ne è salvato soltanto un tratto,recuperato all’interno di una galleria franata e conservato alMuseo Storico dell’Oro Italiano.
Sulla produzione delle tre miniere del Gorzente, comunquescarsa, sappiamo ben poco, perché la società aveva ottenuto dipagare un canone fisso senza obbligo di denuncia, e, almeno neiprimi tempi, l’oro prodotto veniva inviato in Francia. Secondodati sporadici, forniti nel corso di esposizioni internazionali,la produzione si aggirava sui 2-3 chili l’anno e i lingottiprodotti contenevano il 75% di oro, 16% d’argento e 9% di rame ealtri metalli. Negli ultimi tempi, seguiti a periodi più o menolunghi di inattività, lo stabilimento fu rimodernato “col sistemaamericano più moderno di amalgamazione sussidiata da torrefazione e clorurazione”,cosa che consentì, nel 1889, la produzione di 12 chili d’oroargentifero: negli anni successivi la produzione andò man manodiminuendo, fino ai 3 chili del 1895.
La miniera Frasconi, nonostante la più volte dichiarata eaccertata ricchezza di alcuni filoni, non assunse mai veraefficienza e si trascinò stentatamente per alcuni decenni,cambiando spesso di proprietà. Per il trattamento del minerale,dopo una prima piccola costruzione in località Tana, fu attrezzatala Cascina Palazzo, sulle rive del Piota, con macchinariprovenienti dallo stabilimento della Lavagnina. Nel 1908 laconcessione fu revocata, ma grazie all’arrivo di tecnicispecializzati, a pochi lavori di estrazione e allaristrutturazione dello stabilimento, la società ottenne unaproroga: nel 1910, in particolare, dopo aver allargato lamulattiera del Piota, fu trasportato intero, sul posto, un grandevolano in ghisa, di 4 metri di diametro, destando curiosità emeraviglia nella popolazione locale. La società poteva cosìcontinuare a speculare, in Francia, fino al 1911, quando fudichiarata fallita dal tribunale di Commercio di Parigi. L’ultimoproprietario, Rey d’Alissac, riusciva comunque a ottenere, dalMinistero dell’Industria, di fare alcuni lavori in attesa dellarichiesta vendita all’asta, ma di lui si perdono poi le tracce,
nell’aprile del 1913, prima che la vendita fosse concretizzata.Nel corso della prima guerra mondiale furono asportati, dallostabilimento, tutti i macchinari metallici, compresa la granderuota (rudun = ruotone).
Dopo la chiusura delle miniere, la zona è stata oggetto, perbuona parte del Novecento, da ricerche minerarie più o menoapprofondite: nel corso della seconda guerra mondiale vi è stataanche una modica produzione, ottenuta grattando quello che restavadei filoni più ricchi. Le ultime ricerche, eseguite negli anni1984-87 dalla società canadese Cominco, con la mia collaborazione,si sono invece focalizzate sulle zone superficiali di alterazioneche, sebbene a scarso tenore, erano ritenute più interessanti, edeconomicamente coltivabili, rispetto ai “filoni”, grazie alla loroscarsa consistenza rocciosa e alla possibile coltivazione a cieloaperto. Le ricerche sono invece state sospese perché, proprio inquegli anni, andava prendendo corpo il “Parco Naturale delleCapanne di Marcarolo”, in cui i giacimenti sono completamentecompresi: il Parco, istituito ufficialmente nel 1979 a seguito distudi e progettazioni da parte di istituzioni urbanistichegenovesi, che ignoravano completamente le realtà storico-minerariedel territorio, e non solo, fu infatti osteggiato per anni dapopolazione e amministrazioni locali.
Le miniere d’oro dell’Ovadese (da PIPINO 1982). Valle Stura: 1, Ovada, 2, Belforte;Val Gorzente (e Piota): 3, Moglia Ferraio, 4, Cassinotto, 5, Alcione e Maggetta, 6, Frasconi
BelforteLa manifestazione di Belforte Monferrato, in Valle Stura, si
trova sulla destra orografica del torrente, poco più di duechilometri a sud del paese, in vicinanza della C. Zanaia.Interessa tutta la zona collinare soprastante la cascina, ed è benvisibile, anche dall’altra parte della valle, per la tipicacolorazione giallo-rossastra, di alterazione, dei suolisuperficiali.
Si tratta di un piccolo affioramento di serpentiniti alteratee silicizzate, limitato a ovest, in corrispondenza stessadell’alveo del torrente, da una faglia N-S che lo separa da ungrosso affioramento di calcescisti e prasiniti, appendice dellabanda Voltri-Rossiglione; dalle altre parti passa a serpentinitescistosa non mineralizzata, intensamente fratturata, coperta inparte dai sedimenti basali del Bacino Terziario Piemontese. Pocoa sud si erge la massa prasinitica che forma il Monte Colma.
La mineralizzazione affiora bene nel rio appena a sud dellacascina (Fossarone), risalendo il quale si incontrano almeno duebanchi di brecce silicizzate, spessi 2-3 metri, distanti unaventina di metri l’uno dall’altro, con direzione apparente N-S eimmersione a est. La mineralizzazione è costituita da brecciaserpentinitica molto alterata cementata dalle solite venemillimetriche e centimetriche a carbonati e silice, con sporadicapresenza di pirite: la silice è prevalentemente calcedoniosa, malocalmente, in alcune piccole druse, si notano cristallini diquarzo. I banchi proseguono, visibilmente, ai due latidell’incisione torrentizia, dove sono coperti da uno spesso stratodi di terra rosso-giallastra. Anche sulla cresta della collina, indirezione di C. Antononi, affiorano lembi di serpentinitisilicizzate, ma per lo più sono coperte da uno strato di suolo dicolorazione giallastra, ricco di limonite.
Le analisi di alcuni campioni, raccolti dalle vene piùsilicizzate, hanno rilevato scarsissimo contenuto d’oro (max 0,5ppm), mentre nei suoli di alterazione il contenuto raggiunge i 2ppm. È da questi che proviene, con tutta probabilità, l’orodetritico, in minuscole scagliette, presente nel rio Fossarone ein quelli contigui, tra cui quello coll’indicativo nome diGrattarino, e, ancor di più, nelle sabbie della Stura, appena avalle della confluenza, dove sono state trovate scagliette condiametro fino ai due millimetri. In questa zona, la valle èindicata da tempi antichi come Valoria o Valloria e, in alcuni punti,
sui terrazzi si trovano ancora cumuli di ciottoli residui diantichi lavaggi.
Sulla destra del torrente, un chilometro circa a valle dellamineralizzazione e appena a nord di C. Sguardia, si trovano iruderi di un “mulino dell’oro”, costruito a metà Ottocento per iltrattamento del minerale.
La piccola mineralizzazione di Zanaia è stata oggetto di unaconcessione mineraria (“Belforte”), confinante con altra (“Ovada”)sulla sponda sinistra della Stura: in questa affiorano, però,calcescisti con livelli di prasiniti, e non si notano tracce dimineralizzazione, se non le solite, estese, vene di calcite.
* * * * *La presenza della mineralizzazione di Zanaia, in particolare
delle “terre rosse” superficiali, aurifere, è nota da tempo, tantoda dare il nome di “Montagna dell’Oro” al Monte Colma. Se neaccenna anche nei documenti seicenteschi relativi ai lavorieseguiti nel giacimento di ferro della Val Berlino, secondo iquali la “rossezza” del terreno superficiale ne denuncerebbe laricchezza.
La riscoperta in tempi recenti si deve all’ingegnere franceseEdoardo Primard, che lasciata la direzione delle miniere delGorzente, iniziò una intensa attività di ricerca nelle zonecircostanti e, nel 1853, costituì a Genova la “Società Franco-Sarda per le Miniere d’Oro di Ovada”. Le analisi eseguite sualcuni campioni diedero risultati scarsi e contrastanti: tuttavia,nel 1854 vi fu una prima dichiarazione di scoperta e, anche aseguito dell’intervento del console francese, il 9 agosto lasocietà ottenne la concessione delle due miniere, “Ovada” e“Belforte”. Secondo le informazioni promozionali, sarebbero statievidenziati 80 “ricchi” filoni nella seconda concessione, 3 nellaprima, con contenuti d’oro variabili da 10 a 30 grammi pertonnellata, nel quarzo e nella roccia incassante, da 10 a 60grammi nelle terre superficiali e nelle sabbie torrentizie. Nel“Mulino dell’Oro” costruito dalla Società nei pressi di C.Squardia, avrebbero dovuto essere impiantati macchinari ideatidallo stesso Primard, per i quali ottenne brevetto d’invenzionenel 1855.
Ma le cose andarono subito male e, in mancanza di risultati,molti abbandonarono la società e non sottoscrissero le azioni. Sene cercarono altri in Francia, cedendo parte delle proprietà, esulla Borsa di Parigi cominciarono a circolare azioni di duediverse società che si attribuivano la proprietà delle miniere: la“Società Franco-Sarda di Primard & C.” e la “Società Francese
delle miniere d’oro di Ovada e Belforte, Blondelle e C.”. Dopovarie controversie e furiose liti legali, nel novembre del 1859 laSocietà Franco-Sardo fu messa in liquidazione, a Genova. I beniimmobili furono venduti all’asta, mentre le concessioni minerariefurono formalmente revocate, nel 1866, dal Ministerodell’Industria.
In seguito la zona fu oggetto di sporadiche ricerche, ultimadelle quali eseguite intorno al 1980 dalla mia società (TeknogeoSnc.) che ne accertò la scarsa consistenza.
Bric dell’Oro (Masone)Il toponimo Bric dell’Oro è piuttosto diffuso nella Valle
Stura di Ovada e in zone vicine e, quasi sempre, indica lapresenza di limitate mineralizzazzioni oggetto di passate attivitàmineraie. La manifestazione di Masone, indicata anche con nome di“Pian delle Mele”, proprio di una vicina cascina, affiora, ai duelati di questa, negli alvei del Rio Vezzullo e del ramo che scendedal M. Drà, che si congiungono alle falde orientali del Bric dell’Oro;limitate manifestazioni si osservano anche nell’alveo del torrente(Rian Lajassu) che, proveniente da nord, si immette nel Vezzulloalle falde occidentali del Bric dell’Oro. Da notare che ilgiacimento si colloca nel prolungamento sud delle miniere delGorzente, delle manifestazioni minori dell’alta valle del Piota edi altre che fanno capolino al Passo dell’Ovo e nelle alteincisioni dei torrenti Lavazzei, Angassino e Ponzema, alle faldeoccidentali e meridionali del M. Pracaban: in quest’ultima zona,lungo la strada provinciale per Capanne, si trova un’anticasorgente che conserva il nome seicentesco di Tant’Oro, nome che nonpuò certo attribuirsi alla qualità dell’acqua, che è piuttostocattiva.
La mineralizzazione di Masone si colloca, di preferenza, nellazona di intersezione tra faglie a direzione NW-SE e NE-SW einteressa ultramafiti poco serpentinizzate e molto fratturate, conlivelli di duniti, che soltanto in corrispondenza dellamineralizzazione e nelle zone più tettonizzate appaiono più omeno serpentinizzate. È composta dalla solita brecciaserpentinitica molto alterata cementata da vene quarzo-carbonatiche con rara presenza di solfuri: localmente, nel rio diM. Dra poco a monte della confluenza nel Vezzullo, si notadiffusione della colorazione verdastra data dalla presenza di micacromifera.
Le analisi di alcuni campioni hanno rilevato contenuti d’orovariabili da 0,2 a 2,3 grammi per tonnellata: il campione più
ricco è stato raccolto al contatto di una vena con rocciadunitica.
L’indagine geochimica ha evidenziato diffuse anomalie d’oro(da 10 a oltre 400 ppb) in pressoché tutte le incisionitorrentizie della zona, confluenti nel Vezzullo e nell’alto corsodel Ponzema, con due valori eccezionalmente alti (900 e 3800 ppm)localizzati sulla stessa direttrice a nord del Bric dell’Oro.
* * * * *
Le prime notizie di ricerche in territorio di Masone risalgonoal 1825, quando, a seguito dell’indagine statistica promossa dalgoverno sardo, furono raccolti, ed inviati a Torino, campioni diroccia presunta aurifera nel territorio comunale e nel confinanteterritorio di Casaleggio: le analisi non diedero però risultatiutili. Le ricerche in zona, però, continuarono e, nel 1855, PaoloSalvi e Nicolò Ottonello ottennero un permesso per mineralimetalliferi in località Pian delle Mele; nel 1879 il solo Salviottenne un permesso, per oro e rame, in località Pian Drà, poco anord del precedente.
La zona è stata oggetto di ricerca negli anni 1986-87 da partedella piccola compagnia canadese Cal-Denver, con la miacollaborazione: furono ottenuti due permessi confinanti (“RioVezzullo” e “Monte Vesolina”), nell’ambito di una vasta campagnageochimica che interessò tutto lo spartiacque del territoriogenovese. Le ricerche furono interrotte a seguito di contrasti colMinistero dell’Industria, che aveva sottratto alla compagnia ipermessi per oro epitermale in Toscana meridionale, per affidarlialle società parastatali.
Monte Orditano-Monte Pennello (Genova) Lungo la direttrice Monte Orditano-Monte Pennello è segnalatala presenza di sporadiche silicizzazione, oggetto di passatericerche aurifere: la direttrice si estende, non a caso, indirezione nord-sud, in concordanza con le maggiori strutturetettoniche verticali del Gruppo di Voltri e con la vicinissima“Linea Sestri-Voltaggio” che lo separa dall’omonima “Zona”. Intutta l’area affiorano serpentiniti più o meno scistose conisolati lembi di lherzoliti e serpentiniti a relitti.
Già PARETO (1846) segnala la presenza, alle origini deltorrente Varenna, di serpentiniti che “…presentano delle specie diincrostazioni e vene silicee calcedoniose che hanno rassomiglianza a quelle tantocelebrate nelle serpentine di parte del Piemonte”: si riferisce, ovviamente,alle mineralizzazioni aurifere del Gorzente segnalata da BALDRACCO(1839), richiamo che sarà fatto proprio anche da successivi autori
liguri. ROVERETO (1891) segnala la presenza, al pratodell’Anguilla e a Praglia, di “…una particolare serpentina brecciosa acemento siliceo-quarzoso…in correlazione a questa serpentina silicifera stanno i noduli dicalcedonio roseo, che sono a loro volta in corrispondenza con i filoni auriferi quarzosidelle attigue vallate del Piota e del Gorzente”; in una successiva pubblicazione(1939) lo stesso Autore dice che si tratta di “…serpentinite brecciata ericementata da reticolati di vene silicee…una ofisilice localmente detta pria camulà (pietratarlata)…che deve aver relazione con i filoni di quarzo aurifero delle attigue vallate delPiota e del Gorzente”. CORTESOGNO et AL. (1976) segnalano“manifestazioni notevoli” di silicizzazione, con solfuri, traMonte Pennello e Bric dell’Orologio, le quali potrebbero avereanalogie con le “…deposizioni di quarzo aurifero nelle zone più a nord del Gruppo diVoltri”.
Le manifestazioni, già poco estese, sono state sconvolte daricerche minerarie eseguite nell’Ottocento e solo localmente se nevedono le tracce, specie ai Piani di Praglia, alle falde del M.Proralado, nelle incisioni del Rio Vaccarezza alle origini delVarenna e alle falde meridionali del M. Foscallo (Prato dell’Anguilla).Quest’ultima località fu interessata, nel 1976, dal passaggiodell’ossigenodotto (poi trasformato in oleodotto) che dispesemolto materiale e mise allo scoperto un vistoso affioramento convene prevalentemente calcedoniose: analisi su alcuni campioni dame raccolti diedero scarsi contenuti d’oro (max 300 ppb), ma illavaggio di sabbie nei rii che si originano nella zona, rivelòdiscreta diffusione di polverina d’oro.
Limitate manifestazioni, costituite da vene quarzose inbreccia serpentinitica, sono visibili nelle incisioni torrentiziea nord e nord-ovest di Vaccarezza: vi si notano anche piccoliaffioramenti di un litotipo anfibolico ricco di vene carbonatichee quarzose. Circa 100 m a sud-est di Vaccarezza, in località laCiasetta, s’intravede, nella folta vegetazione, un ampio fronte dicava dove, secondo notizie raccolte in posto, fino a qualche hannofa si apriva, in direzione nord-ovest, una galleria dalla quale inpassato sarebbe stato estratto minerale aurifero; il vicino rio,confluente del Vaccarezza, è ancora chiamato Ritano dell’Oro daivecchi abitanti del posto, e Monte dell’Oro è chiamato il non lontanoMonte Larvego.
* * * * *
Le prime notizie sull’oro dell’alta Val Varenna sono contenutein documenti dell’Archivio di Stato di Genova, in parte da me giàsegnalati (PIPINO 1976). Nel 1757 una società che avevaintrapreso la costruzione di una fonderia per rame a Varenna
chiese ed ottenne una concessione venticinquennale per scavare “…metallo, anche del più prezioso” in terreni della parrocchia di SanLorenzo di Torbi, per la quale costituì una nuova società, congente del posto. La cosa non ebbe molto seguito e nel 1798,rispondendo all’inchiesta promossa dalla Repubblica Ligure, ilparroco di Torbi scriveva: “…Sono in luogo d.o Vaccarezza indizi di minierad’Oro, il quale non credo che sia abbondante nella superficie”. Ne accennano poiautori poi autori dell’Ottocento, a partire da BERTOLOTTI (1834):“…Ne’ monti di Cese, non lungi dalle scaturiggini del Varenna…appaiono segni di miniered’oro”.
Fra il 1823 e il 1855 tutta la zona fu oggetto di ricercheminerarie da parte di gente del posto: i dottori fisici GiuseppeParodi e Gaetano Orsini si interessarono alla località Ciasetta,dove “…si prospetta esistervi una miniera di piombo argentifero e altro”; G.B.Magnata e G. Tapella intraprendevano ricerche intorno al monteLorditano, in comune di Ceranesi e in altre zone del comune diLarvego, “…e specialmente nel luogo detto Poggio dell’Oro”; Luigi Centurionie compagni scavavano, per minerali vari, a Vaccarezza, Crema, MonteCerasolo, M. Proralado, Bric dell’Orologio ed altre località vicine.Ulteriori ricerche, per rame, oro argento e carbon fossile,furono eseguite fra il 1879 e il 1882 da Domenico Cerisola inlocalità I Termini, mentre S. Zaccarino ricercava rame a Vaccarezza.
La zona è stata oggetto di ricerca negli anni 1986-87 da partedella Cal-Denver, con la mia collaborazione: in particolare fuchiesto il permesso di ricerca per rame, oro e minerali associatidenominato “Orditano”, nei comuni di Ceranesi e di Genova,confinante con gli altri del versante padano (“Rio Vezzullo” e“Monte Vesolina”): la pratica, contrariamente agli altri permessi,andò per le lunghe a causa dei vincoli forestali e idrogeologicidell’area, poi la domanda fu rinunciata, causa i detti contrasticol Ministero dell’Industria.
Valle Gargassino (Rossiglione)
In Valle Gargassino sono presenti estesi corpi di brecceofiolitiche considerate parte dei sedimenti trasgressivi terziari,tettonizzati a seguito della sovrapposizione di ultramafiti pocoserpentinizzate, dell’unità Erro-Tobbio, che affiorano ancoranelle parti più elevate della valle e appaiono visibilmentesovrascorse, in direzione est o nord-est, sulle brecce e susottostanti serpentiniti più o meno scistose. Queste emergono, inparticolare, nella profonda incisione torrentizia e, nella partepiù montana del torrente, sono accompagnate da un esteso lembo dimetagabbri a smaraldite e prasiniti laminate.
Lungo il torrente, oltre alla presenza di oro alluvionale,sono segnalate mineralizzazioni oggetto di passate ricerche. Nellaparte finale della valle, poco a monte della confluenza neltorrente Gargassa, è ricordato un toponimo “cava dell’oro” e, nellacollina sovrastante (q. 470), un “pozzo della Camilla” che, secondo ivecchi del posto, era stato scavato proprio per la ricercadell’oro: la zona è stata oggetto, in tempi recenti, da interventidi riforestazione, che hanno obliterato le tracce dei vecchilavori e impediscono l’affioramento del substrato. Frammenti dibreccia silicizzata si notano, nei campi, alle falde sud-occidentali della collina, nella località dal significativo nomedi Monterosso.
Più a monte, nei pressi delle case Cerrone di sotto, incorrispondenza di una scarpata tagliata dalla curva della stradadi accesso, e nell’alveo del torrente sottostante, si vedonodiscrete vene calcedoniose in serpentinite alterata: nellevicinanze si intravedono le tracce di antichi scavi. Poco più dicento metri a monte, le profonde incisioni di sinistra orografica(Rian Baggi e Rian Tortu) sono impostate in faglie verticali est-ovestche nella parte alta interessano la breccia tettonica alla basadelle ultramafiti poco serpentinizzate, mentre in prossimitàdella confluenza nel Gargassino si perdono in metagabbri e inprasiniti: nella parte mediana, dove incidono serpentiniti più omeno scistose, assumono l’aspetto di veri e propri filoni, conspessore variabile da uno a tre metri, al cui interno si possonodistinguere bande serpentinitiche e talcose a diverso grado difrantumazione e colorazione varia: quelle più milonitizzate hannocolorazione rossastra e contengono sottili vene siliceefratturate, quelle composte da materiale a pezzatura maggioreconservano il colore verdastro della serpentinite e contengonovene carbonatiche di spessore vario, pure fratturate, con visibilepresenza di grosse plaghe di blenda e galena, oltre che di pirite:analisi chimiche vi hanno riconosciuto tracce appena percettibilidi oro e discreti contenuti di piombo e di argento.
Sulla cresta spartiacque con la valle dell’Orba, ai confinifra Rossiglione e Tiglieto, affiorano ultramafiti pocoserpentinizzate e molto fratturate oggetto di passate ricerche peroro che hanno lasciato traccia nella toponomastica (Cava e Pozzodell’oro). Una breve galleria di ricerca, diretta a sud, si apreproprio sotto la strada in corrispondenza del passo (Km 7,200),alle falde nord-occidentali del M. Calvo; un’altra si trova nelversante occidentale, in posizione più elevata, alle origini delrio che scorre a nord di C. Zanaia in direzione di Tiglieto.Questa si sviluppa, per pochi metri, in direzione nord e nel bosco
sovrastante si notano ancora le tracce di due pozzi scavati a metàOttocento (S. Antonio e S. Francesco), completamente riempiti dadetriti. Il tutto interessa la parte basale delle bancateultramafiche, molto fratturate, contenenti bande di rodingiti elivelletti milonitici di riempimento delle fratture, spessoaccompagnati da sottili e irregolari vene di calcite e disteatite. In questo caso, come accennato, non si hanno tracce disilicizzazione e la mineralizzazione è costituita da sporadichepresenze di oro, anche visibile a occhio nudo, immerso nellamilonite ultramafica delle fratture.
* * * * *
La testimonianza più antica delle mineralizzazioni delGargassino risalgono al 1465, quando viene citata una “ vena di argentoe piombo nel territorio di Rossiglione verso Urbe (PIPINO 1976). Si tratta,evidentemente delle suddette vene di carbonati con solfuri che,nelle parti più alte dei rii che le contengono sono tagliatedall’antica strada Rossiglione-Urbe. A queste si riferisconoancora vaghe testimonianze su ricerche cinquecentesche, effettuareda Nicola Pisuracio e soci, e altre, successive, riguardanti unaminiera d’oro in territorio di Rossiglione, presso il confine conil Regno di Sardegna, contesa da diversi imprenditori. Alla finedel Settecento cominciò ad occuparsene l’arciprete SebastianoStella, parroco di Morbello, che cercò di interessare prima ilprefetto napoleonico di Savona, poi la comunità di Rossiglione e,infine, il subentrato governo sardo. Nel 1832 l’ispettoreSobrero, incaricato del sopralluogo, benché riconoscesse lasporadica presenza dell’oro, sentenziò che la presenza delleminiere era impossibile in quelle zone, in quanto vi mancavano lerocce granitiche e gneissiche: la supposta presenza d’oro nellerocce serpentinose del posto era dovuta alla presenza deldiallagio che “…particolarmente dopo le piogge affetta il bel lucido, ed il coloredell’oro”.
Nonostante le asserzioni dell’Ispettore, la zona continuò adessere oggetto di ricerche , nella speranza di trovarvi filoni diquarzo aurifero analoghi a quelli del Gorzente, incassati proprionelle serpentiniti. Nel 1843 una società rappresentata da AntonioRomanengo ed Emanuele Magana ottenne, dalle intendenze di Genova edi Savona, permessi di ricerca per piombo e argento nellelocalità Soria di Zanaja, Ciazzo del Frate o di Bacchetta, Fontana Marcia, Ramo Torto,Gelosia, Rocca della Lelora, Soria della Presa: le ricerche si focalizzaronopoi sugli indizi d’oro del M. Calvo: dopo alcune prove eseguitein due molinelli di amalgamazione costruiti a Tiglieto, fu chiestala dichiarazione di miniera scoperta, non accordata a causa della
sporadicità della mineralizzazione. Dopo qualche anno diabbandono, nel 1852 cominciò a interessarsene l’ing. Primard,direttore delle miniere di Ovada e Belforte, la cui societàottenne permessi di ricerca per oro nelle località Monte Presa eSerrone, contestati da altri pretendenti.
In tempi più recenti la zona è stata ancora oggetto diricerche più meno serie. Nel 1980 la ditta Cuzzi di Milanopresentò la domanda di permesso di ricerca “Monte Calvo” neicomuni di Tiglieto e Rossiglione, per oro, rame, titanio, cobaltoe nichel: alle ricerche era in effetti interessata la societàcanadese Falcon Bridge, la quale eseguì, in Canada, esame dialcuni campioni raccolti sul posto, anche su mie indicazioni; ladomanda andò per le lunghe, a seguito dell’opposizione di gruppiambientalisti locali, ma il permesso fu comunque accordato, il 2febbraio del 1982, quando visti gli scarsi risultati delleanalisi, la ditta aveva già sospeso le ricerche. Nel 1984 fu poirespinta la domanda avanzata da Quintilio Tessi, di Genova, chechiedeva di cercare minerali di platino, oro, argento rame enumerosi altri metalli nella località “Val Gargassa-Rossiglione”,nel comune omonimo, e aveva suscitato analoghe opposizioni deigruppi ambientalisti locali.
Olbicella
La manifestazione di Olbicella, già segnalata da ROVERETO(1939) si trova sulla sponda destra dell’Orba appena a valle dellaconfluenza dell’Olbicella: è ben visibile perché tagliata dallastrada per Tiglieto, in prossimità del ponticello sul secondotorrente. Si estende per oltre cento metri, nella massa diserpentiniti a relitti molto fratturate, ed è racchiusa da duefaglie con direzione N-S immerse ad est; nella parte inferiore èdelimitata da superfici di scorrimento suborizzontali.
Le vene silicee di maggiori dimensioni, centimetriche,presentano giacitura verticale e direzione N-S, come le fratturedi contenimento. Sono essenzialmente calcedoniose, ma alcunepiccole druse appaiono ricoperte da cristallini di quarzo elenticelle trasparenti di dolomite.
Le analisi chimiche di alcuni campioni hanno evidenziatoscarse tracce d’oro (max 200 ppb). Contenuti maggiori (fino a 2ppm) sono state riscontrati nella serpentinite laminata, conlivelletti di milonite rossastra, che affiora nell’altro versantedell’Orba, sopra C. Canobio.
Poco più di un chilometro a sud, lungo il rio Pian del Foco, sitrova la massa di metagabbri interessata da vistose vene dizeoliti.
Cassinelle-Bandita
Ai primi dell’Ottocento il parroco di Morbello, SebastianoStella, annota, tra l’altro, la presenza di pirite e di grossifiloni di quarzo nel torrente aurifero Medrio, presso Montematino interritorio di Cassinelle e Bandita. Monte Martino, a cuievidentemente si riferisce, si trova oggi in territorio di Molare,appena al di la del confine nord-orientale del comune diCassinelle; quanto al torrente, si tratta dell’odierno Rio SanGiuseppe che scorre in sedimenti terziari, ma vi sono segnalatipiccoli affioramenti di serpentiniti con vene silicee nella partealta, a sud-ovest di Molare, e poche diecine di metri a montedella confluenza nell’Orba: nel rio è stata, in effetti,riconosciuta la presenza di sabbie aurifere.
Particolarmente caratteristica è la silicizzazione diframmenti di legno fossile che si trovano nella parte montana deltorrente Amione, presso la vecchia miniera di lignite (loc. gliUvi), i quali sono spesso attraversati anche da vene di quarzo concristalli ben formati, trasparenti e molto brillanti, che possonosuperare il centimetro di lunghezza: spesso contengono inclusionidi materiale carbonioso che impartiscono loro tonalità dal marroneal nerastro (PIPINO1980). I legni fossili, così come i livelli dilignite, sono contenuti in sedimenti marnosi di origine fluvio-lacustri che stanno alla base dei sedimenti trasgressivi delBacino Terziario Piemontese e che poggiano su serpentiniti (PIPINO1978).
Nell’area circostante l’abitato di Bandita affiorano rocceserpentinitiche molto fratturate e contorte, con locali livelli digabbri a smaraldite ed estese coperture di rocce sedimentarie cheimpediscono di osservare i rapporti di giacitura. La zona apparecomunque molto tettonizzata, con evidenti scagliamenti e localipresenze di feltri amiantiferi che, in qualche caso, possonoassumere discreto sviluppo (Fontana del Ratto). Tracce disilicizzazioni sono presenti in vari punti, ma non assumono grandeimportanza.
Un affioramento piuttosto esteso, di serpentinite silicizzata,con vene anche beanti ricoperte da cristallini ben formati, sitrova sul ripido versante destro del Rio Remorsi-Gorreta, a sud-est di Cascinazza: l’affioramento si estende lateralmente per alcune
diecina di metri; le serpentiniti presentano fratturazioni conimmersione di circa 45° a nord, mentre le vene silicee piùsviluppate hanno giacitura verticale e direzione N-S, concordantecon le incisioni torrentizie in cui sono ospitate. Presenzeanaloghe sono segnalate in località Gorini, alle origini del T.Caramagna, nel versante opposto delle creste spartiacque Bric Rondel Contino (q. 657) e Bric degli Uvi (q. 614).
Toleto-Morbello
Estesi corpi di serpentiniti silicizzate affiorano lungo ilcorso del Rio Tre Alberghi, per circa 3 chilometri, a partiredalle sue origini, presso Toleto (Comune di Ponzone), fin quantodiventa Visone, presso Morbello. Piccole vene silicee fratturateinteressano, come in Val Gorzente, la breccia di contattotettonico con la sovrastante massa di ultramafiti pocoserpentinizzate del Bric degli Uvi (q.754), incisa, nella partesettentrionale, dalla strada provinciale proveniente daCassinelle, poco prima del bivio per Pian Castagna. Poco a ovest,nelle località Ferle e Ceresole, le serpentiniti, alle origini delRio Tre Alberghi, presentano spessi feltri di amianto cheevidenziano la presenza di una evidente faglia, con direzionenord-sud, lunga la quale si sviluppa il torrente stesso. Sulversante opposto, meridionale, livelli di serpentiniti silicizzateaffiorano nell’alveo del Rio Bardanelli, in quale contribuisce allaformazione del Rio Miseria, affluente dell’Erro, che sembra dovereil nome ad antica attività di raccolta dell’oro.
Gli affioramenti più estesi e interessanti si trovano neidintorni dell’abitato di Toleto: sono spesso ricoperti dacalcescisti o da sedimenti terziari e affiorano bene soltantonelle incisioni torrentizie che circondano l’abitato, specie nelramo principale, poco a monte e subito a valle del mulino. I corpimineralizzati, costituiti da breccia serpentinitica cementata devene carbonatiche e quarzose, hanno forma lenticolare, conspessore fino ai 10 metri e lunghezza non ben apprezzabile,comunque variabile da pochi metri ad alcune decine. Nel versantedestro del rio, circa 500 metri a valle del mulino e poco a montedi una piccola cascata, in località Crovera, si notano le tracce diuna vecchia galleria, che gli abitanti del posto chiamano “Tanadella Volpe”. La mineralizzazione si estende verso l’alto, lungoil versante occidentale e settentrionale del colle che si erge anord di Toleto (Rocca del Falco, q. 641).
Nelle vene silicee si aprono spesso druse tappezzate dacristallini di quarzo, poco slanciati, raramente associati a
magnesite, e talora ricoperti da un feltro di bissolite verdastra,da prodotti saponitici di un bel colore verde pisello, da minuticristallini di pirite limonitizzata; localmente, la superficiedelle vene e della roccia incassante è interessata da dendriti dipsilomelano. Spesso la prima generazione di quarzo apparericoperta da una seconda generazione, fatta di microscopicicristallini di colore bianco, meno spesso da croste irregolaricostituite da bellissimi cristallini color miele. Alla Rocca delFalco sono state scavate, da cercatori di minerali, e praticamenteesaurite, vene di quarzo con geodi cristallizzate nelle quali sitrovavano cristalli centimetrici ad abito tozzo, ialini, citrini odi colore mielato tendente al madera, isolati e poggianti su basedi cristallini millimetrici di evidente deposizione precedente. Inquesta zona, la silicizzazione ha interessato anche i sedimentioligo-miocenici che ricoprono la cima della Rocca sul versanteorientale: alcune grosse bancate silicee orizzontali sono infattialternate ai sedimenti, sembrano averne sostituito gli strati piùcalcarei e, alcuni parti, conservano originarie improntecorallifere.
Le analisi chimiche, di campioni del materiale piùsilicizzato, hanno evidenziato tenori d’oro molto vari eirregolari, da 0 a oltre 2 grammi per tonnellata, con valori piùalti in quello affiorante lungo i fianchi della Rocca del Falco astrapiombo sul Rio Tre Alberghi. La prospezione alluvionale haconsentito di raccogliere modeste quantità di polverina d’oro, dalmulino di Toleto alla piccola cascata sotto la Rocca del Falco, elungo i principali rii confluenti.
Poche centinaia di metri a valle, isolati banchi di breccesilicizzate affiorano nell’alveo del torrente, oltre che nelversante sinistro, lungo il confluente Rio delle Soriglie (o Cuniazz) enella soprastante costiera, a sud di C. Carmine e sul fianco sud-orientale del Bric Momborerto: una di queste, a est di C. Vercade,è interessata da una vecchia galleria di ricerca. Un chilometrocirca a valle, in località Rocca di Ghiné, mentre sulla sinistra delrio affiorano calcescisti e prasiniti, sulla destra si ritrovanoaltre lenti serpentinitiche silicizzate con tracce di malachite, ealtre si intravedono più in alto, sui fianchi occidentale e nord-occidentale del M. Brignone, lungo il sentiero per Morbello-Valle,nelle località Terre Rosse e Bardana.
* * * * *
Alle manifestazioni di Toleto sembra si possano riferirele generiche notizie su miniere di oro, argento e altri metalli
nei pressi di Ponzone e di Pareto, oggetto di interesse da partedei duchi di Mantova agli inizi del Seicento. CHABROL DE VOLVIC(1824), che si serve abbondantemente delle notizie fornitegli,quando era prefetto napoleonico di Savona, da Sebastiano Stellaparroco di Morbello, accenna alla presenza dell’oro nel Visone esostiene: “…i torrenti Camborella e Fossato sono auriferi: i Genovesi venivano asetacciarli tutti gli anni, mezzo secolo fa, ma han finito per rinunciare; qualche contadinoancora oggi si dedica a questa ricerca, con guadagni modesti”. Dei due torrenticitati, il Fossato corrisponde al Rio Tre Aberghi, il Camborellaall’altro importante ramo del Visone, che confluisce a nord diMorbello; i “genovesi” erano probabilmente quelli della valleStura, che ne raccoglievano anche nei pressi di Campo e diRossiglione.
Alla fine del Settecento lo stesso parroco ne inviava campioniall’Accademia delle Scienze di Torino, sostenendo che con quellosi era mantenuto agli studi, potendo raccoglierne fino a quattrolibbre e mezza al giorno (BALBO 1786). Anche JERVIS (1874) segnalala presenza di oro nel torrente Visone, nei comuni di Morbello eVisone, ma in scarse pagliuzze.
Nel 1878 Adolfo Allard, già direttore delle miniere delGorzente, ottenne tre permessi per oro: il 3 giugno per lalocalità “Rocca di Ghinè”, il giorno successivo “…in regione Crovera a norddel ritano di Toleto”, il 9 agosto nella località “Soriglie o Momboleto”.Nel 1882 Luigia Porcella, vedova Sileoni, avanzò una genericarichiesta per minerali d’oro, rame, piombo e altri metalli neiterritori comunali di Morbello, Ponzone e Grognardo, domanda chenon ebbe seguito, trattandosi di ben quattro comuni, in alcuni deiquali vigevano già permessi di ricerca.
Un permesso di ricerca per minerali auriferi e cupriferi,denominato “Tre Alberghi”, fu ottenuto il 28 giugno 1980 dallaTeknogeo Snc., che vi compì i primi studi in collaborazione con lasocietà canadese Noranda; il permesso, re-intitolato “Toleto”, fupoi attenuto, il 10 aprile 1986,
Cartina annessa alla domanda di A. Allard per ricerche aurifere in località Soriglie e Momboleto (1878)
A sinistra: cristallini di quarzo trasparenti (1-2 mm) su lenticelle di dolomite, in una drusa della Val Gorzente.A destra: grosso cristallo di quarzo (2,5 cm) su base formata da cristallini più piccoli (1-2 mm), in una drusa
di Toleto
dalla società CAL DENVER che, dopo i primi promettenti risultati,lo abbandonò per i contrasti col Ministero dell’Industria.
Erro-Malvicino
Nella parte mediana della valle dell’Erro, fra il M. Acuto e lavalle del Belbicino, sotto Malvicino, sono presenti, lungo unallineamento NW-SE, interessanti zone a silicizzazione che avevano giàinteressato, ai primi dell’Ottocento, il parroco di Morbello, SebastianoStella: secondo una sua nota, al Monte Acuto si trovano quarzo ecalcedonio in grande quantità, grossi filoni di piriti e marcasiti, oltreche di amianto; vi si troverebbe anche una antica galleria scavata nello“scisto serpentino”. CHABROL DE VOLVIC (1824), basandosi sulle informazioniricevute dal parroco, scrive, tradotto dal francese, che al Monte Acuto,“…la serpentina è attraversata da parecchi filoni di quarzo con geodi tappezzate di piccoli cristallicon strano aspetto. Il resto della massa è calcedonio…in filoni che contengono frammenti di piritee di serpentina in decomposizione…Discendendo l’Erro, ad un miglio di distanza dal monte Acutosi vede una specie di galleria scavata nella serpentina: si dice che sia molto profonda”; cidice, ancora, che la base del monte di Malvicino è formata da rocciaserpentinosa e che il torrente adiacente è aurifero
Brecce serpentinitiche silicizzate affiorano estesamente ai duelati del Roboaro, sotto il Monte Acuto: se ne trovano massi di discretedimensioni nel torrente e se ne vedono affiorare sui versanti del monte edel dirimpettaio colle sopra “i Gelati”. In entrambi i casi sono ricopertida sedimenti terziari che, in alcuni punti sono stati interessati dasilicizzazione. Discreti affioramenti si trovano anche, dall’altra partedell’Erro, al Monte Rosso, non lontano da Cimaferle.
Oltre il colle de “i Gelati”, estesi affioramenti sono messi invista dalle due incisioni torrentizie, parallele e ravvicinate, condirezione SW-NE, che confluiscono nell’Erro a sud dell’abitato di Foi.Il torrente più settentrionale si sviluppa lunga una faglia che mette incontatto le serpentiniti silicizzate con rocce cloritiche e micascistosericche di vene carbonatiche, che contengono diffusa presenza di pirite.In questa zona si trovava, secondo vecchi abitanti di Foi, una anticagalleria (certamente quella segnalata dagli autori suddetti), distruttanel corso della costruzione della strada. Gli stessi abitanti raccontanodi grossi scavi, per ricerche aurifere, eseguiti nelle alluvionidell’Elvo poco a monte, in corrispondenza della confluenza dei riiprovenienti dal Pian Gra (adiacente al Monte Rosso).
Nel versante destro del T. Belbicino, a nord-est di Malvicino,affiorano ancora brecce serpentinitiche silicizzate che sono stateoggetto di raccolta collezionistica per la presenza di quarzo in “…tappetidi cristalli molto lucenti, talvolta limpidi, di dimensioni massime sul centimetro. Il colore varia dalatteo a rosato e, in taluni litoclasi, è nettamente ametista”. Vi sono inoltre statiriconosciuti calcedonio, “…in belle forme coralloidi, stallattitiche o, più raramente,mammellonari”, pirite “…in piccoli e rari noduli alterati inclusi nel calcedonio”,bissolite “…in aghetti di colore verde che riempiono alcune piccole cavità del quarzo”, e
rutilo “…in millimetrici cristalli aciculari, bruni o rossicci, inclusi in ciuffetti entro cristalli diquarzo” (BALDIZZONE 1980).
Dalle silicizzazioni della zona M. Acuto-Malvicino traggono originele alluvioni aurifere del basso corso dell’Erro, oggetto di passataraccolta. In generale, l’oro è presente sotto forma di piccole e sottiliscagliette, difficilmente superiori al millimetro, raramente ingranuletti: in un campione raccolto a circa 5 metri di profondità, allabase di dun paleoalveo, furono trovati due granuletti di circa 4millimetri che, alle analisi, evidenziarono composizione pari a 837millesimi d’oro, 102 d’argento: le scagliette più piccole e sottilihanno, invece, titolo di poco superiore a 900 millesimi, con meno del 10%di argento e tracce di rame. L’oro è sempre accompagnato da magnetite ealtri minerali pesanti: la,prima, in particolare, può superare il 20-30%delle sabbie ricche, alle quali conferisce il colore nero (PIPINO 1984).
Da mineralizzazioni presenti nel versante occidentale del colle diMalvicino, afferente alla valle Bormida, proviene, con ogni probabilità,il ciottolo aurifero trovato nel 1905 durante lavori agricoli presso lastazione di Montechiaro Denice, che aveva fatto gridare alla scoperta diuna importante miniera: si trattava, in realtà, di un unico ciottolo diquarzo, di 2-3 chili, immerso in uno strato di argilla ghiaiosa aprofondità di 7-8 metri, dal quale un orefice di Acqui ricavò alcunigrammi d’oro.
* * * * *
Le sabbie dell’Erro sono notoriamente aurifere e sono stateoggetto di antica attività di “pesca”. Non è comunque vero, comevorrebbe qualche autore, che il torrente sia già riportasto tra ifiumi auriferi oggetto di raccolta nell’alto medioevo, mentreinvece vi è segnalata la Bormida, che riceve il suo oro dall’Erroe, poi, dall’Orba, anche questa segnalata (PIPINO 1982) . Lapresenza di oro nelle sabbie dell’Erro è genericamente ricordatada NICOLIS de ROBILANT (1786), BALBO (1786), CHABROL de VOLVIC(1824), BARELLI (1835) e JERVIS (1874).
Con decreto del 5 ottobre 1940, Barabino & Basaluzzo,ottennero un ampio permesso per cercare minerali di ferro,manganese, titanio e oro nel torrente Erro e, costituita la“Società Industriale della Valle dell’Erro”, lo prorogarono piùvolte, fino al 1951. Il permesso si estendeva per 25 chilometri,in vari comuni, partendo da 500 metri a monte del ponte diMioglia fino alla confluenza nella Bormida, e comprendeva,espressamente, anche i bassi corsi dei confluenti rii Gallareto,Miseria e Monte Rosso, a destra, Roboaro e Belbicino a sinistra.Nel contempo, Oreste Pronzato cercava oro alluvionale, ferro eargento nella Bormida, nei comuni di Rivalta, Strevi, Morsasco e
Acqui. Non si hanno particolari sulle rese, ma, d’altra parte, ipermessi erano collaterali all’estrazione della sabbia, ed èquesta che interessava veramente e che ha poi continuato asopravvivere, fino ad oggi.
Nel 1980 la Cominco Italia, con la mia collaborazione, chiesee ottenne i permessi di ricerca, per oro e minerali associati ,“Monte Rosso”, “Erro-Foi”, “Cartosio”, “Arzello” e “Quartino”,lungo l’Erro, oltre ai permessi “Orsara” e “Visone” lungo iltorrente omonimo. Due dei permessi coprivano gli interessantigiacimenti primari del Monte Rosso e della costa di fronteall’abitato di Foi, ma fu deciso di dedicarsi esclusivamente aidepositi alluvionali: indagini geofisiche e raccolta di campioniin profondità misero in luce un interessante antico “paleo-canale”ricco di magnetite, e su questo fu focalizzata la ricerca.Campioni rappresentativi furono estratti in alcuni punti, lungo ilpaleo-canale, e il materiale raccolto portato nella cava di sabbiadi Cartosio, dove fu installato un impianto pilota, costruito sumio disegno, cosa che fece parlare molto i giornali del tempo (IlSecolo XIX, 15 genn. 1983, etc.). I tenori d’oro riscontrati (da0,2 a 1 gr/T) furono ritenuto troppo bassi, in rapporto ai prezzidel tempo, e le ricerche furono abbandonate.
Sassello
Le silicizzazioni di Sassello si trovano ad ovest del paese,all’interno dell’area protetta “Foresta Demaniale Deiva”, oggiparte del Parco Naturale del Beigua.
Un esteso filone di quarzo e calcedonio, localmente arrossato,è contenuto, in una faglia verticale NO-SE che interessaserpentiniti laminate: parte dal greto del Rio del Giovo, qualchediecina di metri a monte del ponte-ingresso alla ForestaDemaniale, e si perde, una cinquantina di metri più in alto, sottola superficie di scorrimento delle ultramafiti che costituiscono ipicchi orientali del Bric Rocche Turchine; è raggiungibile, nellaparte più alta da uno dei primi tornanti della strada che sale indirezione del Palazzo Bignati (o Castello Bellavista). Le analisichimiche eseguite dalla COMINCO, su campioni da me raccolti lungoil filone hanno evidenziato contenuti d’oro fino a 2 gr/T.
Venuzze di quarzo si vedono di tanto in tanto affiorare, nellaserpentinite, lungo la strada per Palazzo Bignati, in particolare in corrispondenza del piccoloedificio quotato 383. Subito dopo affiora una lente dicloritoscisti laminati che passa a serpentinoscisti. La parte
basale delle sovrastanti ultramafiti dei bricchi Rocche Turchine eGiumenta è molto fratturata e, talora, visibilmente cementata davene silicee e/o carbonatiche, oltre che da minerali secondari dirame. Quarzo e calcedonio, in massi sciolti, si trovano anchelungo tutto il versante orientale, alto, del Bric di Salmaceto, apartire dalla sede stradale che lo taglia: l’aspetto del materialeè prevalentemente calcedonioso e rassomiglia molto a quello che, aOrtiglieto e in Val Gorzente, si trova nella zona di contattoorizzontale della massa ultramafica Erro-Tobbio su serpentiniti,e, infatti, sembra far parte di estese bancate sub-paralleleconcordanti con la superfice di scorrimento, oggi poco visibili acausa dello sconvolgimento provocato dalle ricerche minerarie edelle opere di ri-foretazione. Le analisi chimiche eseguite dallaCOMINCO, su campioni da me raccolti, hanno confermato larassomiglianza anche dal punto di vista del bassissimo contenutoaurifero (max 100 ppb).
Tracce d’oro, come accennato, si trovano anche nellemineralizzazioni cuprifere che interessano le serpentiniti, specielungo il contatto tettonico verticale NNE-SSW con calcescisti eprasiniti, nel quale scorre parte del Rio Bonuzzo, e che sonostate oggetto di intensa ricerca per tutto l’Ottocento. NelGiovo, a valle delle manifestazioni, e in altri torrenti dellazona, è da tempo segnalata la presenza di oro. CASALIS (1849), inparticolare, afferma: “…Nei torrenti sassellesi si trovano pagliuzze d’oro, le qualiprovengono forse dalle roccie ofiolitiche che stanno a scirocco di Sassello”.
Mioglia e Pontinvrea Lungo il torrente Orba, fra Pontinvrea e Mioglia, affiorano
localmente serpentiniti silicizzate ed è piuttosto diffusa,nell’alveo del torrente, la presenza di ciottoli con venecalcedoniose. In una relazione del 1810 l’arciprete SebastianoStella segnala “ …topazi falsi nel ritano aurifero la Pettra”: il torrente, checonfluisce nell’Erro, attraversa serpentiniti localmentesilicizzate e, in effetti, nelle sue sabbie sono presenti quarzileggermente citrini e tracce d’oro.
Vene di quarzo e calcedonio si notano, sporadicamente, anchenelle serpentiniti affioranti nei dintorni di Pontinvrea. Tuttal’area è intensamente tettonizzata, con formazione di potentifiloni di serpentinite milonitica impregnata da ossidi di ferro e,talora, da carbonati di rame. Nella citata relazione, SebastianoStella segnala la presenza di “…cristalli di quarzo” e di “..due filoni dipirite marcasite” nel ritano di Castel Delfino e vicinanze: del castello,medievale, restano pochi ruderi, a destra della strada che daiGiovi porta a Pontinvrea, indicati in carta come “il Castello”. Per
CHABROL de VOLVIC (1824) le vene di quarzo interessano “..uno scistolucente” sottostante il calcare compatto che ricopre la serpentinaed è interessato, nel vicino Rio Bertola, da due scavi.
Vene di silice, nelle serpentiniti, si vedono anche nel tagliodella strada provinciale, sotto la collina del castello, e ancordi più nelle cavette di pietrisco che si trovano ai due lati dellastrada poco prima di Pontinvrea, in località Pian di Ciliegia,dove sono piuttosto comuni le vene di calcedonio, anche di coloreametistino. Serpentinite con vene silicee affiorano di tanto intanto lungo la strada che, dalla località precedente si dirige aMontenotte e, nella località Pian dei Buschi, è interessata da altrapiccola cava di pietrisco: anche qui la silice assume taloracolorazione ametistina e in, alcune geodi, assieme al quarzo sitrovano aghetti di ghoetite.
In località Rocca di Premalò, ai primi del Novecento furonoestratte discrete quantità di materiale limonitico (ocra),derivato dall’alterazione della magnetite contenuta inserpentinite alterata: al Monte Balocco il contenuto di magnetiteraggiungeva il 20%.
Le prospezioni effettuate nell’Erro, appena a valle del paese,hanno confermata la presenza di oro, quantunque assai scarso.
Stella
Alle sorgenti del torrente Sansobbia, nelle vicinanze degliabitati di Stella, è nota la presenza di ofisilici e diserpentiniti sicilizzate. Già l’arciprete Stella segnalava lapresenza di quarzo e calcedonio, con amianto, nel Rio Gajanipresso Stella San Martino, oltre a “…oro nativo piuttosto abbondante”nella Sansobbia in territorio di Stella San Giovanni Battista.ISSEL (1892) parla di silicizzazioni a Corona, di calcedonio sullesponde della Sansobbia presso Santa Giustina, esattamente difronte alla Cappella del Salto e del Passo del Bonomo, e di piritiaurifere a Stella.
Serpentiniti con vene calcedonio, dolomite e quarzo affioranoestesamente lungo la strada da Gameragna a Brasi e, da questelocalità, lungo la strada per Stella San Martino: la serpentinite,in questo caso, è poco alterata e le manifestazioni, a secondadella natura prevalente delle vene, possono essere considerateofisilici oppure oficalciti.
BIBLIOGRAFIA CITATA
BALBE (A. Balbo). Mémoire sur le sable aurifère de l’Orco et des environs. “Mem. R. Acc.Sc. Torino”, 1786 (2).BALDIZZONE G. Quarzo ametista del T. Erro (Alessandria). “Rivista MineralogicaItaliana”, 1980 n. 2.BALDRACCO C. Nozioni intorno a parecchi filoni auriferi di recente scoperti negli Appenniniliguri. “Atti I Riun. Scienz. It. Pisa 1839”. Tip. Nistri, Pisa 1840.BARELLI V. Cenni di Statistica mineralogica degli Stati di S.M. il re di Sardegna, ovveroCatalogo Ragionato della raccolta formatasi presso l’azienda generale dell’ Interno. Tip. G.Fodratti, Torino 1835. BERTOLOTTI Davide. Miniere, cave, fonti medicinali. “Viaggio nella Liguriamarittima”, Tip. Eredi Botta, Torino 1834, Vol. 3°, pp. 245-262(fotocopia).BOYLE R.W. The geochemistry of gold and its deposits (together with a chapter on geochemicalprospecting for the element). Geological Survey, Bulletin 280, Ottawa 1979. Pp.584.BUISSON G., LEBLANC M. Gold-bearing listwaenites (carbonatized ultramafic rocks) fromophiolite complexes. “Metallogeny of basic and ultrabasic rocks”, IMM, Londras.d. (1986).CASALIS G. Dizionario Geografico Storico-Statistico-Commerciale degli Stati di S. M. il Re diSardegna, Vol. XIX. Maspero Libraio, Torino 1849.CHABROL DE VOLVIC F. Statistique des Provinces de Savone, d’Oneille, d’Acqui et d’une partiede la Province de Mondovi, formant l’ancient Département de Montenotte. Vol. I. L. DidotAiné, Paris 1824CHIESA S. et. Al. Assetto strutturale ed interpretazione geodinamica del Gruppo di Voltri.“Boll. Soc. Geol. It.”, 94, 1975.
CONTI S. Valli in serpentiniti della Liguria. 1a contribuzione. “Boll. Soc. Geol. It.”,LX, 1941 n. 1.
CORTESOGNO L., LUCCHETTI G., PENCO A.M. Associazioni a zeoliti nel “Gruppo di Voltri”:caratteristiche mineralogiche e significato genetico. “Rend. SIMP.”, XXXI, 1975 n. 2.CORTESOGNO L., LUCCHETTI G., PENCO A.M. Mineralogia e minerogenesi di associazionia tobermorite, zeoliti e smectiti nel settore nord-orientale del “Gruppo di Voltri. “Per. Min.”,45, 1976, n. 1-3, DE MICHELE V., PIPINO G. Apatite del Monte Sciguello (Savona). “Riv. Min. It.”,1983 n. 4,GAZZI P. Serpentiniti ed idrotermaliti a prevalenti carbonati nelle alte valli dell’Idice e delSillaro (nota preliminare). “Rend. SMI”, XII, 1956.ISSEL A. Liguria Geologica e Preistorica. Vol. II. A. Donath Ed., Genova 1892.
JERVIS G. I tesori sotterranei dell’ Italia P. II. Regione dell’Appennino e vulcani attivi espenti. E. Loescher, Torino 1874.
NICOLIS DE ROBILANT. Essai geographique suivi d’une topographie souterraine,minéralogique, et d’une docimasie des États de S.M. en terre ferme. «Mem. Ac. R. Sc.»,années MDCCLXXXIV-LXXXV, Torino 1786. PARETO L. Cenni geologici sulla Liguria marittima. Tip. Ferrando, Genova 1846. PIPINO G. I giacimenti auriferi dei Laghi di Lavagnina nel Gruppo di Voltri orientale. Tesidi Laurea, Univ. Milano, anno acc. 1974-75, pp.58, 1 carta geol. e num.ill. f.t.PIPINO G. Relazione sulla ricerca di antiche coltivazioni aurifere nell’area del Gruppo di Voltri(escluse quelle già studiate nella tesi di Laurea). Eseguita per conto CNR, unità per lo studio deigiacimenti minerari del bacino alpino-padano. Istituto di Mineralogia, Petrografia e Geochimica,Cattedra di Giacimenti Minerari, Università di Milano. Marzo 1976. Dattiloscritto, pp.20, n. 11 carte f.t.
PIPINO G. Alcune considerazioni sulle vene metallifere del territorio di Genova citate in undocumento del 1465. “Not. Gr. Min. Lomb.”, 1976 n. 2.
PIPINO G. Le manifestazioni aurifere del Gruppo di Voltri con particolare riguardo ai giacimentidella Val Gorzente. “L’Industria Mineraria”, XXVII, 1976.PIPINO G. Le ligniti metallifere dell’Appennino ligure-piemontese e il loro sfruttamento.“L’Industria Mineraria”, XXIX, 1978.
PIPINO G. Oro ed altri minerali dell’Acquese (Alessandria). “Riv. Min. It.”, 1980 n.1.PIPINO G. Gold in Ligurian ophiolites (Italy). “Prooc. Intern. Ophiol. Symposium,Cyprus 1979”, Cipro 1980.PIPINO G. Le sorgenti solfuree del Gruppo di Voltri (Appennino ligure-piemontese).“NATURA”, LXXII, 1981 n. 3-4. PIPINO G. Sulla possibilità di recuperare oro ed altri minerali dalle sabbie prodotte in ValPadana. “Quarry and Construction”, 1984.
PIPINO G. Granatiti e rodingiti. “Riv. Min. It.”, 1981 n. 4.PIPINO G. I giacimenti metalliferi del Piemonte Genovese. Tip. Viscardi, Alessandria1982.PIPINO G. L’oro della Val Padana. “Boll. Ass. Min. Sub.” XIX, 1982 n. 1-2.
PIPINO G. Oro ed altri metalli nelle granatiti. “Riv. Min. It.”, 1985 n. 4.PIPINO G. Le manifestazioni piritoso-cuprifere di Ortiglieto e Marciazza in Val d’Orba.“L’Industria Mineraria”. 1985 n. 4.PIPINO G. Mineralizzazioni nei complessi ofiolitici della Ligura occidentale (Zona Sestri-Voltaggioe Gruppo di Voltri). “L’Industria Mineraria”, XXXVII, 1986 n. 2.ROLANDI V. I giacimenti di Molini, M. Ramazzo e Sassello nel Gruppo di Voltri (Liguriaoccidentale). Tesi di Laurea, Ist. Min., Petr., Geoch., Univ. Milano. A.A.1973-74.
ROSE G. Mineralogisch-geognostiche Reise nach dem Ural, dem Altai and dem KaspischenMeere. Ver. Sanderschen Buchhandlung, C.W. Eichhoff, Berlin. Vol. I 1837,Vol. II 1842.ROVERETO G. La serie degli scisti e delle serpentine antichi in Liguria. I. “Atti Soc.Lig. Sc. Nat. Geogr.” 2, 1891.ROVERETO G. Liguria Geologica. “Mem. Soc. Geol. It., 2, 1939.TEKNOGEO S.n.c. Giacimenti auriferi e cupriferi primari esplorati nell’Appennino Ligure-Piemontese. Dattiloscritto, ottobre 1980.