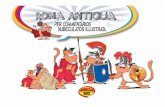La valtellina tra tarda antichità e altomedioevo: i piccoli oggetti
M. MUNZI, S. ZEGGIO (a cura), 312 d.C. Un ponte tra antichità e medioevo. La Roma di Massenzio e...
-
Upload
sovraintendenzaroma -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of M. MUNZI, S. ZEGGIO (a cura), 312 d.C. Un ponte tra antichità e medioevo. La Roma di Massenzio e...
7
SOMMARIO
Genealogia di Costantino e Massenzio(M. Munzi/S. Zeggio) 8
Massenzio. Il conservatore (M. Munzi) 11La Roma di Massenzio (M. Munzi) 171. La Basilica di Massenzio (S. Le Pera) 212. Il “Tempio di Romolo” sulla via Sacra (S. Le Pera) 243. Il Tempio di Venere e Roma (S. Zeggio) 264. Il Colosso del Sole e laMeta Sudans (S. Zeggio) 285. Le Terme massenziane sul Palatino (S. Le Pera) 306. La cinta tardo-antica di Roma e il Museo delle Mura(A. Ceccherelli) 32
7. La Villa di Massenzio e il Mausoleo diRomolo sulla via Appia (C. Camardo) 34
28 ottobre 312. La battaglia di Ponte Milvio (S. Zeggio) 398. L’Arco di Malborghetto: il sogno (S. Zeggio) 449. L’area dei Saxa Rubra: lo scontro (S. Zeggio) 46
10. Il Ponte Milvio: la vittoria (A. Gallitto) 4811. Le insegne imperiali del Palatino: il potere (S. Zeggio) 50
6
Costantino. La nascita di una nuova era (M. Pentiricci) 53La città di Costantino (M. Pentiricci) 5912. Le Terme di Costantino (E. Ronchetti) 6413. L’Arco di Costantino (S. Zeggio) 6614. L’Arco “di Giano” al Foro Boario (G. Schingo) 7015. La Basilica di S. Pietro (M.P. Del Moro) 7216. La Basilica di S. Giovanni in Laterano(S. Serra) 7417. La Basilica di S. Paolo fuori le Mura (M. Marcelli) 7618. La Basilica di S. Croce in Gerusalemme e
il palazzo imperiale del Sessorio (S. Serra) 7819. La Basilica di S. Agnese e il Mausoleo di
S. Costanza (L. Asor Rosa) 8220. La Basilica di S. Lorenzo fuori le Mura (S. Serra) 8621. La Basilica e il Mausoleo nella Villa dei Gordiani
(A. Ceccherelli) 8822. La Basilica dei SS. Marcellino e Pietro e
il Mausoleo di Elena (Torpignattara) (M.P. Del Moro) 9223. La Basilica Apostolorum nell’area delle catacombe
di S. Sebastiano (M. Marcelli) 9624. I ritratti di costantiniano nei Musei Capitolini (F. Ceci) 9825. Itinerario costantiniano nel Museo della Civiltà Romana
(C. D’Amato/L. Ungaro) 102
Mappe (S. Zeggio) 106Le fonti della storia (S. Zeggio) 116Per saperne di più 118
27
na. Il tempio era circonda-to da un colonnato di mar-mo in stile corinzio (10 x 22colonne); la terrazza era de-limitata da un doppio co-lonnato di granito sui latilunghi e aperta con scalina-te di marmo, sia verso la viaSacra che verso il Colosseo.
L’aspetto attuale si devealla ricostruzione voluta da Massenzio nel 307,dopo un incendio, anche se di recente sono stateindividuate piccole modifiche attribuite aCostantino. Le celle (meglio conservata quella diRoma) erano coperte da volte a botte a cassettoni;l’interno, scandito da due file di colonne di porfidoaddossate ai lati lunghi, è arricchito da nicchie perstatue inquadrate da colonnine su mensole; sul latodi fondo l’abside, in cui era la statua della dea introno, è preceduta da due colonne e conserva ilcatino decorato in stucco a rete di rombi. Trionfanoi colori: il rosso del porfido delle colonne e delpavimento a disegni geometrici, il bianco delmarmo di basi, mensole, capitelli e pavimento, l’orodegli stucchi delle volte.
Nel 625 inizia la rovina: papa Onorio I toglie letegole di bronzo del tetto per utilizzarle nellabasilica di San Pietro. Nell’847 parte del tempioviene inglobata nella chiesa di S. Maria Nova (dal1615 S. Francesca Romana), voluta da papa LeoneIV, dotata di un convento, orti e giardini.
26
INDIRIZZO: area archeologica del ForoRomano e Palatino (accessi da largodella Salara Vecchia, snc e da viadi S. Gregorio, 30).
ORARIO: tutti i giorni dalle ore 8,30al tramonto.
COME ARRIVARE: bus 60, 75, 84, 85,87, 117, 175, 186, 271, 571, 810, 850- metro B fermata Colosseo.
L. Rossini, Veduta del Tempiodi Venere e Roma, 1827.
3. IL TEMPIO DI VENERE E ROMA
Il più grande tempio di Roma antica (m 145 x 100) fu ini-ziato nel 121 (e forse progettato personalmente) da Adria-no sull’enorme terrazza artificiale realizzata da Nerone sullaVelia per l’atrio della Domus Aurea, previo spostamento delColosso. Venne inaugurato incompleto nel 135 e ultimatonel 140 da Antonino Pio. Era dedicato a due divinità, cuicorrispondevano due celle opposte, unite sul lato di fondoe aperte con quattro colonne sulla fronte: una verso il Co-losseo per Venere Felice, l’altra verso il Foro per Roma Eter-
29
no in vista le fondazioni della Meta Sudans, la più grandefontana di Roma, costruita da Domiziano a ricordo di quel-la, più piccola, voluta da Augusto nel punto di incontro dialcuni quartieri urbani (regiones). Al centro di una bassa va-sca circolare larga quasi 16 metri svettava una cuspide in la-terizio rivestito di marmo di oltre 17 metri, da cui zampillaval’acqua. Nel quadro della generale ristrutturazione massen-ziana anche laMeta Sudans fu restaurata e circondata da unmuretto rifinito in marmo e dotato di un piccolo tombino,che doveva contenere leeventuali fuoriuscite dellavasca.
Dopo che negli anni1933-1936 i loro resti fu-rono rasi al suolo, dei duemonumenti restano solo la-bili tracce.
28
4. IL COLOSSO DI NERONE E LA META SUDANS
Il Colosso in bronzo di Nerone, dello scultore Zenodoro, siergeva in origine coi suoi quasi 35 metri nell’atrio della Do-mus Aurea sullaVelia; danneggiato dall’incendio del 64, fu tra-sformato daVespasiano in statua del dio Sole.QuandoAdrianoedificò il Tempio di Venere e Roma, fu spostato presso l’An-fiteatro Flavio (da qui il nome Colosseo) e issato su un altissi-mo basamento. Commodo lo trasformò in un suo ritratto investe di Ercole, ma alla sua morte tornò a rappresentare il So-le. Nell’ambito del rinnovamento monumentale operato daMassenzio, che ha fatto attribuire all’area compresa fra il “Tem-pio di Romolo” e il Colosseo la suggestiva definizione di “Fo-ro di Massenzio”, il Colosso fu probabilmente modificato ededicato al figlio Romolo, morto prematuramente. Di recen-te è stato infine ipotizzato che i tre elementi di statua colossa-le bronzea dei Musei Capitolini appartengano ad un’ultimamodifica del monumento, con le sembianze di Costantino.Dopo la citazione del Cronografo del 354 della statua si per-dono le tracce e il basamentoè oggi sostituito da un’aiuolarettangolare.
Più a sud, all’inizio dellavia diretta al Foro, rimango-
INDIRIZZO: piazza del Colosseo.ORARIO: sempre aperto.COME ARRIVARE: bus 60, 75, 84,
85, 87, 117, 175, 186, 271,571, 810, 850 - metro Bfermata Colosseo.
E.G. Coquart,Tempio di Venere e Roma.Prospetto verso il Colosseo:restituzione, Roma 1863.
39
28 ottobre 312La battaglia di Ponte Milvio
«La battaglia del ponte Milvio… è uno di quegli eventiinevitabilmente destinati ad assumere un’importanza
epocale» (A.Marcone). In un Impero ormai frazionato in bloc-chi contrapposti lo scontro fra il figlio diCostanzoCloro e quel-lo diMassimiano pone fine al sogno tetrarchico diDiocleziano.Il sistema di governo ideale, complesso quanto effimero, basa-to sulla concordia e sulla capacità (soprattuttomilitare) dei sin-goli Augusti e Cesari, non regge alle pressioni dinastichedell’intricata trama di parentele creata dagli stessi tetrarchi.
Alla morte di Diocleziano (dicembre 311) in Oriente sifronteggiano Massimino Daia e Licinio. Un accordo in extre-mis scongiura il conflitto, ricostituendo una parvenza di colle-gialità imperiale: Massimino conserva il governo delle areedall’Asia Minore all’Egitto, Licinio quello dei Balcani e dell’Il-lirico. In Occidente la partita è invece fra Costantino e Mas-senzio. Il figlio di Costanzo governaGallia, Spagna e Britannia;ha dalla sua le truppe del padre (che allamorte di questi lo ave-vano acclamato imperatore), il titolo legittimo di Cesare, no-tevole esperienzamilitare e, a dar retta a fonti spesso adulatorie,viva intelligenza e capacità di farsi benvolere. Massenzio è in-vece insediato nel cuore antico dell’Impero, in Italia e Africa;contrariamente al rivale non è militare di professione e, in-
41
di regno, mentre l’avversario si accampa lungo la via Flami-nia, nell’area oggi detta Malborghetto (8). La tattica vorreb-be un lungo assedio: Massenzio al sicuro nella città fortificata,con abbondanti rifornimenti e il Ponte Milvio (10) in parteabbattuto per precauzione. Inspiegabilmente, però, all’albadel 28 ottobre, messi al sicuro moglie e figlio «in una casa pri-vata» (la villa sull’Appia?) e fatte forse nascondere le proprieinsegne di comando (11), Massenzio esce incontro all’avver-sario, attraversando il Tevere su un provvisorio ponte di le-gno. Ha una cieca fiducia nella profezia dei Libri Sibillini:quel giorno «il nemico di Roma vedrà la morte».
Ma anche Costantino è guidato da un’ispirazione divina
40
spiegabilmente considerato che è figlio di Massimiano e gene-ro di Galerio, non è riuscito a far legittimare la sua acclama-zione a imperatore. Quando Costantino dà in sposa a Liciniola sorella Costanza, accettando e insieme condividendo così lacollegialità imperiale, Massenzio resta l’unico usurpatore.
Nel 312 la guerra scoppia inevitabile. Costantino entrarapidamente in Italia con forze limitate (circa 30.000 uomi-ni) ma motivate, conquista Torino e Verona e scende semprepiù a sud. Massenzio ha forse truppe più cospicue (sono pe-rò di certo eccessivi gli oltre 180.000 uomini indicati da Zo-simo), ma preferisce l’attesa, che lo ha premiato in passato.Resta chiuso in Roma sino alla vigilia del sesto anniversario
Giulio Romano, Apparizione della Croce, 1525 circa. Città delVaticano, Palazzo apostolico, Stanza di Costantino (Foto Anderson).
Piero della Francesca, La Battaglia di Ponte Milvio (particolare),1452-1459. Arezzo, Chiesa di San Francesco.
43
pe corazzate in fuga e crolla. Molti annegano trascinati dal-la corrente e tra questi Massenzio. Il Panegirico del 313 dàuna visione truculenta della fine del «parricida di Roma»:neppure il Tevere lo vuole e ne “rigetta” il cadavere (eructa-to cadavere), che viene vilipeso (trucidato).
Il giorno successivo Costantino entra trionfalmente a Ro-ma, mentre la testa del figlio di Massimiano, estremo «pro-tettore della sua città» (conservator urbis suae) è portata suuna lancia per le vie. Cambiano prospettive e percorsi dellastoria. A breve Roma non sarà più la capitale dell’Impero.
42
(instinctu divinitatis recita l’iscrizione sull’arco in piazza delColosseo). Il giorno precedente ha avuto una visione, cheracconta egli stesso, ma di cui abbiamo versioni diverse. Se-condo Eusebio Costantino sta meditando, quando, guar-dando verso il sole (il Sol Invictus da lui venerato), vede raggidi luce formare una croce e sotto di essa la frase greca «conquesto vinci» (reso in latino in hoc signo vinces). Perplesso,nella notte sogna Cristo che gli ingiunge di usare il segnodella croce come difesa dai suoi nemici e subito al mattinochiede ai suoi orafi di realizzare quel simbolo. Per Lattanzio,invece, «Costantino fu esortato nel sonno a segnare gli scu-di dei soldati col segno celeste e a cominciare la battaglia»;all’alba fa quindi dipingere il simbolo composto dalle primedue lettere greche del nome di Cristo, X (chi) e P (ro), det-to appunto chi-ro, o “monogramma costantiniano”. Secon-do le fonti farebbe anche sostituire il vessillo imperiale diporpora con il labaro ceruleo (azzurro cielo) fregiato del chi-ro; il labaro appare però sulle monete solo nel 327.
La battaglia inizia nell’area dei Saxa Rubra (9). Costan-tino, comandante esperto, si espone di persona e conduceall’attacco i suoi (truppe tratte dai confini settentrionali conelementi celtici, britannici e germanici), nella foga il labarogli cade momentaneamente di mano. Le truppe massenzia-ne (soprattutto Italici e Africani, secondo Zosimo), sorpre-se, si sbandano e arretrano progressivamente verso la città eil Tevere; sotto la spinta della cavalleria costantiniana la riti-rata diviene fuga disordinata. Solo la guardia pretoriana re-siste in difesa del ponte, unica via di salvezza; accerchiata,combatte la sua battaglia fino all’ultimo uomo: non sarà piùricostituita. Di grande impatto la scena raffigurata sull’Arcodi Costantino: il ponte di legno non regge il peso delle trup-
A. Vecchio, la battaglia di ponte Milvio. Medaglia commemorativadi Roma Capitale per il Natale di Roma 2012, rovescio.
45
che avesse coppie di colonnecorinzie sui lati della Flaminiae lesene su quelli della via tra-versa. Agli inizi del Novecen-to fu ipotizzato che, vista ladatazione e la collocazione ex-traurbana, l’arco fosse statoedificato per celebrare la vit-toria di Costantino su Mas-senzio nel luogo in cuil’imperatore, scendendo verso Roma, aveva posto il suo ac-
campamento e dove, al tramonto delgiorno precedente la battaglia, aveva avu-to la celebre visione della croce.
L’arco ha subito nei secoli notevolitrasformazioni, sia di funzione che distruttura. Agli inizi del XII secolo, chiu-si tre dei quattro fornici, diventa chiesafortificata con torre e coronamentomer-lato, mentre nel XIII viene inserito nel-la cinta muraria di un borgo fortificato(Burgus Sancti Nicolai de ArcuVirginis).Difeso dalle truppe dei Colonna, fede-li allo Stato Pontificio, nel 1485 è se-midistrutto dai loro acerrimi nemici, gliOrsini, alleati dei Sacrofanesi. Caratte-rizzata dalle rovine del borgo, l’area pren-de così nel tempo il nome diMalborghetto o Borghettaccio, mentrel’arco è trasformato in casale e poi in sta-zione di posta.
44
INDIRIZZO:via di Malborghetto, 1.
ORARIO: lunedì, mercoledì, giovedìe venerdì ore 9,00 - 13,00;sabato ore 15,00 - 18,00;domenica e festivi ore9,00 - 13,00 e 14.30 - 18.30.Martedì chiuso.
COME ARRIVARE: ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo,fermata Sacrofano.
8. L’ARCO DI MALBORGHETTO: IL SOGNO
Al km 19,300 della via Flaminia si staglia (a destra per chi esceda Roma) il massiccio Casale diMalborghetto, che ingloba unarco quadrifronte di IV secolo, posto all’incrocio della conso-lare con una via di collegamento tra Veio e il Tevere. Circon-dato in origine da un piazzale basolato, l’arco ha piantarettangolare ed è costruito in laterizio, tranne basi dei piloni eimposte degli archi, realizzate in travertino. In origine era co-ronato da un attico a copertura piana e i resti della decorazio-ne architettonica inmarmo recuperati nel tempo, fanno pensare
F. de Moucheron,Tour en ruine
proche de Rome,1659.
tamente conservati e splendide ville suburbane, fra cui quel-la dell’imperatrice Livia, moglie di Augusto.
Alla memoria della battaglia si deve forse anche il topo-nimo Labaro (oggi popoloso quartiere al km 11 della Fla-minia), legato, secondo una leggenda tarda, al vessilloimperiale azzurro col monogramma cristiano (labarum), cheCostantino aveva fatto sostituire a quello tradizionale pa-gano (color porpora con la dea Vittoria o l’aquila di Giove)
e che gli sarebbe caduto dimano mentre si accingevaalla battaglia. È però pos-sibile che la parola sia cor-ruzione di Rubras,rimandando così, comeper i vicini toponimi Sa-xa Rubra e Grottarossa, alcolore del tufo.
Nel 1913, per il XVIcentenario dell’Editto di
Milano, papa Pio X fece apporre sulla pendice sovrastan-te l’attuale piazza di Saxa Rubra una grande lapide fregia-ta del chi-ro, che recita: «Costantino il Grande imperatore/ il 28 ottobre 312 a Saxa Rubra / avendodebellato Massenzio col favore delCielo / portò in Roma il laba-ro fregiato del nome insi-gne di Cristo / iniziandol’era più felice della sto-ria umana».
9. L’AREA DEI SAXA RUBRA: LO SCONTRO
L’area dei “sassi rossi”, dove secondo Aurelio Vittore scoppiòla battaglia finale fra Massenzio e Costantino, è situata sul-la riva destra del Tevere e prende nome dalle balze di tuforosso che la caratterizzano. Lo scontro dev’essersi svolto nel-la pianura prossima al fiume, con l’esercito vincitore che manmano avanzava verso Roma lungo la via Flaminia (più o me-no fra i km 12 e 8), ma dato lo spesso strato di limo depo-sitato nei secoli dalle piene del fiume (i livelli antichi si trovanooggi a 6/7 metri di profondità), non ne abbiamo alcuna te-stimonianza diretta. La zona è tuttavia carica di memorie ar-cheologiche, disseminate lungo la consolare e le numerosevie minori: mausolei, tombe rupestri, tratti stradali perfet-
INDIRIZZO: piazza di Saxa Rubra.
ORARIO: sempre aperto.COME ARRIVARE: bus 033, 035, 037,
303 - ferrovia Roma-Civita
Castellana-Viterbo, fermata
Prima Porta.
Rupe di Saxa Rubra. Lapide, commemorativa di papa Pio X per ilXVI centenario della vittoria di Costantino (Foto S. Zeggio).
46
conclusi dalla sua sconfitta emorte nella battaglia di PonteMilvio del 312. Solo un impe-ratore morto in Roma di mor-te violenta, infatti, avrebbeabbandonato le sue insegne, chealtrimenti lo avrebbero seguitofin sul rogo funebre.
50
11. LE INSEGNE IMPERIALI DAL PALATINO: IL POTERE
Nell’ottobre 2005, durante lo scavo di un seminterratoappartenente ad un santuario alle pendici del Palatino,al confine con la piazza del Colosseo, ricercatori del-l’Università di Roma “La Sapienza” si imbatterono in unascoperta eccezionale: in una buca nel pavimento di unsottoscala, forse in origine protetti in una borsa di cuo-io, furono rinvenuti i resti di tre scettri, tre lance da pa-rata e quattro sostegni da vessillo di due tipi diversi.Iniziato da Nerone dopo l’incendio del 64, completatodai Flavi con l’aggiunta di un tempietto, incredibilmen-te conservato tale e quale sino almeno agli inizi del V se-colo, e forse infine sostituito da una chiesa, questocomplesso rappresenta la ricostruzione di un luogo di cul-to ben più antico, bruciato proprio nel 64 e con tuttaprobabilità identificabile con le Curiae Veteres, secondola tradizione fondate addirittura da Romolo e simbolodell’unità civica dei Romani.
In questo quadro carico di memorie e simboli di pote-re, prima regio e poi imperiale, s’inserisce la fossa con leinsegne, eccezionali per preziosità dei materiali (vetro, pie-tra dura, bronzo dorato, ottone, seta, ecc.) e unicità del ri-trovamento. I reperti contenuti nella terra che le coprivaci permettono di datarle agli inizi del IV secolo, mentrel’insieme degli oggetti presenti ne fa un “corredo” impe-riale. Esso non doveva esser custodito molto lontano dalluogo in cui è stato ritrovato, e difatti il Palatino è la sedeimperiale. Per tutto ciò le insegne, ora esposte nel MuseoNazionale Romano di Palazzo Massimo, sono state colle-gate con Massenzio e il loro occultamento con gli eventi
INDIRIZZO: largo di Villa Peretti, 1.ORARIO: tutti i giorni,tranne il lunedì,ore 9,00 - 19,45.
COME ARRIVARE: bus H, 36, 38,40, 64, 86, 90, 92, 105,170, 175, 217, 310, 360,714, 910 – metro A e Bfermata Termini.
Insegne imperiali dalle pendici del Palatino. Da C. PANELLA (a curadi) I segni del Potere. Realtà e immaginario della sovranità nella Romaimperiale, Roma 2011, (rielaborato da S. Zeggio).
51
67
venerato da Costantino in Gallia e a lui affiancato nelle mo-nete.
L’arco (alto m 21, largo 25,70 e profondo 7,40) ha tre for-nici inquadrati da colonne corinzie su alti plinti; è in operaquadrata di marmo fino alla grande trabeazione che sostienele otto statue di prigionieri Daci, mentre l’attico è in lateri-zio rivestito di marmo. La maggioranza di elementi architet-tonici, rilievi e sculture è riutilizzata damonumenti più antichi:sono traianei i quattro frammenti del “Grande Fregio” posti
66
13. L’ARCO DI COSTANTINO
Nel punto in cui la via percorsa dai trionfi (oggi via di SanGregorio) sbocca nella piazza del Colosseo si trova il più gran-de arco onorario romano. Dedicato a Costantino dal Senatoil 25 luglio del 315, in occasione del decennale di regno, ce-lebra la vittoria su Massenzio. L’iscrizione posta sopra il for-nice centrale su entrambi i lati dell’attico è un capolavoro diambiguità politico-religiosa: «All’imperatore Cesare FlavioCostantino Massimo Pio Felice Augu-sto il Senato e il Popolo Romano dedi-carono questo arco insigne per trionfi,perché, per ispirazione della divinità egrandezza del suo spirito, con il suo eser-cito vendicò lo stato con giuste armi,contro il tiranno e tutta la sua fazione».Il “tiranno” è ovviamenteMassenzio,mavolutamente oscuri restano sia la divi-nità ispiratrice quanto i plurimi trionfi.Entrato vittorioso in Roma il 29 otto-bre 312, infatti, Costantino non sacri-ficò a Giove sul Campidoglio e noncelebrò un vero e proprio trionfo, né al-tri ne aveva celebrati in precedenza; se èinnegabile che le parole «per ispirazio-ne divina» (instinctu divinitatis) faccia-no pensare alla celebre visione della crocee al sogno di Cristo, ricordati da Lat-tanzio ed Eusebio, nella città pagana pereccellenza vi si poteva anche vedere ilSole (Sol invictus) del vicino Colosso,
Arco di Costantino eMeta Sudans,1912-1920. ICCD.
69
lonne e lesene, di pavonazzetto violaceo le statue, di lunensee proconnesio bianco e bluastro le pareti, di porfido rosso e(forse) serpentino verde i rivestimenti intorno ai tondi adria-nei e al fregio costantiniano.
Fin dal XVI secolo sottoposto a restauri, il monumentosubì nel 1733 consistenti integrazioni delle parti perdute. Inoccasione di un recente restauro è stata riproposta la teoriache si trattasse in realtà di un arco d’età adrianea, solo modi-ficato da Costantino. Se scavi e studi su tecnica costruttiva ecomposizione dei marmi fanno scartare questa ipotesi, nonsi può invece escludere che almeno le fondazioni siano mas-senziane: il complesso monumentale, comprendente l’areadal “Tempio di Romolo” al Colosso e allaMeta Sudans, avreb-be previsto anche un arco, forse a ricordo della vittoria afri-cana su Domizio Alessandro (311).
68
sui lati dell’attico e nel forni-ce centrale (nel quale Co-stantino è onorato quale«Liberatore della Città» e«Fondatore della Pace»); ri-salgono ad Adriano gli ottotondi con scene di caccia e sa-crificio, disposti a coppie sul-le due fronti dei fornici
minori; derivano da un arco di Marco Aurelio gli otto pan-nelli disposti a coppie sulle due fronti dell’attico, ai lati del-l’iscrizione. All’età costantiniana datano gli altri rilievi: le figuresu plinti, pennacchi dei fornici, chiavi degli archi; i due ton-di del Sole e della Luna sui lati; il fregio che si svolge tutt’in-torno al monumento, raffigurante la vittoriosa campagnad’Italia e l’ingresso a Roma. La scelta dei “pezzi” da riutiliz-zare tende a legittimare Costantino, ponendolo in linea dicontinuità con gli imperatori “giusti e saggi” per antonoma-sia (i volti imperiali furono rimodellati con le fattezze di Co-stantino) e indicandolo come pacificatore dell’Impero. Altracaratteristica distintiva era la policromia: di giallo antico co-
INDIRIZZO: piazza del Colosseo.ORARIO: sempre aperto.COME ARRIVARE: bus 60, 75, 84,85, 87, 117, 175, 186, 271,571, 810, 850 -metro B fermata Colosseo.
Arco di Costantino, lato sud, fregio costantiniano, battaglia di PonteMilvio. Da R. BIANCHI BANDINELLI, M. TORELLI, L’arte dell’antichitàclassica, Etruria-Roma, Torino 1976.
107106
Monumenti massenzianiMemorie della Battaglia di Ponte MilvioMonumenti costantinianiMusei
Legenda
8 Arco di Malborghetto9 Area dei Saxa Rubra
Mappa1
8
Mappa 1
Mappa 2
Mappa 3Mappa 4
Mappa 5 9
10 Ponte Milvio15 Basilica di S. Pietro19 Basilica di S. Agnese e Mausoleo di S. CostanzaA Musei Vaticani (sarcofagi di Elena - 22 - e Costantina - 19)B Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo(insegne imperiali - 11)
Mappa2
10
19
15
A
B
1 Basilica di Massenzio2 “Tempio di Romolo”3 Tempio di Venere e Roma4 Colosso di Nerone eMeta Sudans5 Terme massenziane11 Scavo delle insegne imperiali12 Terme di Costantino13 Arco di Costantino14 Arco “di Giano”16 Basilica di S. Giovanni in Laterano - Patriarchio24 Musei Capitolini (ritratti imperiali)
Mappa3
12
24
14
1
23
411
13
165
18 Basilica di S. Croce in Gerusalemme - Sessorio20 Basilica di S. Lorenzo fuori le Mura21 Basilica e Mausoleo nella Villa dei Gordiani22 Basilica dei SS. Marcellino e Pietro e
Mausoleo di Elena (Torpignattara)
Mappa4
20
18
21
22
6 Museo delle Mura di Roma7 Villa di Massenzio e Mausoleo di Romolo17 Basilica Apostolorum a San Sebastiano25 Museo della Civiltà Romana
(plastico di Roma tardo-antica)
Mappa5
6
1723
7
25
116 117
Le fonti della storia
Aurelio Vittore. Storico africano di umili origini, salì la scala sociale grazie aglistudi, divenendo nel 361 governatore della Pannonia e nel 389 praefectus urbi(prefetto di Roma). La sua opera principale, il De Caesaribus composto nel361 circa, tratta degli imperatori da Augusto a Costanzo II.
Codex Theodosianus (Codice di Teodosio). Raccolta ufficiale di leggi volutadall’imperatore d’Oriente Teodosio II, entrata in vigore nel 439. Unacommissione di funzionari imperiali appositamente nominati vi inserì tutte lecostituzioni di imperatori legittimi a partire dal 312, stilando un monumentalecodice di 16 libri, divisi per argomento, che rimarrà per secoli la base di ognilegislazione.
Cronografo del 354. Definizione convenzionale di una raccolta di testi per lopiù cronografici, compiuta nel 354 da Furio Dionisio Filocalo, calligrafo eletterato. Comprende fra l’altro un elenco dei consoli fino al 354, un elencodei prefetti di Roma tra il 254 e il 354, un elenco dei papi, i Fasti consolariromani, una cronaca universale (la Chronica Horosii), una cronaca degliimperatori di Roma fino a Licinio, una descrizione di Roma per regioni.
De Rebus Bellicis (Sulle Cose della Guerra). Trattatello redatto verso la metà delIV secolo da un anonimo scrittore, probabilmente un aristocratico conrilevanti esperienze nell’amministrazione civile, analizza fra l’altro la crisieconomica e demografica dell’Impero, la disonestà degli amministratori, lacontraffazione della moneta aurea e i problemi che la riforma monetaria diCostantino aveva creato ai ceti più deboli.
Eusebio. Vissuto (265-340 circa) a Cesarea di Palestina, di cui fu vescovo,visse dall’interno la vicenda imperiale di Costantino, sviluppando la primateologia politica cristiana. Scrittore e padre della Chiesa, dedicò a Costantinovari scritti, fondamentali perché spesso riportano testi ufficiali dell’imperatore:la Vita di Costantino, il Discorso all’Assemblea dei Santi e la Lode di Costantino,panegirico pronunciato nel trentennale di regno (335).
Eutropio. Politico, scrittore e retore di origine italica della seconda metà delIV secolo, fu al servizio degli imperatori Giuliano, Valente e Teodosio I. il suoBreviarium ab Urbe Condita è un compendio della storia romana, da Romoloalla morte dell’imperatore Gioviano (364). Gli ultimi quattro libri, dedicati allevicende imperiali, offrono interessanti ritratti dei sovrani, fra cui Costantino.
Giuliano (l’Apostata). Ultimo discendente della dinastia costantiniana,imperatore dal 360 al 363, fu filosofo e letterato. Nel dialogo satirico i Cesari,o i Saturnali, col pretesto di descrivere una festa data da Romolo nella casadegli dei per tutti i suoi predecessori, si scaglia contro suo zio Costantino, lasua opera e la cristianizzazione dell’impero.
Lattanzio. Retore africano convertito al Cristianesimo, fu precettore di Crispo,figlio di primo letto di Costantino. Fra le sue opere interessa soprattutto il DeMortibus Persecutorum, sulla morte violenta degli imperatori persecutori delCristianesimo, opera in oltre cinquanta capitoli, i più ricchi dei quali dedicatiai tetrarchi e ai loro successori.
Liber Pontificalis (Libro dei Papi). Complesso delle vite dei pontefici da S.Pietro a Martino V, compilato in momenti successivi, è fonte di primaimportanza per la storia tardoantica e medievale non solo della Chiesa, maanche della città di Roma e dell’Occidente europeo.
Nazario. Retore latino degli inizi del IV secolo, fu autore di un panegirico inlode di Costantino letto a Roma in Senato nel 321, in occasione delquindicesimo anniversario di regno di Costantino e quinto della nomina aCesari dei suoi figli Crispo e Costantino II.
Panegirico del 310. Scritto da un anonimo, dedicato a Costantino e consegnatoa Treviri in occasione dei quinquennalia, delinea un collegamento fral’imperatore e il dio del Sole, spesso considerato indizio della sua politica primadella visione cristiana. Riferisce Inoltre della leggenda “di legittimazione”,secondo la quale l’imperatore Claudio II (il Gotico) era antenato di Costantino.
Panegirico del 313. Scritto da un anonimo, dedicato a Costantino econsegnato a Treviri nel 313, descrive fra l’altro la battaglia di Ponte Milvio ela morte di Massenzio.
Zosimo. Storico bizantino degli inizi del VI secolo, fu autore della StoriaNuova, ove “nuova” ne sottolineava forse la diversità rispetto al comune sentire.Cinque dei sei libri dell’unica storia non ecclesiastica che parli del regno diCostantino narrano infatti le vicende degli imperatori da questi in poi,attribuendone gli errori all’adozione della religione cristiana, causa di rapidae inarrestabile decadenza dell’Impero.
118 119
Per saperne di più
AFFANNI A.M. (a cura di), La Basilica di S. Croce in Gerusalemme a Roma:quando l’antico è futuro, Viterbo 2003
CARLO-STELLA M.C., LIVERANI P., POLICHETTI M.L. (a cura di), Petros eni.Pietro è qui, Città del Vaticano 2006
COARELLI F., Roma (Guide archeologiche Laterza, 9), Roma-Bari 2008
D’AMATO C., DI TANNA A., LIBERATI A.M., Museo della Civiltà Romana.Guida/Guide, Milano 2008
DE ANGELIS D’OSSAT G., GIULIANO A. (a cura di), Il «tempio di Romolo» alForo Romano, Roma 1981
DE MARIA S., Gli archi onorari di Roma e dell’Italia Romana, Roma 1988
DEY H.W., The AurelianWall and the refashioning of Imperial Rome AD 271–855, Cambridge 2011
DONATI A., GENTILI G. (a cura di), Costantino il Grande. La civiltà antica albivio tra Occidente e Oriente, Cinisello Balsamo 2005
ENSOLI S., LA ROCCA E. (a cura di), Aurea Roma. Dalla città pagana alla cittàcristiana, Roma 2000
FERRUA A., La Basilica e la catacomba di S. Sebastiano, Città del Vaticano1990
FIOCCHI NICOLAI V., GRANINO M.G., ZACCARIA M. (a cura di), LexiconTopographicum Urbis Romae. Suburbium, I-V, Roma 2001-2008
FRASCHETTI A., La conversione. Da Roma pagana a Roma cristiana, Roma 1999
GIAVARINI C. (a cura di), La Basilica di Massenzio. Il monumento, i materiali, lestrutture, la stabilità, Roma 2005
GUIDOBALDI F., GUIGLIA GUIDOBALDI A. (a cura di), Ecclesiae Urbis. Atti delCongresso internazionale di studi sulle chiese di Roma (IV-X secolo), Roma2002
GUYON J., Le cimitière aux deux lauriers: recherches sur les catacombes romaines,Città del Vaticano 1987
IOPPOLO G., PISANI SARTORIO G. (a cura di), La villa di Massenzio sulla ViaAppia. Il circo, Roma 1999
KRAUTHEIMER R., Roma: profilo di una città 312-1308, Roma 1981
LEPPIN H., ZIEMSSEN H,Maxentius. Der letzte Kaiser in Rom, Mainz 2007
MANCINIR.,LemuraAureliane diRoma.Atlante di un palinsestomurario, Roma2001
MARCONE A., Pagano e cristiano: vita e mito di Costantino, Roma-Bari 2002
MESSINEO G., LaVia Flaminia. Da Porta del Popolo a Malborghetto, Roma 1991
PANELLA C. (a cura di), I segni del Potere. Realtà e immaginario della sovranitànella Roma imperiale, Roma 2011
PENSABENE P., PANELLA C. (a cura di), Arco di Costantino. Tra archeologia earcheometria, Roma 1999
PIETRANGELI C., San Paolo fuori le mura a Roma, Firenze 1989
PIETRANGELI C. (a cura di), San Giovanni in Laterano, Firenze 1990
PISANI SARTORIO G., CALZA R., La villa di Massenzio sulla via Appia: il palazzo,le opere d’arte, Roma 1976
RASCH J.J., Das Mausoleum bei Tor de’ Schiavi in Rom, Mainz 1993
REGGI A., TURCHETTI R., Guida archeologica del Parco di Veio, Roma 2010
STEINBYM. (a cura di),LexiconTopographicumUrbis Romae, I-VI, Roma1993-2000
VENDITTELLI L. (a cura di), Il Mausoleo di Sant’Elena. Gli scavi, Milano 2011
VEYNE P., Quando l’Europa è diventata cristiana (312-394). Costantino, laconversione, l’impero, Milano 2008


































![Chiesa dell'Annunziatella [Roma]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ebadf4c5c8fb3a00e5599/chiesa-dellannunziatella-roma.jpg)