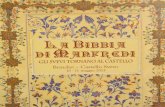Lineamenti di demografia meridionale. La dinamica demografica in Costa d'Amalfi nel primo Ottocento...
Transcript of Lineamenti di demografia meridionale. La dinamica demografica in Costa d'Amalfi nel primo Ottocento...
Annali Storici di Principato Citra XII, 2, 2014, pp. 216-232
Riccardo P. Conte
Lineamenti di demografia meridionale. Ladinamica demografica in Costa d'Amalfi nelprimo Ottocento tra vocazioni agricole ed
attività protoindustriali.
“tutto quello che rende difficile la sussistenza, tende a diminuire la popolazione”
[Gaetano Filangieri]
I. Un mondo in crescita - È cosa ben nota che lademografia – non solo quella di antico regime – èin mutuo rapporto tanto con l'economia, ma anche esoprattutto con l'agricoltura. Rapportodrasticamente mutato a séguito dei prepotentiprocessi della cosiddetta “rivoluzione agraria”, epiù ancòra della rivoluzione industriale1. In talecontesto l'area euro-americana della prima metà delXIX secolo fu interessata da un mastodonticoprocesso di ascesa demografica senza precedenti, e1 Cfr. oltre ai classici di Grigg, Abel e Slicher van Bath, sivedano le riflessioni contenute in S. CAPASSO, P. MALANIMA,Ecomomy and population in Italy (1300-1913), in «Popolazione e storia», 2,2007, pp. 15-40; per il Mezzogiorno G. GALASSO, Mezzogiorno medievale emoderno, Torino, Einaudi, 1965, pp. 303 e sgg.; E. SORI, Popolazionee insediamenti nel Mezzogiorno contemporaneo, in «Meridiana», n. 10, 1990,pp. 45-76; la ragionata bibliografia in A. PLACANICA, I ritmidell'economia: la ripresa settecentesca e la rivoluzione agraria, in La Storia, a curadi N. Tranfaglia e M. Firpo, vol. III, t. I, L'età moderna. I quadrigenerali, Torino, UTET, 1987, pp. 293-325. e G. DELILLE, Agricoltura edemografia nel Regno di Napoli nei secoli XVIII e XIX, Napoli, Guida, 1977, pp.103 e sgg.
216
RICCARDO P. CONTE
del quale certamente beneficiò l'Italia centro-settentrionale come anche il vasto Regno di Napoli.Certo, nulla di lontanamente paragonabileall'Inghilterra, dove la popolazione raddoppiò; o aquanto avvenne negli Stati Uniti, che erano passatiin mezzo secolo da 4 a 23 milioni di abitanti2. Enondimeno anche il Mezzogiorno d'Italia ebbe unapropria felice storia demografica, indubbiamentecon tutte le sue peculiarità, ma non dissimile –nei tratti principali – a ciò che avvenne in altrezone di Europa. Era questa una storia di lungoperiodo, che si ricollegava al trend del secoloprecedente (in cui pure ci si era dovuticonfrontare con un ragguardevole aumentodemografico), ed il cui esito principale e piùevidente fu il progressivo afflusso di uomini chedalla periferia si spostavano verso la città, econseguentemente lo sviluppo impetuoso degli stessicentri urbani, in particolar modo della capitale3.2 Si vedano i vari saggi contenuti nel VI volume della Cambridgeeconomic history of Europe; M. LIVI-BACCI, Storia minima della popolazione delmondo, Bologna, Il mulino, 2002; e E. SONNINO – A. NOBILE, Questionedemografica e grandi migrazioni nell'Europa dell'Ottocento, in La Storia, cit.,vol. VI, t. I, L'età contemporanea. I quadri generali, Torino, UTET, 1988,pp. 315-55; sull'Italia cfr. P. MALANIMA, An Age of Decline. Product andIncome in Eighteenth-Nineteenth Century Italy, «Rivista di Storia Economica»,n.s., XXI, n. 3, 2006, pp. 91-133; A. BELLETTINI, La popolazioneitaliana dall'inizio dell'era volgare ai giorni nostri. Variazioni e tendenze, in Storiad'Italia, vol. V, I documenti, Torino, Einaudi, 1973, pp. 520-30.3 Sulle dinamiche relative all'andamento demograficomeridionale rimando a G. GALASSO, Storia del Regno di Napoli, vol. VI,Società e cultura del Mezzogiorno moderno, Torino, UTET, 2011, pp. 137 esgg.; vd. pure P. BEVILACQUA, Breve storia dell'Italia meridionale dall'Ottocentoad oggi, Roma, Donzelli, 2005, pp. 32 e sgg.; A. DE MATTEIS, Lavicenda del popolamento nel Mezzogiorno continentale (secoli XV-XX), in Natura e
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
L'eccezionale crescita demografica che contrassegnòla prima metà del XVIII secolo fece sì che da tremilioni, il Regno passasse a ben quattro milioni diabitanti. A ciò si aggiunga che il tristementefamoso 1764, nonché il ristagno del torno '81-'85,non impedirono che si sfiorassero comunque i cinquemilioni di abitanti sul finire del secolo. Lacapitale (provincia esclusa) nel 1791 contava ben408.991 abitanti, l'8.3% della popolazione delRegno, la quale ammontava complessivamente a4.810.381 abitanti4.
All'interno del Regno di Napoli, il PrincipatoCiteriore si presenta alla fine del XVIII secolocome una provincia tra le più popolose: stando allecifre del Galanti, nel 1791 la sua popolazionesarebbe ascesa a 448.162 anime, superata solodall'intera provincia di Napoli (1.283.953 anime),
società. Studi in onore di Augusto Placanica, a cura di P. Bevilacqua e P.Tino, Roma, Donzelli, 2005, pp. 61-80; G. DELILLE, Migrations interneset mobilité sociale dans le Royaume de Naples (Xve-XIXe siècle), in Fra storia estoriografia. Studi in onore di Pasquale Villani, a cura di A. Massafra e P.Macry, Bologna, Mulino, 1994, pp. 559-70; Id., Demografia, in Storiadel Mezzogiorno, diretta da G. Galasso e R. Romeo, Napoli, Ed. delSole, 1991, vol. VIII, pp. 19-47; E. DI CIOMMO, L'urbanizzazione nelMezzogiorno nella prima metà dell'Ottocento, in «Storia urbana», 1988, 45,pp. 77-102; e A. FILANGIERI, Territorio e popolazione nell'Italia meridionale,Milano, Franco Angeli, 1980, pp. 145 e sgg.4 L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, tomo I,Bologna, Forni, 1797-1805, pp. CXXXIV-CXXXVII, riporta nel 1792 lacifra di 4.855.200. G. M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica delledue Sicilie, 2 voll., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1969,vol. I, pp. 119-24, riporta per Napoli città 430.312, mentre peril Regno 4.950.533.
RICCARDO P. CONTE
e da Terra di Lavoro (1.308.100 anime)5. Eppure,dai dati addotti dal Giustiniani apprendiamo inveceche l'estensione territoriale della stessa non eraeccessiva: su 23.390.500 moggi di terreno (pari a23.104 miglia quadrate), Principato Citra disponevadi 1.802.828 moggi (1.780 miglia quadrate), ovveroil 7,70% del totale, superata quindi in estensionedai comuni di Lucera, Cosenza, Catanzaro, Matera,Lecce; ciò significa che la densità eraeccezionalmente alta6. E di fatti, per le cifrefornite dal Giustiniani (sensibilmente diverse daquelle del Galanti), su 482.285 anime nel 1792, ven'erano 271 per miglio. Da ultimo, - sul totale delRegno di Napoli (4.855.200) - nella provinciasalernitana era stanziato il 9,93% dellapopolazione, che è una cifra rilevante separagonata agli altri comuni che avevano mediedecisamente inferiori (Catanzaro, ad esempio,
5 G. M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle due Sicilie, cit., p.121.6 L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, Bologna,Forni, 1797-1805, tomo I, pp. CXXXIV-CXXXVII, il quale basa ipropri dati sul Piano per la riforma de' titoli di Legislazione relativi al Tributo,edito a Napoli nell'anno 1792. M. ROTONDO, Saggio politico su lapopolazione e le pubbliche contribuzioni del Regno delle Due Sicilie al di qua del faro,Napoli, Tipografia Flautina, 1834, pp. 32-34, fornisce dati dipoco diversi: 25.275.634 moggi, di cui 1.690.374 (1.670 migliaquadrate) fanno parte del Principato Citra. Identico il calcolo diG. DEL RE, Descrizione topografica fisica economica politica de' Reali dominj al di quadel faro nel Regno delle Due Sicilie, tomo I, Napoli, Tipografia dentro lapietà de' Turchini, 1830, p. 10 e 48. Gennaro Primicerio Guida,redattore per il Principato Citeriore de La «Statistica» del Regno di Napolinel 1811, a cura di D. Demarco, Roma, Accademia Nazionale delLincei, 1988, tomo IV, sez. Caccia, pesca, economia rurale, p. 624,propone tali dati: 1.631.881 (1.612 miglia quadrate).
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
anch'essa provincia vasta quanto popolata, arrivavaa 8,41%; solo Terra di Lavoro svettava invece finoa 26,94%). Seppur turbolenti, gli anni a cavalieretra il XVIII e il XIX secolo non incidonodrammaticamente sul tessuto demografico complessivodella provincia che, dal 1796 - anno in cui lapopolazione era di circa 477.622 anime - al 1816,fa segnare 505.536 anime (quantunque tale calcolosia piuttosto aleatorio)7. Il periodo dellacosiddetta Restaurazione non fa altro cheproseguire lungo questa linea, avvantaggiandosi poidal periodo di equilibrio politico europeo seguìtoalle vicende napoleoniche. È pertantocontrassegnato da un evidente, costante andamentopositivo della popolazione totale del regno, ma dicui beneficiarono a loro modo tutte le provincie,7 Per il 1796 cfr. P. VILLANI, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Roma-Bari, Laterza, 1973, pp. 33 e passim.; per il 1816 cfr. A. ZUCCAGNI-ORLANDINI, Corografia fisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue isole,Tipografia storico-governativa, Firenze, 1845, pp. 379 e sgg. Èaffatto curioso come S. MARTUSCELLI, La popolazione del Regno di Napolinella statistica del re Murat, Napoli, Guida, 1979, pp. CXC-CLXXXVII esgg., registri un brusco decremento per il 1816 fino a 418.840anime, un sproposito di cui, nei summenzionati autori, non v'ètraccia; certo, potrebbe essere cagionato dall'epidemia di queglianni, anche se è anomalo un simile ammanco demografico. Anomaliasu cui conviene pure F. VOLPE, Territorio e popolazione del Principato Citra travecchio e nuovo regime, in Il Principato Citeriore tra Ancien Régime e conquistafrancese: il mutamento di una realtà periferica del Regno di Napoli, a cura di E.Granito – M. Schiavino – G. Foscari, Salerno, Avallone, 1993, pp.306-7. Del tutto inutilizzabili i dati di A. FILANGIERI, Territorio epopolazione, cit., pp. 319-323 e 366-7, in quanto si sono rivelatiessere troppo distanti dalle cifre reali, sia per quanto riguardail Principato Citeriore, sia per quanto riguarda le singole realtàcostiere. Si vedano le varie tabelle in appendice al presentescritto.
RICCARDO P. CONTE
compresa quella del Principato Citeriore. Essaaumentò dal 1814 al 1859 del 36.27%, ben oltre lapiù ricca Terra di Lavoro, la quale ebbe unincremento del 20.64%, ma meno di Napoli, 37.15%(Tab. 3 in Appendice).
Tab. A – Rapporto demografico tra Costiera e provincia8
Anno Principato Citra
Costad'Amalfi
% relativasulla
provincia
Indiceaumento
1814 428.044 36.516 8.53 1001836 520.891 42.074 8.07 115.221859 583.317 48.640 8.33 133.20
Il territorio costiero racchiuso tra Vietri ePositano, nel suo piccolo, pure aveva partecipato aquesta inarrestabile ascesa, e a guardarel'andamento demografico della prima metà del XIXsecolo, non si hanno dubbi nel constatare che,fatto salvo qualche caso particolare, stessebeneficiando anch'esso della floridezza dei tempi9.8 Per il 1814 ho usato S. MARTUSCELLI, La popolazione del Regno diNapoli, cit., pp. 561 e sgg; per il 1836 M. CAMERA, Istoria della città ecostiera di Amalfi, Napoli, Stamperia e cartiera del Fibreno, MDCCCXXXVI,p. 423; per il 1859 G. DE SANCTIS, Specchio statistico delle popolazioni de'comuni delle provincie meridionali d'Italia, Napoli, Ferrante, 1861, p. 15. 9 Floridezza che non caratterizzerà però la seconda metàdell'Ottocento, contraddistinta da una complessiva stagnazionedemografica, dovuta ad un calo della natalità. A tal riguardorinvio a G. PALAMARA, La struttura demografica, in Storia e protagonisti nella
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
A misura che la provincia si ingrandiva in terminidi uomini, anche le zone costiere davano il propriocontributo seguendone il trend ascensionale. Questo lembo di terra – circa 13.726,1 moggi (13.55miglia quadrate) – era una parte infinitesima ditutto il territorio della provincia (0.76%).Contesa tra il mare e la roccia, e connotata dallapiù alta densità demografica, la fascia costieraconteneva all'incirca l'8% della popolazionedell'intero Principato10; il resto era moltovariamente distribuito tra i distretti di Salerno(di cui la Costiera faceva parte), Vallo, Sala eCampagna. Ragionando in termini di macroregioni, l'areasalernitana, coincidente col distretto di Salerno,comprendeva zone alquanto eterogenee percomplessione demo-territoriale. Nonostante ciò, seconfrontata con quella cilentana (compresa negliultimi tre distretti surrichiamati), palesava
Vietri dei secoli XIX e XX, Vietri, 2009, pp. 123 e sgg.; e alla tabella 15di G. IMBUCCI, Popolazione, territorio ed agricoltura a Salerno (1861-1961), Cava,Di Mauro, 1978, p. 49.10 L. CASSESE, La «statistica» del Regno di Napoli del 1811. Relazioni sulla provinciadi Salerno, Salerno, Società di storia patria, 1955, pp. 210 e sgg. Siveda anche V. AVERSANO, Geografia comparata dei comuni della costa d'Amalfi traSette e Ottocento, in La costa di Amalfi nel secolo XVIII, vol. I, cit., pp. 267-369, che avevo già utilizzato in R. P. CONTE, Classe dirigente eamministrazione della costa d'Amalfi nel primo Ottocento, Salerno, Oèdipus,2013, pp. 16 e sgg. e al quale rimando per l'analisi dellaconformazione territoriale. I dati sulla popolazione che lìcompaiono, sono stati qui rimaneggiati ed aggiornati alla luce dipiù recenti acquisizioni. Per il Principato Citra cfr. V.AVERSANO, G. CIRILLO, Quadro agrario e attività «civili» in Principato Citra ai primidell'Ottocento, in Salerno e il Principato Citra nell'età moderna (secc. XVI-XIX), a curadi F. Sofia, Napoli, ESI, 1987, pp. 215-81.
RICCARDO P. CONTE
connotati affatto antitetici: quest'ultima infattiera estremamente estesa, con una densitàdemografica minima – una congerie di centri dimedie e piccole dimensioni, disseminati su di unspazio vastissimo –, laddove invece spicca unaminore dispersione antropica ed una più elevataconcentrazione urbana nelle zone del Salernitano(Cava, Nocera, Pagani, Sarno e Salerno). Inoltrel'area cilentana aveva avuto un andamentodecisamente meno sostenuto appetto a quellasalernitana, giacché – tra i tre distretti –l'unico ad aver avuto un'evoluzione paragonabile èquello di Vallo, il quale passa dai 76.715 abitantiai 113.137, un aumento del 47.50% dovuto allamortalità più bassa del regno (13.88‰); Campagnadel 21.76% e Sala del 13.96%. Ragionando però intermini di macroregioni, e trattando pertanto comeun unicum i tre distretti cilentani, da unapopolazione complessiva di 246.352 nel 1814, eranopassati a 314.260 anime nel 1859, un aumento del27.56%; laddove il distretto di Salerno era invecepassato nei medesimi anni dai 180.692 ai 267.057abitanti, ovvero un dovizioso aumento del 47.79%11. Cosicché, stando a questi dati, la macroregioneCostiera dal primo quindicennio del XIX secoloall'unità non si segnalava tra quelle piùdinamiche, essa avendo avuto un aumento del 33.20%.Un aumento non significativo soprattutto separagonato a quello di altre realtà del medesimodistretto – l'agro nocerino-sarnese e Cava, ad11 Ho utilizzati ancòra una volta Martuscelli e De Sanctis. Per ilCilento si vedano i vari studi di Ebner, Volpe, Rossi e Aliberti.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
esempio, avevano avute evoluzioni ben piùrimarchevoli. Possiamo quindi dire che l'andamentodella costiera era più vicino all'andamento dellacittà di Salerno12 e alle aree cilentane: certamentein fase di crescita, ma una crescita non di certoirresistibile (Tab. 4, in Appendice).Concentrata soprattutto nei maggiori e più vivacicentri economici, la popolazione costiera nellaprima metà dell'Ottocento appariva cosìdistribuita: una prima zona, in evidenteespansione, è quella tra Vietri ed Amalfi, storicie popolosi agglomerati dell'area salernitanaracchiudente il grosso della popolazione, circa il72%, e che hanno andamento demografico positivo nelprimo cinquantennio. Al suo interno in particolaredistinguiamo poi un'area comprendente i vicinicomuni di Vietri e Cetara (24%). Un'altra ancòra,circa il 14%, tra Maiori e Minori. Un'altra parteconsistente era compresa tra Amalfi, Atrani edAgerola, cioè un altro 28% della popolazione.L'area tra Ravello e Scala cui corrispondeva circail 6%. Una seconda, più vasta area, ben distaccata dallealtre, è quella di Tramonti, che varia tra 8 e 10%a seconda del periodo.Infine una terza area, più depressa, è invecequella che da Conca giunge fino a Positano, dove
12 Per il trend di Salerno cfr. F. SOFIA, La popolazione nell'età moderna,in Storia di Salerno, vol. II, a cura di A. Placanica, Avellino,Sellino, 2001, pp. 41-47. Vd. Id., Popolazione e territorio ad Eboli dall'iniziodei Seicento all'unità, in «Bollettino storico di Salerno e PrincipatoCitra» (BSSPC), A. VII, 1-2, 1989, pp. 91-129.
RICCARDO P. CONTE
gli agglomerati, oltre a caratterizzarsi per trenddemografico negativo, vanno perdendo laconcentrazione con cui erano arrivati alle soglieXIX secolo.
Tab. B – Distribuzione percentuale della popolazione costiera (1814-1859)13
A B C D E F G H I L M N O P
1814
8.30
5.03
14.91
2.79
5.19
– 8.65
5.33
8.80
5.44
3.39
3.68
8.59
16.97
1836
8.49
5.23
15.09
3.04
5.70
1.87
9.81
5.73
7.03
2.60
3.19
3.36
9.73
19.07
1859
8.41
5.85
15.56
2.23
5.49
1.61
9.81
6.28
6.27
2.68
2.84
3.06
10.25
19.22
È da dirsi che le svariate carestie ed epidemie chesi susseguirono lungo la prima metà del secolo nelregno, sia nel Principato Citra sia nella Costiera,non ne inficiarono l'accrescimento demografico. Ilcolera fu la tabe ottocentesca più presente. Eraquesta la classica patologia endemica, cioèperdurante allo stato latente, ricomparendo ditempo in tempo per poi scemare, ed esploderenuovamente; certo senza mai raggiungere perintensità le catastrofiche pandemie di peste del1656 e del 176414.13 Vd. Nota 8. Per Vietri e Cetara cfr. G. PALAMARA, La strutturademografica, cit., p. 124. Agerola = A; Atrani = B; Amalfi = C;Conca = D; Cetara = E; Furore = F; Maori = G; Minori = H; Positano= I; Praiano = L; Scala = M; Ravello = N; Tramonti = O; Vietri =P.14 Sulle epidemie ottocentesche di colera in Italia cfr. E.TOGNOTTI, Il mostro asiatico. Storia del colera in Italia, Bari, Laterza, 2000.Sull'epidemiologia meridionale cfr. G. GALASSO, Storia del Regno diNapoli, vol. VI, cit., pp. 132 e sgg. È a mio credere ancor oggi
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
È però da rilevarsi come, rispetto all'andamentocomplessivo, il periodo immediatamente successivoalla restaurazione – con la carestia\epidemia del'16-'17 – non ha nella Costiera la medesimaincidenza che ha nel Principato Citeriore: inquesto è visibile il nadir tra gli anni '15 e i '20(Tab. 3); in quella invece non si registranovariazioni apprezzabili, che anzi continua lapropria crescita (cfr. ultra)15. La nefasta epidemia di colera, che impazza pocodopo la metà degli anni '30, è invece l'unicabattuta d'arresto (per altro non clamorosa) tantoper l'area costiera quanto per tutta la provincia16.È infatti nel periodo dal '36 al '41 che si notauna perdurante stagnazione e, in taluni casi, delleperdite consistenti nel tessuto demografico che siprotraggono anche dopo l'inizio degli anni '40.Laddove altre popolazioni del Mezzogiorno eranostate profondamente falcidiate dall'epidemia, tuttosommato l'area costiera reagisce ancòra una voltapiuttosto bene a questa impasse demografica, e ciò inragione del suo evidente isolamento geografico chele permette di attraversare illesa il periodo del
valida quella parenesi sugli studi delle crisi del XIX secolo, cheillo tempore ebbe a fare A. LEPRE, Azienda agraria e azienda feudale traCinquecento e Ottocento, in Problemi di storia delle campagne meridionali nell'etàmoderna e contemporanea, a cura di A. Massafra, Bari, Dedalo, 1981,p. 37; l'unico testo ad oggi rispondente a quegli interrogativiresta M. R. STORCHI, Prezzi, crisi agrarie e mercato del grano nel Mezzogiornod'Italia (1806-1854), Napoli, Liguori, 1991.15 G. DELILLE, Agricoltura e demografia, cit., p. 12.16 Si veda G. MALDACEA, Storia del colera della città di Napoli, Napoli,Guttemberg, 1839, pp. 12 e sgg.
RICCARDO P. CONTE
colera. A conferma di ciò, si noti come le comunitàpiù isolate (Tramonti e Scala) siano praticamenteimmuni alla stagnazione; per converso, comunità cheerano molto attive economicamente (e quindi incostante contatto con altre genti) accusano perditepiù alte (è il caso di Majori). Il ventennio'40-'60, vede una crescita demografica costante delterritorio costiero, ma anche qui è necessario undistinguo. Il Mezzogiorno è investito in queglianni da un'altra epidemia di colera (185417), che,sebbene imperversi anche in Campania (Terra diLavoro per esempio ne è travolta in pieno), nonfunesta però la popolazione del Salernitano cheprosegue indisturbata la propria crescita. Nellacosta invece, quantunque ancòra una volta escasostanzialmente illesa la popolazionedall'epidemia, è tuttavia netta una complessivastagnazione negli anni '50.Da ultimo, possiamo dire che nel complesso i ritmidi crescita della Costiera se non ricalcano appienoquelli della provincia, per via di sostanzialidifferenze nelle strutture territoriali, comunquene seguono l'andamento. Un andamento quindi nonesplosivo nel primo ventennio del secolo, macaratterizzato comunque da una crescita demograficacostante dopo il Decennio, che si caratterizzò unpo' ovunque come periodo di stagnazionedemografica18. Ciò risulta ancor più chiarodall'osservazione della Tab. C in cui è patente un17 Cfr. S. DE RENZI, Intorno al colera di Napoli dell'anno 1854, Napoli, Gaetano Nobile, 1854, pp. 6-88.18 Cfr. A. BELLETTINI, La popolazione italiana, cit., p. 520.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
accrescimento nel ventennio '20-'40, segnatamentepiù nel primo decennio che nel secondo; e viceversauna complessiva diminuzione delle percentuali dicrescita nella maggioranza dei comuni durante ilventennio '40-'60. Se però negli anni '50 (inparticolare nella seconda metà) si nota unaccrescersi della popolazione sia nel regno che nelPrincipato Citra, nel territorio costiero, man manoche ci si avvicina all'unità, è di contro evidentese non una stagnazione vera e propria, comunque unprincipio di rallentamento (che per alcune realtàurbane si concretizzerà nella seconda metà delsecolo)19.
Tab. C – Percentuali di aumento\decremento (1820-1861)20
19 Francamente non mi ritrovo con A. LEPRE, Storia del Mezzogiornod'Italia, 2 voll., Napoli, Liguori, 1986, vol. II, Dall'antico regime allasocietà borghese (1657-1860), pp. 111 e sgg, che sostiene esservi stataper tutto il regno un'accelerazione negli anni Trenta e Quaranta(cioè a dire proprio gli anni più intensi del colera) estagnazione nei Cinquanta, che pure vedono una epidemia\carestianel '53-'54, ma che può considerarsi oltrepassata demograficamentegià nel '55, e nella Costiera addirittura nello stesso '54. Sullaflessione negli anni '30-'40 conviene anche G. GALASSO, Mezzogiornomedievale e moderno, cit., p. 308. Ma basti guardare i trend del regnoe del Principato Citeriore in appendice, Tab. 2 e sgg. A ciò siaggiunga che tanto evidente fu l'aumento negli anni successivi al'56 che gli stessi studiosi di statistica, basiti davanti a cosìceleri variazioni, hanno ventilata l'ipotesi di alcuni errori neicalcoli; su tali questioni cfr. G. GALASSO, Storia del Regno di Napoli,vol. VI, cit., pp. 138-9.20 Mie elaborazioni attraverso i dati desunti dagli Stati discussicontenuti nel fondo Intendenza dell'Archivio di Stato di Salerno(d'ora in poi ASS). Per Atrani, Scala, Tramonti, non essendodisponibili i dati del 1820 e 1861, ho adoperati, ove necessario,quelli del 1818 e 1859. Per Vietri e Cetara ho utilizzati i datidel succitato Palamara.
RICCARDO P. CONTE
1820-30 1830-40 1840-50 1850-61 1820-40 1840-61
Amalfi + 4.59 % + 11.77%
+ 10.14%
+ 8.82 % + 16.90 % + 19.14 %
Atrani - - - - + 40.54 % + 29.39 %Cetara - - - +11.75% - -Conca – 10.71
%+ 10.71
%– 7.80
%– 1.40 % +10.61 % – 10.96 %
Majori + 18.93%
+ 9.01%
- - + 29.65 % + 18.53 %
Minori + 23.58%
+ 9.11%
- - + 34.85 % + 25.60 %
Ravello + 11.82%
+ 0.42%
- - + 12.30 % + 6.60 %
Scala + 12.15%
+ 2.74%
- - + 15.23 % + 3.19 %
Tramonti
- - - - + 34.39 % + 20.15%
Vietri - - - - + 12.43 % + 18.36 %
A tutta prima possiamo notare come la situazionedemograficamente più felice sia quella di Tramonti.Era questa infatti la zona che più di tutte potevavantare ettari disponibili, e molto si avvantaggiòdi questa prerogativa, e già alla metà degli anni'30 infatti si intravvedono aumenti significativi;insieme a Maiori e Minori è quella che hal'incremento più ragguardevole. Tra la prima decadedel secolo fino all'unità crebbe addirittura del66.33%. Pur non avendo la popolazione più alta inassoluto (un primato questo sempre detenuto daVietri), certamente fu la più dinamica sotto ilrispetto demografico, superando tra gli anni '30 e
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
'40 la stessa Maiori in popolazione complessiva. Ècomunque l'unica realtà a continuare adingrandirsi, con aumenti significativi anche nellaseconda metà del secolo.Maiori e Minori sono quelli che, dopo Tramontihanno una evoluzione demografica ragguardevole. Inparticolare la seconda, come può vedersi daconfronto tra le tabelle C e D, risulta nettamentevincente sulla prima: Minori è quella che cresce dipiù nel decennio tra gli anni '20 e i '30. Purcontinuando a crescere, anche qui è palese lafrattura tra il ventennio '20-'40 e '40-'60. Siaccosta comunque ai ritmi di Maiori tra gli anni'30-'40. Entrambe, insieme alle altre comunitàcostiere, aumentano secondo un saggio che vadecrescendo volta a volta che ci si avvicinaall'unità. Sebbene non abbia una crescitarimarchevole, l'unica che riesca ad invertirequesta tendenza è Amalfi, in particolare verso lafine degli anni '50. È anche quella che più ditutte cresce tra il 1807 ed il 1818 (8.20%),seguìta da Tramonti (5.93%).Atrani spicca come il comune che più di tutti siingrandì tanto nel ventennio di accelerazione,quanto in quello successivo. Insieme a Tramonti,Maiori, Minori e Vietri in mezzo secolo è quellache ha aumentata più del 50% la popolazionecomplessiva. Vietri era la più imponente di tutte per quantoriguardava la popolazione assoluta, concentrata inuno spazio estremamente piccolo. Dopo Atrani ed
RICCARDO P. CONTE
Amalfi, era quella più densamente popolata21, e talerimarrà anche nel Novecento inoltrato. Il suo trendnon è dissimile da quello delle realtà urbane piùpopolate che crescono attorno al 50%22. Distinguerladalle altre realtà, e ad accomunarlaall'altrettanto popolosa Amalfi è una crescita piùvivace nel ventennio '40-'60 piuttosto che nelprecedente. Decisamente più contenuta la crescita di Ravello eScala. La prima, dal Decennio al 1861 è cresciutadel 24.41%; la seconda dello 07.92%. Nondimeno,mentre Ravello si ingrandirà con un buon trend anchenella seconda metà del secolo, Scala declinerà.Oltrepassato il comune di Amalfi, la “striscia” cheva da Conca de' Marini a Positano è caratterizzatada un andamento tutt'affatto negativo. Tra quelleche spiccano per un andamento non positivo, Furore,sebbene caratterizzata da un cronico immobilismodemografico, è una eccezione alla regola: riesce asopravvivere con una popolazione che non sfioreràmai i 1.000 abitanti (la più bassa in assoluto);pur arrivando con 799 abitanti al 1861, apprendiamosuccessivamente dall'inchiesta Jacini chescenderanno a 63323. Positano e Prajano, due realtàche molto si somigliano (la prima ben più popolosadella seconda), sono quelle che invece registrano –insieme a Conca – trend profondamente negativi. Tale
21 D. TAJANI, Monografia sul circondario di Salerno, Salerno, 1879, p. 17.22 G. PALAMARA, La struttura demografica, cit., pp. 123 e sgg.23 L. ROSSI, L'agricoltura nella costiera amalfitana tra stasi ed innovazione, in Lacosta di Amalfi nel secolo XIX, 2 voll., Amalfi, CCSA, 2005, vol. I, pp.231-50.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
decrescita risulterà essere inarrestabile perPositano che andrà spopolandosi soprattutto lungotutta la seconda metà dell'Ottocento. Prajano, perconverso, riuscirà ad invertire tale infelicetendenza man mano che si avvicinerà alle soglie delXX secolo (vd. Tab. B). Sono le uniche realtà chefacciano registrare saldi passivi. Conca tral'inizio del secolo e gli anni '30 non riesce atenere il passo demografico delle altre; e purtuttavia, tra il 1830 e il 1840 era riuscita arecuperare, portandosi ai livelli di crescita diCetara e Minori. Ma già dopo la metà degli anni '30la popolazione inizia a decrescere, senzamodificare tale andamento nella seconda metà delsecolo. Complessivamente non si possono notare qui grandirivoluzioni sotto il rispetto demo-territoriale:laddove nel regno l'accrescimento demografico avevaportato ad alcune rivoluzioni nella gerarchiademografica, con lo sviluppo dei centri urbani piùgrandi a tutto detrimento di quelli più piccoli,nella Costiera l'unico vistoso avvicendamento èquello che vede Maiori sopravanzata da Tramonti.Tutte le aree si accrescono prima facie nei limiti deipropri (ristrettissimi) àmbiti geografici senzasconvolgere l'equilibrio demografico. Tuttavia, unosguardo più addentro alle singole realtà ladistribuzione rivela anche qui una diffusa, seppurminuta, decrescita in percentuale dei comuni piùpiccoli, mentre la popolazione tende a concentrarsiin quelli più grandi, e allora vediamo come dal '14al '59 aumentino le percentuali Amalfi, Maiori,
RICCARDO P. CONTE
Minori, Tramonti e Vietri; laddove invece Conca,Agerola, Furore, Ravello e Scala, in quanto realtàminute, tendono – complice anche il loro andamentodemografico non eccezionale – a perdere puntipercentuali durante la prima metà del secolo. Leeccezioni sono costituite da Atrani, certo non unodei centri più grandi, che riesce però aagglutinare una porzione via via più ingente;Maiori, sebbene non blocchi la crescita, vienesuperata da Tramonti; ma soprattutto Positano,realtà urbana di una certa grandezza all'internodel panorama demografico costiero, perdevistosamente piede rispetto alle aree a lei piùsimili (Tab. B).
Tab. D – Indici percentuali dell'andamento demografico costiero (1813-1878)24
A B C D E F G H I L M N
1813 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1836 117.81
120.47
126.44
127.28
132.20
125.62
88.61
55.37
103.22
108.76
132.37
129.44
1859 140.78
155.87
140.72
107.83
158.35
159.27
91.46
65.92
106.06
114.75
161.22
150.83
1878 128.25
133.23
132.29
97.22
156.72
169.94
77.83
49.52
105.90
138.58
155.83
129.16
II. Alcuni limiti ermeneutici – Siccome cifre,
24 Vd. Nota 8; per il 1878 D. TAJANI, Monografia sul circondario diSalerno, cit., p. 9. Amalfi = A; Atrani = B; Cetara = C; Conca = D;Maiori = E; Minori = F; Positano = G; Praiano = H; Scala = I;Ravello = L; Tramonti = M; Vietri = N.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
serie e tabelle prese in se stesse sono mute, è oranecessario analizzare taluni problemi inerentiall'interpretrazione delle stesse, quello che glistudiosi chiamano passare dalla “demografiadescrittiva” alla “demografia investigativa”.Prescindendo (momentaneamente) dai moventi dettatidalla psicologia sociale e dalle dinamiche geo-economiche25, da ultimo possiamo direschematicamente che due siano le cause meramentebiologiche cui imputare l'incremento demografico (el'una non esclude l'altra):1) l'aumento della natalità – a sua volta dovuto adun aumento del tenore di vita (si guadagna di più,si fanno più figli), o ad un fisiologico aumentodella fecondità.2) la diminuita mortalità – in ragione di migliorieoccorse nell'intima e pubblica igiene, od anchenella qualità\quantità del cibo (le quali cosepermettono di ammalarsi di meno, e di conseguenzamorire di meno), oppure ad un fisiologicodecremento di fecondità26. Le quali cause primepossono a loro volta scaturire da fattori di ordinesocio-economico. La differenza tra il tasso di
25 Su tali complesse questioni rimando comunque alleconsiderazioni di G. DELILLE, Crescita e crisi di una società rurale.Montesarchio e la Valle Caudina tra Seicento e Settecento, Bologna, Il Mulino,2014, passim.26 La concione che il Cagnazzi tenne nel 1819 innanzi alla Realaccademia delle scienze di Napoli, dal titolo Sul periodico aumento dellepopolazioni, Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici,2003, pp. 67 e sgg., dimostra come fossero già ben chiare questedinamiche. Vd. anche il surrichiamato S. CAPASSO, P. MALANIMA,Ecomomy and population in Italy (1300-1913), cit., passim.
RICCARDO P. CONTE
natalità e tasso della mortalità, ci dà il saggiodi incremento naturale della popolazione. Altafecondità, alta natalità ed alta mortalità erano itratti distintivi dell'andamento naturale dellapopolazione di antico regime, talvoltacaratterizzato dalla perniciosa prevalenza dellamortalità sulla natalità27.
Per quanto riguarda il Principato Citra alla finedel Decennio francese, lo studio della Martuscellici rende avvertiti della natalità stagnante, cuiperò si accompagna una sostanziale diminuzionedella mortalità (la più bassa del Regno col suo24.15‰), nonché il massimo aumento medio dellapopolazione (13.77‰), dovuti alle concomitantimigliorie igienico-sanitarie introdotte daiNapoleonidi, la qual cosa parrebbe in partegiustificare i progressivi aumenti di popolazioneattiva28.Malauguratamente per quanto riguarda i tassi difecondità, natalità e morte nella costa d'Amalfi,le fonti sono piuttosto scarne per poter affrontareun discorso esaustivo su tutta la prima metà delXIX secolo e, purtuttavia, ci permettono di
27 G. DELILLE, Demografia, cit., p. 22, individuava agli albori del'500 e nel secondo '600 questo tipo di situazione per ilMezzogiorno. 28 S. MARTUSCELLI, La popolazione del Regno di Napoli, cit., p. CLXXXIX,dice: “l'incremento demografico registrato, non è tanto imputabilea migliorato tenore di vita, che si concretizzerebbe in un'altanatalità, quanto ad un maggior grado di civilizzazione, che riescea far registrare la più bassa punta di mortalità di tutto ilRegno.” Cfr. tab. 1, 3 e 4.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
avanzare alcune ipotesi, seppur approssimative.Basandoci sullo studio del Delille condotto sulprimo quindicennio del secolo, siamo edotti suibassi tassi di fecondità riscontrabili in tutta lafascia costiera. Infatti, ad onta di quantoavveniva nelle altre aree dello stesso distretto,dove vi erano tassi che non scendevano mai al disotto del 30‰, qua invece si abbassavanodrasticamente29. L'agro nocerino-sarnese aveva tassiche si attestavano sul 38‰, e la più vicina Salernoil 40‰; la Costiera invece aveva dei tassievidentemente più simili alla vicina costasorrentina, da 20 al 27‰. L'unica eccezione eracostituita dall'asse Atrani-Minori che facevaregistrare tassi più elevati (31-40‰) e quindi piùsimili al distretto di appartenenza (cfr. ultra). Lostesso dicasi per i tassi di mortalità: quellidella fascia costiera si attestavanoinequivocabilmente su valori più bassi (19-25‰),eccezion fatta per il tratto Atrani-Maiori (39‰).Tali dati si invertiranno completamente alla dimanedell'Unità. Rimane pertanto da illuminare l'unicazona d'ombra: la natalità e la mortalità nelperiodo della Restaurazione30.Ciò posto, è bene precisare fin da sùbito che tragli anni '30 e la metà del secolo i tassi dinatalità erano già aumentati in misuraconsiderevole rispetto al periodo francese, eassomigliavano molto a quelli che si osserveranno29 G. DELILLE, Agricoltura e demografia, cit., pp. 5-9.30 Per tali dati mi sono basato sulle Statistiche contenute nel fondodell'Intendenza in ASS; vd. Appendice.
RICCARDO P. CONTE
nel 1864. Ma, ancorché aumentati, erano ancòrainvariati nelle proporzioni. Le stime di natalitànel 1850 presentavano ancòra tutti i caratterifinora esposti, ovverosia un asse costituita daAtrani, Majori, Minori – cui si aggiunge Ravallo –con valori nettamente più alti rispetto alle zoneconvicine, le quali avevano per contro tassiinferiori: Minori è quella che presenta i valorimaggiori, natalità 52‰ e mortalità del 37‰; Majori,Atrani e Ravello si attestavano sul 40‰ dinatalità. Tutte le altre erano di almeno due puntial di sotto del 40‰ di natalità; Tramonti e Vietriraggiungevano entrambe 38‰ di natalità; Amalfi,similmente a Positano e Cetara era sul 30‰ dinatalità. I dati di Furore e Scala collimano colloro surriferito immobilismo (9‰ di natalità e 9‰di mortalità la prima, e 26‰ e 26‰ la seconda),così come quelli di Conca si appaiano bene al suotrend negativo (11‰ di natalità e 23‰ dimortalità). Quel che invece colpisce è il fatto chei tassi di mortalità si siano abbassati seconfrontati con quelli dell'inizio del secolo:nell'asse Atrani-Minori, dove prima erano anch'essipiù alti, adesso oscillano tra il 20 e il 30‰. Idati estremamente felici di Prajano (38‰ dinatalità e 12‰ di mortalità) parrebbero a tuttaprima essere in aperto contrasto col suo trenddemografico; in effetti non era la mortalità adaffliggere il tessuto demografico, sibbenel'emigrazione. Come infatti appurava l'inchiestaJacini, il prevalere del cotone ne aveva inficiatal'economia, costringendo le forze del paese ad
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
andare in cerca di fortuna altrove.Sicché la dinamica demografica tipica dell'ancienrègime, ovvero alta natalità, ed altrettanto altamortalità nella Costiera si può dire che non vi fumai. Quella che si ebbe nella prima metà del XIXsecolo fu qualcosa di più simile a quanto stavaavvenendo nel resto del regno: non tanto unanatalità eccezionalmente alta (che era in fondosimile a ciò che avveniva nel resto dell'areasalernitana), quanto piuttosto una diminuzionedella mortalità. Cionondimeno, tali considerazioni sonoinsufficienti a spiegare due evidenze, cioè quelladi Tramonti e quella di Ravello: se la prima mostraun trend spiccatamente positivo e la seconda unodecisamente inferiore – quantunque non negativo –,ciò sicuramente non rispecchia il rapporto tranatalità e mortalità dal momento che esso èpalesemente più favorevole alla seconda che allaprima. La qual cosa ci porta a concludere che idati del 1850 sono indicativi solo di una porzionedi tempo, ma non sono rappresentativi dell'interoperiodo, in cui si ebbero altri tassi di incrementonaturale. La dimostrazione è proprio l'andamento diTramonti, che, come si è visto, sopravanza inpopolazione assoluta Maiori nel giro di mezzosecolo.In attesa di dati più precisi, possiamo ex hypotesiaffermare che l'aumento di natalità sia intervenutoben prima del 1864, accompagnato da una drasticadiminuzione della mortalità e un aumento evidentedella popolazione attiva – all'incirca ciò che la
RICCARDO P. CONTE
Martuscelli aveva individuato per l'interaprovincia nel 1815. Ed effettivamente ciò rientraappieno nel successivo andamento complessivo delRegno di Napoli, ove una siffatta diminuzione dellamortalità nella prima metà del secolo pure avevacolpito uno studioso avvertito come il De Renzi31.Si badi poi che a diminuire la mortalità non fusolo la vaccinazione, ma anche opere meritorie cuiattese fattivamente la borghesia: la costruzionedei cimiteri pubblici (spostati finalmente fuoridalle chiese, che erano diventate loro malgrado deiricettacoli di patologie), la pulizia sistematicadelle strade ed anche la costruzione di pubblichefontane, ad esempio, furono opere meritorie checontribuivano ad elevare l'igiene non solopersonale, ma pubblica, prevenendo il propagarsi dimalattie32.Il che ci porta a soffermarci su di un altro datosignificativo: l'aspettativa di vita erapalesemente aumentata, ed in una fascia ben precisadi età. All'interno del regno, il PrincipatoCiteriore deteneva il primato della mortalitàinfantile più alta, e la Costiera ricalca questoandamento negativo. Scartabellando i documenti cisi avvede dell'incidenza altissima (siamo ben oltre
31 S. DE RENZI, Topografia e statistica medica, Napoli, Sebezio, 1845, pp.197-8. W. L. LANGER, Europe's initial population explosion, in «Americanhistorical review», n. 69, 1963, pp. 1-17, rinveniva proprio nelladiminuita mortalità il tratto distintivo dell'aumento europeo diquegli anni. 32 Rimando ad un mio lavoro di prossima pubblicazione R. P. CONTE,Aspetti della vita socio-economica costiera attraverso la contabilità comunale: laborghesia della costa d'Amalfi tra crediti e appalti.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
il 50%) della mortalità infantile nel computo deltasso di mortalità, a fronte di una sostanzialeassenza di mortalità nella fascia attiva33:l'aspettativa di vita era patentemente maggiorenella fascia che dai 7 menava ai 30-35. Lamortalità si assestava comunque ben oltre i 40anni, non diversamente da quanto avveniva nel restodel Mezzogiorno34. All'alzarsi dell'aspettativa divita si alzano le cifre dei matrimoni e si alzanoin particolare le età dei matrimoni: si muore dopo,ci si sposa dopo. Inoltre nati illegittimi eranopochissimi, quasi assenti, e l'età media a cui cisi sposava era tra i 19 ed i 24 (con rare punteverso i 27) anni per i maschi, e 18 e i 21 (conpunte verso i 25) anni per le femmine35.
L'andamento non eccezionalmente alto della Costieranella prima metà del secolo, se paragonato allealtre più prolifiche aree del salernitanosembrerebbe in antitesi con quanto aveva ventilatoil Delille: egli stabiliva una deterministicacorrispondenza tra strutture agricole e strutturedemografiche per ascrivere poi la differenza neitassi di mortalità\natalità al fattore socio-territoriale, che è anch'esso in funzione del tipodi struttura agricola. Dalla struttura agricoladipenderebbe quindi la struttura economica e quindi
33 Ho considerata infantile l'età al di sotto dei 7 anni di vita;quella attiva dai 10 ai 60 anni. Su ciò cfr. G. GALASSO, Mezzogiornomedievale e moderno, cit., p. 319.34 A. DE MATTEIS, La vicenda del popolamento, cit., p. 74.35 G. DELILLE, Demografia, cit., p. 30.
RICCARDO P. CONTE
quella sociale. Il primum è perciò la complessioneagricola, e atteso che nella Costiera essa sibasava quasi unicamente sul vigneto esull'agrumeto, dava luogo a tassi affatto dissimilidai paesi che vivevano di grano. Le aree del granoavevano avuti andamenti demografici più prolificiappetto a quelle che basavano la propriaagricoltura sul vigneto: là infatti si moriva dipiù e si nasceva di più. Ciò posto, i tassimortalità\natalità della Costiera si sarebbero dipoi rialzati al diminuire dei prezzi del vino eall'aumentare dei prezzi del grano lungo la primametà del XIX secolo. La Costiera si sarebbe insommaavvantaggiata perciò dell'andamento dei prezzi alfine di smerciare una maggior quantità di prodottiprovenienti dall'albero e dalla vigna – le qualiultime già dal periodo francese effettivamenteandavano aumentando di numero – per acquistare legranaglie di cui abbisognava36. Si sarebbe sopperitoall'aumento dei prezzi del grano a mezzo di unsimilare aumento delle rendite e dei profittidovuti agli aumenti delle vendite. Ciò significache si adopera una spiegazione antitetica a quelladel Ricardo, ossia all'aumento dei prezzi del granovi sarebbe stata una diminuzione delle rendite edei profitti dovuta alle diminuite vendite dellegranaglia, donde una diminuzione demografica in
36 Id., Agricoltura e demografia, cit., pp. 12-35 e passim. L. BIANCHINI,Della storia delle finanze del Regno di Napoli, Napoli, Stamp. Reale, 1859, pp.535-45 e passim. Vd. pure N. F. FARAGLIA, Storia dei prezzi in Napoli dal1131 al 1860, Napoli, Stamp. Nobile, 1878, pp. 299 e sgg., il qualepone l'attenzione maggiore sui grani e sui salari.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
quelle zone che vivevano di questa coltura.Se però per i prezzi dei grani le analisi diStorchi sembrano rendere ragione di questa ipotesi,essendo i prezzi del grano più alti del regnoproprio nel Salerniatno, ciò non pare confermareuna economia della vigna degna di nota. Per quantoconcerne il vino bisogna dire che né il regno, nétanto meno la Costiera avevano una produzionevinicola degna di nota37. È stata nel tempo smentitala consistenza della produzione vinicola nellacostiera amalfitana, che era invece più viva nellazona cilentana38. La stessa Statistica neridimensionava molto la portata quando diceva che“Il vino di quei territorj si è come essi didifferente qualità e di pochissima quantità, nientebastevole nemmeno per il terzo della necessitànazionale”39. In sostanza, se produzione vi fu, era
37 M. R. STORCHI, Prezzi, crisi agrarie e mercato del grano, cit., passim; eId., Grani, prezzi e mercati nel Regno di Napoli (1806-1852), e A. LEPRE,Produzione e mercato dei prodotti agricoli, entrambi in Il Mezzogiorno preunitario.Economia, società e istituzioni, a cura di A. Massafra, Bari, Dedalo, 1988,pp. 121-48. Non così in V. CIMMELLI, Agricoltura ed economia agricola nellaValle del Sarno 1800-1860, in BSSPC, V, 2, 1987, pp. 87-105.38 F. VOLPE, Il Cilento tra antico e nuovo regime, Napoli, ESI, 1998, pp. 47e sgg. Inoltre P. BEVILACQUA, Clima mercato e paesaggio agrario nelMezzogiorno, in Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea, 3 voll., acura di P. Bevilacqua, Venezia, Marsilio, 1989, vol. I, pp. 643-67, in particolare p. 658, per notare l'inarrestabile deperimentodell'industria vinicola verificatosi ben prima della fine delXVIII secolo. 39 La «Statistica», cit., tomo IV, sez. Sussitenza della popolazione, p. 566.Anche il L. BIANCHINI, Della storia delle finanze, cit., p. 545, portaval'attenzione sull'aumento dei vigneti, ma non dei traffici di vinoall'estero. Per un'analisi di questo aspetto vedasi P. TINO, Napolie i suoi dintorni. Consumi alimentari e sistemi colturali nell'Ottocento, in
RICCARDO P. CONTE
per lo più finalizzata all'autoconsumo e allavendita sui mercati locali, la cosiddetta “venditaal minuto”, non già ad un commercio di entità taleda giustificare un aumento della natalità40. L'olio– certamente non un prodotto di punta costiero –non fu interessato da una diminuzione, ma da unaumento dei suoi prezzi già nel 1819; è da dirsipoi, mercè gli studi della Onorato, che esso venivaaddirittura importato nella stessa Costiera, laquale tutt'al più poteva esportare olive41. Relativamente agli agrumi e alla frutta, già ilBianchini aveva notato esservi stato un copiosoaumento nelle produzioni e nei commerci (la cuientità gli era però impossibile calcolareinqantoché erano navi straniere che caricavano lemerci)42. All'interno del Principato Citeriore, lacosta amalfitana non era l'unica a produrne, ma –stando al Tajani – era quella che produceva laqualità migliore di tutte, ed era infatti perquesto che tali merci erano vendute finanche sui«Meridiana», 1993, n.18, pp. 47-99, segnatamente 70 e sgg.40 Cfr. R. P. CONTE, Classe dirigente e amministrazione, cit., pp. 89-90,in cui si dice delle pressioni fatte da un politico del posto perfar vendere il proprio vino in alcuni spacci locali. Cfr. anche S.ROMANO, Economia e società tra crisi di fine Settecento e la prima metà dell'Ottocento, inTramonti la terra operosa, a cura di C. P. Di Martino – M. C.Sorrentino, Amalfi, CCSA, 2008, pp. 253 e sgg. il quale difattinon fa parola alcuna in merito alla produzione vinicola.41 Cfr. M. R. A. ONORATO, Rotte marittime e vie di comunicazione nel PrincipatoCiteriore borbonico, in Il Mezzogiorno preunitario, cit., pp. 271-90; ed Ead.,Autoconsumo o scambi interprovinciali (1806-1860)?, in Salerno e il Principato Citra inetà moderna, cit., pp. 707-12. Vedi anche G. BARBERA CARDILLO, Allaricerca di una reale indipendenza. I Borboni di Napoli e la politica dei trattati, Milano,Franco Angeli, 2013, passim.42 L. BIANCHINI, Della storia delle finanze, cit., pp. 545 e sgg.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
porti americani, e potrebbero di per sé stessegiustificare un aumento della natalità, dovuto adun aumento dei redditi43. Infatti, ancòra una volta,se l'aumento demografico è dovuto al prevaleredell'agricoltura dell'albero rispetto a quello delgrano, ciò spiegherebbe come mai il territorio checonteneva la più parte dei vigneti, Tramonti, abbiaperciostesso visto un costante, notevole erepentino incremento nella prima metà del XIXsecolo. Questo paradigma esegetico – basantesi suldeterminismo tra abbassamento dei prezzi deiprodotti della vigna e aumento demografico nellezone di maggior presenza della vigna –effettivamente ben si accorda con l'esigua presenzadi vigneti in Conca (40 moggi) e Furore (49 moggi)che ebbero un tasso d'incremento naturale negativola prima e praticamente vicino allo zero laseconda; malauguratamente non spiega come mai ilterritorio che dopo Tramonti aveva più vigneti,Ravello (272 moggi), non si sia ingrandito quanto ecome Maiori (262 moggi) o Amalfi (240 moggi) oMinori (33 moggi)44. Non spiega quindi come mai nonsi sia attenuato il dislivello nei tassi di
43 D.TAJANI, Monografia, cit., p. 23. Cfr. P. BEVILACQUA, Breve storiadell'Italia meridionale, cit., p. 44, afferma che “gli agrumi, in quellafase, sempre più richiesti sulle mense della ricca borghesiaamericana ed europea, si diffusero con intensità crescente”. Cfr.Id., Tra natura e storia. Ambiente, risorse, economie in Italia, Roma, Donzelli,2000, pp. 70 e sgg.; P. TINO, Napoli e i suoi dintorni, cit., pp. 79 esgg.; e S. LUPO, Il giardino degli aranci. Il mondo degli agrumi nella storia delMezzogiorno, Venezia, Marsilio, 1990, il quale si interessaspecificamente dell'area siculo-calabrese.44 V. AVERSANO, Geografia comparata, cit., pp. 312 e sgg.
RICCARDO P. CONTE
mortalità\natalità tra l'asse Atrani, Minori,Maiori – plaghe “operaie”, in cui vi era maggiorconcentrazione di pastifici e cartiere (settore,quest'ultimo, già abbondantemente in crisi45) – edil resto della zona – ove vi era una maggiorconcentrazione colonico-contadina. Minori, più dialtre avrebbe dovuto rimanere indietrodemograficamente, ed avviene invece l'esattocontrario. Eppure sono queste zone nelle quali c'èuna consistente fetta di lavoro artigianale dovutoalla produzione di paste, e ove il prezzo alto deigrani andava a tutto detrimento di quelle comunità,a cagione del quale non avrebbero potuto lavorare,e a fortiori crescere. Certo, anche quest'ultimointerrogativo potrebbe esser risolto avendomaggiori dati su cui basare l'analisi del tasso diincremento naturale, come prima si diceva. Non cheil Delille non fosse ben consapevole dei limiti edelle difficoltà di questa lettura; era anziproprio per questo che si era rivolto agli aspettied alle convenienze sociali, nonché ai rapportieconomici al fine di spiegare più estesamente icambiamenti intercorsi nella dialettica tranatalità e mortalità46.
III. Il settore primario e quello secondario – LaCostiera si reggeva su di un precario equilibrio incui erano coinvolte molteplici sfere economiche,che però erano vincolate l'una all'altra dal grano45 R. P. CONTE, Classe dirigente e amministrazione, cit., pp. 28 e sgg.46 Vd. soprattutto G. DELILLE, Famiglia e proprietà nel regno di Napoli,Torino, Einaudi, 1988, pp. 326-38 e passim.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
ed i suoi circuiti. È d'uopo allora notare in primaistanza che non tutte le realtà costiere vivesserodell'agricoltura dell'albero stricto sensu: molte zonedel Principato Citeriore erano caratterizzate sì daaree boschive, ma a cui si appaiava però lacosiddetta “selva cedua”, ossia un'area boschivadestinata al taglio. Pratica nefasta quanto sivuole, ma talune comunità sia della provincia(soprattutto le cilentane), sia della Costieratraevano ottimo partito dal taglio e vendita deilegnami, dei quali – come già ebbe a sottolineareil Braudel47 – difettava il Mezzogiorno e di cui eraquindi particolarmente famelico48. Questa praticaera particolarmente viva in comuni come Scala, dovenon vi erano industrie ma in cui vi era una doviziedi codesta selva cedua. Gli abitanti erano adusi araccogliere la legna secca, unica vera industrialocale, per venderla nei comuni vicini, i quali sene servivano per alimentare i forni, ma non solo49;ci si può facilmente immaginare che tutti i comuniove fossero dislocati i forni tanto per la mera“panizzazione”, tanto per fare le paste avessero47 F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, 2 voll.,Torino, Einaudi, 1953, vol. I, p. 146.48 Annali Civili del Regno delle Due Sicilie, fs. CIX, vol. LV, 1855, pp. 39-44. Sul disboscamento vd. P. TINO, La montagna meridionale. Boschi, uomini,economie tra Otto e Novecento, in Storia dell'agricoltura italiana, cit., vol. I,pp. 715-37; e G. GALASSO, Storia del Regno di Napoli, vol. VI, cit., pp.35-64. Per il Principato Citra cfr. W. PALMIERI, Alcuni dati sui boschinelle province meridionali nell'Ottocento preunitario, in «Quaderni ISSM», n.174, Napoli, 2012, pp. 13 e sgg. 49 ASS, Intendenza, Annona, B. 629, f. 1 e sgg. Cfr. P. BEVILACQUA,Tra natura e storia, cit., pp. 163-218; e P. TINO, Napoli e i suoi dintorni,cit., p. 72.
RICCARDO P. CONTE
necessità di approvvigionarsi sistematicamente aquesto mercato, quella combustibile essendo lafonte di energia per eccellenza. Tale era iltraffico dei legnami che dal Decennio francese inavanti, fu istituita una tassa su tale merce, cheera quella che rendeva di più al comune, essoavendo poco o niente da riscuotere50. Un discorsoconsimile vale pure per la vicina Ravello, laquale, sebbene avesse un quantitativo di terrenodecisamente inferiore a Scala, pure aveva un suomercato del legname che attingeva grandemente dalleproprie esigue risorse silvestri51.Talaltre – come Conca, Positano e Praiano, unaplaga che non brillava né per l'agricoltura né peril settore secondario – avevano categoriebracciantili che vivevano unicamente della pesca,(senza per questo disdegnare l'attivitàimprenditoriale della pasta e della carta, che perònon avevano la stessa incidenza economica che siriscontra altrove). Anche Vietri aveva maestranzededite alla pesca, e nel 1819 era stata vietata lapesca di nudilli, alicelle e saredelle, che sepescati eccessivamente avrebbero danneggiata lafauna marina impedendole di riprodursi. Il sindacorisponde che “non si distrugghino quelle piccolespecie” che, una volta cresciute potranno“apportare l'abbondanza alle popolazioni, chevivono con la pescazione”52.50 ASS, Intendenza, Conto materiale, B. 3950.51 Ivi, BB. 3832-33-34. Cfr. P. TINO, La montagna meridionale, cit.,pp. 682 e sgg. 52 ASS, Intendenza, Statistiche, B. 1759, ff. 51-3. P. TINO, L'Italia
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
Cert'altre ancòra avevano invece vocazionieminentemente secondarie. E la stessa Tramonti,benché tutta tesa all'agricoltura, aveva lecartiere più produttive della zona. E se l'àmbitodella carta faceva segnare un irreversibile periododi crisi, ciò non valeva per l'attività deipastifici che invece lavoravano a pieno regime, eche talvolta riuscivano a calamitare manodopera daaltri comuni, attirandosi così le lamentele deinaturali che viceversa restavano senza lavoro: è ilcaso di Minori e Vietri53. Insomma, la macroregioneCostiera è un panorama estremamente eterogeneosotto il rispetto economico, che vede unaaltrettanto eterogenea commistione tra settoreprimario e secondario, estrinsecantesi in formereddituali molto diverse.Ancorché si sia deterministicamente portati aindividuare nell'accresciuta popolazione un nessocausale con le migliorate condizioni di vita, lasituazione in cui versavano i braccianti (cioè la
meridionale e il mare. Pesca, natura e insediamenti costieri tra XVIII e XIX secolo, inNatura e società, cit., pp. 97-129; A. CLEMENTE, La pesca napoletananell'Ottocento tra tradizione e innovazione: le traiettorie di un declino, in Pesci, barche,pescatori nell'area mediterranea dal medioevo all'età contemporanea, a cura di V.D'Arienzo – B. Di Salvia, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 404-21;M. ARMIERO, L'Italia di Padron 'Ntoni. Pescatori, legislatori e burocrati tra XIX e XXsecolo, in A vele e a vapore, a cura di P. Frascani, Roma, Donzelli, 2001,pp. 177-213. 53 ASS, Intendenza, Annona, B. 628, f. 24. Cfr. D. IVONE, L'industriadelle paste alimentari nella costiera amalfitana tra Ottocento e Novecento, in La costa diAmalfi nel secolo XIX, cit., vol. I, pp. 251 e sgg.; R. FUSCO, Laproduzione delle paste alimentari, in Le arti dell'acqua e del fuoco. Le attivitàproduttive protoindustriali della Costa d'Amalfi, Amalfi, CCSA, 2004, pp. 65-75; R.P. CONTE, Classe dirigente e amministrazione, cit., pp. 22 e sgg.
RICCARDO P. CONTE
stragrande maggioranza della popolazione) non eracertamente una delle più felici d'Europa. A benvedere, non solo si è rivelata essere fallacequesto tipo di inferenza, ma, anzi, diversi studihanno dimostrato che in verità il determinismo puòessere interpretato in senso inverso: ad un aumentodemografico conseguirebbero peggiori condizioni divita, sia economiche che alimentari. Se dunque un miglioramento non era provenutodall'aumento dei poteri d'acquisto, di contro, unmiglioramento delle condizioni di vita sanitariadeterminerebbe invece una diminuita mortalità,sarebbe a dire l'allungamento della vita media; edè il caso della Costa d'Amalfi. Ne consegue quindiche non necessariamente la diminuita mortalità siada attribuirsi ad un aumento del reddito, e,quindi, la popolazione può da ultimo aumentare purrestando ugualmente misere le sue condizionieconomiche54. La popolazione della costiera sarebbequindi potuta aumentare indipendentemente dairedditi, dal tenore di vita e dal potered'acquisto, aggravando così le sue condizionimateriali ed economiche. L'aumento demografico sefosse dovuto ad un aumento dei redditi, sitradurrebbe ipso facto in un'accresciuta natalità; dalmomento che la Costiera non è particolarmente54 Cfr. A. PLACANICA, Uomini, strutture, economia in Calabria nei secoli XVI-XVIII.Demografia e società, Reggio Calabria, Edit. Merid. Riuniti, 1974, pp.42-7; e F. VOLPE, La borghesia di provincia nell'età borbonica, Napoli, ESI,1991, pp. 133-4. Non mi ritrovo quindi con quanto affermato da G.GALASSO, Mezzogiorno medievale e moderno, cit., pp. 304, il quale sibasa su C. M. CIPOLLA, The economic history of world population,Harmondsworth, Penguin, 1962.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
interessata da un fenomeno di accresciuta natalità(se non in determinate zone), i redditi dovrebberoessere rimasti sostanzialmente stabili. Di fatto, iredditi qui come altrove55, a parte qualchesporadica oscillazione, si erano mantenuti costantidall'inizio del secolo fino all'unità; a rigore erail potere d'acquisto ad essersi mantenuto costante,giacché – com'ebbe a sottolineare il Faraglia –all'aumento dei prezzi del grano sarebbecorrisposto un altrettale aumento dei salari56.Infatti notiamo che allorquando l'acuirsi deiprezzi ha il proprio démarrage, ossia poco dopo lametà degli anni Trenta, si manifesta un consimilesalire dei redditi degli amministratori. A Vietrile retribuzioni seguono questo trend: nel 1816vengono corrisposti all'amministrazione stipendiper 1.120 duc.; nel 1835 erano aumentati a 1.314;nel '45 passano a 1.520; e nel '52 sono 1.58957. Nondiversamente a Cetara, che dal 1836 al 1860 vede unaumento senza soluzione di continuità: da 256.55
55 Cfr. P. MALANIMA, Wages, productivity and working time in Italy (1270-1913),in «Journal of european economic history», 36, 2007, pp. 127-74; P.MALANIMA, V. DANIELE, Il prodotto delle regioni e il divario Nord-Sud Italia (1861-2004), in «Rivista di politica economica», 2007, XCVII, pp. 1-49;si veda pure il classico D. DEMARCO, Il crollo del Regno delle due Sicilie,Napoli, ESI, 2000, p. 208. 56 N. F. FARAGLIA, Storia dei prezzi di Napoli, cit., pp. 304, 319 e sgg.Un ipotesi su cui converrà poi B. H. SLICHER VAN BATH, L'agricolturanella rivoluzione demografica, in Storia economica Cambridge, Torino, Einaudi,1878, vol. V, passim. Molteplici sono comunque le ipotesi; persemplicità rimando a W. ABEL, Congiuntura agraria e crisi agrarie, Torino,Einaudi, 1976, pp. 293 e sgg., il quale ne discute alcune tra lepiù accreditate.57 ASS, Intendenza, Conto materiale, BB. 3993-3994.
RICCARDO P. CONTE
duc., in un decennio arriva a 408.40, fino ai442.16 del 185958. A Maiori le retribuzioni eranoandate crescendo già dal 1815, in cui erano a400.25 duc., passando poi a 551 duc. nel 182959. Lafascia in recessione demografica li aveva vistiinvece decrescere: se Prajano ebbe una stagnazionetra il '40 ed il '60 (da 218 duc. si era passati a217.50 duc.), Positano decrebbe le retribuzioniamministrative da 474.17 duc. nel 1840 fino a417.39 duc. nel 186060. Tuttavia se ci addentriamonei singoli ambienti amministrativi balzaimmantinente all'occhio che essi si erano mantenuticostanti, quando non erano andati addiritturacalando (vd. Appendice). È bene sottolineare peròcome questo tipo di reddito riguardasse pur sempreuna singola fascia sociale, ossia quella delterziario (quella né produttiva né trasformativa),numericamente ancòra insignificante perché lamaggioranza della popolazione era impiegata neglialtri due settori, soprattutto nel primo. Ladocumentazione non ci permette ad oggi speculazionidi sorta sull'andamento di salari, rendite eprofitti durante la prima metà del secolo per laCostiera, ma non sembra un caso che l'area indepressione demografica fosse caratterizzata daun'economia eminentemente marittima, cioè un tipodi economia tra le più povere di sempre nelMediterraneo, un grande mare ma comprensibilmente58 Ivi, B. 3646.59 Ivi, BB. 3716-3717-3718-3719-3720.60 Positano cfr. ivi, BB. 3823-3824-3825-3826; per Prajano BB. 3832-3833-3834.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
con pochi pescatori61. Da un punto di vista squisitamente economico, èfacile notare come tutte le aree che avessero unavviato settore secondario, fossero in una fasetanto di promozione sociale ma anche di espansioneeconomica; anche qui però dei distinguo sarebberoopportuni. Le “liste degli eligibili” parrebberosuffragare quanto appena detto: l'area che siingrandisce demograficamente (da Vietri ad Amalfi)è anche quella che vede aumentare il numero degliabbienti: le liste di tali comunità sonointeressate da un aumento dei compartecipantiall'agone politico. Per converso l'area inrecessione (Conca-Positano) non è interessata da unsimilare aumento dei benestanti, ma semmai da unaloro diminuzione. Donde parrebbe facile inferirneche il secondario ed i redditi che produceva sianostati la chiave di volta dell'espansione, laddovel'attività della pesca l'abbia nettamentecompromessa; ma di nuovo il caso di Tramontirintuzza questa ipotesi, dal momento che il suocomportamento sociale è identico alle aree inrecessione (il numero degli iscritti nelle listeinfatti diminuisce), eppure sappiamo essere inespansione come e più delle altre. Ma ancòra, Ravello, la quale certamente non vivevadel secondario, pure si espande siademograficamente che economicamente62; infine
61 P. TINO, L'Italia meridionale e il mare, cit., p. 99.62 Cfr. R. P. CONTE, Le “liste degli eligibili” della costa d'Amalfi, in «Annalistorici di Principato Citra», A. XII, n.1, 2014, pp. 124-34; e A.CONTE, Gli eligibili della costa di Amalfi nell'ultimo periodo borbonico, in La costa di
RICCARDO P. CONTE
Atrani, che pure aveva una sua economia marittima,non ha un andamento demografico connotato da untrend negativo. In particolare questi ultimi dueesempi mostrano perspicuamente come anche economienon particolarmente floride abbiano consentito uningrandimento demografico.
La condicio sine qua non della crescita demografica èche la produzione non aumenti parallelamente con lapopolazione, ma la superi di gran lunga: primaaumenta lo stock, e solo dopo aumenta lapopolazione63. A fronte delle inizialiconsiderazioni riguardanti la eziologia dellacrescita nel Regno di Napoli, certamente non si puòascrivere alle due rivoluzioni (agraria eindustriale) una siffatta ascesa demografica.Sebbene si ritenga a buon diritto essersiverificata una “rivoluzione commerciale” nelmeridione – un cospicuo ampliamento del mercato edei rapporti commerciali, così come delle velocitàdi commercio e trasporto – è però fuori d'ognidubbio che non fosse stato altresì investito da unarivoluzione industriale. Certo, anche qui eranostate apportate nel tempo delle migliorieproduttive; e pur non potendosi parlare di
Amalfi nel secolo XIX, cit., vol. I, pp. 41-52; Id., Antiche e nuove élitesnell'ultimo periodo borbonico: gli eligibili del comune di Salerno, in L'éliteamministrativa a Salerno negli anni della Restaurazione (1815-1860), a cura di L.Rossi, Salerno, Quaderni del Dipartimento di Teoria e Storia delleIstituzioni, pp. 14 e sgg.63 Tale assunto, condiviso dal gran parte della storiografia,rimonta al Galiani; cfr. A. DE MATTEIS, La vicenda del popolamento, cit.p. 71.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
rivoluzione, è innegabile che un'incipienteindustrializzazione – pur nella sua diversità daiben noti fenomeni anglosassone e francese – fossevisibile in alcune zone64. E purtuttavia sotto ilriguardo dell'aumento demografico, ascrivere unapreminenza agli aspetti meramente economico-monetarî su quelli agricoli porterebbe aconclusioni fallaci. A tal proposito esempla moltobene la questione proprio il caso salernitano. Lastoriografia ha ravvisato nei celebri cotonificisalernitani caratteri ed elementi spiccatamenteprotocapitalistici, e c'è senz'altro del vero inciò65. Ma se guardiamo gli indici di crescitademografica di Salerno, ci si avvede che essi eranoi più bassi di tutti (Tab. 4), eppure quegli operaiavrebbero avuti addirittura i salari più alti del
64 P. BEVILACQUA, Breve storia dell'Italia meridionale, cit., pp. 32-58 esgg. e G. GALASSO, Storia del Regno di Napoli, vol. VI, cit., pp. 467 esgg. Per l'area salernitana A. MUSI, Manifatture, preindustria eprotoindustria in Principato Citra (secc. XVI-Prima metà XIX), in «Rassegna StoricaSalernitana» (RSS), A. XIII, n. 1, 1996, pp. 152-74; e S. DE MAJO,Produzione agraria, pluriattività e protoindustria in Principato Citra nell'Ottocentopreunitario, in RSS, A. VI, n. 2 (12), 1989, pp. 141-213.65 Cfr. S. DE MAJO, Dalla casa alla fabbrica: la lavorazione delle fibre tessilinell'Ottocento, in La Campania, a cura di P. Macry – P. Villani, inStoria d'Italia, Le regioni, Torino, Einaudi, 1990, pp. 319 e sgg. Id.,L'industria protetta. Lanifici e cotonifici in Campania nell'Ottocento, Napoli, Athena,1989. G. DE CRESCENZO, Le industrie del Regno di Napoli, Napoli, Grimaldi,2001, pp. 85 e sgg.; G. WENNER, L'industria tessile salernitana dal 1824 al 1918,Napoli, ESI, 1983; A. SPAGNOLETTI, Storia del Regno delle Due Sicilie, cit.,pp. 262 e sgg. Per alcuni ragguagli sulla classe operaiasalernitana si vedano i lavori di L. CASSESE, Contadini e operai nelSalernitano nei moti del quarantotto, in RSS, A. IX, nn. 1-4, 1948, pp. 5-74; e di A. GENOINO, Agitazioni operaie e moti comunisti nel Salernitano. Il 1848,Cava, Coda, 1936.
RICCARDO P. CONTE
regno66. La posizione che vede nell'espansione dellaeconomia una altrettale espansione demografica ètroppo superficiale e semplificante, perché noncoglie il nesso causale, cioè che non è con lamoneta che si nutrono gli stomaci67. La monetapermette semmai di acquistare il nutrimento, masolo se questo è disponibile. Si potrebbe infattiverificare il caso di un massimo di denaro liquidoed eo ipso un minimo di risorse, la qual cosa eraavvenuta nel XVII secolo: mastodontiche massemonetarie che potevano comprare un'infinità dirisorse, che purtroppo la terra non era in grado diprodurre. E qualora le risorse non permettessero dialimentare la popolazione, si finirebbe per credere– come sosteneva il conte Attilio alla tavola diDon Rodrigo, o come si credeva comunemente nellacrisi del 1816-17 – che siano piuttosto gliincettatori e i fornai a nascondere il grano (che66 Cfr. D. DEMARCO, Il crollo del Regno delle Due Sicilie, cit., pp. 146 esgg., in cui sono riportati i salari delle maestranze salernitane,che stando a E. DELLE DONNE, Attività manifatturiera fra tradizione einnovazione, in Il Principato Citeriore tra Ancien Régime e conquista francese,cit., p. 271 sarebbero stati i più alti del Regno. Cfr. i saggi diRossi e Parrella in Storia di Salerno, vol. III, a cura di G.Cacciatore, Avellino, Sellino, 2008; e A. MUSI, Il Principato Citra dal1266 al 1861, in Storia del Mezzogiorno, cit., vol. V, p. 312 e sgg.67 Sarebbe troppo lungo approfondire in questa sede tale complessodiscorso. Per una ragionata bibliografia sull'argomento si rimandaa T. DETTI, G. GOZZINI, L'Ottocento, Milano, Mondadori, 2000, pp. 36-8; per l'Italia vd. M. AYMARD, La transizione dal feudalesimo al capitalismo,in Storia d'Italia, Annali, Torino, Einaudi, 1978, vol. I, Dal feudalesimo alcapitalismo, pp. 1133-92. Per il Mezzogiorno cfr. A. LEPRE, IlMezzogiorno dal feudalesimo al capitalismo, Napoli, Società editricenapoletana, 1979.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
in realtà non c'era). Perché anche la terra ha deilimiti e non può nutrire oltre un certo limite (èla fin troppo nota trappola di Malthus), a meno chenon intervengano profonde migliorie che aumentinograndemente le rese unitarie, ciocché eragiustappunto avvenuto con la “rivoluzioneagricola”. Nelle plaghe meridionali l'accresciutadomanda si era estrinsecata nell'estensionedell'area coltivabile (cfr. ultra). Epperò la preminenza del settore primario sulsecondario non spiega l'antitesi più evidente,ovvero come mai la demografia sia stataletteralmente “esplosiva” in certe aree delSalernitano indifferentemente dalla loro vocazionesocio-economica: sia che avessero un'economiaagricola basantesi in toto sul settore primario, comeil distretto cilentano di Vallo, la zonacerealicola più florida; sia che avesseroun'inclinazione più secondaria come Cava eSanseverino-Baronissi; sia che fossero un giustomélange delle due come l'agro nocerino ove sicoltivava il cotone, che però poi veniva impiegatonei celebri cotonifici68. Ebbene, se per quanto68 A. SINISI, Mutamenti colturali ed irrigazione nel Principato Citra, in IlMezzogiorno preunitario, cit., pp. 103 e sgg.; e S. DE MAJO, Produzioneagraria, pluriattività e protoindustria, cit., p. 153; su Cava cfr. Id.,L'industria dei mercanti. Il sistema commerciale e manifatturiero di Cava dei Tirreni nel XIXsecolo, Salerno, Laveglia&Carlone, 2012; Id., Il sistema protoindustriale diCava dei Tirreni nell'Ottocento, in Tra storia e storiografia, cit., pp. 775-88; G.FOSCARI, Economia e società locale nel Mezzogiorno: reddito e gabelle a Cava 1806-1860, Nocera, Alethèia, 1991; Id., Terra ed economia in un comune delMezzogiorno napoleonico: Cava dei Tirreni, in «Ricerche di storia sociale ereligiosa», 29, 1986, pp. 67-92. Sull'agro nocerino oltre alsurriferito Cimmelli, cfr. E. DE NICOLA, Il Borgo ed il Mercato di Nocera
RICCARDO P. CONTE
riguarda le zone a vocazione marcatamente agricola,la richiesta di manodopera era pressoché continua,tale da giustificare un aumento demografico, dovutoanche ad un comprensibile e sostenuto afflusso diimmigrati dalle aree finitime (ma non solo), comespiegare invece il caso di Cava, che si avvalse –come fece Salerno – della materia prima (il cotone)piantata nelle vicine fertili plaghe dell'agro? Sidovrebbe dire che anche il settore secondario fosseanch'esso in grado di attrarre bracciadall'esterno. Ed effettivamente le stesse Vietri eMinori coi loro pastifici ebbero un bel daffare conun'immigrazione a fini lavorativi. Ma se alloraanche il settore secondario fosse stato in grado dicalamitare manodopera esogena, non si intende comemai non si sia inverata questa ipotesi anche peraltre aree del Principato Citra ad economiaaltrettanto secondaria, come Salerno ed i suoicotonifici (di cui sopra) o come le stesse
dei Pagani tra XVIII e XIX secolo, in RSS, n. s. XIV, n. 27, 1997, pp. 113-60; Su Sanseverino si vedano i vari saggi contenuti in MercatoSanseverino e la sua storia, Salerno, Plectica, 2004. Sull'area cilentanacfr. L. ROSSI, Il reticolo urbano e la dinamica economica in provincia di Salernodurante l'Ottocento, in Le città del Mezzogiorno in età moderna, a cura di A.Musi, Napoli, ESI, 2000, pp. 385-434; Id., Profili socio-economici di unMezzogiorno minore, Acciaroli, Centro di promozione culturale per ilCilento, 1992, pp. 81-156; Id., Terra e genti del Cilento borbonico,Salerno, 1983, pp. 100-60; e R. MARINO, Aspetti dell'agricoltura cilentananella prima metà dell'Ottocento, in Guida alla storia di Salerno e della sua provincia,3 voll., a cura di A. Leone – G. Vitolo, Salerno, Laveglia, 1982,vol. III, pp. 665 e sgg. Su Montecorvino, oltre al cennato lavorodi De Majo, cfr. V. AVERSANO, In destra Sele: rapporti montagna-collina-pianurae frazionamento amministrativo negli ultimi due secoli, in «Annali» del centrostudi Antonio Genovesi per la storia economica e sociale, vol.III, 1999, pp. 93-113.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
Tramonti, Amalfi e Maiori. A ben vedere il settore secondario avanti larivoluzione industriale non aveva un'economia ingrado di competere – anche solo lontanamente – conquella del primario69, e ciò vale in particolar modonella Costiera che non si era tenuta al passo coitempi. Colà difatti la manodopera proveniente da“fuori”, era in effetti forza lavoro dei comunilimitrofi che non trovava occupazione nei propri,ed era pertanto costretta ad “emigrare” nei comunicontermini; è il caso dell'area che abbiamo vistaessere interessata da trend negativi, la fascia chesuperata Amalfi va da Conca a Positano, oggetto diun progressivo spopolamento70. Messo poi a paragonecol primario, il settore secondario aveva capacitàdi assorbimento estremamente limitate, nellaCostiera siamo su un 4% circa del popolazionecomplessiva, quindi certamente non tali da potergiustificare un accrescimento progressivo dellapopolazione. Escludendo l'economia certamente nontrainante delle ceramiche – che riguardòesclusivamente Vietri e non tutta la Costiera –, ildeclinante settore cartario accoglieva circa 1.281operai negli anni Cinquanta, ma il numero si andavaassottigliando di anno in anno, la crisi essendoinarrestabile. I vari comuni costieri tentarono disopperire alla incalzante disoccupazione impiegando
69 G. GALASSO, Storia del Regno di Napoli, vol. VI, cit., pp. 517-602; eA. LEPRE, Storia del Mezzogiorno d'Italia, cit., vol. II, pp. 145-9.70 ASS, Intendenza, Annona, B. 629, f. 2 e sgg. Si veda la letterada Vietri, 4 Ottobre, 1853. Per i dati sui cotonifici svizzeri, S.DE MAJO, Produzione agraria, pluriattività e protoindustria, cit., p. 179.
RICCARDO P. CONTE
questa manodopera nella costruzione di operepubbliche, cui si attese a quel tempo71. Per quanto concerne i pastifici (settore che se nonera in espansione, aveva comunque un suo mercato)siamo nell'ordine di circa cinquecento posti dilavoro in tutta la Costiera, la più parte situatain Amalfi, ben distanti quindi dai numeri deicotonifici svizzeri sparpagliati in tutto ilSalernitano72. I profitti alquanto esigui – compliciretrive metodologie di produzione – non eranocertamente atti a favorire un irrobustirsi deicapitali immessi, cui eventualmente avrebbe potutofar sèguito un aumento della manodopera73. Ma era inparticolar modo un settore estremamente precario:bastava una pioggia per mandare all'aria laproduzione giornaliera dei pastifici ed i loroguadagni. La pasta abbisognava di una particolareessiccazione, che un giorno di pioggia od anchesolo dell'umidità passeggera poteva inficiare74. Sepoi malauguratamente uno scarso raccolto (matalvolta erano anche semplici voci messe in giro diproposito) provocava un “incarimento” dei grani,71 Ibid. È il caso di Maiori nel '54 (ma il discorso riguarda anchegli altri centri costieri), in cui ”appalessasi una miseria,massime nella classe di bracciali una volta addetti alle macchineidrauliche per la fabrica della carta”.72 S. DE MAJO, Produzione agraria, pluriattività e protoindustria, cit., pp.167-173. Sulle ceramiche cfr. A. TESAURO, Le faenzere nell'apparatoproduttivo vietrese, in Le arti dell'acqua e del fuoco, cit., pp. 178-200, e labibliografia ivi contenuta. 73 Rimando all'analisi fatta in R. P. CONTE, Classe dirigente eamministrazione, cit., pp. 38-47.74 ASS, Intendenza, Annona, B. 628, f. 24 e sgg. Si veda la letterada Salerno, 18 Giugno 1854.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
erano pochi i pastifici che potessero permettersiil lusso di continuare il lavoro. A Scala 18 aprile1821, il sindaco faceva presente “che persone degnedi ogni eccezione del comune di Minori mi hannoaccertato niuna quantità di grano vi esiste, cheper ragione de' prezzi incariti, gl'industrianti dipaste lavorate hanno cessato di più farne, e soledue persone ne fanno, ma si provveggono del granoin ciascun mercato; in Ravello, ed in questo Comunemai vi è stata persona negoziante di tal genere, eperché tutti i poveri si provveggono alla giornatadel pane nel pub[bli]co forno, a riserva di pochiagiati cittadini che possono farsi la provvista maessendo terminata, anch'essi si servono alpubblico”75.Da ultimo, sia il settore secondario costiero, cosìcome quello di Salerno accoglievano manodoperaeminentemente locale. Il loro andamento, positivo onegativo, era ben lungi dall'avere una influenzaragguardevole sull'andamento demograficocomplessivo; piuttosto esso ne aveva solo sulparticolare contesto comunale, e ciò a motivo chesolo una porzione piuttosto esigua era impiegata intale economia, la mobilità non aveva la medesimaincidenza che poteva avere in altre aree comequella ebolitana o sarnese76. Quel che invececolpisce è la connessione, che prima si richiamava,tra i vari contesti economici e l'andamento delgrano. La crisi del primo lustro degli anni '50 fu75 ASS, Intendenza, Statistiche, B. 1759, f. 38.76 F. SOFIA, Popolazione e territorio ad Eboli, cit., p. 107; V. CIMMELLI,Agricoltura ed economia agricola, cit., passim.
RICCARDO P. CONTE
un banco di prova notevole per i precari equilibricostieri. Nell'Aprile del '54, il sindaco diMinori, piuttosto piccato, spiega icasticamente lostatus quo della società costiera, scrivendo che77:
Dopo le lusinghe e le speranze che un termine si fossedato all'attuale penuria, veggo sventuratamente crescereil bisogno, ed aumentare la pezzenteria. Ieri l'altroquando il sovrano si degnò di far proprio a questo paesedi onorarlo di sua presenza, trattenni i reclami diquesti sventurati, che volevano accorrere presso laClemenza del Re per chiedere ajuto e soccorso. […] Ellail sa che questo paese, veste le condizioni del pesce,che muore appena sorte dalle acque, così questi paesaniaddetti alla manipolazione delle paste muojono inerti,appena se ne attrassa il lavorio.
Ciò detto, è facile capire come la crisi di granifosse tale anche per quei comuni che non vivevanodella economia del grano, ma che il grano eranocostretti ad acquistarlo e non solo per motivialimentari. Ma è altrettanto immediato comprenderecome, allorché cessa il lavoro dei pastifici, nonsolo tale situazione crea disoccupazione nel comunede quo, ma si ripercuote anche su altre realtà comeRavello e Scala, le quali non potevano piùsmerciare il legname in Atrani ed Amalfi giacché ladomanda di combustibile era drasticamente diminuitain quanto a sua volta diminuita era la domanda digrano (che costava troppo)78. Il problema di quelledue comunità era che venendo meno questa attività,che stando alle allarmate parole del sindaco
77 ASS, Intendenza, Annona, B. 629. Minori nel Marzo del 1854.78 Ivi, B. 628, Scala, 21 Marzo 1854.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
avrebbe interessato “un terzo della popolazione”locale, mancavano i mezzi per poter comperare ilgrano, donde non solo l'aumento della miseria maanche la stagnazione demografica.Con ciò non si vuol certo dare una assoluta edinconcussa preminenza al primario sul secondario79,ma semplicemente coglierne l'effettiva portata neldiscorso sulla causalità demografica e comprenderecome segnatamente per il Mezzogiorno l'aumento deiprezzi del grano non avrebbe resa la sua domandapiù elastica, giacché non vi sarebbero stati benisostitutivi con cui sopperire, mais e patata nonavendo ancòra preso piede come nelle altre areeeuropee; tant'è che il governo stesso eranecessitato ad intervenire a calmierare i prezzi(la famosa e spesso disattesa assisa)80, pratica chetanto faceva imbestialire proprio fornai,incettatori et similia, una fauna professionale di cui
79 Alla luce di quanto finora detto, appaiono allora quanto menodiscutibili – a mio credere – talune affermazioni sull'incidenzadella pesca e del settore secondario tutto, nonché la totaleassenza dell'agricoltura nell'economia della Costiera fatte da S.DE MAJO, Produzione agraria, pluriattività e protoindustria, cit., pp. 171-3.Rimane tutt'ora poi aperto un interrogativo riguardante lacrescita di Cava, cui pure si contrapponeva la concorrenza deifilati meccanizzati salernitani, che prevalgono tra gli anniQuaranta e Cinquanta. Siccome è proprio dall'unità in poi cheSalerno sopravanzerà Cava, non è da escludersi che parte dellocale bracciantato cavese, all'affermazione definitiva delsistema industriale salernitano su quello protoindustriale cavese,sia passato nelle file dei cotonifici svizzeri. Alcune similiipotesi sono state ventilate da S. DE MAJO, Il sistema protoindustriale diCava, cit., pp. 785-8. 80 Sull'assisa G. LANDI, Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie,2 voll., Milano, Giuffré, 1977, vol. II, p. 1027.
RICCARDO P. CONTE
la Costiera abbondava potendo grandemente specularesull'assenza di grano. Perché calmierare un benedel quale si sarebbe semplicemente potuto fare ameno comperando alla bisogna una merce simile inalternativa alla prima, facendo così calare ilprezzo del primo bene? Perché, com'è noto, non cisi era ancòra emancipati dai circuiti del grano.Ciò significa che se la fascia costiera non ebbeuno sviluppo demografico paragonabile ad altre areedel Salernitano fu per una congerie di motivi:primo tra tutti il fatto che non facesse gola anessuno, e ciò a motivo delle sue vocazioniagricole. Gli incrementi sono dovuti a motivazionibiologiche, non già alla mobilità; fenomenoquest'ultimo cui si può invece facilmente ascriverela crescita delle altre succitate aree. Masignifica anche che non ebbe la stessa crescita pervia della sua agricoltura: se le altre aree delSalernitano erano così concupite era anche per lacoltura del grano (o quella del cotone per icotonifici), che richiamava manodopera dalle zonevicine, ma anche dalle lontane che ne rimpolpavanograndemente la demografia. Se ciò non valesegnatamente per Salerno e la Costiera, la cuimanovalanza era strettamente locale, vale per icotonifici scafatesi. Da ultimo si aggiunga chel'aumento dei prezzi, lungi dallo sfavorire larendita e i profitti delle zone del grano,grandemente le favorì, inverando quei copiosiaumenti di cui fu orfana la Costiera81. Questa ebbe81 Cfr. M. AYMARD, La transizione dal feudalesimo al capitalismo, cit.,pp. 1158-69.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
sì la sua crescita demografica, ma che non fu talein quanto differentemente da altre zone non attiròla manodopera forestiera, allettandola colle sicureretribuzioni salariali offerte dall'incipientesettore industriale. Nella costa, l'assenza di una forte oligarchiaeconomica è dovuta al maggior frazionamento dellaproprietà fondiaria e, quindi, alla maggioredistribuzione dei redditi. Il fatto che in Tramontinon si formi una cerchia sempre più corposa dimaggiorenti che accedono alle “liste deglieligibili”, può esser dovuto alla minoreconcentrazione dei redditi, che spiegherebbe ancheil suo incremento demografico82. All'aumento deiprezzi del grano, e quindi delle rendite e deiprofitti, corrisponde una generale diminuzione delpotere d'acquisto dei salari. Nondimeno, la forbicetra prezzi e salari non avrebbe avuta la stessadrammatica incidenza che ebbe in altre aree inquanto qui solo una piccola parte della popolazioneera salariata; il resto attendeva all'agricolturanella piccola proprietà, agricoltura di un settore,quale quello degli agrumi la cui domanda era increscita sui mercati vicini e lontani. Mal'incidenza ci fu, perché il prezzo del grano è unfattore decisivo anche per la Costiera ed i suoipastifici, ed è decisivo per le popolazioni che nonpossono ovviare al rincaro dei prezzi con un benead esso sostitutivo83.82 Il che mi pare confermi quanto ventilava G. DELILLE, Agricoltura edemografia, cit., pp. 63, 103, 124 e passim.83 Cfr. M. LIVI BACCI, Popolazione e alimentazione. Saggio sulla storia
RICCARDO P. CONTE
Tuttavia, anche a fronte degli assunti testéproposti, resta il problema di come abbia potutouna società concentrata in uno spazio geograficocosì ristretto, aumentare tanto costantemente,atteso che già nel XVIII secolo patisse scarsezzadi viveri (che le dovevano giungere dall'esterno);le possibilità di autoconsumo erano state insommasuperate ab immemorabili, tanto che parrebbedifficile anche solo immaginare un'ulteriorecrescita in un ambiente così costipato come quellacostiera.
IV. Una battaglia per il grano – La questionemeramente alimentare non può trovare soluzionealcuna nella messa a coltura di nuove terre. Vero èche nella maggior parte del Mezzogiorno si eraproceduto sistematicamente a sfamare le nuovebocche attraverso l'ampliamento dell'area dicoltivazione84, e ciò a tutto danno della
demografica europea, Bologna, Il mulino, 1987, passim. Si badi chenella quasi totalità dei casi, allorquando il grano aumentava diprezzo, anche il granone – con cui si alimentava la popolazione“infima” – aumentava di prezzo.84 G. CORONA, G. MASSULLO, La terra e le tecniche. Innovazioni produttive e lavoroagricolo nei secoli XIX e XX, in Storia dell'agricoltura italiana, cit., vol. I, pp.356-9, in cui si dice che “l'aumento di produzione, verificatosiin particolare nei periodi di maggiore incremento demografico,risulta affidato all'estensione delle colture e dei dissodamenti”.Sulla Campania cfr. P. TINO, Per una storia della Campania in etàcontemporanea, in «Annali» del centro studi Antonio Genovesi, vol.I, 1989, pp. 287-91; ed E. L. JONES, S. J. WOOLF, Agricoltura e sviluppoeconomico, Torino, Einaudi, 1973, pp. 7-14; e G. DELILLE, Agricoltura edemografia, cit., p. 126.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
produttività. L'accrescere il volume del prodottoatto a sfamare una crescente popolazione, mediantela messa a coltura delle terre marginali, nonsempre adatte alla coltivazione che di volta involta si tentava, fece cadere perentoriamente laproduttività (Ricardo a tal proposito parlerà di“legge dei rendimenti decrescenti”). Ma la messa acoltura delle terre marginali era una pratica tantoesiziale quanto inevitabile in talune realtà – eciò a motivo dell'assodata impossibilità climaticaper la più parte del Mezzogiorno di innesto dellefamose foraggere85. Tuttavia questa pratica eranella Costiera di fatto impossibile poiché nonc'era altro terreno disponibile. Cioè non erapossibile mettere a coltura le terre cosiddettemarginali, perché – oltre a quelle già coltivate odestinate al (pochissimo) pascolo – non ve n'eranoaffatto. Valga per tutti la situazione di Amalfi,esplicitata all'intendente dal sindaco nel Luglio183086.85 P. BEVILACQUA, Clima mercato e paesaggio agrario nel Mezzogiorno, in Storiadell'agricoltura italiana, vol. I, cit., pp. 647-8. “In terre dominate dafrequente aridità primaverile-estiva la coltura del trifogliodell'erba medica, della lupinella non perveniva a rese in grado dicompensare adeguatamente i costi e i rischi della coltivazione[…]. Accadeva infatti che d'inverno quando il fattore termico edunque la vita vegetativa era al minimo, al sud si aveva ilmassimo di pioggia; e viceversa d'estate, quando il fattoretermico era al massimo, e la vita vegetativa nella sua fase piùintensa, si aveva il minimo di pioggia.” Si vedano pure A.PLACANICA, Le vocazioni territoriali e le linee della trasformazione, in «MaterialiImes», 1986, 2; ed E. SERENI, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari,Laterza, 1962, p. 296. 86 ASS, Intendenza, Statistiche, B. 1757, f. 6. Cfr. pure G. M. GALANTI,Della descrizione geografica e politica delle due Sicilie, cit., vol. II, p. 364.
RICCARDO P. CONTE
i Comuni di questo circondario non hanno terreni dasperare la raccolta de' cereali, eccetto il solo Comunedi Agerola, i di cui naturali attualmente conservanoapprossimativamente mille tomola tra germano e grano,abbisognano quindi altre ottomila tomola permantenimento annuale, che si acquista in dettaglio ne'vicini mercati di Castellammare e Salerno
Purtroppo non era facile nemmeno rifornirsi, e giàil Galanti sul finire del XVIII secolo ci metteva agiorno sullo stato alquanto precario in cuiversavano le plaghe costiere relativamenteall'approvvigionamento. La situazione quasidisperata oggetto di una denuncia accorata delsindaco di Majori, fatta il 14 Aprile del 1822, èrappresentativa della condizione esistenziale diquelle popolazioni87.
avendo preso esatta informazione del quantitativo digrano esistente in questo circondario, mi sonoassicurato, non trovarsene quantità veruna; essendonecerto personalm[en]te dacché se il tempo non si sarebberimesso, io nella qualità di sindaco, sarei stato nellacircostanza di far varcare queste impenetrabilimontagne, per procurare il giornaliero necessario di talgenere per q[ue]sta popolazione, mentre assorbito daquel poco di mercato in mercato che qua s'incetta, ilmare non permetteva di farne pervenire di costà
Tanto meno si sopperì al crescente fabbisogno conun massiccio utilizzo delle culture intensive,giacché, se esse difettavano nel resto delMezzogiorno, erano di già ampiamente utilizzatenella costa d'Amalfi, non potendosi essa permettere87 Ivi, B. 1758, f. 6.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
altro che questo tipo di cultura88. Anche altre areedel Salernitano soffrivano la medesima scarsezza digrani, alla quale però riuscirono a sopperire neltempo attraverso la coltura maidica e quella dellapatata, che comunque durarono una certa fatica adinserirsi nella compagine colturale meridionale.Tuttavia, anche dopo il superamento dell'inizialescetticismo che ne aveva impedita la diffusione,esse non avevano attecchito nella zona costiera oveil clima mal si prestava per questo tipo dicolture, non a torto definite “di rapina”89. L'unicaarea in cui vi fosse un'estensione di coltura dellapatata – stando al Camera – sarebbe stata inTramonti, ma, benché fosse alquanto remunerativacome coltivazione, non si è in grado di capirequale sia stata la sua effettiva portata90. È88 C. MAIELLO, Pratiche colturali e conoscenze agronomiche sulla costa d'Amalfi nelSettecento, in La costa di Amalfi nel secolo XVIII, 2 voll., a cura di F.Assante, Amalfi, CCSA, 1988, vol. I, pp. 372 e sgg; G. IMPERATO,Note per una storia dell'agricoltura sulla costiera amalfitana, in Salerno e il PrincipatoCitra in età moderna, cit., pp. 521-43; L. CASSESE, La «statistica» del Regnodi Napoli del 1811. Relazioni sulla provincia di Salerno, Salerno, Società distoria patria, 1955, pp. 210 e sgg.; P. AMOS, A. GAMBARDELLA, Ilpaesaggio naturale-agrario della costa amalfitana, in «Promemoria», n. 4,Salerno, «magazzino» cooperativa editrice, 1976, pp. 7 e sgg.89 Sulla coltura della patata cfr. A. SPAGNOLETTI, Storia del Regnodelle Due Sicilie, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 256. Per il PrincipatoCitra vd. S. DE MAJO, Produzione agraria, pluriattività e protoindustria, cit.,pp. 153-4; e A. SINISI, Mutamenti colturali, cit., pp. 109-13. Sivedano pure P. TINO, La montagna meridionale, cit., passim; e M.AYMARD, Il Sud e i circuiti del grano, in Storia dell'agricoltura italiana, vol. I,cit., pp. 782 e sgg.; su mais e patata cfr. A. MASSAFRA, Campagne eterritorio nel Mezzogiorno tra Settecento e Ottocento, Bari, Dedalo, 1984, pp.34-9 e passim. 90 M. CAMERA, Memorie Storico-Diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalficronologicamente ordinate e continuate fino al secolo XVIII, 2 voll., Salerno,
RICCARDO P. CONTE
evidente che fosse insufficiente dal momento chenel 1820 si era tentata attraverso un'ingiunzioneformale dell'intendente la semina coatta dellapatata, ma tutti i comuni provvisti di terrenodisponibile avevano immediatamente rintuzzato iltentativo: la vocazione dei terreni costieri eradifatti chiamata a tutt'altri ardimenti colturali(quasi sempre agrumi e vitigni, dalle discrete reseunitarie e richiestissimi). Il sindaco di MinoriFilippo Gambardella “avvisa non esservi territorjin quel comune per piantarsi le patate”91.
Intorno alla seminaz[ion]e delle patate ho l'onoreparteciparle che il territorio di questo comune essendodi poca estensione e la maggior parte arbustato diagrumi, e viti. I proprietarj e i coloni de' priminessun genere vi seminano perché il terreno nienteproduce essendo tutto occupato dai fronzuti alberi, equelli de' secondi non vi seminano il genere desiderato,cioè le patate, perché offende l'arbusto di viti e ciòanche per mancarvi l'ingrasso per non esservi armentibastevoli
Non erano rare poi le zone in cui, sebbene fossedisponibile una porzione di terra, nemmeno lecolture mediterranee classiche e le foraggerecrescevano. Ad onta delle antitetiche geografie, ilDe Majo aveva rinvenute le medesime carenzealimentari sia nei comuni della Costiera, sia neicentri dell'agro nocerino-sarnese. In questi ultimiperò, l'afflusso di manovalanza forestiera e lacrescita demografica, sebbene non fossero stati nel
Stabilimento tipografico nazionale, 1876, vol. II, p. 686.91 ASS, Intendenza, Statistiche, B. 1758, f. 10.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
sessantennio preunitario compensate dalla messa acoltura delle terre marginali, lo furono attraversoil prospero e fortunoso utilizzo del granone, dellapatata e delle leguminose. Malauguratamente nemmenoquesto espediente fu qui attuabile. A Conca, cosìcome in altre zone, non solo i cereali, le patateed il mais, ma anche le leguminose avevanodifficoltà notevoli ad attecchire92. Alcune aree,come Scala, erano tanto sterili che gli stessiamministratori concedevano alla “miserabil classe”,secondo gli antichi (e mai dismessi) usi civici, dipoter seminare a grano le zone sterili delle variemontagne93.Da ultimo, la questione precipua rimaneva quelladella resa unitaria rispetto all'area seminata.Quel poco di grano che cresceva nella Costieraaveva delle rese mediamente superiori a quelle delregno, le quali si aggiravano sui 1:4, e noninferiori a quelle estremamente competitive delleferaci zone paganesi e nocerine: queste siaggiravano su una media di 1:8 (raggiungendo picchidi 1:12-14)94, mentre la trebbiatura vietrese del1829 fa segnare una resa di 1:7-8, e di 1:4½-5½ nelnon florido 183095. Il problema era che però erano
92 Ivi, B. 1757, f. 49. Il terreno non era atto alla coltura digrani (d'India, duri, teneri), orzo, avena, lenticchie, fagioli,castagne. Era però atto alla vite, olive, mele e pere.93 Ivi, B. 1759, f. 39.94 M. STORCHI, Grani, prezzi e mercati nel Regno di Napoli, cit., pp. 145-6.Lo studio del V. CIMMELLI, Agricoltura ed economia agricola, cit., p. 87fornisce per i nostri anni rese eccezionalmente alte, anche di1:17.95 ASS, Intendenza, Statistiche, B. 1759, f. 3.
RICCARDO P. CONTE
rese unitarie estremamente basse se paragonate aquelle del mais e del riso, che davano anche 1:30,e che richiedevano una quantità minima di spazio,rispetto al grano che invece ne richiedeva troppo.Orbene, mentre nell'area cilentana la coltivazionedel grano non rappresentava un problema, gli spaziessendo amplissimi e sterminate le pianure96, laCostiera in ciò era sommamente impastoiata da unageografia invalidante.
Non è improbabile allora che a rendere possibile lasoddisfazione del fabbisogno di una popolazione inpiena crescita, abbia contribuito non solo il granopugliese o siciliano, ma anche quello provenientedall'area balcanica. Il porto di Odessa, alle portedel Mediterraneo, divenne porto franco nel 1819,trasformandosi così nell'epicentro del commerciodei grani russi, che da là si riversavano inEuropa97. Il che ci dà il destro per analizzare unaquestione sulla quale si era soprasseduto prima. Lecrisi del '16-'17 e del '20-'21, del '44, del '48,del '53 furono crisi tipiche di antico regime:nacquero e finirono nei campi di grano. A tal segno
96 F. VOLPE, Il Cilento tra antico e nuovo regime, cit., pp. 47-107; ilCilento, i cui prodotti di punta erano il grano e, immediatamentedopo, l'olio e il vino; coltivati prevalentemente coi retrivimetodi estensivi e a bassa, bassissima produttività.97 P. BEVILACQUA, Il Mezzogiorno nel mercato internazionale (secoli XVIII-XX), in«Meridiana», 1987, n.1, pp. 19-45. Vd. anche A. LEPRE, Produzione emercato, cit., p. 130. Si vedano anche le tabelle di A. GRAZIANI, Ilcommercio estero del Regno delle due Sicilie dal 1832 al 1858, in «Archivioeconomico dell'unificazione italiana», s. I, vol. X, f. I, 1960,pp. 1-46, in particolare la tab. II.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
colpì la carestia sopravvenuta dopo il Decenniofrancese, che fu addirittura necessaria la misuradi vietare l'esportazione di granaglie dal regno;misura rivelatasi presto insufficiente ealtrettanto presto si corse ai ripari comperandogranaglie provenienti da Odessa. Lo stesso ebbe aripetersi anche nell'Ottobre del 1838, quando ilgoverno permise che entrassero i grani esteri.Durante i sommovimenti degli anni '20 e nella crisidel '44 il governo tamponò la crisi impedendo chele esportazioni di grano98. Epperò è affatto curiosoche la zona che meno di tutte aveva grano adisposizione, proprio in quegli anni continuòindisturbata la propria ascesa, laddove tutto ilPrincipato invece faceva segnare una brusca battutad'arresto. Se l'epidemia non ebbe gioco facile a propagarsiper via dell'isolamento, alla deficienza di granisopperì il governo stesso che lo faceva venderenelle zone di fame ad un prezzo minore di quello acui era stato acquistato99. Così che ciò che unsecolo prima avrebbe facilmente messo il morso allademografia meridionale, si risolse, non senza tantetraversie, attraverso una celere compera di graniesteri, resa possibile dalla migliorata velocitàdei trasporti100. Sicuramente fu un colpo durissimo98 Giornale dell'intendenza di Principato Citeriore, 1845, p. 85, il 3 maggio1844 vista la penuria di cereali viene sospesa l'emissione dicereali dal regno; viene ritirato finita la penuria nel '45.99 N. F. FARAGLIA, Storia dei prezzi in Napoli, cit., pp. 308-12.100 G. GALASSO, Mezzogiorno medievale e moderno, cit., pp. 310-11; suitrasporti vedasi G. CIRILLO, I traffici del Regno. Strade e porti nel Mezzogiornomoderno, in Vie del Mezzogiorno. Storia e scenari, Roma, Donzelli, 2002, pp.
RICCARDO P. CONTE
per l'economia meridionale, che esportava ab antiquoi propri grani, rinomati per l'alta qualità, maconosciuti anche per l'alto prezzo. Il diminuiredel prezzo dei grani non poteva però andare adetrimento della Costiera che invece era una paese“trasformatore”, cioè a dire: l'unica materia primache non esportasse era proprio il grano, cheesportava tutt'al più sotto forma di pasta. Quindil'apertura ai grani balcanico-levantini non funestòl'economia costiera, così come avvenne per consuetigranai meridionali; anzi essa se ne avvantaggiò,giacché adesso li pagava meno. Allorquando aumentòinvece, gli effetti si riverberarono in ogni dove,come abbiamo visto. E non è certo un caso che gliaumenti iniziano a declinare nel ventennio '40-'60.Si tenga presente che più volte gli alti prezzi delgrano e la penuria dello stesso favorironograndemente la pauperizzazione: le industrie dellapasta smettevano di lavorare. Stando alla vecchialegge di Gregory King, alla diminuzione dello stockdel 10%, il prezzo di questo sarebbe aumentato del30%; al 20% sarebbe aumentato dell'80%101. Ciòposto, al sopraggiungere delle crisi di penuria, ilcomune spesso e volentieri non era in grado (acausa delle disastrate finanze locali) di aiutare i
75-114; A. SPAGNOLETTI, Storia del Regno delle Due Sicilie, cit., pp. 237-9;L. DE ROSA, Trasporti terrestri e marittimi nella storia dell'arretratezza meridionale,in «Rassegna economica», 1928, n. 3, pp. 24 e sgg. Sulle vie nellaCostiera cfr. R. P. CONTE, Classe dirigente e amministrazione, cit., pp. 13e sgg.101 V. PARETO, Corso di economia politica, Torino, Einaudi, 1942, pp. 378e sgg., riteneva che se tale inferenza del King non fosse vera pertutti i generi di prima necessità, lo fosse almeno per il grano.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
poveri; talvolta era allora la classe abbiente chesopperiva a ciò in due modi: comperava ella stessai grani di cui abbisognava la Costiera (attraversoofferte volontarie al comune, oppure brevi manu); odanche offriva lavoro in opere pubbliche di variogenere che il comune appaltava loro (costruzione dicimiteri, fontane, pubblici orologi, pulizia dellestrade). Nelle zone ove il settore secondariolanguiva era però impossibile avere dei maggiorentiche attendessero alla compera del grano; e fuquesto il caso di Tramonti, Ravello, Conca,Positano, Scala102; era in questo caso demandato aifunzionari amministrativi di mettere mano alleproprie personali finanze o quelle comunali per lacompera del grano. È allora estremamenteinteressante vedere quali dinamichesistematicamente si innescassero in questaoccasione. Non furono affatto sporadici i casi incui, nelle crisi posteriori a quella del '16-'17,allorché il governo intervenne col calmiere, gliincettatori costieri, acché non perdessero i propriprofitti, effettivamente occultavano il grano (chenon era una merce tanto deperibile), per tornare avenderlo solo successivamente all'aumento deiprezzi, o – peggio ancòra – lo acquistavano tuttoper poi venderlo al prezzo fatto da loro medesimiai funzionari che erano costretti a comprarlo obtorto collo. La documentazione tracima di delazionidel popolo in cui si lamenta del cosiddetto“monopolio” (tecnicamente era un oligopolio),102 ASS, Intendenza, Statistiche, B. 628, vd. la seduta decurionale diRavello il 26 Novembre 1853, e passim.
RICCARDO P. CONTE
ovvero un drappello di speculatori del grano, iquali lo acquistavano per il popolo sui mercatisalernitani e poi tornavano in Costiera a venderloai panettieri. Quando i prezzi si alzavano ed ilgoverno metteva un'assisa che non gli permettevalauti guadagni, provvedevano a questi sotterfugi.Talvolta addirittura noncuranti dell'assisa,incettatori e panettieri vendevano deliberatamentead un prezzo superiore ad essa103. In una delleultime crisi, quella del '53-'54, onde evitare chesi perpetrassero nuovamente questi spiacevolisotterfugi, fu stabilito che il primo elettoaccompagnasse di persona gli incettatori ai varimercati (Salerno, Nocera e Castellammare) evigilasse costantemente de visu questi; lo stesso fufatto poi per i panettieri, i quali furonosottoposti a scrupolosi controlli.
Alle soglie dell'Ottocento la produttività non eraaumentata di pari passo con la popolazione, irendimenti medi erano sempre alquanto bassi escarsa la diffusione dell'informazione delleinnovazioni e debolissima la sensibilità allenovità tecniche da parte degli agricoltori. Nonessendovi state innovazioni tecniche tali damodificare la produttività agricola, la crescitanon fa altro che accentuare lo squilibrio risorse103 ASS, Intendenza, Annona, B. 629, si veda seduta decurionale diAtrani, 16 Novembre 1853. I “travagliatori” ed il popolo minuto“dipendono dalla volontà loro [incettatori e panettieri]esclusivamente di vendere quando vi è guadagno, ed allorché nongli piace l'assisa ne sospendano la vendita facendo restar lapiazza priva di tal genere”
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
popolazione104, e la soluzione con cui si ovviò atale dislivello fu la messa a coltura estensiva dinuovi terreni, senza l'accrescimento di produzioneunitaria. Nella Costiera – così come in buona partedel regno – oltre ai grani esteri, talune misureprotezionistiche del governo borbonico, reseropossibile ad una popolazione povera e spessosproporzionata alle disponibilità, un sostentamentoche non sarebbe stato loro possibile con misureliberistiche. L'importazione di grani esteriall'arrivo della carestia era pratica vetusta; madifferentemente da quanto era avvenuto perl'addietro, la rivoluzione agraria rese possibilela diminuzione dei prezzi dei grani esteri (dovutoall'aumento di produttività): costavano di meno ederano di più. Quel che appare poi certo è chel'economia della vigna e degli agrumi ebbero unloro apporto – forse non decisivo, ma comunquerilevante –, ed unitamente ad una minorconcentrazione del reddito nonché una maggioreperequazione fondiaria (assenza totale dellatifondo per evidenti motivazioni geografiche)sconosciuta altrove, permise ad una popolazionecrescente e che non produceva per l'autoconsumo chepochi beni, di accrescersi come le altre105. I casipiù eclatanti rimangono quelli quasi antipodici diVietri e Tramonti, la prima evidentemente molto piùricca della seconda, avente redditi molto più
104 F. VOLPE, Il Cilento tra antico e nuovo regime, cit., pp. 36-41; e G.GALASSO, Mezzogiorno medievale e moderno, cit., pp. 304-10.105 Cfr. M. PETRUSEWICZ, Latifondo. Economia morale e vita materiale in unaperiferia dell'Ottocento, Venezia, Marsilio, 1989.
RICCARDO P. CONTE
elevati rispetto alla seconda (e simili a quellidella vicina Salerno), ed avente parte dellapopolazione impegnata nel secondario; cionondimenoè nella seconda, in Tramonti, che la demografia siespande notevolmente, ove il secondario stenta adavere una parte incisiva, e dove è preponderante ilprimario. Il Decennio e i suoi portati avevano poimesso – pressoché dappertutto – in seria difficoltài meno abbienti a causa della obliterazione degli“usi civici”; ma fu proprio perciò che si reseineluttabile il sopravvivere della “economiamorale”, a mezzo della quale anche le famiglieeconomicamente meno avvantaggiate della Costieratrovarono sostentamento.
Appendice
Tab. 1– Andamento demografico nella Costa d'Amalfi (1807-1861)106
106 I dati sono ricavati dall'ASS, Intendenza, Stati discussi; Amalfi (A)BB. 3343-3344; Atrani (B) B. 3348; Conca (C) B. 3375; Cetara (D)B. 3372; Furore (E) B. 3383; Maiori (F) BB. 3395-3396; Minori (G)B. 3399; Positano (H) B. 3426; Praiano (I) B. 3428; Scala (L) B.3459; Ravello (M) B.3429; Tramonti (N) B. 3470; Vietri (O) BB.3475-3476. Sono stati poi integrati (ove mancanti) per gli anni1813, 1814 e 1815 attraverso S. MARTUSCELLI, La popolazione, cit.,pp. 561 e sgg; per il 1816 con G. PALAMARA, La struttura demografica,cit., p. 124; per il 1823 non ho invece utilizzati i dati di G.DEL RE, Calendario per il 1823... della provincia di Principato Citeriore, Napoli,Stamp. Giornale del Regno delle Due Sicilie, 1823, in quantoeccessivamente divergenti da quelli degli Stati discussi; per il1836 con M. CAMERA, Istoria della città e costiera di Amalfi, cit., p. 423; peril 1828 ed il 1843 ho utilizzato, non senza cautela (vd. nota 7),A. FILANGIERI, Territorio e popolazione, cit., pp. 319-23; per il 1859con G. DE SANCTIS, Specchio statistico, cit., p. 15. I dati di Vietri
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
A B C D E F G H I L M N O
1807
4.936
3.216
1.200 3.000 9.288
1808
1.000
3.226
2.200
3.000
1809
1.875
986 9.288
1810
5.081
1.689
2.158
1.287
2.920 9.332
1811
5.126
1.833
976 3.218
2.200
1.309
1.190 3.094 9.123
1812
5.119
1.833
981 3.208
2.170
1.307
1.185 3.064 9.099
1813
5.390
1.827
1.008
3.124
1.920
3.339
1.981
1.303
1.301 3.095 9.096
1814
5.448
1.837
1.021
3.162
1.947
3.216
1.990
1.240
1.345 3.139 9.137
1815
5.464
1.857
1.025
3.124
1.966
3.222
604 1.287
1.346 3.037 9.288
1816
5.469
1.742
1.040
649 3.183
2.000
3.315
1.341
1.272
1.300 3.107 9.193
1817
5.528
1.725
1.150
3.200
1.916
1.286
1.396 3.118 9.705
1818
5.341
1.566
1.038
3.200
1.280
1.168
1.260 3.178 9.619
1819
5.385
1.137
9.034
sono quelli riportati nei documenti, quindi fino al '34 sonocomprensivi di quelli di Cetara. Non ho utilizzati i dati ISTATdel primo censimento dell'Italia unita (31 Dicembre 1861), i qualidivergono in misura notevole dagli Stati discussi; ciò è dovuto ad unaloro palese approssimazione per eccesso. A tal riguardo vd. G.GALASSO, Mezzogiorno medievale e moderno, cit., pp. 308-9.
RICCARDO P. CONTE
1820
5.490
1.120
3.200
1.819
1.252 9.431
1821
5.353
1822
5.193
1.788
1.100
3.276
1.839
1.185
1.237 3.141 9.488
1823
5.310
1.769
1.827
698 3.305
1.900
3.315
1.382
1.142
1.232 3.194 9.443
1824
5.408
1.795
1.100
3.305
1.931
1.185
1.252 3.178 9.836
1825
1.871
1.100
3.417
1.991
1.317
1.252 3.739 9.882
1826
1.890
1.000
3.495
2.016
1.317
1.272 9.897
1827
5.507
1.890
1.100
3.552
2.094
1.241
1.310 3.488 9.896
1828
1.981
1.100
2.230
719 3.703
2.157
3.566
1.379
1.296
3.495 9.759
1829
1.100
3.763
2.196
1.279
1.361 10.320
1830
5.742
1.000
808 3.806
2.248
3.263
1.214
1.313
1.400 10.370
1831
1.000
800 2.300
1.310
1.410 10.507
1832
5.949
1.200
800 2.345
1.327
1.419 10.640
1833
2.196
1.267
800 4.020
2.359
1.424 10.085
1834
6.153
1.269
800 3.998
2.384
1.349
1.420 4.081 10.930
1835
6.251
1.270
800 4.107
2.387
1.349
1.414 8.024
1836
6.350
2.201
1.283
2.400
788 4.130
2.412
2.959
1.097
1.345
1.415 4.097 8.024
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
1837
6.377
1.300
800 4.204
2.461
1.354
1.421 8.089
1838
6.485
2.131
1.247
800 4.075
2.430
1.340
1.428 4.219 8.164
1839
6.418
2.173
1.240
800 4.093
2.445
1.340
1.406 4.250 7.981
1840
6.418
2.201
1.240
800 4.149
2.453
1.346
1.406 4.271 7.899
1841
6.506
2.251
1.240
800 4.293
2.674
1.350
1.409 4.301 7.966
1842
6.585
2.251
1.122
800 4.238
2.674
1.350
1.400 4.329 8.059
1843
2.318
1.048
2.227
764 4.396
2.677
2.922
1.240
1.361
1.406 4.475
1844
2.700
1845
2.701
1846
2.692
1847
2.727
1848
7.065
2.470
1.025
2.379
3.038
1849
7.065
2.400
1.019
2.396
3.038
1850
7.069
2.400
1.032
2.424
3.038
1851
7.187
2.522
1.032
2.465
3.038
1852
7.244
2.522
1.038
2.478
3.038
1853
7.352
2.586
1.043
2.521
2.812
1.480
RICCARDO P. CONTE
1854
7.352
2.591
1.055
2.556
2.812
1.498
1855
7.486
2.591
1.058
2.565
3.010
1.498
1856
7.432
2.633
1.041
2.556
3.010
1.483
1857
7.437
2.657
1.040
2.612
3.058
3.010
1.486
1858
7.534
1.062
2.645
775 4.998
3.015
3.046
1.297
1.382
1.492 4.934
1859
7.572
2.848
1.087
2.671
784 4.947
3.058
3.054
1.306
1.386
1.493 4.990 9.350
1860
7.647
1.097
2.709
790 4.981
3.081
3.095
1.321
1.389
1.495 5.031
1861
7.693
1.104
799 4.918
3.081
3.139
1.350
1.389
1.502 5.132
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
1792
1793
1816
1817
1820
1822
1823
1824
1826
1827
1828
1830
1831
1832
1833
1834
1837
1840
1844
1852
1853
1854
1855
1859
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
6,500,000
7,000,000
7,500,000
Popolazione del Regno di Napoli 1792-1859
RICCARDO P. CONTE
Tab. 2 - Popolazione del Regno di Napoli (1788-1859)107
1788 – 4.815.182 1825 – 5.599.802[+1.5%]
1836 – 6.111.642[+0.2%]
1792 – 4.855.200[+0.8%]
1826 – 5.661.624[+1.1%]
1837 – 6.089.288 [-0.3%]
1793 – 4.828.000 [-0.5%]
1827 – 5.704.831[+0.7%]
1840 – 6.142.895[+0.8%]
1816 – 4.914.375[+1.7%]
1828 – 5.733.430[+0.5%]
1844 – 6.309.894[+2.7%]
1817 – 5.035.000[+2.4%]
1830 – 5.777.311[+0.4%]
1852 – 6.826.327[+8.1%]
1820 – 5.207.373[+3.4%]
1831 – 5.809.839[+0.5%]
1853 – 6.883.150[+0.8%]
107 Tali dati sono mie elaborazioni tratte dalle seguenti fonti: G.DE SANCTIS, Dizionario statistico de' paesi del Regno delle Due Sicilie, Napoli,Tipografia Nobile, 1840, pp. 29-30; Id., Specchio statistico, cit., p.79; M. ROTONDO, Saggio politico su la popolazione e le pubbliche contribuzioni delRegno delle Due Sicilie al di qua del faro, Napoli, Tipografia Flautina, 1834,p. 25; e A. ZUCCAGNI-ORLANDINI, Corografia fisica, storica e statistica del Regnodelle Due Sicilie (domini di quà del faro), sez. 2, vol. XI, in Id., Corografiafisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue isole, Tipografia storico-governativa, Firenze, 1845, pp. 379-80 (il quale tuttavia proponeper il 1816 la cifra poco credibile di 5.727.133; pertanto l'hosostituita con quella di D. DEMARCO, Il crollo del Regno delle Due Sicilie,cit., p. 204); L. SERRISTORI, Statistica del Regno delle Due Sicilie (dominj diquà dal faro), in Id., Statistica dell'Italia, Firenze, Stamperia Granducale,1839, pp. 9-10; G. DE LUCA, L'Italia meridionale o l'antico Regno delle DueSicilie, Napoli, Stabilimento tipografico del classici italiani,1860, pp. 340-341.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
1822 – 5.370.463[+3.1%]
1832 – 5.818.430[+0.1%]
1854 – 6.857.265 [-0.3%]
1823 – 5.436.433[+1.2%]
1833 – 5.932.898[+1.9%]
1855 – 6.872.151[+0.2%]
1824 – 5.512.379[+1.3%]
1834 – 6.002.020[+1.1%]
1859 – 7.146.864[+3.9%]
Tab. 3 – Trend demografici di P. Citra, Terra di Lavoro e Napoli (1814-
1859)
Principato Citra Terra di
Lavoro Napoli (con provincia)
1814 - 428.044 - 565.049 -
(12.8%) 639.530 - (14.4%)
1816 - 505.536 - [+18.1%] 632.181- [+11.8%]
730.165 - [+14.1%]
1820 - 420.305 - [–16.8%] 600.334 - [–5.0%]
669.787 - [–8.2%]108
1822 - 432.817 - [+2.9%] 611.091 - [+1.7%]
685.004 - [+2.2%]
1823 - 438.808 - [+1.3%] 619.590 - [+1.3%]
108 I dati dal 1820 al 1831 sono presi da L. SERRISTORI, Statistica delRegno delle Due Sicilie, cit., pp. 9-10; per il 1824 il R. PETRONI,Censimento ossia statistica de' reali dominii di qua dal faro del Regno delle Due Sicilie,Napoli, De Bonis e Morelli, 1826, pp. 52-4 dà per il PrincipatoCitra la cifra complessiva di abitanti 478.450; il G. DEL RE,Descrizione topografica, cit., p. 16, per il 1828 riporta uno spropositodi 505.536.
RICCARDO P. CONTE
692.491 - [+1.0%]
1824 - 446.714 - [+1.8%] 627.796 - [+1.3%]
701.083 - [+1.2%]
1825 - 454.862 - [+1.8%] 633.615 - [+0.9%]
709.867 - [+1.2%]
1826 - 461.493 - [+1.4%] 634.485 - [+0.1%]
717.232 - [+1.0%]
1827 - 466.693 - [+1.1%] 644.511 - [+1.5%]
724.239 - [+0.9%]
1828 - 470.368 - [+0.7%] 652.234 - [+1.1%]
730.165 - [+0.8%]
1829 - 475.624 - [+1.1%] 661.346 - [+1.3%]
734.894 - [+0.6%]
1830 - 481.005 - [+1.1%] 667.926 - [+0.9%]
736.843 - [+0.2%]
1831 - 488.620 - [+1.5%] 671.328 - [+0.5%]
741.276 - [+0.6%]
1832 - 492.228 - [+0.7%] 675.349 - [+0.5%]
745.390 - [+0.5%]109
1833 - 498.662 - [+1.3%] 680.408 - [+0.7%]
747.826 - [+0.7%]110
1834 - 505.090 - [+1.2%] 687.304 - [+1.0%]
745.192 - [-0.3%]
109 M. ROTONDO, Saggio politico su la popolazione, cit., p. 25.110 I dati dal 1833 al 1837 sono presi da L. SERRISTORI, Statistica del Regno delle Due Sicilie, cit., p. 10.
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
1835 - 512.569 - [+1.4%] 694.259 - [+1.0%]
745.608 - [+0.05%]
1836 - 520.891 - [+1.6%] 707.610 - [+1.9%]
742.096 - [-0.4%]
1837 - 513.177 - [-1.4%] 694.986 - [-1.7%]
715.654 - [-3.5%]
1840 - 513.866 - [+0.1%] 696.220 - [+0.1%]
714.207 - [-0.2%]111
1844 - 532.192 - [+3.5%] 713.199 - [+2.4%]
777.003 - [+8.7%]112
1852 - 574.550 - [+7.9%] 776.287 - [+8.8%]
860.252- [+10.7%]113
1853 - 578.814 - [+0.7%] 778.421 - [+0.2%]
862.810 - [+0.2%]
1854 - 580.660 - [+0.3%] 774.523 - [-0.5%]
850.443 - [-1.4%]
1855 - 583.979 - [+0.5%] 770.898 - [-0.4%]
855.812 - [+0.6%]
1859 - 583.317 - [-0.1%] 681.709 - [-11.5%]
877.120 - [+2.4%]114
Tab. 4 Popolazione complessiva ed indici di aumento nei mandamenti di P.111 G. DE SANCTIS, Dizionario statistico de' paesi, cit., p. 29112 A. ZUCCAGNI-ORLANDINI, Corografia fisica, storica e statistica, cit., p. 383.113 I dati dal 1852 al 1855 sono presi da G. DE LUCA, L'Italia meridionale, cit., p. 341.114 G. DE SANCTIS, Specchio statistico della popolazione, cit., p. 79.
RICCARDO P. CONTE
Citra115
A B C D E F G H I L M
1814 14.335
14.484
13.221
10.271
14.796
11.334
16.001
4.978 10.039
9.693 17.012
1859 24.378
22.915
18.873
19.909
24.076
17.387
24.343
13.905
17.487
17.465
21.241
+ % 70.05 58.20 42.75 93.83 62.71 53.40 52.13 179.32
74.19 80.18 24.85
115 S. MARTUSCELLI, La popolazione del Regno di Napoli, cit., passim; e G.DE SANCTIS, Specchio statistico, cit., passim. Cava = A; Nocera = B;Pagani = C; Angri = D; Sarno = E; S. Giorgio = F; Sanseverino = G;Baronissi = H; S. Cipriano = I; Montecorvino; = L; Salerno = M.
1814
1822
1824
1826
1828
1830
1832
1834
1836
1840
1852
1854
1859
400000
420000
440000
460000
480000
500000
520000
540000
560000
580000
600000
Popolazione del Principato Citra 1814-1859
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
Nati e morti nel 1830 e nel 1850Amalfi – ASS, Intendenza, B. 1744, f. 7; B. 1752, ff. 11-
12; B. 1757, ff. 5-6
Mese\Anno
NatiM
NatiF
TOT MortiM
MortiF
Morti tra 0e 7 anni
TOT Matrimoni
1850Gennaio 9 8 17 4 7 2 11 1Febbraio 7 9 16 6 6 5 12 3Marzo 12 13 25 7 6 8 13 8Aprile 6 9 15 7 5 6 12 1Maggio 9 7 16 4 2 3 6 3
Atrani – ASS, Intendenza, B. 1744, f. 6; B. 1752, ff. 15-
16; B. 1757, f. 10
Mese\Anno
NatiM
NatiF
TOT MortiM
MortiF
Morti tra 0e 7 anni
TOT Matrimoni
1830Gennaio 5 3 8 2 3 3 5 1Febbraio 2 - 2 4 1 - 5 1
1850Gennaio 4 2 6 3 3 - 3 2Febbraio 2 8 10 1 - - 1 -Marzo 12 2 14 4 3 4 7 2Aprile 4 1 4 4 3 6 7 1Maggio 4 3 7 4 2 6 3 -
RICCARDO P. CONTE
Cetara – ASS, Intendenza, B. 1744, f. 21
Mese\Anno
NatiM
NatiF
TOT MortiM
MortiF
Morti tra 0e 7 anni
TOT Matrimoni
1850Gennaio 3 2 5 2 - 1 2 2Febbraio 5 1 6 4 2 5 6 -Marzo 4 4 8 - 2 - 2 1Aprile 1 5 6 2 2 2 4 -
Conca – ASS, Intendenza, B. 1744, f. 22; B. 1752, ff. 48-49; B. 1757, ff. 48-49
Mese\Anno
NatiM
NatiF
TOT MortiM
MortiF
Morti tra 0e 7 anni
TOT Matrimoni
1830Gennaio 3 3 6 - 4 2 4 -1850
Febbraio 3 2 5 1 1 - 2 3Marzo - 1 1 - - - - 2Aprile 1 1 2 1 2 1 3 1Maggio - - - 2 - 1 1 -Giugno 1 1 2 1 2 1 3 1
Furore – ASS, Intendenza, B. 1752, f. 30; B. 1744, ff. 57-59Mese\Anno
NatiM
NatiF
TOT MortiM
MortiF
Morti tra 0e 7 anni
TOT Matrimoni
1830Gennaio - 1 1 1 2 1 3 -1850
Gennaio 1 - 1 2 - - 2 2Febbraio - - - - 1 - 1 -
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
Marzo - - - - 1 - 1 1Aprile - 2 2 - 1 - 1 -Maggio 1 1 2 - - - - -1853
Ottobre - 1 1 - 1 - 1 1
Majori – ASS, Intendenza, B. 1744, ff. 34-35; B. 1753, ff. 7-8; B. 1758, ff. 5-6
Mese\Anno
NatiM
NatiF
TOT MortiM
MortiF
Morti tra 0e 7 anni
TOT Matrimoni
1830Gennaio 8 7 15 8 6 5 14 51850
Gennaio 9 6 15 6 6 7 12 5Febbraio 9 11 20 4 8 8 12 2Marzo 12 5 17 4 1 2 5 1Aprile 6 6 12 7 6 6 14 4Maggio 11 7 18 8 6 9 14 11853
Ottobre 7 14 21 4 5 4 9 8
Minori – ASS, Intendenza, B. 1744, ff. 38-39; B. 1753, ff. 12-13; 1758, ff. 10-12
Mese\Anno
NatiM
NatiF
TOT MortiM
MortiF
Morti tra 0e 7 anni
TOT Matrimoni
1830Gennaio 3 4 7 3 5 5 8 1Febbraio 1 4 5 8 8 10 16 3
1850Gennaio 4 5 9 5 5 7 10 -
RICCARDO P. CONTE
Febbraio 9 10 19 5 5 4 10 1Marzo 5 7 12 4 6 7 10 2Maggio 4 5 9 2 3 2 5 31853
Ottobre 4 6 10 4 5 5 9 1
Positano – ASS, Intendenza, B. 1746, ff. 29-31; B. 1753, ff. 38-40
Mese\Anno
NatiM
NatiF
TOT MortiM
MortiF
Morti tra 0e 7 anni
TOT Matrimoni
1830Gennaio 8 2 10 8 3 2 11 -1850
Gennaio 9 3 12 5 7 4 12 -Febbraio 4 1 5 1 1 2 2 1Marzo 3 4 7 2 5 5 7 31853
Ottobre 1 7 8 2 2 2 4 2
Prajano – ASS, Intendenza, B. 1746, ff. 33-39; B. 1753, ff. 41-42
Mese\Anno
NatiM
NatiF
TOT MortiM
MortiF
Morti tra 0e 7 anni
TOT Matrimoni
1830Gennaio - 1 1 - 1 - 1 -1850
Gennaio 2 2 4 1 - 1 1 -Febbraio - 1 1 - 1 - 1 -Marzo 3 3 6 1 1 - 2 1Aprile 1 1 2 1 - - 1 -
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
Maggio 3 1 6 - 1 - 1 -
Ravello – ASS, Intendenza, B. 1746, ff. 40-41; B. 1753, ff. 44-45; B. 1758, f. 43
Mese\Anno
NatiM
NatiF
TOT MortiM
MortiF
Morti tra 0e 7 anni
TOT Matrimoni
1830Gennaio 1 - 1 1 - - 1 11850
Gennaio 3 1 4 4 3 4 7 1Febbraio 3 2 5 1 - 1 1 -Marzo 2 4 6 - 1 - 1 -Aprile 2 4 6 - 1 - 1 -Maggio 3 1 4 - 2 - -1853
Ottobre 2 2 4 2 3 2 5 1
Scala – ASS, Intendenza, B. 1747, ff. 25-26; B. 1755, ff. 17-18;B. 1759, ff. 38-40
Mese\Anno
NatiM
NatiF
TOT MortiM
MortiF
Morti tra 0e 7 anni
TOT Matrimoni
1830Gennaio 1 3 4 1 2 - 3 -1850
Gennaio 4 2 6 4 3 2 7 -Febbraio - 1 1 1 1 - 2 4Marzo - 2 2 1 - - 1 1Aprile 2 1 3 2 - - 2 1
Tramonti – ASS, Intendenza, B. 1747, ff. 37-38; B. 1755, f. 25Mese\ Nati Nati TOT Morti Morti Morti tra 0 TOT Matrimo
RICCARDO P. CONTE
Anno M F M F e 7 anni ni1830
Gennaio 4 10 14 4 3 4 7 -1850
Gennaio 6 2 8 4 5 4 9 -Febbraio 3 4 7 7 2 8 9 1Marzo 6 4 10 3 6 4 9 1Aprile 13 7 20 5 5 6 10 41853
Maggio 5 3 8 1 4 1 5 4Ottobre 4 3 7 2 3 2 5 3
Vietri – ASS, Intendenza, B. 1747, ff. 42-43; B. 1755, ff. 33-34; B. 1759, ff. 51-53
Mese\Anno
NatiM
NatiF
TOT MortiM
MortiF
Morti tra 0e 7 anni
TOT Matrimoni
1850Gennaio 15 14 29 8 8 8 16 6Febbraio 21 8 29 9 11 6 20 4Marzo 15 19 34 9 9 10 18 8Aprile 8 12 20 6 3 9 6 7Maggio 11 13 25 8 6 9 14 61853
Ottobre 18 8 26 6 17 13 23 9
Stipendi annuali (in ducati)
Majori – ASS, Intendenza, BB. 3716, 3717, 3718, 3719, 3720Medic
oCerusi
coMaestr
oMaestr
aImpiega
toServiente
Cancelliere
cassiere
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
1810 137.50
60 - 36 - 180 - -
1811 150 80 72 36 - - - 701815 120 80 - 36 48 - 66 76.741817 - 80 72 36 48 30 64 79.541818 120 80 72 36 48 30 64 51.501819 120 80 72 36 48 30 64 51.501820 120 80 72 36 48 30 64 51.501821 120 80 72 36 48 30 64 51.501822 120 80 72 36 48 30 64 51.501823 120 80 72 36 48 30 64 51.501824 120 80 72 36 48 30 64 51.501825 120 80 72 36 48 36 66 801826 120 80 72 36 48 36 66 801827 120 80 72 36 48 36 66 801828 120 80 72 36 48 36 44.59 125.7
61829 120 - 72 36 48 36 44.59 125.7
61830 120 - 72 36 28 36 74 1301831 56 - 72 36 36 36 60 83.501832 56 - 72 36 36 36 60 83.501833 56 - 72 36 36 36 60 83.501834 56 40 72 25 36 36 60 84.561835 56 40 72 25 36 36 60 84.561836 56 40 72 25 36 36 60 84.561840 56 50 - 25 36 36 60 69.221841 - - 22.25 25 - - - 83.961842 48.90 45.83 22.25 25 - - - 83.96
RICCARDO P. CONTE
1843 53.34 80 25 25 36 36 63.90 661844 - 13.77 40 25 - - - -1845 53.34 80 25 25 36 36 63.90 661846 53.34 80 25 25 36 36 63.90 661848 80 80 26.64 25 36 36 69.81 53.421849 - - 40 - - - - 72.361850 80 80 40 - - - - 84.771851 80 80 - - - - 23.26 96.501854 80 80 72 36 48 - 98.72 111.5
61855 80 80 72 36 - 36 - 84.201856 80 80 72 36 44 - 98.72 79.501857 80 80 72 36 48 - 98.72 81.781858 80 80 72 36 48 - 98.72 76.551859 80 80 72 36 48 - 98.72 87.80
Tramonti – ASS, Intendenza, BB. 3977, 3978, 3979, 3980Medic
oCerusi
coMaestr
oMaestr
aImpiegato
Serviente
Cancelliere
cassiere
1806 - 8 - - - - 12 -1808 - - 53.66 - - - 40 -1810 132 - - - - - 50 -1811 72 - - - 20 12 50 371815 80 70 - - 24 18 60 35.261816 - - 40 40 24 - 60 34.351818 80 70 30 30 30 22 62 46.301819 80 70 30 30 30 22 62 46.301820 80 70 30 30 30 22 62 46.301821 80 70 30 30 30 22 62 46.30
La dinamica demografica in Costa d'Amalfi
1822 80 70 30 30 30 22 62 46.301823 80 70 30 30 30 22 62 46.301824 80 70 30 30 30 22 62 46.301825 80 70 25 25 30 22 62 46.301826 80 70 30 30 30 22 62 46.301827 80 29.72 30 30 30 22 62 46.301828 80 12.50 30 30 30 - 72 501829 80 70 30 30 30 - 72 501830 80 70 30 30 30 - 72 501831 36 30 18 18 20 22 57 441832 - - 25 25 - - - -1833 45 36 30 30 24 22 58 421834 45 36 30 30 24 22 58 421835 45 36 30 30 24 22 58 421836 45 36 30 30 24 22 58 64.331840 45 36 30 30 24 22 60 641841 45 36 30 30 24 22 30 641842 30 36 30 30 20 22 20 421843 30 36 30 30 20 22 20 711844 60 40 30 30 24.40 22 54.40 421845 50 50 30 30 24.40 22 54.40 421846 32 33 30 30 24.40 22 54.40 421847 60 50 - - 19.60 22 - 421848 50 40 33 33 24 22 69.16 42.501849 60 40 30 30 24 14.40 69.16 42.501850 60 40 30 30 24 14.40 69.16 42.501851 20 20 30 30 24 - 69.16 42.501852 20 20 30 30 24 6 69.16 42.50
RICCARDO P. CONTE
1853 60 40 30 30 30 4 95.26 42.501854 50 50 30 30 30 13.19 95.26 42.50
Vietri – ASS, Intendenza, BB. 3993, 3994Medic
oCerusi
coMaestr
oMaestr
aImpiegato
Serviente
Cancelliere
1816 - 72 60 60 60 144 163.741817 - 72 60 60 60 144 163.741818 - 72 60 60 60 168 163.741819 - 72 60 60 60 168 163.741820 - 72 60 60 60 168 163.741821 - 72 60 60 60 168 163.741822 - 72 60 60 60 168 163.741823 - 72 60 60 60 168 163.741824 - 72 60 60 60 135 169.531825 - 72 60 60 60 120 192.131826 - 72 60 60 60 120 1801827 - 72 60 60 60 120 1801828 - 72 60 60 60 120 1801829 - 72 60 60 60 194 1801830 - 72 60 60 60 194 1801831 - 72 60 60 60 194 1401832 - 72 60 60 60 194 113.501834 - 72 60 60 60 194 1401835 - 72 60 60 60 194 1401836 - 72 60 60 60 194 1401840 - 72 60 60 60 194 128.941841 - 72 60 60 60 194 -1843 120 72 40 60 60 120 140
























































































![[2000] A. FERRARESE, L’evoluzione demografica di una comunità veneta in età moderna. Cerea tra XVI e XIX secolo [ISBN 978-88-87082-72-2]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313ad945cba183dbf0734d8/2000-a-ferrarese-levoluzione-demografica-di-una-comunita-veneta-in-eta.jpg)
![[2002] A. FERRARESE, La popolazione di Soave in età moderna. Strutture familiari, evoluzione demografica, congiunture. In: Soave ‘terra amenissima, villa suavissima’; a cura di](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313aecfb033aaa8b2103155/2002-a-ferrarese-la-popolazione-di-soave-in-eta-moderna-strutture-familiari.jpg)