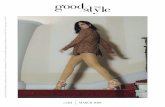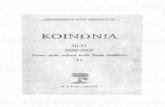L’esame della ricevibilità dei quesiti pregiudiziali: la prassi italiana
Transcript of L’esame della ricevibilità dei quesiti pregiudiziali: la prassi italiana
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA
VIII Congresso giuridico – forense per l’aggiornamento professionale
Roma, Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia
– Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia – Venerdì 15 marzo 2013
17h00-19h00
“L’esame della ricevibilità dei quesiti pregiudiziali: la prassi italiana”
a cura di Daniele P. Domenicucci (referendario presso il Tribunale dell’Unione europea*)
*Le opinioni espresse sono personali e non possono essere riferite all’Istituzione cui l’autore appartiene. NB Testo provvisorio
1
TESTO PROVVISORIO
1. – Il mio intervento verterà sui profili per così dire patologici del meccanismo del rinvio
pregiudiziale, vale a dire quelle situazioni in cui la Corte di giustizia dell’UE (in prosieguo la
“Corte”) rigetta, in sostanza, la domanda di pronuncia pregiudiziale che le viene rivolta da un
giudice nazionale. Nell’esaminare tali profili, mi soffermerò, in particolare, sulla casistica
concernente le domande di pronuncia pregiudiziale proposte da organi giurisdizionali italiani. Uso
volutamente il termine atecnico “rigetto”, in quanto, come si vedrà, pur trattandosi prevalentemente
di casi di irricevibilità (o, se si preferisce, di inammissibilità1), tra questi vanno annoverati anche
alcuni casi in cui la Corte si dichiara incompetente o addirittura ritiene che non vi sia luogo a
provvedere2. Peraltro ‒ sia detto per inciso ‒ la distinzione tra incompetenza e irricevibilità non è
priva di rilevanza. Una dichiarazione d’incompetenza della Corte è infatti irrimediabile per il
giudice nazionale. Qualora invece la domanda di pronuncia pregiudiziale sia semplicemente
restituita al mittente come irricevibile, il giudice a quo può sempre, ove lo ritenga opportuno,
ripresentarla, a condizione però che siano rimossi gli ostacoli che avevano impedito alla Corte di
dare una risposta utile alla prima domanda. Così, a seconda dei casi, il giudice nazionale dovrà
fornire le precisazioni mancanti o, più semplicemente, spiegare meglio i fatti di causa, rendendo
così più chiara la pertinenza delle questioni sollevate per la risoluzione della controversia dinanzi a
lui pendente3.
1 Nella versione italiana delle pronunce della Corte si usa sempre il termine irricevibilità (dall’originale francese
“irrecevabilité”), anche se, trattandosi di un procedimento sui generis di cooperazione da giudice a giudice, il termine
inammissibilità sarebbe, a mio avviso, più pertinente. 2 La Corte impiega, infatti, indistintamente le nozioni di incompetenza, irricevibilità e non luogo a provvedere.
3 Emblematico è, ad es., il caso delle domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte dal Giudice di Pace
di Bitonto (v. infra) nella nota vicenda relativa alle azioni seriali di risarcimento danni intraprese da numerosi
consumatori, su tutto il territorio nazionale, nei confronti delle imprese di assicurazione colpevoli, secondo l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, di aver posto in essere un’intesa tra loro volta alla fissazione dei prezzi delle
polizze per la RCA (sul punto, v., dapprima, CG, ord. 11.2.2004, Cannito e.a., C-438/03, C-439/03, C-509/03 e
C-2/04, Racc. p. I-1605, e poi CG, sent. 13.7.2006, Manfredi e.a., cause riunite da C-295/04 a C-298/04, Racc. p.
I-6619). Al riguardo, è appena il caso di segnalare che sono diversi i casi in cui il giudice a quo ha riproposto, spesso
con successo, un nuovo provvedimento di rinvio, con quesiti identici o quasi, ma semplicemente più curato nella
redazione. Cfr., ad es., con riferimento a rinvii pregiudiziali, i casi Banchero e Viacom, in cui la Corte, dopo avere
rigettato la prima domanda di pronuncia pregiudiziale (CG, ord. 19.3.1993, Banchero, C-157/92, Racc. p. I-1085;
ord. 8.10.2002, Viacom, C-190/02, Racc. p. I-8287), ha accolto parzialmente alcuni dei quesiti riproposti dagli stessi
giudici (CG, sent. 14.12.1995, Banchero, C-387/93, Racc. p. I-4663 e CG, sent. 17.2.2005, Viacom Outdoor,
C-134/03, Racc. p. I-1167).
2
2. – Prima di entrare nel vivo dell’analisi dei rinvii pregiudiziali italiani, mi preme soffermarmi,
brevemente e a titolo introduttivo, su alcuni aspetti di carattere generale. In primo luogo, è
opportuno introdurre un dato statistico che consente di fotografare la rilevanza attuale del
meccanismo del rinvio pregiudiziale: le domande pregiudiziali superano largamente, e ormai da
tempo, la metà dell’intero contenzioso pendente dinanzi alla Corte4 e, fortunatamente, solo uno
sparuto gruppo di queste sono state sinora rigettate dalla Corte5.
La natura e la concezione stessa del meccanismo pregiudiziale mal si concilia, infatti, con il rigetto,
soprattutto per irricevibilità, delle domande di pronuncia pregiudiziale che i giudici nazionali
pongono, di regola, al fine specifico di dirimere una controversia concreta sulla quale sono
chiamati a pronunciarsi. Non a caso, in dottrina si è parlato in proposito di trasmutazioni o
deformazioni pregiudiziali6, ponendo l’accento così sull’anomalia delle decisioni di rigetto. D’altra
parte, le uniche condizioni per il rinvio che l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea («TFUE») – già art. 234 CE e, prima ancora, art. 177 CEE – pone sono: i) l’organo di
rinvio deve rispondere alla nozione di organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione7; ii)
4
Secondo quanto affermato dalla stessa Corte, i rinvii pregiudiziali rappresentano ormai la prima categoria di cause
di cui essa è investita e svolgono, sotto diversi profili, un ruolo determinante nello sviluppo del diritto dell’Unione e
nella sua integrazione all’interno degli ordinamenti giuridici nazionali (v. la relazione introduttiva al Progetto di
regolamento di procedura che la Corte ha sottoposto al Consiglio, pag. 67). Più in particolare, le ultime statistiche
pubblicate sul sito web della Corte (www.curia.europa.eu) indicano che, alla fine del 2012, su 886 cause pendenti
ben 537 sono domande pregiudiziali, mentre, su un totale di 595 cause definite nello stesso anno, ben 386 erano
domande pregiudiziali. Il dato assoluto, relativo alle cause promosse dal 1953 al 2012, mostra che, su un totale di
18139 cause introdotte davanti alla Corte, ben 7832 sono domande pregiudiziali. Tra queste, 1165 provengono
da giudici italiani (111 dalla Corte di Cassazione, 1 dalla Corte Costituzionale, 86 dal Consiglio di Stato e 967
da altri organi giurisdizionali). Da un rapido sguardo alle statistiche si può inferire che il numero delle domande
pregiudiziali proposte da organi giurisdizionali italiani è aumentato nel corso degli anni in modo progressivo e
continuativo. La media calcolata sull’intero periodo di appartenenza dell’Italia alla Comunità/Unione è di poco meno
di 20 domande di pronuncia pregiudiziale l’anno, anche se è nel corso degli ultimi anni che il numero è aumentato
considerevolmente. Un’analisi puntuale e analitica dei dati statistici relativi ai casi italiani, limitatamente al periodo
1964-2005, è rinvenibile in Reale M. C., Borraccetti M., Da giudice a giudice. Il dialogo tra giudice italiano e Corte
di giustizia delle Comunità europee, Milano, 2008, pp. 102-170. 5 Limitando l’analisi, anche per ragioni di omogeneità del dato (trattasi peraltro di dati ufficiosi, di elaborazione
interna ai servizi della Corte, che potrebbero non avere carattere esaustivo), ai soli casi di irricevibilità lato sensu
(che include, nell’accezione della Corte, anche l’incompetenza e il non luogo a statuire) risolti dalla Corte con
ordinanza, alla data del 30 settembre 2012 i numeri (lordi, che non tengono cioè conto delle eventuali riunioni di
cause) sono i seguenti: Austria (13 casi), Belgio (15), Bulgaria (3), Germania (12), Gran Bretagna (1), Francia (18),
Lussemburgo (1), Paesi Bassi (1), Portogallo (7), Romania (9), Slovacchia (1), Spagna (6), Svezia (1), Ungheria (2).
Il dato italiano ben più eclatante, che sarà commentato più avanti e che, sebbene empirico e non esaustivo, è
aggiornato ad oggi, è di complessivamente 54 casi (48 risolti con ordinanza e 6 con sentenza), v. la scheda in calce
alla presente relazione. 6 Barav A., Études sur le renvoi préjudiciel dans le droit de l’Union européenne, Bruxelles, 2011, pp. 19 e ss. e pp.
217 e ss.. 7 Secondo la giurisprudenza della Corte, rispondono a tale nozione gli organi giurisdizionali che presentano i
seguenti requisiti : i) l’origine legale; ii) il carattere permanente; iii) l’obbligatorietà della giurisdizione; iv) la natura
contraddittoria del procedimento; v) il fatto che applichino norme giuridiche e non si pronuncino secondo equità; vi)
3
deve sorgere nel processo nazionale un problema di interpretazione o di validità di un atto lato
sensu dell’UE.
Il meccanismo del rinvio pregiudiziale si fonda dunque su una netta ripartizione di competenze tra
giudici dell’Unione e nazionali: mentre ai primi è riservato il compito di fornire la risposta
ermeneutica ai quesiti, al giudice nazionale spetta, in via esclusiva, il compito, dapprima, di
apprezzarne la pertinenza8 con riguardo alla causa di cui è investito e, poi, di risolvere la stessa
applicando le norme così come interpretate dalla Corte. Cosicché l’oggetto del procedimento
pregiudiziale risulta sostanzialmente delineato dal giudice nazionale attraverso la scelta dei quesiti
da sottoporre alla Corte9, anche se quest’ultima – nell’ottica della massima collaborazione ed al
dichiarato intento di rendere una pronuncia utile per la soluzione della causa principale – non ha
lesinato di intervenire sulle questioni inviatele, riformulando quelle poste in maniera oscura10
o
impropria11
, procedendo a un accorpamento di quelle eccessivamente numerose o ripetitive12
,
oppure disponendole in ordine gerarchico o in un diverso ordine logico13
e, in ultima analisi, anche
dichiarandoli irricevibili.
l’indipendenza e la terzietà (cfr., CG., sentt. 30.6.1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, Racc. p. 408; 17.9.1997, Dorsch
Consult, C-54/96, Racc. p. I-4961; 31.5.2005, Syfait e a., C-53/03, Racc. p. I-4609; 10.12.2009, Umweltanwalt von
Kärnten, C-205/08, Racc. p. I-11525. Da ultimo, CG, sent. 14.6.2011, Miles, C-196/09, non ancora pubb. in Racc.,
punto 37). Giova precisare, al riguardo, visto il consesso odierno, che è stato considerato tale il Consiglio nazionale
forense (nel caso in cui la controversia principale verta sulle condizioni di ammissione al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati o su una sanzione inflitta da un Consiglio dell’Ordine, in cui questo stesso Consiglio è «per legge chiamato
a decidere», CG. 30.11.1995, Gebhard, C-55/94, Racc. p. I-4165). In verità, in questo caso la Corte ha risposto a dei
quesiti posti dal CNF, omettendo tuttavia di pronunciarsi preliminarmente, come avrebbe dovuto, sulla natura di
giurisdizione ai sensi dell’odierno art. 267 TFUE del CNF (la questione viene invece puntualmente affrontata
dall’avvocato generale Léger nelle sue conclusioni relative allo stesso caso, v., in particolare, punti 13 e 14). Tale
questione è peraltro tornata di attualità, con un nuovo rinvio effettuato di recente dal CNF, in relazione alla vicenda
di una domanda d’iscrizione all’albo da parte di un cittadino italiano con il titolo di “abogado” spagnolo (Causa
C-59/13, Torresi c. Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Macerata, pendente). 8 CG, sent. 17.7.2008, Corporación Dermoestética, C-500/06, Racc. p. I-5785, punti 21 e 23.
9 In assenza di prescrizione in ordine al tipo di provvedimento prescelto per disporre il rinvio, v’è un’assoluta libertà
di forma nell’adozione dello stesso (il nostro ordinamento prevede la forma dell’ordinanza, v. art. 3 L. 13.3.1958, n.
204) e il giudice nazionale è altresì libero di deciderne il contenuto, oltre che in quale stadio e stato del processo
effettuarlo (CG, sent. 10.3.1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., cause riunite 36/80 e 71/80, Racc.
p. 735), sebbene la Corte abbia tuttavia precisato che è preferibile attendere di disporre di tutti gli elementi di fatto e
di diritto necessari a fornirle un quadro della causa nazionale tale da consentirle di pronunciarsi utilmente (CG, sent.
11.6.1987, Pretore di Salò/X, 14/86, Racc. p. 2545) e che si sia instaurato il contraddittorio tra le parti (CG, sent.
3.3.1994, Eurico Italia e a., C-332/92, Racc. p. I-711). 10
CG, sent. 18.11.1999, Teckal, C-107/98, Racc. p. I-8121, punto 34. 11
V., a titolo di esempio, CG, sent. 18.3.2010, Alassini e a., cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08,
Racc. p. I-2213, punto 37. 12
CG, sent. 17.1.2013, Hewlett-Packard Europe, C-361/11, non ancora pubb. in Racc., punto 35. 13
Ex multis, CG, sent. 22.12.2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Racc. p. I-11061, punto 15.
4
Il procedimento pregiudiziale costituisce, in definitiva, uno strumento di cooperazione14
tra la Corte
e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione
del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti15
.
Nel dialogo che così si instaura tra giudice del rinvio e Corte, è dunque prerogativa del primo, che è
l’unico ad avere piena cognizione dei fatti di causa, l’essere nella situazione più idonea a valutare
la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la propria sentenza16
. Ne consegue,
secondo la Corte, che se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del
diritto dell’Unione, essa è, in via di principio, tenuta a statuire17
.
La descritta ripartizione di ruoli impedirebbe pertanto alla Corte di sindacare i termini della
questione proposta dal giudice nazionale, di valutare la veridicità e l’esattezza della ricostruzione in
fatto operata nel provvedimento di rinvio e, conseguentemente, di apprezzare la stessa rilevanza
della questione sottopostale. In effetti, per lungo tempo la Corte si è mostrata riluttante a compiere
un tale esame.
Ciò nondimeno, la competenza del giudice nazionale non può considerarsi esclusiva e deve
contemperarsi ‒ come ha spiegato più volte la Corte stessa ‒ con l’esigenza di preservare la
funzione assegnata a quest’ultima, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia
negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche18
. La
Corte ha così stabilito progressivamente, in via pretoria, una serie di requisiti alla cui stregua
valutare la rilevanza delle questioni sottopostele e, se del caso, dichiarare la domanda di pronuncia
pregiudiziale irricevibile in toto, mediante ordinanza, o, più semplicemente, dichiarare irricevibili,
nell’ambito di una sentenza, solo alcune delle questioni proposte19
.
14
CG, ord. 13.7.2006, Eurodomus, C-166/06, non pubb. in Racc., punto 41. 15
CG, sent. 14.9.2006, Stradasfalti, C-228/05, Racc. p. I-8391, punto 44. Per la precisione, la Corte non valuta la
compatibilità con il diritto dell’Unione della disposizione nazionale apparentemente con esso in conflitto, ma è
esclusivamente competente a fornire al giudice interno gli elementi d’interpretazione ricavabili dal diritto
dell’Unione idonei a consentirgli di pronunciarsi su tale compatibilità per la decisione della causa principale. 16
CG, sent. 25.3.2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a., cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da
C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00, Racc. p. I-2943, punto 72; cfr. anche CG, sent. 16.7.1992, C-83/91,
Meilicke, Racc. p. I-4871. 17
Ex multis, CG, ord. 13.7.2006, Eurodomus, C-166/06, non pubb. in Racc., punto 4. 18
V., ad es., CG, sent. 8.9.2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, Racc. p. I-7721. 19
Per un’esemplificazione dei diversi profili d’irricevibilità, v., di recente, CG, sent. 24.4.2012, Kamberaj, C-571/10,
non ancora pubb. in Racc., punti 40-58, in cui vengono dichiarate irricevibili 5 delle 7 questioni sollevate dal
Tribunale di Bolzano. In verità, come si vedrà meglio più avanti, non mancano i casi (pochi per la verità) in cui il
5
3. ‒ La giurisprudenza della Corte in materia di irricevibilità delle domande di pronuncia
pregiudiziale ha scaldato molto gli animi e incontrato nella dottrina autorevoli contraddittori20
.
Infatti, da una parte, né il Trattato né il regolamento di procedura definivano le condizioni minime
in assenza delle quali dichiarare inammissibile una domanda di pronuncia pregiudiziale. Dall’altra,
la giurisprudenza della Corte appare difficilmente prevedibile e classificabile21
.
Un primo segnale di mutamento nella giurisprudenza della Corte si registra intorno ai primi anni
ottanta del secolo scorso, con la nota sentenza Foglia c. Novello22
. Sino ad allora, infatti, il numero
relativamente esiguo di cause, da un lato, e la consapevolezza di contribuire significativamente,
attraverso le proprie pronunce, al processo di integrazione europea, avevano fatto sì che la Corte
trovasse sempre, o quasi, il modo di rispondere alle sollecitazioni provenienti dai giudici nazionali.
È dunque in questi anni, forse anche in considerazione dei vari allargamenti già realizzati e di
quelli in fieri, che la Corte ha iniziato a predisporre dei filtri volti sostanzialmente a fronteggiare il
numero crescente di domande pregiudiziali, oltre che l'incremento in termini assoluti del carico di
lavoro (siamo ancora in un periodo in cui la Corte era una giurisdizione unica). Il vero punto di
svolta è rappresentato tuttavia dalla sentenza Telemarsicabruzzo del 1993, nella quale, per la prima
volta, la Corte, pur avendo acquisito degli elementi di fatto e di diritto agli atti di causa, ha ritenuto
che non occorresse statuire sui quesiti posti dal giudice nazionale (nella fattispecie, il vicepretore di
Frascati) a causa del carattere lacunoso dell’ordinanza di rinvio23
. Con tale pronuncia, che verrà
spesso richiamata nella giurisprudenza successiva, la Corte eleva dunque a regola generale
rigetto integrale della domanda pregiudiziale avviene con sentenza e non con ordinanza. Sul punto, v. anche Naomé
C., Le renvoi préjudiciel en droit européen. Guide pratique, 2a ed., Bruxelles, 2010, pp. 94-104 e 185-190.
20 Per un’ampia e critica trattazione della giurisprudenza in materia d’irricevibilità, v., in particolare, Vandersanden,
La procédure préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne, cit., pp. 60-77, nonché Barav, Études
sur le renvoi préjudiciel dans le droit de l’Union européenne, op. cit.., pp. 19-36 e 252-271. Secondo l’Avvocato
generale Jääskinen (v. conclusioni presentate l’11.3.2010 nella causa Sbarigia, C-393/08), in linea di principio, le
questioni pregiudiziali andrebbero esaminate nel merito piuttosto che dichiarate irricevibili. A tal proposito, egli
indica che « il fatto che la Corte si limiti ad indicare che la questione è irricevibile potrebbe essere percepito dai
giudici nazionali come una violazione del principio di cooperazione con questi ultimi, principio fondamentale che
presiede la relazione in questione. » 21
Come rilevato a giusto titolo da Borraccetti, Reale, cit., p. 176, in mancanza di una disponibilità sistematica di
informazioni basilari in materia (circa l’utilizzo di espressioni all’apparenza fungibili quali “irricevibilità”,
“incompetenza” o “non luogo a provvedere”), non è dato comprendere, ad es., con quale percentuale le domande
vengono rigettate, a seconda dei casi, perché troppo generiche, imprecise, o perché i quesiti posti sono giudicati
irrilevanti o vertono su questioni analoghe già risolte (ai sensi del vecchio art. 103 reg. proc.). 22
CG, sent. 11.3.1980, Foglia, 104/79, Racc. p. 745, punti 10-12. 23
CG, sent. 26.1.1993, Telemarsicabruzzo C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Racc. p. I-393, punto 7. Al riguardo, la
Corte, dopo aver rilevato, che in ogni caso le informazioni in suo possesso avevano carattere frammentario e non le
consentivano di interpretare le regole di concorrenza evocate dal giudice del rinvio, conclude con un luogo a statuire.
6
l’obbligo di motivare il provvedimento (un’ordinanza, secondo le regole processuali del nostro
ordinamento) attraverso il quale il giudice nazionale le sottopone, in via pregiudiziale, dei quesiti,
siano essi di interpretazione o di validità24
, pena l’irricevibilità dello stesso.
Sebbene non sia affatto agevole sistematizzare le diverse tipologie di ordinanze di irricevibilità
emanate dalla Corte, è possibile nondimeno individuare dei temi ricorrenti in esse25
.
4. ‒ In primo luogo, la Corte ha dichiarato irricevibili le questioni pregiudiziali manifestamente non
rilevanti per la soluzione della causa principale. Al riguardo, se è vero che la valutazione della
rilevanza delle questioni (per la quale vige una presunzione) spetta al giudice a quo, è ugualmente
vero però che, nel rispetto dello spirito di cooperazione reciproca, la Corte verifica che il giudice
del rinvio non abbia oltrepassato i limiti del potere discrezionale che gli viene di norma
riconosciuto26
. Cosicché sono state rigettate questioni pregiudiziali non aventi alcuna relazione con
le concrete circostanze o l’oggetto della causa principale27
, poste in un giudizio già concluso28
,
aventi carattere generale e meramente ipotetico29
, aventi ad oggetto questioni interpretative la cui
soluzione non era necessaria ai fini della decisione della causa principale30
e, infine, sollevate in
cause nel cui ambito il diritto dell’UE non era applicabile 31
.
24
Giova precisare che, solo qualche anno prima, nel 1985, sempre in una causa pregiudiziale italiana la Corte aveva
affermato sostanzialmente l’opposto, ritenendo che, nonostante l’assenza di motivazione, sarebbe stato contrario alle
ragioni di economia della procedura non rispondere ai quesiti sollevati sulla base di questo solo motivo, v. CG, sent.
12.6.1986, Bertini e.a., cause riunite 98/85, 162/85 e 258/85, Racc. p. 1885. 25
Cfr., per un caso in cui la Corte ritiene ricevibili le questioni, nonostante le svariate eccezioni sollevate al riguardo
da alcuni Stati membri intervenuti nel processo, v. ad es., CG, sent. 28.6.2007, Dell’Orto, C-467/05, Racc. p. I-5557,
punti 40-49. 26
CG, sent. 31.1.2008, Centro Europa 7, C-380/05, Racc. p. I-349, punti 48-63 (in cui 2 delle 10 questioni proposte
sono state dichiarate irricevibili). 27
CG, ord. 26.1.1990, Falciola, C-286/88, Racc. p. I-191, in cui nel dichiararsi incompetente a pronunciarsi sulle
questioni sottopostele, la Corte ha osservato che il TAR Lombardia non le aveva affatto chiesto di interpretare le due
direttive in materia di appalti, ma si era semplicemente limitato a segnalarle che doveva applicare queste direttive
nella controversia su cui era stato chiamato a pronunciarsi. La Corte ritiene, infatti, che si evince dalla formulazione
stessa dell’ordinanza di rinvio che il tribunale amministrativo ha dei dubbi unicamente sulle «possibili reazioni
psicologiche di taluni giudici italiani» di fronte all'approvazione della legge 13 aprile 1988, n . 117, relativa al
risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie ed alla responsabilità civile dei magistrati
(punto 9 dell’ordinanza). 28
CG, sent. 21.4.1988, Pardini, 338/85, Racc. p. 2041. 29
CG, sent. 16.7.1992, Lourenço Dias, Racc. p. I-4673. 30
CG, sent. 4.12.2003, EVN e Wienstrom, C-448/01, Racc. p. I-14527. 31
CG, sent. 29.5.1997, Kremzow, C-299/95, Racc. p. I-2629 ‒ in cui la Corte non ha riscontrato alcun fattore di
collegamento col diritto dell’UE ‒ e sent. 10.1.2006, Ynos, C-302/04, Racc. p. I-371, relativa ad un caso di
inapplicabilità ratione temporis del diritto dell’UE.
7
In secondo luogo, ha rigettato le questioni pregiudiziali contenute in provvedimenti di rinvio nei
quali il giudice a quo aveva omesso di definire il contesto di fatto e di diritto in cui si inserivano le
questioni sollevate o di spiegare almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni erano fondate32
. In
mancanza di tali elementi, la Corte non è infatti in grado di assicurare i diritti dei soggetti abilitati a
presentare osservazioni né di fornire al giudice nazionale una risposta utile33
.
In terzo luogo, ha rigettato le questioni sollevate nell’ambito di una controversia fittizia34
. La Corte
ha tuttavia mostrato estrema cautela in proposito, esitando a considerare fondate eccezioni di
irricevibilità relative al carattere artificiale della controversia nazionale35
. La ricevibilità della
domanda di pronuncia pregiudiziale non è così stata esclusa per il fatto che le parti fossero
d’accordo sul risultato da ottenere, dal momento che i quesiti rispondevano ad un bisogno
oggettivo inerente alla soluzione della causa principale36
.
La declaratoria di irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale resta, tutto sommato,
l’extrema ratio, cosicché, sempre nell’ottica di piena collaborazione che ispira il dialogo tra Corte e
giudice nazionale, la Corte può chiedere chiarimenti a quest’ultimo al fine di dissipare ogni dubbio
in ordine alla ricevibilità della questione sollevata37
(v., al riguardo, l’art. 101 reg. proc.).
32
CG, sent. 19.4.2007, C-295/05, Asemfo, Racc. p. I-2999. In una recente ordinanza, la Corte ha, ad es., ritenuto
manifestamente irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dal Tribunale di Torre Annunziata e
riguardante l’interpretazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del
27.11.2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale, poiché il giudice del rinvio non aveva definito il contesto di fatto, né esposto le
ipotesi fattuali su cui la domanda è basata. La Corte aggiunge che il giudice a quo «non offre indicazioni
circostanziate sul contesto di diritto nazionale tali da consentire alle parti di presentare osservazioni e alla Corte di
fornire risposte utili. Infine, il giudice del rinvio non spiega sufficientemente i precisi motivi per i quali la richiesta
interpretazione del diritto dell’Unione gli appare necessaria ai fini della risoluzione del procedimento principale, né
formula quesiti pregiudiziali allo scopo di ottenere siffatta interpretazione» (v. CG, ord. 3.5.2012, Ciampaglia, C-
185/12, non pubb. in Racc., punti 7-10). 33
CG, sentt. 26.1.1993, Telemarsicabruzzo, C-320/90, Racc. p. I-393; 17.2.2005, Viacom Outdoor, C-134/03, Racc.
p. I-1167. 34
CG, sentt. 11.3.1980, Foglia c. Novello, 104/79, Racc. p. 745; 16.12.1981, Foglia c. Novello, 244/80, Racc. p.
3085, resa all’esito di un secondo rinvio. 35
CG, sentt. 21.9.1988, Van Eycke, 267/86, Racc. p. 4769; Mangold, cit.. 36
CG, sent. 9.2.1995, Leclerc-Siplec, C-412/93, Racc. p. I-179. 37
CG, ord. 11.3.2008, Consel Gi. Emme, C-467/06, non pubb. in Racc., punto 14; cfr. anche sentt. 8.11.2007,
Schwibbert, C-20/05, Racc. p. I-9447 e 11.3.2010, Attanasio Group, C-384/08, Racc. p. I-2055, punti 28 e 29. Ad
ogni modo, la risposta del giudice a quo alla richiesta di chiarimenti non necessariamente si è risolta nel senso
dell’ammissibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, v., inter alia, CG, ord. 12.3.2004, Austroplant-
Arzneimittel, C-54/03, non pubb. in Racc.. Sul punto, v. anche Barav, Études sur le renvoi préjudiciel dans le droit
de l’Union européenne, op. cit., p. 271 e Naomé, Le renvoi préjudiciel en droit européen. Guide pratique, op. cit.,
pp. 140-145.
8
Diversi sono, invece, i casi in cui la Corte rigetta i quesiti posti dal giudice a quo, quando le norme
dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione non siano applicabili alla fattispecie oggetto della
causa contraddistinta dall’esistenza di una situazione cd. “puramente interna” (ambito quest’ultimo
in cui è peraltro difficile tracciare la linea di demarcazione tra questioni ricevibili e irricevibili e
che esorbita dal presente intervento)38
.
5. ‒ Per ovviare al problema del carattere lacunoso di talune domande di pronuncia pregiudiziale,
che obbliga la Corte, come si è visto, a dichiararle irricevibili per l’assenza totale di precisazioni
relative alle circostanze di diritto o di fatto della causa principale, o eccezionalmente per la
mancanza di un qualsiasi quesito, la Corte, a completamento della parabola iniziata con la citata
sentenza Telemarsicabruzzo, ha inteso di recente esplicitare ulteriormente i requisiti minimi che la
domanda di pronuncia pregiudiziale deve possedere, enunciandoli nel suo nuovo regolamento di
procedura39
(segnatamente all’art. 9440
), e non più nella Nota informativa41
, alla quale tuttavia il
testo di tale articolo chiaramente si ispira.
38
V., sotto distinti profili, CG, sent. 1.7.2010, Sbarigia, C-393/08, Racc. p. I-6337 (nonché le conclusioni presentate
dall’AG Jääskinen nella stessa causa l’11.3.2010, punti 29-38) e CG, sent. 21.12.2011, Cicala, C-482/10, non ancora
pubb. in Racc.. Diversamente, nel caso in cui il diritto nazionale rinvii al contenuto di una norma dell’UE per
determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna allo Stato membro, la Corte ha riconosciuto
la propria competenza. Ex multis, CG, sent. 18.10.1990, Dzodzi, C-297/88 e C-197/89, Racc. p. I-3763. A
fondamento di tale conclusione, la Corte ha dichiarato che l’ordinamento comunitario ha «manifestamente interesse,
per evitare future divergenze d’interpretazione, a garantire un’interpretazione uniforme di tutte le norme di diritto
comunitario, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate» (punto 37 della sentenza), sebbene, poi, spetti
solo ai giudici nazionali applicare la disposizione interpretata dalla Corte di giustizia, tenendo conto delle circostanze
di fatto e di diritto della causa loro sottoposta, e altresì determinare la portata esatta del rinvio al diritto dell’Unione
(tale approccio è stato peraltro seguito dalla Corte a più riprese, nonostante le riserve espresse da alcuni avvocati
generali; per una ricostruzione sul punto v., da ultimo, le conclusioni presentate dall’AG Cruz Villalón il 25.10.2012
nella causa Allianz Hungária Zrt. e a., C 32/11, non ancora pubb. in Racc., punti 24-32. Analogamente, non
interessano in questa sede, sebbene siano anch’esse indice di un approccio per così dire disinvolto da parte del
giudice nazionale, le ordinanze rese dalla Corte, ai sensi del vecchio art. 104.3 reg. proc. (ora art. 99 reg. proc.), nei
casi la giurisprudenza abbia già fornito una risposta ai quesiti sollevati dal giudice a quo. Vale la pena, in ogni caso,
di sottolineare che, anche in questo ambito, i casi relativi a rinvii pregiudiziali italiani sono abbastanza numerosi. 39
In GUUE L 265 del 29.9.2012, p. 1, reperibile sul sito www.curia.europa.eu. Per un primo commento dello stesso,
v. Iannuccelli P., La réforme des règles de procédure de la Cour de justice, Il Diritto dell’Unione europea, n° 1/2013
(in corso di pubblicazione). Al riguardo, è appena il caso di ricordare che sinora non erano state mai precisate regole
formali su come dovesse essere redatta una domanda di pronuncia pregiudiziale (v., in proposito, Melloni M., I
requisiti formali delle decisioni di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, Il foro italiano, n. 10/2011, pt. IV, col.
480-484). Peraltro, uno specimen basilare del provvedimento di rinvio pregiudiziale è reperibile sul sito della Corte
d’Appello di Milano al seguente indirizzo Internet: http://www.corteappello.milano.it/de_pre7.aspx. 40
Per una prima menzione in giurisprudenza di tale articolo, v. Conclusioni dell’AG Mengozzi del 7.3.2013, nella
causa Amazon.com International Sales Inc. e a. (C-521/11), il quale, al punto 71, ritenendo che la terza questione
dovesse essere dichiarata irricevibile in quanto troppo generale (CG, sent. 28.3.1979, Beneventi, 222/78, Racc. 1163,
9
L’art. 94 reg. proc. prescrive che, oltre al testo dei quesiti, la domanda di pronuncia pregiudiziale
deve contenere: a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti
rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di
fatto sulle quali si basa la domanda di pronuncia pregiudiziale; b) il contenuto delle norme
nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia; c)
l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o
sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso
stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.
La previsione di una tale disposizione nel nuovo regolamento di procedura, sebbene possa apparire
prima facie come una “banale” opera di codificazione, ha, a mio avviso, una particolare importanza
poiché dà finalmente una veste giuridica ad una prassi giurisprudenziale che si è progressivamente
affermata in via pretoria e in maniera talvolta incoerente42
. È vero che la sua violazione non
prevede testualmente la “sanzione” dell’irricevibilità, ma il disposto è sufficientemente assertivo
per far comprendere che si tratta di veri e propri requisiti formali, il cui mancato rispetto non può
restare privo di conseguenze (una sorta di ‘condizioni di ricevibilità’ de facto). Non si può quindi
escludere che, attraverso l’articolo in commento, la Corte abbia voluto lanciare un monito ai giudici
nazionali, invitandoli ad una maggiore responsabilizzazione nell’utilizzo del meccanismo
pregiudiziale, al fine di ridurre al massimo i casi di irricevibilità43
, preparandosi nel contempo a dar
prova di maggiore rigorismo negli anni a venire.
6. ‒ Volgendo ora lo sguardo alla prassi italiana44
, si può osservare che le pronunce in cui la Corte
ha rifiutato di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte da giudici italiani45
si suddividono, a
punto 20), si riferisce all’articolo in questione come ad una disposizione che ha codificato la giurisprudenza
esistente. 41
La “Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali” (la cui
ultima versione è pubblicata in GUUE C 160 del 28.5.2011, p. 1) è stata di recente sostituita dalle “Raccomandazioni
all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” (disponibili
sul sito www.curia.europa.eu e pubblicate in GUUE C 338 del 6.11.2012) che la hanno sostanzialmente adattata alle
modifiche introdotte dal nuovo regolamento di procedura entrato in vigore il 1° novembre 2012. 42
Non a caso la dottrina ha rilevato che “the Court is prepared to give a ruling in cases to which it wants to respond,
even where the information is deficient in some way” (v. Barnard C., Sharpston E., The changing face of Article 177
references, in Common Market Law Review, 1997, Vol. 34, p. 1149). 43
V., in proposito, Iannuccelli, La réforme des règles de procédure de la Cour de justice, op. cit.. 44
Per un dettaglio delle varie pronunce della Corte relative a domande di pronuncia pregiudiziale inviatele da giudici
italiani, v. la tabella riepilogativa in calce alla presente relazione.
10
loro volta, anch’esse in ordinanze e sentenze. Nel caso delle ordinanze, il rigetto delle domande è
integrale, mentre, nel caso delle sentenze, solo alcune questioni sono rigettate mentre altre vi
trovano risposta46
. Nel merito, va precisato che, conformemente alla tendenza generale sopra
descritta, anche con riguardo ai rinvii dei giudici italiani si possono osservare pronunce in cui la
Corte ha dichiarato i quesiti irricevibili, altre in cui si è detta incompetente, altre ancora in cui ha
utilizzato la formula del “non luogo a statuire”.
Soffermando, più in particolare, l’attenzione sui soli casi di rigetto con ordinanza, da
un’elaborazione informale, interna ai servizi della Corte, emerge che, ad oggi, il numero delle
domande di pronuncia pregiudiziale italiane rigettate (oltre 50) equivale a circa un terzo del totale.
Si tratta per certi versi di un dato stupefacente, soprattutto se comparato a quello di altri grandi
Paesi che, a fronte di un numero altrettanto elevato, se non superiore (come nel caso della
Germania con i suoi 1800 rinvii) di domande pregiudiziali proposte, registrano un numero
estremamente limitato di casi rigettati con ordinanza (tra tutti, si pensi alla Germania che ne ha solo
12 o alla Francia che ne ha 18, la maggior parte dei quali sono peraltro risalenti). L’altro dato
significativo è che il numero dei casi italiani rigettati dalla Corte cresce costantemente e
progressivamente ogni anno. A titolo di esempio, ricordo che all’inizio del 2012 ad oggi, la Corte
ha rigettato ben 9 domande di pronuncia pregiudiziale presentate da giudici italiani (nell’ordine, 1
dalla commissione tributaria di Benevento, 1 dal giudice di pace di Mestre, 1 dal tribunale di
Brescia, 3 dal giudice di pace di Revere, 1 dal tribunale di Torre Annunziata, 2 dal tribunale di
Tivoli47
).
È difficile, se non impossibile, individuare le ragioni di questa percentuale così elevata48
. Si può
tuttavia osservare che in molti casi si tratta di ordinanze di rinvio (talvolta provenienti dallo stesso
giudice) che appaiono spesso lacunose (talvolta prive di qualsiasi spiegazione49
) se non addirittura
45
Sul punto, sia consentito rinviare a Domenicucci D. P., Circa il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia, Il foro italiano, n. 10/2011, pt. IV, col. 484-487. 46
Va, tuttavia, osservato che, ad es., nei casi Foglia, Telemarsicabruzzo e, da ultimo, Sbarigia e Cicala, v. infra, la
Corte ha rigettato le questioni pregiudiziali integralmente con sentenza. 47
V. la scheda allegata in calce. 48
Va d’altra parte detto che la mancanza di pubblicità del provvedimento di rinvio (di cui peraltro, non si dà quasi
conto nella sentenza o nell’ordinanza d’irricevibilità della Corte) rende approssimativo qualsiasi tentativo di
classificazione. 49
V., ad esempio, i casi Ettaghi, Tam e Abdel, rinviati dal giudice di pace di Revere, in cui la Corte rileva
nell’ordinanza d’irricevibilità che “l’ordinanza di rinvio [..] non contiene nessuna descrizione, anche solo succinta,
dell’ambito in fatto e in diritto del procedimento principale e non spiega nemmeno le ipotesi di fatto sulle quali si
11
pretestuose. A tal riguardo, a prescindere dall’immagine distorta del nostro Paese che generano
questo tipo di provvedimenti, l’unica consolazione è che almeno il giudice del rinvio non ha perso
molto tempo e che la Corte ha potuto rispondere con maggiore celerità50
, riducendo al minimo la
durata dell’incidente procedurale nonché l’impiego delle proprie risorse51
. La casistica è in ogni
caso talmente ampia, per cui non mancano, soprattutto di recente, ordinanze di rinvio che si
caratterizzano, all’opposto, per un eccesso di dettaglio e un groviglio d’informazioni, senza riuscire
tuttavia a spiegare le ragioni sottostanti alla proposizione delle questioni pregiudiziali o che celano
addirittura un errore sulle disposizioni applicabili nel processo principale52
.
Faccio infine osservare che vi sono casi, non molti, in cui le ordinanze di rinvio si piegano agli
interessi delle parti, le quali sperano talvolta di poter scardinare la normativa nazionale, con la leva
del meccanismo pregiudiziale, facendo genericamente richiamo a disposizioni o principi del diritto
dell’Unione. In questi casi, in cui il giudice è, di fatto, venuto meno alla sua funzione di filtro e di
mediazione tra le parti del processo e la Corte, la debolezza argomentativa del provvedimento di
rinvio, sebbene spesso celata dietro un’imponente ricostruzione giurisprudenziale e normativa,
costituisce spesso la ragione ultima del rigetto delle questioni da parte della Corte.
Quanto alle materie trattate, sono assolutamente predominanti i casi in cui le questioni rigettate
dalla Corte vertevano sull’interpretazione delle norme in materia di concorrenza e/o aiuti di stato,
fonda la domanda di pronuncia pregiudiziale” (punto 6 delle ordinanze). V. anche, sempre a titolo di esempio, il
punto 8 dell’ordinanza Ciampaglia. 50
I tempi di reazione della Corte per questo tipo di causa si accorciano sempre più e variano, ultimamente, per
quanto riguarda i casi italiani, dai 10 giorni dell’ordinanza Ciampaglia, ai 3 mesi delle ordinanze Gentile e Pedone,
ai 16 mesi dell’ordinanza Volturno Trasporti. Sia detto per inciso, il progressivo accorciamento dei termini di durata
del procedimento pregiudiziale è un obiettivo che la Corte persegue ormai da tempo con successo (si è passati infatti
passati da una durata media, nel 2003, di 25,5 mesi, ad una di 15,7 nel 2012), sebbene la Corte europea dei diritti
dell’Uomo di Strasburgo abbia ritenuto che la parentesi del procedimento pregiudiziale non debba essere presa in
considerazione quando si valuta la durata ragionevole del processo nel cui ambito è stato effettuato il rinvio (v.
CEDU, sent. 26.2.98, Pafitis e.a./Grecia, punto 95). 51
Al riguardo, sebbene sia un tema che sfugge ai più, ogni causa che viene introdotta dinanzi al giudice dell’UE ha
un moltiplicatore di costi, che probabilmente non ha eguali in nessun’altra giurisdizione al mondo. Si pensi, ad es., al
semplice caso di un rinvio pregiudiziale che arriva alla Corte. Esso sarà studiato preliminarmente dalla cancelleria e
dal servizio di ricerca e documentazione, tradotto quasi sicuramente in tutte le lingue ufficiali dell’UE (a meno che
non siano dubbi sul suo carattere manifestamente irricevibile), oltre che in francese, che è la lingua di lavoro della
Corte, notificato alle parti e a tutti i soggetti interessati, esaminato dal presidente della Corte e studiato dal giudice
relatore (e dai suoi collaboratori) e dagli altri membri della sezione. 52
Nell’ordinanza Volturno Trasporti (su rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria di Benevento), la Corte
rileva, ad es., che il giudice del rinvio le pone “dei quesiti sulla compatibilità con la direttiva 69/335 di un diritto
annuale come quello controverso nel procedimento principale prendendo in considerazione disposizioni prive di
relazione con il diritto annuale di cui si contesta la validità” (punto 15 dell’ordinanza).
12
spesso in abbinamento o in alternativa alla richiesta di interpretazione delle norme in materia di
libera circolazione53
. Rari sono, invece, i casi vertenti sull’interpretazione di disposizioni specifiche
o di carattere tecnico (per es. in materia fiscale)54
. Negli ultimi tempi, si registra tuttavia un
incremento esponenziale di casi in cui le questioni rigettate (parzialmente o in toto) vertono sui
principi della Carta dei diritti fondamentali se non, addirittura, della CEDU55
. Segno tangibile che
il concetto oggi molto in voga della cd. tutela multilevel, l’improvviso interesse per la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo e quello rinnovato (anche a grazie ad un’intensa attività
di formazione resa accessibile a tutti gli operatori del diritto) per la Corte di Lussemburgo generano
non di rado (e forse non del tutto a torto) confusione nei giudici, ma anche, e più in generale, negli
avvocati, riguardo alle varie forme di tutela attivabili e in relazione alle diverse competenze delle
due corti europee.
7. ‒ In conclusione, è anche opportuno rilevare, però, che la giurisprudenza della Corte non ha
certo agevolato il compito di per sé già arduo dell’interprete nazionale, considerato che, da un lato,
le ordinanze di irricevibilità sono spesso scarsamente motivate, se non ricalcate l’una sull’altra,
nonché in passato difficilmente reperibili, e che, dall’altro, l’approccio della Corte in tema di
ricevibilità non è sempre del tutto lineare56
. Si ha quasi l’impressione, infatti, che la Corte voglia
mantenere una certa souplesse nel determinare la ricevibilità delle questioni sottopostele,
mostrandosi a seconda dei casi più o meno severa e rigorosa57
.
53
Al riguardo, si rinvia alla scheda allegata in calce. 54
Forse perché nei casi in cui la questione verte effettivamente su questioni specifiche o tecniche, il giudice compie
uno studio più attento e approfondito e, nel momento in cui decide di operare il rinvio, ha una conoscenza molto
precisa dei fatti di causa e delle questioni giuridiche che si pongono. 55
V., ad es., la sentenza Cicala e le ordinanze Currà, Gentile, Pedone (tutte elencate nella tabella) o, anche la sent. Kamberaj (di irricevibilità parziale) cit.. 56
Si pensi, ad es., alla vicenda dei due distinti rinvii pregiudiziali operati dal Giudice di Pace di Bitonto nell’ambito
delle cause di risarcimento danni avviate da alcuni consumatori nei confronti delle compagnie di assicurazioni,
colpevoli di aver posto in essere un’intesa, sanzionata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la
fissazione dei prezzi delle polizze RCA. In quella vicenda, nonostante i quesiti posti nelle due ordinanze fossero
sostanzialmente simili, la Corte non si è sentita di rigettarli una seconda volta, nonostante le eccezioni formalmente
sollevate da una delle parti (v., rispettivamente, Corte giust., ord. 11 febbraio 2004, cause riunite C-438/03, C-
439/03, C-509/03, C-2/04, Cannito e a., Racc. p. I-1605 e sent. Manfredi e a., cit.). La spiegazione più plausibile,
anche se giuridicamente claudicante, di un tale revirement potrebbe forse essere rinvenuta nel contesto particolare,
contraddistinto dalle iniziative nel frattempo avviate dalla Commissione in materia di cd. private enforcement del
diritto antitrust, in cui il secondo rinvio è pervenuto alla Corte. 57
V. Molinier J., Lotarski J., Droit du contentieux de l’Union européenne, Paris, 2012, p. 129.
13
Parafrasando l’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, possiamo affermare che la giurisprudenza
della Corte in materia di ricevibilità è talvolta «casistica e poco scientifica»58
. Ciò non esime
tuttavia il giudice nazionale, cui il meccanismo del rinvio pregiudiziale riserva un importante ruolo
di comprimario, dallo svolgere in pieno il suo ruolo di principale interprete e applicatore del diritto
dell’Unione, evitando di sottoporre alla Corte quesiti votati all’insuccesso, perché se è vero che
un’ordinanza di rigetto è, in prima battuta, un insuccesso per il giudice e le parti del processo a
quo, essa lo è ancor più per il buon funzionamento della giustizia italiana e europea.
D’altra parte, l’onere particolare che incombe al giudice nazionale che intenda investire la Corte di
una questione non esime gli avvocati59
, soprattutto quando il rinvio pregiudiziale scaturisca da una
loro tesi difensiva, dal valutare attentamente i rischi, sempre più elevati, di veder rigettata la loro
istanza dalla Corte, ove non sia pertinente e fondata, con buona pace dei tempi già lunghi del nostro
processo.
58
Conclusioni dell’AG Ruiz-Jarabo Colomer del 28 giugno 2001 nella causa De Coster, C-17/00, Racc. p. I-9445,
punto 14, nota 18. 59
Alla stregua di quanto prevede, ad es., il nuovo codice del processo amministrativo, i cui primi articoli sono
essenzialmente improntati ad uno spirito di cooperazione tra i vari attori del processo.
14
Bibliografia generale
(in ordine cronologico)
Briguglio A., Pregiudiziale comunitaria e processo civile, Padova, 1996; Adinolfi A.,
L’accertamento in via pregiudiziale della validità di atti comunitari, Milano, 1997; Anderson
D., Demetriou M., References to the European Court, 2a ed., London, 2002; Trisorio Liuzzi
G., Processo civile italiano e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della Comunità
europea, in Riv. Dir. Proc., 2003, p. 727 ss.; Reale M.C., Borraccetti M., Da giudice a
giudice. Il dialogo tra giudice italiano e Corte di giustizia delle Comunità europee, Milano,
2008; Condinanzi M., Mastroianni R., Il contenzioso dell’Unione europea, Torino, 2009, pp.
186 ss.; Domenicucci D. P., Il ruolo del giudice nazionale e la presentazione delle questioni
pregiudiziali, con particolare riferimento alle direttive contro la discriminazione 2000/43 e
2000/78, in Diritto e lavoro nelle Marche, 2010, n. 1-2, p. 21 ss; Naomé C., Le renvoi
préjudiciel en droit européen. Guide pratique, 2a ed., Bruxelles, 2010; Broberg M., Fenger
N., Preliminary references to the European Court of Justice, Oxford, 2010; Barav A., Études
sur le renvoi préjudiciel dans le droit de l’Union européenne, Bruxelles, 2011; Adam R.,
Tizzano A., Lineamenti di diritto dell’Unione Europea, Torino, 2010; Ciccone R., Il rinvio
pregiudiziale e le basi del sistema giuridico comunitario, Napoli, 2011; Soulard C., Renvoi
préjudiciel, in Soulard C., Rigaux A., Munoz R., Contentieux de l’Union européenne/3.
Renvoi préjudiciel. Recours en manquement, Rueil-Malmaison, 2011, pp. 19 ss.;
Vandersanden G., La procédure préjudicielle devant la Cour de Justice de l’Union
européenne, Bruxelles, 2011; D’Alessandro E., Il procedimento pregiudiziale interpretativo
dinanzi alla Corte di giustizia. Oggetto e efficacia della pronuncia, Torino, 2012; Dittert D.,
Art. 267 TFUE, in Curti Gialdino C. (a cura di), Codice dell’Unione europea operativo,
Napoli, 2012, pp. 1926 ss.; Tesauro G., Diritto comunitario, 7a ed., Padova, 2012, pp. 290 ss..
15
Elenco dei rinvii pregiudiziali proposti da giudici italiani rigettati dalla Corte di giustizia UE60
Giudice rinvio Nome della causa Numero Causa Oggetto
(disposizioni dell’UE)
Tipo di pronuncia
Pret. Brà Foglia 104/79 Interp. art. 92, 95 e 177 CEE Incomp. (sentenza)
Trib. Varese BNP 80/83 Interp. Conv. Bruxelles Irric. manifesta
Trib. Milano Celestri 172/84 Valid. Comunicazione Comm. Sui
prezzi-basi di prodotti siderurgici
Non luogo a statuire
Comm. Cons. infr. valutarie
Roma
Greis Unterweger 318/85 Interp. art. 106 CEE Irric. manifesta
TAR Lombardia Falciola 286/88 Interp. artt. 5, 177 e 189 CEE Incomp. manifesta
Vice-Pret. Frascati Telemarsicabruzzo da C-320/90
a C-322/90
Interp. artt. 85, 86 e 90 CEE Incomp.(sentenza)
Pretura Genova Banchero C-157/92 Interpr. artt. 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 e
95 CEE ; artt. 2 e 6 dir. 72/464/CEE e
dir. TVA 77/388/CEE
Irric. manifesta
Pret. Roma (sez. Frascati) Saddik C-458/93 Interp. artt. 5, 9, 30, 37, 85-88 e 90 CEE Irric. manifesta
Trib. Milano Job Centre C-111/94 Artt. 48, 55, 59, 60, 66, 86 e 90 CEE Incomp. (sentenza)
Comm. Trib. I gr. Reggio
Emilia
Max Mara C-307/95 Art. 7 dir. 85/303/CEE
Irric. manifesta
Pret. Ivrea (sez. Strambino) Sunino e Data C-2/96 Interp. artt. 48, 55, 59, 60, 66, 86 e 90
CEE
Irric. manifesta
Pret. Roma (sez. Tivoli) Italia Testa C-101/96 art. 30 CEE Irric. manifesta
Pret. Roma (sez. Tivoli) Modesti C-191/96 art. 30 CEE Irric. manifesta
Pret. Roma (sez. Tivoli) Lahlou C-196/96 art. 30 CEE Irric. manifesta
Pret. Roma (sez. Tivoli) Annibaldi C-309/96 Art. 40.3 CEE Incompetenza(sentenza)
Pret. Roma (sez. Tivoli) Testa C-128/97 art. 30, 36, 85 e 86 CEE Irric. manifesta
Pret. Roma (sez. Tivoli) Modesti C-137/97 art. 30, 36, 85 e 86 CEE Irric. manifesta
Corte Conti ANAS C-192/98 dir. 92/50/CEE Incomp. manifesta
Corte Conti RAI C-440/98 dir. 93/38/CEE Incomp. manifesta
Tribunale Bari Colapietro C-390/00 norme sulla distillazione obligatoria Incomp. manifesta
Tribunale Bari Colapietro C-391/00 norme sulla distillazione obligatoria Incomp. manifesta
Corte d’appello Milano
VIS Farmaceutici
C-454/00
art. 4 reg. CEE nº 1768/92 Irric. manifesta
Trib. Bologna Cond. Facchinei Orsini C-129/01 art. 2, lett. b), dir. 93/13/CEE Irric. manifesta
Trib. Biella Simoncello e Boerio C-445/01 art. 48, 52 e 90 CE Irric. manifesta
Giudice pace Genova-Voltri Viacom
C-190/02 artt. 2, 3.1, 9, 29, 37, 59, 60, 85, 86, 90 e
92 CE
Irric. manifesta
Trib. Catania Dem'Yanenko
C-45/03 artt. 7, 8 e 9 dir. 64/221/CEE ; artt. 2, 5,
6, 13 e 14 CEDU
Incomp. manifesta
60
Si tratta di un elenco che non ha alcuna pretesa di esaustività, essendo stato ricavato empiricamente dai servizi
della Corte grazie a delle funzionalità della banca dati interna.
16
Giudice pace Milazzo Regio C-425/03 art. 153 CE Irric. manifesta
Giudice pace Bitonto Cannito C-438/03 artt. 81 e 82 CE Irric. manifesta
Giudice pace Bitonto Murgolo C-439/03 artt. 81 e 82 CE Irric. manifesta
Giudice pace Bitonto Manfredi C-509/03 artt. 81 e 82 CE Irric. manifesta
Giudice pace Bitonto Tricarico C-2/04 artt. 81 e 82 CE Irric. manifesta
Trib. Vicenza CaseificioValdagnese C-358/04 art. 2, par. 2, reg. CEE n° 3950/92 Irric. manifesta
Trib. Viterbo D’Antonio C-480/04 artt. 31, 43, 49, 81 e 86 CE Irric. manifesta
Trib. Bolzano Eurodomus C-166/06 art. 6, par. 2 TUE Irric.
Trib. Genova Consel Gi. Emme C-467/06 artt. 43, 49, 82, 86 e 87 CE Irric. manifesta
Trib. Genova Autostrada dei Fiori-Aiscat C-12/07 Art. 86 CE Irric. manifesta
Trib. Genova RAI C-305/07 Art. 86 CE Irric. manifesta
Trib. Milano Savia e a. C-287/08 artt. 6, par. 2, UE e 6 CEDU Incomp. manifesta
TAR Lazio Sbarigia C-393/08 artt. 49, 81-86 CE; artt. 152 e 153 CE Irricevibilità (sentenza)
TAR Sicilia Pignataro C-535/08 artt. 17 e 18 CE Incomp. manifesta
Comm. Trib. Parma Calestani C-292/09 art. 13, B), lett. c) dir. 77/388/CEE Irric. manifesta
Comm. Trib. Parma Lunardi C-293/09 art. 13, B), lett. c) dir. 77/388/CEE Irric. manifesta
Trib. Bari Colapietro C-519/10 Reg. CEE n° 822/87 Irric. manifesta
Corte Conti – sez. Regione
Sicilia
Cicala C-482/10 Artt. 296 TFUE e 41.2, lett. c), Carta
diritti fondamentali
Incomp. (sentenza)
Comm. Trib. Parma Debiasi C-613/10 art. 13, a), dir. 77/388/CEE Irric. manifesta
Comm. Trib. Benevento Volturno Trasporti
C-21/11
art. 10, lett. c), e 12, lett. e), dir.
69/335/CEE
Irric. manifesta
Giudice pace Mestre Abdallah C-144/11 dir. 2008/115/CE Irric. manifesta
Trib. Trani Vino C-161/11 dir. 1999/70/CE, relativa all’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato
Incomp. manifesta
Trib. Brescia
Currà e a. C-466/11 artt. 3, 4.3, 6 e 21 TUE e 17, 47 e 52
Carta diritti fondamentali
Incomp. manifesta
Giudice pace Revere
Ettaghi
C-73/12 artt. 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 dir.
2008/115/CE
irric. manifesta
Giudice pace Revere
Tam C-74/12 artt. 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 dir.
2008/115/CE
irric. manifesta
Giudice pace Revere
Abdel C-75/12 artt. 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 dir.
2008/115/CE
irric. manifesta
Trib. Torre Annunziata Ciampaglia C-185/12 artt. 8 e 12 reg. CE n° 2201/2003 irric. manifesta
Trib. Tivoli Pedone C-498/12 art. 47 carta diritti fondamentali e 6
CEDU
incomp. manifesta
Trib. Tivoli Gentile C-499/12 art. 47 carta diritti fondamentali e 6
CEDU
incomp. manifesta
Trib. Tivoli Loreti C-555/12 art. 47, 52 carta diritti fondamentali e 6
CEDU
?



















![La psicologia italiana tra scienza e filosofia: Una prassi senza teoria? [Italian psychology between science and philosophy: A practice without theory?]. Il Giornale Degli Psicologi,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314759a3ed465f0570b27d9/la-psicologia-italiana-tra-scienza-e-filosofia-una-prassi-senza-teoria-italian.jpg)