Capua preromana e dintorni. Lineamenti della ricerca storico-archeologica
Le origini del culto della Madonna di Pasano e il miracolo del masso (itinerari cultuali tra Sava,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Le origini del culto della Madonna di Pasano e il miracolo del masso (itinerari cultuali tra Sava,...
Le origini del culto della Madonna di Pasano eil miracolo del masso. Itinerari cultuali tra Sava, Pasano e dintorni in un continuum storico. DaDemetra, Ecate, Artemide, ai Lari e alla Madonna, il riadattamento dei culti.
Gianfranco Mele
“Non adorate gli idoli, le pietre, gli alberi, i luoghi appartati,le fonti, i quadrivi. Non affidatevi a chi fa incantesimi, aglistregoni, ai maghi, agli aruspici, agli indovini, a chi scruta gliastri, a chi getta le sorti. Non credete al significato magicodegli starnuti, né alle superstizioni relative all’orecchio, né aimalefici diabolici. Che altro è se non un culto demoniaco ilcelebrare i Volcanalia e le calende, il far corone di lauro, ilbadare alla posizione dei piedi, lo stendere la mano sui tronchid’albero, il gettate del vino o del pane nelle fonti? È un cultodemoniaco quello delle donne che, tessendo, invocano Minerva, oquello di chi aspetta il venerdì o un giorno preciso per celebrareil matrimonio o per mettersi in viaggio […]” (Dicta Pirmini oScarapsus, sec. VIII)
Introduzione
Di megalitismo, e della storia e delle origini delle “pietresacre” nel Salento ormai si parla moltissimo: ma dellasingolarissima storia di un culto megalitico affermatosi in epocaassai tardiva e cioè nel 1600, in accostamento alla figuradella Madonna, tra Sava e Pasano (contrada nell'agro dellaanzidetta cittadina), non si è parlato se non nei classicitermini descrittivo-devozionali del culto e del miracolo del massodi Pasano senza intravedere né ricercare analogie di sorta con latradizione più antica e suggestiva del popolo salentino. Laleggenda del masso di Pasano, tramandatasi oralmente e ricostruitain un documento redatto da un vescovo della Diocesi di Oria ben170 anni dopo la datazione dell'avvenimento, attribuisce ad unmiracolo operato dalla Madonna l'improbabile caduta di un grandemasso dal cielo, a beneficio di uno schiavo imprigionato da unapesante catena di ferro, provvidenzialmente spezzata da talemacigno.La leggenda di Pasano è davvero singolare anche nella “storia deimiracoli”: non si tratta di una apparizione, o di un prodigio checoncerne la guarigione di un infermo, o di un presunto intervento
“divino” nell'ambito dei fenomeni naturali: qui si racconta lastoria di una enorme pietra che piove all'improvviso dal cielo indirezione di un preciso “bersaglio”. Singolare è anche, del resto,la devozione e l'adesione acritica ed incondizionata allaleggenda, da parte degli storici locali che si son prestati piùvolte a descrivere e ricostruire l'accadimento e la storia delmiracolo.Il prodigioso masso è a tutt'oggi conservato in una teca, aricordo dell'evento, ed è divenuto da subito, sin dal tempo dellasua “apparizione”, oggetto di culto esso stesso, si può dire,andando ad occupare un posto privilegiato in chiesa, assieme allestatue e alle icone dei santi. La leggenda di questo macigno, assieme alle caratteristiche delluogo e a numerose altre storie e leggende che si intrecciano nelpercorso cultuale che lega Pasano alle zone circostanti,conferiscono al sito, ma anche ad una più vasta area (in unraggio di diversi km partendo dall' ”epicentro” che è la chiesa diPasano), un aspetto magico, che è in definitiva l'oggettodell'analisi di questo scritto. Si può affermare l'esistenza di una sorta di continuità dellavenerazione delle pietre e nello specifico delle “pietre cadutedal cielo” in loco, poiché successivamente all'epoca delmegalitismo, si affermano sia tra i greci che tra i romani, checolonizzano questi posti, culti delle pietre intesi sia comesimulacri che come lapis ex coelis. L'attaccamento a questo genere diculti, difficile da sradicare, deve essere sopravvissuto in epocacristiana, opportunamente riadattato. In queste pagine si parlerà anche di località limitrofe ecollegate sia nella tradizione storica e cultuale che nellaviabilità a Pasano, in quanto sin dai tempi più remoti partiintegranti di un unico percorso devozionale.
La presenza bizantina a Pasano e gli studi di Gaetano Pichierri sulleorigini del culto della Madonna
Seppure questo studio è finalizzato a rintracciare residui ditradizioni cultuali antecedenti il cristianesimo, è utile citaregli studi del Pichierri che si riferiscono al periodo storico nelquale in Pasano si fissa il culto cristiano, ovvero la devozionealla Madonna. Il Coco ritiene che l'antica chiesa di Pasano, andata distrutta,doveva trovarsi accanto alla attuale costruzione. Di recente sonostai riportati alla luce i resti della antica chiesa che
corrispondono a quanto indicato dal Coco (ROSSETTI, 2006).Attualmente, si è ancora in attesa del compimento di operazioni direstauro della parte più antica, che a quanto pare tardano avenire (sono già passati oltre 8 anni). Gaetano Pichierri era convinto (sulla scia delle affermazionidello stesso Primaldo Coco) che a Pasano esisteva una chiesabizantina da cui avrebbe tratto evidente origine anche l'iconadella Madonna con Bambino dipinta su un masso tufaceo dell'altezzadi m. 1,80 per m. 1,20 di base, poi spostata al centro dell'altaredella chiesa ricostruita a inizi 1700, e tuttora ivi presente(fig. 6). Ed è al periodo bizantino che il Pichierri fa risalirele origini del culto, individuando Pasano e zone limitrofe comeun'area di grande importanza per i Bizantini stessi in quantocaratterizzata dall'attraversamento del cosiddetto LimesBizantino, e dagli accampamenti delle truppe accasermate nellecontrade della zona (“Camarda” a tal proposito è un toponimotipico che indicherebbe appunto la zona degli accampamenti). Lapresenza di un culto a Pasano sarebbe perciò da ricollegare alconfine bizantino e costituirebbe la componente religiosa dellapresenza organizzata delle truppe bizantine sul confine(PICHIERRI 1985). Il Pichierri fornisce anche con un suo schizzo (qui di sottoriportato) la mappa del percorso del Limes Bizantino nel feudo diSava, un percorso strategico-insediativo-cultuale che ricomprendezone come Agliano, Curti ti l' Oru, Magalastro (e SS. Trinità infeudo di Torricella), contenenti tracce di storia e insediamentistrategici, militari, civili e cultuali anche precedenti rispettoal periodo bizantino e perciò evidentemente privilegiati sin daitempi più remoti sia per lo stanziamento dei popoli che per losviluppo e la permanenza dei culti.
schizzo di Gaetano Pichierri, il Limes nel feudo di Sava
Pasano e dintorni: successione di insediamenti nei secoli. Greci eRomani.
Nella documentazione storiografica e in quella storico-religiosa,e inoltre nella ricerca archeologica intorno alla località inagro di Sava (Ta) denominata Pasano, la centralità delle notizie edelle attenzioni è stata occupata sinora principalmente da dueelementi:
il culto della Vergine di Pasano (e dunque la storia della
Cappella intitolata alla Madonna (fig. 1), e quella, ad essacollegata, dei relativi “miracoli”, tra cui, il piùconosciuto, quello detto “dello Schiavo”);
la presenza, nella vicina contrada Camarda, di un Limes (o“Paretone”) molto dibattuto, e identificato da alcuni come unlimes di origine bizantina, da altri un confine di matricefeudale, da altri ancora come una delimitazione eretta aitempi magno-greci per separare il territorio tarantino dallaMessapia.
Per l'approfondimento di questi aspetti, si rimanda alla vastaletteratura, saggistica e e storiografia esistente (PICHIERRI, 1994;STRANIERI, 2000; STRANIERI et. al., 2009). Il Limes attraverserebbecomunque un tracciato del quale avrebbero fatto parte certa,considerati i resti individuati da una visita ispettiva condottanel 1669, il Monte Maciulo (in agro di Maruggio), c.da Tremola(tra Maruggio Sava e Torricella), la zona della SS. Trinità diTorricella, il Monte Malagastro (ove sorse una fortificazione o unagglomerato), per raggiungere poi Pasano e le attigue contradeCamarda e Agliano, e proseguire verso S. Marzano di S. Giuseppe(CARDUCCI G., 1993). In questo caso, l'analisi dei resti delParetone sarebbe stata condotta al fine di delineare i limiti delterritorio tarantino da quelli della Foresta Oritana, che eranoconsiderati coincidenti con il Paretone stesso. La questione del “miracolo” (e del culto della Madonna saràripresa invece più avanti, ma solo al fine di delineare alcunecuriose analogie e un continuum (o meglio, una sostituzione funzionalee probabilmente nient' affatto casuale) con culti preesistenti.Il Santuario di Pasano si trova in una zona caratterizzata da unsuccedersi di insediamenti nelle diverse epoche: Primaldo Cocoriporta in vari passaggi le origini del Casale di Pasano comeinsediamento sorto nei principi dell' Impero Romano. Riferisceinoltre del ritrovamento di numismatica di tipo latino, magno-greco e bizantino, e di sepolcri a coperchi monoliti (COCO, 1915). Annoscia riferisce di sporadiche scoperte (tombe con corredinumismatici e ceramici) che hanno permesso di individuare lapresenza di un centro abitato protrattasi nei secoli (dal periodoellenistico a quello romano, bizantino, ecc. - v. ANNOSCIA, 1996).Il Pichierri, uno dei più meticolosi ricercatori e storiografi delterritorio, cita Pasano (insieme ad altre contrade limitrofe inagro di Sava) come luogo di “rinvenimenti di gruppi di tombe con ceramicamagnogreca associata a ceramica indigena” (PICHIERRI, 1994). In Pasano sono state ritrovate tombe e ceramiche risalentiall'epoca magno-greca, ma non si ha notizia di oggetti di tipovotivo o di resti di costruzioni direttamente riconducibili
all'esistenza di un luogo di culto (diversamente che nellavicinissima contrada denominata Agliano). E' pur vero che suPasano non sono mai stati effettuati scavi rigorosi e sistematici:i rinvenimenti sono di tipo accidentale o frutto di ricercheepisodiche condotte da studiosi e appassionati locali.Ritrovamenti archeologici che lasciano pensare ad un anticoinsediamento di una certa consistenza, ovvero che abbracciava unraggio abbastanza esteso tra Pasano e Agliano, sono statidescritti anche per le contrade limitrofe, in particolare Camardae Morfitta.Pichierri rileva anche che una serie di contrade circostanti hannoconservato toponimi di derivazione greca (tra le quali appuntoMorfitta, e altre come Samia, Fallenza, Tima, Minoto, Comò,Panareo, Silea, mentre il toponimo Camarda sarebbe di evidentederivazione bizantina – cfr. DE VECCHIS).Vicina a Pasano, subito dopo la confinante contrada Camarda, sitrova Agliano, che insieme a Pasano fu casale in epoca romana, eche è stato identificato come un luogo di culto magno-grecodedicato a Demetra e Kore prima dell'occupazione romana (PICHIERRI,1975). A proposito di Pasano, il Pichierri scrive :
“Questo centro, al pari di Aliano, era ritenuto di origineromana dell'età imperiale. Invece, da reperti arrivati dallalocalizzata necropoli e dagli etnici toponomastici della zona hamostrato una facies chiaramente greca per la inconfondibilecaratteristica ceramica del tipo Gnathia. Siamo qui di nuovoalmeno in presenza di una fattoria o di un villaggio dellaChora. Anche qui vi sono le stesse esigenze di culto con glistessi problemi politici e sociali che scaturivano dallasacralità del luogo. Certamente un santuario doveva essere anchequi. Dove lo andiamo a vedere questo? Qui l'indagine è nulla,niente ex-voto, nessun segno per adesso per poter localizzare;però l'attuale Cappella della Madonna di Pasano è una tentazioneforte per vedere proprio in quel posto la continuità di ritireligiosi antichi”. (PICHIERRI, 1994)
Ci sono dunque elementi che lasciano presupporre che nell'anticoCasale di Pasano, in quanto centro abitato sia in età magno-grecache romana, siano sorti luoghi di culto (oppure che Pasano siastato, quantomeno, parte integrante e fondamentale del cultodemetriaco stanziato in Agliano), ciascuno dei quali ha sostituitoquello antecedente, in un continuum che si protrae sino allacostruzione (più volte rieffettuata) del santuario cristiano delquale conserviamo una storia più dettagliata.
Prima dei Greci
Pichierri cita spesso, anche se fugacemente, nei suoi scritti, nonmeglio identificati ritrovamenti di manufatti di tipo “indigeno”,accanto a quelli romani e magno-greci; in un suo ulteriorepassaggio, deduce poi un continuum di tipo insediativo e cultualeche figura l'esistenza in Pasano e zone limitrofe, di stanziamentiabitativi preesistenti all'epoca magno-greca, con i loro usi, e iloro rituali, che seppure il Pichierri descrive come “barbari” esottomessi ai greci proprio in virtù di una loro inferioritàculturale ed evolutiva, hanno lasciato traccia (non appienoindagata, per la verità), anch'essi, della loro presenza.Di fatto, esistono degli elementi che possono permetterci ditracciare una linea temporale attraversata dal susseguirsi diciviltà e culti, nella zona di Pasano e nel complesso rituale ecultuale che ha accompagnato le leggende, le storie e letradizioni di questi luoghi da una antichità remota ai giorninostri. Così come, da una analisi dei luoghi, si possono rilevareanche resti tangibili e concreti della presenza di un uomo che haposto, per così dire, le “basi” dell'evolversi (o dell'involversi,a seconda dei punti di vista) e comunque del trasformarsi di ritie tradizioni, adattati di volta in volta a chi dominavaculturalmente e politicamente il territorio. In vari passaggi deisuoi studi, il Pichierri evidenzia un un continuum di stanziamentiin Pasano, ciascuno dei quali assorbe e integra (anche a livellodi culti e tradizioni) quelli precedenti. E' convinzione delPichierri, spesso rimarcata nei sui scritti, che gli stessi cultie insediamenti magno-greci si siano innestati (come è avvenutodopo per i romani e per le successive civiltà) in un territoriocaratterizzato da presenze cultuali e demografiche antecedenti eabbiano costituito, poi, la base per lo sviluppo, non casuale,negli stessi, identici siti, di culti e tradizioni di caratterecristiano.
Fig. 1: Sava, c.da Pasano: Chiesa Madonna di Pasano
Agliano, Pasano e il culto di Demetra
I vari storici locali riportano in più passaggi delle rispettiveopere i rapporti e i vincoli insediativi e cultuali che legano levicinissime contrade di Agliano e Pasano, luoghi ricchi di storiaantica, di miti e tradizioni. Agliano e Pasano, distanti pochi kmdal centro abitato di Sava, costituirebbero gli avamposti dellaChora tarantina al confine con la Messapia, sedi di antichisantuari di frontiera. L'attuale centro abitato di Sava sarebbeinvece, secondo alcune ricostruzioni, un avamposto messapico dellavicinissima Manduria.Gli studi su Agliano, nonché le passate, varie testimonianze circala presenza di un “edificio a ferro di cavallo” ovvero di “un antico tempio”(COCO, 1915) e i rinvenimenti di numerosi frammenti e statue votiveidentificate con Demetra e Kore (PICHIERRI, 1975), testimoniano lapresenza in antichità di culti agrari e dedicati alle divinitàctonie. La colonizzazione di Agliano avvenne intorno al IV secoloa.C., periodo in cui la polis tarantina estende i suoi confini inaree rurali dell'entroterra, colonizzandole e impiantandovifattorie (PICHIERRI 1975; FINOCCHIETTI 2009). In questo periodo vi è,secondo le ricostruzioni storiche e la documentazionearcheologica, il picco di presenze insediative al di fuori dellacittà. In precedenza, Agliano viene identificato come “probabile
territorio japigio” (FINOCCHIETTI 2009), mentre i frammenti ceramicie coroplastici riferibili al culto di Demetra si fanno risalireall'epoca dell'insediamento magno-greco. Un recente saggioarcheologico ha rinvenuto ulteriore materiale ceramico e lefondamenta di un edificio crollato (il tempio citato da Coco?)costituite da blocchi in pietra di grandi dimensioni (CARRINO, 2009).La distanza tra Agliano e Pasano, casali viciniori, è pressochèirrisoria (le due suddette contrade sono inframezzate dalla c.daCamarda che fa da anello di congiunzione) e quindi si può supporreche come furono centri attigui e caratterizzati dai medesimiinsediamenti in epoca romana, lo furono anche nei periodiprecedenti. Il compianto Gaetano Pichierri, entusiasta e meticoloso studiosodi Agliano e Pasano, nonché scopritore di vari repertiarcheologici nella zona, opera anche attraverso osservazioni ericostruzioni di stampo etnobotanico. Le sue osservazioni inquesto ambito, fanno anche da apripista ad una ulteriore serie diconsiderazioni circa il continuum, le similitudini e le assonanzetra il culto di Demetra (e varie divinità e miti associati), equello della Madonna, che col tempo sostituisce sia Demetra stessache un più vasto complesso di miti, credenze e tradizioniprecedentemente esistenti nelle medesime località: partiinteressanti della analisi del Pichierri sono i collegamenti dellemillenarie colture olivicole di Pasano con le tecniche e gliutilizzi dell'antichità, e i riferimenti alla sacralità tipicadegli “orti”, delle colture e delle piante assegnata dall'uomo inquelle epoche, nonché quelli relativi alla coltivazione del grano.La pertinente frase “le bionde messi assegnate alla Dea” inserita in uno deisuoi studi su Pasano (il riferimento è ancora a Demetra) ci portaancora una volta a considerare il carattere del culto di tipopreminentemente agrario instauratosi tra Pasano e nellavicinissima Agliano, perfettamente inserito in un contestofavorevole allo sviluppo e alla tradizione del culto demetriacostesso. La presenza di elementi votivi dedicati a Demetra e Kore,e i tratti del culto più volte descritti sia dal Coco che dalPichierri come caratteristici dell' Orfismo, con elementi chehanno fatto rintracciare ad entrambi analogie con i culti diEleusi, non può non riportarci a congetture circa la possibilitàdi un tracciato cultuale che, nella zona, abbia potutoricomprendere, tra l'altro, elementi caratteristici di un culto ditipo misterico-iniziatico molto centrato anche sugli effetti dellepiante quali veicoli sia di iniziazione che di visioni estastichee perciò di contemplazione del “divino” ( ELE G., 2014). In ognicaso, sappiamo per certo che il culto di Demetra e Kore in zona
era presente, e molto sentito.
Insediamenti e percorsi cultuali tra Sava e Pasano
I miracoli, il culto della Madonna di Pasano ed i riti ad essocollegati, si inseriscono nell'ambito di un itinerario viario ecultuale che comprende la zona detta della “Cappella delloSchiavo” (dove si narra sia avvenuto il miracolo del “masso cadutodal cielo”), sino al casale di Pasano (nel quale sorge ilsantuario denominato Madonna di Pasano), situato a circa 3 kmdalla Cappella dello Schiavo. Del “miracolo dello schiavo” si tratterà nei dettagli più avanti,ma è il caso di anticipare che, secondo la leggenda, nei primi del1600 un uomo sottoposto alla schiavitù di un nobile dell'epoca, fuliberato dalla pesante catena che gli cingeva la caviglia permezzo di un masso caduto dal cielo ad opera della Madonna, allaquale si era rivolto. Lo schiavo si trovava nella attuale Sava,nella zona che oggi è ricompresa tra la Cappella dello Schiavo(istituita in onore del miracolo) e l' Edicola detta “di Fra Giannibale”,lungo la strada che porta a Pasano. Lo schiavo, non cristiano, siera rivolto in direzione della chiesa (o meglio della strada cheporta alla chiesa) per supplicare la Madonna di liberarlo, con lapromessa solenne che si sarebbe convertito se ciò fosse accaduto.Ecco che la Madonna fa cadere la pesante e grande pietra dal cielosulla catena che ne viene spezzata, liberando così l'uomo cheperciò si assoggetta alla fede cristiana. La Cappella dello Schiavo (fig. 2) sorge nella attuale Sava, pocodistante dalla periferia del paese, tra via Santa Filomena e CorsoItalia. La zona di via Santa Filomena è citata più volte dalPichierri per essere parte di una necropoli antica, probabilmentemessapica. In questa zona sono state ritrovate tombe con corredi,ma l'unica testimonianza visibile, attualmente, è la foto di unoSkyphos a vernice nera (datazione presunta, IV sec. a.C.)riportata dal Pichierri in uno dei suoi testi (fig. 3). L'oggettonon è mai stato consegnato alla Sovraintendenza, e non si conoscela sua destinazione. Ciò basta però a dimostrare la presenza, inzona, di insediamenti molto antecedenti rispetto a quelli di epocacristiana, e la successione, in termini di sacralità dei luoghi,di culti appartenenti a diverse civiltà.Proseguendo in direzione di Pasano da via Filomena attraversoCorso Italia, a pochi metri dalla Cappella dello Schiavo si
ritrova l' edicola della “Madonna di Fra Giannibale” (fig.4), siteentrambe sulla destra, sulla strada che porta a Pasano. A sinistradei due luoghi cultuali, dopo due isolati, si ritrova viaMontebello, che conserva un tratto non edificato, che si affacciasulla via per Torricella e corrisponde in linea d'aria all'edicoladi Fra Giannibale. Ivi, si nota la presenza di una serie diblocchi in pietra, alcuni dei quali appaiono, se non modellatidalla mano dell'uomo, da questo utilizzabili: ad esempio, massicon fori che ricordano le “coppelle” descritte nella letteraturaarcheologica, e/o con fori di quelli classicamente identificaticome utilizzati per l'impianto di pali atti a sostenere capanne.Molti di essi sono di notevoli dimensioni e tutto può farpresupporre che in quella zona, essendovi stata abbondante“materia prima”, si siano potuti ricavare in tempi remoti pietreutilizzate come monoliti sacri o come materiali a cui dar formacon sculture primordiali. Un tipico Betilo, difatti, è presente nellazona retrostante la Cappella dello Schiavo (fig. 5), ed èritornato alla luce pochi anni fa, dopo che sono stati eseguitidei lavori di abbattimento di un cortiletto fatto di tufiinnalzati a “secco” che circondava la chiesetta, e che occultavaperciò la vista del Betilo stesso, nonchè l'accesso al piccolopiazzale retrostante la chiesetta. Zona ricca di monoliti, dunque,dalla quale, molto verosimilmente, proviene lo stesso “masso” chela leggenda racconta esser caduto dal cielo, per un “miracolodella Madonna”, sulla catena che teneva imprigionato lo schiavo.Occorre aggiungere, che alcuni decenni fa parte della zonacircostante il trivio dell' Edicola di Fra Giannibale non eraancora edificata, e si osservavano in maggiore quantità blocchi dipietra di grosse dimensioni.
Fig. 2: Sava – C.so Italia – Cappella dello Schiavo
Fig. 3: Sava, via S. Filomena, Skyphos a vernice nera rinvenuto in una tomba (foto tratta da “Omaggio a Sava” - op. cit. - di G. Pichierri)
Fig. 5 – Betilo nel cortiletto della Cappella dello Schiavo
Leggende e trasformazioni dei culti delle pietre sacre. La Madonna e il miracolo del masso
Il Santuario della Madonna di Pasano fu abbandonato, distrutto eriedificato più volte. Il culto della Madonna tuttavia è giàpresente in epoca basiliana, partendo da una data imprecisa che ilCoco colloca a partire dal secolo IV (altri parlano di un arcotemporale che va dal VI al VII sec. d. C.). Secondo il Coco iBasiliani fiorirono comunque in questo territorio sino alla finedel secolo XI, al seguito del quale si inizia a verificare il lorodeclino, l'usurpazione dei loro beni da parte dei principi, el'affidamento delle loro parrocchie e dei loro culti aiBenedettini o ai preti latini. La vita del casale di Pasano si protrae, in ogni caso, tra alti ebassi sino alla metà del XIV secolo; intorno al 1378 vienedistrutto insieme ad altri casali viciniori, a causa delle guerredi secessione tra angioini ed aragonesi. Nel 1454 il casalerisulta ancora disabitato, per poi iniziare a ripopolarsi solo inparte, giacchè i pasanesi assieme agli abitanti di altri casalicome Aliano e S. Maria di Bagnolo, avevano preferito rifugiarsi inun luogo vicino e gettare le fondamenta della attuale Sava.
Oggi la chiesa di Pasano ha l'assetto di una ricostruzioneavvenuta nel 1712: in essa, al centro dell'altare, è conservataun'icona di origini bizantine, una grande lastra tufacearaffigurante la Vergine Odigitria, più volte restaurata, e condiademi incastonati in epoca successiva. (fig. 6).Sono attribuiti alla figura della Madonna di Pasano diversimiracoli: di tipo atmosferico (la Madonna che fa venire la pioggiao che fa cessare o devia catastrofi), altri concernenti guarigionidi infermi, d'altro genere, ma il più popolare (e anche uno deipiù singolari) resta il “miracolo del masso”, avvenuto, secondo laleggenda, nel 1605. L'avvenimento del “miracolo” (fig. 7) è così riportato dal Coco,che riprende un passo del Vescovo di Oria Monsignor Kalefati (ilquale a distanza di circa 170 anni dall'accaduto, ne ricostruiscela “storia”):
“ Nel 1605 dunque viveva in Sava il Signor Marcantonio Ragoricco di feudi, e parente forse del Barone Prato; questi avevaal suo servizio uno schiavo, il quale con grosso ferro al piedelegato a grave catena era obbligato spesso nel giorno fare deitrasporti di robba da Sava nei campi del padrone posti versoPasano, e di là condurre altri nella casa del padrone in Sava:quanto sfiaccato e spossato maltollerasse la schiavitù suaquesto disgraziato uomo, lo mostrò un giorno, che portando daSava nei campi un grande carico, essendo lungi cento passi daSava, rivoltosi verso l'antica chiesa di Pasano, che in distanzagli veniva di rimpetto, con grande fede al certo e fermezza diproponimento, gridando, chiese alla B. Vergine di Pasano, che seli toglieva dal piede la catena serrata con chiavistello, eglisi sarebbe battezzato. Nel momento non si sa come, cadutodall'alto un macigno sul ceppo, ruppe il medesimo, senza nuocereal piede dello schiavo: questi intanto fermo sulla promessa,chiese battesimo; ed istruito dei Misteri della nostra SantaReligione Cristiana, nel dì 12 di giugno del 1605 già detto fucondotto in processione per lo paese, quindi nella chiesaArcipretale di Sava, dove per ringraziamento del Signore Iddio,fu celebrata la Messa solenne: Lo schiavo nel Battesimo fuchiamato Francesco, e fu padrino il Signore Ottavio Prato,battezzato D. Donato del Martire essendo Arciprete D. DonatoGioia, quindi nel luogo dove seguì il miracolo del ceppo sotto,fu edificato un tempietto con altare; su cui in tela è dipintala Beata Vergine di Pasano sulle nubbi con lo schiavo ignudo,che rivolto verso la sua liberatrice ha un ceppo catenato rotto;ed in mezzo busto la figura di un galantuomo vestito allaspagnola, il quale credo rappresentare il padrone dello schiavoSignor Marcantonio Rago, benchè altri mi dicesse, figurarsi untal Muccioli Dottore Oritano (come mi asserivano i
convisitatori, Oritani, od i Savesi) Padrone dei vicini fondi”.(COCO, 1915)
Nella Cappella dello Schiavo, istituita a seguito del “miracolo”,si conservò, in una nicchia appositamente costruita, il macigno“caduto dal cielo”, mentre la catena che imprigionava lo schiavofu conservata nella Chiesa di Pasano. Successivamente, macigno ecatena furono posti insieme nella Chiesa di Pasano, dove sitrovano a tutt'oggi (fig.8). La conversione dello schiavo, il suo battesimo e la sualiberazione, furono vissuti dal popolo come un fatto eclatante estraordinario. Da qui, partì la leggenda del miracolo che fucondita di ulteriori elementi molto probabilmente innestati sucredenze, culti e tradizioni più antiche e rimaste impresse inqualche modo nei luoghi. L'attribuzione di un evento imprevisto e straordinarioall'intervento divino non si è affatto stemperata nella comunitàsavese: è sopravvissuta addirittura ai giorni nostri, con lavicenda della “Madonna della Tromba d' Aria”: nell'agosto del 1976un tornado imperversa nel paese, arrecando numerosi, seri danni amolte abitazioni specialmente in zona “via Croce” ove è situatauna Chiesa. Poichè non si registrarono feriti e poiché una statuadella Madonna da poco innalzata e non ancora cementata su unobelisco sul quale era stata posta non cadde né subì danni, sicreò e si sparse la voce del “miracolo”. Da quel giorno sifesteggia il miracolo della “Madonna della Tromba d' Aria” senzaalcun effettivo nesso logico-causale tra un presunto intervento“divino” e l'accaduto.Il miracolo soddisfa il bisogno di fede e di fatti prodigiosi emagici attribuibili dal popolo a una divinità: e crea un continuumtra la visione magica tipica dei vecchi culti e la necessità diquello attuale di elementi “di pari rango”. Nel capitolo del Cocodedicato alla Madonna di Pasano e al relativo miracolo, eglistesso scrive:
“Uno dei più grandi miracoli che riaccese (si noti quel“riaccese” n.d.a.) nel popolo savese la divozione verso laVergine SS. Di Pasano, fu quello dello Schiavo”.
Il Coco prosegue offrendoci un importante spaccato storico delfenomeno della schiavitù ai tempi:
“Nei secoli XVI e XVII turchi e schiavi vivevano a servizio dinobili e ricche famiglie feudatarie e di altri privati cittadiniin diversi paesi, specialmente di questa nostra provincia.
Provenienti costoro, come afferma l' Argentina dall' Oriente, odall' Africa erano venduti nei pubblici mercati dei porti diOtranto, di Brindisi e di Taranto, sulle coste di S. Cataldo edel litorale salentino. Alcuni di essi tornavano nei loro paesinativi, altri battezzati ed emancipati assumevano i nomi deigenerosi signori, che li rendevano liberi; altri restavano aformar famiglia; altri ancora passavano come merce qualsiasinelle carte dotali di qualche patrizio o nella rassegna deimanieri feudali.” (COCO, 1915)
Quella del battesimo e della liberazione (totale o parziale) eradunque prassi frequente in Puglia, come dimostrano anche alcunericerche storiche (BONO, 2010; ARGENTINA 1908 cit. dallo stesso Coco). IlCoco specifica poi:
“Il nostro schiavo però più che comprato, pare che sia statofatto prigioniero da Marcantonio Raho Capitano dei Cavalieri delripartimento di Terra d'Otranto, quando nel gennaio del 1605,liberò la città di taranto investita dai turchi .Parecchi dicostoro presi e catturati, furono ritenuti presso dei vincitoricome servi, avvalendosi del decreto della Regia Camera dellaSummaria del 1575“.
Prosegue aprendo poi il racconto del “miracolo” già riportato inqueste pagine:
“Riferiamo il miracolo che si ebbe uno degli schiavi delsullodato de Raho con le parole del Vescovo di Oria MonsignorKalefati, avendo costui dopo circa 170 anni dall'accadutoraccolte le tradizioni scritte e orali circa il grandiosoavvenimento, che come egli dice procurò altresì spogliare dallefavole e alterazioni popolari...” .
Prima di proseguire con il testo di Kalefati (che ho riportato disopra) il Coco inserisce qui una nota nella quale rimarca:
“Di questo miracolo si hanno parecchie narrazioni, però tutteconvergono nella sostanza e hanno come fondamento il racconto diMonsignor Kalefati; il quale prese la notizia dall'accuratoprocesso fatto nel 1718 che tuttora si conserva nell' Arch.Della Curia Vescovile di Oria...” . (COCO, cit.)
Trattasi dunque di un evento tramandato nella narrazione orale innumerose versioni (sarebbe interessante conoscere i contenuti diquelle ulteriori versioni che Kalefati definì “favole” e“alterazioni popolari”, come se peraltro questa stessa suaversione fosse esente da tali tratti). Trattasi oltretutto di un
evento sul quale si istruisce un processo conoscitivo 113 annidopo, e sul quale il Kalefati ne stila un rapporto dopo altri 57anni circa dall'istruttoria (dopo, appunto, 170 anni dall'eventodel “miracolo” e del battesimo avvenuti nel 1605). Luoghi e itinerari di antichi culti ed antichi prodigi, queitratti dell'agro di Sava che vanno dal confine del paese stessosino a Pasano, Agliano, e altre zone limitrofe, possono esserestati “trattati”, come da “prassi”, per il recupero di fortisentimenti e devozioni popolari reinnestati su basi cristiane(cfr. SCHETTINO, 2014) . Nel nostro caso, non si può non considerarela possibilità di un sapiente e diplomatico innesto ad opera delvescovo Kalefati, che fu, secondo alcuni storici, uomoparticolarmente incline alla manipolazione di fatti storici e alla“creazione” di sana pianta di miracoli e leggende (cfr. TEOFILATO,1952).A integrazione di quanto sopra, e per tornare alla questione delloschiavo, si può aggiungere che dal 1500 sino a 1800 inoltrato leattività del Santo Officio nel territorio della diocesi di Oriasi occuparono di identità etnico-religiose in quanto potenzialiveicoli ereticali, di generi letterari e libri proibiti, dieretici, di forme varie di stregoneria e sortilegi, di“superstizione” ecc., insomma, coerentemente con la prassiinquisitoriale di ogni luogo, di tutto lo scibile che potesse inqualche modo minare la fede e il credo cristiano. Questo, ci dà ilquadro di quanto fosse importante e fondamentale per la Chiesa siacatechizzare e convertire eretici e persone praticanti altredottrine, che sradicare ogni residuo, ogni tentativo, e ogniaffacciarsi o riaffacciarsi di culti, dottrine e pratiche pagane,eretiche o in palese contrasto con il credo ufficiale. Ma ci dàanche l'idea, assieme all'analisi dei residui di paganesimo atutt'oggi presenti nella cultura contadina, di quantol'attaccamento ai culti pagani sia rimasto presente nellatradizione popolare stessa e di quanto abbia costituito unaminaccia per il culto dominante. In particolare, nella zonaconsiderata doveva ancora persistere un forte attaccamento a cultidi origine pagana o quantomeno a loro residui e reminiscenze: siintendono con questo termine i vari culti magnogreci e messapiciin quanto siamo in zona di confine, quelli antecedenti sino a etàneolitica, e quelli affermatisi nel periodo della occupazioneromana. Partendo dalla presenza di culti incentrati su oggettilitici di rudimentale forma e architettura, si passa ai pilastrivotivi – le “erme” o gli “enodi” dedicati alle divinità e ai cultisuccessivi. Tutto questo, lo andiamo a vedere, ricostruendolo perquanto possibile, più avanti nella trattazione.
Una riflessione la merita anche la catena conservata nella teca diPasano e attribuita allo schiavo. Molti studiosi locali (anche tracoloro i quali restano per fede convinti della veridicità dellastoria del miracolo) hanno messo in dubbio sia che si tratti dellaoriginale, effettiva catena che legava tale schiavo; altri, chelo schiavo avesse realmente come mezzo di contenzione una catena.Questo oggetto, peraltro, non risulta essere stato mai indagatoapprofonditamente per stabilirne una datazione. Ancora una volta,emerge una caratteristica che lega uno degli “oggetti-simbolo” delculto di Pasano con le caratteristiche dei culti più antichitipici della località. In diverse zone caratterizzate dallapresenza di santuari magno-greci, difatti, sono state ritrovatecatene, ceppi e collari in ferro utilizzati per gli schiavi deitempi. E' il caso, ad esempio, del santuario di Crotone dedicatoad Hera, e quello di Policoro (Herakleia) dedicato a Demetra.Demetra a Taranto e Herakleia è la divinità che può liberare ifedeli da condizioni di vita sfavorevoli (GOLIN, M. 2007). Nelsantuario di Policoro sono stati trovati alcuni esemplari di ceppidi schiavi. In tale santuario Demetra sembra essere esplicitamenteindicata come dea della liberazione dalla schiavitù, anche daalcune dediche votive incise su laminette bronzee. Secondo alcuniè propriamente Artemis Bendis la divinità a ciò deputata, secondoaltri Demetra. A Crotone, è Hera che ha questa facoltà.
Fig. 6 : Chiesa di Pasano, particolare dell' altare e dipinto di originebizantina posto su di esso
Fig. 7: Pasano, tela raffigurante il “miracolo dello schiavo”
Fig. 8 – il Masso “del miracolo”
Culti magico-religiosi pagani e cristiani tra la Cappella dello Schiavo e l' Edicola di Fra' Giannibale: similitudini e considerazioni. Diana, Ecate, i Lari.
Se ad Agliano c' era di sicuro il culto di Demetra e Kore comeelemento religioso di spicco, che si irradiava sino allecircostanti contrade (Pasano, Panareo, Camarda, ecc), nei pressidella attuale Sava doveva esserci qualcosa che aveva a che farecon divinità neolitiche prima, e con un complesso cultuale distampo messapico o magnogreco dopo, giungendo poi al paganesimodei romani che occuparono quei posti. Ancor più che i cristiani, ipagani, ai quali erano sacri di per se' elementi naturali (grotte,
alberi, fonti ecc.) e litici (pilastri, massi, menhir), nondistruggevano le presenze e gli echi dei culti a loro antecedenti,ma li integravano nella loro religione. Di un siffatto “impasto”cultuale, si possono notare nelle zone oggetto di questo studiotracce evidenti, perchè i loro residui e i loro simboli persistonoe si ripercuotono nella tradizione cristiana, fondendosi con essa:cerchiamo di scoprirli ed identificarli, continuando a percorrerel'itinerario cultuale che collega Sava con Pasano e con le altrelocalità vicine parti integranti del medesimo percorso. A proposito della “ubicazione” esatta dell' avvenimento delcosiddetto miracolo dello schiavo (ovvero della “caduta del massodal cielo”), Primaldo Coco afferma:
“Alcuni vogliono che il miracolo avvenisse vicino al bivioLizzano Torricella dove vi è l'immagine della Madonna, cosìdetta di F. Giunipero, laico alcantarino, altri ritengono dovesorge la cappellina dello Schiavo”. (COCO, 1915)
Mario Annoscia riprende i contenuti di questa annotazione del Cocoper esprimere alcune sue considerazioni:
“Sava, trivio Sava-Lizzano-Torricella: edicola votiva dedicataalla Madonna di Pasano, eretta intorno alla metà del XIX sec. E'questo il luogo dove la leggenda locale vuole sia avvenuto ilmiracolo dello schiavo? O l'altro dove trovasi l'omonimacappella? Perchè, distanti tra loro poche centinaia di metri,l'edicola sacra e la cappella ricorderebbero lo stesso evento?Oppure è da sospettare che questa edicola votiva abbiasostituito qualcos'altro?” (ANNOSCIA, 1996)
Ed è in questo passo, in una nota a piè di pagina, che Annosciaricorda che il toponimo di questo sito è “La Petra Santa”.Interessanti la posizione della edicola su un trivio (Coco parladi bivio) e il nome suddetto, che assieme ad una singolare usanzariportata dallo stesso Annoscia, descritta più avanti, vanno acostituire elementi di rimando ad un antico culto oracolare.Annoscia cita quello che può sembrare un curioso, simpatico efolkloristico aneddoto, ma che, in realtà, risulta importantissimoper la decifrazione del culto dell' Edicola, delle sue origini, edella sua ubicazione:
“Fino ai primi anni '60 si continuò la locale tradizione, daparte dei giovani in procinto di partire per il servizio dileva, di imbiancare ed adornare con mazzetti di fiori questaedicola sacra. In questo senso, fu mèta di particolare devozionedurante l'ultima guerra quando da Sava partirono oltre 2.000
soldati, tra giovani di leva e richiamati alle armi (novantanovetra caduti e dispersi, numerosi tra mutilati ed invalidi”.(ANNOSCIA, 1996)
Questa singolare tradizione è sopravvissuta in realtà fino aigiorni nostri, tanto che anche il sottoscritto ne è stato fatto“partecipe”: quando negli anni '80, infatti, mi accingevo apartire per la chiamata di Leva, delle anziane parenti miraccomandarono di andare a fermarmi in contemplazione davanti alla“Cappella di Fra Sciannibuli” e rivolgere alla statua di quellaMadonna una preghiera e raccomandarmi ad essa, “perchè così si fa”. Sia Diana (Artemide) che Ecate erano divinità protettrici dellestrade e dei crocicchi: verosimilmente, per questo motivo adentrambe era dati l'appellativo di Trivia. In loro onore venivanoedificate edicole, in prossimità appunto degli incroci delle vie.Divinità lunare, Diana-Artemide illuminava di notte le strade conla luce della luna, e per questo motivo era considerata ancheprotettrice dei viandanti e delle “partenze”. Curiosamente (altraanalogia che potrebbe essere casuale ma anche non esserloaffatto), Diana era anche protettrice della plebe, e deglischiavi, cui era consentito, persino a quelli fuggitivi, dipartecipare alle feste in suo onore. Greci e Romani innalzavano lungo le pubbliche strade colonne epilastri in pietra detti Enodii , sui quali erano scolpite le testedi divinità come Mercurio, Apollo, Ercole, Diana, e che fungevanoda custodi e protettori delle vie. A questi, solevano porgeresacrifici e voti prima di intraprendere viaggi. Diana fu dettaanche “Enodia” e, come si è detto, insieme ad Ecate godette anchedell'appellativo di “Trivia”, “perchè né trivii e quadrivii additavaall'incerto viandante la via” (BAZZARINI A., 1830). Da notare l'analogia trala tradizione savese del recarsi verso l' Edicola prima diintraprendere la partenza militare, e quindi le funzioni diprotezione e supporto della Madonna nei confronti del soldato chesi appresta ad un viaggio particolarmente carico di emotività edi incognito rispetto al futuro, e quella degli “Enodi”protettori, appunto, del viaggiatore. La tradizione del recarsipresso l' Edicola della Madonna connessa alle partenze militari(ovvero per avere notizie dei parenti partiti in guerra o, daparte degli stessi soldati, come augurio/protezione/divinazioneper la partenza verso il servizio di Leva o verso imprese diguerra) ha un suo corrispettivo in antiche - ma anche più recenti- tradizioni oracolari e divinatorie, a partire dagli antichiculti oracolari greci e romani, nei quali sono istituitiimportanti centri di consultazione rispetto ad ogni aspetto
importante e fatidico della vita individuale e sociale, tra cui leimprese di guerra, fino alla tradizione molto presente e sentitain Puglia della “Santa Monica”, un rituale di tipomagico/predittivo/oracolare sopravvissuto fino ai giorni nostri, eche si innesta su antichi rituali pagani. Analogamente ai culti sopra descritti, nell'antichità romanavenivano venerati i Lari nei crocevia. Inizialmente, più che iprotettori del focolare della famiglia, furono divinitàprotettrici dei campi, e venivano venerati, appunto, nei crocicchi(compita). La cappella stessa era chiamata Compitum. Anche in questocaso, c'era un particolare “legame” tra culto dei Lares Compitales eservitù: le famiglie dei servi e degli schiavi partecipavano alloro culto, tanto che i Lari ne erano protettori. E anche inquesto caso, queste divinità erano a protezione dei membri dellafamiglia quando partivano per un viaggio (oltre che, più ingenerale, a protezione di ogni evento o ricorrenza particolare).Un Larario, “serviva” più poderi o famiglie e per questo venivamesso al centro di un crocevia, in modo che vi fosse accesso edisponibilità verso i diversi occupanti dei poderi. Ai tempi diAugusto, il culto fu incrementato con un Lararium ad ogni vico (7a.C.). Oltre ai Lares Familiares, quindi, vi furono (ancor prima,secondo alcune interpretazioni storiche) i Lares Compitales(protettori di poderi e città) e i Lares Viales (protettori distrade).E' curiosamente suggestiva, sia per quanto riguarda l' Edicola diFra Giannibale che la Cappella dello Schiavo, la somiglianza conla tipologia architettonica di alcuni Larari, particolare che tral'altro ricorre in numerose Cappelle rurali e perifericheedificate negli stessi luoghi ove in precedenza esistevanofabbricati o elementi votivi pagani. Anche il relazione a talesingolare somiglianza, oltre che nelle caratteristiche di questisiti (posizione sul crocicchio e tradizione protettivo-oracolarenel caso dell'Edicola di Fra Giannibale), si può ipotizzare unacontinuità di tipo “culturale” e devozionale. A questo proposito,e con riferimento sia alle caratteristiche dell' Edicola di “FraSciannibali” che a quelle della Cappella dello Schiavo, vorreicitare anche un saggio-ricerca di A. Basile :
“... Comunque sin dal Medioevo si assiste ad una invasionecontinua delle immagini sacre all'interno della vita quotidiana,in quanto il clero vi intravede un facile ed immediato momentodi veicolazione dei princìpi cristiani, per cui diversi sono glistimoli che tramite i suoi rappresentanti rivolge ai credenti,affinchè facciano uso delle immagini sacre anche all'internodelle mura domestiche. […] Ed è proprio a partire dal medioevo,
periodo in cui si verifica l'invasione del sacro nel quotidiano,che si inizia nel nostro paese a diffondere l'usanza di erigereedicole votive, usanza che in clima cristiano ripropone momentidi culto tipicamente pagani, che trovano riscontro nell'anticoculto dei Lari”. (BASILE A., 1982)
Un altro elemento che rintraccia il Basile come tipico e comunedelle Edicole devozionali è quello che le vede sorgere comerelazionate a particolari accadimenti come miracoli, guerre,epidemie, cataclismi e avvenimenti religiosi eccezionali.Ulteriore elemento ricorrente, nella ricerca del Basile, è quello(ancora una volta in analogia con i culti tipici dei lararipagani, della loro collocazione ai crocicchi e del loro dupliceutilizzo (come per molti Larari) sia ai fini del culto privato chedi quello collettivo:
“... a differenza degli ex-voto che sono e che restanol'espressione di un rapporto privato tra il devoto ed il santoanche nel momento in cui vengono donati al santuario, le edicolevotive poste in relazione ai miracoli, invece, pur essendoanch'esse l'espressione di un rapporto privato, nel momento incui vengono erette al crocicchio di due strade o in unapiazzetta, diventano patrimonio di tutti, tanto che chiunquesenza la paura di invadere la proprietà altrui, provvede almantenimento ed al restauro di esse e col tempo cementano ilsentimento della coralità e della comune convivenza”. (BASILE,1982)
A chiusura di questo capitolo vorrei evidenziare alcuni altriparticolari della Cappella dello Schiavo: è singolare il fatto chenella parte inferiore delle facciate esterne della Cappella, visiano iscritti strani simboli e croci (fig. 9). Il fenomeno dellaiscrizione di croci è in genere attribuibile alla cristianizzazionedi luoghi di culto in precedenza “eretici” o adibiti ad usi pagani,riutilizzati o meno nel culto cristiano. La costruzione dellaCappella però avviene successivamente alla data attribuita al“miracolo dello schiavo” (avvenuto secondo il Coco nel 1605) e daalcune fonti è fatta risalire addirittura ai primi del 1700. Ilsignificato di queste croci (e delle altre incisioni) è perciò dachiarire. Probabilmente, si tratta, come ha suggerito qualcheosservatore, di segni tracciati dai pellegrini durante i loroviaggi spirituali, usanza non infrequente.
Fig. 9 – iscrizioni sulla facciata esterna del muro della Cappella dello Schiavo
Dalla Dea Madre a Demetra, Artemide, Ecate sino alla Madonna
“Allora il segretario, calmata la folla, disse: «Uomini di Efeso,c'è forse qualcuno che non sappia che la città degli Efesini è lacustode del tempio della grande Diana e della sua immagine cadutadal cielo?” (Atti degli Apostoli, 1:35)
Non può non balzare alla mente, considerando in generale i mitidella Madonna, specialmente quelli inseriti nell'ambito deiSantuari di campagna e legati a culti agrari e ctoni, che questafigura si sostituisce, nelle sue caratteristiche e nellavenerazione assegnatale, al vecchio culto pagano della Dea Madre,e a quelli tipici di Demetra, Ecate, ed altre divinità ctonie.Inoltre, una non trascurabile analogia tra la pietra caduta dal
cielo a Pasano, ad opera della Madonna, si rintraccia nell'anticoculto di Cibele, che si manifestava nella sostanza della roccia, eche si credeva fosse caduta dal cielo sotto forma di una pietranera. Più in generale, l' “Omphalos” (termine coniato dagliantichi greci) è una pietra caduta dal cielo, o una pietra sacrache comunque rappresenta l'unione fra cielo e terra, fra divino eterreno. Ancora, è assai considerevole la somiglianza del masso diPasano con quello scoperto e interpretato a Bisceglie comerappresentante la Dea-Madre, sia come forma che come dimensioni:il masso di Bisceglie, è legato anch'esso ad un complesso cultualeche riguarda elementi ctoni. Ancora: i simulacri delle Graziegreche descritti da Pausania sono fatti di pietre cadute dal cielo, e perciò ritenute sacre (CIAMPI, 1829). Ateneo nel descrivere leorigini cretesi degli iapigi e dei tarentini parla della lorocredenza nelle pietre cadute dal cielo. (WUILLEUMIER, 1987). Neltempio di Artemide ad Efeso si venerava una pietra caduta dalcielo, tanto che l'utilizzo dell'edificio, proseguito in epocacristiana nonostante parziali distruzioni, era mal tollerato dallareligione dominante: la gente continuava ancora a venerare lepietre sottratte all'area sacra, e la più venerata era la “pietracaduta dal cielo”. Anche per questo, Giovanni Crisostomo, Vescovo diCostantinopoli, ordinò la totale distruzione del tempio nel 401.Il culto delle pietre sacre sopravvive in epoca cristiana ed èaddirittura oggetto di una fitta serie di provvedimenti tra il450 e il 700 d.C. (Concilio Arelatense - 452, Concilio Turonense- 567, epistole di Gregorio Magno - 590-604, Concilio Namnetense -658, Concilio Tolentanus - 681 e 693). Di fatto, poiché spesso gliattaccamenti a questo genere di culti risultavano sradicabili,popolari ed estesissimi, più che per la distruzione la Chiesa optòspesso per un controllo ed una incorporazione delle credenze. Si può, in definitiva, supporre un forte legame residuale da partedelle genti cristianizzate, e nel nostro caso, delle coscienzesavesi, con oggetti litici “magici”, considerando che l'intero“itinerario” dedicato al culto della Madonna di Pasano (ovverodalla zona della Cappella dello Schiavo in Sava sino alla contradaPasano e zone limitrofe) è costellato di simboli e miti derivabilida culti e tradizioni di molto antecedenti il cristianesimo.Difatti, l'intero percorso del culto è delineato dalla presenza,quasi ossessiva, di riferimenti magici e cultuali che si innestanosu altri più remoti: di tipo “profano”-medioevale, a ritroso sinoa culti pagani di vari epoche.
Il “Sannai della Pioggia”
Pasano, come si è detto, assieme alla vicina Agliano è statafattoria magno-greca, successivamente fattoria romana, e luogodi insediamenti ancor precedenti; nei pressi di Pasano si trovanoaltre contrade dagli indiscutibili segnali di insediamentiripetuti nel corso dei millenni; in particolare la contrada“Grava” con la grotta Palombara offre alla visione del visitatoresuggestioni che rimandano ai tempi della preistoria e dellaprotostoria; infine, la presenza di “Sannai” (Osanna) e di mitidedicati alla pioggia rimanda a possibili letture di innesti delculto su retaggi di miti e tradizioni di molto antecedenti. E' ilcaso, anche, del complesso rituale proveniente dai “miracolidellla pioggia” attribuiti sempre alla Madonna di Pasano. E'infatti degno di nota il fatto che la Madonna di Pasano, tipica“divinità agreste”, è stata da sempre collegata anche agli eventiatmosferici e ai fenomeni naturali, nella duplice veste didispensatrice di pioggia ma anche di figura che riesce a fermaretemporali e uragani. Si ha inoltre notizia di una processione perinvocare la pioggia praticata a Sava, lungo un itinerario che, daSava verso Pasano, prevedeva una “fermata” a metà strada, pressoil “Sannai della pioggia” (fig.10), situato in contrada “Panareo”. Danotare come nell'omonima isola siciliana (Panarea) si siarintracciata la presenza di antichi culti dedicati a fenomeninaturali. Lo stesso Pichierri, riprendendo uno studio di Rohlfs,cita l'analogia dei due toponimi, considerandoli entrambi disostrato magno-greco (PICHIERRI, 1994). Sulle questioni della funzione, significato e origini dei“Sannai” esiste ormai una vasta letteratura, molto interessante daconsultare e approfondire, per il rapporto che è statorintracciato e che lega Menhir, pietre e pilastri votivisuccessivi (di epoca greca e romana) e infine Sannai. Basti quiricordare che il culto e l'utilizzo di pilastri “votivi” sitrascina e riveste significati ed importanza anche in epoca grecae romana, continuando a diffondersi sino ai primi secoli delcristianesimo. Molte di queste pietre magiche sono sopravvissutefino ai giorni nostri, circondandosi di vecchie e nuove leggende,di ulteriori attribuzioni magiche e sacrali, altre sono statecristianizzate e riadattate agli scopi della chiesa cattolica (ilcaso, appunto, dei cosiddetti Osanna o “Sannai” - cfr. CONGEDO, P.,2012). Una – forse non casuale – analogia tra la Dea originale delle messi(Demetra) e la Madonna di Pasano la si ritrova anche in un anticodetto popolare savese:
Ohi Matonna ti Pasanu fammi fari motu granu, ca lu tata mia è purieddu,mà 'ccattà lu ciucciarieddu” (oh Madonna di Pasano, fammi fare moltograno, perchè mio padre è poverello, dobbiamo comperare l'asinello”).
Ciò che balza alla mente, oltre che la bellezza poetica di questaorazione popolare, è, ancora una volta, l'attribuzione allaMadonna locale delle stesse prerogative della sua figuracorrispettiva antecedente.
Fig. 10 Sannai “Panareo”, 1979, foto tratta da Annoscia M. (in: “Il santuariodella Madonna di Pasano presso Sava”, Del Grifo ed., pag. 44)
L' antica tradizione degli ex voto a Pasano
Per quanto non necessariamente collegabile in via diretta allaprecedente tradizione pagana in loco, ma a completamento, in ognicaso, della trattazione sull'innesto e sulla commistione dielementi di derivazione pagana con quelli più esattamentedefinibili come cattolico-cristiani, vorrei citare la tradizionedegli ex-voto nella Chiesa di Pasano. Di questa caratteristica,della quale è ormai scomparsa ogni traccia, ci offre un esaustivoquadro Gaetano Pichierri:
“Vi è, presso la Biblioteca Francescana di Sava, una brevepubblicazione del 1897 dal titolo: I miracoli di Maria SS. DiPasano, stampata dalla Tipografia D'Errico di Manduria e privadel nome del suo autore. Da tale libello e da un manoscrittoappartenente alle signorine Caraccio, gentilmente messomi adisposizione, scritto dal loro parente Davide Mele intorno al1860, ho tratto alcune -forse- nuove notizie sulla devozionesavese alla Vergine di Pasano. […] La devozione a quella sacraimmagine non era sentita solamente da parte degli abitanti delnostro paese, ma anche dei paesi circonvicini e di altri purepiù lontani. Cosicchè le pareti del Santuario erano piene di exvoto per grazie ricevute. Ecco, a proposito, quanto si leggenell'elenco dell'autore anonimo: “A destra e a sinistra dell'Altare Maggiore, una gran quantità di mani, di busti, teste,piedi di votivi tutti di cera vi sono appesi [...]”. (PICHIERRI,1994)
La ceroplastica a fini cultuali e votivi ha origini moltoantiche: gli antichi romani usavano conservare i ritrattiin cera degli antenati (Lares e Penates) in nicchie ricavatenei muri delle case, e questi volti in cera raffiguranti idefunti venivano “trasportati” in occasioni solenni ecommemorative come funerali , matrimoni, nascite,festività, per rendere i defunti stessi partecipi dellecerimonie; così come pare anche che nell'antica Gecia(oltre che nella stessa Roma) si modellavano sia ex voto interracotta raffiguranti psrti del corpo, che bambole colviso di cera (pupae), arte perdurata fino al 1800 circa. Lacera fu utilizzata anche a scopi votivi, per realizzaremodelli di organi malati o sani utilizzati come “offerte”.Depositi di questo genere di ex-voto sono venuti alla lucenella ex Magna Grecia, e nelle necropoli della Campania e
in quelle degli Etruschi (i materiali utilizzati, oltrealla cera erano la terracotta e l'argento – quest'ultimolimitatamente ai ricchi); la tradizione si è perpetratasino alla presenza di questi oggetti in santuari cristianicome ad es. la chiesa della SS. Annunziata a Firenze oquella della Madonna delle Grazie a Mantova, nella quale,in particolare, sono presenti numerosi ex-voto in cera,disposti lungo pareti e colonne, raffiguranti particolarianatomici (cfr. BALESTRIERO, 2006). La tradizione degli ex voto a Pasano potrebbe dunquerappresentare un continuum “cristianizzato” derivante dauna tradizione molto antecedente instauratasi nel medesimoluogo, oppure essere stata mutuata (in ogni caso) daresidui di usi e credenze più antiche. Nel santuario magno-greco di Herakleia (Policoro) Demetra svolge anche funzionidi divinità salutare, e a lei vengono dedicati ex voto interracotta nella forma di parti del corpo come piedi, manie dita (GOLIN, 2007).
La grotta Grava-Palombara nei pressi di Pasano e altri luoghi edelementi ctoni
Nel tragitto tra Sava (zona Cappella dello Schiavo - Edicola diFra Giannibale - via Montebello e dintorni) e Pasano (Panareo – Pasano - Grava) ricorrono dunquecostanti la commistione di culti cristiani e pagani, e inparticolare di venerazioni e tradizioni legate alle “pietresacre”. Ma ricorre anche la presenza di elementi cultuali legatiall'acqua. Dalle “coppelle” presenti nei monoliti di viaMontebello, al “Sannai della Pioggia” in zona Panareo, dallaMadonna che preserva dalle tempeste, alla stessa Madonna cheriesce a causare la pioggia in periodi di siccita, sino alsuggestivo scenario della grotta “Palombara” in contrada Grava,mentre nella stessa Agliano, che non è molto distante da Pasano(tanto da aver evocato in diversi studiosi locali l'immagine di ununico - o collegato- complesso cultuale e/o insediativo), pareesistesse in antichità una grossa palude (e il terreno argillosocaratteristico della zona circostante la Masseria di Agliano ne èprova ancora visibile, oltre ad antichi documenti che citanoespressamente l'esistenza della “Palude di Agliano”).L'importanza dell'acqua come elemento cultuale è stata descrittain diversi lavori di taglio etno-archeologico (cfr. BIANCO, 1999).Rocce e monoliti, grotte e cavità sotterranee, acque, fenomeniatmosferici, piante (e loro utilizzi), agricoltura, si
ricollegano a culti ctonii e di conseguenza a divinità ctonie efemminili. Non può non venire alla mente il nesso esistente tra iluoghi, e divinità che in un certo senso portano la "staffetta"dei culti ctonii collegati a questi aspetti della natura, qualiappunto la Dea Madre, Demetra (e sua figlia Kore), la Madonna diPasano. Le divinità maschili probabilmente compresenti inquest'area, stando non solo alle interpretazioni storiografiche(in merito ai ritrovamenti) ma anche alla "logica" dei culti ealle caratteristiche dei paesaggi, potevano essere Dioniso, Ade,Pan, Helios. E' il caso di menzionare anche, parlando del complesso dei mitilegati a Pasano ed Agliano, di una località non molto distante,chiamata "Curti di l' Oro", con la leggenda ad essa legata (ecomune a molte zone d' Italia) de "la chioccia dai pulcini d'oro"nonchè i racconti di "occhiature" (a loro volta collegati alla"chioccia" o a fantastiche leggende di tesori custoditi da dèmoni)situate nella zona. Inoltre, sia passi provenienti da ricerche distorici locali, che racconti provenienti dalla tradizione orale,in merito alle gallerie sotterranee presenti nel sottosuolosavese, vogliono che dette "gallerie" si estendessero entro unraggio che collegava anche Sava con Pasano :
"Secondo le ricerche di Achille D'Elia, di cui è notizia in unmanoscritto inedito di proprietà della famiglia Spagnolo-Rochiradi Sava, la località ove ha trovato ubicazione questo UggianoMontefusco era stata già sede di un fortilizio messapicocollegato da cunicoli sotterranei a vari centri dell'interno eprobabilmente, a mio avviso, anche della zona costiera se è vero,come è vero, che tali passaggi nascosti, utilizzaronoparzialmente, a tratti, anche naturali tracciati carsici che sidiramano sottoterra in un tessuto fitto di camminamentiannodantisi fino a Pasano, cittadina distrutta innumerevoli voltedalle scorrerie piratesche provenienti dai lidi africani e di cuiè noto il reiterato esodo della popolazione inerme verso Sava chesorse e si estese proprio intorno allo sbocco di questi cunicoli"(DEL PRETE, 1973)
Un'altra versione, la fornisce Primaldo Coco, su questi "passaggisotterranei": non si evince esattamente, dalle parole del Coco,che mettessero in comunicazione Pasano con Sava, ma chesicuramente e comunque fossero situati in zona "Castelli"(l'attuale centro di Sava) e che erano utilizzati come rifugio enascondiglio o via di fuga dalle incursioni:
"Nel 1378 adunque distrutto Albaro, avvenne anche l'abbandonoe la distruzione dei vicini casali di Aliano, di Pasano e di S.
Maria di Bagnolo, gli abitanti dei quali, presi dal panico e dalterrore, fuggirono e pochi, anzi pochissimi vi tornarono [...]La maggior parte di questi profughi per sfuggire alla mortevennero a dimorare in un luogo più sicuro messo sul confine delfeudo di Pasano o di Aliano dalla parte del levante, nellacontrada chiamata i Castelli; ove poteano in tempi dipersecuzioni facilmente salvarsi nei diversi cunicolisotterranei che vi erano e che tuttora in parte sussistono"(COCO, 1915)
Tornando alla Grava , poco distante da Pasano, è nota la presenzadi una imponente grotta (detta "Palombara"), sicuramente meta diculti e frequentazione in svariate epoche. Il sito èspeleologicamente censito ma non sembra essere mai stato oggettodi studi approfonditi. Conserva degli aspetti affascinanti che, inqualche modo, parlano da sè della sua storia, o la suggeriscono.La grande grotta, è aperta verso l'alto da un grande lucernario(fig. 11) , e circondata da grandi "sedili" scavati nella rocciache potevano anche svolgere la funzione di aree di accomodamento,mentre al centro c'è una sorta di incavatura che suggerisce lapresenza di un fonte. La somiglianza del sito con il FontePliniano di Manduria è veramente notevole , e, come noto, lostesso "Scegnu" di Manduria è stato individuato da molti come unluogo dedicato a divinità e culti delle acque. Sugli scalinitufacei che consentono di scendere, dal piano, attraverso unsuggestivo corridoio (fig. 12), nel profondo della grotta,numerose croci segni di cristianizzazione (successiva) e difrequentazione dei luoghi (fig. 13). Probabilmente, dunque, siamo in presenza di un "complesso"cultuale che dalla preistoria attraversa l'epoca magno-greca,quella romana, e quella bizantina. Dalla Dea Madre, quindi, a Pan,a Demetra e Dioniso (le grotte erano luoghi sacri a questo tipo didivinità), sino ad arrivare alla cristianità e alla contemporaneapresenza-persistenza di culti "profani", retaggio erimaneggiamento delle antiche tradizioni pagane stesse (luogod'appuntamenti sabbatici e rituali di "malombre" e "masciari"): alproposito è degno di menzione il fatto che in una mia visitarecente al sito, in compagnia di gente di Sava, uno di costoroaccennava a racconti, tramandati da anziani parenti, in merito ariunioni di "streghe" nella Grotta Palombara. La tradizione"magico-stregonesca" è rimasta, difatti, viva nelle nostrecontrade e nella locale cultura popolare sino ai primi del '900, eper alcuni suoi aspetti anche oltre. Si può perciò pensare ad unasorta di continuum "frequentativo" di questa grotta a partire dalperiodo indigeno (caratterizzato ovunque dalla presenza e
dall'insediamento – anche di tipo cultuale – presso grotte ecavità naturali), per poi arrivare alla popolazione magno-greca ea quella latina, con utilizzi rituali di tipo pagano: certamente,vista la presenza provata di insediamenti, negli immediatissimiparaggi, non poteva essere loro sfuggito questo sito che è, nellesue caratteristiche, uno dei tipici luoghi prediletti negliantichi culti (con una serie di divinità "tipiche", come Demetra,Ecate, Dioniso, Pan, ecc.). Attraversando poi l'utilizzo nelperiodo basiliano, sarà stato poi ancora frequentato nel periodomedioevale e in quelli successivi come luogo tipico difrequentazione e rituali residuati dagli antichi culti pagani eperciò "segreti" ed eretici.
Fig. 11: Grotta "Grava", lucernario
Il Percorso cultuale e viario : altri collegamenti
Vorrei riportare soltanto qualche cenno rispetto ad un' altraparte del territorio che ricollega Pasano ad altri luoghiattraversati nei secoli e nei millenni da antichi insediamenti eda percorsi cultuali. Esiste una ulteriore arteria che, partendoda Pasano, (“tagliata” dalla attuale Sava-Torricella) costeggiandola contrada detta “Monaci” giunge, attraverso la zona “TrudduLuengu” sino a zona “Petrose”, località anticamente detta anche“Pietra Fitta”, e prosegue (superando attraverso un incrocio neiparaggi di Masseria Petrose, l'attuale strada Sava-Maruggio),verso la zona detta “Carrara di Mare” giungendo sino a Bagnolo (o“Bagnulu”) e quindi Uggiano Montefusco. Da un rilievo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sava pubblicato in un documento diAnnoscia, emerge che questa strada (così come è ancora intuibile evisibile a tutt'oggi) rappresentava un antico collegamento daPasano (e, ancor prima, da Lizzano) verso Bagnulu e UggianoMontefusco, tanto da essere ancora indicata, in un fogliorisalente presumibilmente al 1911, “Strada Comunale di Lizzano eUggiano” (DESANTIS – ANNOSCIA, 1993). Questa strada, seppur modificatanel tempo e spaccata da recenti arterie, è ancora sostanzialmentepercorribile e presenta tuttora tratti e caratteristiche di unantico collegamento viario. Il primo collegamento di rilievo èquello con la zona detta “Petrose”: in prossimità di questacontrada, infatti, si rintracciano ancora costruzioni di probabileepoca medioevale, alcuni indizi che possono far risalire allapresenza di antiche “centurie” romane, e frammenti di laterizi diepoca probabilmente romana. Nelle adiacenze della MasseriaPetrose vi è una antica cappelletta dedicata a S. Eligio(protettore dei fabbri e dei cavalli, nonché santo “avversario”del diavolo) e successivamente alla Madonna delle Grazie.Sul tetto della Masseria si staglia una antica figura apotropaica,e alle sue spalle si erge una altura luogo di rinvenimentineolitici (PICHIERRI 1994; DESANTIS, ANNOSCIA 1993). Strane formeantropomorfe in pietra sono sparse in cima all'altura, insieme adaltri blocchi litici che appaiono in qualche modo modellati, efanno pensare ad un luogo anticamente vissuto come una sorta di“centro” cultuale primordiale. Nei paraggi di queste pietre cisono altri blocchi di dimensioni molto più grandi, che non èescluso che abbiano potuto essere in passato assemblati a mo' diDolmen.
La strada “Petrose” si collega poi a Bagnolo attraverso lacosiddetta “Carrara di mare”. Bagnolo è stato antico casale ed èsede di rinvenimenti archeologici a partire dall'età neolitica(RUSSO - TARENTINI) sino alle varie epoche successive (DE SANTIS -ANNOSCIA). Si notano ancora oggi la Masseria (ristrutturata rispettoalla sua forma originale) e l'antica chiesetta di Santa Maria diBagnolo, mentre il Monte Bagnolo che vi passa appresso è sede diuna antica leggenda, anche questa di carattere “litico”: unaserie di cumuli di pietre presenti su quel monte sarebbero i corpipietrificati di fanciulli e fanciulle che in antichità su quelmonte avrebbero avuto un eccesso di piacere (SOLITO, 2014). Neipressi della Masseria di Bagnolo si trova anche la cosiddetta“Grotta Lucerna”, luogo suggestivo e magico che doveva far partein antichità del complesso cultuale specifico. Nella grotta siintravedono tuttora delle emblematiche, antiche iscrizioni inparte consumat ed erose dal tempo.
Conclusioni
In conclusione, la curiosa concomitanza e mescolanza di unavarietà di elementi litici sacri in antichità, e di tradizioni edaspetti cultuali che rimandano a forme pagane, con il culto dellaMadonna di Pasano e con tutto l'itinerario cultuale connesso aquesta figura della cristianità, non sembra affatto casuale.Elementi cultuali litici ricorrono nella storia e nella "scena"dei percorsi cultuali e viari della zona, sia in quelli che hannomantenuto un continuum come tradizione (l'itinerario Sava – Pasanoche ancora oggi è caratterizzato da una processione) sia nelcollegamento storico-archeologico tra Pasano ed Agliano, che nellaantica viabilità dalla quale si intravedono collegamenti anche traPasano ed altri luoghi come Petrose e Bagnulu, tutticaratterizzati da una successione di culti e insediamenti apartire dal periodo litico. Culti dedicati a Demetra, e, ancor precedentemente, ad unadivinità ctonia antecedente, sono stati rintracciati in molte zonedel Meridione d' Italia, e spesso l'analisi dei luoghi, delletradizioni e della storia ha rivelato un sorprendente continuumtra la figura di Demetra e quella della Madonna che la hasostituita con l'avvento del cristianesimo. Demetra, a sua volta,sostituisce divinità precedenti di stampo femminile e legate aglistessi aspetti (terra, fenomeni naturali, agricoltura, ecc.).Altre divinità ctonie (come Persefone, Ecate ecc.) sono
caratteristiche dei luoghi di frontiera della Chora tarantina (inambito messapico, le divinità equivalenti), così come lo sonodivinità e semidivinità di stampo rurale (Pan, Dioniso, Artemide,i Lari, ecc.). Ecate e Artemide (spesso la stessa Persefone)appartengono anche alle deità divinatorie caratteristiche deicrocicchi e protettrici dei viandanti assieme ai Lares e aHermes, altro dio legato sia agli inferi che alla divinazione.Sradicare miti e culti arcaici, fortemente impressi nellatradizione popolare, era impresa ardua e difficile, per cui sipreferiva rendere meno traumatico il passaggio da una religioneall'altra incorporandone vecchi elementi, riadattandoli o“chiudendo un occhio” rispetto ad alcune manifestazioni dipaganesimo che venivano reincorporate nella fede e nellasimbologia cristiana; d'altra parte, era il popolo stesso checompiva questa operazione sincretica non riuscendo a rinunciareall'attaccamento al vecchio culto e alle vecchie tradizioni.
BIBLIOGRAFIA
Anniboletti, Lara “Compita vicinalia a Pompei: testimonianze del culto”in Vesuviana, Serra editore, 2010Anniboletti, L. “Compita vicinalia di Pompei e Delo: testimonianzearcheologiche del culto domestico di theoi propylaio” in Religionemsignificare : aspetti storico-religiosi, strutturali, iconografici emateriali dei sacra privata : atti dell'incontro di studio, Padova, 8-9giugno 2009 / a cura di Maddalena Bassani, Francesca Ghedini AnthenorQuaderni, Università degli studi di Padova, Dipartimento di archeologia,2010Annoscia, Mario: "Il Santuario della Madonna di Pasano presso Sava –cronaca, leggenda e tradizioni”, Del Grifo, Le, 1996; Archeocalabria Virtual – Soprintendenza per i beni archeologici dellaCalabria – Crotonehttp://www.archeocalabria.beniculturali.it/archeovirtualtour/calabriaweb/crotone6_2.htmBalestriero Roberta, “Storia della ceroplastica”, 2006Basile Antonio, “Momenti di religiosità popolare nel Salento: le edicolevotive” in Sallentum, Rivista quadrimestrale di cultura e attivitàsalentina, Anno V, n. 1, Genn-Apr. 1982, EPT Lecce – Ed. Salentina –Galatina, pp. 93-100.Bazzarini A., Dizionario Enciclopedico delle Scienze, Lettere ed Arti –
Vol. II Venezia, Andreola, 1830Bianco, Salvatore "Il culto delle acque nella preistoria", in Archeologiadell'acqua in Basilicata", Soprintendenza Archeologica della Basilicata -Consiglio Reg. Basilicata, 1999Boccadamo, Giuliana: “Napoli e l' Islam. Storie di musulmani, rinnegati eschiavi in età moderna” D'aura Ed., Napoli, 2010Bono, Salvatore “Schiavi in Italia: maghrebini, neri, slavi, ebrei ed altri (secc. XVI – XIX)” in “ Mediterranea – ricerche storiche anno VII agosto 2010” n. 19Carducci, Giovangualberto “I confini del territorio di Taranto tra basso medioevo ed età moderna”, Mandese Editore, 1993Carrino, Francesco “Una campagna di scavi per scoprire le bellezze della nostra storia” in Sportello Aperto – Periodico di Economia, Cultura e Sociale Anno VI n. 2, BCC S. Marzano di S. Giuseppe, luglio 2009Centro Studi Helios – La Sicilia in Rete - "Demetra e Persefone"http://www.lasiciliainrete.it/STORIAECULTURA/culti_miti_SICILIA/2_cultidiorigineindigena/demetra.htm Centro Studi DATP - Misteri dell’antichità: Culti delle acque e Mitodel Sole- viaggio nei luoghi sacri di Andria, Bisceglie, Turi. - Lescoperte di Pina Catino - http://www.dirittodellearti.it/index.asp Ciampi, Sebastiano “la Grecia descritta da Pausania”, Sonzogno, 1829,Tomo Quinto, pag. 330 Coco, Primaldo "Cenni Storici di Sava, Marzo editore, 1984Coco, Primaldo "Maria di Pasano protettrice di Sava" in "Cenni Storici diSava, Marzo editore, 1984 (ristampa dell'opera omonima uscita nel 1915 ede dita da Stab. Tipografico Giurdignano, LE) pp. 271-281 Congedo, Pietro “Dolmen e Menhir con particolare riferimento a quellidel Basso Salento” , dic. 2012, in “Blog di Pietro Congedo”http://pietrocongedo.blogspot.it/2012/12/dolmen-e-menhir-con-particolare.htmlDel Prete, Pasquale, “Il Castello federiciano di Uggiano Montefusco”, inArchivio Storico Pugliese, 26, 1973De Sanctis, Gianluca “Più grande di un uomo ma non ancora dio. Immaginiteologiche e presupposti politici del culto imperiale” Desantis Cosimo, Annoscia Mario, “L'insediamento neolitico di Contrada LePetrose in agro di Sava” in “Lu Lampiune”, IX, n. 2, 1993Desantis Mimino, Annoscia Mario “Santa Maria di Bagnolo e Sant' Anastasiocasali distrutti in Diocesi di Oria” in “Brundisii res” VIII (1976), pp.143-159De Vecchis, Gino “Denominazioni comuni e nomi propri di localitàabitate”, in: Toponomastica, Istituto Geografico Militare Finocchietti, Luigi “Il distretto tarantino in età greca” in Workshop diArcheologia Classica Paesaggi Costruzioni Reperti Annuario Internazionalediretto da Andrea Carandini ed Emanuele Greco Serra Editore 6-2009Giannelli, Giulio, “Lari” in Encicloperdia italiana Treccani, 1933Golin, Marta “Il santuario di Demetra a Policoro” Scorpione Editrice,Taranto, 2009Lilliu, G., “Betilo”, in Enciclopedia dell' Arte Antica, Treccani, 1959
http://www.treccani.it/enciclopedia/betilo_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/ Mele, Gianfranco “Piante spontanee ad uso magico, rituale, medicinale einebriante in provincia di Taranto e del Salento. Usi tradizionali , noteetnobotaniche, ricostruzioni storichje e documentarie” 2014Mele, Gianfranco “Agliano al confine tra Magna Grecia e Messapia, unsito ancora da indagare” in Cultura Salentina, rivista di pensiero ecultura meridionale, ottobre 2014Pichierri, Gatetano, “Agliano nella storia della Magna Grecia”, inLomartire G. Sava nella storia, Cressati – Taranto, 1975, pp. 98-111Pichierri, Gaetano “Le origini del culto di Maria SS. Di Pasano – notizieantiche e recenti” Italgrafica, Oria, 1985Pichierri, Gaetano “Un insediamento magnogreco ed un santuario di cultoorfico ad Agliano” in Presenza e memoria” Anno I, 3, ottobre-dicembre1987, e in “Omaggio a Sava” 1994Pichierri G., “Il Limes Bizantino o Limitone dei Greci in agro di Sava”,in: Gaetano Pichierri, Omaggio a Sava, a cura di V. Musardo Talò, DelGrifo Edizioni – LE 1994, pp. 49-86, raccolta di articoli del Pichierriediti tra il 1975 e il 1989Pichierri, G., “I confini orientali della Taranto greco-romana”, in“Omaggio a Sava, cit., pag. 242Pichierri G., “Gli ulivi di Pasano”, in Pichierri, “Omaggio a Sava” acura di Vincenza Musardo Talò, Del Grifo Edizioni, LE, 1994Pichierri G., “La devozione alla Vergine di Pasano attraverso la letturadi due documenti del secolo scorso”, in “Omaggio a Sava”, Del Grifo, 1994Pichierri, G., “Il villaggio neolitico sulla via dell' Ossidiana” in“Corriere del giorno anno III n. 61, e in “Omaggio a Sava”, 1994)Pichierri G. “Torricella nacque a Malagastro?” in Corriere del Giornoanno III n. 135 del 29/6/1986 e in “Omaggio a Sava”, 1994Righetto, Elena “E non lases iuvate! Appunti d'analisi sul cultodomestico romano”, 2014Rossetti, Giuseppe: "Due significativi monumenti in agro di Sava" , FiloEditore, LE, 2006 Russo, Gemma; Tarentini, Paride “Uggiano Montefusco fraz. di ManduriaLoc. S. Maria di Bagnolo – Masseria Le Fiate: Villaggio Neolitico” in“Notiziario Ric. e St.” Emeroteca Brindisi, pp. 265-66Schettino, Stefania “Iside e Maria di Nazareth attraverso mito estregoneria”, ebook, Hoepli, 2014Solito, Carlos: “Sava, Lime e il Messico” in VanityFair.itStranieri, Giovanni: “Un limes bizantino nel Salento? La frontierabizantino-longobarda nella Puglia meridionale. Realtà e mito del“Limitone dei Greci” - Archeologia Medioevale, XXVII, 2000, pp. 333-355Stranieri G., Fiorentino G., Grasso A., Napolitano C.: “Organizzazione etrasformazioni dei paesaggi agrari medievali nel Salento Un approccioarcheologico ed archeobotanico allo studio di una delimitazione agrariain pietra a secco (Sava – Taranto)” - in "Archeologia Medioevale" XXXVI2009, pp. 259-271Teofilato, Cesare: "Sui falsi diplomatici di Monsignor Calefati vescovo
















































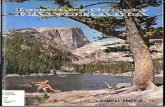




![E]E!DH - RERO DOC](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63233b14f3cd44b80906ba12/eedh-rero-doc.jpg)








