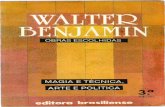“Le implicazioni per la politica di difesa e lo strumento militare”, In S.M. Torelli e...
Transcript of “Le implicazioni per la politica di difesa e lo strumento militare”, In S.M. Torelli e...
L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
A cura di Stefano M. Torelli e Arturo Varvelli
ISBN 978-88-98014-69-9 (edizione Pdf)
© 2015 Edizioni Epoké
Prima edizione: 2015
Edizioni Epoké. Via N. Bixio, 5
15067, Novi Ligure (AL)
www.edizioniepoke.it
ISPI. Via Clerici, 5
20121, Milano
www.ispionline.it
Progetto grafico e impaginazione: Simone Tedeschi
I edizione
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può
essere fotocopiata, riprodotta o archiviata, memorizzata o trasmessa in
qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale
– se non nei termini previsti dalla legge che tutela il diritto d’autore.
Nato ottant’anni fa, l’ISPI è un think tank indipendente dedicato
allo studio delle dinamiche internazionali, con l’obiettivo di favo-
rire la consapevolezza del ruolo dell’Italia in un contesto globale
in continua evoluzione.
È l’unico istituto italiano – e fra i pochissimi in Europa – ad af-
fiancare all’attività di ricerca un altrettanto significativo impegno
nella formazione, nella convegnistica e nelle attività specifiche di
analisi e orientamento sugli scenari internazionali per imprese ed
enti.
Tutta l’attività è caratterizzata da un approccio interdisciplinare -
assicurato dalla stretta collaborazione tra specialisti in studi eco-
nomici, politici, giuridici, storici e strategici, provenienti anche da
ambiti non accademici - e dalla partnership con analoghe istituzio-
ni di tutto il mondo.
Indice
Introduzione,
Paolo Magri .................................................................................... 7
Parte prima – Gli scenari geopolitici e gli interessi italiani
1. Da al-Qaida alle nuove formazioni:
la minaccia jihadista cambia
Paolo Maggiolini .......................................................................... 17
2. Libia: la sfida dello Stato Islamico
Laurentina Cizza, Karim Mezran ................................................. 43
3. L’ascesa del jihadismo in Algeria e Tunisia:
gli interessi italiani
Stefano M. Torelli ......................................................................... 57
4. Non solo Sinai, l’estremismo di matrice islamica in Egitto
Wolfgang Pusztai .......................................................................... 77
5. “Siraq” tra terrorismo e guerriglia
Andrea Beccaro ............................................................................ 93
6. AfPak: i rischi del broader disengagement
Riccardo Redaelli ....................................................................... 105
7. I pericoli di una spirale balcanica
Giovanni Giacalone .................................................................... 115
6 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Parte seconda – Quali implicazioni per l’Italia
8. Le implicazioni per la politica estera
Arturo Varvelli ............................................................................ 129
9. Le implicazioni per la politica di difesa
e lo strumento militare
Fabrizio Coticchia ...................................................................... 143
10. Le implicazioni per l’intelligence
Marco Minniti ............................................................................. 159
11. Le implicazioni per la politica
degli aiuti e dell’immigrazione
Lia Quartapelle .......................................................................... 167
Gli Autori .................................................................................... 177
Introduzione
L’ascesa dello Stato Islamico (IS) in un vasto territorio tra Siria e
Iraq e la competizione innescatasi all’interno della galassia jihadi-
sta della vecchia al-Qaida sembrano attivare dinamiche di concor-
renza/coesistenza che hanno conseguenze molto rischiose per
un’intera area geopolitica affetta da una situazione d’instabilità
che già costituiva un terreno fertile per la proliferazione di gruppi
radicali. La minaccia sembra coinvolgere in particolare un vasto
spazio di prossimità – che va dai Balcani sino al Maghreb – alta-
mente rilevante per gli interessi europei e soprattutto italiani. Que-
sta rilevanza è data non solamente dalla constatazione che il Medi-
terraneo e il Medio Oriente rappresentano per l’Italia quell’area di
primario interesse politico-strategico incluso in un raggio che dai
vicini Balcani oltrepassa la Turchia verso la sponda sud del Medi-
terraneo fino all’Atlantico, ma anche per evidenti motivazioni
economico-commerciali e di politica energetica. I fenomeni legati
all’emergere di quest’arco d’instabilità regionale, quindi, coinvol-
gono direttamente l’interesse nazionale dell’Italia in tutte le sue
sfaccettature.
Le nuove forme di terrorismo islamico, che tentano di assume-
re una forma proto-statuale, sembrano stravolgere i parametri poli-
tici del passato poiché presentano una vocazione universalista e
intransigente che esercita un innegabile fascino, soprattutto sulle
nuove generazioni. Questa nuova minaccia ha chiaramente una
duplicità che la vecchia al-Qaida non aveva: è un network terrori-
stico e continua ad avere una dimensione ideologica, ma si tra-
sforma anche in qualcosa di concreto e visibile. Proprio per la ca-
ratterizzazione territoriale e per la sua necessità “globale” e “uni-
versale”, la nuova minaccia è caratterizzata, dal punto di vista
8 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
geopolitico, da una visione militare espansiva che considera quale
suo primo nemico i vicini, siano essi i regimi o i rappresentanti
della vecchia élite politica, le minoranze cristiane o le comunità
sciite, accusate di travisare la visione “ortodossa” dell’islam.
Anche per queste ragioni, tale minaccia costituisce qualcosa di
molto diverso da quelle terroristiche del recente passato: non so-
lamente perché Roma, quale centro della cristianità, sembra rap-
presentare oggi un obiettivo simbolico dell’ondata propagandistica
di IS, ma anche perché l’emergere del fenomeno “vicino a casa”
obbliga l’Italia a un profondo ripensamento della propria politica
estera e degli strumenti necessari al mantenimento degli interessi
internazionali, a cominciare da una revisione delle relazioni con il
“vecchio” Medio Oriente. Questo sforzo sembra rendersi necessa-
rio tanto più ora che “guerra/lotta al terrorismo” ed “esportazione
della democrazia” (divenuti in breve tempo i fari della proiezione
strategica occidentale a guida statunitense nella fase post-11 set-
tembre) e le guerre scaturite da questo approccio – Afghanistan
(2001) e Iraq (2003) – non solo si sono rivelate fallimentari, ma
sembrano esse stesse concausa del nuovo revival dell’islam radi-
cale. Infatti, nonostante il dispiegamento permanente degli eserciti
occidentali, la minaccia jihadista non solamente è sopravvissuta
ma si è anche rigenerata e sviluppata nel nuovo caos post Primave-
re arabe.
Sullo sfondo di tali trasformazioni, obiettivo di questo Rappor-
to è principalmente quello di analizzare la natura di questa rinno-
vata minaccia e la sua reale portata, ripulendola degli effetti me-
diatici della propaganda, osservando le aree geopolitiche di per-
meabilità alla stessa in relazione agli attori locali e agli interessi
italiani ed europei. Oltre a quello di approfondire le implicazioni
per la nostra politica estera e di difesa e sicurezza in senso ampio,
cercando di fornire alcuni spunti di policy nell’ottica dell’azione
internazionale dell’Italia.
Il contributo di Paolo Maggiolini sull’evoluzione della minac-
cia jihadista apre il nostro Rapporto. Una ricognizione del feno-
meno e di come questo sia cambiato nel corso degli ultimi anni:
una storia caratterizzata da un costante percorso trasformativo e
Introduzione 9
adattativo. Il concetto di resilienza appare davvero opportuno per
descrivere un fenomeno che è stato in grado di portare a termine
importanti operazioni su vari livelli, ma anche di metabolizzare
frequenti sconfitte che, tuttavia, non l’hanno mai del tutto piegato
ed eliminato. Aspetto tra più problematici dal punto di vista anali-
tico risulta essere quello di sistematizzare le diverse tipologie di
sfide e minacce provenienti da questa galassia jihadista in quanto
potenzialmente in grado di avanzare in sincrono. Questo non già
per l’esistenza di una o due grandi organizzazioni di riferimento
(IS e al-Qaida), ma per la notevole diffusione e atomizzazione del
concetto di jihad: dimensione globale, regionale e locale possono
facilmente inter-scambiarsi e sincronizzarsi. Da qui nasce un ri-
schio e una sfida che impone un’ancor maggiore livello di coordi-
namento tra il piano politico, quello militare e gli apparati di sicu-
rezza e polizia nazionale.
A seguire, vi sono interventi di analisi dei singoli contesti loca-
li e regionali. Il contributo di Karim Mezran tratta di un tema di
straordinaria rilevanza per il nostro paese: la crisi libica e la pro-
gressiva penetrazione dello Stato Islamico e di altre formazioni
radicali nell’instabile e violento panorama politico e militare del
paese. La presenza dello Stato Islamico in Libia ha sollevato timo-
ri a livello internazionale per la possibile nascita in Nord Africa di
una provincia del “califfato” sorto fra Iraq e Siria. Paesi come
l’Italia devono certamente temere le conseguenze di questo poten-
ziale sviluppo, che intacca interessi politici ed economici, anche se
lo scenario sopra delineato appare un’eventualità lontana, almeno
per il momento. Lo Stato Islamico ha limitate possibilità di trovare
terreno fertile in Libia per due motivi principali: in primo luogo la
natura della battaglia appare locale e non ideologica; in secondo
luogo, i libici sono piuttosto moderati per tradizione e religiosa-
mente omogenei, storicamente riluttanti a seguire gli appelli e i
gruppi del radicalismo islamico. Tuttavia l’espansione di IS in Li-
bia appare strettamente legata a una stabilizzazione del paese che
diviene progressivamente sempre più difficile e improbabile.
Gli attentati di Tunisi, avvenuti mentre si redigeva questo Rap-
porto, sembrano ribadire la necessità che l’Italia prenda coscienza
10 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
della minaccia presente in Tunisia e nella vicina Algeria. Analiz-
zando il panorama jihadista in questi due paesi, Stefano Torelli so-
stiene che il fatto stesso che non si tratti di stati falliti o semi-
falliti, come nel caso della Libia, rende paradossalmente i movi-
menti e i singoli jihadisti presenti in quelle aree potenzialmente
più pericolosi per i teatri esterni. Non è un caso che la Tunisia for-
nisca un altissimo numero di foreign fighters, dal momento che gli
elementi radicalizzati in loco non hanno spesso la possibilità di
mettere in pratica il jihad in casa propria. Come conseguenza, vi è
la tendenza a cercare altri teatri di operazione e questo fattore,
contestualmente alla forte impronta anti-occidentale dell’ideologia
jihadista propria di IS e dei suoi gruppi affiliati, può costituire un
innesco per tentare d’infiltrare l’Occidente.
Elementi analoghi sembrano caratterizzare l’Egitto. Wolfgang
Pusztai esamina l’attuale contesto in cui operano i numerosi grup-
pi estremisti attivi nel paese, in particolare nel Sinai, regione poco
controllata dal governo del Cairo. Alcuni di questi si sono recen-
temente affiliati all’IS. L’Egitto ha rappresentato un paese chiave
nell’evidente fallimento del processo delle Primavere arabe e
nell’“istituzionalizzazione” della Fratellanza musulmana quale
gruppo politico legittimo. La sua criminalizzazione ha spinto di-
versi membri nell’ombra e li ha avvicinati ai gruppi militanti. È
probabile che alcuni di questi si siano uniti in una lotta armata
contro il governo, conducendo atti di violenza contro le forze di
sicurezza come risposta alla repressione delle proteste pubbliche.
In prospettiva futura il successo di queste formazioni in Egitto,
paese cardine per la regione e fondamentale anche per gli interessi
italiani, appare strettamente connesso al grado di legittimità demo-
cratica e inclusività politica del paese.
Un capitolo, quello di Andrea Beccaro, è interamente dedicato
all’evoluzione della situazione in “Siraq”, come può essere defini-
ta l’area di primario sviluppo di IS, alle sue dinamiche, agli even-
tuali effetti di spillover regionali, in particolare in Libano, e agli
interessi italiani ed europei. L’analisi di questo scenario rende evi-
denti le cause settarie alla base dell’ascesa del “califfato” e riman-
da alle possibili sistemazioni politiche dell’area: la spaccatura tra
Introduzione 11
sunniti e sciiti è radicata e inficia profondamente non solo le capa-
cità operative dell’esercito iracheno, che si vorrebbe nazionale, ma
anche quelle d’influenza politica di Baghdad in cui il controllo
sciita è forte e visto con sospetto dalla minoranza sunnita. La-
sciando da parte i bombardamenti aerei condotti dall’eterogenea
alleanza anti-IS, il futuro appare segnato dalle interrelazioni di
numerosi gruppi di attori, non omogenei al loro interno, che com-
battono sul terreno: dai curdi, alle milizie sciite, alle forze del re-
gime di Assad, che rendono assai nebuloso il quadro e sembrano
continuare a reiterare le condizioni di successo di IS.
L’area AfPak continua a essere un altro scenario di grande rile-
vanza per gli interessi europei e occidentali. Riccardo Redaelli lo
spiega osservando come questo rappresenti simbolicamente anche
una cartina di torna-sole dell’impegno internazionale – e italiano –
nel fronteggiare la minaccia jihadista. Tuttavia questo quadrante
sembra subire un processo di riduzione del senso di priorità, al
quale contribuisce il tentativo di disimpegno statunitense, ma an-
che la trasformazione dei Taliban in una galassia molto più artico-
lata e spesso lontana dal movimento originario, strettamente legato
al jihadismo globale, e la “derubricazione” del conflitto in Afgha-
nistan in conflitto “nazionale”, che sembra rimandare a soluzioni
più politiche che militari.
Infine, per la volontà di focalizzarsi sugli interessi italiani, il
Rapporto assegna specifico rilievo anche al quadro in evoluzione
nei Balcani, dove le difficili condizioni socio-economiche di alcu-
ne zone permettono all’ideologia jihadista, come descrive Giovan-
ni Giacalone, di far breccia nelle menti dei giovani, portando la
cosiddetta “spirale balcanica” a una nuova fase, quella
dell’esportazione di combattenti all’estero e alla costruzione di
network estremisti specializzati nella propaganda radicale e nel
reclutamento: un fenomeno che non può assolutamente essere sot-
tovalutato e che comporta seri rischi per il nostro paese.
Ad aprire la seconda parte del volume dedicata alle specifiche
conseguenze per l’Italia è Arturo Varvelli che focalizza la propria
analisi sulle implicazioni per la politica estera italiana. Il contribu-
to si sviluppa dalle premesse del nuovo sistema internazionale nel
12 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
quale l’Italia si trova a operare e, prendendo in considerazione le
cause profonde della recente ascesa di IS, cerca di proporre una
riflessione su un necessario riadattamento della sua politica: la
stabilizzazione dell’area deve essere un obiettivo prioritario
dell’azione italiana, ma questa non può basarsi in via esclusiva su
un appoggio a regimi autoritari, poco inclusivi e settari. È facile
comprendere come un nuovo e rinnovato appoggio a paesi di que-
sto tipo possa contribuire a riprodurre i medesimi meccanismi che
hanno portato alla destabilizzazione della regione pochi anni fa.
Fabrizio Coticchia delinea le implicazioni per la politica di di-
fesa e lo strumento militare. L’analisi degli interventi militari che
hanno visto le Forze armate italiane contrastare gruppi armati ter-
roristici permette di comprendere l’importanza dell’addestramento
delle forze locali e della più generale ricostruzione delle capacità
delle istituzioni dei paesi interessati. Un processo che appare com-
plicato, soprattutto in assenza di una chiara pianificazione strategi-
ca e di una convincente narrazione che giustifichi un impegno
oneroso. Ma più di tutto anche le Forze armate si sono rese conto
dell’importanza di altri strumenti per “vincere” un conflitto non
tradizionale, a partire dal fondamentale processo d’isolamento dei
gruppi terroristici, parallelo a un percorso inclusivo di condivisio-
ne del potere tra gli altri attori coinvolti e al rafforzamento delle
capacità d’intelligence.
Proprio della risposta dell’intelligence tratta il capitolo di Mar-
co Minniti, Sottosegretario di Stato e Autorità Delegata per la Si-
curezza della Repubblica. Partendo dal presupposto che l’Europa e
l’Italia debbano avere la capacità di rispondere come grandi de-
mocrazie, non limitando drasticamente le libertà fondamentali, la
risposta al terrorismo deve, al contempo, muoversi sia sul terreno
militare, sia su quello della prevenzione e dei valori. Bisogna pun-
tare a isolare e colpire la minaccia quando è ancora nel suo stato
d’incubazione, cercando cioè di anticipare la soglia di prevenzione
per diminuire il tasso d’imprevedibilità.
Nel capitolo conclusivo Lia Quartapelle traccia alcune linee
guida sulla questione degli aiuti allo sviluppo e sulla gestione del
fenomeno migratorio. L’Italia deve al più presto adeguare le sue
Introduzione 13
politiche di cooperazione internazionale alla sfida jihadista, essen-
zialmente con due tipi d’intervento: da un lato dotandosi di linee
di azione a sostegno delle istituzioni, sia come interventi di svi-
luppo, sia all’interno di una riflessione sulla cooperazione civile e
militare; dall’altro lato influenzando la costruzione di una politica
migratoria europea che attraverso azioni di reinsediamento con-
tenga i rischi e i costi dei rifugiati nei paesi con istituzioni messe a
dura prova dagli avvenimenti degli ultimi anni.
Paolo Magri,
vice-presidente esecutivo e direttore dell’Ispi
1. Da al-Qaida alle nuove formazioni: la minaccia jihadista cambia
Paolo Maggiolini
A partire dagli attacchi del settembre 2001, analisti, politici, gior-
nalisti e opinione pubblica si sono progressivamente abituati a do-
ver fare i conti con il rischio del terrorismo internazionale di ma-
trice islamica, sempre più definito attraverso il termine jihadismo
sotto le insegne di al-Qaida. Come sempre lo sguardo storico ci
ricorda che tale fenomeno aveva già imboccato la strada del suo
“destino” qualche decade prima, come ad esempio gli scritti di
Abdullah Yusuf Azzam1 avevano in parte preconizzato. Nutrita e
incubata dai molteplici teatri del “nuovo jihad” in Afghanistan,
Algeria e nell’ex-Jugoslavia la minaccia jihadista aveva assunto
contorni sempre più delineati e precisi, a dispetto di un’attenzione
di media e agenzie di sicurezza non consona alla sua portata.
A quasi quindici anni dagli attacchi sul suolo statunitense, la
galassia jihadista ha dimostrato di saper cambiare e adattarsi al
mutare delle condizioni internazionali e regionali. Una realtà resi-
liente sia dal punto di vista tattico-strategico sia da quello organiz-
zativo.
Senza snaturare o contraddire i suoi principi e orientamenti
dottrinali, il jihadismo ha prima pervaso la dimensione globale, o
si è almeno imposto su tale piano, divenendo poi sempre più una
realtà profondamente inserita nei molteplici fronti di crisi locali
che si sono aperti nel corso di questi anni, come testimoniato dalla
1 Abdullah Yusuf Azzam (1941-1989), studioso e teologo islamico di origine palesti-nese, è ritenuto tra i primi ideologi del jihad globale contemporaneo.
18 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
nascita dei vari al-Qaida nel Maghreb, nella Penisola Araba e in
Iraq2.
Naturalmente le due dimensioni, locale e globale, non si sono
sostituite, bensì sovrapposte come egualmente necessarie e possi-
bili. L’Occidente è rimasto il “nemico lontano”, da colpire in
quanto considerato occupante e aggressore del cosiddetto mondo
musulmano. Al tempo stesso, il movimento verso il territorio e
l’ancoraggio locale hanno rafforzato in molti soggetti la retorica
del “nemico vicino”, dando corpo a uno scontro senza esclusioni
di colpi nei confronti tanto della dimensione non-musulmana
quanto di quella musulmana, laddove non corrispondente ai canoni
dell’ortodossia e dell’ortoprassi jihadista e alla sua narrativa.
La recente ascesa dello Stato islamico in Iraq e Levante (Isis),
ormai conosciuto come Stato Islamico (IS) dopo l’auto-
proclamazione del califfato, getta nuova luce e solleva ulteriori
domande circa questa parabola evolutiva. Non più solamente lotta
globale, non solo insurrezione, ma ora anche pretesa statualità sot-
to l’immediata e unica responsabilità di quest’organizzazione.
Una differenza, questa, che pare notevole rispetto a passate
esperienze, come ad esempio in Afghanistan con il connubio qai-
dista.
Al tempo stesso anche il contesto internazionale e regionale è
profondamente mutato. Tra gli eventi più significativi che si sono
rincorsi in queste decadi emerge sicuramente la cosiddetta “Pri-
mavera araba” che ha messo in discussione non solo il rapporto tra
potere centrale e cittadinanza, ma la tenuta stessa di molti sistemi
statuali. Su questo percorso, inoltre, pesano le incognite di natura
geopolitica, geoeconomica e demografica. Sfide che già erano ben
chiare nella proiezione delle analisi di lungo periodo rispetto a
questi contesti.
Le pagine che seguono si propongono di analizzare brevemente
il cambiamento della natura della minaccia jihadista alla luce di
questo complesso quadro di trasformazioni. La prospettiva è quel-
la dell’Europa e dell’Italia, mentre lo snodo su cui ci si sofferma è
2 New and (Old) Patterns of Jihadism: al-Qa‘ida, the Islamic State and Beyond, a cura di A. Plebani, Milano, ISPI, settembre 2014.
Da al-Qaida alle nuove formazioni 19
il passaggio da un movimento dominato da al-Qaida a una situa-
zione più fluida e articolata come quella attuale. Un panorama che
vede la galassia jihadista frammentata tra soggetti che si distin-
guono per tattiche e strategie differenti. Tra essi spicca IS, che
cerca di accreditarsi sempre più come vera e propria alternativa al
modello qaidista.
Principali Organizzazioni e Aree di Operazione.
■ Network di al-Qaida
1 al-Qaida nella penisola araba (AQAP)/Ansar al-Shari’a (Yemen) 2 al-Shabaab (Somalia) 3 Brigate Abd Allah’Azzam (Libano) 4 Emirato Islamico del Caucaso (Russia) 5 Fronte al-Nusra (Siria) 6 al-Qaida in Magreb (AQIM) e alleati (MUJAO, al-Mourabitoun) (Algeria, Mali, Tunisia, Niger) 7 Ansar al-Shari’a (Libia) 8 Tehrik-I-Taliban/al-Qa’ida Khurasan (Pakistan, Afghanistan) 9 Katibat’Uqba Ibn Nafi (Tunisia) 10 Jemaah Islamiyah (Indonesia)
■ Stato Islamico/Gruppi e Province
(Wilayat) 11 Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIS) (Siria, Iraq) 12 Ansar Bayt al-Maqdis - Wilayat Sina' 13 Stato Islamico della Libia - Wilayat Barqa, Tarabulus (Libia) 14 Boko Haram - Wilayat al Sudan al-Gharb (Nigeria, Ciad, Camerun) 15 Jund al-Khilafa - Wilayat al-Jazair (Al-geria, Tunisia) 16 Abu Sayyaf Group - Nessun Wilayat creato (Filippine*) * giuramento di fedeltà (bay'ah) non ancora accettato
Fonti: Jihadology (Aaron Zelin), Esperti
20 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Il contesto storico
Per poter evidenziare quali possano essere i profili delle minacce
che il più recente corso dei movimenti jihadisti pone all’Europa e
all’Italia è importante riconsiderare la storia recente che ha visto la
nascita e l’affermazione di queste realtà. Una ricognizione che non
pretende di approfondire e abbracciare tutti gli eventi che si sono
rincorsi durante le ultime due decadi, ma che serve per inquadrare
e collocare brevemente le profonde e multiformi trasformazioni
che si sono succedute. È infatti lungo questo orizzonte che si sta-
glia il percorso che ci conduce alla nascita di IS e allo sviluppo
delle altre formazioni jihadiste che ora dominano la scena regiona-
le e internazionale.
Al-Qaida dà il via alle sue operazioni proprio nel cuore degli
anni Novanta fino a imporsi all’opinione pubblica con la realizza-
zione degli attacchi sul suolo statunitense. È così che
l’organizzazione guidata da Osama bin Laden assurge nei primi
anni del nuovo secolo a principale pericolo da contrastare, dive-
nendo in breve tempo la nemesi politica della superpotenza statu-
nitense. Questo gruppo è stato così considerato l’espressione pla-
stica del nuovo orizzonte di minacce che l’Occidente avrebbe do-
vuto affrontare nel secolo che si apriva davanti ai suoi occhi, orfa-
no delle logiche e delle consuetudini di una Guerra fredda ormai
archiviata da circa un decennio. Un mondo che si dischiudeva alla
globalizzazione con fiducia e speranza si è così trovato ad affron-
tare un nemico paradossalmente “a misura” di questo ideale. Al-
Qaida si è presentato come una realtà de-territorializzata, tragica-
mente calata dal cielo, concentrata sulla lotta internazionalista da
parte di un’avanguardia preparata e potenzialmente presente in
ogni luogo. Tale percezione è paradossalmente racchiusa nel suo
stesso nome. Al-Qaida (la base), quasi come se l’Occidente avesse
individuato consapevolmente o meno in questa realtà il terminale
ultimo e unico di un’idea di coordinamento e di una visione
d’insieme alla guida del fenomeno jihadista “globalizzato”. Lotta
al jihadismo ed esportazione della democrazia sono in breve tem-
po divenuti i fari della proiezione strategica occidentale a guida
statunitense. Ne sono seguite, così, la guerra in Afghanistan (otto-
Da al-Qaida alle nuove formazioni 21
bre 2001), il “covo” della minaccia qaidista, e poi quella in Iraq
(2003), i cui strascichi sono tutt’ora evidenti. A queste operazioni
hanno fatto seguito molti episodi di “risposta” da parte delle diver-
se formazioni qaidiste, come ad esempio a Madrid (2004) e Lon-
dra (2005), ma anche Bali, Istanbul e Casablanca.
Nonostante il dispiegamento permanente degli eserciti occiden-
tali in Afghanistan e in Iraq, la minaccia jihadista non è solamente
sopravvissuta ma si è anche sviluppata.
È infatti nell’arco di questi pochi anni che, mentre sempre
maggiori fronti di crisi si aprivano, al-Qaida ha iniziato a mutare,
o forse più pericolosamente ha proseguito a svilupparsi su quella
linea preconizzata, prima, da Azzam e, poi, attuata da bin Laden.
Internazionalismo, ma anche attenzione al contesto, alla pene-
trazione e al radicamento sono quindi divenute ben presto le di-
mensioni della minaccia di al-Qaida, legando la sfera del terrori-
smo globale a quella dell’insurrezione.
È così che prende forma e corpo nei primi anni Duemila sem-
pre più Tanzim al-Qaida (l’organizzazione di al-Qaida secondo il
nome utilizzato da Osama bin Laden) con le sue diverse ramifica-
zioni regionali che hanno contribuito a ridefinire l’orizzonte del
rischio sia nella prospettiva del suo cosiddetto “nemico lontano”,
l’Occidente, sia di quello “vicino”, i vecchi regimi dei paesi me-
diorientali instauratisi nel periodo della Guerra fredda.
In tutto questo, contesti come l’Iraq e lo stesso Afghanistan so-
no divenuti dopo le diverse “guerre di liberazione” veri e propri
incubatori di questa trasformazione. I fronti all’interno dei quali
sperimentare e mettere alla prova la resilienza e l’efficacia della
strategia jihadista.
Contestualmente, l’Occidente, che guardava preoccupato alla
minaccia qaidista, non ha colto che si erano messi in moto proces-
si di ancora più ampia portata e differente significato. Sulla scia di
un malessere sempre più diffuso, di scioperi soffocati, di opposi-
zioni tacitate e libertà negate stava di fatto prendendo forma una
vasta massa critica d’insoddisfazione nell’area mediorientale e in
quella nordafricana. Alla fine del 2010 le piazze iniziarono a
riempirsi. Prima in Tunisia e poi con un effetto domino in Egitto,
22 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Bahrein, Siria, Libia e Yemen, solo per citare i casi più rilevanti,
le popolazioni arabe hanno dimostrato di voler affrontare di petto
il proprio “passato”.
La “Primavera araba” (2011), come nuovamente l’Occidente
ha inteso chiamare questo momento di “risveglio” e sollevamento
popolare (intifada), ha proiettato l’intera regione lungo una nuova
direzione. È così che un mondo focalizzato su al-Qaida ha pensato
che la storia e la volontà del popolo avessero lasciato indietro que-
sta minaccia. Una sfida ormai superata e resa quasi anacronistica
dall’eliminazione delle primule rosse del jihadismo internazionale
ma, soprattutto, dalle richieste di manifestanti che invocavano li-
bertà, giustizia, perequazione sociale ed economica, tralasciando
slogan anti-americani o contrari all’Occidente.
Eventi di questa portata hanno diviso, e tuttora polarizzano, i
giudizi di analisti e commentatori. Da una parte gli entusiasti, i
molti felici di veder contraddetto l’adagio di un mondo arabo, ma
non solo, destinato all’insoddisfazione e al controllo. Dall’altra gli
scettici che hanno invece assistito con preoccupazione a questa
nuova fase di rimescolamento e imprevedibile cambiamento.
Il punto centrale, al di là delle opinioni e degli schieramenti, è
che queste dinamiche di trasformazione non hanno semplicemente
messo in discussione i vecchi regimi, sopravvissuti alla fine della
Guerra fredda attraverso successioni o percorsi di riforma interna
rivelatisi poi spesso prettamente estetici, ma hanno chiaramente
scosso le fondamenta delle costruzioni statuali e i principi del pat-
to sociale all’interno della vasta regione mediorientale. Da questo
punto di vista possono essere definiti evidentemente “rivoluziona-
ri”3, seppur rimane ancora poco chiaro quale sia l’epilogo e la di-
rezione ultima di tale percorso. Ed è proprio su questa “incertezza”
che oggi si staglia l’attuale sfida jihadista nella regione.
3 La scelta di racchiudere il termine rivoluzione tra virgolette non ha nessuna valore di opinione o espressione di diminuzione verso quegli eventi, bensì rispecchia l’idea che sia necessario in una prospettiva analitica mantenere una certa sospensione di giudizio sulla portata di eventi certamente dal grande impatto trasformativo ma che ancora devono confermare il loro valore rivoluzionario in ambito sociale, economi-co e politico.
Da al-Qaida alle nuove formazioni 23
Al tempo stesso, all’interno di questa fase di ribellione e cam-
biamento si sono riversate anche le tensioni geopolitiche che an-
davano sempre più prendendo forma nell’area. La contrapposizio-
ne tra Iran e Arabia Saudita, le tensioni tra quest’ultima e il Qatar,
il desiderio di giocare un ruolo egemone da parte della Turchia
nell’area mediorientale e mediterranea e, infine, le scomposte poli-
tiche di alcune potenze europee hanno contribuito ad aumentare la
propensione entropica delle dinamiche in atto.
Di conseguenza, sia nei paesi in cui le piazze sono riuscite a
determinare un cambio di regime (Egitto, Tunisia, Libia e Yemen)
sia laddove, a maggior ragione, ciò non è avvenuto (Siria e Bah-
rein) la complessità e la profondità delle sfide in campo non hanno
tardato a manifestarsi. La prova di tale difficoltà è stata incarnata
dalla vicenda politica delle formazioni islamiste, in particolare in
Egitto, e della loro performance alla guida dei paesi post-2011.
Tralasciando per il momento il contesto siriano, sprofondato in
una guerra civile che dura ancora oggi, l’ascesa del cosiddetto
islam politico, del modello dei Fratelli musulmani, ha contraddi-
stinto di fatto il primo passaggio alle urne nei paesi in cui le piazze
sono riuscite a determinare un cambio di regime o l’adozione di
riforme costituzionali. Confermando l’appeal di tali formazioni e
della loro organizzazione dal punto di vista della capacità di con-
vogliare e indirizzare il consenso, a fronte invece di una tendenzia-
le impreparazione degli schieramenti laici o secolari, i partiti isla-
misti hanno però in breve tempo sperimentato la difficoltà di tra-
sformare il consenso popolare in risultati politici concreti. È così
che ben presto si è manifestato uno dei problemi centrali di ogni
processo di apertura e “democratizzazione”, ovvero la difficoltà di
articolare in modo bilanciato il rapporto tra maggioranza e mino-
ranza, evitando d’interpretare l’esito delle urne come una carta
bianca per governare unilateralmente senza compromesso e me-
diazione. In breve tempo si è così diffusa la percezione di un “raf-
freddamento” della spinta al cambiamento a cui ha fatto seguito
l’immagine della “rivoluzione tradita”.
24 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
L’epilogo di questa fase è noto ed è culminato in Egitto con
l’estromissione di Morsi da parte dei militari, esemplare monito
per gli altri paesi della regione.
Da questo momento, fatta eccezione per la Tunisia, su vari
fronti la situazione politica è parsa rimescolarsi con rapidità, of-
frendo lo spazio e le condizioni per un rilancio della causa jihadi-
sta, mai sopita, all’interno del contesto mediorientale. In tale fran-
gente, il fallimento dell’islam politico ha giovato alla causa jihadi-
sta, che dopo tutto aveva sì applaudito alle iniziative popolari, ma
aveva anche duramente criticato la decisione della Fratellanza e
dei partiti di orientamento salafita di partecipare alle elezioni4.
Di fatto, durante tutti questi eventi al-Qaida ha proseguito nel
suo percorso di adattamento ed evoluzione. Dal corpo centrale (al-
Qaida core, come è stata rinominata) si erano già sviluppate e dif-
fuse diverse terminazioni locali sempre più autonome nella defini-
zione del proprio modus operandi, che hanno poi potuto ulterior-
mente introdursi negli interstizi e nelle debolezze di contesti sta-
tuali e sociali fortemente provati dalle forze sprigionate dalla co-
siddetta “Primavera araba”.
A ciò si deve aggiungere l’uccisione di Osama bin Laden
(2011) cui ha fatto seguito la successione di Ayman al-Zawahiri,
determinando così un altro passaggio importante nel modo di con-
cepire e indirizzare il fronte jihadista sotto la bandiera di al-Qaida.
E proprio durante questo periodo sembrerebbe compiersi il pas-
saggio tra il concetto di Tanzim al-Qaida e l’idea di Qaida al-
jihad (la base del jihad)5. Una transizione che rimane ancora da
verificare con certezza, ma che pare voler sottintendere l’ormai
chiara formazione di una galassia jihadista ampia, diffusa e su
molteplici livelli. Una realtà che può essere al più guidata ideolo-
gicamente sotto l’insegna condivisa della necessità del jihad, piut-
tosto che realmente controllata e influenzata nei diversi contesti in
cui opera.
4 O. Ashour, Collusion to Crackdown: Islamist-Military Relations in Egypt, Analysis Paper, Brookings, 5 marzo 2015. 5 N. Lahoud, M. al-‘Ubaydi, Jihadi Discourse in the Wake of the Arab Spring, Combating Terrorism Center, 2013, p. 12.
Da al-Qaida alle nuove formazioni 25
In uno di questi, l’Iraq, tale fenomeno ha preso un corso parti-
colarmente spedito e autonomo, alimentandosi delle specifiche
debolezze di un territorio segnato da anni di guerra. È qui che al-
Zarqawi ha aperto la strada alla lotta jihadista che oggi ha preso il
nome di Stato Islamico (IS). Ed è da qui che al-Baghdadi decide di
riversarsi nel contesto siriano in piena guerra civile, trovando così
il teatro ideale per affermare definitivamente tale progetto.
È alla luce di questa breve ricognizione storica che si manifesta
la complessità di un fenomeno jihadista non più riconducibile a
quell’unico qaidista dei primi anni Duemila e di una minaccia che
si articola solo lungo le due direttrici del terrorismo e
dell’insurrezione, ma che ambisce direttamente alla statualità, su-
perando le attuali divisioni “nazionali”. La galassia jihadista non
esprime quindi solo la molteplicità delle capacità e della possibili-
tà degli obiettivi da colpire, ma anche una distinzione nella natura
e nella ratio della sua strategia e visione.
Jihad globale e territorio
A ben vedere il fenomeno al-Qaida, dopo essersi manifestato in
tutta la sua spettacolarità con gli attacchi del 2001, proietta quasi
immediatamente la sua sfida globale nella prospettiva locale. Un
esempio di tale percorso può essere ritrovato in Arabia Saudita.
Tra il 2002 e il 2004, infatti, la sua terminazione saudita si concen-
tra sulla realizzazione di un ampio programma di destabilizzazione
nel regno, cercando di colpire infrastrutture e figure politiche e mi-
litari di rilievo. In questo momento, però, tale direzione rimane
strettamente ancorata alla prospettiva di una guerra di risposta
contro l’Occidente e i suoi alleati, ovunque questi possano essere
raggiunti grazie all’impegno di un’avanguardia ideologicamente e
militarmente pronta6.
6 B. Wilkinson, J. Barclay, The Language of Jihad. Narratives and Strategies of al-Qa‘ida in the Arabian Peninsula and UK Responses, Whitehall Report, Rusi, dicembre 2011, pp. 4-11.
26 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Resistenza contro l’“occupante” e “risveglio” della comunità
islamica (umma) sono tra i concetti chiave che danno corpo a que-
sta fase di jihad globale, senza confini e barriere. È una fase chia-
ramente conseguente al programma qaidista e, al tempo stesso,
importante per affinare e sviluppare il proprio concetto strategico e
operativo. Sulla base di successi e altrettanti fallimenti, la grand
strategy dell’organizzazione prende quindi sempre più corpo an-
che grazie all’apertura del fronte iracheno che le offre un nuovo
inaspettato teatro d’azione.
Il “primo” contatto con il territorio non è però semplice.
Da una parte, in seguito alle contromisure messe in campo dal-
le forze saudite, la frangia jihadista si riposiziona sempre più in
Yemen, che da lì a pochi anni diverrà teatro privilegiato di al-
Qaida nella Penisola Araba (Aqap) fino alla fusione (2009) delle
realtà provenienti dalla cosiddetta ard al-haramain (la terra dei
due santuari, l’Arabia Saudita). In tale contesto, il regime di Salah
e la presenza statunitense divengono gli obiettivi principali del
movimento, in attesa di un forte rilancio della propaganda in favo-
re del jihad globale che giungerà l’anno seguente proprio da que-
sto territorio.
Dall’altra, al-Zarqawi assurge a leader della causa jihadista in
Iraq, guidando la formazione di al-Qaida in Iraq. Con lui la pres-
sione sul territorio, la spinta alla polarizzazione settaria e la dispo-
nibilità a portare tale scontro anche in una prospettiva regionale, si
manifestano prepotentemente, come denotano gli attacchi ad Am-
man nel 2005.
Al-Zarqawi rimane la figura di riferimento fino alla sua ucci-
sione nel 2006, divenendo in seguito ispirazione dell’attuale IS. Lo
stesso anno, l’avvio del movimento del “risveglio” (sahwa)7 nel
paese determinò una significativa botta d’arresto del progetto Aqi
(al-Qaida in Iraq), mettendo a nudo le contraddizioni di una strate-
gia eccessivamente dura nei confronti della popolazione locale, in
7 Sahwa è stato un movimento a base tribale che ha giocato un ruolo centrale nell’operazione statunitense denominata “surge”. Grazie alla combinazione di un maggior impegno militare di Washington e del supporto delle tribù arabe dell’Iraq il livello di violenza all’interno del paese fu notevolmente ridotto.
Da al-Qaida alle nuove formazioni 27
particolare della componente tribale sunnita8. Un’importante espe-
rienza per il fronte jihadista. Una lezione da cui si è poi sviluppata
una maggior attenzione verso le alleanze locali e la realizzazione
di programmi di sostituzione allo stato nei servizi alla popolazio-
ne, che attualmente caratterizza la presenza jihadista.
Contestuale a questa fase di diffusione nella sfera mediorienta-
le, quindi non più realtà legata al solo settore afghano-pakistano,
nel 2007 il gruppo salafita per la Predicazione e il Combattimento
(Gspc) annuncia la sua entrata nella sfera qaidista proclamando la
creazione di al-Qaida nel Maghreb islamico (Aqim).
Con il senno di poi, a pochi anni dall’avvio della “Primavera
araba” i profili della minaccia jihadista contemporanea sono in
parte già ben evidenti. Al-Qaida si diffonde e penetra in diverse
regioni, idealmente occupando l’ampio arco mediorientale e medi-
terraneo che guarda all’Europa. Il territorio diviene progressiva-
mente qualcosa di più che un safe haven, un luogo protetto in cui
addestrarsi ideologicamente e militarmente, attirando nuove reclu-
te, e si consolida come fronte ulteriore e coerente della lotta jiha-
dista in cui colpire le forze dei regimi “apostati” (filo Occidentali)
e realizzare le prime forme di applicazione della sharia e quindi di
controllo sociale e politico, proseguendo nel contempo nella pro-
mozione e ispirazione di operazioni terroristiche internazionali.
Da questo punto di vista, a partire dal 2009 la crescita del peso
specifico di Aqap ha dimostrato la capacità di riuscire a veicolare
questo duplice sforzo verso il territorio9. La causa qaidista prose-
gue, quindi, sia nell’ottica della guerra per fronti, le terminazioni
locali facenti capo alla base centrale, sia attraverso la promozione
di una sorta di atomizzazione e individualizzazione del jihad arma-
8 M.M. Eisenstadt, “Tribal Engagement: Lessons Learned”, Military Review, settem-bre-ottobre 2007. 9 La lotta contro Ali Abdullah Saleh e la presenza statunitense nell’area; la sperimen-tazione di formule di controllo territoriale con Abiyan e Zinjibar; l’ispirazione di operazioni terroristiche individuali sul suolo occidentale attraverso la rivista Inspire. Non è da tralasciare tutto il dibattito rispetto all’autenticità e alla rilevanza di questo periodico, la cui ultima uscita risale a dicembre 2014. Non essendo qui il luogo per approfondire tale confronto, risulta comunque rilevante inserire tale strumento all’interno della strategia operativa di Aqap e quindi della più ampia galassia jihadista.
28 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
to globale10
. È così che a partire da quegli anni al-Qaida chiama
all’azione e alla mobilitazione non solo cellule e gruppi chiara-
mente affiliati ma anche singole persone secondo proprie capacità
e possibilità, con micro-azioni diffuse11
.
Guerra di emorragia all’Occidente – occupato nella costante at-
tività di controllo e sicurezza – come è stata descritta, e assalto
agli apparati statuali dei regimi regionali alleati per stimolare ulte-
riormente polarizzazione e conflittualità.
Contemporaneamente, si delinea in modo chiaro e strutturato
l’altra dimensione, da sempre presente ma ora sotto l’attenzione di
tutti, quella della guerra psicologica. L’utilizzo dei nuovi strumen-
ti di comunicazione e di una strategia ad hoc permette ad al-Qaida
di sistematizzare una vastità di materiale già abbondantemente
presente in rete. Come ricordato in precedenza, la diffusione del
concetto di Qaida al-jihad può ben rappresentare la sensazione di
un coordinamento su una galassia varia ed eterogenea già formata-
si, in qualche modo ormai ben ancorata a determinati territori, uni-
ta dal comune sentire del jihad armato seppur già proiettata verso
differenti orientamenti strategici. L’attuale IS nasce integralmente
da questo percorso, dalle sue contraddizioni e dalle sue intuizioni.
Aspetto importante è il fatto che quest’organizzazione non elimina
alcuni dei profili di rischio precedentemente menzionati, ma ne
aggiunge di nuovi tra cui il più evidente è quello di una pretesa
statualità che, con la sua esistenza e le sue attività, denuncia pub-
blicamente l’ostilità non solo verso i regimi “apostati”, ma contro
lo stesso assetto degli stati della regione.
Cambi di regime e sfida jihadista
L’avvio delle proteste di piazza nei diversi paesi arabi ha rappre-
sentato un momento rilevante nella parabola evolutiva del feno-
meno jihadista. Ciò evidentemente non per una connessione più o
meno diretta tra queste due realtà, cosa che non è avvenuta nean-
11 B. Wilkinson, J. Barclay, (2011), p. 20.
Da al-Qaida alle nuove formazioni 29
che nella prospettiva del fenomeno dell’islam politico, ma per la
ridefinizione del quadro politico regionale e dei paesi arabi. Que-
sto è l’ambiente in cui si muovono attualmente tali gruppi.
L’aspetto importante è che a partire dalla fine del 2010, al-Qaida e
la galassia jihadista hanno dovuto riflettere sulla loro missione e
organizzazione, riposizionandosi in relazione all’avvio di questa
fase di trasformazione.
Di fatto, se da una parte le popolazioni arabe si sono ribellate e
sollevate proprio contro quei regimi che il qaidismo ha da sempre
dichiarato “apostati”, dall’altra non hanno abbracciato il progetto
jihadista bensì al più, per quanto vicini all’ideale della necessità di
un ruolo dell’islam in politica, hanno guardato alle formazioni
ispirate alla Fratellanza musulmana e al conservatorismo salafita. I
Fratelli musulmani e alcune frange salafite hanno, infatti, accettato
di costituire partiti giuridicamente riconosciuti scegliendo le urne
come via per la realizzazione dei propri programmi. Ciò ha evi-
dentemente colto in contropiede la galassia jihadista dato che
l’idea del riscatto e quella dell’emancipazione tanto attese e pro-
spettate si sono realizzate lungo direttrici da sempre contestate e
combattute.
Allo stesso tempo, l’andamento ondivago di queste dinamiche
di ribellione12
ha ulteriormente rimescolato la situazione, offrendo
alle formazioni jihadiste inaspettati nuovi fronti d’azione in cui
proseguire, rinnovate, la loro lotta.
Ciò che appare interessante non è tanto la naturale instabilità
che la “Primavera araba” ha determinato nel promuovere la transi-
zione dai regimi autocratici a sistemi ispirati ai principi democrati-
ci e più perequativi13
, bensì è importante constatare che le aperture
12 È importante ricordare il numero di eventi che si sono verificati in questi anni, tra i cambiamenti di regime realizzati in Tunisia ed Egitto (in modo molto meno evi-dente anche in Yemen con il passaggio dei poteri da Ali Abdullah Saleh a Abd Rab-buh Mansour Hadi), il rapido precipitare della situazione egiziana con l’intervento dei militari, la promozione di riforme come via d’uscita dalle proteste in Giordania e Marocco e, infine, la fiera resistenza da parte del regime al potere come in Siria, con il conseguente scoppio di una guerra civile che ancora perdura. 13 Ricordiamo ad esempio l’uccisione di Chukri Belaid e Muhamed Brahmi (Tunisia 2013); la deposizione di Morsi (Egitto 2013); l’uccisione dell’ambasciatore statuni-
30 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
conseguite durante questi anni hanno favorito una nuova fase di
filiazione di nuovi soggetti jihadisti, alcuni dei quali più o meno
pubblicamente legati ad al-Qaida. Dato che l’analisi sistematica
dei singoli casi è sviluppata nel corso del volume, è qui importante
sottolineare brevemente alcune delle sfide legate a tale fase di evo-
luzione.
Di fatto, a partire dal 2011 si assiste alla proliferazione e repli-
cazione di gruppi radicali jihadisti che si concentrano sulla dimen-
sione della da‘wa (predicazione), piuttosto che sulla lotta armata.
Tra i più famosi ritroviamo Ansar al-Shari‘a (i partigiani della sha-
ria), in particolare in Yemen, Libia e Tunisia14
. Tralasciando il ca-
so yemenita poiché esula dall’obiettivo specifico del volume, no-
nostante sia ormai in corso una vera e propria guerra civile, queste
formazioni hanno cercato di creare dei nuovi contenitori per rein-
dirizzare la causa jihadista nel quadro post-rivoluzionario. Questi
sembrano permettere di mantenere inalterata la connessione alla
prospettiva della lotta jihadista globale, tendenzialmente evitando
il richiamo a operazioni militari all’interno dei territori di riferi-
mento in modo tale da concentrarsi in particolare sull’erogazione
di servizi alla popolazione e sulla da‘wa. Sono movimenti che
ambiscono quindi a creare sfere pubbliche alternative e separate
rispetto a quelle ufficiali, potendo contare su una chiara divisione
di compiti all’interno del gruppo15
.
Sebbene sia ancora da appurare con certezza come questa espe-
rienza evolverà nei vari contesti d’azione, Ansar al-Shari‘a pare
proseguire lungo la linea di evoluzione verso un rapporto più
proattivo da parte del fenomeno jihadista nei confronti del territo-
tense Chris Stevens (Libia 2012) e di Abdul Salam al-Musmari (Libia, 2013) e, infine, la tensione tra la Fratellanza musulmana e le formazioni laiche (attuale crisi libica). 14 D. Gartenstein-Ross, Ansar al-Sharia Tunisia’s Long Game: Dawa, Hisba, and Jihad, ICCT Research Paper, 2013 and Raising the Stakes: Ansar al-Sharia in Tunisia’s Shift to Jihad, ICCT Research Paper, 2014. A. Zelin, “Meeting Tunisia’s Ansar al-Sharia”, Foreign Policy, 2013. S.M. Torelli, F. Merone, F. Cavatorta, “Salafism in Tunisia: Chal-lenges and Opportunities for Democratization”, Middle East Policy, vol. 19, n. 4, 2012, p. 150. 15 A. Plebani, “The Unfolding Legacy of al-Qa‘ida in Iraq”, in New (and Old) Patterns of Jihadism: al-Qa‘ida, the Islamic State and Beyond, a cura di A. Plebani, Milano, ISPI, 2014.
Da al-Qaida alle nuove formazioni 31
rio e delle popolazioni locali. Inoltre, essa sembra anche rappre-
sentare una sorta di bacino da cui i diversi fronti qaidisti potrebbe-
ro attingere, come sembra aver prospettato Aqim nel richiamare la
gioventù tunisina, che guardava al jihad siriano, a rimanere nella
regione piuttosto che partire16
.
Nella sfera egiziana, la “Primavera araba” e la conseguente fa-
se d’instabilità che è culminata con l’intervento dell’esercito, ha in
qualche modo favorito la proliferazione di differenti sigle jihadiste
sia nella penisola del Sinai, con legami alla dimensione di Gaza,
sia nel cuore del territorio egiziano. In questo contesto la situazio-
ne pare essere molto più confusa rispetto al contesto tunisino. Da
una parte sono rintracciabili organizzazioni che evitano di riferirsi
direttamente ad al-Qaida, pur rinnovando il loro supporto alla cau-
sa jihadista globale. Al tempo stesso esse non praticano la lotta
armata, dimostrando l’intenzione piuttosto di radicarsi sul territo-
rio e tra la popolazione sulla base chiara del rifiuto di ogni com-
promesso con il potere e le leggi dello stato.
Dall’altra, una realtà come Ansar Bait al-Maqdis ha realizzato
diverse operazioni militari nel Sinai, rispecchiando formule classi-
che della lotta jihadista, nonostante oscilli tutt’ora tra una compo-
nente che si schiera con il sedicente Stato Islamico e una che se
n’è discostata riferendosi ancora ad al-Qaida.
La presenza di tali gruppi nel contesto egiziano non rappresen-
ta solamente una minaccia di per sé, ma si collega alle molteplici
sfide che il paese deve attualmente affrontare. Esiste, infatti, il
problema del controllo dei confini e dei territori periferici sia in
direzione della Libia sia del Sinai dove diverse tipologie di attività
parallele e illegali possono liberamente proliferare. In questi con-
testi non si pone solo un problema di sicurezza, ma anche di ritor-
no dello stato e dei suoi servizi alla popolazione. Inoltre, però, ri-
mane la questione del rapporto con i Fratelli musulmani che ri-
mangono una forza ben radicata nel paese, nonostante le misure di
contenimento adottate dal nuovo corso politico di al-Sisi. Infine, in
un quadro più generale restano aperte questioni di fondamentale
importanza come quella della gestione delle acque del Nilo in rap-
16 N. Lahoud, M. al-‘Ubaydi, (2013).
32 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
porto ai progetti di sbarramento annunciati dall’Etiopia e da altri
paesi rivieraschi a monte di questo bacino fluviale. Di fatto, questi
sono punti di debolezza che potrebbero colpire gli strati più deboli
della popolazione egiziana, un mondo che alcune delle attuali
formazioni jihadiste hanno già individuato come obiettivo della
loro missione.
Di fronte a tale situazione, nuovamente il dato rilevante risulta
essere il rapporto tra questi gruppi, il territorio e le popolazioni lo-
cali. In questo senso non si registra solamente uno scarto nella
propensione e attenzione, ma una vera e propria riconfigurazione
dell’obiettivo immediato.
Dato il perdurante stato d’instabilità di contesti di primaria im-
portanza nella prospettiva europea, non solo per la prossimità geo-
grafica, è evidente che tali realtà possono rappresentare una sorta
d’ipoteca pendente pronta a riscuotere i frutti di politiche poco bi-
lanciate e lungimiranti. La conquista dei “cuori” o delle “pance” in
competizione con una struttura statale non in grado di assistere la
propria popolazione può infatti rappresentare una sfida molto più
grande di quella militare.
Inoltre, il collegamento con la dimensione qaidista non deve
essere sottovalutato, così come sarebbe erroneo pensare che la
maggior attenzione nei confronti della da‘wa manifesti
un’irreversibile rinuncia alla lotta armata, scelta che per ora appare
tattica piuttosto che strategica o frutto di una riconfigurazione
ideologica ancora ben lungi dall’essere compiuta. A ciò si deve
aggiungere l’esistenza di nuovi soggetti già impegnati sul fronte
militare che, nonostante si concentrino sulla dimensione eminen-
temente locale, si rifanno internazionalmente a realtà quali al-
Qaida e IS17
.
Questo movimento aggiuntivo nel territorio segna quindi un ul-
teriore avanzamento di una propensione che abbiamo visto essere
già in atto da tempo. Se da queste realtà non è prevedibile una
proiezione militare internazionale, la loro capacità operativa locale
17 A.Y. Zelin, The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement, Research Notes, The Washington Institute For Near East Policy, H.20, giugno 2014.
Da al-Qaida alle nuove formazioni 33
può rappresentare una minaccia chiara per l’Europa e per i suoi
interessi economici ed energetici nella regione.
Fallimenti politici e un “nuovo” paradigma jihadista: lo state making
La “Primavera araba” o meglio le dinamiche politiche che si sono
susseguite a partire dal 2010 non hanno avanzato solo la proble-
matica del cambio dei regimi e del temporaneo indebolimento dei
sistemi statuali di fronte alla fase di transizione. Per varie e spesso
differenti ragioni, in contesti come Iraq, Siria e Libia si è assistito
a un vero e proprio fallimento delle proposte politiche, delle stra-
tegie e delle risposte avanzate per affrontare le sfide del momento.
Ciò è il risultato di un numero elevato di variabili che si sono
combinate nel peggior modo possibile e che attengono
all’influenza esterna giocata dai principali attori regionali,
all’atteggiamento delle classi politiche al potere18
e infine
all’incerta posizione tenuta dall’Occidente.
La nascita e affermazione di IS tra Raqqa (Siria) e Mosul (Iraq)
ne è la più evidente manifestazione, così come l’attuale situazione
di profondo disordine interno al contesto libico. Per la nostra ana-
lisi però le dinamiche più rilevanti riguardano il contesto del Vi-
cino Oriente, e che solo recentemente sembrano cercare una loro
via nell’area nordafricana, nutrendosi delle debolezze e delle con-
traddizioni di un paese che non ha ancora trovato una via credibile
al post-Gheddafi.
Nel 2010 in concomitanza con il ritiro delle truppe statunitensi
in Iraq la situazione poteva essere giudicata con speranza. Ormai
orfana da anni del suo leader al-Zarqawi, Aqi era in arretramento,
obbligata a ripiegare e ritirarsi nelle aree di Ninive grazie agli
sforzi militari statunitensi, ma ancor più in conseguenza al succes-
18 Ricordiamo, ad esempio, in Siria con Bashar al-Assad e la decisione di rispondere alle manifestazioni con la violenza, sprofondando il paese nella guerra civile e in Iraq con Nuri al-Maliki e la sua deriva settaria.
34 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
so della sahwa a guida tribale sunnita19
. Nello spazio di pochi mesi
si era acceso però il settore siriano. Le piazze di Deraa si sono
riempite così come quelle degli altri centri urbani del paese. La ri-
sposta del regime è ben nota. Come in una riproposizione delle lo-
giche e degli schemi di Hama del 1982, pur senza riuscire a rista-
bilire l’ordine, l’apparato di sicurezza si è mosso con decisione.
Nel rapido susseguirsi di pochi mesi il paese si è così trovato dra-
sticamente diviso e polarizzato fino a cadere nell’attuale guerra
civile volutamente settarizzata. Inoltre, nel breve volgere di questi
eventi, dall’Iraq vennero inviate forze fresche per combattere il
regime di al-Assad. Fu l’intuizione di Abu Bakr al-Baghdadi, già
leader dello Stato Islamico dell’Iraq, che permise di ripensare e
riproporre lo schema dello scontro settario applicato in precedenza
nel contesto iracheno, prospettando l’unione del fronte iracheno e
di quello siriano che si andava delineando. L’Iraq, nel frattempo,
si è mosso inesorabilmente lungo un piano inclinato che lo ha
condotto a una nuova fase di scontro interno anche a causa della
deriva settaria adottata dal premier Nuri al-Maliki. Nel paese si è
diffuso così un nuovo clima di polarizzazione tra la dimensione
sciita e quella sunnita, che ha permesso il contestuale rilancio della
causa jihadista20
.
Da qui si dipana il percorso che ci conduce fino all’auto-
proclamazione del califfato nell’estate del 2014, che ha segnato
non solo una recrudescenza del fenomeno jihadista, ma anche
l’affermazione di due nuovi orientamenti: Jabhat al-Nusra (JN; Si-
ria) e l’auto-proclamato “Stato Islamico” (IS; Siria-Iraq).
In questo senso, stati falliti e fallimenti politici non hanno sem-
plicemente riproposto la questione dell’implosione di singoli si-
stemi socio-politici ma, data la molteplicità di fronti d’instabilità,
hanno generato una nuova sfida. Dalla gestione di spillover si è
ora passati a sfide transnazionali con organizzazioni posizionate in
più contesti contigui tra loro. Ciò naturalmente complica il piano
19 B. Fishman, “After Zarqawi: the Dilemmas and Future of Al Qaeda in Iraq”, The Washington Quarterly, vol. 29, n. 4, autunno 2006. 20 P. Halaka, Iraq’s deadly spiral toward a civil war, European Parliament, Directorate General for External Policies – Policy Department, Policy Briefing, ottobre 2013.
Da al-Qaida alle nuove formazioni 35
del confronto. Da una parte c’è un’unica fonte da contrastare ben
localizzata. Dall’altra questa minaccia si alimenta di problemati-
che differenti richiedendo quindi soluzioni ad hoc altamente cali-
brate sul contesto. Queste, inoltre, sono rese sempre più necessarie
proprio per la presenza di organizzazioni che pongono la sfida
nell’ordine militare, sociale ed economico, sia nella dimensione
locale sia in quella globale.
Tra il 2011 e il 2013 JN ha conquistato la scena siriana, dimo-
strando significative capacità operative e una marcata sensibilità al
contesto locale e alle esigenze della guerra civile in corso. Lo ha
fatto collaborando con le altre forze ribelli, concentrandosi
sull’arruolamento in loco, beneficiando inoltre dei primi arrivi
dall’estero e ritagliandosi spazi in cui riprodurre un sistema di
controllo alternativo a quello del regime di al-Assad, con
l’erogazione di servizi alla popolazione e l’amministrazione della
giustizia. È così che JN è emerso come attore di spicco nel fronte
delle opposizioni, articolando già un modello alternativo rispetto
alle precedenti esperienze jihadiste.
In qualche modo JN ha dimostrato di non essere più semplice
“insurrezione”. In questo ha pesato sicuramente la dinamica di una
guerra civile in piena regola che ha consentito ampi margini di
manovra.
A partire dalla primavera del 2013, però, qualcosa ha iniziato a
muoversi. Le forze di al-Baghdadi, rinominate Isis, hanno recla-
mato sempre più la guida del fronte siro-iracheno, richiedendo
formalmente un atto di riconoscimento della sua leadership su un
fronte che doveva essere sempre di più quello dei due stati. Ciò ha
evidenziato il suo chiaro rifiuto a ogni tipo di divisione territoriale
che assecondasse gli antichi progetti coloniali occidentali, mentre
al-Zawahiri invitava JN a concentrarsi sul contesto siriano e Isis su
quello iracheno21
. La scissione si è compiuta di lì a poco, non sen-
za mostrare una certa dose d’ironia di fronte alle esitazioni della
guida di al-Qaida centrale, che non è riuscito a ricomporre il fron-
te, limitandosi paradossalmente a proporre una ripartizione fun-
21 W. McCants, “How Zawahiri Lost al Qaeda. Global Jihad Turns on Itself”, Foreign Affairs, 19 novembre 2013.
36 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
zionale tra i due gruppi proprio in ragione di quelle divisioni di
campo contro cui il fenomeno jihadista combatte da sempre.
In seguito, mentre nell’aprile JN abbandonava Raqqa, il mese
successivo Isis consolidava la sua presenza nella città, eleggendola
a cuore politico di un progetto che guardava già a qualcosa di dif-
ferente rispetto al solo controllo del territorio e della popolazione,
come ha dimostrato la successiva divulgazione di un bayan al-
hudud (dichiarazione con cui stabiliva le leggi vigenti nella città),
replicato poi con la presa di Mosul del 201422
.
Da questi eventi, l’ascesa di Isis è stata costante sia nel conte-
sto siriano sia in quello iracheno. Sottomettendo altri gruppi mili-
tanti, conquistando importanti dotazioni militari sul campo, con-
trollando risorse e canali di finanziamento sempre più significativi,
rinsaldando legami con le autorità tribali, integrando al suo interno
ex-ufficiali baathisti iracheni e spingendo con decisione su una
campagna di reclutamento all’estero dei cosiddetti foreign
fighters, Isis ha costruito efficacemente la sua forza e si è proietta-
to sul territorio. L’estate del 2014 ha rappresentato il coronamento
di questa fase conclusasi con la conquista della seconda città ira-
chena per peso demografico, Mosul, l’auto-proclamazione del ca-
liffato e l’assunzione definitiva dell’appellativo di Stato Islamico.
L’idea del fronte tramonta, la battaglia è così rilanciata in tutta
un’altra dimensione che è globale, regionale e naturalmente locale
secondo il modello della statualità e non più quello qaidista
dell’organizzazione. Mai prima d’allora una formazione jihadista
aveva pensato a tanto. La linea di frattura con al-Qaida si manife-
sta definitivamente e in qualche modo una storia nella storia del
jihadismo globale prende corpo.
In questo senso, JN rappresenta un’esperienza di grande inte-
resse che sembra sviluppare al massimo la dimensione della pene-
trazione e dell’identificazione con le istanze del territorio e anche
con la disponibilità alla cooperazione nel quadro di un fronte più
22 H.H. al-Qarawee, “Il modus operandi di Isis: il messaggio politico, la propaganda e l’indottrinamento”, in Twitter e Jihad: la comunicazione dell’Isis, a cura di M. Maggioni e P. Magri, Milano, Edizioni Epoké - ISPI, p. 167.
Da al-Qaida alle nuove formazioni 37
ampio23
. IS, invece, ha ribaltato completamente tale visione, rifiu-
tando non solo le limitazioni specifiche del territorio e della que-
stione locale, ma attaccando qualsiasi soggetto che si fosse rifiuta-
to di piegarsi e soggiacere alla sua causa. Lo ha fatto sulla base
dell’esercizio di un’autorità effettiva sia sotto il profilo statuale sia
sotto quello teologico. Nel compiere tale operazione le logiche
dello scontro e la pretesa di avanzare un programma di state-
building autonomo corrono di pari passo. Il califfato è proclamato
e con ciò IS ha affermato la sua pretesa superiorità politica e teo-
logica su tutto il fronte jihadista e la comunità islamica senza limi-
ti o barriere24
. La lotta al nemico, sia esso vicino o lontano, interno
oppure esterno, diviene quindi parte di qualcosa che va oltre, al-
meno nella propaganda, la strategia e la tattica. L’idea è quella
della creazione di un sistema sociale e politico nuovo, in sostitu-
zione totale rispetto a tutto quello che lo precede. Di qui la distru-
zione esibita della storia di questi territori, il violento massacro di
comunità non-musulmane o considerate eterodosse e, infine, la
chiamata alla hijra (emigrazione) verso il califfato non solo per
possibili nuovi militanti, ma per qualsiasi professionista capace di
contribuire alla macchina statale e amministrativa di IS25
. È evi-
dente che propaganda e autocelebrazione amplificano tale narra-
zione, che l’analisi sul campo deve ancora valutare nella sua com-
pleta veridicità. L’uso spinto della comunicazione e dei media in
effetti sta moltiplicando il prestigio di quest’organizzazione26
.
Al tempo stesso, è necessario comprendere gli elementi di “no-
vità” che IS sta cercando d’imprimere nella storia del jihadismo27
.
Un cambiamento che si somma alle linee di minaccia e sfida che
23 J. Caffarella, “Jabhat al-Nusra in Syria: an Islamic Emirate for al-Qaeda”, Middle East Security Report, Institute for the Study of War, n. 25, dicembre 2014, p. 14. 24 P. Maggiolini, A. Plebani, “La centralità del nemico nel califfato di al-Baghdadi”, in Twitter e Jihad: la comunicazione dell’Isis, a cura di M. Maggioni, P. Magri, Milano, ISPI, 2015, pp. 29-51. 25 “A Call to Hijra”, Dabiq, al-Hayat Media Center, n. 3, 2014, p. 32. 26 B. Wilkinson, J. Barclay, (2011). 27 E. Brooking, “The ISIS Propaganda Machine Is Horrifying and Effective. How Does It Work?”, Defense in Depth, 21 agosto 2014, http://blogs.cfr.org/davidson/2014/08/21/the-isis-propaganda-machine-is-horrifying-and-effective-how-does-it-work/.
38 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
permangono lungo direzioni più tradizionali e conosciute. Non è
in atto una sostituzione, ma un’ulteriore moltiplicazione e diffu-
sione all’interno della sfera dello state making, pur nell’ottica
dell’immutata causa jihadista globale. Inoltre, se la questione dei
foreign fighters è ormai ben nota, permane il problema di come
gestirli e valutare la possibilità che un loro rientro consenta una
diffusione della minaccia di IS secondo i canoni già “esplorati” da
al-Qaida. Parallelamente, rimane pressante la necessità di verifica-
re come IS stia cercando di tenere fede al suo proclama «rimarre-
mo e ci espanderemo». Se da una parte si osserva un tendenziale
rallentamento della spinta militare di IS nel contesto siro-iracheno,
ciò non rappresenta ancora una notizia del tutto rassicurante. La
questione del radicamento e la possibilità d’integrare con successo
la popolazione, o almeno una parte di essa, rimane infatti la mi-
naccia più significativa. Questo aumenta la responsabilità delle
scelte politiche che verranno adottate per dar soluzione alle crisi in
Iraq, ancora scosso dalla polarizzazione settaria, e in Siria, dove
rimane la questione di come rapportarsi con il regime di al-Assad.
La sfida di IS complica la situazione non solo sul piano milita-
re, ma soprattutto su quello politico. Al tempo stesso, l’opa lancia-
ta da IS sul fronte jihadista sembra prendere sempre più corpo e
sulla scia dei suoi successi differenti formazioni stanno ricono-
scendo la sua autorità. È il prosieguo di quella competizione in se-
no a questo mondo che vede contrapposti al-Qaida e IS. Se da un
Da al-Qaida alle nuove formazioni 39
punto di vista generale, come abbiamo visto la galassia jihadista è
già cambiata e in qualche modo rispecchia da tempo alcuni dei
tratti evidenziati in questa sezione, il pericolo che dai proclami si
possa passare credibilmente alla realizzazione in diversi contesti
del progetto di IS è una minaccia da studiare e considerare con at-
tenzione. Per ora ciò che sembra essersi realizzato è l’adozione
della retorica di questo gruppo che prevede non tanto
l’associazione della “q” al nominativo specifico di un gruppo terri-
toriale (Aqap, Aqim, la stessa Aqi), secondo l’idea qaidista, ma
quella di wilaya (provincia), a sottintendere l’espansione dello Sta-
to Islamico.
Il caso libico è in questo senso interessante in quanto pare of-
frire tutte le condizioni d’instabilità e polarizzazione interna. Sep-
pur profondamente differenti da quelle del Vicino Oriente, esso
sembra offrire il teatro ideale su cui testare l’adattabilità di questo
progetto. Rimane quindi da valutare se IS sarà in grado di apporta-
re modifiche strategiche e tattiche nella costruzione degli equilibri
interni di divisione delle risorse e delle rendite a misura delle “esi-
genze” libiche, rimanendo ovviamente nel quadro di una retorica
ideologica incarnata dall’adesione al califfato. Anche nella situa-
zione in cui ciò non si realizzasse immediatamente, è chiaro che in
una congiuntura che vede gli stati centrali fortemente indeboliti, la
proposta di IS può essere particolarmente critica. Un pericolo che
nasce dalla scelta di puntare sulla sostituzione e riscossa di quelle
realtà escluse e ai margini con la promessa che ciò possa realizzar-
si ora e immediatamente.
Conclusioni
Questa breve ricognizione nella sfera del fenomeno jihadista e di
come esso sia cambiato nel corso di questi anni ha cercato di evi-
denziare il costante percorso trasformativo e quasi adattativo che
ne ha caratterizzato la storia quasi fin dalla sua imposizione
all’attenzione generale. Il concetto di resilienza ha davvero ragio-
ne nel cogliere un tratto di un mondo in grado di portare a termine
importanti operazioni su vari livelli, ma anche di metabolizzare
40 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
più frequenti sconfitte che ciononostante non l’hanno mai del tutto
piegato ed eliminato dalla storia. Una minaccia che sta ormai sem-
pre più riposizionandosi dal settore afghano-pakistano nella vasta
regione del Mediterraneo allargato, cercando di radicarsi in territo-
ri d’indubbia importanza simbolica e dalla chiara rilevanza geopo-
litica, geoeconomica ed energetica.
Attualmente, l’aspetto più problematico dal punto di vista ana-
litico è riuscire a sistematizzare le diverse tipologie di sfide e mi-
nacce provenienti da questa galassia jihadista in quanto poten-
zialmente in grado di avanzare in sincrono. Questo non già per
l’esistenza di una o due grandi organizzazioni di riferimento, ma
per la notevole diffusione, atomizzazione e individualizzazione del
concetto di jihad dove dimensione globale, regionale e locale pos-
sono facilmente inter-scambiarsi e sincronizzarsi. Il risultato è che
attualmente la galassia jihadista non descrive più solamente
un’ampia pluralità di attori, ma anche una vasta area di specializ-
zazione della minaccia che può essere portata avanti da soggetti
più o meno capaci di muoversi su più piani, ma che comunque si
riferiscono allo stesso immaginario. Da qui nasce un rischio e una
sfida che impone un ancor maggiore livello di coordinamento tra il
piano politico, quello militare e degli apparati di sicurezza e poli-
zia nazionale.
In tutto questo, comunicazione e guerra psicologica divengono
sempre più strumenti fondamentali per alimentare e ispirare
quest’ampia e diffusa sfera ideologica, senza la necessità
d’investire eccessivamente su una reale struttura di coordinamen-
to. Naturalmente, il quadro non va esagerato cadendo nella trappo-
la delle percezioni e delle soggezioni. Il nodo centrale, come visto
in queste pagine, non è solo legato a una capacità autonoma di
leggere le situazioni politiche e geopolitiche da parte del fenome-
no jihadista, ma è più frequentemente connesso a come attori sta-
tuali regionali e internazionali proiettano le loro politiche.
L’instabilità e i fallimenti registrati negli ultimi anni sono infatti
conseguenza di tale dimensione, piuttosto che della presenza di
cellule od organizzazioni jihadiste. La nuova natura che queste pe-
rò paiono assumere suggerisce che la risposta dovrà essere calibra-
Da al-Qaida alle nuove formazioni 41
ta su un arco temporale medio lungo, passando ancor più attraver-
so la popolazione, il territorio e la dimensione del patto sociale ed
economico tra questi e il potere centrale.
Per l’Italia ovviamente si presenta la necessità di leggere atten-
tamente il posizionamento e la direzione che la minaccia jihadista
sta assumendo nei contesti regionali in cui è presente con propri
contingenti o attività economiche ed energetiche, come il Rappor-
to analizza sistematicamente. Al tempo stesso, permangono i ri-
schi a livello globale o internazionale con la combinazione del fe-
nomeno dei cosiddetti “lupi solitari” e dei foreign fighters da cui il
nostro paese non può dirsi immune. In questo senso, l’Italia deve
proseguire lungo la via della ridefinizione dei propri strumenti le-
gislativi e di sicurezza, come ha recentemente fatto, preparandosi a
gestire la questione dei “rientrati”28
. Ciò anche in ragione del fatto
che IS non si focalizza più solamente sulla dimensione
dell’avanguardia, preparata dottrinalmente e militarmente, ma ha
esteso la sua chiamata all’intera comunità islamica e in particolare
alle giovani generazioni. Tutto ciò sarebbe necessario poterlo di-
scutere nella dimensione europea. In particolare, l’UE dovrebbe
fortemente rivedere le proprie politiche per il Mediterraneo, non
già nella prospettiva del fenomeno jihadista che evidentemente
non attiene direttamente a questa sfera, ma in quella delle sfide po-
litiche e di tenuta del sistema statuale che l’attuale arco di crisi sta
manifestando con chiarezza. Nel compiere tale operazione, l’Italia
dovrebbe stimolare a livello europeo una seria valutazione
dell’efficacia dei propri programmi in relazione ad altre potenze
regionali che stanno realizzando analoghe iniziative con disponibi-
lità economiche assai maggiori. Questo elemento è vitale proprio
in ragione delle conseguenze che la competizione tra potenze a li-
vello regionale ha prodotto. Al tempo stesso ciò è necessario per
evitare di vedere annullati nei fatti gli obiettivi che ci si propone,
con effetti distorsivi non previsti che vadano ad alimentare i mol-
teplici livelli possibili su cui l’attuale fenomeno jihadista sembra
concentrarsi.
28 Aa. Vv., L’Italia e il terrorismo in casa: che fare?, a cura di L. Vidino, Milano, ISPI, 2014.
2. Libia: la sfida dello Stato Islamico
Laurentina Cizza, Karim Mezran
La presenza dello Stato Islamico (IS) in Libia ha sollevato timori a
livello internazionale per la possibile nascita in Nord Africa di una
provincia del “califfato” sullo stile di quello sorto fra Iraq e Siria. I
paesi confinanti, come l’Italia, dovrebbero temere le conseguenze
di questo potenziale sviluppo, che intacca i loro interessi politici
ed economici nello stato nordafricano e l’interesse dell’Italia a vi-
vere in una regione stabile. Tuttavia l’istituzione di un “califfato”
in Libia è un’eventualità remota, almeno per il momento. Lo Stato
Islamico ha scarse possibilità di trovare terreno fertile in Libia per
due motivi principali: in primo luogo la natura dello scontro in Li-
bia è locale e non ideologica; in secondo luogo, i libici sono mode-
rati per tradizione e religiosamente omogenei, storicamente rilut-
tanti a seguire gli appelli e i gruppi del radicalismo islamico.
Nel contestualizzare la guerra civile libica, gli analisti hanno
convenzionalmente e inaccuratamente diviso i governi rivali lungo
la linea del confronto tra l’islamismo (Tripoli) e l’anti-islamismo
(Tobruk). Ma al cuore della battaglia libica vi è la protezione degli
interessi locali, tribali e regionali, e non solo un disaccordo sul
ruolo dell’islam in politica. Fin dal 2011 la società libica si è divi-
sa lungo linee sociali, militari, tribali e religiose, rafforzando la
tendenza della popolazione a identificarsi con la città e la tribù. Le
città hanno iniziato a essere amministrate come fossero “città sta-
to” e hanno scelto di sostenere dal punto di vista militare e politico
uno o l’altro dei due schieramenti contrapposti – in una rete di al-
leanze non contigua dal punto di vista geografico. I sostenitori
pro-Tobruk includono ufficiali del vecchio regime, tribù dell’est
del paese, federalisti e milizie della città occidentale di Zintan e
44 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
condividono tutti il timore della presa di potere degli islamisti. Il
blocco cosiddetto “islamista” include invece la Misurata led al-
liance (Mla), milizie di varie città della costa occidentale, islamisti
moderati e jihadisti armati: forze che condividono l’intenzione di
escludere dal governo figure compromesse con il vecchio regime.
Fin dal lancio nel maggio 2014 dell’iniziativa anti-islamista nota
con il nome di Operazione Dignità, i combattimenti si sono con-
centrati su aeroporti, porti e giacimenti d’idrocarburi, danneggian-
do pesantemente le infrastrutture più importanti del paese.
A differenza che in Siria e in Iraq, lo Stato Islamico in Libia
non può sfruttare le divisioni settarie, poiché il paese è al 90 per
cento musulmano sunnita. Nonostante la notevole crescita urbana
e la colonizzazione da parte degli italiani, la società libica ha stori-
camente preservato la sua natura tribale, tradizionale e moderata.
L’incapacità dell’islamismo di mettere radici nel paese come mo-
vimento di massa è un’attestazione di questa tendenza storica.
L’insurrezione ventennale di Omar al-Mukhtar contro gli italiani
ha dimostrato che l’islam è stato un potente strumento di resisten-
za nella storia della Libia, ma anche che, come si è visto dal falli-
mento degli islamisti nel conquistare un sostegno generalizzato
durante e dopo il regime di Gheddafi, l’islamismo come ideologia
politica non ha mai goduto di un supporto di massa.
Con la sua ideologia islamista e transnazionale lo Stato Islami-
co è un attore esterno, uno spoiler, la cui ambizione all’egemonia
del califfato è incompatibile con gli obiettivi e gli interessi delle
fazioni libiche in lotta. Come provato dalla defezione degli islami-
sti radicali a Derna, lo Stato Islamico potrebbe riuscire ad attrarre
gli elementi più radicalizzati della coalizione Alba Libica. Ma per
espandersi lo Stato Islamico avrà bisogno di ottenere il controllo
degli idrocarburi e delle infrastrutture strategiche del paese – an-
dando a intaccare gli interessi delle milizie libiche, che a quel pun-
to combatteranno tra di loro e contro l’intruso. Per l’Italia questo
significherebbe un accesso ridotto alle risorse energetiche e un
aumento nel flusso di migranti. Come suggerisce lo stesso slogan
Libia: la sfida dello Stato Islamico 45
del gruppo, baqiyya wa tatamattad1, l’obiettivo è prima quello di
stabilizzarsi e poi quello di espandersi. Lo Stato Islamico sarà più
impegnato a rafforzare le sue conquiste in Libia che a mandare mi-
litanti a Roma.
Gli islamisti durante il regime di Gheddafi
Quando era al potere, Gheddafi ha affrontato l’opposizione di tre
diversi gruppi islamisti: i Fratelli musulmani, i jihadisti del Grup-
po dei Combattenti Islamici Libici (Lifg) e il movimento decentra-
lizzato dei salafiti. La draconiana repressione contro i dissidenti –
sia reale che percepita – esercitata dal regime, ha reso difficile per
il movimento islamista guadagnare il sostegno popolare. Inoltre, i
libici, tradizionalisti e moderati, non hanno mai percepito il mes-
saggio di islamisti e jihadisti come particolarmente nuovo, soprat-
tutto considerando che Gheddafi aveva assimilato alcuni aspetti
della sharia nella sua ideologia. Perfino nella Libia orientale dove
Lifg ha la sua base operativa, gran parte della popolazione non si è
arruolata nelle sue fila e non ha sfidato Gheddafi. Al contrario, gli
islamisti e i jihadisti stessi hanno iniziato a negoziare con il regi-
me.
La Fratellanza musulmana è approdata per la prima volta in Li-
bia nel 1949, quando il principe Idris al-Senussi accolse alcuni
membri egiziani del gruppo in fuga dalle persecuzioni di Nasser al
Cairo. In Libia la Fratellanza musulmana è riuscita a radunare il
supporto delle giovani élite, ma ha fallito nel costruire un ampio
sostegno di base presso la popolazione libica più tradizionale e tri-
bale, rimasta sospettosa di ogni ideologia importata dall’estero.
Nella Libia conservatrice del re Idris la Fratellanza musulmana
non poteva mostrare per contrasto un’immagine pia e devota, co-
me quella che l’aveva rafforzata agli occhi delle masse impoverite
dell’Egitto secolarizzato di Nasser. Quando nel 1974 Gheddafi
bandì la Fratellanza musulmana dalla Libia, il gruppo era ancora
1 A.Y. Zelin, “The Islamic State’s Model”, The Washington Post, 28 gennaio 2015, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-islamic-states-model.
46 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
in fase embrionale. Il movimento della Fratellanza fiorì fuori dal
paese, tra gli emigrati libici per i quali era diventato accessibile
pagare per poter studiare negli Stati Uniti o in Europa dopo il
boom del prezzo del petrolio negli anni Settanta2.
La repressione brutale e prolungata inflitta ai Fratelli musul-
mani impedì al gruppo di sviluppare una base di supporto che si
estendesse al di là dell’intellighenzia. L’effetto asfissiante della
Jamahiriya sulla società civile impedì alla Fratellanza della Libia
di svolgere quel ruolo sociale che le avrebbe invece permesso di
resistere alla repressione3. Solo nei primi anni Duemila i Fratelli
musulmani libici iniziarono a dialogare con il regime tramite il fi-
glio di Gheddafi, Saif al-Islam, che era disponibile a tollerare la
loro presenza in cambio del silenzio e della rinuncia alla resistenza
armata4. Allo scoppiare della rivoluzione nel 2011 i Fratelli mu-
sulmani avevano già sviluppato un rapporto di collaborazione con
il regime di Gheddafi. I membri più anziani della Fratellanza erano
ritornati a vivere in Libia e molti di loro lavoravano con la Ghed-
dafi Charitable Foundation di Saif al-Islam, contribuendo ai nego-
ziati con Lifg5.
Nonostante le veementi critiche, inizialmente rivolte contro i
gruppi jihadisti che erano stati riabilitati dal regime, anche il
Gruppo dei combattenti islamici libici alla fine concluse un accor-
do simile con i Gheddafi. Lifg era stato creato nel 1989 dai muja-
heddin libici di ritorno dall’Afghanistan, con l’obiettivo dichiarato
di far cadere Gheddafi. La base di Lifg in Cirenaica era riuscita a
rimanere nascosta alle forze governative fino al 1995. La scoperta
casuale di una cellula del gruppo a Bengasi portò alla dichiarazio-
2 A. Pargeter, “Qadhafi and Political Islam in Libya”, in Libya since 1969: Qadhafi’s Revolution Revisited, a cura di D. Vandewalle, Basingstoke, England, Palgrave Macmil-lan, 2011, pp. 85-86. 3 Ibidem, p. 90. 4 O. Ashour, Libya’s Islamists Unpacked: Rise, Transformation, and Future, Policy Brief, Brookings Doha Center, maggio 2012, http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2012/5/02%20libya%20ashour/omar%20ashour%20policy%20briefing%20english.pdf. 5 N. Benotman, J. Pack, J. Brandon, “Islamists”, in The 2011 Libyan Uprisings and the Struggle for the Post-Qadhafi Future, a cura di J. Pack, New York, Palgrave Macmillan, 2013.
Libia: la sfida dello Stato Islamico 47
ne dello stato di emergenza in tutto l’est del paese, cui Lifg rispose
con un’insurrezione armata di tre anni, prima di essere sconfitto ed
espulso dalla Cirenaica nel 19986.
Agli inizi della guerra degli Usa ai Taliban, Saif al-Islam prese
l’iniziativa di evacuare le famiglie arabe dall’Afghanistan, inclusi
molti membri Lifg e le loro famiglie – un fatto che ebbe un forte
impatto sui jihadisti, portandoli a riconsiderare le loro opinioni
negative sul regime. Per rinforzare la propria posizione all’interno
della famiglia Gheddafi e della società libica più in generale, Saif
al-Islam diede avvio a un processo di riforme con alcuni membri
di Lifg arrestati nel 2007. Questo processo culminò con la pubbli-
cazione nel 2010 di un libro a firma Lifg in cui il gruppo rinuncia-
va all’insurrezione armata e faceva un appello alla tolleranza. Le
rivolte del 2011 esplosero proprio mentre il regime stava rila-
sciando l’ultimo gruppo di combattenti detenuti del Lifg. A quel
punto i militanti del gruppo erano pochi e la sua situazione eco-
nomica disastrosa, tuttavia con tutti i combattenti fuori dal carcere
Lifg era libero d’imbracciare le armi senza il timore di rappresa-
glie da parte del regime sui militanti arrestati7.
La diffusione negli anni Settanta del wahabismo d’ispirazione
saudita pose una minaccia più sottile e permanente al regime di
Gheddafi di quanto non avessero fatto i Fratelli musulmani o il
Lifg. Il wahabismo saudita lanciava una sfida implicita al regime,
condannando il socialismo e aderendo a una definizione restrittiva
di governo legittimo, che non si estendeva alla Jamahiriya di
Gheddafi. Durante gli anni Settanta e Ottanta la società libica di-
venne più conservatrice sotto il profilo religioso man mano che
l’opera di proselitismo dei sauditi andò a fondersi con il revival
islamico innescato dalla rivoluzione islamica dell’Iran e
dall’invasione sovietica dell’Afghanistan. I ragazzi dei campus
universitari libici iniziarono a indossare il thawb di stile saudita e
si fecero crescere la barba – le ragazze invece a indossare hijab e
niqab. Presto i campus universitari libici divennero lo spazio non
solo di una passiva resistenza religiosa, ma di un dichiarato attivi-
6 Ibidem, p. 202. 7 Ibidem, p. 206.
48 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
smo anti regime. La sfida implicita del salafismo alle credenziali
politiche e religiose del regime di Gheddafi attraeva la gioventù
libica, frustrata e asfissiata dalla mano pesante del regime. Inoltre,
l’aderenza al salafismo e al wahabismo come forma di dissidenza
era difficile da riconoscere rispetto al senso religioso che lo stesso
Gheddafi promuoveva. In una società in cui tutte le forme di asso-
ciazione erano state soppresse, la Moschea divenne una sorta di
riparo dall’intrusione dello stato8.
Nonostante i timori di Gheddafi, il movimento salafita in Libia
rimase fortemente localizzato, apolitico e non sviluppò mai una
leadership a livello nazionale. Il salafismo ripudiò l’impegno poli-
tico come una fonte di fitna (divisione tra i credenti). Quindi
nell’ultima metà del suo governo Gheddafi riuscì ad assicurarsi la
neutralità dei salafiti. Nel 2011 i salafiti continuarono a denunciare
le rivolte come forza divisiva e proibita dall’islam fino a quando
un’importante figura degli ulama sauditi dichiarò ufficialmente il
regime di Gheddafi illegittimo9.
La reazione islamista alla rivoluzione del 2011
Allo scoppiare della rivoluzione l’opposizione islamista libica sta-
va ancora sostenendo tacitamente il regime e rispose in maniera
esitante ai cambiamenti che stavano sconvolgendo la Libia nel
febbraio 2011. Man mano che il regime collassava sotto la spinta
degli eventi, gli islamisti si unirono alla rivoluzione, ognuno dan-
do un contributo secondo le proprie capacità. Gli ex combattenti
Lifg fondarono e addestrarono diverse brigate grazie ai fondi del
Qatar, e nonostante la loro forza militare non abbia mai raggiunto
quella delle milizie tribali di Zintan o Misurata, il loro apporto mi-
litare fu comunque importante. Allo stesso tempo, il Gruppo Isla-
mico Libico (Lig) – un ramo dei Fratelli musulmani – aveva raf-
forzato la propria presenza nella società libica attraverso la conse-
gna di servizi sociali di base, assicurandosi un’influenza significa-
8 Ibidem, p. 198. 9 Ibidem, p. 220.
Libia: la sfida dello Stato Islamico 49
tiva nel Consiglio Nazionale di Transizione, il governo de facto
della Libia, che aveva amministrato il paese nei dieci mesi seguen-
ti la caduta di Gheddafi10
.
Nel luglio del 2012 il popolo libico aveva eletto il suo primo
Parlamento, il Congresso Nazionale Generale (Gnc). La coalizione
islamista, composta da affiliati dei Fratelli musulmani e del Lifg
non ebbe molto successo rispetto alla più liberale Alleanza delle
Forze Nazionali (Nfa). Il leader del Nfa, Mahmoud Jibril, forma-
tosi negli Stati Uniti, era in grado di capire abbastanza bene i valo-
ri tribali e tradizionali della Libia da accettare la sharia come una
delle fonti fondamentali per la legislatura della sua coalizione.
Inoltre i libici avevano iniziato a guardare con sospetto gli islami-
sti per gli aiuti militari e finanziari ricevuti durante le rivolte11
.
Tuttavia, nonostante la vittoria iniziale dei partiti laici, i gruppi
islamisti, più organizzati e più uniti, erano stati in grado di domi-
nare il parlamento per tutto il 2013. La rivalità tra queste due fa-
zioni politiche ha condotto il paese a una progressiva polarizza-
zione, un processo aggravato dall’intervento, dall’uso della vio-
lenza e dal condizionamento della dinamica politica da parte delle
milizie fedeli alle due fazioni rivali. Quest’erosione della sicurezza
politica e i numerosi omicidi hanno portato alla grave crisi cui as-
sistiamo oggi.
A causa dell’aggressività delle milizie, soprattutto nella città di
Bengasi, l’ex generale Khalifa Haftar nel maggio 2014 lancia un
attacco mirante a espellere tutti i gruppi islamisti dal paese. Un in-
sieme di gruppi laici, milizie tribali e soldati del vecchio regime
rispose alla chiamata alle armi. Tuttavia il considerare tutti gli
islamisti come un fronte unico, ha fatto sì che le milizie di Bengasi
si unissero tra loro e con gruppi simili a Tripoli o Misurata e lan-
ciassero l’operazione Alba Libica, un contrattacco coordinato non
solo a Bengasi ma in buona parte della Libia occidentale. Con il
sostegno delle potenti milizie di Misurata, le brigate islamiste
hanno costretto il neo-eletto parlamento, ampiamente laico, a cer-
10 Ibidem, p. 221. 11 N. Jebnoun, “Tribal Loyalties Supersede National Identity in Libya Vote”, Al Akhbar english, 20 luglio 2012, http://english.al-akhbar.com/node/10058.
50 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
care rifugio nella città orientale di Tobruk, sotto la protezione del-
le truppe del generale Haftar. Dall’estate del 2014 la Libia è para-
lizzata da una guerra civile tra due fazioni contrapposte, ognuna
delle quali sostiene un parlamento e un governo diversi.
Lo Stato Islamico in Libia
Il lancio dell’Operazione Dignità ha avuto l’effetto inatteso di ri-
chiamare nella madrepatria i miliziani libici impegnati in Siria o
Iraq. Tra loro anche al-Battar Battalion, sostenitore dello Stato
Islamico, che ha probabilmente facilitato l’arrivo di suoi emissari
a Derna dall’Arabia Saudita e dallo Yemen12
. Il 20 agosto la pre-
senza dello Stato Islamico in Libia è diventata palese, quando il
gruppo Majlis Shura Shabab al-Islam (Mssi) di Derna ha mostrato
la bandiera nera nel video dell’esecuzione di un cittadino egiziano.
A metà ottobre il Mssi di Derna ha giurato fedeltà al gruppo e dato
avvio a un tribunale islamico sotto la guida di emissari dello Stato
Islamico, arrivati con l’esplicito proposito di stabilire la Wilayat
al-Barqa13
.
Da allora in poi lo Stato Islamico sta replicando in Libia il mo-
dello d’espansione utilizzato in Siria e in Iraq, seppure in scala
minore. IS ha esteso le sue attività a Bengasi, Sirte, Tripoli e in al-
tre aree della Libia meridionale. Il gruppo ha rivendicato gli atten-
tati all’esterno del Security Directorate di Ajdabiya (1 dicembre),
del Diplomatic Security Headquarters di Tripoli (27 dicembre),
della Camera dei deputati a Tobruk (30 dicembre) e
dell’ambasciata algerina (17 gennaio). Nello stesso periodo lo Sta-
to Islamico ha anche portato a termine una serie di rapimenti e de-
capitazioni, compresa l’uccisione di due giornalisti tunisini, e il
rapimento di 21 egiziani copti. L’attacco all’Hotel Corinthia di
12 F. Wehrey, Mosul on the Mediterranean? The Islamic State in Libya and U.S. Counterter-rorism Dilemmas, Carnegie Endowment for International Peace, 17 dicembre 2014, http://carnegieendowment.org/2014/12/17/islamic-state-in-libya-and-u.s.-counterterrorism-dilemmas. 13 Islamic State Activity in Libya, Kalam Institute for Network Science, 2 febbraio 2015, http://www.slideshare.net/movelibyaforward/islamic-state-activity-in-libya.
Libia: la sfida dello Stato Islamico 51
Tripoli il 27 gennaio da parte di affiliati dello Stato Islamico ha
sollevato timori internazionali sul fatto che il gruppo possa diveni-
re un serio contendente nel conflitto libico. Timori che si sono ul-
teriormente rafforzati quando gli affiliati dello Stato Islamico han-
no annunciato la presa di Sirte e la decapitazione dei ventuno
ostaggi copti, il 12 febbraio14
.
Lo Stato Islamico ha unito alla sua caratteristica brutalità alcu-
ne attività culturali attinenti all’“imposizione morale” e al proseli-
tismo. Gli uffici stampa del gruppo hanno diffuso immagini dei
combattenti impegnati nella distruzione di stecche di sigarette, di
caramelle ai bambini, di aiuto ai poveri e nella chiusura forzata di
attività commerciali durante le ore di preghiera15
. L’attenzione
dello Stato Islamico alle pubbliche relazioni potrebbe derivare dal-
la necessità del gruppo di competere con una moltitudine di mili-
zie libiche e di fazioni in lotta per il supporto delle popolazioni lo-
cali. Finora, comunque, gli sforzi di proselitismo a Derna sono sta-
ti accolti con una fredda reazione. Secondo fonti locali, una confe-
renza sponsorizzata dallo Stato Islamico sul califfato ha raccolto
un interesse scarso o nullo da parte dei locali. Dopo il giuramento
del Mssi a ottobre, una fazione locale ribelle, la brigata dei martiri
Abu Salim, ha reagito duramente. I report successivi al giuramento
mostrano cittadini arrabbiati per la presenza di coloro che percepi-
scono come stranieri, provenienti da Iraq, Siria e Tunisia16
.
Parte del disinteresse potrebbe derivare dal fatto che, a diffe-
renza che in Iraq e in Siria, lo Stato Islamico in Libia non può pun-
tare sulle rivalità settarie tra sunniti e sciiti. Il conflitto tra i due
parlamenti libici e le loro rispettive coalizioni di militanti è forte-
mente radicato nelle rivalità locali per il potere e il controllo delle
14 A. Engel, The Islamic State’s Expansion in Libya, The Washington Institute for Near East Policy, Policy Analysis, Policywatch 2371, 11 febbraio 2015, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-islamic-states-expansion-in-libya. 15 R. Lefèvre, “Is the Islamic State on the Rise in North Africa?”, The Journal of North Africa Studies, vol. 19, n. 5, 2014, p. 855. 16 F. Wehrey, “The Battle for Benghazi”, The Atlantic, 28 febbraio 2014, http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/02/the-battle-for-benghazi/284102/.
52 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
risorse strategiche17
. Temprate dai combattimenti, le fazioni libi-
che saranno probabilmente in grado di resistere a perdite di territo-
rio significative a favore dei nuovi arrivati stranieri, come lo Stato
Islamico e i suoi adepti locali. Senza grande sorpresa dunque, lo
Stato Islamico ha evitato di confrontarsi direttamente con le fazio-
ni in lotta, approfittando piuttosto dell’anarchia libica e
dell’inclinazione storica di Derna a favore della resistenza jihadi-
sta per stabilire la sua presenza nella Libia orientale.
Per ora il controllo dello Stato Islamico sul territorio in Libia
rimane limitato. Gli affiliati dello Stato Islamico non controllano
totalmente nessuna delle città libiche a cui hanno esteso le proprie
attività, inclusa Derna. Ma l’ampiezza della presenza dello Stato
Islamico in Libia potrebbe dipendere non tanto dalla popolarità
presso i libici quanto dall’abilità del gruppo di cooptare jihadisti
locali. Abbandonando al-Qaida e presentandosi come affiliato del-
lo Stato Islamico, Mssi si è distinto dal punto di vista ideologico
rispetto ai rivali locali, come la Brigata Martiri Abu Salim, e ad
altre branche di al-Qaida18
. Alla luce di ciò il giuramento di Derna
è un segnale preoccupante del potere di attrazione globale dello
Stato Islamico. La crescita delle affiliazioni nel Nord Africa po-
trebbe rappresentare il modello futuro delle conquiste territoriali di
IS19
.
Il cambiamento di alleanza del Mssi è emblematico di come la
competizione tra IS e al-Qaida per il controllo del jihad globale
stia impattando sulle alleanze delle milizie in Nord Africa. Nel
Maghreb lo Stato Islamico ha fatto appello ai combattenti di Ansar
al-Shariʻa affinché abbandonino al-Qaida così come ha incorag-
17 E. Fowler, “From Raqqa to Derna: Exceptionalism in Expansionism”, Jadaliyya, Arab Studies Institute, 4 dicembre 2014, http://reviews.jadaliyya.com/pages/index/20182/from-raqqa-to-derna_exceptionalism-in-expansionism. 18 A.Y. Zelin, The Islamic State’s First Colony in Libya, The Washington Institute for Near East Policy, Policy Analysis, Policywatch 2325, 10 ottobre 2015, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-islamic-states-first-colony-in-libya. 19 B. Faucon, “Islamic State Gained Strength in Libya by Co-Opting Local Ji-hadists”, Wall Street Journal, 17 febbraio 2015, http://www.wsj.com/articles/islamic-state-gained-strength-in-libya-by-co-opting-local-jihadists-1424217492.
Libia: la sfida dello Stato Islamico 53
giato i combattenti di Jabhat al-Nusra a fare altrettanto in Siria.
Sempre di più sembra che gli appelli dello Stato Islamico non stia-
no cadendo nel vuoto. Il 3 febbraio un ex affiliato di al-Qaida nel
Maghreb Islamico (Aqim), la brigata Tarek Ibn Ziyad, ha lanciato
un attacco al giacimento di petrolio al Mabrook in nome dello Sta-
to Islamico. Nel 2012 l’intervento militare francese nel nord del
Mali ha smantellato la brigata dal sud del Sahara spingendola tra
le braccia di Ansar al-Shariʻa in Libia, altro affiliato di Aqim.
Come suggerisce l’attacco del 3 febbraio, gli affiliati e gli alleati
di Ansar al Shariʻa stanno iniziando a rispondere agli appelli dello
Stato Islamico20
.
Nonostante Ansar al Shariʻa non abbia ufficialmente giurato
fedeltà allo Stato Islamico, i legami e le manifestazioni di simpatia
stanno iniziando a emergere da parte degli affiliati minori. Sia in
Tunisia sia in Libia il gruppo ha diffuso propaganda a favore dello
Stato Islamico21
, mentre stanno emergendo altri resoconti sui pro-
grammi di addestramento dei combattenti di Ansar al-Shariʻa da
parte dello Stato Islamico22
. Riuscire a reclutare combattenti
esperti di Ansar al-Shariʻa rappresenterebbe il primo passo di una
strategia a lungo termine verso l’egemonia dello Stato Islamico23
.
Poiché la rivalità tra Stato Islamico e Jabhat al-Nusra/al-Qaida
è esplosa in Siria, Aqim ha fatto appello alla riconciliazione e ha
tentato di rimanere neutrale. In ogni caso, hanno cominciato a
emergere divisioni tra i ranghi più elevati e più bassi di Aqim. A
giugno, Abdelmalek Droukdel, capo di Aqim, ha condannato
l’approccio unilaterale con cui lo Stato Islamico si è impossessato
dei territori in Iraq e in Siria, chiedendo un maggiore coordina-
20 A.Y. Zelin, The War between ISIS and Al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement, The Washington Institute for Near East Policy, Policy Analysis, Research Notes, n. 20, giugno 2014, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-war-between-isis-and-al-qaeda-for-supremacy-of-the-global-jihadist. 21 A. Engel, Libya as a Failed State, The Washington Institute for Near East Policy, Policy Analysis, Research Notes, n. 24, novembre 2014, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/libya-as-a-failed-state-causes-consequences-options (22 febbraio 2015); A.Y. Zelin, (2014). 22 A. Engel, (2015). 23 R. Lefèvre, (2014), p. 854.
54 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
mento con al-Qaida. Ma a luglio, un giudice islamico di alto grado
nelle gerarchie Aqim, Abdullah Othman al-Assimi, ha difeso il
leader dello Stato Islamico, accusando i critici d’invidia e malevo-
lenza24
. Il fatto che il giudice si sia schierato con l’emiro dello Sta-
to Islamico ha indebolito la pretesa di legittimità da parte di
Droukdel. Negli ultimi mesi, solo pochi affiliati di Aqim hanno
disertato verso lo Stato Islamico, compreso Jund al-Khalifa, che ha
decapitato in Algeria un turista francese a settembre25
. In ogni ca-
so al-Qaida è lontana dal perdere il sostegno degli affiliati nella
regione del Sahel e del Maghreb. Mokhtar Belmokhtar, il capo dei
Murabitun, importante ramo di al-Qaida nel Sahara, si è schierato
con decisione a fianco della vecchia guardia.
Conclusioni - Implicazioni
Per stabilire il califfato lo Stato Islamico ha necessità di conquista-
re territorio e sottomettere la popolazione libica attraverso una
campagna persistente d’inimmaginabile violenza, che consegue
presentandosi come l’opzione da temere maggiormente e costrin-
gendo le persone ad accettare il controllo da parte sua o pagare
con la morte. IS cerca di spodestare i governi di Tobruk e Tripoli,
affermando la propria influenza e scalzando le fazioni al potere.
Lo Stato Islamico spera anche di ergersi a difensore delle terre
e dei valori dell’islam contro l’intervento esterno. L’orribile ucci-
sione degli egiziani copti, che ha condotto a una rapida rappresa-
glia da parte dell’Egitto e agli appelli di Abdullah al-Thani per una
risposta internazionale, rientra perfettamente nella strategia di IS
per attirare gli eserciti stranieri. Lo Stato Islamico userebbe allora
il jihad contro l’intervento esterno per radunare nuove reclute.
Un terzo importante aspetto della strategia dello Stato Islamico
è quello di garantirsi il controllo del territorio. Per ora i suoi soste-
nitori e le sue milizie hanno stabilito delle roccaforti nelle città
lungo la costa mediterranea. Queste basi sul litorale permettono un
24 Ibidem. 25 Ibidem.
Libia: la sfida dello Stato Islamico 55
facile afflusso di uomini e di beni dal levante. IS vuole unire Der-
na e Bengasi a est, Sirte nel centro e Tripoli a ovest in un territorio
più esteso; ha già iniziato a mettere in atto questa strategia entran-
do a Ben Jawad, un’area a circa 140 km a est di Sirte, cui si può
avere accesso solo attraverso le principali strade costiere e da cui
IS può controllare tutti i movimenti tra Sirte e Ben Jawad. Per
spostarsi efficacemente all’interno della Libia, il gruppo tenterà di
collegare tutte le sue basi in questo modo. L’attacco ai giacimenti
di petrolio di al Mabrook indica che lo Stato Islamico ha già mes-
so gli occhi sulle risorse petrolifere della Libia e che impedirà a
ogni altro attore di ottenerle.
Lo Stato Islamico è effettivamente un’organizzazione pericolo-
sa ma, per adesso, ancora gestibile. Se la comunità internazionale
deciderà d’impiegare tutte le sue forze e la sua reputazione nelle
negoziazioni guidate dall’Onu, la crisi libica e il fenomeno jihadi-
sta potranno essere risolti. Le due fazioni di Tobruk e Tripoli do-
vranno giungere a un accordo e dar vita a un governo di unità na-
zionale che possa ristabilire l’ordine e la sicurezza in tutto il paese,
con la collaborazione di forze internazionali e delle milizie libiche.
Una risposta internazionale coordinata ridurrà le opportunità a
disposizione dello Stato Islamico, rendendo le diserzioni da Alba
Libica minori e meno significative. Inoltre, una risposta interna-
zionale regolerebbe le interferenze esterne, evitando che la Libia
diventi preda dei politici autoritari della regione. La rappresaglia
egiziana per il brutale assassinio dei copti ha pesato sulla remota
speranza che la minaccia di IS potesse unire i partiti rivali. I bom-
bardamenti di al-Sisi hanno ufficializzato il sostegno dell’Egitto al
governo di Tobruk, spostando l’equilibrio di forze sul campo a fa-
vore delle truppe del generale Haftar e riducendo quindi la dispo-
nibilità di queste ultime al negoziato e al compromesso. Interventi
unilaterali di questo tipo da parte di politici autoritari apertamente
anti-islamisti come al-Sisi non faranno che esasperare la rivalità
tra Tobruk e Tripoli. Molte prove dimostrano la contro produttivi-
tà dei bombardamenti nel ridurre il potere di attrazione dei gruppi
terroristi: una ragione in più per perseguire uno sforzo coordinato
con gli attori libici.
56 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
L’Italia è il paese che, rispetto a tutti gli altri stati europei, ri-
schia di essere più danneggiato dal collasso della Libia.
L’aumento dell’afflusso di migranti metterà a dura prova le deboli
strutture di accoglienza italiane: senza dubbio una minaccia alla
sicurezza nazionale. La possibilità che terroristi si nascondano tra
gli arrivi di migranti è un’ipotesi possibile, ma remota. Dal punto
di vista economico, il collasso della Libia darebbe un colpo rile-
vante alla sicurezza energetica italiana, al settore del petrolio e ad
altre aree economiche duramente colpite dalla crisi. È quindi
nell’interesse nazionale italiano studiare un possibile intervento in
coordinamento con gli altri stati europei che possa condurre al ri-
stabilimento dell’ordine pubblico e della sicurezza in Libia. Più
dello Stato Islamico e dei suoi raccapriccianti sogni di stabilire un
califfato nel Medio Oriente, è l’instabilità della Libia a essere una
minaccia per l’Italia.
3. L’ascesa del jihadismo in Algeria e Tunisia: gli interessi italiani
Stefano M. Torelli
L’attentato contro il Museo del Bardo a Tunisi del 18 marzo 2015,
che ha causato la morte di 24 persone, quasi tutti turisti, e di cui
quattro di nazionalità italiana, avveniva quando il presente capito-
lo era già stato concluso. I fatti di Tunisi non fanno altro che riba-
dire la necessità che l’Italia prenda coscienza della minaccia jiha-
dista presente anche al confine tra Algeria e Tunisia e di tutte le
misure necessarie per tutelare i propri interessi, di natura econo-
mica e di sicurezza, in questa parte del Nord Africa. Il quadro nor-
dafricano, infatti, interessa direttamente l’Italia e in generale tutti i
paesi dell’Europa meridionale che si affacciano sul Mediterraneo.
Soprattutto a partire dalla seconda metà del 2014, però, è stata la
Libia a diventare il paese su cui l’Italia ha concentrato maggior-
mente la propria l’attenzione in tema di sicurezza. Di tutte le realtà
del Nord Africa, infatti, si tratta del contesto più instabile e che è
stato testimone, in maniera sicuramente superiore rispetto ad altri
paesi, dell’emergere di forze islamiste radicali di stampo jihadista.
Inoltre, è qui che risiedono i maggiori interessi italiani strategici,
economici e finanziari. Tuttavia, la realtà del Nord Africa è molto
eterogenea; dal 2011 in poi – anno delle cosiddette Primavere ara-
be, che hanno segnato uno spartiacque all’interno dello sviluppo
storico-politico del mondo arabo e musulmano – i paesi che ne
fanno parte hanno intrapreso nuovi percorsi istituzionali e hanno
visto la nascita di nuovi attori non statali, potenzialmente forieri di
minacce alla stessa sicurezza italiana. In particolar modo, la Tuni-
sia e l’Algeria rivestono oggi un’importanza di primo piano
all’interno delle dinamiche di sicurezza della regione mediterra-
58 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
nea. La composita galassia dei movimenti jihadisti, la cui attività
si è notevolmente intensificata dopo il 2011, è oggi composta an-
che da nuovi attori, alcuni dei quali agiscono proprio al confine tra
questi due paesi, determinando una situazione d’instabilità ai no-
stri confini, che potenzialmente può minacciare lo stesso territorio
europeo.
Dal punto di vista strutturale, Algeria e Tunisia hanno pochi
aspetti che le accomunano. Sotto il profilo economico, la differen-
za più sostanziale riguarda la presenza in Algeria d’ingenti risorse
naturali, soprattutto petrolio e gas1. Se da un lato questo aspetto
rende l’Algeria relativamente ricca2, dall’altro comporta proble-
matiche di lungo termine (mancata diversificazione economica e
un’eccessiva dipendenza da un’unica fonte di rendita), anche dal
punto di vista politico-istituzionale. Il fatto che l’Algeria possa in
parte sfruttare la propria ricchezza per decidere deliberatamente
come redistribuirla tra la popolazione e, dunque, usandola come
calmiere per eventuali richieste di riforme socio-economiche, fa sì
che il paese non sia ancora riuscito a sviluppare delle reali dinami-
che politiche di democratizzazione. Nel caso dell’Algeria, così
come era stato per la Libia fino al 2011, ed è tuttora nelle monar-
chie arabe del Golfo, gli idrocarburi rappresentano paradossalmen-
te un freno allo sviluppo politico e sociale. Lo stesso non si può
dire per la Tunisia, la quale, proprio in virtù di una società civile
sicuramente più sviluppata e di un panorama socio-politico più
composito di quello algerino, è riuscita a incamminarsi verso un
percorso di transizione politica che, a partire dal 2011, sta portan-
do il paese a diventare il primo e unico caso di successo rispetto a
tutti gli altri contesti in cui si è manifestata la “Primavera araba”.
Altre differenze strutturali tra Algeria e Tunisia – in parte ricondu-
cibili alle diversità appena delineate – riguardano i livelli di svi-
1 L’Algeria è il nono produttore al mondo di gas naturale, con più di 80 miliardi di metri cubi l’anno, e il primo in Africa. Con quasi 2 milioni di barili al giorno, è anche il quindicesimo produttore di petrolio al mondo e il secondo in Africa, dietro la Ni-geria. Dati: BP e Iea. 2 Si tratta del paese con il più alto Pil del Maghreb, con 208 miliardi di dollari nel 2014. La Tunisia ha un Pil di 46 miliardi di dollari. Dati: International Monetary Fund.
L’ascesa del jihadismo in Algeria e Tunisia: gli interessi italiani 59
luppo e benessere sociale. Sebbene la stessa Tunisia non possa dir-
si in assoluto un paese ricco o benestante, è indubbio che i mag-
giori indicatori di sviluppo facciano registrare rendimenti molto
più elevati in questo contesto, piuttosto che in quello algerino. E,
probabilmente, è stata proprio questa differenza di fondo a far sì
che le rivolte tunisine assumessero le caratteristiche di un rove-
sciamento sistemico, mentre quelle algerine sono rientrate in se-
guito alle misure economiche prese dal governo di Bouteflika nel
2011. Ciò detto, nel contesto attuale Tunisia e Algeria sono acco-
munate da un elemento che riguarda proprio il fattore sicurezza e
la diffusione di gruppi lungo una nuova direttrice, vale a dire quel-
la del loro confine condiviso. La questione del jihadismo in
quest’area assume rilevanza per gli interessi italiani in quanto que-
sti due paesi, per motivazioni differenti, sono legati all’Italia da
rapporti di tipo economico, culturale e geopolitico, rispetto ai quali
l’attività terroristica che interessa tali contesti – e che da tali con-
testi può fuoriuscire fino a toccare direttamente l’Italia e l’Europa
– si pone come un elemento destabilizzante.
Algeria: tra nuove traiettorie di Aqim e sicurezza energetica
Sebbene la letteratura specialistica, l’opinione pubblica italiana e,
talvolta, le stesse analisi di policy non diano la necessaria rilevan-
za a questo attore statale, l’Algeria è uno dei perni della politica
estera e di sicurezza italiana. Dall’Algeria proviene una parte si-
gnificativa dell’approvvigionamento energetico italiano3 e, poten-
zialmente, qualsiasi sconvolgimento di tipo politico e di sicurezza
in questo paese si tradurrebbe immediatamente in una minaccia
diretta alla sicurezza italiana. Soprattutto in un momento in cui le
altre due fonti principali di approvvigionamento energetico italia-
no – Russia e Libia – sono a rischio per via degli sviluppi geopoli-
3 Il discorso è valido soprattutto per l’approvvigionamento di gas naturale, del quale l’Italia ha importato nel 2014 dall’Algeria 6,8 miliardi di metri cubi (ovvero il 13 per cento del totale delle importazioni italiane di gas). Dati: Snam Rete Gas.
60 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
tici e del parziale deterioramento delle relazioni con questi due at-
tori, la sicurezza dell’Algeria risulta quanto mai determinante per
gli interessi nazionali italiani. Senza dubbio, tra gli elementi che
concorrono a minacciare la stabilità algerina – oltre all’incertezza
sulla possibile successione all’attuale presidente Bouteflika – vi è
proprio la presenza di gruppi jihadisti radicati da anni in Algeria e
ai suoi diretti confini. Il jihadismo algerino ha sperimentato diver-
se fasi nella sua storia e ha le sue radici nella guerra civile degli
anni Novanta, che conta più di 200.000 vittime. Il maggiore grup-
po islamista presente in quegli anni era il Gruppo Salafita per la
Predicazione e il Combattimento (Gspc), che in seguito avrebbe
cambiato nome dopo la sua affiliazione ad al-Qaida, diventando
quello che ancora oggi è conosciuto come al-Qaida nel Maghreb
Islamico (nell’acronimo inglese, Aqim). Nato ufficialmente nel
2007, il movimento ha avuto sempre come principale obiettivo lo
stesso governo algerino, puntando direttamente alla costituzione di
uno stato islamico all’interno dei confini algerini. Quello che, ini-
zialmente, era ritenuto essere il gruppo più attivo e “ricco” tra tutti
i movimenti jihadisti affiliati ad al-Qaida, ha però subìto una serie
di mutamenti tattici, strategici e strutturali, che lo hanno in parte
indebolito, ma d’altro canto ne hanno espanso il raggio d’azione,
rendendolo potenzialmente più pericoloso anche per altri paesi
dell’area4. Il primo riferimento è alla cosiddetta fascia saheliana,
che comprende la Mauritania, il Mali e il Niger, lambendo anche il
Ciad. Si possono individuare alcune motivazioni alla base della
cosiddetta “regionalizzazione” di Aqim lungo la direttrice del Sa-
hel:
la necessità emersa dalle operazioni delle Forze di sicurezza
algerine, che hanno spinto Aqim fuori i confini algerini;
le condizioni strutturali di paesi in cui il controllo del territorio
è più difficilmente effettuato;
4 Si veda anche S.M. Torelli, A. Varvelli, Il nuovo Jihadismo in Nord Africa e nel Sahel, in Osservatorio di politica internazionale, n. 75, Roma, Senato della Repubblica, mag-gio 2013.
L’ascesa del jihadismo in Algeria e Tunisia: gli interessi italiani 61
una sorta di ritirata strategica, volta a riorganizzare le proprie
forze, in vista di nuovi attacchi all’Algeria.
Come conseguenza di questa nuova tattica da parte di Aqim, vota-
ta più alla propria riorganizzazione interna, che agli attacchi con-
tro il nemico (l’Algeria), l’organizzazione qaidista aveva comin-
ciato a intraprendere tutta una serie di attività cui solitamente i
gruppi jihadisti non erano dediti fino alla metà degli anni Duemila:
traffico di armi;
traffico di stupefacenti e merci contraffatte;
controllo delle rotte dell’immigrazione sulla direttrice Sud-
Nord;
rapimento di civili, spesso occidentali, per ottenere il paga-
mento di riscatti.
Il conflitto scoppiato in Mali tra il 2011 e il 2012, influenzato an-
che dal flusso di armi ed elementi tuareg dalla Libia a seguito del-
la guerra civile libica, ha costituito un primo momento di divisione
all’interno di Aqim. La parte dirigente del gruppo, infatti, non si
trovava in accordo con gli elementi di Aqim che hanno appoggiato
la costituzione di un sedicente Stato Islamico nel Nord del Mali,
da parte del Movimento per l’Unicità e il Jihad in Africa Occiden-
tale (Mujao). Agli occhi della dirigenza di Aqim l’obiettivo ultimo
sarebbe dovuto rimanere il jihad in Algeria e, in quest’ottica,
l’ingresso nelle dinamiche interne del Mali avrebbe potuto disto-
gliere le forze dall’obiettivo principale. Allo stesso tempo, un’altra
divisione stava prendendo piede: quella rappresentata dalla fazione
riunitasi intorno alla figura di Mokhtar Belmokhtar. Quest’ultimo
aveva creato una propria sacca di autonomia proprio grazie (an-
che) ai traffici di merci contraffatte e sigarette di contrabbando,
fino a entrare in conflitto con la leadership di Aqim, di cui for-
malmente faceva parte. La spaccatura interna al movimento qaidi-
sta nordafricano ha provocato un effetto immediato sulla stessa
sicurezza dell’Algeria, determinando nuovi fattori di rischio. È
stato proprio il gruppo di Belmokhtar, infatti, a effettuare lo spet-
tacolare attacco contro gli impianti di gas naturale di In Amenas,
nel Sud-Ovest dell’Algeria, nel gennaio 2013. L’attacco, che ha
62 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
provocato la morte di 37 lavoratori stranieri, tra cui molti occiden-
tali, ha segnato una svolta tattico-strategica del jihadismo algerino
– seppure non di Aqim – dal momento che ha colpito direttamente
il cuore dell’economia e dell’industria del paese, vale a dire quella
degli idrocarburi. La potenziale minaccia derivante da attentati di
questo tipo, rispetto alle operazioni tipiche del Gspc e in seguito di
Aqim, concentrate esclusivamente contro obiettivi militari e istitu-
zionali algerini, va invece a colpire anche altri settori. Conseguen-
temente, il livello di tale minaccia coinvolge in maniera maggiore
anche l’Occidente, per due ordini di motivi: gli obiettivi stessi de-
gli attentati possono essere cittadini occidentali che lavorano nel
settore degli idrocarburi in Algeria; eventuali danni all’industria
petrolchimica algerina potrebbero ripercuotersi sulla sicurezza
energetica dei paesi della sponda Nord del Mediterraneo, in primis
Spagna, Italia e Francia.
La stessa Algeria, però, non è stata immune neppure
dall’ascesa ideologica di IS (Stato Islamico) e, come accaduto in
altri contesti arabi e mediorientali, anche in Algeria si sta verifi-
cando una polarizzazione del panorama jihadista, con la nascita di
gruppi affiliati al califfato di Abu Bakr al-Baghdadi. È questo il
caso del movimento sorto nel settembre 2014 da una scissione in-
terna ad Aqim e chiamato Jund al-Khilafa. Il gruppo era guidato
da Abdelmalek Gouri, un ex comandante di Aqim che ha succes-
sivamente deciso di dichiarare la propria affiliazione a IS. Tale
scissione testimonia la tendenza diffusa in tutto il mondo arabo e
musulmano (anche in Africa), che vede il monopolio della scena
jihadista di al-Qaida messo in discussione dalla “nuova generazio-
ne” di jihadisti afferenti a IS. A differenza di al-Qaida, l’IS si di-
stingue per metodi molto più violenti, che prevedono anche un at-
tacco più indiscriminato contro cittadini occidentali o, in generale,
ritenuti “infedeli”, ricorrendo in maniera radicale alla pratica del
takfir5. Nel caso di Jund al-Khilafa, ad esempio, tale caratteristica
5 Il termine takfir identifica l’atto di dichiarare infedele (kafir, da cui comporre il ter-mine takfir) una persona o una pratica. Per l’islam, la dichiarazione di takfir rappre-senta una grave accusa e comporta delle serie conseguenze sia per l’accusatore, il quale può vedersi rivolgere la medesima accusa qualora la sua dichiarazione fosse
L’ascesa del jihadismo in Algeria e Tunisia: gli interessi italiani 63
è emersa chiaramente con l’uccisione tramite decapitazione del
cittadino francese Hervé Gourdel, guida alpina rapita dal gruppo il
21 settembre 2014. A oggi, è difficile fare una stima delle reali for-
ze in campo di Jund al-Khilafa, che secondo alcune fonti non ecce-
derebbero il centinaio di persone. Il leader Abdelmalek Gouri è sta-
to ucciso in un raid aereo dell’esercito algerino nel dicembre 20146
e non è chiaro chi abbia assunto la leadership del gruppo. Tuttavia,
l’emergere di Jund al-Khilafa è sintomatico della graduale presa
dell’ideologia di IS anche in Nord Africa e, insieme alle operazioni
condotte dai gruppi affiliati a Belmokhtar, diventa una nuova fonte
di pericolo per l’Algeria. Rimane comunque la “tradizionale” mi-
naccia rappresentata da Aqim che, a sua volta, sembra aver ripreso
in parte le attività in Algeria e, soprattutto, sembra essersi infiltrata
in maniera abbastanza efficace nella vicina Tunisia.
Tunisia: una minaccia trascurata?
Proprio la Tunisia rappresenta, dal punto di vista cronologico,
l’ultimo territorio d’espansione delle forze jihadiste legate ad
Aqim in Nord Africa. Il paese, fino alla caduta di Ben ‘Ali, era
stato praticamente immune da manifestazioni d’islamismo radicale
e di salafismo di tipo jihadista. Alcuni sporadici episodi, a dire il
vero, avevano già messo in evidenza la presenza di gruppi jihadisti
in Tunisia tra il 2006 e il 20077, ma la loro attività non era mai ar-
rivata a minacciare seriamente la stabilità e la sicurezza tunisine.
Dal 2012 e, con maggiore evidenza, dal 2013, gruppi salafiti jiha-
disti sono apparsi anche in Tunisia, ponendo una minaccia diretta
giudicata falsa, sia per l’accusato, passibile di morte. Secondo l’interpretazione mili-tante jihadista, la questione del takfir viene direttamente all’interno della dimensione musulmana divenendo lo strumento per legittimare l’uccisione di fedeli musulmani giudicati empi o negatori della “vera” fede posta, si veda P. Maggiolini, A. Plebani, “La centralità del nemico nel califfato di al-Baghdadi”, in Twitter e jihad: la comunica-zione dell’Isis, a cura di M. Maggioni, P. Magri, Milano, ISPI, 2015, nota a p. 29. 6 “Leader of Algerian ‘beheading group’ killed”, Al-Jazeera, 23 dicembre 2014. 7 Si veda anche J. Garçon, “Fusillades à répétition dans la Tunisie tranquille de Ben Ali”, Libération, 4 gennaio 2007.
64 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
al processo di transizione politica del paese a seguito della caduta
di Ben ‘Ali nel 2011. Allo stesso tempo, la radicalizzazione dei
giovani tunisini non minaccia solo il piano interno, ma ha le po-
tenzialità di porre una seria sfida anche al di fuori dei confini na-
zionali: più di 3.000 sarebbero i tunisini partiti per combattere in
Siria e Iraq, mentre connessioni tra jihadismo locale ed elementi
tunisini si riscontrano nella vicina Libia, ma anche in Occidente8.
Ed è per questo tipo di considerazioni che l’Italia deve porre
grande attenzione nel monitorare l’evoluzione del jihadismo in
Tunisia, fenomeno che non ha ancora contorni molto chiari e che
potrebbe espandersi nel breve-medio periodo. Inoltre, un equivoco
– più o meno voluto da parte delle stesse autorità tunisine – che
riguarda la natura dei gruppi salafiti nati dopo il 2011 e, in manie-
ra particolare, le attività di Ansar al-Shari‘a in Tunisia (Ast) con-
tribuisce ad accrescere la confusione sullo stato dei movimenti ji-
hadisti nel paese. Quest’ultimo è un movimento salafita che, for-
matosi ufficialmente nel marzo del 2011, non poteva definirsi co-
me gruppo salafita di tipo jihadista, in quanto né le proprie azioni,
né lo stesso messaggio di cui si faceva portatore, potevano essere
ricondotti alla pratica del jihadismo. Sebbene il suo leader e fonda-
tore Abu ‘Ayyadh avesse un passato da muhajid in Afghanistan,
egli stesso sembrava aver adottato nuove strategie ed essere passa-
to a proclamare e sostenere un salafismo di tipo quietista e “socia-
le”, piuttosto che politico o addirittura violento9. Ast è riuscita in
breve tempo a raccogliere attorno a sé la maggioranza delle perso-
ne che hanno abbracciato l’ideologia salafita e, in poco tempo, è
riuscita a organizzarsi in movimento ben strutturato, con “bran-
che” locali presenti in molte aree della Tunisia, anche le meno svi-
luppate e geograficamente più remote rispetto ai tradizionali centri
urbani. Allo stesso tempo, tra il 2011 e il 2012 ha raggiunto un li-
vello di visibilità piuttosto alto, grazie alle manifestazioni organiz-
8 Si veda anche J. Githens-Mazer, R. Serrano, T. Dalrymple, “The curious case of the Tunisian 3,000”, Open Democracy, 19 luglio 2014. 9 S.M. Torelli, “A Portrait of Tunisia’s Ansar al- Shariʻa Leader Abu Iyad al-Tunisi: His Strategy on Jihad”, Militant Leadership Monitor, Washington DC, The Jamestown Foundation, vol. 4, n. 8, 2013, pp. 9-11.
L’ascesa del jihadismo in Algeria e Tunisia: gli interessi italiani 65
zate in supporto alla sharia, ai raduni annuali che teneva nella città
santa di Kairouan e all’organizzazione di convogli destinati ad aiu-
tare le famiglie più bisognose nelle aree povere del paese e nei
sobborghi della stessa Tunisi. La posizione di Ast è divenuta più
ambigua dopo i fatti del settembre 2012, quando un gruppo di ap-
partenenti al movimento ha attaccato l’Ambasciata statunitense di
Tunisi, provocando, negli scontri che sono seguiti con le Forze di
sicurezza, la morte di quattro persone. Questo episodio ha segnato
due importanti novità per il movimento: prima di tutto, per la pri-
ma volta, Ast si è resa protagonista di veri e propri scontri con le
Forze di sicurezza tunisine; in secondo luogo ha preso di mira un
obiettivo occidentale. La conseguenza diretta degli scontri, invece,
è stata la fuga del leader Abu ‘Ayyadh, da quel momento divenuto
uno degli uomini più ricercati di tutta la Tunisia, e un primo giro
di vite del governo alle attività del movimento.
La situazione si è fatta più tesa con i due omicidi politici di
esponenti dell’opposizione Chokri Beklaid e Muhammad Brahmi
rispettivamente nel febbraio e nel luglio 2013, la cui responsabilità
– sebbene gli omicidi non fossero stati rivendicati – fu fatta ricade-
re su Ast. Infine, nel 2013 hanno cominciato a verificarsi i primi
episodi di terrorismo di matrice jihadista contro le forze
dell’ordine tunisine, soprattutto membri dell’esercito e della Guar-
dia Nazionale, quasi esclusivamente nell’area dello Jebel Chaam-
bi, al confine con l’Algeria. I due fenomeni, sia quello della radi-
calizzazione di centinaia di ragazzi tunisini che decidono di partire
per combattere il jihad in Iraq e Siria, sia quello della comparsa
del jihadismo direttamente all’interno del territorio tunisino, non
sono da leggere come due fenomeni automaticamente collegati. È
in questo discorso che s’inserisce anche l’analisi della natura e
della provenienza dei gruppi jihadisti che attualmente operano in
Tunisia. Sebbene inizialmente le autorità tunisine e i media main-
stream avessero additato Ast come responsabile degli attacchi
condotti nello Jebel Chaambi, tale versione non sembrava essere
suffragata da sufficienti prove. Al contrario, secondo la ricostru-
zione dei fatti e l’analisi di fonti di intelligence algerine, sembrava
prendere piede l’ipotesi che dietro gli attentati in Tunisia non vi
66 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
fossero elementi afferenti al jihadismo autoctono – e Ast è un mo-
vimento salafita tunisino –, quanto piuttosto che esistessero delle
connessioni con ambienti jihadisti algerini. Nello specifico, diver-
se fonti sembravano giungere alla conclusione che l’apparizione
del jihadismo in Tunisia fosse il risultato di un tentativo di Aqim
di espandere il proprio raggio d’azione non soltanto sulla direttrice
saheliana, come già visto, ma anche verso Est, proprio attraverso
la Tunisia.
La pista algerina e l’infiltrazione di Aqim in Tunisia
Più di una volta i servizi d’intelligence algerini avrebbero allertato
il governo tunisino dei tentativi d’infiltrazione di alcuni guerriglie-
ri riconducibili ad Aqim, dall’Algeria fin dentro la stessa Tunisia.
Dal 2013 in poi si sono registrati diversi attacchi, di cui molti pro-
prio nell’area montuosa dello Jebel Chaambi, al confine con
l’Algeria, fino all’attentato di Tunisi del marzo 201510
:
Data Luogo Tipo di attacco Vittime
6 giugno 2013 Jebel Chaambi Ordigno
improvvisato 2 soldati
29 luglio 2013 Jebel Chaambi Attacco armato 8 soldati
4 agosto 2013 Jebel Chaambi Ordigno
improvvisato 2 soldati
17 ottobre 2013 Goubellat Attacco armato 2 guardie nazionali
23 ottobre 2013 Sidi Ali Ben
Aoun Attacco armato
6 soldati; 1 poliziotto
23 ottobre 2013 Menzel
Bourguiba Attacco armato 1 poliziotto
2 dicembre 2013 Jebel Chaambi Ordigno
improvvisato 1 soldato
3 febbraio 2014 Raoued (Tunisi) Scontro a fuoco 1 guardia nazionale
10 Nella tabella sono riportati soltanto gli attacchi che hanno provocato delle vittime. Oltre a quelli qui riportati, ve ne sono stati altri che non hanno causato vittime.
L’ascesa del jihadismo in Algeria e Tunisia: gli interessi italiani 67
16 febbraio 2014 Ouled Manaa Finto posto di blocco
4 guardie nazionali
18 aprile 2014 Jebel Chaambi Attacco armato 1 soldato
23 maggio 2014 Jebel Chaambi Attacco armato 1 soldato
16 luglio 2014 Jebel Chaambi Attacco armato 14 soldati
5 novembre 2014
Kef Attacco armato 5 soldati
1° dicembre 2014
Kef Attacco armato 1 guardia nazionale
18 febbraio 2015 Boulaabad Attacco armato 4 soldati
18 marzo 2015 Tunisi
(Museo Bardo) Attacco armato 24 vittime
23 marzo 2015 Kef Ordigno
improvvisato 1 soldato
A parte la contiguità geografica tra i due paesi, che renderebbe
plausibile l’ipotesi che dietro gli attacchi contro le Forze di sicu-
rezza tunisine possano esservi soggetti algerini, tale ipotesi è stata
avvalorata da alcuni elementi, in particolare:
la presenza stessa di jihadisti di nazionalità algerina nei terri-
tori in cui sono stati effettuati attacchi, riscontrata dopo
l’arresto, o l’uccisione, di alcuni di loro;
lo stile di alcuni attacchi, effettuati con tattiche molto simili a
quelle utilizzate da jihadisti algerini durante la guerra civile
degli anni Novanta; incluso l’utilizzo di uniformi rubate e finti
posti di blocco, tattica privilegiata dai jihadisti algerini.
In effetti, così come le accuse contro Ast di essere responsabile
degli attentati e degli assassinii politici avvenuti in Tunisia non
erano inizialmente corroborate da prove certe, la presenza di alge-
rini nei commandi che operavano nello Jebel Chaambi era invece
una costante. Ad esempio, la cellula che ha organizzato l’attacco
del 29 luglio 2013 sarebbe stata guidata da Kamal Ben Arbiya, ji-
hadista algerino arrestato proprio due giorni prima dell’attacco (il
68 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
che farebbe ipotizzare lo stesso attentato come una risposta
all’arresto di Ben Arbiya). Secondo altre fonti, lo stesso attentato
del luglio 2013 sarebbe stato orchestrato da Abu ‘Abd al-Rahman,
un jihadista algerino appartenente alla rete di Aqim e in contatto
diretto con ‘Abd al-Malik Droukdel. Allo stesso modo, secondo
l’intelligence algerina, soltanto nella prima metà del 2013 vi sa-
rebbero stati più di 80 tentativi d’infiltrazione in Algeria dal terri-
torio tunisino, un chiaro segnale della relazione tra gruppi algerini
e tunisini. Infine, nel giugno 2014, per la prima volta, Aqim stessa
ha rivendicato direttamente un attacco avvenuto in Tunisia, speci-
ficamente quello contro l’abitazione dell’allora ministro degli In-
terni, Lotfi Ben Jeddou, che aveva provocato la morte di quattro
poliziotti il 27 maggio del 2014 a Kasserine.
La Brigata ‘Uqba ibn Nafi‘: il jihad spaccato?
Nel corso del 2014, è divenuto chiaro che in Tunisia non agissero
soltanto jihadisti infiltrati dall’Algeria, ma che si stesse realizzan-
do la radicalizzazione di elementi interni. Se non è chiaro quanto i
singoli jihadisti tunisini – che da un lato, come già visto, diventa-
no dei foreign fighters, ma dall’altro, in misura minore, si unisco-
no ai gruppi jihadisti che già operano nel paese – possano essere
direttamente ricollegati ad Ast o meno, ciò che sembra assodato è
invece la nascita di un nuovo gruppo, la Brigata ‘Uqba ibn Nafi‘.
La natura più prettamente tunisina di questo gruppo, rispetto alle
cellule legate ad Aqim, con cui almeno inizialmente ‘Uqba ibn
Nafi‘ sembrava avere contatti, è evidenziata dal nome stesso del
movimento. ‘Uqba ibn Nafi‘, infatti, era il generale arabo che nel
VII secolo aveva conquistato l’Africa del Nord, tra cui l’attuale
Tunisia, islamizzandola e arabizzandola, e il fondatore della città
santa di Kairouan, in cui ancora oggi sorge la moschea a lui dedi-
cata. Le fonti sul gruppo jihadista sono poche, ma già dal dicem-
bre del 2012 questo nome aveva cominciato a circolare e l’allora
ministro degli Interni Ali Laarayedh aveva individuato il gruppo
come responsabile degli attacchi sullo Jebel Chaambi, dichiarando
L’ascesa del jihadismo in Algeria e Tunisia: gli interessi italiani 69
che avesse legami con Aqim11
. Nel settembre 2014, però, il grup-
po ha ufficialmente ammesso la propria affiliazione allo Stato
Islamico (IS) e al califfato di Abu Bakr al-Baghdadi, riproducendo
anche in Tunisia le dinamiche di divisione interna alla galassia ji-
hadista che si sono verificate sia a livello globale tra al-Qaida e IS,
sia in altri contesti locali12
. I collegamenti tra IS e ‘Uqba ibn Na-
fi‘ sono sembrati evidenti anche dall’analisi di alcuni episodi av-
venuti nella seconda metà del 2014 e, a differenza di altre “dichia-
razioni di sottomissione” (bay‘a, in lingua araba e nella termino-
logia storica del califfato) di gruppi come Boko Haram, sembrano
esservi dei legami diretti tra il califfato e il movimento jihadista
tunisino. Da un lato, vi sono le prove del fatto che diversi tunisini
si siano arruolati nelle fila di IS, dall’altro un jihadista tunisino,
Abu Bakr al-Hakim, ha postato in rete nel dicembre 2014 un video
girato in Iraq in cui – da membro d’IS – rivendica per la prima
volta l’uccisione di Chokri Belaid e Muhammad Brahmi, minac-
ciando la Tunisia stessa. Osservando, inoltre, il trend di attentati e
uccisioni nel paese, proprio come accaduto in Algeria con il caso
dell’ostaggio francese Hervé Gourdel, si nota una recrudescenza
nella violenza che richiama le azioni di IS, come confermato dalla
decapitazione di un membro della Guardia Nazionale, avvenuta il
1° dicembre 2014. Infine, va comunque sottolineato che, sebbene i
jihadisti della brigata ‘Uqba ibn Nafi‘ sarebbero in gran parte di
origine autoctona tunisina, a coordinare le loro azioni vi sarebbe
un jihadista algerino, Lokman Abu Sakhr. Questo elemento, che
dimostra come i movimenti jihadisti in Nord Africa (con riferi-
mento anche alla Libia) siano sempre più connessi tra di loro, met-
te in evidenza come sia necessario, per poter contrastare le attività
terroristiche, un coordinamento anche da parte dei governi degli
stessi paesi interessati.
11 “Une cellule d’Al Qaïda démantelée en Tunisie: 16 terroristes arrêtés et 18 recher-chés”, Leaders, 21 dicembre 2012. 12 “Tunisie: Kabibat Okba Ibn Nafaa, pro-Aqmi, aurait déclaré son soutien à l’Etat islamique”, Webdo.tn, 20 settembre 2014.
70 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Quali minacce dirette per l’Italia?
Alla luce del quadro appena delineato, è lecito chiedersi quali sia-
no – se vi sono – i fattori di minaccia per la sicurezza dell’Italia e
come dovrebbe agire il governo di Roma nei confronti di tali sce-
nari. Per ciò che concerne gli aspetti che riguardano in maniera di-
retta la sicurezza italiana, la presenza di elementi e gruppi jihadisti
in Tunisia sembra essere più preoccupante rispetto al contesto al-
gerino. Tale considerazione avviene alla luce di diversi fattori:
la vicinanza geografica della Tunisia ai confini italiani;
la tendenza dei jihadisti tunisini a espandere le proprie reti del
network jihadista al di fuori dei confini della Tunisia;
la relativa inesperienza delle autorità e delle forze di sicurezza
tunisine ad affrontare la minaccia jihadista;
la storica presenza di elementi di nazionalità tunisina in Italia
e la precedente attività di network di jihadisti tunisini
all’interno del territorio italiano;
la maggiore esposizione di persone di nazionalità italiana in
Tunisia.
Ancora prima degli attentati dell’11 settembre 2001 a New
York e Washington, nel corso delle indagini della magistratura ita-
liana era emersa la connessione tra una cellula qaidista composta
da elementi tunisini e la rete del jihadismo europeo. Uno dei lea-
der della cellula appartenente a un gruppo terrorista chiamato
Gruppo Combattente Tunisino (Gct), Sami bin Khamis bin Salih
Essid, sarebbe stato un punto di connessione tra la stessa leader-
ship di al-Qaida e un gruppo di tunisini che pianificava un attenta-
to all’Ambasciata statunitense di Roma. A sua volta, Essid sarebbe
stato in contatto con un altro tunisino con cittadinanza belga, Ta-
rek Maaroufi, accusato di essere uno dei leader della rete qaidista
in Europa e di avere avuto rapporti con lo stesso bin Laden13
. A
distanza di anni, dopo la caduta di Ben ‘Ali, entrambi sono tornati
liberi in Tunisia e hanno stretto contatti con Abu ‘Ayyadh, fonda-
13 “Maaroufi, latitante in fuga perché il Belgio non collabora”, Il Corriere della Sera, 14 dicembre 2001.
L’ascesa del jihadismo in Algeria e Tunisia: gli interessi italiani 71
tore di Ansar al-Shari‘a in Tunisia ed ex leader dello stesso Gct. A
maggio del 2002, inoltre, il tribunale di Milano aveva condannato
tre tunisini che avevano avuto rapporti con Essid per attività terro-
ristiche. Sebbene tali rapporti non provino l’attuale esistenza di
una rete di jihadisti che porta in Italia, le connessioni tra i jihadisti
tunisini ed eventuali contatti in Italia non risultano improbabili.
Tra le nove persone espulse dall’Italia a gennaio 2015, dopo gli
attentati di Parigi contro la sede del giornale satirico Charlie Heb-
do, ad esempio, ben cinque erano di nazionalità tunisina. Esten-
dendo il raggio di analisi, anche uno degli stessi attentatori di Pa-
rigi, Chérif Kouachi, era stato in contatto con il già menzionato
Abu Bakr al-Hakim, jihadista tunisino ora presumibilmente in
Iraq.
La comunità tunisina in Italia è una delle più numerose, con più
di 122.000 persone regolarmente registrate, secondo i dati Istat del
2014, mentre i cittadini algerini sono poco meno di 30.000. Ov-
viamente, ciò non si traduce automaticamente in una minaccia di-
retta all’Italia, ma allo stesso tempo la presenza di una cospicua
comunità tunisina rende potenzialmente l’Italia (dopo la Francia, il
secondo paese per presenza di tunisini all’estero) un obiettivo più
facilmente raggiungibile da eventuali foreign fighters tunisini (il
cui numero è di per sé molto alto) che volessero esportare il jihad
in Europa. Allo stesso tempo, qualora i gruppi jihadisti tunisini
pianificassero attacchi contro obiettivi occidentali in Tunisia, il
settore turistico potrebbe essere uno dei più esposti, come dimo-
strato dall’attacco suicida compiuto nell’ottobre 2013 in un resort
di Sousse e il più recente attentato al Museo del Bardo. Anche in
questo caso, la presenza di italiani è abbastanza significativa: se-
condo i dati Istat, infatti, la Tunisia è la seconda meta turistica de-
gli italiani al di fuori dell’Unione Europea, dietro gli Stati Uniti. In
termini numerici, ciò si traduce in più di 560.000 italiani che nel
2013 si sono recati in Tunisia. Di fronte a tali cifre e alle dinami-
che di radicalizzazione presenti in Tunisia, è lecito che l’Italia as-
suma tutte le precauzioni necessarie per controllare il flusso
d’informazioni e persone e che agisca in cooperazione con le isti-
tuzioni tunisine per prevenire e affrontare la minaccia jihadista in
72 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Tunisia. Anche alla luce delle carenze strutturali delle Forze di si-
curezza tunisine di fronte a una minaccia che negli anni passati
non si era mai manifestata con tale enfasi, è interesse dei governi
europei e dello stesso governo italiano assistere la Tunisia, for-
nendole mezzi e know-how per far fronte alla minaccia terroristica.
In questo quadro, rientra anche la cooperazione con l’Algeria, la
quale ha peraltro avviato programmi congiunti con Tunisi in mate-
ria di anti-terrorismo.
Infine, non si può trascurare la connessione sempre più eviden-
te tra elementi afferenti a gruppi jihadisti tunisini e i movimenti
jihadisti in Libia. Molti tunisini avrebbero trovato rifugio in Libia,
come dimostrato dall’attacco all’hotel Corinthia di Tripoli avvenu-
to il 28 gennaio 2015, perpetrato da due affiliati allo Stato Islami-
co in Libia, di cui uno, Abu Ibrahim al-Tunisi, di nazionalità tuni-
sina. Sempre per ciò che concerne il passaggio dalla Tunisia alla
Libia, inoltre, la questione dei flussi migratori rimane da tenere
sotto osservazione. Sebbene non vi siano evidenze della correla-
zione tra i flussi migratori provenienti dalla Libia verso l’Italia e la
minaccia terroristica, l’opzione di possibili infiltrazioni non è del
L’ascesa del jihadismo in Algeria e Tunisia: gli interessi italiani 73
tutto da escludere. In quest’ottica, occorre prestare attenzione alle
indicazioni fornite dall’agenzia dell’Unione Europea Frontex, se-
condo la quale il flusso di profughi che dalla Siria arriva in Europa
segue soprattutto la rotta che, via aerea, porta dalla Turchia
all’Algeria, per poi proseguire via terra verso la Libia, transitando
anche per la Tunisia. Qualora i gruppi jihadisti che operano in Li-
bia intendessero realmente sfruttare il traffico di migranti per lu-
crare, le aree orientali e meridionali dell’Algeria e della Tunisia
potrebbero risultare strategiche.
Per ciò che concerne l’Algeria, a differenza della Tunisia, le
possibili minacce per l’Italia derivanti dall’espansione di gruppi
jihadisti sono sostanzialmente di carattere geo-economico. Soprat-
tutto in un momento in cui l’approvvigionamento energetico ita-
liano ha già sperimentato una carenza al riguardo dalla Libia e ha
nella Russia un fattore di potenziale incertezza, l’Algeria è un
partner fondamentale per gli interessi italiani ed europei in genera-
le. D’altro canto, l’esercito algerino, con le sue forze anti-
terrorismo, è probabilmente il più efficace tra tutti quelli dell’area
nordafricana in termini di lotta al jihadismo. Se da un lato tale
considerazione rende la minaccia potenzialmente meno grave,
dall’altro la nascita di nuovi gruppi legati allo Stato Islamico e i
tentativi di Aqim d’infiltrarsi in Tunisia fanno intendere quanto la
situazione algerina sia ancora delicata. Ciò risulta ancora più vero
alla luce dell’incertezza circa la successione a Bouteflika, la cui
scomparsa dalla scena pubblica rischierebbe di creare un nuovo
clima d’instabilità di cui le forze jihadiste potrebbero cercare di
approfittare.
Conclusioni
Nel quadro della lotta al terrorismo e del contrasto alla radicaliz-
zazione e alla presenza di nuovi gruppi di estrazione jihadista, il
contesto nordafricano è quello che riguarda in maniera più diretta
l’interesse strategico italiano. Sebbene la Libia costituisca la fonte
di minaccia maggiore, l’Algeria e soprattutto la Tunisia non pos-
sono essere trascurate. Ciò è vero alla luce di due fattori: che tali
74 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
contesti sono legati allo stesso scenario libico e in parte lo influen-
zano; sia la Tunisia, sia l’Algeria, sperimentano dinamiche di tipo
politico, sociale, economico e di sicurezza che si ricollegano diret-
tamente agli interessi italiani. La presenza di gruppi jihadisti in
Algeria e l’adozione di nuove tattiche volte a colpire il settore de-
gli idrocarburi nel paese, ad esempio, innescano minacce che ri-
guardano direttamente l’Europa del Sud e l’Italia stessa, mettendo
potenzialmente a rischio una delle nostre principali fonti di ap-
provvigionamento. D’altro canto il fatto che la Tunisia, le cui co-
ste si trovano a poche decine di chilometri da quelle italiane, sia il
paese più interessato al mondo dal fenomeno dei cosiddetti foreign
fighters e dalle dinamiche di radicalizzazione e, contestualmente,
che vi sia uno storico legame tra la comunità tunisina all’estero e il
territorio italiano, costituisce un motivo ulteriore di allerta per la
nostra sicurezza. Non si possono, infine, trascurare i legami del
jihadismo nordafricano con quello della fascia del Sahel, dai quali
i gruppi operanti in Nord Africa potrebbero trarre beneficio. Per
contrastare tali sviluppi, alcuni governi europei – in primis la
Francia – e gli Stati Uniti si sono già attivati14
.
Nel caso dell’Algeria e della Tunisia, il fatto che non si tratti di
stati falliti o semi-falliti (come nel caso della Libia), né di territori
a scarso controllo da parte dell’autorità centrale (come accade nei
paesi del Sahel), rende i movimenti e i singoli jihadisti presenti in
quelle aree potenzialmente più pericolosi per i teatri esterni. Non è
un caso che la Tunisia fornisca un altissimo numero di foreign
fighters, dal momento che gli elementi radicalizzati in loco non
hanno spesso la possibilità di mettere in pratica il jihad in casa
propria. Come conseguenza, vi è la tendenza a cercare altri teatri
di operazione e questo fattore, contestualmente alla forte impronta
anti-occidentale dell’ideologia jihadista propria di IS e dei suoi
gruppi affiliati, può costituire un innesco per tentare d’infiltrare
l’Occidente. Per tali motivazioni, occorre un costante monitorag-
gio delle azioni che avvengono oltre il Mediterraneo, per tentare
14 Si veda “How is DOD Responding to Emerging Security Challenges in Europe?”, testimonianza del sotto-segretario alla Difesa Christine Wormuth, U.S. Department of Defense House Armed Services Committee Hearing, 25 febbraio 2015.
L’ascesa del jihadismo in Algeria e Tunisia: gli interessi italiani 75
un’opera di prevenzione dell’espansione del jihadismo verso
l’Italia e l’Europa meridionale.
4. Non solo Sinai, l’estremismo di matrice islamica in Egitto
Wolfgang Pusztai
Il 29 gennaio 2015 un’ondata di attacchi coordinati con colpi di
mortaio, autobombe e armi da fuoco di piccolo calibro sono stati
compiuti in Egitto dal gruppo estremista islamico, Ansar Bayt al-
Maqdis. Gli attacchi hanno colpito diversi obiettivi nel nord del
Sinai – tra cui una base militare, una stazione di polizia, un hotel,
la sede di un giornale e alcuni checkpoint nei pressi di al-Arish,
Port Said e Suez – causando 29 morti e 58 feriti, sebbene fonti uf-
ficiose riportino dati più alti (74 feriti e la morte di 45 persone1).
L’estremismo islamico non è un fenomeno nuovo in Egitto: qui
hanno proliferato i gruppi islamici estremisti come Jihad Islamica
Egiziana e al-Gamaʻa al-Islamiyya – responsabili dell’assassinio
del presidente egiziano Anwar al-Sadat (1981) – e sempre nel pae-
se nordafricano è nato l’attuale leader di al-Qaida, Ayman al-
Zawahiri, il quale in gioventù (1965) entrò a far parte
dell’organizzazione dei Fratelli musulmani.
Recentemente, sembra che il fenomeno nel paese stia risorgen-
do.
Il quadro strategico e i fattori di rischio
La posizione di rilevanza geostrategica dell’Egitto, localizzato
nell’intersezione delle storiche rotte commerciali e delle moderne
1 “45 dead in Sinai and Ansar Bayt al-Maqdis takes responsibility” (in arabo), Al Jazeera, 30 gennaio 2015, http://goo.gl/wt15Ht.
78 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
linee di comunicazione, la vicinanza a Israele e il ruolo giocato nel
processo di pace mediorientale assicurano al paese costante atten-
zione da parte delle grandi potenze. L’Egitto, grazie al canale di
Suez, che con i suoi 167 km di lunghezza fornisce la via più breve
alle navi che viaggiano dal Golfo Persico e dall’Asia meridionale
verso l’Europa, si trova al centro delle più importanti rotte com-
merciali del mondo. Solo nel 2014 il Canale è stato, infatti, attra-
versato da 16.744 navi per un carico totale di 784.191.000 tonnel-
late2.
Dal punto di vista ambientale, la più grave minaccia, non solo
per la qualità della vita della popolazione egiziana ma anche per
l’intera economia del paese, è rappresentata dal degrado ambienta-
le, provocato dalla riduzione delle terre destinate all’agricoltura,
dall’inquinamento da idrocarburi, che mette in serio pericolo
l’ecosistema marino, dall’inquinamento delle falde acquifere, cau-
sato dall’uso di pesticidi agricoli, dai liquami e dagli scarichi indu-
striali. Le emissioni di quasi cinque milioni di macchine che attra-
versano ogni giorno le strade del Cairo, la combustione dei rifiuti
e i gas inquinanti delle attività industriali contribuiscono a rendere
la capitale egiziana una delle città più inquinate del pianeta.
Dal punto di vista energetico, il paese possiede riserve di petro-
lio accertate per 4,4 miliardi di barili (contro i 50 miliardi della
Libia) e nel 2013 ha esportato circa 189.000 metri cubi di greggio
al giorno. Nonostante l’Egitto vanti il più grande settore della raf-
finazione in Africa, dal 2011 la produzione nazionale è scesa al di
sotto dei consumi e per soddisfare la propria domanda interna si è
resa necessaria l’importazione. Con 77 miliardi di metri cubi di
riserve di gas naturale accertate, l’Egitto gode della quarta mag-
giore riserva dell’Africa e nuovi giacimenti vengono scoperti ogni
anno3. Così come per il petrolio, gran parte del gas estratto viene
utilizzato per il consumo interno, in particolare per alimentare le
centrali elettriche, l’aumento della domanda interna ha comporta-
2 Suez Canal Authority, Brief Fiscal Year Statistical Report, http://www.suezcanal.gov.eg/TRstat.aspx?reportId=9. 3 U.S. Energy Information Administration, “Country Analysis Brief: Egypt”, 14 ago-sto 2014, http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Egypt/egypt.pdf.
Non solo Sinai, l’estremismo di matrice islamica in Egitto 79
to, a partire dal 2010, un calo delle esportazioni. Poiché l’Egitto ha
stabilito prezzi molto bassi che vengono pagati alle compagnie
straniere per l’abbattimento, possibili nuovi progetti
d’investimento risultano commercialmente poco attrattivi.
Dal punto di vista economico, la principale fonte di valuta este-
ra del paese proviene dal Canale di Suez, che solo nel 2014 ha
portato nelle casse dell’Egitto 5,5 miliardi di dollari4. La costru-
zione attualmente in atto di un canale parallelo e l’allargamento di
quello esistente, ne aumenteranno la capacità per consentire la na-
vigazione a doppio senso di un tratto più lungo, portando in questo
modo a un aumento degli introiti di circa 9 miliardi di dollari
l’anno, nel corso dei prossimi dieci anni. Un’altra importante fonte
di riserva estera è rappresentata dal turismo, un settore che, nel
momento in cui la situazione politica dovesse stabilizzarsi, potreb-
be presentare grandi prospettive di crescita. Una componente vita-
le dell’economia del paese è sempre stata rappresentata
dall’agricoltura, settore che impiega la quota più cospicua di forza
lavoro egiziana (quasi il 30 per cento). Tuttavia, a causa della ra-
pida crescita della popolazione e della riduzione dei terreni agrico-
li, l’Egitto ha perduto la propria autosufficienza alimentare.
Le infrastrutture sono ben sviluppate rispetto ai paesi limitrofi,
ma il settore soffre di una mancanza cronica di investimenti. Gli
incidenti ferroviari sono frequenti e la mancanza di manutenzione
ai sistemi idrici ha gravi ripercussioni sulla qualità dell’acqua po-
tabile. L’inadeguatezza dei generatori di corrente elettrica, che so-
prattutto durante i mesi estivi si traduce in numerosi black-out, ha
contribuito negativamente da un lato alla contrazione della produ-
zione industriale e dall’altro al crescente malcontento nei confronti
delle autorità. A febbraio del 2015, durante la visita del presidente
russo Vladimir Putin, al Cairo è stato firmato un progetto per lo
4 M. Georgy, “Suez Canal revenues forecast to hit record $5.5 bln this year”, Reuters, 20 marzo 2014, http://in.reuters.com/article/2014/03/20/egypt-canal-idINL6N0MH4T720140320.
80 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
sviluppo di una centrale nucleare con un impianto di desalinizza-
zione che dovrebbe migliorare significativamente la situazione5.
Mentre, durante l’amministrazione Morsi, il Qatar è stato
l’unico paese del Consiglio di Cooperazione del Golfo a sostenere
l’Egitto, al momento Il Cairo è quasi interamente dipendente dagli
aiuti provenienti da Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uni-
ti. Questi stati, allarmati dall’ascesa dei Fratelli musulmani, stanno
aiutando il governo egiziano a mantenere i sussidi alimentari ed
energetici fino a che il ripristino della fiducia degli investitori e i
conseguenti finanziamenti esteri possano far ritrovare al paese una
certa indipendenza finanziaria.
Circa il 40 per cento delle esportazioni egiziane è diretto
all’Unione Europea e, se si considerano i 28 singolarmente, l’Italia
rappresenta la principale destinazione (6,7 per cento nel 2013).
Nel 2014 il Pil è cresciuto del 3 per cento, più lentamente ri-
spetto al 5,2 del 20106, ma nel medio termine si stima che il tasso
di crescita economica torni ad aumentare, grazie anche allo stimo-
lo che l’attività economica dovrebbe ricevere attraverso l’avvio di
grandi progetti infrastrutturali. Nonostante ciò, è improbabile che
l’Egitto sarà in grado di affrontare autonomamente tutti i problemi
economici in tempi brevi.
Dal punto di vista demografico, è prevista una crescita allar-
mante della popolazione (98 per cento arabi egiziani) che, secondo
le stime raggiungerà i 95,6 milioni entro 2026, rappresenta il mag-
gior aumento tra le regioni più povere. Il 49,9 per cento della po-
polazione è di età inferiore ai 25 anni e il tasso di disoccupazione
ha raggiunto il 13,4 per cento7. Le divisioni sociali e culturali sono
acuite dall’aumento della disuguaglianza nella ricchezza in una
società in cui, le élite liberali e occidentalizzate si trovano ad af-
frontare la maggioranza della società egiziana religiosamente più
conservatrice, che non si è ancora appropriata della propria fetta di
ricchezza del paese.
5 “Egypt, Russian Federation: Egypt, Russia to Collaborate for Nuclear Power Plant Project”, MENA, 13 febbraio 2015. 6 “Egypt 2014”, Oxford Analytica Ltd, Oxford, 17 settembre 2014. 7 Central Intelligence Agency, CIA Factbook, Egypt, 2014.
Non solo Sinai, l’estremismo di matrice islamica in Egitto 81
Dal punto di vista religioso, la popolazione egiziana appartiene
in prevalenza alla corrente sunnita dell’islam, mentre si conta solo
una risicata minoranza sciita nell’area del delta del Nilo. Non solo
al Cairo ha sede l’Università di al-Azhar, centro principale della
letteratura araba e cultura islamica nel mondo, ma nel paese vi so-
no rappresentate tre delle quattro principali scuole giuridiche sun-
nite (Hanafi nel delta del Nilo, nel deserto occidentale e nel nord
del Sinai; Shafi’i nella valle del Nilo, nel deserto orientale e nel
Sinai meridionale; Maliki nel sud). La tradizione mistica interna
all’islam del sufismo è molto popolare in Egitto tanto da contare
tra i 6 e i 15 milioni di seguaci. Inoltre, sta diventando sempre più
importante il movimento salafita, che al contrario considera le pra-
tiche sufi “non islamiche”.
Sebbene la popolazione sia prevalentemente musulmana, esiste
anche un’importante minoranza cristiana copta a cui appartiene il
6-15 per cento della popolazione, di cui la maggioranza fa parte
dell’antica chiesa ortodossa copta, la più grande comunità cristiana
nel mondo arabo. La tutela della comunità copta in Egitto ha rap-
presentato una questione di bassa priorità sia per Mubarak sia per
Morsi e, dal momento che la Costituzione del 2012 non è riuscita a
proteggerne adeguatamente i diritti e la libertà religiosa, essa ha
fortemente sostenuto la destituzione del presidente Morsi. Come
conseguenza, si è registrato un aumento del numero di attacchi ri-
volti contro chiese, abitazioni e attività commerciali.
Nonostante i rispettivi leader religiosi tendano a negare, esisto-
no divisioni significative tra cristiani e musulmani, in particolar
modo con il movimento salafita, che possono sfociare in atti di
violenza innescati da questioni riguardanti conversioni forzate,
stupri imputati e dispute sulla terra.
Dal punto di vista della sicurezza, una delle principali questioni
che destano preoccupazione è la guerra civile in corso in Libia,
poiché il territorio confinante viene utilizzato sia per
l’addestramento dei terroristi sia come base da cui far partire gli
attacchi. Inoltre, il contrabbando di armi e la riuscita infiltrazione
di jihadisti oltre il confine libico potrebbero contribuire in maniera
significativa alla destabilizzazione del paese. Per tale ragione, è
82 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
intenzione dell’Egitto nel prossimo futuro impedire la creazione di
uno Stato Islamico fondamentalista lungo il confine occidentale,
garantendo il proprio sostegno alla coalizione anti-islamista del
governo riconosciuto a livello internazionale, a prescindere da chi
ne sarà alla guida. Infine, l’esercito egiziano potrebbe in ultima
istanza intervenire direttamente entro i confini libici.
A livello interno, le Forze armate egiziane sono intervenute per
ben due volte negli ultimi anni: nel febbraio 2011, per rimuovere
Mubarak, dopo averne ritirato l’appoggio, e, nel luglio 2013, per
sospendere la costituzione e deporre il presidente Morsi. Ufficial-
mente le Forze armate in Egitto non sembrano interessate ad as-
sumere il potere su base permanente, ma si considerano il princi-
pale garante della sicurezza nazionale e arbitro di ultima istanza a
livello politico. Per questo motivo, sono intervenute nel maggio-
giugno 2012 e nel maggio 2014 con l’obiettivo di agevolare lo
svolgimento delle elezioni presidenziali democratiche.
Sebbene agli islamisti o ai sospetti islamisti sia vietato servire
nelle Forze armate, poiché è stato applicato un regime di tolleran-
za zero, peraltro non accolto favorevolmente da tutti i coscritti, si
può presumere che ci siano migliaia di soldati, in particolare pro-
venienti dalle aree rurali, con un background religioso di stampo
conservatore. Inoltre, dalla deposizione di Morsi, tutti i coscritti
identificati come “simpatizzanti” sono stati estromessi
dall’esercito.
L’Egitto possiede il comparto della difesa più grande del mon-
do arabo e questo è interamente sotto il controllo militare. Oltre
alle attività puramente militari, l’esercito gestisce diverse aziende
che spaziano dalla produzione agricola, alla costruzione,
all’immobiliare e vari settori industriali che a differenza delle im-
prese civili sono esenti da alcune tasse governative.
Dal quadro strategico precedentemente delineato, è quindi pos-
sibile identificare tre fattori di rischio:
Con le prossime elezioni politiche potrebbero innescarsi foco-
lai di protesta, in particolare nelle aree in cui è ancora forte il
sostegno verso i Fratelli musulmani. Una strategia di successo
per ridurre al minimo l’escalation di violenze e gli eventuali
Non solo Sinai, l’estremismo di matrice islamica in Egitto 83
danni alle proprietà sarà probabilmente garantita da una mas-
siccia presenza delle Forze di sicurezza.
Sebbene l’insurrezione islamista rappresenti una crescente
fonte di minaccia, non saranno sufficienti i soli atti terroristici
a destabilizzare l’intero paese. Il pericolo principale del terro-
rismo è se questo dovesse essere rivolto oltre che contro le
Forze di sicurezza, anche contro le infrastrutture, le attività
economiche e gli obiettivi civili. Un altro fattore d’instabilità
potrebbe essere rappresentato dalla diffusione del fenomeno
terroristico al di fuori del Sinai e più precisamente verso la
valle del fiume Nilo, acuendo le difficoltà economiche in cui
già versa il paese.
La principale minaccia per la stabilità del paese è rappresenta-
ta dal malcontento socio-economico. Qualora le riforme venis-
sero mal gestite, l’aumento della disoccupazione, la riduzione
dei sussidi, l’aumento dei prezzi, la scarsità di energia e più in
generale la delusione delle aspettative economiche e politiche
della popolazione potrebbero sfociare in disordini destabiliz-
zanti.
Analisi dei gruppi islamisti
I Fratelli musulmani (MB, al-Ikhwan al-Muslimun) costituiscono
attualmente il movimento islamista più influente. Nato in Egitto
nel 1928 come movimento anti-coloniale diretto contro
l’imperialismo e contro la costituzione dello stato d’Israele, si è in
seguito diffuso in diversi altri paesi della regione. L’ideologia del
movimento, che segue un programma pan-islamico, politico e so-
ciale ben diverso da quello salafita, ha ispirato molti partiti islami-
ci e organizzazioni terroristiche tra cui Hamas e al-Qaida. In molti
paesi, invece, i Fratelli musulmani sono stati dominati dalla classe
media e la maggior parte di essi ha adottato una politica di riforme
non violenta.
Dopo che Mohamed Morsi è stato estromesso dal potere, i Fra-
telli musulmani in Egitto sono stati considerati un’organizzazione
terroristica e sono stati ufficialmente messi al bando: le attività
84 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
delle organizzazioni a questi affiliate sono state congelate e molti
dei membri, tra cui la leadership, sono stati imprigionati.
Il ramo egiziano dei Fratelli musulmani conta tra 100.000 e
600.000 membri8 e ciò li rende il più grande gruppo politico in
Egitto. Nonostante non rappresenti una posizione maggioritaria
dell’Islam, la forza del gruppo, determinata dalla fedeltà dei suoi
membri e dalla potenza organizzativa, rende i Fratelli musulmani
la principale opposizione politica al governo del presidente al-Sisi.
In futuro i sostenitori dei Fratelli musulmani potrebbero cercare di
sfruttare a proprio vantaggio un eventuale aumento del malconten-
to popolare.
Ayman al-Zawahiri ha assunto il ruolo di capo di al-Qaida
(AQ) nel maggio 2011 durante uno dei periodi di cambiamento
più significativi nel mondo arabo. Durante la “Primavera araba”,
che ha fornito un’occasione non sufficientemente sfruttata da AQ,
al-Zawahiri ha rilasciato più di una dozzina di messaggi diretta-
mente indirizzati alle rivolte, tra cui lodi ed elogi per gli attacchi
ripetuti contro il gasdotto nel Sinai, Arab Gas Pipeline. Questa
particolare attenzione rivolta da al-Zawahiri verso il proprio paese
d’origine dipende dal fatto che il leader di al-Qaida ritiene il futuro
dell’Egitto fondamentale per il destino di tutto il mondo musul-
mano.
Esistono numerosi gruppi estremisti islamici attualmente attivi
in Egitto, ma poiché la maggior parte degli attacchi non viene re-
clamata, è difficile stabilire l’effettiva pericolosità di ciascuno di
essi. La criminalizzazione dei Fratelli musulmani ha spinto i suoi
membri nell’ombra e li ha avvicinati ai gruppi militanti. È proba-
bile che alcuni di questi gruppi si siano uniti in una lotta armata
contro il governo, conducendo atti di violenza contro le Forze di
sicurezza come risposta alla repressione delle proteste pubbliche.
Nella zona del Sinai molti estremisti hanno cercato di unirsi al-
le tribù beduine, che da sempre hanno un rapporto ambivalente
con il governo, generato dalla storica assenza dello stato nella re-
gione. In alcune occasioni, invece, i leader beduini più moderati
8 A oggi non esistono dati ufficiali circa il numero di affiliati nella confraternita dei Fratelli musulmani.
Non solo Sinai, l’estremismo di matrice islamica in Egitto 85
sono stati attaccati e uccisi dai terroristi, che, durante e dopo le ri-
volte del 2011 e del 2013, hanno beneficiato del ritiro delle Forze
di sicurezza verso Il Cairo. Anche tra i beduini, comunque, è dif-
fusa la percezione che la reazione dello stato verso gli attacchi ter-
roristici avvenga in maniera casuale e con un uso eccessivo della
forza.
Jamaat Ansar al-Bayt Maqdis (Abm, Partigiani di Gerusalem-
me) ha annunciato “ufficialmente” la propria esistenza il 24 luglio
2012, rivendicando la responsabilità di 13 attacchi effettuati a par-
tire dal febbraio 2011 contro il gasdotto tra Egitto e Israele. La
campagna di Abm si è intensificata in seguito alla destituzione del
presidente Morsi (luglio 2013) e il gruppo in alcune occasioni ha
espresso la propria solidarietà verso i Fratelli musulmani per le
proteste contro il nuovo governo. Si pensa che i leader più rilevan-
ti di Abm siano Ahmed Salam Mabruk, un estremista islamico di
lunga data, che intrattiene legami con al-Qaida, e Abu Osama al-
Masri, che ha dichiarato fedeltà ad Abu Bakr al Baghdadi, il “ca-
liffo” dello Stato Islamico.
I Partigiani di Gerusalemme aderiscono a un’ideologia jihadi-
sta salafita, concentrando le proprie attività a livello locale. Se
l’obiettivo primario del gruppo è l’istituzione di uno stato islamico
fondamentalista in Egitto, nel lungo periodo questo ha posto come
suo target finale la conquista di Gerusalemme. Per tale ragione,
Abm non mostra alcun interesse a partecipare al processo politico.
Anzi, così come molti altri gruppi estremisti islamici, considera la
fine della presidenza Morsi la prova che il processo democratico
sia un fallimento, poiché qualsiasi processo che concede il potere
di fare le leggi senza far direttamente riferimento alla sharia non è
di per sé accettabile.
Abm non ha collegamenti diretti con altri stati, ma coordina le
proprie attività con alcuni gruppi attivi nella Striscia di Gaza, co-
me il Comitato di Resistenza Popolare e i Mujahidin Shura Coun-
cil in the Environs of Jerusalem, – altra organizzazione entrata
nell’orbita di IS – e molto probabilmente ha contatti con le sigle
jihadiste salafite in Libia.
86 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
A livello operativo, l’attenzione è concentrata nel Sinai centro-
settentrionale e lungo il confine con Israele, ma sono stati condotti
frequenti attacchi anche nella parte meridionale della penisola, nel
delta del Nilo, lungo il canale di Suez, al Cairo, nel distretto della
capitale e nella parte occidentale del paese vicino al confine libico.
Dal momento in cui le attività si sono diffuse in altre parti del pae-
se, affianco al nucleo del gruppo composto da membri di tribù be-
duine del Sinai, che attualmente conta fino a 1.000 membri, sono
stati reclutati anche egiziani non beduini.
Fin dall’inizio Abm ha condotto attacchi armati transfrontalieri
contro Israele, principalmente tramite razzi e in rare occasioni con
rapide incursioni terrestri. In Egitto, invece, i principali target sono
le forze di sicurezza, i funzionari governativi e vari obiettivi di na-
tura economica, in particolare oleodotti e gasdotti, diverse struttu-
re di approvvigionamento energetico e le infrastrutture del settore
turistico. A livello tattico, tali offensive vengono portate a termine
attraverso attacchi coordinati su larga scala, attentati suicidi, im-
boscate, omicidi e rapimenti utilizzando sia ordigni esplosivi a
tempo o con controllo remoto sia armi di piccolo calibro. Il gruppo
ha inoltre a propria disposizione un numero limitato di ManPads
(Man-Portable Air-Defense Systems – sistema missilistico antiae-
reo a corto raggio trasportabile a spalla), probabilmente giunti di
contrabbando oltreconfine dalla Libia.
L’origine dei finanziamenti del gruppo non è tuttora chiara,
sebbene sia evidente che una parte di essi derivi dal pagamento dei
riscatti.
A novembre del 2014 il gruppo ha giurato fedeltà allo Stato
Islamico e ciò dovrebbe contribuire a facilitare l’integrazione di
altri estremisti islamisti, a diffondere la violenza e ad aumentare
gli obiettivi futuri in modo tale da includere individui e risorse oc-
cidentali in linea con la strategia di IS. Per tale ragione, si prevede
un aumento degli attacchi al di fuori del Sinai e uno spostamento
dell’attenzione dalle Forze di sicurezza agli obiettivi di rilevanza
economica.
Pertanto Abm rappresenta e continuerà a rappresentare il grup-
po estremista più attivo e letale in Egitto.
Non solo Sinai, l’estremismo di matrice islamica in Egitto 87
A gennaio del 2012, il nuovo gruppo jihadista Ansar al-Jihad
(chiamato anche al-Qaida nella penisola del Sinai) guidato dall’ex
medico di Osama bin Laden, Ramzi Mahmoud al-Mawafi, ha giu-
rato fedeltà ad al-Zawahiri. Nonostante non vi sia certezza dei re-
sponsabili del massacro, il gruppo, concentrato nel Sinai, è salito
alla ribalta il 19 agosto 2013 in seguito a un brutale attacco a Ra-
fah, durante il quale sono stati giustiziati 25 soldati. Poiché recen-
temente non sono state registrate attività del gruppo, si pensa si sia
unito al gruppo Ansar al-Bayt Maqdis.
Ajnad Misr (Soldati d’Egitto) è il gruppo terrorista più attivo
che opera al di fuori del Sinai. È attivo dall’inizio del 2014
nell’area della capitale, dove ha rivendicato diversi attacchi effet-
tuati contro le forze di sicurezza attraverso Ied (Improvised Explo-
sive Device – ordigni esplosivi improvvisati) e armi di piccolo ca-
libro. Il gruppo, sebbene non insista sulla creazione di un califfato,
segue un’ideologia jihadista salafita ed è collegato in maniera vaga
e indefinita ad Abm.
Anche il gruppo di Ansar al-Shariʻa fi Ard al-Kinanah (Ansar
al-Shariʽa in Egitto) ha condotto alcuni attacchi nel Sinai, ma dopo
l’arresto di un alto comandante del gruppo non si sono registrate
molte altre attività.
Kataib al-Furqan (Brigate al-Furqan) è un gruppo collegato alle
Brigate al-Qassam a Gaza che ha condotto numerose imboscate
contro le Forze di sicurezza in tutto il paese, in particolare lungo il
Canale di Suez e al Cairo. Le Brigate al-Furqan hanno anche con-
dotto attacchi utilizzando lanciarazzi (Rpg, Rocket Propelled Gre-
nade) contro una nave cisterna che costeggiava il canale e una sta-
zione di comunicazione satellitare Satcom al Cairo.
Muhammed Jamal è un militante islamista egiziano con alle
spalle importanti esperienze jihadiste in Afghanistan ed Egitto.
Negli anni Jamal ha sempre mantenuto stretti legami con AQ
(compreso il suo leader Ayman al-Zawahiri), Aqim, Aqap e vari
altri affiliati ad AQ core. Rilasciato dalle autorità egiziane nel
2011, Muhammed Jamal ha creato una propria organizzazione
islamista (Mohammed Jamal Network - Mjn) e grazie a finanzia-
menti provenienti da Aqap ha istituito alcuni campi di addestra-
88 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
mento per jihadisti in Egitto e Libia. Jamal e altri 25 membri della
sua cellula sono stati arrestati nel mese di novembre 2012, Jamal è
stato accusato dalle autorità egiziane di voler stabilire una cellula
terroristica nel Cairo, in particolare nel distretto di Nasr City. Da
qui appunto deriva la ragione del nome dell’organizzazione Nasr
City Cell. I fondatori di questa cellula sarebbero stati lo stesso Ja-
mal, Sheikh Adel Shehato (ex membro del jihad islamico egiziano
e co-fondatore del Mjn) e Tariq Abu-al-Azm (un ex ufficiale
dell’aeronautica arrestato nel 2002 sotto il regime di Mubarak con
l’accusa di terrorismo). Dopo l’arresto dei suoi leader e di altri
membri del gruppo nel novembre 2012, non vi è alcuna conferma
che la cellula sia ancora attiva.
In Egitto esistono inoltre molti altri gruppi estremisti meno ri-
levanti quali ad esempio al-Takfir wa al-Hijra, Jund al-Islam, al-
Salafiyya al-Jihadiyya Fi Sina e Tawhid wal-Jihad.
La strategia che guida tutti questi gruppi estremisti islamisti
mira, in prima fase, a indebolire le Forze di sicurezza in alcune
aree specifiche e, più in generale, a colpire l’economia del paese.
Da quando l’esercito ha destituito il presidente Morsi nel luglio
2013, i principali obiettivi degli attacchi terroristici sono diventati
le tre maggiori fonti di valuta estera per il paese, ovvero il canale
di Suez, gli idrocarburi e il turismo. Inoltre, è anche parte della
strategia di questi gruppi provocare la dura reazione delle Forze di
sicurezza in modo tale da renderle ostili agli occhi della popola-
zione. Ciò, unito al peggioramento della situazione socio-
economica, dovrebbe preparare il terreno alle proteste di massa e a
una rivolta pubblica che condurrà al rovesciamento del governo in
carica.
La situazione attuale e i possibili sviluppi futuri
Nonostante le difficoltà economiche in cui versa al momento il
paese, la crisi energetica, la forte repressione degli oppositori e, in
assenza di un parlamento, i pieni poteri legislativi ancora concen-
trati nelle proprie mani (dall’elezione del maggio 2014 avvenuta
con il 97 per cento dei voti), la popolarità del carismatico presi-
Non solo Sinai, l’estremismo di matrice islamica in Egitto 89
dente Abdel Fattah al-Sisi è attualmente all’apice. Con la promes-
sa di un miglioramento del tenore di vita entro i prossimi due anni,
al-Sisi esorta costantemente gli egiziani a sostenere il suo operato
e ad attendere con pazienza la ripresa. Inoltre, la maggioranza del-
la popolazione sembra sostenere la campagna di soppressione dei
movimenti islamisti e l’assertività dimostrata in risposta agli atten-
tati terroristici, il cui numero è aumentato a livelli senza preceden-
ti.
La continuità del sostegno finanziario da parte di Arabia Saudi-
ta, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti nei prossimi anni sarà cruciale
per la sopravvivenza economica del governo di al-Sisi, al punto da
limitarne il margine di manovra nel trattare con i Fratelli musul-
mani, con cui al momento ogni compromesso politico risulterebbe
irrealistico.
Con Israele al-Sisi manterrà probabilmente buone relazioni e
una continua cooperazione nella lotta al terrorismo, al fine di con-
tenere l’insurrezione nel Sinai. Per tale ragione, la Striscia di Gaza
resta di fondamentale importanza nella politica estera dell’Egitto.
Gli estremisti islamici continueranno a rivolgere i propri attac-
chi contro le Forze di sicurezza, ma si prevede un aumento degli
attentati rivolti verso le infrastrutture statali (oleodotti, impianti di
energia e infrastrutture ferroviarie), verso i civili e verso le struttu-
re turistiche. Poiché durante i primi due mesi dell’anno sono stati
già compiuti più di 100 attentati (contro i 400 totali del 2014) è
previsto per il 2015 un ulteriore aumento. È probabile poi che i
gruppi più piccoli si andranno a consolidare attorno ad Ansar al-
Bayt Maqdis e allo Stato Islamico. Nonostante ciò, è poco proba-
bile che a breve termine i militanti islamisti attraverso i soli attac-
chi terroristici siano in grado di minare la stabilità dello stato.
Un problema sarà ancora rappresentato dalla violenza settaria,
che si manifesterà attraverso focolai sporadici di attacchi terrori-
stici e di aggressioni a livello locale contro la comunità cristiana
copta e nei quartieri misti, in particolare nelle aree povere delle
grandi città.
La minaccia più grande sarà invece rappresentata dal possibile
sfruttamento da parte degli islamisti delle mobilitazioni di massa e
90 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
dalle agitazioni sociali che potrebbero scaturire dal malcontento
economico per la mancanza di soddisfazione delle aspettative del-
la popolazione da parte del governo.
Conclusioni
L’Italia nutre in Egitto interessi strategici significativi. Sul fronte
della sicurezza, è elevata la preoccupazione per la possibile diffu-
sione degli attacchi terroristici e la perdita del controllo delle mi-
grazioni verso le sponde italiane; sul fronte economico,
un’eventuale interruzione delle attività del Canale di Suez potreb-
be avere gravi ripercussioni sull’Italia, in quanto potenza maritti-
ma mediterranea, poiché quasi 160 milioni di tonnellate di merci
che ogni anno passano attraverso il Canale sono provenienti o de-
stinate ai paesi del versante nord del Mediterraneo9.
Attraverso la fornitura di pattugliatori, la Marina Militare Ita-
liana contribuisce attivamente alla Multinational Force and Obser-
ver (Mfo)10
che è stanziata nel Sinai settentrionale ad al-Gorah.
Dall’inizio delle rivolte del 2011 la Mfo è stata oggetto di numero-
si attacchi terroristici.
L’Italia ha inoltre in Egitto anche importanti interessi economi-
ci. Nel 2014 103 imprese italiane sono state attivamente coinvolte
nel paese, in diversi settori quali l’agricoltura, il turismo, le tele-
comunicazioni e gli idrocarburi11
. In quest’ultimo settore, in parti-
colare dal 1954, l’azienda italiana Eni è fortemente coinvolta
nell’esplorazione e nella produzione sia di gas sia di petrolio e, at-
traverso le sue società, con una produzione complessiva nel 2014
di 451.662 barili equivalente di petrolio al giorno, rappresentando
9 Suez Canal Authority, “Cargo Ton by Region”, http://www.suezcanal.gov.eg/TRstat.aspx?reportId=6. 10 La Mfo è una forza di peacekeeping internazionale istituita nel 1981 a seguito degli accordi di Camp David del 1978-79 firmati da Egitto e Israele. 11 Ice, “Presenza Economica Italiana in Egitto,” aprile 2014, http://www.ice.gov.it/paesi/africa/egitto/upload/110/Presenza%20Economia%20Italiana%20in%20Egitto%20-%20Aprile%202014.pdf.
Non solo Sinai, l’estremismo di matrice islamica in Egitto 91
il principale attore energetico internazionale in Egitto12
. Attual-
mente la Ieoc (International Egyptian Oil Company) interamente
posseduta da Eni, con una quota del 28 per cento (in particolare,
30 per cento di liquidi e 27 per cento di gas), è il primo produttore
di idrocarburi del paese.
Il progetto di ampliamento del Canale di Suez, del valore di 8
miliardi di dollari, offre nuove e significative opportunità
d’investimento per le imprese italiane.
La costruzione della democrazia in Egitto sarà di fondamentale
importanza per avere stabilità nel lungo termine. Per far in modo
che ciò accada saranno necessari: una comprensione di base del
concetto di “democrazia” (“come funziona la democrazia”), esi-
stenza di strutture su cui la democrazia possa poggiarsi (ammini-
strazione, polizia, strutture giuridiche/stato di diritto, partiti demo-
cratici); un certo grado di stabilità e sicurezza; prospettive econo-
miche e volontà della popolazione, al momento la democrazia è
solo al terzo posto per importanza nelle priorità di molti cittadini.
Considerando la situazione attuale dell’Egitto è difficile imma-
ginare che la democrazia rappresentativa secondo il modello occi-
dentale sia davvero la soluzione migliore per il paese. È necessario
trovare dei compromessi e per far ciò è essenziale il contributo
dell’Unione Europea.
I problemi relativi alla sicurezza sono solamente i “sintomi del-
la malattia”. È importante che anche questi vengano “trattati”, ma
la chiave del successo sta nell’affrontare ciò che sta alla base del
problema, ovvero la difficile situazione socio-economica.
L’Egitto necessita fortemente del sostegno internazionale per
risolvere i propri problemi interni, in particolare quelli relativi alla
minaccia rappresentata dall’estremismo islamico. Per far ciò è ne-
cessario influenzare l’ambiente strategico, che è in parte responsa-
bile dell’origine del terrorismo. Bisogna mantenere elevata, e gra-
12 Eni, “Eni has been awarded 3 new exploration licenses in Egypt”, 25 settembre 2014, http://www.eni.com/en_IT/media/press-releases/2014/09/2014-09-25-eni-egypt.shtml?shortUrl=yes; ENI, “ENI in Egypt”, novembre 2014, https://www.eni.com/it_IT/attachments/documentazione/brochure/eni_egitto_2014.pdf.
92 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
dualmente soddisfare, la fiducia della popolazione egiziana nel
governo e la speranza di migliori condizioni di vita e maggior oc-
cupazione, così dovranno essere garantite le libertà individuali e i
diritti umani.
L’Italia dovrà svolgere un ruolo significativo nella questione
tenendo a mente i propri interessi strategici.
5. “Siraq” tra terrorismo e guerriglia
Andrea Beccaro
L’area tra Iraq, Siria e Libano è oggi scossa da profondi mutamen-
ti politici che non solo stanno trasformando la sistemazione geopo-
litica nata dopo la Prima guerra mondiale, ma pongono anche seri
problemi di sicurezza all’interno del bacino del Mediterraneo e
dunque all’Italia e all’Europa. In questo contributo descriveremo
prima tale minaccia soffermandoci in particolar modo sullo Stato
Islamico (IS) per poi offrire un quadro il più dettagliato possibile
dei paesi in esame.
Terrorismo o guerriglia?
In questa particolare congiuntura internazionale IS rappresenta la
minaccia più consistente anche a causa della sua pericolosità fuori
area, come dimostrano le sue propaggini in Sinai, Libia e non solo.
Non si dimentichi però che molte delle sue caratteristiche operati-
ve valgono anche, con le dovute diversità, per gruppi simili
dell’area.
Offrire una definizione precisa della minaccia è difficile, poi-
ché ormai il concetto stesso di guerra è radicalmente mutato, a tale
trasformazione però non è corrisposta una condivisa visione del
fenomeno da parte degli specialisti. Una delle definizioni più cal-
zanti per IS e gruppi affini è Hybrid Warfare, concetto proposto da
Hoffman1 nel 2006 in occasione del conflitto tra Israele ed Hez-
bollah, che descrive una situazione bellica generalmente tra uno
1 F. Hoffman, Conflict in the 21st Century: the Rise of Hybrid Wars, Arlington, Potomac Institute for Policy Studies, 2007.
94 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
stato e un gruppo di irregolari i quali adottano una combinazione
di tattiche. Da un lato troviamo elementi della guerriglia classica:
alta mobilità, conoscenza del terreno, velocità d’azione, sfrutta-
mento dell’elemento sorpresa, nonché tattiche prettamente terrori-
stiche. Queste ultime sono sempre state centrali nelle guerre irre-
golari e come sostiene Metz: «È più accurato considerare il terro-
rismo come una tattica o un metodo operativo che può essere uti-
lizzato all’interno di una varietà di strategie compresa quella di
un’insorgenza. I movimenti puramente terroristici sono quasi
sempre incapaci d’implementare una completa strategia
d’insorgenza»2. Dall’altro lato però troviamo elementi tipici degli
eserciti statuali: addestramento all’impiego di esplosivi e di armi
avanzate, impiego di movimento tattico tipico della fanteria o an-
che delle Sof (Special Operation Forces), uso di armi tecnologi-
camente avanzate come missili contro carro, mezzi corazzati, arti-
glieria. Da questa commistione nasce il concetto di “hybrid” e ciò
porta a due ulteriori riflessioni.
Primo, tali combattenti non si limitano alla sfera puramente
violenta dei conflitti, ma agiscono anche, e con sempre maggiore
efficacia, sui media e sui social network3. Tali aspetti sono parte
integrante della loro strategia e servono per portare a termine al-
cuni obiettivi come il reclutamento di nuove leve (qui IS ha co-
struito molta della sua forza, basti pensare al ruolo dei cosiddetti
foreign fighters4) e la promozione della propaganda con il duplice
risultato di compattare le proprie fila e di colpire la volontà del
nemico di combattere5. Secondo, il campo di battaglia si è ormai
allargato alla sfera mediatica e social, poiché la propaganda che si
2 S. Mets, Rethinking insurgency, in, The Routledge Handbook of insurgency and Counterinsur-gency, a cura di P.B. Rich, I. Duyvesteyn, New York, Routledge, 2012, p. 38. 3 C. Winter, How the Islamic State Makes Sure You Pay Attention to It, http://warontherocks.com/2015/02/how-the-islamic-state-makes-sure-you-pay-attention-to-it/. 4 D. Byman, J. Shapiro, Be Afraid. Be A Little Afraid: The Threat of Terrorism from West-ern Foreign Fighters in Syria and Iraq, Policy Paper, n. 34, novembre 2014, http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/11/western-foreign-fighters-in-syria-and-iraq-byman-shapiro/be-afraid--web.pdf. 5 Si veda Twitter e jihad: la comunicazione dell’Isis, a cura di M. Maggioni, P. Magri, Mila-no, Edizioni Epoké - ISPI, 2015.
“Siraq” tra terrorismo e guerriglia 95
sviluppa in quei contesti è parte integrante del conflitto. Le imma-
gini diffuse da IS e i reali combattimenti sul campo sono elementi
che vanno letti e interpretati in modo complementare, sono la stes-
sa battaglia combattuta con strumenti e mezzi diversi. Il campo di
battaglia su cui IS e gruppi similari agiscono è dunque fluido: da
un lato, grazie all’impiego di tattiche terroristiche tali organizza-
zioni possono con grande facilità colpire anche fuori dalla zona
operativa come dimostrano i recenti attacchi in Francia, Belgio,
Australia e Canada; dall’altro, anche in Iraq e Siria il “fronte” si
sposta rapidamente, non è delineato e ciò rende molto difficile
analizzare il conflitto e il suo andamento.
Il quadro geopolitico
La denominazione IS nasce il 29 giugno 2014 quando il suo lea-
der, Abu Bakr al-Baghdadi, dichiara la creazione del califfato, do-
po aver conquistato un terzo del territorio iracheno oltre a quello
che già aveva sotto il suo controllo in Siria, ma in realtà il gruppo
è attivo con vari nomi e leader almeno dal 1999. Pur nascendo
come emanazione di al-Qaida, cui si è affiliato nel 2004, esiste una
profonda frattura a livello operativo ancora oggi rilevante per
comprendere le dinamiche tra IS e Jabat al-Nusra (JN). L’impiego
di tattiche eccessivamente violente del gruppo, e in particolare
l’impiego massiccio di attentatori suicidi e Ied (Improvised Explo-
sive Device) contro i civili iracheni principalmente sciiti, fu criticato
da al-Qaida, ciò sottolineava una diversa visione degli obiettivi della
lotta: lo scopo di Zarqawi era di creare le condizioni per una guerra
civile tra sunniti e sciiti, mentre al-Qaida invitava a colpire le forze
occidentali. Grazie alla dottrina della Counter-insurgency e al mo-
vimento dell’Awakening6, si riuscì tra il 2007 e il 2008 a ridurre si-
gnificativamente la violenza nel paese7 e le capacità operative del
6 A. Beccaro, La guerra in Iraq, Bologna, il Mulino, 2013. 7 B. Price, D. Milton, M. al-ʻUbaydi, N.Y. Lahoud, The Group That Calls Itself a State: Understanding the Evolution and Challenges of the Islamic State, CTC Sentinel, Combating Terrorism Center, West Point, 2014, p. 21.
96 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
gruppo, ma fu una vittoria di Pirro per due diverse ragioni. Da un
lato, la politica settaria portata avanti dal premier Maliki fece sì che
i sunniti tornassero sempre più verso posizioni d’opposizione al go-
verno centrale. Dall’altro lato la congiuntura geopolitica regionale
stava profondamente mutando con la guerra civile in Siria che per-
mise all’IS, seppur con modalità e tempistiche diverse, di conqui-
starsi spazio e di procedere con la sua stabilizzazione. Bisogna però
ricordare che dal punto di vista militare IS si trova in una situazione
complessa, infatti la forza che gli ha permesso di conquistare il terri-
torio tra Iraq e Siria risiedeva sia nella sua alta mobilità sia
nell’effetto sorpresa che riusciva a ottenere, con la fine dell’estate il
gruppo, ormai solidificato, ha acquisito una postura più statica.
IS dunque rappresenta a tutti gli effetti un attore regionale im-
portante, il fatto di non essere uno stato nel senso occidentale e
moderno del termine non deve essere un pretesto per non ricono-
scerne lo status che si è guadagnato sul campo, anche perché al
suo fianco abbiamo attori dalle stesse caratteristiche e del tutto re-
frattari al concetto di confine. IS opera indifferentemente in Siria e
in Iraq senza contare le sue varie province – Wilayat, in Sinai, Li-
bia e altrove. I Peshmerga curdi godono ormai di una più o meno
ampia indipendenza dal 1991, vengono armati e addestrati anche
da paesi europei in funzione anti-IS ma un domani, nemmeno
troppo lontano, potrebbero diventare una forza trainante per un
Kurdistan più ambizioso. Hezbollah in quanto emanazione della
politica estera iraniana gioca in tutta l’area dal Libano all’Iraq,
passando per la Siria, un ruolo centrale sia dal punto di vista mili-
tare (il suo supporto ad Assad è stato determinante per evitare il
crollo del regime) sia dal punto di vista politico. JN è fortemente
radicata in Siria e ha propaggini in Libano. Dunque qualunque
strategia d’intervento nell’area deve prendere realisticamente in
considerazione questo aspetto e non può ragionare in termini spa-
ziali ormai superati dagli eventi8.
8 A.Y. Zelin, “The Islamic State’s model”, The Washington Post, 28 gennaio 2015, http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/01/28/the-islamic-states-model/.
“Siraq” tra terrorismo e guerriglia 97
Qui affronteremo separatamente i tre paesi, poiché tale suddi-
visione semplifica l’esposizione, invitiamo però il lettore a tenere
presente quanto appena esposto e a cercare di vedere le intercon-
nessioni presenti tra le diverse aree.
Iraq
Dal giugno 2014 l’IS è stato in grado di ampliare notevolmente il
territorio sotto il suo controllo conquistando la città di Mosul, le
province di Ninive e Anbar oltre a varie altre aree del paese. Al
momento IS ha perduto la spinta offensiva che aveva mantenuto
fino all’autunno scorso. Ciò però non significa che la milizia sia
stata sconfitta. È vero che alcune aree sono oggi più stabili (come
la provincia di Diyala a nord della capitale), ma non per questo
fuori pericolo, anche perché fino al mese di febbraio IS ha mante-
nuto quasi inalterate le sue posizioni. Tale situazione è lievemente
mutata a seguito dell’operazione per liberare Tikrit. A metà marzo,
due settimane dopo l’inizio dell’offensiva, le truppe irachene e le
milizie sciite appoggiate dall’Iran sono penetrate in città, ma non
sono ancora riuscite a controllare completamente il centro. Il pro-
blema però non è tanto se riusciranno o meno a liberare la città,
quanto, e se, siano in grado di controllare lo spazio conquistato e
quindi di tenere fuori IS, un fatto che potremo verificare solo nei
prossimi mesi.
La violenza nel paese resta comunque altissima se si pensa che,
secondo la United Nations Assistance Mission for Iraq (Unami), a
febbraio ci sono state 1100 vittime, un dato che non prende in con-
siderazione il territorio controllato dall’IS. Ciò dimostra come le
stesse aree “liberate”, o che non sono sotto il suo diretto controllo,
sono costantemente sotto attacco come Ramadi e Baghdad. Ben-
ché il premier al-Abadi abbia deciso a inizio febbraio di togliere il
coprifuoco nella capitale, che ormai durava da anni, un tentativo,
per sua stessa ammissione, di normalizzare la vita degli iracheni
più che il risultato di una maggiore sicurezza e infatti pochi giorni
dopo l’annuncio si sono verificati tre attacchi suicidi. Altra area
cruciale e più volte dichiarata sicura, ma in realtà fortemente con-
98 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
tesa, è quella di Baji e della sua raffineria liberata a novembre e
riconquistata in parte a dicembre da IS, teatro di aspri scontri tra
gennaio e febbraio. Oppure la cittadina di al-Baghdadi nella pro-
vincia di Anbar che ha registrato diversi attacchi tra novembre e
dicembre per via della sua collocazione strategica, ma che era stata
dichiarata sicura il 12 gennaio. Il 13 febbraio IS con un attacco a
sorpresa è riuscito a conquistarla, mettendo così in grave pericolo
la vicina base aerea di al-Asad dove circa 320 soldati americani
sono impegnati in operazioni di addestramento. Tale operazione
dimostra sia la capacità di resistenza e di adattamento di IS, sia la
scarsa efficacia dell’operazione aerea e la debolezza strutturale
delle forze irachene.
Il problema però non è quanto o se si riesce a far retrocedere IS
o sconfiggerlo, bensì, in Iraq come in Siria, cui prodest? La spac-
catura tra sunniti e sciiti è radicata e inficia profondamente non
solo le capacità operative dell’esercito che si vorrebbe nazionale,
ma anche quelle d’influenza politica di Baghdad in cui il controllo
sciita è forte e visto con sospetto dalla minoranza sunnita. La-
sciando da parte i bombardamenti aerei condotti da un’eterogenea
alleanza, possiamo individuare almeno tre gruppi di attori, non
omogenei al loro interno, che combattono sul terreno, facendo così
emergere il problema di come verrà gestito il territorio iracheno
nel caso di una sconfitta di IS. Le Forze di sicurezza irachene,
avendo perduto le regioni in cui erano meno radicate e dove il
malcontento verso il governo centrale era più forte, grazie al so-
stegno del potere aereo americano, possono essere uno strumento
più efficace di lotta, ma non è detto che siano realisticamente in
grado di riconquistare il terreno perduto, anche perché si trattereb-
be di condurre complesse operazioni urbane. I Peshmerga curdi
sono stati la prima linea di difesa dopo lo sfaldamento delle forze
regolari, e sia l’Italia (circa 60 militari a Erbil con compiti di adde-
stramento più un contingente di circa 400 uomini in Kuwait utili
per far operare quattro Tornado, due Predator e un aereo cisterna)
sia altri paesi occidentali hanno inviato loro armi e altro materiale
bellico. I curdi però hanno approfittato della crisi creata da IS per
entrare a Kirkuk e non sembrano intenzionati a lasciare la città.
“Siraq” tra terrorismo e guerriglia 99
Bisogna poi prendere in considerazione l’influenza iraniana sia sul
governo di Baghdad sia sulle milizie che si sono dimostrate molto
capaci sul terreno, diventando un attore della politica interna ira-
chena temibile e al contempo un’ulteriore ragione di preoccupa-
zione per una spaccatura del paese. Tra i gruppi sciiti più attivi
possiamo indicare Asaib Ahl al-Haq (La lega dei giusti) che ha
avuto un ruolo determinante nella zona di Babil, è anche uno dei
gruppi iracheni che combattono in Siria, a ulteriore dimostrazione
di una crescente integrazione delle aree; Kata’ib Hizbollah (I bat-
taglioni del partito di Dio) hanno sempre combattuto la presenza
americana in Iraq e ora sono al fianco dell’esercito regolare sin
dall’inizio della crisi con IS. Fino a poco tempo fa le loro opera-
zioni si erano limitate alla difesa dei luoghi santi e delle aree a
maggioranza sciita, ma recentemente alcuni elementi sono attivi
nella provincia di Anbar, il che ha sollevato dubbi e resistenze da
parte dei sunniti. Esse pongono seri problemi al futuro dell’Iraq
non solo per il loro forte legame con l’Iran, ma anche perché si
sono macchiate di pesanti ritorsioni contro la popolazione sunnita
delle aree in cui operano, perpetuando così la lotta interna tra sun-
niti e sciiti9. Infine, il lato sunnita non è rappresentato dal solo IS,
ma è sfaccettato in una pluralità di gruppi che in parte sono legati
al califfo, in parte, invece, si schierano in opposizione anche se
non per forza di cose a favore del governo di Baghdad.
Siria
La situazione siriana è probabilmente ancor più complicata e flui-
da con una guerra civile che ormai si trascina da quattro anni e che
nei soli ultimi 12 mesi ha causato la morte di circa 76.000 persone,
senza prendere in considerazione l’enorme numero di rifugiati. Sul
campo si scontrano molteplici milizie che rendono la comprensio-
ne del conflitto particolarmente complessa, ma che in realtà ri-
specchiano sia i diversi interessi in gioco degli attori regionali
(Turchia, Siria, Iran, Arabia Saudita, Iraq, Qatar) sia le spaccature
9 http://iswiraq.blogspot.de/2015/02/iranian-backed-militias-cause-political.html.
100 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
etnico-religiose del Medio Oriente (sunniti, sciiti, curdi su tutte).
La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che si contano
migliaia di combattenti stranieri. Accanto alle forze lealiste di As-
sad appoggiate in modo diretto anche da Hezbollah10
troviamo tra
gli attori principali IS e Jabat al-Nusra, ovvero la sigla locale di al-
Qaida più una serie di altre milizie11
. L’esercito regolare ha chia-
ramente alcuni problemi, le defezioni, le diserzioni e circa 44.000
perdite ne hanno ridotto gli effettivi da 325.000 a circa 150.000
uomini12
. Inoltre avendo perduto alcune basi strategiche
nell’interno del paese non sembra in grado di riconquistare ampi
spazi di ciò che fu la Siria, questo però non significa che non pos-
sa tenere testa alle milizie nelle zone che ancora controlla oppure
di organizzare offensive più limitate, come infatti è avvenuto a
febbraio ad Aleppo (un’avanzata che preoccupa non poco la Tur-
chia) e in diverse zone nei pressi di Damasco.
La vittoria curda di Kobane non deve far pensare a un IS in riti-
rata, anche se i curdi sono stati in grado di ampliare le zone con-
trollate. Sicuramente il fatto di non aver conquistato la città dopo
che se n’era fatto un emblema della forza militare del califfato è
uno smacco mediatico notevole (controbilanciato però dal video in
cui il pilota giordano viene arso vivo e dal recente rafforzamento
in Libia), ma resta il fatto che l’IS controlla ancora saldamente
ampi territori della Siria centro orientale e le annesse risorse petro-
lifere che insieme a quelle irachene rappresentano una porzione
importante della sua economia.
JN è un altro attore importante in Siria radicato soprattutto nel
nord-ovest del paese. Fino alla primavera del 2014 combatteva al
fianco di IS, ma poi quest’ultimo ha rotto la collaborazione riu-
scendo a scalzare al-Qaida dal suo ruolo di leader del movimento
10 P.P. Smyth, The Shiite Jihad in Syria and its Regional Effects, Policy Focus 138, The Washington Institute for Near East Policy, febbraio 2015. 11 Per un’analisi più dettagliata dei vari gruppi si veda Syria: A.Y. Zelin, Syria: The Epicenter of Future Jihad, Policy Analysis, Policywatch 2278, The Washington Institute for Near East Policy, 30 giugno 2014. 12 C. Kozak, The Assad Regime Under Stress: Conscription and Protest among Alawite and Minority Populations in Syria, http://iswsyria.blogspot.de/2014/12/the-assad-regime-under-stress.html.
“Siraq” tra terrorismo e guerriglia 101
jihadista sia sul campo sia dal punto di vista mediatico grazie a
una campagna che purtroppo conosciamo fin troppo bene. JN in-
torno al 14 dicembre, insieme ad altre milizie, ha conquistato le
basi militari di Wadi al-Deif e al-Hamidiyah nei pressi di Idlib,
così facendo ha fortemente indebolito la presenza lealista nell’area
e attraverso le sue abilità tattiche e di pianificazione operativa, al
fine di condurre offensive simultanee e coordinate, ha dimostrato
la sua forza e la sua influenza. Con l’inizio del nuovo anno si sono
registrate tensioni con altri gruppi ribelli sia ad Aleppo sia nel sud
della provincia di Idbil il che potrebbe indicare un crescente mal-
contento verso le azioni offensive di JN. A gennaio però il gruppo
è stato anche in grado di conquistare un’altra base siriana vicino a
Sheikh Miskin nel sud della provincia di Dera’a. La risposta a tali
attacchi si è registrata a febbraio quando Hezbollah ha guidato
un’offensiva con elementi dell’esercito regolare proprio per bloc-
care l’avanzata e ripristinare i collegamenti.
I colloqui tenutisi a fine gennaio a Mosca non rappresentano un
vero passo avanti nella risoluzione della crisi siriana, ma potrebbe-
ro aver ulteriormente rafforzato la posizione russa nell’area. Gli
accordi firmati a febbraio tra Stati Uniti e Turchia per
l’addestramento dei ribelli siriani filo-occidentali non solo sono
una mossa tardiva, ma prevedono un’operazione talmente limitata
nei numeri che difficilmente potrà avere un impatto nel breve pe-
riodo.
Libano
La questione libanese è quanto mai delicata per svariate ragioni:
confina con Israele e in passato si è arrivati più volte allo scontro
aperto; è un paese profondamente diviso e con una pluralità di
confessioni che in un quadro regionale così instabile rappresenta-
no un potenziale rischio futuro; ha una presenza militare occiden-
tale e in particolare di soldati italiani inquadrati nella missione
Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) (1100 uomini
della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”). Il paese è però da decenni
parzialmente in mano alle milizie di Hezbollah che da lì sono poi
102 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
partite per aiutare Assad in Siria. Inoltre, dopo un periodo di rela-
tiva calma, nella seconda parte di gennaio il confine con Israele si
è di nuovo fatto rovente a causa di una serie di attacchi e ritorsioni
tra Hezbollah e Idf (Israel Defense Forces) che hanno causato al-
cuni morti da entrambe le parti più quella di un Casco Blu. Quello
che emerge però è che anche sulle Alture del Golan non si tratta
più di un confronto tra queste due forze, da mesi ormai vi opera
anche Jabat al-Nusra, e questo ha fatto sì che sia le milizie sciite
sia Teheran alzassero il loro livello di guardia. Almeno secondo il
comando italiano responsabile dell’area però la situazione pur tesa
resta sotto controllo13
, anche se non è escluso che con la primavera
gli scontri possano intensificarsi.
Le milizie di Hezbollah non sono le uniche presenti,
nell’ultimo anno specie nella zona nord del paese nella regione di
Arsal si sono registrati aspri scontri tra l’esercito regolare e gruppi
sunniti variamente legati a JN o IS. Per evitare scontri aperti che
potrebbero degenerare e portare il paese al collasso, le Forze arma-
te hanno cercato d’isolare l’area. In questo modo però il Libano si
presenta spaccato in tre parti con un nord particolarmente perico-
loso dove è forte, anche se non maggioritaria, la presenza di grup-
pi sunniti jihadisti, un centro relativamente pacifico e un sud in
mano a Hezbollah. Bisogna inoltre ricordare che la stabilità del
paese è resa estremamente più debole dall’enorme flusso di rifu-
giati siriani in fuga dalla guerra.
È sintomatico che nel gennaio 2015 il generale iraniano Qasem
Soleimani abbia compiuto una visita a Beirut. Soleimani è
l’eminenza grigia della politica estera e militare iraniana nella re-
gione, è stato più volte visto in Iraq (dove ha guidato anche
l’operazione a Tikrit) dove ha stretto rapporti con le milizie sciite
locali, in Siria e anche in Yemen, è la persona a cui Teheran dele-
ga il processo di decision-making sul campo. La tempistica della
visita, di cui però s’ignorano i contenuti, è significativa visto che è
avvenuta poco dopo lo scontro sul confine tra Israele ed Hezbol-
lah.
13http://www.analisidifesa.it/2015/02/libano-sullorlo-della-guerra-parla-il-generale-portolano/.
“Siraq” tra terrorismo e guerriglia 103
Conclusioni
L’intera regione è quindi estremamente instabile e le prospettive di
breve/medio termine non sono migliori. Siria e Iraq, seppur in
modi diversi, possono essere considerati degli stati falliti che non
controllano più ampi spazi del loro territorio, molti altri attori sono
attivi in quegli spazi con le proprie agende politiche. Tra questi
l’IS rappresenta sicuramente la minaccia maggiore, poiché ha mo-
strato la capacità e la volontà di alterare l’ordine internazionale e
in particolare quello dell’area del Mediterraneo. Questo aspetto
interessa da vicino l’Italia non solo per la sua collocazione geogra-
fica, ma anche perché il nostro paese da anni investe risorse politi-
che e militari sia in Libano, dove siamo al comando della missione
Unifil dal 2007, sia in Iraq, dove le Forze armate sono state forte-
mente impegnate tra il 2003 e il 2006, e ora nuovamente altri mili-
tari italiani sono attivi sul campo.
6. AfPak: i rischi del broader disengagement
Riccardo Redaelli
La “scomparsa” dello scenario afghano
Sembrerebbe a prima vista paradossale che il tentativo più ambi-
zioso e più impegnativo dal punto di vista umano, economico e
organizzativo della Nato e della comunità internazionale – vale a
dire la stabilizzazione dell’Afghanistan post-2001 – sia entrata in
un profondo “cono d’ombra” mediatico. Di Afghanistan si parla
pochissimo ormai, nonostante sia ancora presente un forte contin-
gente Nato, anche dopo la fine della Missione di assistenza alla
stabilizzazione di quel paese (la più che decennale missione Isaf –
International Security Assistance Force), sostituita, come vedre-
mo, dal nuovo impegno militare di Resolute Support. E nello stes-
so cono d’ombra sembrano essere finite anche le abbinate strategie
counter-insurgency (contro i Taliban) e counter-terrorism (nei
confronti dei movimenti jihadisti) nell’AfPak (la dizione ormai in-
valsa per identificare la regione afghano-pakistana).
Certo, vi sono ormai ben altri scenari di crisi, molto più vicini
all’Europa, che focalizzano la nostra attenzione, in particolare con
l’ascesa del movimento jihadista post-qaidista dello Stato Islamico
(IS). IS ha non solo calamitato l’attenzione in Levante e nel Medi-
terraneo, ma ha anche innovato il frame concettuale e operativo
dell’attivismo islamico violento1, apparentemente marginalizzando
il modello di al-Qaida e il suo leader al-Zawahiri. I colpi subiti da
1 Cfr. New (and Old) Patterns of Jihadism: al-Qa’ida, the Islamic State and Beyond, a cura di A. Plebani, Milano, ISPI, 2014.
106 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
al-Qaida e la trasformazione di quella struttura, per sopravvivere a
quasi quindici anni di lotta al terrore statunitense e occidentale,
fanno oggi apparire come meno prioritario lo scacchiere
dell’AfPak, e in particolare quello afghano, mentre cresce in peri-
colosità quello pakistano, con l’aumento della violenza del movi-
mento Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp – si veda il paragrafo a p.
109).
A contribuire alla riduzione del senso di priorità di questo qua-
drante vi è anche la trasformazione del movimento dei Taliban in
una galassia molto più articolata e spesso lontana dal movimento
originario, strettamente legato al jihadismo globale, e la “derubri-
cazione” del conflitto in Afghanistan in un conflitto “nazionale”,
per il quale esistono soluzioni più politiche che militari.
Da Isaf a Resolut Support
Per capire lo scenario attuale e valutare il rischio rappresentato dai
movimenti del jihad globale regionali, occorre tuttavia partire da
un bilancio complessivo di Isaf, conclusasi nel dicembre 2014 do-
po oltre un decennio di attività. Se si dovesse sintetizzare in modo
estremo, si potrebbe dire: molti sforzi, molti errori. L’impegno in-
ternazionale di Isaf, sotto la guida Nato, ha coinvolto quasi 60
paesi (ben oltre quindi i 28 paesi dell’Alleanza Atlantica) a partire
dal 2003 con decine di migliaia di soldati impiegati, arrivando a
un massimo di 140.000 uomini dislocati nel paese durante il 2011,
per poi scendere progressivamente fino ai 35.000 di quest’anno. A
essi vanno aggiunte decine di migliaia di civili che hanno lavorato
negli innumerevoli progetti di sviluppo. Non esistono cifre sicure
riguardo ai costi totali di quest’impegno verso l’Afghanistan, ma
le stime più accurate superano i mille miliardi di dollari nell’arco
di 13 anni. Di questi fondi, più del 99 per cento sarebbe stato in-
ghiottito dallo sforzo militare per combattere i Taliban e addestra-
re le truppe nazionali afghane. Per l’impegno umanitario, non sa-
AfPak: i rischi del broader disengagement 107
rebbero rimaste che le briciole, meno dell’1 per cento2. Una cifra
che, da sola, dice molto sulle enormi difficoltà nel mettere in sicu-
rezza il paese.
È vero che al-Qaida non ha più potuto usare quella regione
come proprio rifugio sicuro e i guerriglieri islamisti sono stati cac-
ciati da Kabul, ma il terrorismo di matrice islamista in questi anni
è ben lungi dall’essere sconfitto, come dimostrano le tristi crona-
che di questi ultimi mesi. E i Taliban continuano a minacciare la
fragile democrazia afghana; hanno anzi infettato il vicino Pakistan
che si era illuso di usarli per i propri obiettivi strategici; Islamabad
è invece stata colpita dagli stessi demoni del radicalismo che ave-
va colpevolmente evocato.
Parte di questi risultati deludenti è anche dovuta agli errori di
prospettiva, alla distrazione (causa Iraq) e alla mancanza di coor-
dinamento dei paesi impegnati in Afghanistan. È solo dopo il 2009
che Isaf ha iniziato a cambiare strategia, rafforzando il coordina-
mento interno e incrementando il training delle truppe nazionali,
per “afghanizzare” la lotta contro gli insorti, riducendo progressi-
vamente il proprio impegno diretto nelle battaglie sul terreno.
L’Italia è stata certo uno dei principali protagonisti di questo
sforzo: per anni abbiamo impegnato in Afghanistan migliaia di
uomini, guidando uno dei quattro comandi regionali di Isaf, quello
di Herat, nell’Ovest. Un impegno pagato con la vita di più di 50
nostri soldati, ma i cui frutti in tema di stabilità militare e di svi-
luppo economico e sociale vengono sempre sottolineati dagli stes-
si afghani.
Nonostante errori e fallimenti, il cambiamento sociale e cultu-
rale dell’Afghanistan è comunque impressionante: oggi gli stessi
Taliban accettano le tante scuole femminili aperte nel paese (e che
loro consideravano anti-islamiche), esistono giornali e tivù delle
più varie tendenze, le università sono in forte crescita, così come
le organizzazioni non governative. Il paese si è trasformato da
questo punto di vista e nessuno immagina possa accettare di torna-
2 S. Perlo-Freeman, C. Solmirano, “The economic costs of the Afghanistan and Iraq wars”, Yearbook 2012. Armaments, Disarmaments and International Security, SIPRI, Ox-ford, 2012.
108 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
re indietro al tetro fanatismo del Mullah Omar. Un’evoluzione so-
ciale che ha contagiato gli stessi insorti islamisti, spesso in disac-
cordo con la vecchia guardia dei Taliban apparentemente più di-
sponibili a un compromesso politico3.
Si sarebbe potuto ottenere molto di più, se non fosse stato per
la piaga spaventosa dell’inefficienza e della corruzione, rappresen-
tata dagli otto fallimentari anni di potere dell’ex presidente Hamid
Karzai. Ministri e alti funzionari hanno saccheggiato i fondi desti-
nati allo sviluppo, rubando decine di miliardi di dollari (ora depo-
sitati per lo più nelle compiacenti banche di Dubai). Le enormi e
sfacciate malversazioni hanno umiliato la popolazione afghana,
contribuendo a spegnere gli entusiasmi e a favorire la propaganda
degli insorti. Il nuovo presidente, il pashtun Asharf Ghani – salito
al potere dopo uno stallo di mesi per i brogli elettorali nelle ele-
zioni dell’estate 2014 – guida un governo di coalizione con il riva-
le Abdullah Abdullah e sta cercando di ridurre le inefficienze e la
corruzione.
A gennaio 2015, con la fine di Isaf, inizia Resolute Support,
una missione che deve assicurare il training degli oltre 350.000
soldati e poliziotti afghani (i cui salari sono pagati pressoché to-
talmente dalla comunità internazionale) e che è composta da al-
meno 13.000 soldati di decine di paesi diversi, senza però alcun
ruolo attivo nei combattimenti4. Un numero che non soddisfa mol-
to gli afghani, timorosi che il nostro sostegno sia molto meno che
“risoluto”. Dovrà invece aumentare l’impegno finanziario e uma-
nitario per migliorare la vita quotidiana della popolazione e per
rafforzare la capacità gestionale del governo di Kabul (senza farsi
troppe illusioni). Ma il problema di Resolute Support sembra so-
prattutto essere quello di una mancanza di chiarezza circa i veri
obiettivi della missione e la loro prioritarizzazione e soprattutto di
un’ambiguità di fondo. Così come Isaf, anche RS punta soprattutto
sul training e il mentoring per la stabilità e le best practices; eppu-
re, il comandante generale di RS – come per Isaf – mantiene il
3 Cfr. A. Gopal, “Serious Leadership Rifts Emerge in Afghan Taliban”, CTC Sentinel, vol. 5, n. 11-12, novembre 2012. 4 Dati forniti nel corso di colloqui al Nato HQ, Bruxelles, 17 ottobre 2014.
AfPak: i rischi del broader disengagement 109
doppio cappello di comandante di una forza multinazionale per la
stabilità e di comandante della missione US contro-terrorismo, da
gennaio battezzata Operation Freedom’s Sentinel¸ che riproduce
l’ambiguità degli interessi e degli obiettivi di cui l’azione Nato ha
sofferto in passato.
Taliban e terrorismo: le possibili trasformazioni nell’AfPak
Dall’altra parte, il decennio abbondante di lotta ha profondamente
modificato anche il fronte dei Taliban, che oggi sembrano più una
“galassia” che un movimento ben strutturato.
Sotto quest’etichetta vi è infatti una pluralità di gruppi, spesso
con agende e prospettive divergenti. Da un lato vi è la vecchia
guardia ideologica legata al leader storico, Mullah Mohamad
Omar, a capo della cosiddetta Quetta Shura, che riunisce veterani
pashtun del movimento Taliban e ha legami con il cosiddetto
Haqqani Network (creato dal comandante mujaheddin Jalaluddin
Haqqani – che godette di corposi aiuti dagli Stati Uniti negli anni
Ottanta), un’altra organizzazione estremista attiva nell’AfPak,
spesso collegata ai grandi attentati con l’uso di volontari suicidi,
che tuttavia appare operativamente autonoma rispetto alla Quetta
Shura5. Quest’ultima, a lungo protetta dalle autorità pakistane, ap-
pare ora indebolita dalle uccisioni mirate dei droni statunitensi e
da rapporti più tesi con le forze armate pakistane. Importante an-
che la Peshawar Shura, il secondo dei consigli politico-militari dei
Taliban (i rimanenti consigli sono basati a Miranshah nel Nord
Waziristan e a Karachi), molto attiva nei combattimenti
nell’Afghanistan orientale e che beneficia della protezione dei
centri religiosi del network Haqqani.
Vi è poi una moltitudine di comandanti militari attivi lungo la
frontiera, pressoché tutti pashtun, i quali – negli ultimi anni – han-
no mostrano minore coesione e fedeltà ai vertici storici del movi-
5 A. Siddique, “The Quetta Shura: Understanding the Afghan Taliban’s Leadership”, Terrorism Monitor, vol. 12, n. 4, febbraio 2014.
110 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
mento (tanto che essi vengono fatti ruotare sul terreno, con un sen-
sibile peggioramento dell’efficienza militare delle loro unità).
L’elemento scatenante di questa frammentazione è stato il combi-
nato degli attacchi mirati US/Nato contro i comandanti Taliban sul
terreno e l’avvio dei negoziati di pace con il governo di Kabul. Chi
rischia la vita sul campo, e si espone alla possibilità concreta di
essere eliminato dalla tecnologia militare occidentale, è scoraggia-
to dall’intensificarsi delle trattative, dato che esse sembrano rende-
re quasi inutile il loro sacrificio6.
Altri comandanti, soprattutto quelli con forti legami tribali lo-
cali, diventano così meno intransigenti e disposti al compromesso
(tacito o meno) con il governo centrale, che negli ultimi anni ha
negoziato accordi e tregue informali con singoli gruppi di insorti.
Infine, è cresciuto il numero di gruppi militari che adottano
l’etichetta di Taliban, ma che rappresentano per lo più o istanze
estremamente locali o, peggio ancora, sono di fatto semplici grup-
pi criminali dediti ai traffici illeciti che prosperano nella regione
dell’Asia centro-meridionale (traffico di droga in primis), al bri-
gantaggio, rapimenti ed estorsioni.
Vi sono poi i movimenti che operano in Pakistan e che vedono
tra le proprie file prevalere i pashtun pakistani (definiti come pa-
than) rispetto a quelli afghani. Ponte fra queste due realtà è il già
citato Haqqani Network, che mantiene profondi legami con gli
ambigui servizi segreti militari pakistani (il potentissimo e famige-
rato Inter-Service Intelligence, Isi), con il nucleo centrale di al-
Qaida e con i gruppi jihadisti pakistani, soprattutto quelli confluiti
con il Ttp. Il peggioramento dello scenario di sicurezza pakistano
e l’accentuarsi della crisi negli ambigui “rapporti” fra Forze arma-
te pakistane e la galassia talibana e jihadista hanno portato al lan-
cio, negli ultimi anni, di alcune campagne militari nelle Tribal
areas della North-West Frontier Province contro la presenza tali-
bana e degli Haqqani. Campagne in ogni caso risultate non decisi-
ve; per qualche analista, anzi, sono sostanzialmente state opera-
zioni di facciata per ridurre la crescente irritazione statunitense e
6 A. Giustozzi, S. Mangal, “Violence, the Taliban, and the Afghanistan’s 2014 Elec-tions”, USIP – PeaceWorks, issue 103, dicembre 2014.
AfPak: i rischi del broader disengagement 111
Nato, esasperati dal doppiogiochismo dei militari e dei politici pa-
kistani.
Quanto al Ttp, si tratta di una coalizione di movimenti jihadisti
e islamisti radicali come il Lashkar-e Jhangvi (Esercito di Jhang-
vi), il Jaish-e Mohammad (Esercito di Muhammad) e il Sipah-e
Sahaba Pakistan (Esercito dei Compagni [del Profeta] in Pakistan),
con la partecipazione anche di militanti della resistenza islamista
anti-indiana in Kashmir7. Fondato nel 2007 da Baitullah Mehsud
(ucciso nel 2009), il Ttp rappresenta uno dei principali problemi di
sicurezza del Pakistan, dato che da anni colpisce obiettivi politici e
militari, non disdegnando le stragi spettacoli di tipo qaidista (come
l’infame attacco alle scuole frequentate dai figli dei militari a Pe-
shawar nel dicembre 2014). La violenza dei loro attacchi, che
hanno provocato la morte di migliaia di poliziotti, soldati e civili,
ha finito per incrinare i legami con i Taliban afghani, contrari a
colpire uno stato che li ha a lungo protetti, finanziati e armati.
Al contrario, si sono rafforzati i rapporti operativi con al-
Qaida: oltre ad addestrarsi assieme, i militanti di Ttp e quelli qai-
disti sembrano condividere rifugi e basi operative, gli esperti di
esplosivo e parte dei meccanismi di finanziamento. Questa cre-
scente sinergia preoccupa gli analisti di anti-terrorismo, dato che
sono comprovati anche i legami con altre organizzazioni regionali,
soprattutto con il Movimento islamico uzbeko. Vi è quindi il ri-
schio che il Ttp possa progressivamente trasformarsi da fenomeno
eminentemente locale, che privilegia la lotta contro lo stato paki-
stano rispetto al jihad globale, a hub macro-regionale per
l’addestramento e la formazione di cellule jihadiste, seguendo lo
schema già verificatosi nei decenni scorsi nell’AfPak, con cata-
strofiche conseguenze per lo scenario di sicurezza internazionale.
Proprio la violenza degli attacchi e la ferocia con cui Ttp ha
colpito i gangli sensibili dello stato pakistano sembrano aver raf-
forzato la determinazione delle Forze di sicurezza del paese nel
combattere l’organizzazione, ponendo fine a quell’ambiguità nelle
politiche counter-terrorism e counter-insurgency che così tante
7 T. Ruttig, “The Other Side: Dimensions of the Afghan Insurgency: Causes, Actors and Approaches to ‘Talks’”, Afghan Analysts Network, luglio 2009, p. 24.
112 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
critiche hanno attirato contro il governo d’Islamabad. Un cambio
di rotta che è la premessa necessaria per recuperare credibilità in-
ternazionale (e ottenere il rafforzamento della politica di aiuti eco-
nomici e militari occidentali) e per attenuare il clima di sfiducia e
ostilità con il vicino Afghanistan. Nel 2014 le operazioni militari
delle Forze armate pakistane nelle aree tribali sono andate in que-
sta direzione, con attacchi più risoluti ed efficaci contro le milizie
talibane e jihadiste. Il 2015 sarà, da questo punto di vista,
un’importante cartina di tornasole, dato che si tratta del primo an-
no post-Isaf in Afghanistan.
Conclusioni
A distanza di oltre un decennio dall’inizio delle operazioni militari
di Enduring Freedom, che dovevano portare alla distruzione dei
Taliban e di al-Qaida, il bilancio è certamente deludente, dato che
la comunità internazionale ha raggiunto solo una parte degli obiet-
tivi che si era troppo ottimisticamente data.
Il punto cruciale è tuttavia rappresentato oggi dalla distanza fra
la retorica dell’impegno internazionale – e US in particolare – e la
realtà della strategia dei paesi Nato. Se retoricamente continuiamo
a sottolineare l’impegno per la stabilizzazione dell’area
dell’AfPak, la verità è che tutti gli indicatori parlano di un “broa-
der disengagement” da quel quadrante strategico8. Questo perché
l’interesse primario del paese che maggiormente ha investito mili-
tarmente nell’AfPak, ossia gli Stati Uniti, era ed è concentrato
nell’area di contro-terrorismo, più che nella stabilizzazione. E da
questo punto di vista, sia pure con molti distinguo e cautele, è evi-
dente come la presenza US e Nato negli ultimi tre lustri abbia for-
temente indebolito il network terroristico di al-Qaida nella regio-
ne. Al punto che il presidente Obama ha potuto affermare che la
guerra in Afghanistan è riuscita nel «devastating the core al-Qaida
8 Cfr. A.H. Cordesman, “Transition in Afghnistan: Losing the Forgotten War? The Need to Reshape US Strategy in Afghanistan, Pakistan and Central Asia”, Center for Strategic and International Studies, Washington, 23 febbraio 2015.
AfPak: i rischi del broader disengagement 113
leadership, delivering justice to Osama bin Laden, disrupting ter-
rorist plots and saving countless American lives» pur dovendo
ammettere che «Afghanistan remains a dangerous place, and the
Afghan people and their security forces continue to make tremen-
dous sacrifices in defense of their country»9.
Un’affermazione, quella del presidente statunitense, non priva
di verità. Ma quanto appare evidente è l’aleatorietà dei risultati
raggiunti, soprattutto per quanto riguarda il post-conflict institu-
tion building. È quindi importante che il disengagement non fini-
sca per divenire disinteresse del quadrante dell’AfPak, se voglia-
mo tutelare gli interessi occidentali nel lungo periodo e se voglia-
mo rendere credibile lo shift operativo attuato in questi anni. Pas-
sando cioè, da un’azione diretta contro i network dell’estremismo
islamista a un approccio più indiretto tramite il training, il mento-
ring, la partnership e l’assistenza alle forze di sicurezza globali.
Il nostro successo nella distruzione dei canali di collegamento
della cupola qaidista nell’AfPak ha portato a una frammentazione
del terrorismo jihadista e alla sua dispersione. Non alla sua distru-
zione. Come affermato più volte dall’ex comandante generale di
Isaf, il generale Stanley McChrystal: «It takes networks to defeat
networks». Quindi dobbiamo mantenere lo sforzo per un approc-
cio collaborativo, multi-laterale alla lotta al terrorismo che coin-
volga (e motivi) tanto gli attori locali quanto quelli regionali e in-
ternazionali. Infine andrebbero ancor meglio distinti i meccanismi
d’intervento e le politiche tese alla stabilizzazione politico-sociale
o economica da quelli finalizzati alla lotta al terrore.
Tutto ciò è fondamentale non solo per la stabilizzazione di un
quadrante di grande importanza strategica, ma soprattutto indiret-
tamente per evitare i contraccolpi politici e psicologici di un falli-
mento del nostro impegno pluridecennale in Afghanistan. Un col-
lasso del “nuovo Afghanistan” o la ripresa dei network jihadisti
suonerebbe come una sconfitta e un indebolimento dell’immagine
9 The White House, Office of the Press Secretary, “Statement by the President on the End of the Combat Mission in Afghanistan”, 28 dicembre 2014, http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2014/12/28/statement-president-end-combat-mission-afghanistan.
114 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
della Nato, e spingerebbe i governi e l’opinione pubblica – in par-
ticolare quelli europei – a rafforzare la loro contrarietà a politiche
proattive e d’intervento negli scenari d’instabilità mediorientali,
come già evidenziatosi con le crisi nel Levante e in Libia.
Una perdita di fiducia nei processi di post conflict institution-
building e d’interventi counter-terrorism che sarebbe estremamen-
te pericolosa per la sicurezza di un paese geograficamente sovra-
esposto agli effetti dell’instabilità mediorientale come l’Italia. An-
cor più di altri paesi, infatti, la nostra penisola non può evitare di
“tenere alto” il baricentro delle politiche di sicurezza verso il Me-
dio Oriente. Continuare l’impegno nell’AfPak, quindi, lungi
dall’essere una distrazione d’attenzione e risorse verso scenari più
prossimi a noi, è cruciale per mantenere il più possibile proattive
le nostre politiche di sicurezza, evitando di cedere all’illusione che
la “fortezza Europa” si possa difendere solo dall’interno del conti-
nente, senza impegnarsi nei quadranti di crisi euroasiatici e medi-
terranei.
7. I pericoli di una spirale balcanica
Giovanni Giacalone
La minaccia jihadista oggi va ben oltre il raggio d’azione medio-
rientale, coinvolgendo anche aree prossime all’Italia; una di queste
è l’area balcanica occidentale, dove le difficili condizioni socio-
economiche di alcune zone permettono all’ideologia jihadista di
far breccia nelle menti dei giovani, portando la cosiddetta “spirale
balcanica” a una nuova fase, quella dell’esportazione di combat-
tenti all’estero. Un fenomeno che non può assolutamente essere
sottovalutato e che comporta seri rischi per il nostro paese.
Con il termine “spirale balcanica” s’intende un processo di ra-
dicalizzazione ben preciso che ebbe inizio nei primi anni Novanta
in concomitanza con l’afflusso in Bosnia di jihadisti stranieri, mol-
ti dei quali reduci dalla guerra in Afghanistan, per combattere a
fianco dei musulmani autoctoni contro serbi e croati. In breve
tempo, e grazie anche al ruolo di varie organizzazioni caritatevoli
e Ong, venne creata l’unità El-Mujahid1, formata in gran parte da
combattenti arabi.
Dopo gli accordi di Dayton del 1995 molti di loro restarono in
Bosnia, sposarono donne del posto, ottennero la cittadinanza bo-
sniaca e diedero vita a delle vere e proprie enclaves in zone come
quella di Zepce, Zenica, Bihac, Teslic, Gornja Maoca. In queste
zone vivono oggi numerose famiglie che seguono alla lettera
l’ideologia salafita e applicano la sharia in modo letterale; non si
mescolano con i “miscredenti” e l’accesso ai loro villaggi è asso-
1 Formato ufficialmente il 13 agosto 1993 dall’esercito bosniaco con l’obiettivo di controllare il crescente numero di jihadisti stranieri che affluivano nel paese.
116 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
lutamente precluso a chiunque non sia un salafita e non sia refe-
renziato.
Col tempo, in Bosnia si sono sviluppate delle vere e proprie reti
gestite da predicatori radicali come Jusuf Barcić, Nusret Imamo-
vić, Bilal Bosnić, Muhamed Fadil Porca (alcuni dei quali ex com-
battenti dell’unità El-Mujahid) che hanno saputo far leva sulle
giovani generazioni soggette a una difficile situazione socio-
economica e a precarie aspettative per il futuro, attirando un co-
spicuo numero di seguaci pronti a passare all’azione in nome del
jihad, tessendo legami anche in Europa, con particolare attenzione
all’Austria, luogo di notevole diaspora balcanica e dove operano
alcuni imam radicali bosniaci2.
Il fenomeno ha fatto breccia anche al di fuori dei confini bo-
sniaci, coinvolgendo Kosovo, Albania, Macedonia e Sangiaccato
serbo; tutte zone nelle quali, negli ultimi dieci anni, si è registrato
un incremento degli episodi d’intolleranza, non soltanto nei con-
fronti dei cosiddetti “nemici dell’islam”, ma anche nei confronti di
alcune branche dell’islam tradizionale, considerato dai salafiti
troppo laico e in alcuni casi “fuorviante” a causa di pratiche da lo-
ro ferocemente avversate.
È interessante notare come nonostante questi salafiti vivano
senza telefoni o televisioni, siano però molto attivi su internet, in
particolare sui social network e in siti e canali YouTube come
www.putvjernika.com (Il cammino dei Credenti),
www.studiotewhid.it.gg e www.sahwa.info, nonché il canale
Muzdaxx, che raccoglie numerosissimi filmati di Bosnić.
Bosnia
La prima comunità salafita in Bosnia venne fondata dall’imam
Jusuf Barcić nel villaggio di Bocinje, ed era principalmente com-
posta da arabi ex combattenti dell’unità El-Mujahid. Barcić si ri-
fiutò di riconoscere leggi e istituzioni bosniache e creò una vera e
propria società parallela fondata sulla sharia. Secondo
2 Tra cui Fadil Porca e Misrad Omerovic “Ebu Tejma”.
I pericoli di una spirale balcanica 117
l’establishment religioso bosniaco ufficiale, l’attività di Barcić ve-
niva finanziata da Muhamed Fadil Porca3, un religioso bosniaco e
capo della moschea di Al-Tawhid, con sede a Vienna, col quale
aveva studiato in Arabia Saudita. In seguito alla morte di Barcić
nel 2007, la leadership passò in mano a Nusret Imamović4.
Nusret Imamović, classe 1971 e successore di Jusuf Barcić, bo-
sniaco naturalizzato austriaco, veterano della guerra di Bosnia ed
ex imam della moschea King Fahd di Sarajevo, ha fatto per un cer-
to periodo la spola tra Vienna e Gornja Maoca. Imamović divenne
meglio conosciuto al grande pubblico bosniaco quando, assieme
ad altri sei salafiti, tre dei quali cittadini austriaci, aggredì il serbo-
bosniaco Mihajlo Kisić a Brcko, nel 20065. Dopo un breve proces-
so, i sette vennero condannati a pene simboliche in libertà vigilata
e alcuni di loro ritornarono a Vienna. Imamović venne poi arresta-
to e rilasciato nuovamente nel febbraio 2010 assieme ad alcuni
suoi seguaci, tra cui Edis Bosnić, cittadino statunitense di origine6
bosniaca, considerato dagli Usa vicino ad al-Qaida e ricomparso
anche recentemente nell’area di Gornja Maoca7.
3 Muhamed Fadil Porca, residente in Austria, imam del centro islamico Tewhid di Vienna. Secondo alcuni funzionari della Comunità islamica di Bosnia, Porca sarebbe tra gli organizzatori di viaggi in Bosnia per i musulmani radicali provenienti da Ger-mania e Austria. Secondo documentazioni del governo austriaco, Asim Cjvanović, il quarantunenne bosniaco che nell’ottobre del 2007 cercò d’infiltrarsi all’interno dell’ambasciata statunitense di Vienna con uno zaino imbottito di esplosivo, al mo-mento dell’arresto aveva con sé un testo, Namaz u Islamu pubblicato proprio dal cen-tro islamico Tewhid di Fadil Porca. 4 Come documentato ampiamente in: A. Ceresnjes, R. Green, “The Global Jihad Movement in Bosnia. A time bomb in the heart of Europe”, Middle East Media Re-search Institute (Memri), 2012 e dal rapporto del Parlamento europeo, Direttorato Generale per le Politiche Estere dell’Unione: “Salafist Wahhabbite support to educa-tional, social and religious institutions”, 2013, http://www.europarl.europa.eu/Reg/Data/etudes/etudes/join/2013/457136/EXPO-AFET_ET(2013)457136_EN.pdf. 5 http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?lng=en&id=98336. 6 http://gudmundson.blogspot.it/2012/06/bosnisk-jihad-i-norrkoping.html?m=1. 7 https://search.wikileaks.org/gifiles/?viewemailid=765133; http://www.islamicpluralism.org/1977/bosnia-re-arrests-top-wahhabi-plotter-after-us;_http://intelwire.egoplex.com/2010_02_09_blogarchive.html; https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/altrenews/2015/03/11/isi
118 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Il 28 ottobre 2011 Mevlid Jasarević si presentò davanti
all’ambasciata statunitense di Sarajevo e sparò un centinaio di col-
pi di Kalashnikov verso l’edificio prima di essere neutralizzato e
arrestato dalle forze speciali bosniache. S’ipotizzò subito il coin-
volgimento di Nusret Imamović e di una sua possibile influenza
nei confronti di Jasarević. In particolare risultò di estremo interes-
se per gli investigatori la permanenza dell’attentatore a Gornja
Maoca, roccaforte di Imamović8. Quest’ultimo prese però le di-
stanze dall’attentato, affermando che fatti di questo tipo non fanno
altro che danneggiare la comunità di Gornja Maoca9.
Fonti bosniache hanno recentemente messo in evidenza come
Nusret Imamović, all’interno del conflitto siriano, si sia schierato
con Jabat al-Nusra, a differenza di Bilal Bosnić che ha invece di-
chiarato fedeltà all’Isis. Secondo quanto affermato da alcuni pa-
renti di jihadisti bosniaci partiti per la Siria, sarebbe stato proprio
Imamović ad averli reclutati10
.
L’esponente che ha però fatto più parlare di sé negli ultimi me-
si, anche per legami con l’Italia, è Bilal Bosnić, originario della
zona di Buzim, vicino al confine croato e ben noto in Bosnia e
all’estero per i suoi sermoni nei quali fa affermazioni del tipo:
«tutto ciò che va da Prijedor al Sangiaccato appartiene ai musul-
mani... Un giorno anche il Vaticano sarà musulmano». In un altro
sermone il predicatore salafita ha incitato i suoi seguaci ad «amare
s-stampa-croata-bosnia-principale-centro-reclutamento_ba2fb855-2718-40c3-84cc-2129019ed035.html. Edis Bosnić risultava attivo nella traduzione di materiale qaedista dall’inglese al bo-sniaco.http://www.slobodna-bosna.ba/vijest/275/gornja_maocha_je_tranzit_za _vehabije_koje_odlaze_u_sveti_rat.html. 8 http://www.theguardian.com/world/2011/oct/28/us-embassy-bosnia-gunman; http://www.sarajevotimes.com/mevlid-jasarevic-is-sentenced-to-18-years-in-prison/. 9 http://www.islamicpluralism.org/1977/bosnia-re-arrests-top-wahhabi-plotter-after-us; http://bportal.ba/nusret-imamovi%C4%87-mevlid-ja%C5%A1arevi%C4%87-nanio-nam-je-%C5%A1tetu-takav-postupak-ne-mo%C5%BEe-se-opravdati-video/; https://www.youtube.com/watch?v=21RFF4vKY2w. 10 http://www.vecernji.ba/nusret-imamovic-medu-najtrazenijim-teroristima-svijeta-963255; http://www.rferl.org/content/syria-balkan-militants-join-rebel-cause/25011213.html.
I pericoli di una spirale balcanica 119
tutti coloro che amano Allah e odiare tutti coloro che odiano Al-
lah; odiare gli infedeli, anche se sono nostri vicini o vivono nelle
nostre case». A luglio del 2011 venne inoltre pubblicato in rete un
video, ripreso anche dal Memri (Middle East Media Research In-
stitute), nel quale si vede Bosnić mentre canta: «con l’esplosivo
sul nostro petto prepariamo la nostra strada verso il paradiso… La
splendida jihad si è innalzata sulla Bosnia… Se Allah vuole
l’America sarà distrutta dalle sue fondamenta»11
.
Bosnić è ben noto anche per i suoi tour che attirano numerosi
seguaci in Austria, Germania, Svizzera, Olanda, Belgio e anche in
Italia dove è stato ospite di alcune comunità islamiche tra cui a
Pordenone, Bergamo, Siena, Cremona e Roma, con tanto di video
pubblicati dai suoi seguaci su YouTube12
.
Ritratto in diverse foto nell’estate del 2014, assieme ad alcuni
seguaci, davanti alla bandiera di IS, il predicatore ha poi dichiarato
in un’intervista al Corriere della Sera di aver conosciuto Ismar
Mesinović, l’imbianchino bosniaco, residente a Longarone e mor-
to in Siria nel gennaio dello scorso anno mentre combatteva nelle
file di IS. Mesinović aveva portato con sé anche il figlio di tre an-
ni, apparso successivamente in alcune foto, presumibilmente nella
zona di Aleppo, accompagnato da alcuni jihadisti13
.
Vi sono poi due cittadini macedoni, Munifer Karamaleski ed
Elmir Avmedoski, rispettivamente residenti a Chies d’Aplago e
Gorizia, recatisi in Siria a combattere, dopo essere entrati in con-
tatto con Bilal Bosnić in uno dei suoi viaggi italiani, come quello a
Pordenone nel giugno del 201314
.
11 http://www.memrijttm.org/bosnian-salafi-preacher-bilal-bosni-sings-songs-of-jihadwith-explosives-on-our-chests-we-pave-the-way-to-paradise.html; http://acdemocracy.org/the-ideology-of-militant-islamism-in-southeastern-europe/#_edn20; http://rogersparkbench.blogspot.it/2012/06/with-explosives-on-our-chests-we-pave.html. 12 https://www.youtube.com/watch?v=ei4y1w40u1M; https://www.youtube.com/watch?v=cw9qKK2u2ZM. 13 http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_agosto_26/propaganda-choc-dell-imam-in-italia-tante-reclute-jihadiste-d758bf6c-2ceb-11e4-b2cb-83c2802e5fb4.shtml. 14 http://serbianna.com/analysis/archives/2929.
120 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Il 3 settembre 2014 Bilal Bosnić e quindici suoi seguaci venne-
ro arrestati in Bosnia dagli agenti della Sipa. Le operazioni coin-
volsero diciassette differenti località della Bosnia-Erzegovina, tra
cui Sarajevo, Zenica, Buzim e Teslić. Durante le perquisizioni è
stata rinvenuta una notevole quantità di armi, munizioni, attrezza-
ture militari, tessere sim, computer ed altre apparecchiature infor-
matiche. Alla fine di dicembre 2014 un tribunale bosniaco ha con-
validato la custodia cautelare per Bilal Bosnić fino a dicembre
2016 e lo scorso 11 febbraio è iniziato il processo a suo carico15
.
Kosovo
Il radicalismo di matrice islamica è progressivamente cresciuto nel
tempo anche in Kosovo, partendo dall’immediato dopoguerra
(1999) in maniera ridotta, fino a diventare una notevole minaccia
per la sicurezza dell’area. Lo scorso 10 marzo il segretario della
Comunità Islamica del Kosovo, Resul Rexhepi, ha affermato che
IS offrirebbe ai giovani kosovari uno stipendio di 20-30 mila euro
per andare a combattere in Siria e Iraq. Una proposta estremamen-
te allettante per una generazione in difficoltà a causa della difficile
situazione economica e dell’alto tasso di disoccupazione che han-
no portato molti ragazzi ad abbracciare l’estremismo islamico16
.
Il direttore esecutivo del Kosovo Center for Security Studies,
Florian Qehaja, ha spiegato come l’islam politico faccia fatica ad
allargare ulteriormente il proprio raggio d’influenza sulla società
kosovara; ragion per cui si fa dunque ricorso alla violenza e al ji-
had. Sempre secondo Qehaja, i gruppi estremisti in Kosovo sono
molto ben organizzati e finanziati. Il potenziale ritorno di jihadisti
15 http://balkans.aljazeera.net/vijesti/produzen-pritvor-huseinu-bilalu-bosnicu; http://www.balkaneu.com/salafi-leader-trial-continues/; http://uk.reuters.com/article/2015/02/11/uk-mideast-crisis-bosnia-cleric-idUKKBN0LF20R20150211; http://www.haaretz.com/news/middle-east/middle-east-updates/1.641980. 16 http://opozita.com/2015/03/18/shqiptaret-i-bashkohen-isis-per-30-mije-euro/.
I pericoli di una spirale balcanica 121
kosovari attualmente in Medio Oriente diventerebbe un rischio per
la stabilità e la sicurezza dell’area17
.
Fulcro del radicalismo islamista in Kosovo è Rastelica, città di
4.700 abitanti situata nel sud della regione, in una fascia che si
estende a sud di Prizren. Tra agosto e settembre 2014 le Forze di
sicurezza kosovare hanno messo in atto una serie di operazioni an-
ti-terrorismo che ha portato all’arresto di una quarantina di perso-
ne in diverse località kosovare, tutte sospettate di essere coinvolte
a supportare e reclutare volontari per il jihad. Tra gli arrestati figu-
rano anche dodici imam tra cui Shefqet Krasniqi, Idriz Bilibani e
Mazllam Mazllami, tre volti noti alle autorità italiane in quanto
ospitati in centri islamici, rispettivamente a Grosseto, Siena e
Cremona18
.
Bilibani, noto anche come “Ebu Usama”, nel 2010 fu arrestato
nella zona di Prizren assieme ad alcuni militanti; il gruppo venne
trovato in possesso di armi e munizioni19
. Nel 2012 Bilibani appa-
re in un video girato presso il Centro Islamico “Rastelica” di Mon-
teroni d’Arbia (SI), assieme a Bilal Bosnić20
. Il “Rastelica”, fre-
quentato principalmente da kosovari-albanesi, viene gestito
dall’imam kosovaro Sead Bajraktar, noto sia alle autorità italiane
che kosovare per frequenti viaggi in patria, dove s’incontra con
altri esponenti dell’islam radicale. Nel luglio del 2012 venne arre-
stato, assieme ad altri esponenti della moschea di Monteroni
d’Arbia, tra le montagne di Dargas mentre partecipava a un “cam-
peggio islamico” che ricordava molto lo stile paramilitare, anche
se la polizia non trovò armi.
17 http://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Kosovo-estremismo-religioso-in-crescita-155153. 18 http://friendsofkosovo.com/tag/imams/; http://www.telegraf.rs/vesti/773249-kosovski-dobrovoljci-ratuju-u-siriji. 19 Secondo la stampa serba il gruppo, composto da tre albanesi con passaporto bo-sniaco (incluso Bilibani) e due albanesi della zona di Prizren, aveva anche fondato una società dal nome “Sincerità” (Sinqeriteti), http://serbianna.com/blogs/bozinovich/archives/615. 20 https://www.youtube.com/watch?v=7hqultvzrqw.
122 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Albania
Un altro scenario di estremo interesse per quanto riguarda il pano-
rama jihadista dei Balcani è quello albanese; anche nel “paese del-
le aquile” si è infatti registrato un progressivo incremento della
presenza salafita, in particolare nelle aree più disagiate di Tirana e
nelle zone di Elbasan, Cerrik e Librazhd. I predicatori di turno,
spesso legati ad ambienti criminali, anche in questo caso fanno le-
va su giovani in condizioni di forte disagio economico, per indot-
trinarli all’ideologia del terrore, convincendoli a partire per il jihad
e fornendo loro i mezzi logistici e finanziari per raggiungere il
fronte.
Nel marzo 2014 la polizia albanese ha emesso mandati di cattu-
ra per dodici membri21
di un’organizzazione facente base
all’interno di una moschea della capitale; tra gli arrestati anche
due imam, Genci Balla e Bujar Hysa, accusati di essere a capo
dell’organizzazione e di aver reclutato più di settanta volontari per
il jihad in Siria e Iraq. Le operazioni hanno coinvolto diverse loca-
lità dell’Albania tra cui Tirana, Elbasan e Pogradec e le Forze di
sicurezza hanno recuperato notevoli quantità di armi, esplosivi,
munizioni, mimetiche, telefonini con schede sim, documenti in
arabo e apparati radio. Secondo gli inquirenti albanesi, il gruppo
finanziava i viaggi in Turchia dei jihadisti, i quali venivano a loro
volta preparati in loco per essere poi trasportati oltre il confine con
la Siria.
Il raggio d’azione dell’organizzazione andava ben oltre i confi-
ni albanesi, coinvolgendo anche l’Italia, come nel caso di Maria
Giulia Sergio e del marito albanese Aldo Kobuzi, entrambi partiti
per il jihad in Siria grazie al supporto dell’organizzazione di Balla
e Hysa.
Aldo Kobuzi ha vissuto per diverso tempo nel grossetano, dove
ha frequentato un centro islamico locale, ma non è il primo della
famiglia a radicalizzarsi; sua madre Donika infatti, anche lei resi-
dente in zona per un certo periodo, è stata la prima a sposare
21 Tra gli arrestati ci sono Genci Balla, Bujar Hysa, Edmond Balla, Zeqir Imeri, Ver-di Morava, Fadil Muslimani, Astrit Tola.
I pericoli di una spirale balcanica 123
l’ideologia islamista, seguita poi dalla figlia Serjola che ha a sua
volta sposato Mariglen Dervishllari, albanese di Pogradec, morto
in Siria mentre combatteva nelle file dei jihadisti. Secondo fonti
albanesi, anche Donika e Serjola si troverebbero attualmente in
Siria assieme a Maria Giulia Sergio. Tempo addietro, la polizia
albanese aveva intercettato una conversazione telefonica tra Der-
vishllari e Hysa, nella quale il miliziano riferiva al predicatore di
aver dato il suo contatto ad Aldo Kobuzi: «Ti sto mandando mio
cognato, gli ho dato il tuo numero».
Bujar Hysa, imam della moschea di Mezezit, è senza dubbio
uno dei predicatori di spicco dell’estremismo islamico locale, noto
anche presso la diaspora albanese in Italia e avrebbe persino ope-
rato come insegnante di Corano per i bambini presso alcune mo-
schee della periferia di Tirana. Fonti albanesi parlano addirittura di
possibile reclutamento di minori da mandare a combattere22
. Il 17
marzo 2015 per nove degli arrestati è iniziato il processo, con le
accuse di reclutamento, indottrinamento e finanziamento a favore
di organizzazioni terroriste23
.
Macedonia
L’infiltrazione salafita in Macedonia ebbe inizio a fine anni No-
vanta, dopo gli accordi di Dayton che posero fine alla guerra in
Bosnia. Durante il conflitto macedone del 2001 fu segnalata la
presenza di un battaglione di jihadisti noto come “Imran Elezi”,
composto da circa un centinaio di mujaheddin e operante nella re-
gione di Kumanovo, Tetovo e Skopje24
. I salafiti non tardarono a
prendere il controllo di numerose moschee del paese e in partico-
22 http://www.panorama.com.al/shkolla-sekrete-brenda-ne-xhami-pranga-dy-imameve-qe-rekrutuan-70-shqiptare-per-ne-siri/. 23 http://www.durreslajm.com/aktualitet/%E2%80%9Cna-mbron-allahu%E2%80%9D-t%C3%AB-akuzuarit-p%C3%ABr-rekrutimet-e-siris%C3%AB-nuk-pranojn%C3%AB-avokat. 24 http://dl.fzf.ukim.edu.mk/index.php/sd/article/download/892/897; http://www.ab.xlibx.com/1economy/1662-8-thesis-the-spread-islamic-extremism-the-republic-macedonia-ata.php.
124 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
lare nella capitale, come quelle di Yahya Pasha, Sultan Murat,
Hatundzik e Aladja. Dai primi anni Duemila sono inoltre aumenta-
ti gli episodi d’intolleranza nei confronti dei sufi, storicamente
presenti sul territorio. Nel 2002 ad esempio, una tekke Bektashi di
Tetovo venne invasa e occupata da alcuni estremisti salafiti dopo
aver minacciato gli occupanti e nel dicembre 2010 un’altra tekke
Bektashi fu data alle fiamme, tanto che la leadership sufi fu co-
stretta a contattare le autorità statunitensi presenti in Macedonia
affinché facessero pressione sul governo macedone per far allon-
tanare i jihadisti25
.
L’islam radicale cerca di strumentalizzare i pesanti attriti tra
albanesi e macedoni, sfociati anche recentemente in violenti scon-
tri26
, per diffondere la propria ideologia tra gli albanesi, di religio-
ne musulmana, contrapponendoli ai macedoni ortodossi. Alle ul-
time manifestazioni di Skopje sono infatti iniziate ad apparire
bandiere islamiste affianco di quelle albanesi; vessilli neri o verdi,
con la shahada. In realtà non è la prima volta che l’ideologia sala-
fita penetra nelle manifestazioni di piazza in Macedonia; secondo
alcune fonti la prima apparizione in pubblico sarebbe avvenuta nel
2006, in seguito alle proteste per i fumetti raffiguranti il profeta
Maometto, pubblicati su un giornale danese. All’epoca, circa mille
manifestanti si riunirono fuori della moschea Yahya Pasha di Sko-
pje al grido «Allah è grande», con bandiere islamiste; stessa scena
anche a Tetovo. Secondo gli apparati di sicurezza macedoni, la
maggior parte dei manifestanti era formata da giovani studenti, fa-
cili prede della propaganda jihadista.
25 http://www.islamicpluralism.org/415/when-wahhabis-attack-the-case-of-the-harabati-tekke; http://www.islamicpluralism.org/2340/the-bektashi-alevi-continuum-from-the-balkans-to; http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010_5/168324.htm. 26 Il 4 luglio 2014 alcune migliaia di manifestanti di etnia albanese hanno messo a ferro e fuoco le strade di Skopje al grido: «Non siamo terroristi, vogliamo giustizia» e «Vogliamo la Grande Albania». Il corteo ha cercato di raggiungere i palazzi governa-tivi e la polizia macedone è stata costretta a intervenire in forze con gas lacrimogeni, e spray urticanti. Le proteste sono scoppiate in seguito al verdetto di un tribunale di Skopje che aveva condannato all’ergastolo sei estremisti albanesi per l’omicidio di cinque cittadini macedoni durante la Pasqua Ortodossa del 2012.
I pericoli di una spirale balcanica 125
Il possibile ritorno dei jihadisti dalla Siria e la presenza di cit-
tadini macedoni che combattono tra le file dello Stato Islamico in
Siria e Iraq sono elementi di grande preoccupazione per il governo
macedone che ha recentemente introdotto pene severe per chi do-
vesse decidere di recarsi all’estero per combattere. Il ministro de-
gli Interni, Gordana Jankulovska, ha sottolineato il pericolo di un
loro potenziale ritorno, aggiungendo che il governo non ha una
stima precisa del numero di macedoni presenti in Siria, ma per ora
quattro risultano deceduti27
. Lo scorso marzo, Zekiri Muhammad e
Immer Bunjamin Gërçec, due jihadisti macedoni, assieme a un cit-
tadino kosovaro, erano stati accusati di aver assassinato tre agenti
di polizia nel sud della Turchia28
. Il 12 giugno, in un video pubbli-
cato su YouTube, apparivano alcuni jihadisti dello Stato Islamico
mentre mostravano i propri passaporti macedoni. Macedoni erano
poi Munifer Karamaleski ed Elmir Avmedoski, entrambi partiti
dal nord-est dell’Italia per unirsi ai jihadisti in Siria. Nella zona
nord-occidentale della Macedonia sono concentrate diverse rocca-
forti salafite e la vicinanza con il Kosovo e il Sangiaccato serbo,
altre zone ad alta presenza radicale islamista, non fanno che rende-
re il tutto più pericoloso.
Conclusioni
Le aree territoriali caratterizzate da instabilità politica ed econo-
mica sono particolarmente sensibili alle infiltrazioni jihadiste, co-
me illustra anche Vlado Azinović, esperto di sicurezza nei Balcani
e autore del libro Al-Qaeda’s presence in Bosnia-Herzegovina; un
paese con istituzioni assenti, in preda a una forte crisi politica, do-
ve vige un indebolimento dei valori morali, diventa terreno fertile
per la propaganda degli imam radicali, e purtroppo i fatti dimo-
strano che è esattamente ciò che sta accadendo29
.
27 http://www.balkaninsight.com/en/article/jihadists-in-syria-pose-threat-for-europe. 28 http://friendsofkosovo.com/2014/03/28/macedonia-set-to-imprison-jihadists-who-fight-in-syria/. 29 http://www.rferl.org/content/bosnia-islamists/24916517.html.
126 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
È la prima volta che un numero così elevato di musulmani pro-
venienti dai Balcani si mobilita per andare a combattere guerre in
Medio Oriente, con tutti i relativi rischi di un loro potenziale rien-
tro. Secondo alcune stime della Central Intelligence Agency circa
350 jihadisti bosniaci sarebbero presenti in Siria e Iraq, 150 dal
Kosovo, 140 dall’Albania e 20 dalla Macedonia30
.
I Balcani sono la porta sud-orientale dell’Europa e l’Italia ha
tutte le ragioni per preoccuparsi vista la prossimità territoriale (ben
più vicina della Libia), come dimostrano i collegamenti con alcune
reti e gli sviluppi di alcuni casi che hanno visto coinvolti predica-
tori e jihadisti su suolo italiano.
30 http://www.agenzianova.com/a/546626c9b612a5.41394587/885863/2014-11-14/terrorismo-usa-inviano-70-procuratori-di-stato-nei-balcani-in-medio-oriente-e-nord-africa-6; http://voiceofserbia.org/it/content/kosovo-%E2%80%93-la-porta-principale-l%E2%80%99islam-radicale-europa; http://www.balkaninsight.com/en/article/hundreds-of-balkan-jihadist-reportedly-joined-isis.
8. Le implicazioni per la politica estera
Arturo Varvelli
Lo scenario internazionale e l’Italia, il “ventre molle” dell’Europa?
L’ascesa del radicalismo islamico in Medio Oriente e Nord Africa,
costituisce l’evento politico internazionale che maggiormente de-
sta preoccupazioni e impone sfide all’Italia nel corso della sua re-
cente storia. Questa rilevanza è data non solamente dalla constata-
zione che il Mediterraneo e il Medio Oriente rappresentino per
l’Italia quell’area di primario interesse politico-strategico incluso
in un ipotetico raggio che, partendo dai vicini Balcani, oltrepassa
la Turchia verso la sponda sud del Mediterraneo fino all’Atlantico,
ma anche per evidenti motivazioni economico-commerciali e di
politica energetica. I fenomeni manifestatisi con l’emergere di un
arco d’instabilità regionale coinvolgono direttamente l’interesse
nazionale dell’Italia in tutte le sue sfaccettature.
In presenza di un sistema internazionale più fluido rispetto al
passato, e con un evidente disimpegno statunitense nell’area, il
Mediterraneo e il Medio Oriente hanno vissuto negli ultimi anni
una molteplicità di episodi destabilizzanti dell’ordine precostituito
ai quali gli attori internazionali, compresi i partner europei
dell’Italia, hanno risposto in modo disorganizzato, spesso su base
unilaterale anziché in un consesso multilaterale, cercando di sal-
vaguardare ognuno i propri interessi nazionali. L’Unione Europea
ha affrontato questi fenomeni con un atteggiamento piuttosto pas-
sivo, incapace di essere artefice di politiche attive, facendo recen-
temente leva solamente su un abbozzato tentativo dell’alto rappre-
130 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
sentante Federica Mogherini di un maggior coordinamento tra i
principali attori europei.
Il contesto internazionale degli ultimi anni sembra inoltre met-
tere in evidenza che i compiti di gendarmeria internazionale, for-
ma di “politica delle cannoniere” su scala collettiva invece che in-
dividuale, affidati sino a pochi anni fa essenzialmente agli Stati
Uniti, potranno essere gradualmente assunti anche da altri paesi, in
primo luogo da quelli europei e arabi. L’intervento da parte statu-
nitense contro l’insorgenza dello Stato Islamico (IS) tra Siria e
Iraq, a difesa del fragile alleato iracheno e atto a favorire la crea-
zione di una coalizione internazionale, non sembra far venir meno
i presupposti della “ritirata strategica” statunitense dai pericoli di
over-streching nell’area mediorientale, con un più attento eserci-
zio degli impegni rispetto alle risorse. Questa riduzione degli ob-
blighi è sembrata chiaramente l’obiettivo dell’intervento in Libia
nel 2011 (il “leading from behind”) ed è stato il presupposto della
mancata azione militare contro il governo siriano di Assad nel
2013. L’ascesa di IS pare costringere gli Stati Uniti, sempre più
egemone riluttante, a rimandare, ma non annullare, la “ritirata” da
questi quadranti1.
All’Italia in particolare, per la sua configurazione geostrategi-
ca, dovrebbero “naturalmente” spettare compiti crescenti, se non
fosse che queste nuove minacce e instabilità hanno colto e colgono
il nostro paese in un momento particolarmente difficile sia dal
punto di vista economico, per il protrarsi di una crisi che ancora
non è conclusa, sia dal punto di vista politico, per l’involuzione
del quadro interno e le difficoltà legate alle stabilità dei nostri ese-
cutivi, dlle quali sembra per ora sfuggire l’attuale governo Renzi.
A questa situazione va aggiunta la progressiva perdita di rilevanza
strategica che l’Italia ha assunto agli occhi dell’alleato statunitense
nell’ultimo ventennio. Se, infatti, l’Italia durante l’epoca bipolare
1 Per un’analisi approfondita dell’attuale sistema internazionale si veda A. Colombo, “La crisi generale dell’ordine internazionale” in In mezzo al guado. Scenari globali e l’Italia. Rapporto 2015, a cura di A. Colombo, P. Magri, Milano, Edizioni Epoké - ISPI, http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/rapporto-2015-mezzo-al-guado-scenari-globali-e-litalia-12145.
Le implicazioni per la politica estera 131
si trovava ai confini della sfera d’influenza di Washington – avan-
guardia e insieme barriera degli interessi e dei valori occidentali in
Europa e nel Mediterraneo nel costante confronto con la minaccia
sovietica – nel ventennio seguente ha perduto questa centralità
geopolitica, “superata” dallo spostamento a est del baricentro eu-
ropeo e dall’asimmetrica guerra al terrorismo.
La gestione delle vicende del Medio Oriente e del Mediterra-
neo nell’ultimo quinquennio da parte dell’Italia ha mostrato tutte
le costanti, e insieme, tutti i difetti della politica estera italiana, a
cominciare dal carattere reattivo dell’azione che ha finito spesso
per sembrare un adattamento tardivo all’evolversi della situazione
internazionale2. Non sola, e neppure ultima, tra i paesi occidentali
a rimanere “sorpresa” dalle rivolte nei paesi arabi, l’Italia ha mani-
festato evidenti oscillazioni strategiche, anche e soprattutto per ef-
fetto dell’ulteriore e drastico deterioramento della vulnerabilità
esterna e interna del paese, esaltate mediaticamente dalle minacce
di IS nei confronti di Roma, che sembrano descrivere e ricordare
l’Italia quale “ventre molle” dell’Europa.
Quindi, al possibile maggior spazio d’azione per l’Italia deri-
vante dall’attuale conformazione del sistema internazionale, e alle
crescenti minacce in un’area di prioritario interesse nazionale,
sembra corrispondere un diminuito potenziale d’intervento del no-
stro paese, tale da far riflettere sull’attuale validità della descrizio-
ne dell’Italia quale media potenza3. Altri attori emergenti, in parti-
colare quelli del Golfo Persico, sembrano acquisire sia politica-
mente sia economicamente un ruolo nuovo e attivo nella regione
del Medio Oriente allargato e nelle relazioni con l’Europa.
L’Italia, sostanzialmente, si trova oggi costretta ad affrontare in
maniera più sistematica la propria politica estera, rivedendo i tra-
dizionali parametri d’azione nei quali si è mossa, anche negli ulti-
mi vent’anni.
2 Si veda A. Varvelli, “L’Italia, l’Europa e la primavera araba”, in Panorama 2012, a cura di N. Pedde, K. Mezran e V. Cassar, GAN, 2012. 3 Sul concetto di “media potenza” e l’Italia si veda C.M. Santoro, La politica estera di una media potenza: L’Italia dall’Unita ad oggi, Bologna, il Mulino, 1991.
132 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Tre miti sull’Italia e il rischio terrorismo
Nell’approccio al terrorismo internazionale di oggi l’Italia ri-
ceve in eredità alcune convinzioni che possiamo definire “miti”. Il
relativo basso numero di tentativi di attentati e attacchi condotti ai
danni del nostro paese, su suolo italiano o all’estero – verso i no-
stri interessi, le nostre rappresentanze o i nostri contingenti militari
– sembra avvalorare la tesi che l’Italia non sia storicamente tra i
maggiori obiettivi delle formazioni islamiste militanti. Gli elemen-
ti a favore di questa visione risiedono essenzialmente nella perce-
zione dell’Italia quale paese dalla limitata propensione interventi-
sta, una delle maggiori cause di rivendicazione di attacchi violenti
contro i nostri partner occidentali, dagli Stati Uniti, alla Gran Bre-
tagna, alla Francia. Senza intervenire qui in merito alla nostra sto-
ria coloniale, questa percezione appare comunque ammantata del
mito autoindulgente degli “italiani brava gente” con il quale anco-
ra spesso il nostro paese ama ritrarsi. In realtà negli ultimi quindici
anni l’Italia ha preso parte, spesso in prima linea, con un’alta
esposizione politica, a tutte le missioni internazionali nell’area
mediorientale, dall’Afghanistan, all’Iraq, al Libano, fino alla Li-
bia, anche nel tentativo di compensare agli occhi del principale al-
leato americano la progressiva perdita di rilevanza geo-strategica,
di cui abbiamo detto, con un presenzialismo che è andato anche
oltre le aree storiche di stretto interesse nazionale.
A questo primo mito, poi, se ne somma un secondo: quello di
una sorta d’immunità da attacchi su suolo italiano che i nostri go-
verni avrebbero pattuito con le organizzazioni terroristiche inter-
nazionali negli anni Settanta e Ottanta. Secondo quest’ipotesi, un
patto, firmato dall’allora presidente del Consiglio Aldo Moro (“lo-
do Moro”), garantiva, in particolare ai palestinesi, la possibilità di
far passare nel nostro paese flussi d’armi, destinati a cellule terro-
riste presenti in Europa, e la liberazione dei terroristi detenuti nelle
carceri italiane. In cambio, i militanti non avrebbero colpito gli ita-
liani e avrebbero lasciato il nostro paese immune da attacchi e atti
Le implicazioni per la politica estera 133
terroristici4. Da allora l’Italia per le organizzazioni terroristiche
sarebbe divenuta, più che un obiettivo sensibile, un comodo paese
di transito nel quale procurarsi documenti falsi o armi, una sorta di
hub per le proprie attività logistiche in preparazione ad attacchi e
attentati da condursi altrove. La “tradizione” si sarebbe protratta
nel tempo anche con le nuove forme terroristiche di stampo isla-
mico radicale5. Se, da una parte, questa teoria di un accordo cer-
tamente non può essere dimostrata e deve essere confinata nel
campo delle speculazioni, dall’altra è vero che la difficoltà di con-
trollo dell’Italia di gran parte delle proprie frontiere e la presenza
del crimine organizzato possano favorire questa “specializzazio-
ne”. Diverse inchieste, l’ultima quella condotta dai magistrati della
procura di Napoli, confermerebbero il suolo italiano come una
tappa, o luogo di transito, per molti personaggi di spicco del terro-
rismo islamico. Napoli stessa, per esempio, costituirebbe una delle
principali centrali europee di produzione e distribuzione dei do-
cumenti falsi6. Tuttavia questa caratterizzazione non può escludere
che l’Italia non sia nel mirino delle nuove forme jihadiste o del
network di al-Qaida. Anzi, IS sembra dimostrare un’attenzione
marcata per l’Italia, indicata chiaramente come obiettivo, non so-
lamente nella ormai celebre copertina della rivista jihadista Dabiq
4 Si veda per esempio G. Pellegrino, presidente Commissione Stragi 1994-2001, http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/video/il-lodo-moro/1944/default.aspx. 5 Relativamente alla percezione dell’Italia quale paese di transito si vedano diverse dichiarazioni di esponenti istituzionali, quali Francesco Rutelli, presidente del Copa-sir: «L’Italia è stato ed è un luogo di transito e di reclutamento per organizzazione terroristiche di tipo jihadistico, ma non un luogo in cui si sono fatti degli attentati», http://www.alleanzaperlitalia.it/articolo/?id=6026&I=Terrorismo__Rutelli__Italia_paese_di_transito_e_reclutamento. Oppure Emma Bonino, ministro degli Esteri: «Tra milioni di rifugiati, tra donne e bambini trova facile nascondiglio tutta una serie di altri signori. Si tratta di un problema europeo perché l’Italia è un paese di transito e dove vanno a finire le cellule dormienti è una questione europea», http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/2014/notizia/terrorismo-allarme-della-bonino-cellule-dormienti-tra-i-rifugiati-_2022237.shtml. 6 A. De Simone, “Napoli crocevia internazionale per la falsificazione di documenti destinati ai terroristi”, Corriere della Sera, http://www.corriere.it/inchieste/napoli-crocevia-internazionale-la-falsificazione-documenti-destinati-terroristi/858428e4-9f22-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml.
134 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
che proponeva un Vaticano sotto la bandiera dello Stato Islamico7,
ma anche nella frequenza dei messaggi, proposti per la prima volta
anche in lingua italiana8. L’Italia nell’attuale congiuntura interna-
zionale non appare quindi per nulla immune dal divenire un im-
portante obiettivo delle nuove formazioni radicali.
Un terzo mito è sembrato invece progressivamente sgretolarsi
con l’ascesa dello Stato Islamico tra Siria e Iraq: la convinzione
che l’esistenza di safe haven in Medio Oriente potessero fungere
da catalizzatore di elementi radicali pericolosi che altrimenti risie-
derebbero in Europa e in Italia, costituendo un fattore di rischio. In
realtà questa percezione – presente anche in apparati di sicurezza
sino a poco tempo fa – è stata rapidamente abbandonata. Consenti-
re ampie zone di rifugio ai jihadisti “lontano da casa” si è dimo-
strato a più riprese contro-producente. L’ascesa di IS ha chiara-
mente dimostrato come la sicurezza internazionale o “esterna” di
un paese sia sempre più legata alla sicurezza nazionale o “interna”
e viceversa, tanto che appare sempre più complesso scinderle. Il
fenomeno dei cosiddetti foreign fighters costituisce il segnale più
evidente di questo legame. Chi parte per combattere sul fronte ira-
cheno e siriano può ritornare un giorno in patria sia con
un’accresciuta capacità operativa, poiché acquisita sul campo di
battaglia, sia con convinzioni più estreme, venendo a contatto con
forme di islam radicale che possono anche non appartenere alla
cultura d’origine. Perciò l’elemento di territorialità e il programma
di state-building di IS, atto a istituzionalizzare la sua presenza
nell’area, costituisce una minaccia grave agli interessi europei e
dell’Italia dal momento che si dimostra potenzialmente capace di
trasformarsi da semplice ideologia a regime totalitario, come ana-
lizzato nel primo capitolo da Paolo Maggiolini.
7 Per un’analisi completa della propaganda del “califfato” di veda Twitter e Corano. La comunicazione dell’ISIS, a cura di M. Maggioni, P. Magri, Milano, ISPI, febbraio 2015. 8 M. Lombardi, “Lo Stato Islamico, una realtà che ti vorrebbe comunicare”, il do-cumento di IS in italiano, http://www.itstime.it/w/lo-stato-islamico-una-realta-che-ti-vorrebbe-comunicare-il-documento-di-is-in-italiano-by-marco-lombardi/.
Le implicazioni per la politica estera 135
La politica estera italiana e il fenomeno del terrorismo tra dimensione repressiva e preventiva
Come evidenziato nella prima parte di questo rapporto la minaccia
jihadista si sta sempre più riposizionando dal settore afghano-
pakistano alla regione del Mediterraneo allargato, finendo quindi
con l’interessare territori di grande rilevanza geopolitica, geo-
economica ed energetica per l’Europa e per l’Italia. Uno degli
aspetti più problematici dal punto di vista analitico, e di conse-
guenza nella valutazione delle opzioni politiche, è quello di riusci-
re a sistematizzare le diverse tipologie di sfide e minacce prove-
nienti da questa galassia jihadista, e in particolare di come conci-
liare la doppia natura simmetrica (la presenza territoriale dello Sta-
to Islamico) e asimmetrica (la minaccia terroristica).
Analizzando le possibili implicazioni per la politica estera ita-
liana, non si può non partire dalle molteplici root-causes alla base
dell’insorgenza del fenomeno: alcune interne alla dimensione
islamica, altre certamente legate alle azioni militari Usa e occiden-
tali in Afghanistan e Iraq, nella progressiva e protratta instabilità
regionale tra Siria e Iraq, oltre che nel “grande gioco” che le due
potenze d’area – Iran e Arabia Saudita – hanno intrapreso in ma-
niera crescente nell’ultimo ventennio, e che proprio in questa in-
stabilità ha trovato il suo humus ideale. Più di ogni altra cosa però,
su questa radicalizzazione progressiva di alcune fasce della società
– in particolare le più giovani – ha pesato il fallimento del modello
sociale, politico ed economico sul quale le società mediorientali si
reggevano.
Possiamo partire da alcuni dati molto semplici. Più del 40 per
cento della popolazione complessiva del mondo islamico vive sul-
la o al di sotto della soglia di povertà di 2 dollari al giorno. In Ye-
men è il 62 per cento degli abitanti, in Sudan è il 69 per cento. In
Egitto, uno dei paesi al centro delle Primavere arabe e il più popo-
loso del mondo arabo con circa 80 milioni di abitanti, parliamo del
40 per cento circa della popolazione9. Nella grande maggioranza
9 Si vedano i dati forniti dalla Word Bank, http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview.
136 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
dei paesi mediorientali la classe media è limitata, l’economia è ge-
stita principalmente dallo stato di concerto con pochi monopolisti,
e da decenni regimi corrotti e clientelari mantengono il proprio po-
tere attraverso la repressione politica e la restrizione delle libertà
civili. Se uniamo questo modello fallimentare alla crescita demo-
grafica che accomuna praticamente tutte le società regionali, pos-
siamo capire perché queste siano altamente instabili e come alcune
fasce sociali siano particolarmente esposte alla radicalizzazione.
Questa chiave di lettura ci permette di comprendere come
l’Occidente, che di questi regimi di fatto era il modello e l’alleato,
sia indirettamente diventato anch’esso “nemico”, facile oggetto di
odio da parte delle frange più integraliste.
Su questo pesa anche l’estrema eterogeneità settaria, e in alcuni
casi etnica, che indebolisce l’autorità statuale di molti paesi me-
diorientali. La questione della divisione interna al mondo musul-
mano è senz’altro centrale. Il terrorismo islamico colpisce soprat-
tutto i musulmani e rappresenta uno scontro tra le diverse fazioni
sunnite da un lato e, dall’altro, tra sunniti e sciiti. Il mondo arabo
musulmano, quello sunnita in particolare, appare alla chiara ricer-
ca di nuove formule identitarie, alle quali IS sembra offrire
un’evidente risposta.
La base d’azione della politica estera italiana, e di quella euro-
pea, dovrebbe trovare fondamento su questi presupposti. Se osser-
viamo la mappa dei regimi falliti, degli stati fragili, o di quelli che
non hanno pieno controllo territoriale, possiamo notare una straor-
dinaria sovrapposizione con le aree di emersione di IS e di altre
forme di islamismo radicale. Facilmente ne possiamo derivare che
la stabilizzazione dell’area sia un obiettivo prioritario dell’azione
italiana, tuttavia questa non può basarsi in via esclusiva su un ap-
poggio a regimi autoritari, poco inclusivi e settari. È facile com-
prendere come un nuovo e rinnovato appoggio a paesi di questo
tipo possa contribuire a riprodurre i medesimi meccanismi che
hanno portato alla destabilizzazione della regione registrata a par-
tire dal 2011.
Bisognerebbe quindi essere in grado di distinguere tra una di-
mensione “repressiva” o militare della politica estera (di cui la co-
Le implicazioni per la politica estera 137
siddetta “guerra” al terrorismo è uno degli esempi più chiari) che
talvolta può essere utile e necessaria, ma che non può rappresenta-
re una sorta di scorciatoia al contrasto del fenomeno (che spesso si
concretizza in interventi armati o, di nuovo, nell’appoggio incon-
dizionato a regimi forti ma non inclusivi) e una dimensione pre-
ventiva più profonda, o più propriamente “politica”, che sia di
contrasto all’emersione delle cause. Certamente si tratta di un più
lungo e laborioso tentativo da parte dell’Italia – da attuarsi in si-
nergia con la UE e i partner europei – di ri-consolidamento dei re-
gimi fragili. In questo senso una rinnovata attenzione agli stru-
menti di nation-building e state-building dovrebbe costituire una
chiave di volta della politica estera europea.
Scegliersi gli amici e gestire le crisi
La nuova retorica anti-terroristica dei paesi occidentali sta ridu-
cendo progressivamente il “leverage” degli stessi sui paesi arabi,
impedendo di fare su questi reali pressioni per portare avanti ri-
forme che possano affrontare le cause profonde della radicalizza-
zione. In Egitto, per esempio, gli Stati Uniti hanno facilitato i tra-
sferimenti di armi avanzate, come aerei ed elicotteri, per aiutare il
regime contro possibili insurrezioni jihadiste, senza riuscire però a
premere su al-Sisi perché non faccia “terra bruciata” intorno a sé
di tutti gli avversari politici e dei critici10
. I partner arabi mettono
spesso in bella vista programmi di “contro-radicalizzazione”, che
hanno lo scopo di evitare riforme atte ad affrontare le cause pro-
fonde dell’esistenza di ideologie radicali. Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti ed Egitto spesso utilizzano questi programmi di con-
tro-ideologia che cercano di minare lo Stato Islamico su basi teo-
logiche, come copertura per evitare riforme politiche, giuridiche
ed economiche più sostanziali. Le figure religiose che si fanno
10 M. Dunne, F. Wehrey, Three risks of US cooperation with its Arab partners, Carnegie Endowment for International Peace, 4 novembre 2014, http://carnegieendowment.org/2014/11/04/three-risks-of-u.s.-cooperation-with-arab-allies-against-islamic-state.
138 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
portatrici di tali messaggi vengono finanziate dai regimi, ma la
mancanza di una legittimità di questi agli occhi dell’opinione pub-
blica, soprattutto giovani emarginati, può inficiare questa batta-
glia.
L’intervento militare a guida saudita in Yemen nel marzo scor-
so sembra testimoniare la perduta capacità statunitense di esercita-
re influenza determinante presso gli alleati storici e una corrispon-
dente rinuncia a essere l’attore militare preponderante negli inter-
venti regionali. Inoltre, l’azione militare rende evidente l’emergere
di nuovi sistemi di alleanze nell’area mediorientale con un conso-
lidamento del fronte sunnita sotto la leadership saudita11
. Queste
evoluzioni sembrano spingere alcuni paesi europei, Italia inclusa,
a cercare un rapporto privilegiato con questo fronte. In realtà, co-
me visto, questa scelta nasconde insidie di lungo termine. Pensare
infatti che l’Italia possa avere capacità d’influenza su questi paesi,
quando neppure gli Stati Uniti sembrano dimostrare di averne, ap-
pare piuttosto illusorio. L’Italia dovrebbe invece tentare di premia-
re, con realismo e pragmatismo, le politiche inclusive, appoggian-
do i gruppi che dimostrano volontà di partecipazione politica in
senso democratico, al di là delle tendenze politiche, ed evitare di
contribuire ad alimentare visioni manichee. In questo senso, sia la
politica estera dell’Egitto, schierato sul fronte anti-islamismo (in-
teso in senso estensivo e soprattutto anti-Fratellanza musulmana)
sia quella della Turchia, sul fronte opposto, appaiono più un pro-
blema che un’opportunità o soluzione. L’Italia è nella posizione,
politica ed economica, di poter contribuire a essere un elemento di
decompressione di queste rivalità, in particolare dal momento che
a trovarsi in contrasto sono storici partner regionali. Questa politi-
ca contribuirebbe a un contenimento delle frizioni e dei contrasti
all’interno dell’area mediterranea e mediorientale che hanno
un’importante incidenza sull’instabilità di diversi paesi e che, con-
11 G. Friedman, The Middle Eastern Balance of Power Matures, Stratford Global Intelli-gence, 31 marzo 2015, https://www.stratfor.com/weekly/middle-eastern-balance-power-matures?utm_source=freelist-f&utm_medium=email&utm_term= Gweekly&utm_campaign=20150331.
Le implicazioni per la politica estera 139
seguentemente, alimentano le cause dell’emersione dell’islam ra-
dicale e violento.
Il caso della crisi libica è piuttosto esemplificativo sia
dell’impellenza dei rischi che l’Italia corre, sia della necessità di
sostenere politiche il più inclusive possibili. I tentativi di media-
zione tra le parti, condotti sinora sotto l’egida delle Nazioni Unite,
non sono riusciti a ottenere i risultati sperati, essenzialmente per-
ché hanno come presupposto di legittimità le passate elezioni e
quindi il riconoscimento della debole Camera dei Rappresentanti
come unico organo rappresentativo del paese. Se questa argomen-
tazione è corretta dal punto di vista formale non lo è dal punto di
vista sostanziale12
. È nell’interesse italiano sorreggere con con-
vinzione la mediazione dell’inviato Onu, non fornendo tuttavia
“patenti di legittimità” a nessuna delle due parti.
Allo stesso tempo le preoccupazioni, principalmente egiziane,
ma anche europee e statunitensi, di una Libia in mano a estremisti
islamici costituiscono un vincolo importante tra l’azione politica e
quella diplomatica che si riverbera fortemente sulla capacità
d’indicare un punto di equilibrio tra le forze in campo nel paese. In
pratica sembra difficile conciliare due esigenze percorrendole in-
sieme: un cessate-il-fuoco con l’attivazione di un dialogo vero tra
le parti (e la formazione di un governo unitario) e il contempora-
neo contenimento della minaccia jihadista.
Solamente scorporando la questione del contrasto alle forma-
zioni islamico-radicali dal più complessivo tentativo di avvio di
dialogo tra le parti in lotta si può immaginare, a livello internazio-
nale, di contenere le pulsioni egiziane (e francesi nel Fezzan) ver-
so un intervento unilaterale indiscriminato, che metterebbe defini-
tivamente in crisi ogni residua speranza di ricomposizione pacifica
del paese e aprirebbe inquietanti scenari di conflitto su scala re-
gionale. Se la crisi legata a una minaccia jihadista in Libia fosse
internazionalizzata, magari con la creazione di una coalizione si-
12 F. Wehrey, W. Lacher, “Libya’s Legitimacy Crisis: The Danger of Picking Sides in the Post-Qaddafi Chaos”, Foreign Affairs, 6 ottobre 2014, http://www.foreignaffairs.com/articles/142138/frederic-wehrey-and-wolfram-lacher/libyas-legitimacy-crisis.
140 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
mile a quella anti-IS operante in Iraq e Siria, o con la sua estensio-
ne sulla Libia, l’Italia e l’Europa avrebbero certamente in mano
carte più rilevanti per contenere gli attori regionali coinvolti e con-
seguentemente creare un nuovo discrimine tra le parti in causa –
nell’adesione alla lotta all’IS – che consentirebbe di rimodulare il
fronte politico.
È evidente che un nuovo intervento militare – proprio come per
Iraq e Siria – non possa essere risolutivo per sconfiggere le forze
radicali sul campo; contemporaneamente, infatti, sarebbe necessa-
rio ricostruire una nuova legittimità del paese. Questa chance è
probabilmente offerta dalla stesura della Costituzione che dovrà
essere il più condivisa possibile e dovrà trovare una sintesi tra le
forze politiche che rispettivamente si sentono attualmente legitti-
mate dalle elezioni o dall’aver preso parte alla rivoluzione. A que-
sto proposito è utile che cadano le pregiudiziali sinora operanti
contro una partecipazione ai negoziati di milizie e gruppi armati.
La Tunisia, d’altronde, può fornire un esempio di modello per
la conduzione di una politica inclusiva in tutta l’area. La Tunisia
appare, a oggi, l’unico paese dell’area mediorientale e nordafrica-
na a portare avanti un lineare processo di transizione politica dopo
le rivolte. Il partito islamico al-Nahda è partecipativo del sistema
parlamentare quale forza politica capace di governare in coalizio-
ne o scendere a compromessi13
. Il recente attacco terroristico ha
dimostrato quanto le forze jihadiste siano disposte a colpire que-
sto modello e quanto la comunità internazionale debba necessa-
riamente sorreggerlo, anche quale elemento altamente simbolico.
Infine, risulta inevitabile che la politica estera e di sicurezza
dell’Italia debba prevedere, rispetto al passato, misure che tenga-
no conto di fattori di riduzione/controllo dei rischi della protratta
instabilità degli stati dell’area, a cominciare da operazioni di con-
trollo delle acque territoriali fino al necessario ri-orientamento dei
13 S.M. Torelli, La transizione politica in Tunisia: opportunità e sfide, Note, n. 54, gennaio 2015, Osservatorio di politica internazionale, Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Ministero degli Affari Esteri, http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/note_tunisia_012015pdf.pdf.
Le implicazioni per la politica estera 141
referenti della nostra politica estera: dagli attori statuali a quelli
sub-statuali. Gruppi politici, comunità locali e tribali, per esempio,
soprattutto quando divengono elementi d’influenza politica e mili-
tare o controllano parte degli interessi economici italiani (pozzi di
petrolio, infrastrutture strategiche, via di comunicazione o traffici),
acquisiscono una rilevanza che non deve essere sottostimata.
Conclusioni
L’Italia, che si trova ad affrontare un periodo d’instabilità che non
si risolverà a breve, deve necessariamente riadattare la propria po-
litica estera. In un contesto internazionale caratterizzato
dall’ascesa di alcuni attori regionali a scapito del tradizionale
egemone americano, al nostro paese è richiesta una nuova capacità
di salvaguardia degli interessi nazionali attraverso l’intervento del-
la diplomazia, ma anche con l’utilizzo dello strumento militare. La
sfida più importante è relativa al fatto che la dimensione repressi-
va del fenomeno terroristico non debba andare a scapito della di-
mensione “politica”. Contrastare le cause profonde del revival
dell’islamismo radicale – in chiave proto-statuale – dovrebbe ri-
manere una priorità da perseguire sul piano bilaterale, ma soprat-
tutto su quello multilaterale. Questo interesse comune con gli altri
partner potrebbe essere fondamentale per un rilancio della politica
estera europea di cui l’Italia potrebbe farsi promotrice.
9. Le implicazioni per la politica di difesa e lo strumento militare
Fabrizio Coticchia
Le Forze armate italiane sono da anni impiegate nel contesto in-
ternazionale per affrontare quelle che sono percepite e definite
quali “nuove minacce”, non puramente militari. In una concezione
multidimensionale della sicurezza nazionale, fenomeni quali im-
migrazione clandestina, terrorismo internazionale, criminalità or-
ganizzata, pirateria, “stati falliti”, crisi regionali e disastri ambien-
tali sono stati affrontati facendo ricorso anche allo strumento mili-
tare. Nello scenario post-bipolare le minacce alla sicurezza nazio-
nale non provengono principalmente da attori statuali e da Forze
armate regolari. Non è più prioritario garantire la difesa dei confini
nazionali come avveniva durante la Guerra fredda. Pertanto si è
passati da una concezione statica dello strumento militare a una
modalità dinamica di continua proiezione esterna delle forze, tesa
a garantire la stabilità in aree di crisi, dalle quali possono emergere
nuove e complesse sfide per la sicurezza nazionale.
Il coinvolgimento in molteplici missioni all’estero rappresenta
il fattore di maggiore continuità della politica di difesa italiana
nello scenario post-bipolare. Grazie al crollo dei constraints inter-
ni e internazionali che avevano di fatto bloccato la Difesa italiana
per decenni, l’Italia ha perseguito una politica bipartisan molto at-
tiva dal punto di vista militare. Dalle operazioni nei Balcani negli
anni Novanta ai più complessi interventi di stabilizzazione, contro-
insorgenza e nation-building del nuovo secolo, il percorso di evo-
luzione compiuto dalle Forze armate italiane è stato davvero con-
siderevole. Tale trasformazione ha riguardato non solo le missioni
sul campo ma anche la struttura della difesa, riformata a più ripre-
144 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
se, e l’atteggiamento della pubblica opinione nei confronti delle
Forze armate, una delle istituzioni più apprezzate dagli italiani.
Un elemento cruciale di questo complessivo processo di evolu-
zione è rappresentato dal cambiamento dottrinale con il quale
l’Italia ha affrontato la sua sicurezza. La natura multidimensionale
della minaccia, e le modalità con le quali farvi fronte, sono al cen-
tro della riflessione strategica degli ultimi decenni. In particolare,
dal 2001 in poi, l’attenzione è stata diretta verso le sfide poste dal
terrorismo internazionale e dal crescente ruolo svolto da attori
non-statuali.
Alla luce delle lezioni apprese durante gli anni della war on
terror, delle operazioni in Afghanistan e Iraq e della lotta globale
al terrorismo, occorre oggi ripensare modalità di azioni e strumenti
impiegati per affrontare tali minacce. L’emergere dello Stato Isla-
mico (IS) e la sua crescente influenza in altri contesti geografici,
rappresenta l’ultimo fenomeno rilevante di un lungo processo sto-
rico che vede confrontarsi stati nazionali con nuove forme di sfide
alla propria sicurezza.
Dall’instabilità regionale ai foreign fighters, dalle connessioni
tra gruppi armati radicali e criminalità organizzata, dalla guerra
psicologica al fronte mediatico, le implicazioni per il futuro della
politica estera e di difesa italiana sono molteplici. Scopo del pre-
sente capitolo è illustrare il percorso di evoluzione della riflessione
strategica nazionale in materia di minacce multidimensionali, ana-
lizzare le lezioni apprese sul terreno nelle azioni di prevenzione e
contrasto al terrorismo internazionale e mettere in luce, infine, lo
sforzo attuale per combattere i gruppi jihadisti di IS. Il focus speci-
fico riguarderà l’ambito della Difesa italiana e il suo complesso
processo di trasformazione (dottrinale e strutturale) volto a con-
frontare nel modo più efficace ed efficiente la minaccia del terrori-
smo jihadista. La dimensione esterna (e non quella della sicurezza
interna e della homeland security) sarà quindi al centro di
quest’analisi. Attraverso l’uso di fonti primarie (quali documenti
ufficiali) e secondarie, la disamina permetterà di ricostruire un
quadro ampio e dettagliato del caso italiano e di avanzare alcune
Le implicazioni per la politica di difesa e lo strumento militare 145
raccomandazioni di policy relative ad approcci e modalità
d’impiego dello strumento militare.
Le minacce alla sicurezza nazionale: la riflessione strategica nazionale
L’analisi della riflessione strategica nazionale relativa alle minac-
ce poste dal terrorismo internazionale e alle possibili azioni di
contrasto attraverso la proiezione esterna delle Forze armate non
può essere scollegata dal processo di rielaborazione dottrinale av-
venuto a livello internazionale in materia di sicurezza.
L’idea stessa di minaccia asimmetrica è stata posta stabilmente
al centro del dibattito globale soprattutto in seguito agli attentati
terroristici dell’11 settembre 20011. La Quadriennal Defense Re-
view (Qdr), presentata al Congresso degli Stati Uniti nel settembre
2001 enfatizza proprio il concetto di asimmetria come logica di
base della dottrina militare statunitense.
La European Security Strategy (Ess) del 2003 evidenzia invece
il carattere transnazionale delle sfide contemporanee, ponendo
l’accento sui rischi, fra loro interconnessi, legati a conflitti regio-
nali, stati falliti, crimine organizzato, armi di distruzione di massa
e terrorismo. Anche il “Concetto Strategico” della Nato del 2010
sottolinea la centralità di minacce ambientali, economiche e socia-
li. Parallelamente, di fronte al proliferare delle sfide non-militari
alla sicurezza, il focus principale della letteratura registra un note-
vole spostamento, muovendo dal concetto di deterrenza a quello di
vulnerabilità. La trasformazione del sistema internazionale rappre-
senta così la premessa all’affermazione di un crescente “spazio
cognitivo”2 nel quale si sviluppano nuovi orientamenti e sistemi di
riferimento concettuale in materia di sicurezza.
1 Dal punto di vista terminologico occorre chiarire come generalmente ogni conflit-to tenda a essere asimmetrico per sua stessa natura, poiché ogni parte cerca di otte-nere un vantaggio sull’avversario al fine d’imporre la propria volontà. La parte “de-bole” punta inevitabilmente ad alterare il livello di densità del confronto. 2 J. Prezelj, “Challenges in conceptualizing and providing Human Security”, HUM-SEC Journal, n. 2, 2008, pp. 23-45.
146 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
La metamorfosi del contesto globale, caratterizzato
dall’impraticabilità di nuove grandi guerre interstatali, ha influen-
zato profondamente non solo la riflessione strategica e la diffusio-
ne di norme e valori, ma ha condizionato l’evoluzione stessa degli
interventi militari. Rupert Smith definisce i conflitti odierni come
«war amongst the people»3, ovvero di guerra tra le gente, in quan-
to la popolazione rappresenta l’obiettivo e il fulcro del confronto,
ben più della mera conquista territoriale. Si tratta del più recente
sviluppo di un processo che trova le sue origini nella guerriglia
spagnola contro Napoleone e prosegue durante la Guerra fredda in
Algeria, Vietnam e in molti altri teatri. Secondo Smith la forza mi-
litare è oggi considerata come soluzione di una serie di problemi
per i quali non è stata originariamente configurata, né ipotizzata.
Il dibattito contemporaneo, in seguito alle difficoltà incontrate
in Iraq e Afghanistan nelle azioni di contrasto a gruppi armati irre-
golari si è concentrato proprio sull’irregular warfare, guerra a
“bassa intensità”, e sul concetto di counterinsurgency. Il manuale
U.S. Army and Marine Corps Counterinsurgency Field Manual 3-
244, elaborato in prima battuta dal generale David Petraeus, che ne
ha poi applicato i dettami in Iraq e successivamente in Afghani-
stan, ha contribuito ad alimentare un’attenzione sulla contro-
insorgenza (Coin). Lo studio di tali operazioni ha messo in luce
come i fattori centrali nelle operazioni di counterinsurgency non
riguardino tanto la distruzione diretta del nemico, ma siano legati a
un approccio indiretto volto a separare la popolazione dagli insor-
ti, garantirne la sicurezza e conquistarne “cuori e menti”. I gruppi
armati che i soldati italiani hanno combattuto in Somalia, Iran e
Afghanistan sono ampiamente riconducibili all’idea di una rete
non unitaria di attori, un network decentralizzato e flessibile.
I fattori sopra descritti illustrano il processo di evoluzione della
sicurezza internazionale che ha caratterizzato i decenni successivi
alla caduta del Muro di Berlino e ha imposto una radicale revisio-
3 R. Smith, The Utility of Force, Allen Lane, 2005. 4 “FM 3-24/Marine Corps Warfighting Publication (MCWP), 3-33.5”, Counterinsur-gency, Washington DC, Headquarters, Department of the Army, and Headquarters, U.S. Marine Corps, 2006, p. 1.
Le implicazioni per la politica di difesa e lo strumento militare 147
ne concettuale e operativa al fine di affrontare al meglio le nuove
sfide e opportunità.
Dal punto di vista della riflessione strategica, occorre osservare
in primis quanto prodotto dall’Italia nei primi anni Novanta. Il mi-
nistro della Difesa Virginio Rognoni presentò il “Nuovo Modello
di Difesa” nel novembre del 1991, subito dopo l’operazione Desert
Storm in Iraq. Il punto-chiave dell’intero documento è
l’identificazione tra la sicurezza nazionale e la salvaguardia degli
interessi politici ed economici all’estero, attraverso una nuova ca-
pacità di power projection dello strumento militare. Squilibri eco-
nomici, nazionalismo, fondamentalismo religioso e terrorismo so-
no descritti come i maggiori elementi d’incertezza del contesto
post-bipolare. Il dispositivo militare italiano è così chiamato a dare
un contributo importante per la gestione delle crisi internazionali.
Non essendoci più bisogno di assicurare la presenza avanzata di
fronte alla possibile invasione sovietica, viene auspicato un gene-
rale processo di ristrutturazione riduttiva delle forze convenzionali
per assicurare flessibilità e mobilità e rispondere a nuove sfide.
Già allora si riteneva la fascia d’instabilità che affligge in partico-
lare Mediterraneo e Medio Oriente foriera di conseguenze dirette
sulla sicurezza europea non più sottoposta a una minaccia di tipo
tradizionale. Il passaggio dalla semplice necessità di difesa al
“mantenimento della stabilità”5 sembra così evidenziare uno dei
fattori ricorrenti nell’approccio nazionale alle crisi, ovvero la per-
cezione della natura multidimensionale della minaccia.
Il Libro Bianco (2002), che risente inevitabilmente del contesto
internazionale emerso in seguito agli attentati dell’11 settembre
2001, illustra una «nuova realtà della sicurezza planetaria»6 nella
quale si auspica che una rinnovata coesione atlantica contrasti ef-
ficacemente la minaccia del terrorismo. Proprio al fine di adattarsi
a scenari in continua trasformazione il “Concetto Strategico del
Capo di Stato Maggiore” (2005) mette poi in luce il bisogno di
5 Ministero della Difesa, Modello di Difesa. Lineamenti di sviluppo delle FF.AA. negli anni
ʼ90, Roma, Stato Maggiore della Difesa, 1991, p. 13. 6 Ministero della Difesa, Libro Bianco della Difesa, Roma, Stato Maggiore della Difesa, 2002, p. 11.
148 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
sposare appieno una logica di flessibilità e interoperabilità delle
forze, sia a livello nazionale che internazionale. Le sfide alla sicu-
rezza del XXI secolo vengono individuate proprio nella minaccia
terroristica, nel potenziale utilizzo di armi di distruzione di massa
e nell’instabilità regionale. Ancora una volta emerge la percezione
diffusa di una natura multidimensionale della minaccia. Il Concet-
to Strategico sottolinea poi la necessità di una forza expeditionary,
che possa cioè intervenire anche a grande distanza dai confini na-
zionali, per «far fronte dinamicamente alla minaccia laddove essa
si alimenta»7.
In conclusione, quindi, la minaccia del terrorismo internaziona-
le e le crisi regionali che possono minare la stabilità internazionale
appaiono come i rischi più concreti che l’Italia dovrà affrontare
nel nuovo contesto post-bipolare. In attesa del nuovo Libro Bianco
(previsto per la primavera 2015), occorre esaminare la modalità
con la quale le Forze armate italiane hanno interpretato la dottrina
nazionale nelle missioni oltre confine. Il prossimo paragrafo illu-
strerà alcune lezioni apprese derivanti dall’impiego dello strumen-
to militare in scenari operativi complessi, nei quali le Forze armate
si sono confrontate con milizie irregolari, insorti e jihadisti.
La politica di difesa italiana e la minaccia jihadista. Operazioni militari e lezioni apprese
Dopo la fine della Guerra fredda l’Italia ha avviato una ristruttura-
zione del proprio sistema difensivo, creato per affrontare la mi-
naccia sovietica, adattandolo a una nuova realtà. Come già sottoli-
neato, il fattore maggiormente innovativo all’interno di questo
processo di trasformazione è rappresentato dalla costante presenza
di Forze armate oltre confine. Molti autori hanno collegato
l’impiego dello strumento militare all’estero con la necessità di
adattarsi al mutato contesto strategico e di proteggere l’interesse
7 Ministero della Difesa, Il concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore, Roma, Stato Maggiore della Difesa, 2005, p. 11.
Le implicazioni per la politica di difesa e lo strumento militare 149
nazionale da nuove e vecchie minacce8. Secondo tale prospettiva,
è proprio la natura multidimensionale delle sfide contemporanee
(dal crimine transnazionale al terrorismo globale) a richiedere una
costante capacità di proiettabilità delle forze oltre confine.
Come illustrato dai documenti strategici, la minaccia posta dai
network terroristici e dall’instabilità regionale, in particolare dal
2001 in poi, è stata considerata la sfida principale dalla Difesa ita-
liana nel nuovo secolo. Molto spesso le analisi delle azioni di anti-
terrorismo si concentrano, giustamente, sulla dimensione interna,
sull’homeland security e sulle cruciali attività di prevenzione, at-
traverso l’uso di strumenti quali intelligence e forze di polizia.
Cercheremo qui di capire, invece, la modalità con la quale le Forze
armate italiane hanno contrastato attori non statuali, quali gruppi
armati radicali, che impiegavano anche tattiche di tipo terroristico
per raggiungere i propri scopi militari e politici. In altre parole, gli
esempi di Iraq (2003-2006) e Afghanistan (2001-2014) aiutano a
comprendere importanti lezioni apprese alla luce del nuovo impe-
gno contro i gruppi di IS in Medio Oriente (e in Nord Africa).
In maniera sintetica, in base all’analisi della letteratura e dei
documenti ufficiali9, possiamo distinguere almeno quattro generali
lessons learnt.
Il primo elemento cruciale nel confronto sul campo con milizie
e gruppi armati jihadisti è rappresentato dall’appropriata pianifica-
zione strategica dell’operazione. Lo studio cross-time
dell’impegno militare rivela atteggiamenti distinti nella predispo-
sizione delle missioni italiane post-2001: approcci, strumenti e ca-
veat diversi ai quali sono corrisposti risultati divergenti sul terre-
8 Si vedano per esempio: G. Cucchi, “Gli interessi Vitali che l’Italia Protegge”, Rela-zioni Internazionali, Milano, ISPI, n. 22, 1993, pp. 66-70; V. Coralluzzo, “Le missioni italiane all’estero, problemi e prospettive”, in L’Italia fra nuove politiche di difesa e impegni internazionali, ISPI Studies, 2012, http,//www.ispionline.it/it/documents/ISPI%20StudiesItalia.htm. 9 Per un’analisi esaustiva delle operazioni militari italiane nell’era post-bipolare si veda F. Coticchia, Qualcosa è cambiato. L’evoluzione della politica di difesa italiana dall’Iraq alla Libia (1991-2011), Pisa, Pisa University Press, 2013. Per una disamina del pro-cesso di trasformazione militare e adattamento delle forze italiane nel contesto post-2001 si veda F. Coticchia, F.N. Moro, Adapt, Improvise, Overcome? The Transformation of Italian Armed Forces in Comparative Perspective, Ashgate, 2015 (in pubblicazione).
150 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
no. Alcune operazioni, infatti, sono state impostate in una logica
coerente con la retorica della “missione di pace”, ma aperte al ri-
schio di mission creep, a causa di un’eccessiva distanza tra piani-
ficazione e realtà (spesso assai ostile) sul terreno. Alcuni interven-
ti, sebbene in contesti conflittuali, hanno adottato un basso profilo,
influenzati da rigidi caveat e regole d’ingaggio (per esempio
“Nibbio” in Afghanistan nel 2003) o perché drammaticamente
privi di mezzi adeguati (come gli elicotteri “Mangusta” in Iraq).
Dopo il 2006-2008, invece, le truppe italiane in Afghanistan hanno
potuto disporre degli asset richiesti per portare a compimento
l’operazione, pur tra le mille difficoltà dello scenario bellico. In
altre parole, le operazioni che prevedono una parte combat devono
poter dispiegare sul terreno tutti i mezzi a disposizione, sia per ga-
rantire un’adeguata protezione dei soldati sia per l’efficacia com-
plessiva dell’intervento, che altrimenti si rivela controproducente e
sostanzialmente fallimentare, come nel caso di “Antica Babilo-
nia”. Le operazioni contemporanee richiedono una direzione stra-
tegica chiara e un’attenta valutazione politica che riduca la distan-
za tra retorica e realtà, tra ambizioni di prestigio e risorse effettive.
Di fronte a scenari in continuo mutamento, la fase post-bellica si
rivela ancora più importante della precedente, proprio per la ne-
cessità pressante di pianificare adeguatamente l’intervento, come
ben illustrato dal caos libico o iracheno.
Il secondo aspetto riguarda la capacità di rafforzare il controllo
del territorio e conquistare il “cuore e le menti della popolazione”
attraverso strumenti non militari. Il confronto con gruppi insurre-
zionali sub-statuali o transnazionali non avviene solo lungo la di-
mensione militare dello scontro armato. Al contrario, i recenti in-
terventi internazionali hanno attribuito una rilevanza crescente alla
sfera politica, economica e sociale. L’analisi delle missioni rivela
la capacità delle forze italiane di operare attraverso tre direttrici
fondamentali. La prima riguarda il ruolo della cooperazione civile-
militare nelle attività di ricostruzione. Un expertise ampiamente
sviluppato dai nostri contingenti, a partire dalle prime operazioni
post-bipolari in Africa e soprattutto nei Balcani. La seconda attie-
ne alla fondamentale azione di addestramento di Forze armate e di
Le implicazioni per la politica di difesa e lo strumento militare 151
sicurezza locali. Un aspetto sempre più importante nelle operazio-
ni contemporanee “tra la gente”, proprio per il valore aggiunto da-
to da attori locali nel rapportarsi con la popolazione e dalla conse-
guente maggiore capacità dello stato di controllare il territorio. In
tal senso, i carabinieri appaiono un asset estremamente richiesto e
apprezzato dai nostri alleati. La terza direttrice è infine quella del
tipo di approccio da tenere sul campo, tra il serrato confronto mili-
tare con gli insorti e il necessario dialogo con la popolazione civi-
le.
Da questo punto di vista “Nibbio” rappresenta un esempio mol-
to interessante. La missione svoltasi nella provincia orientale di
Paktia si poneva l’obiettivo d’interdire i tentativi di attraversamen-
to del confine tra Afghanistan e Pakistan da parte dei membri di
al-Qaida, limitandone la libertà di movimento e neutralizzandone i
“santuari”. Proprio quell’operazione, al di là della durata assai cir-
coscritta (pochi mesi) e del limitato coinvolgimento militare na-
zionale sul terreno rispetto agli alleati, evidenzia l’attenzione posta
dagli italiani al dialogo con gli elder dei villaggi, piuttosto che alle
azioni di search&destroy guidate dalle forze Usa. Queste ultime,
in seguito all’introduzione del manuale di Petraeus e alle nuove
direttive di McChrystal in Afghanistan, adotteranno solo anni do-
po un atteggiamento sul terreno simile a quello italiano, limitando
l’uso del fire power e aumentando gli sforzi per favorire dialogo e
ricostruzione.
In generale possiamo notare come da una parte, senza un effi-
cace controllo del territorio, le attività che le Forze armate com-
piono sul piano economico-sociale si rivelino inutili (come avve-
nuto in Iraq) o limitate (soprattutto se confrontiamo la sproporzio-
ne tra spese militari e non dei più recenti interventi internazionali).
Dall’altro, senza un processo d’inclusione politica degli attori
coinvolti nel conflitto, ogni azione si dimostra inefficace nel me-
dio-lungo periodo. Proprio per isolare le forze jihadiste e gli attori
più radicali legati a network terroristici globali, occorre dialogare
con tutte le componenti del conflitto interessate a una condivisione
del potere a livello nazionale. In Iraq la diminuzione della violenza
in seguito al surge e alla dottrina Petraeus creò le condizioni per
152 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
favorire il ritiro delle forze ma non per risolvere politicamente il
conflitto, come ben dimostrato dall’instabilità recente.
Il terzo elemento cruciale, proprio per agevolare il controllo del
territorio, promuovere il dialogo tra gli attori politici rilevanti e
portare avanti attività di targeting, contrasto e prevenzione di
gruppi terroristici, è l’intelligence. Parallelamente al dispiegarsi
delle truppe in molteplici contesti di crisi, i Servizi italiani hanno
svolto un compito delicato e preziosissimo. La raccolta
d’informazioni attendibili del contesto d’intervento, della natura,
delle risorse e degli obiettivi degli attori in conflitto rappresenta un
fattore decisivo nelle operazioni contemporanee. Al di là del cre-
scente peso di mezzi tecnologicamente avanzati (per esempio dro-
ni) che garantiscono un valore aggiunto in aree complesse, la di-
mensione della Humint (Human Intelligence) riveste
un’importanza cruciale negli attuali conflitti. In particolare lo
stretto connubio tra servizi informativi e forze speciali sul terreno
ha rappresentato uno strumento privilegiato per contrastare gruppi
terroristici e limitarne il possibile raggio d’azione e la capacità
d’influenza.
L’ultimo aspetto attiene al rapporto tra missioni volte a contra-
stare la minaccia terroristica e il grado di “tenuta domestica” nel
sostenerne i costi, umani ed economici. Senza un’efficace “narra-
zione strategica”, che sia coerente con valori e interessi nazionali,
consistente con la realtà sul terreno e chiara in termini di obiettivi
e risultati attesi, sarà complesso “preparare” adeguatamente
l’opinione pubblica e ottenere un consenso durevole. L’Italia non
ha mai portato a giustificazione di un proprio intervento militare
che lo scopo fosse quello di combattere il terrorismo internaziona-
le (nemmeno in Afghanistan), bensì che ci fosse la necessità di
contribuire alla sicurezza internazionale attraverso “missioni di
pace”. In altre parole, la scarsa chiarezza della retorica politica,
necessaria in parte per contare su un consenso bipartisan rispetto a
operazioni di questo tipo, non ha mai contribuito a delineare una
narrazione davvero efficace in relazione alla presunta minaccia
posta da organizzazioni terroristiche.
Le implicazioni per la politica di difesa e lo strumento militare 153
Le lezioni apprese dagli interventi degli ultimi anni, avvenuti
perlopiù in un contesto di grave crisi economica e finanziaria, ri-
velano la pericolosità della discrasia tra retorica e realtà e la cre-
scente difficoltà di sostenere onerose missioni di nation-building
in aree di crisi con molti soldati sul terreno, anche per la scarsa
possibilità di riuscita delle stesse. Ciò contribuisce a spiegare il
“prudente” atteggiamento occidentale verso le attuali crisi in Iraq e
Libia. Da una parte emerge chiaramente la centralità della dimen-
sione politica per risolvere le crisi attuali, dall’altra si è diffusa
gradualmente la convinzione che operazioni più mirate possano
evitare gli errori del passato e rivelarsi maggiormente incisive con-
tro gruppi terroristici.
L’emergere di IS pone però un nuovo dilemma ad attori come
l’Italia, stretti tra restrizioni di bilancio, revisione strategica e la
volontà di dare il proprio contributo per affrontare la minaccia. Il
prossimo paragrafo analizzerà sinteticamente il tipo di apporto
fornito finora dalle Forze armate italiane contro il sedicente calif-
fato.
L’ascesa di IS e l’impegno militare italiano
Nell’agosto 2014, dopo un’accesa discussione in Parlamento,
l’Italia ha deciso d’inviare armi in Iraq per contrastare la rapida
avanzata delle forze di IS. Le armi, perlopiù mitragliatrici, razzi
per Rpg e munizioni, sono state recapitate alle forze che sul terre-
no combattono contro le milizie jihadiste10
. Ma il maggior aiuto
che l’Italia porta alla coalizione internazionale che combatte IS in
Iraq e Siria è fornito dalla poco conosciuta missione “Prima Par-
10 Per un’analisi critica (rispetto alla scelta di mandare armi e in relazione al tipo di mezzi inviati) si vedano rispettivamente, dichiarazioni alla Camera del Ministro della Difesa Roberta Pinotti, “mandare armi e militari in Iraq peggiora la situazione”, Con-trollarmi. Rete italiana per il disarmo, 17 ottobre 2014, http://www.disarmo.org/rete/a/40837.html e G. Gaiani, “ecco la lista delle (poche) armi italiane ai curdi”, Analisi Difesa, 4 settembre 2014 http://www.analisidifesa.it/2014/09/ecco-la-lista-delle-poche-armi-italiane-ai-curdi/.
154 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
thica”. Assieme ad altri paesi l’Italia opera sulla base delle Risolu-
zioni n. 2170 del 15 agosto 2014 e n. 2178 del 27 settembre 2014,
in seguito alla richiesta di soccorso presentata dal rappresentante
permanente iracheno al presidente del Consiglio di Sicurezza
dell’Onu. Come evidenziato dal sito del Ministero della Difesa11
, i
compiti del contingente italiano sono i seguenti: contribuzione con
personale qualificato impiegato negli staff dei comandi della Coa-
lizione, attività Air-to-Air refueling a favore degli assetti della
Coalizione e attività di ricognizione e sorveglianza con aerei a pi-
lotaggio remoto e Tornado IDS. In altre parole, gli aerei italiani
non bombardano, ma hanno funzione di “ricognitori”. Dopo aver
garantito “supporto umanitario” ad agosto e inviato materiale bel-
lico alle Iraqi Security Forces (Isf) e alle milizie curde, l’Italia ha
costituito una Combined Joint Task Force a ottobre, dislocata tra
Kuwait, Qatar, Baghdad ed Erbil. Sempre a ottobre è stata creata
la Task Force Air (TF-A) con circa 190 unità in Kuwait. Sono lì
schierati due Predator, un velivolo da rifornimento in volo KC 767
e appunto quattro velivoli A-200 Tornado IDS. Tra forze aeree e
addestratori sul terreno l’impegno complessivo si quantifica in di-
verse centinaia di uomini.
Proprio le attività di training, come abbiamo visto, rappresen-
tano un dato costante nelle operazioni militari italiane intraprese
nel nuovo secolo. L’Italia assume spesso un ruolo-guida per
l’addestramento di Forze armate e di sicurezza locali in operazioni
multinazionali. Nel corso del tempo anche le modalità di training
si sono adattate al cambiamento degli scenari bellici, come dimo-
stra l’evoluzione compiuta dal complesso processo di training av-
venuto in Afghanistan. I recenti interventi evidenziano come il
processo di temporanea “decentralizzazione” delle responsabilità
di sicurezza (per esempio attraverso milizie di autodifesa) non do-
vrebbe mai minare il ruolo dello stato nel monopolio della violen-
za.
Nel caso dell’Iraq le attività di addestramento saranno princi-
palmente orientate sui sistemi d’arma contro carri e sulla neutra-
11http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Prima_Parthica/Pagine/default.aspx.
Le implicazioni per la politica di difesa e lo strumento militare 155
lizzazione di ordigni improvvisati, un ambito nel quale le Forze
armate italiane hanno sviluppato notevolissime competenze e le-
zioni apprese, in continuità con una delle migliori capacità svilup-
pate negli ultimi decenni, ovvero quello del mine-clearing. Come
riporta il sito del Ministero della Difesa, l’Italia «ha già iniziato lo
schieramento di un Centro di Addestramento finalizzato a coordi-
nare, armonizzare e condurre attività di training a favore delle uni-
tà dei Peshmerga»12
(forze curde nel nord dell’Iraq, coinvolte nelle
operazioni anti-IS). Nel complesso, la partecipazione nazionale
all’operazione a guida Usa Inherent Resolve sembra quindi foca-
lizzarsi su tre direttrici: l’addestramento, la ricognizione aerea e il
supporto umanitario.
È ipotizzabile che tali attività riusciranno a ottenere risultati
concreti solo nel medio periodo. Come ci insegnano le operazioni
intraprese dalle Forze armate italiane durante l’era della war-on-
terror, un efficace addestramento richiede tempo, e deve focaliz-
zarsi non solo sulla dimensione quantitativa (il numero delle unità
“addestrate”) ma soprattutto su quella qualitativa (sviluppando ef-
fettivamente gli adeguati skills richiesti), evitando al contempo i
rischi di pericolose infiltrazioni esterne (come avvenuto in Afgha-
nistan attraverso gli attacchi green on blue da parte di reclute con-
tro gli addestratori).
In generale, appare chiaro ai decisori politici nazionali che seb-
bene lo sforzo militare rappresenti una parte fondamentale
dell’operazione (diretta in particolar modo a sviluppare capacità di
combattimento delle forze locali), la dimensione politica gioca an-
cora una volta una parte fondamentale. Sia all’interno dell’Iraq,
per promuovere quel processo d’inclusione che non è mai stato
portato avanti negli anni di Iraqi Freedom e che ha contribuito ad
alimentare divisioni settarie, soprattutto nelle zone limitrofe o in
quelle adesso controllate da IS. Sia in Siria, dove permane la diffi-
coltà di avviare un processo di negoziazione che coinvolga gli at-
tori in gioco e dove i rapporti con il regime di Assad rimangono
naturalmente complessi. In questo scenario (al cui confine l’Italia
schiera centinaia di soldati all’interno della missione Unifil Liba-
12 Ibidem.
156 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
no) la frammentazione dei soggetti che operano sul terreno rende
molto difficile una soluzione a breve termine di una guerra dram-
matica. È proprio in tale contesto che emerge chiaramente la di-
mensione internazionale del conflitto, con il costante coinvolgi-
mento di potenze regionali. Inoltre, dal punto di vista militare, ci
troviamo di fronte a un paradosso: organizzazioni definite a livello
globale come “terroristiche”, quali Pkk e Hezbollah, sono le uni-
che formazioni che hanno inferto severe sconfitte alle milizie del
sedicente califfato. Al tempo stesso, alleati occidentali e membri
della Nato, come la Turchia, tengono da tempo un comportamento
ambiguo nei confronti di IS, come ben illustrato dalla gestione del-
le frontiere con la Siria.
Infine, in relazione alle possibili implicazioni dell’ascesa del
cosiddetto Stato Islamico per la politica di difesa italiana, occorre
prestare prioritaria attenzione al conflitto in Libia. Qui la presenza
di gruppi legati a IS suscita notevole preoccupazione, sebbene sia
al momento di difficile interpretazione per quanto riguarda i reali
rischi effettivi presenti. Certamente, l’instabilità e la guerra civile
tra le diverse milizie sono un dato di fatto che alimenta da mesi
l’instabilità dell’area, con tutte le potenziali conseguenze che ciò
potrebbe avere per l’Italia. Roma, dopo il riluttante coinvolgimen-
to nell’operazione Unified Protector nel 2011, aveva avviato alcu-
ni interventi (tesi proprio all’addestramento delle Forze di sicurez-
za). Ma, come ben illustrato anche dalla missione nazionale “Mare
Nostrum”, il coinvolgimento degli alleati europei è apparso limita-
to e sfilacciato. L’emergere della minaccia terroristica, così ben
propagandata da IS, dovrebbe spingere l’Italia a svolgere un ruolo
guida nel difficile processo negoziale tra le due principali fazioni
in lotta (le forze islamiste che controllano Tripoli e quelle del “go-
verno” di Tobruk), al fine d’isolare e circoscrivere la potenziale
ascesa dei jihadisti aderenti al “califfato”, senza propendere per
una soluzione militare al fianco dell’Egitto e dei suoi alleati locali.
Questo non vuol dire precludere un’azione puntuale, anche dal
punto di vista d’intelligence e militare, per prevenire e contrastare
ogni minaccia proveniente dalle coste libiche. Ma, come osservato
da Arturo Varvelli nel capitolo 8, ogni intervento dovrà essere
Le implicazioni per la politica di difesa e lo strumento militare 157
guidato da un’attenta pianificazione strategica che si colleghi a un
preciso disegno politico sul futuro della Libia, nella consapevolez-
za che una vasta missione di nation-building simile a quelle intra-
prese in Iraq e Afghanistan difficilmente riuscirà a ottenere risulta-
ti positivi, proprio come dimostrano le negative esperienze passa-
te.
Conclusioni
Osservando il percorso di cambiamento post-bipolare della politi-
ca di difesa italiana è possibile mettere in risalto almeno tre grandi
novità: il contributo alla sicurezza internazionale attraverso le mis-
sioni, le riforme interne (sospensione del servizio di leva, riforma
dei Vertici delle Forze armate, ristrutturazione complessiva del
Nuovo Modello di Difesa, ecc.) e la nuova immagine delle Forze
armate (concezione positiva da parte dell’opinione pubblica del
ruolo dei soldati come “attori di pace”). Al contempo si possono
evidenziare due considerevoli paradossi che ne hanno influenzato
(e ostacolato) il cammino: lo squilibrio del bilancio e della struttu-
ra delle forze e la paradossale rimozione della dimensione militare
nella retorica nazionale. Parziale conseguenza di quest’ultimo
aspetto è stato lo scarso dibattito strategico (l’ultimo Libro Bianco
risale al 2002) e la limitata sistematizzazione di lezioni apprese
durante gli ultimi 25 anni di interventi militari. La Difesa italiana,
al fine di contrastare la minaccia del terrorismo, deve invece poter
contare sul vasto bagaglio di esperienza accumulata nell’era post-
bipolare.
Dal punto di vista dottrinale, come abbiamo cercato di mettere
in luce, si è definitivamente affermata una concezione multidi-
mensionale di sicurezza, non più limitata alla difesa dei confini.
Per far fronte a sfide transazionali, l’Italia è stata costantemente
chiamata a svolgere allora un ruolo attivo a livello internazionale
attraverso le Forze armate. Nello scenario post-Guerra fredda il
tipo di minaccia affrontata dall’Italia non riguarda più un’entità
statuale che rappresenta un pericolo diretto ai confini, bensì crisi
158 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
regionali e conflitti intra-statali dai quali possono delinearsi nuove
sfide alla sicurezza nazionale.
Dal punto di vista operativo, l’analisi degli interventi militari
che hanno visto le Forze armate italiane contrastare gruppi armati
terroristici permette di delineare la centralità di un approccio basa-
to sull’addestramento delle forze locali e sulla più generale rico-
struzione delle capacità delle istituzioni dei paesi d’intervento. Un
processo che appare complicato, specie se in assenza di una chiara
pianificazione strategica e di una convincente narrazione che giu-
stifichi l’impegno oneroso. Ma più di tutto anche le Forze armate
si sono rese conto della priorità di altri strumenti per “vincere” un
conflitto non tradizionale, a partire dal fondamentale processo
d’isolamento dei gruppi terroristici, parallelo a un percorso inclu-
sivo di condivisione del potere tra gli altri attori coinvolti. Mante-
nere tale direzione, assieme al rafforzamento delle capacità di in-
telligence, appare fondamentale per contrastare le complesse sfide
attuali.
10. Le implicazioni per l’intelligence
Marco Minniti
La minaccia jihadista
Il terrorismo islamico continua a rappresentare una minaccia pri-
maria alla sicurezza internazionale e, anche alla luce di quanto av-
venuto nel 2014, costituisce una sfida con cui dovremo confron-
tarci ancora per un lungo periodo.
L’anno scorso si è assistito, infatti, all’affermazione dello Stato
Islamico (IS) nel mondo. Ciò ha segnato un assoluto cambio di
passo, determinando quella che i filosofi chiamano una rottura
epistemologica, perché, per la prima volta, un’organizzazione ter-
roristica si è dotata di un territorio ed è diventata “stato”. In questo
modo l’IS è stato in grado di realizzare ciò in cui nessuno era riu-
scito in passato: avere la capacità di muoversi, da un lato secondo i
canoni tipici di una guerra simmetrica, conducendo una campagna
militare con un vero e proprio esercito, conquistando una parte
della Siria, una parte dell’Iraq, mettendo in discussione il Kurdi-
stan, dall’altro su un piano tipicamente asimmetrico come ogni
gruppo terroristico. A questo si aggiunge anche il raggiungimento
di una capacità economica senza precedenti tra i gruppi terroristi-
ci, ottenuta attraverso molteplici attività a partire dal controllo di
risorse petrolifere.
L’IS rappresenta pertanto una minaccia irriducibile, non gesti-
bile diplomaticamente e che va sconfitta anche militarmente; que-
sto è il senso della grande coalizione internazionale cui l’Italia
partecipa.
Oltre all’IS, un elevato indice di rischio è legato ad al-Qaida
tanto in relazione al tentativo dell’organizzazione terroristica di
160 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
riaffermare il proprio ruolo di leader nel jihad globale, quanto per
eventuali convergenze con lo Stato Islamico in un’ottica antiocci-
dentale.
In questo quadro, le azioni terroristiche compiute a Parigi nel
gennaio 2015 e a Copenaghen nel mese di febbraio hanno ulte-
riormente evidenziato sia l’attualità e la concretezza della minac-
cia jihadista in Europa sia la pericolosità per il nostro continente
del fenomeno degli homegrown terrorists e dei foreign fighters.
I foreign fighters sono cittadini europei o immigrati che risie-
dono stabilmente in Europa, i quali spesso radicalizzatisi su inter-
net e, di sovente, inseriti in contesti di disagio personale, familiare
e socio-economico decidono di raggiungere i teatri di jihad per
“unirsi alla causa”, anche in un’ottica di riscatto personale.
È evidente la grande pericolosità dei militanti di ritorno
dall’esperienza combattente (returnees) che, rafforzatisi nelle pro-
prie posizioni estremiste e acquisito il know how necessario, pos-
sono alimentare circuiti estremisti o realizzare progettualità offen-
sive.
Tanto i returnees quanto i terroristi homegrown (singoli indivi-
dui o micro-cellule) che decidono di attivarsi (selfstarters) hanno
un tasso di pericolosità aggiuntiva dovuta all’elevata imprevedibi-
lità delle loro azioni. Manca, infatti, una centrale strategica, una
catena di comando che assegna l’obiettivo da colpire e poi ci sono
le cellule che eseguono. Al contrario c’è, a livello individuale, il
riconoscimento in un riferimento politico-culturale radicale con la
decisione di passare all’azione.
È il terrorismo molecolare, realizzato da piccoli gruppi o indi-
vidui, con una forte connotazione di spontaneismo. Proprio que-
sto, se ci si ferma a riflettere, è il comune denominatore che acco-
muna gli attacchi terroristici dell’ultimo anno in Occidente. Gli
attentati di Ottawa, Bruxelles, Sidney, Parigi e Copenaghen sono
azioni terroristiche fra loro profondamente diverse, ma che tuttavia
hanno un filo conduttore, costituito dal singolo individuo o dal
singolo gruppo che si attiva sulla scorta di un riferimento ideolo-
gico.
Le implicazioni per l’intelligence 161
In quest’ottica sono di estrema pericolosità, proprio per il ri-
schio di essere recepiti da una vasta platea di internauti radicali, i
numerosi messaggi di propaganda jihadista diffusi sul web in cui
si invitano i musulmani d’Occidente a raggiungere i teatri di jihad,
o a colpire i “miscredenti”, con ogni mezzo, nei loro paesi attra-
verso azioni di jihad individuale.
A tal proposito, il “successo” di azioni terroristiche attuate con
i più disparati strumenti (dall’arma da taglio all’automobile lancia-
ta contro un bersaglio) possono stimolare fenomeni emulativi, pe-
raltro estremamente difficili da prevenire anche perché fuori dagli
schemi tradizionali di valutazione delle capacità organizzative e
operative delle formazioni terroristiche.
Un profilo di particolare attenzione rimanda, inoltre, al flusso
di jihadisti che raggiungono il teatro siro-iracheno dal Nord Afri-
ca, ma che – per personali trascorsi in Europa, per collegamenti
con soggetti residenti nel vecchio continente o per contatti matura-
ti sul campo di battaglia – potrebbero raggiungere il territorio eu-
ropeo.
Anche per questi aspetti il quadrante nordafricano è costante-
mente monitorato dall’intelligence, specie per quel che concerne la
Libia, la cui situazione di sicurezza già fortemente critica, si è ul-
teriormente deteriorata per la presenza di una multiforme galassia
jihadista, nel cui ambito l’IS sta cercando di ritagliarsi visibilità e
spazi sul terreno.
Il peggioramento della situazione con il rischio di una “soma-
lizzazione” della Libia accresce il livello di rischio per il nostro
paese. Ciò impone l’obbligo per la comunità internazionale, e in
primis per l’Europa, di un forte impegno in ambito Onu finalizzato
a spingere le parti a creare un governo di unità nazionale capace di
stabilizzare il paese e di fare fronte comune contro l’IS.
La minaccia verso l’Italia
L’Italia rientra tra i potenziali obiettivi dell’azione terroristica, ol-
tre che per la sua partecipazione alla coalizione internazionale
contro l’IS, soprattutto per la sua centralità per il mondo cristiano.
162 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Esemplificativo in tal senso come la “conquista di Roma” sia
un tema ricorrente nella violenta campagna mediatica di IS e dei
suoi sostenitori. In proposito, tra gli altri, si ricordano: l’audio-
messaggio postato a luglio 2014 in cui l’autoproclamato califfo
dello Stato Islamico al Baghdadi invita i suoi seguaci a combattere
sotto la sua bandiera, così seguendo il suo consiglio «conquisterete
Roma e diventerete padroni del mondo, con la volontà di Allah»;
la copertina della rivista dello Stato Islamico, Dabiq, di ottobre
2014 con la foto della bandiera nera di IS che sventola
sull’obelisco di piazza San Pietro; il video postato sul web
all’indomani dell’attentato parigino alla rivista Charlie Hebdo in
cui si susseguono le immagini di campi di addestramento e quelle
di Roma (piazza San Pietro, Colosseo, Pantheon) con minacce
profferite in lingua araba; il messaggio del 26 gennaio 2015 del
portavoce di IS Abu Muhammad al-Adnani, in cui vengono incita-
ti i jihadisti a colpire in Europa e viene dato “appuntamento a Ro-
ma”; il video dell’IS postato il 15 febbraio 2015 che mostra la de-
capitazione di 21 ostaggi e contiene minaccia all’Italia «Ci avete
visto in Siria, ora siamo qui a sud di Roma»; il documento di mi-
naccia postato online dall’IS nel mese di febbraio in cui, tra l’altro,
s’incitano i lupi solitari a colpire.
Al momento, nel nostro paese sono sottoposti alla particolare
attenzione d’intelligence e Forze di polizia una cinquantina di fo-
reign fighters partiti dal territorio nazionale e comunque a vario
titolo collegati con l’Italia. Sono numeri contenuti rispetto al pano-
rama europeo, dove si stimano alcune migliaia di combattenti. In
ogni caso, però, il rischio di reducismo va valutato anche in rela-
zione all’arrivo nel nostro paese di foreign fighters partiti per la
Siria da altri paese europei o nordafricani.
Nonostante queste considerazioni, a oggi, non sono emersi
concreti segnali di pianificazioni offensive contro il nostro paese
da parte di IS, di al-Qaida o di homegrown terrorists.
In sostanza, a fronte di tre livelli di rischio terrorismo (possibi-
le, probabile, concreto), il nostro paese si colloca al livello del
“possibile”. Può, cioè, essere oggetto di un attentato terroristico. Il
livello di guardia è, però, altissimo, si ragiona quanto a dispositivi
Le implicazioni per l’intelligence 163
di sicurezza come se ci si trovasse di fronte a concrete e precise
situazioni di rischio. Questo è il modo per garantire il massimo
della prevenzione, stando, peraltro, molto attenti a non cadere nel-
la sindrome della paura che costituisce proprio un obiettivo delle
organizzazioni terroristiche.
Lo Stato Islamico, infatti, punta all’opinione pubblica attraver-
so un’attenta strategia comunicativa volta a seminare insicurezza,
terrore e soggezione psicologica e culturale. Si tratta di professio-
nisti della comunicazione, che operano scelte raffinate anche su
dettagli come il taglio delle fotografie: nulla è lasciato al caso. La
violenza esibita delle decapitazioni e, più in generale, delle esecu-
zioni è un pezzo di tutto ciò: ostentare spregio e sicurezza per
spargere terrore.
L’intelligence nell’attività di prevenzione e contrasto
La risposta al terrorismo deve avvenire su più piani.
In primo luogo, a livello militare nei confronti di IS. In tal sen-
so, come sopra ricordato, l’Italia fa parte della coalizione interna-
zionale contro lo Stato Islamico.
Il secondo livello di risposta si trova sul terreno della preven-
zione e, in tale ambito, è di primaria importanza il ruolo
dell’intelligence.
In materia di prevenzione l’Italia costituisce un punto di riferi-
mento, siamo tra i pochi che mettono in condivisione in tempo
reale tutte le informazioni di cui si sia in possesso. In particolare è
eccellente il coordinamento interno al comparto informativo, è sta-
ta ulteriormente rafforzata la cooperazione internazionale
d’intelligence e, attraverso il Comitato di Analisi Strategica Anti-
terrorismo (Casa), viene assicurata una perfetta sinergia tra Servizi
e Forze di polizia. Il Casa è un esercizio ormai consolidato nel no-
stro paese e potrebbe tranquillamente essere esportato come mo-
dello a livello europeo.
Nell’attività di prevenzione è massimo lo sforzo
dell’intelligence che deve avere la capacità d’impiegare al meglio
tutti gli strumenti di cui può disporre. Il contrasto al terrorismo
164 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
molecolare passa sicuramente attraverso l’utilizzo della tecnolo-
gia, specie in relazione al web (sulla cui centralità nelle dinamiche
di radicalizzazione individuale mi sono sopra soffermato), ma as-
sumono grande importanza l’Osint (Open Source Intelligence) e la
Humint (Human Intelligence). Quanto alla prima, oggi, su internet
è disponibile una grande quantità d’informazioni e l’intelligence
deve avere la capacità di enucleare quelle utili; per quel che con-
cerne la Humint, è fondamentale avere la conoscenza del territo-
rio, essere in grado d’infiltrarsi negli ambienti sospetti, avere un
controllo diretto in funzione preventiva di coloro che sono poten-
zialmente sospetti, conoscere le persone e avere anche la piena
collaborazione dell’opinione pubblica. Ciò non significa istituzio-
nalizzare la delazione o vivere in un clima di sospetto, ma la rispo-
sta della società civile è un’arma in più nella lotta al terrorismo. In
questo l’Italia ha già dato prova di grande maturità negli anni ’70-
’80 contro le Brigate Rosse. Un contributo di rilievo potrebbe ve-
nire dall’attivazione dell’islam moderato. In questo senso, è im-
portante promuovere il culto nelle moschee, in ambienti pubblici
trasparenti, perché i rischi maggiori si annidano nel culto cata-
combale o peggio sul web.
Dunque all’attività di prevenzione e contrasto messa in atto da
servizi, magistratura e forze dell’ordine devono contribuire anche i
singoli cittadini, magari segnalando eventuali situazioni sospette.
Nell’ambito di tali attività, particolare impegno viene profuso
dall’intelligence anche in merito alle forme di finanziamento delle
formazioni jihadiste, mirando a individuare fonti e canali di trasfe-
rimento delle risorse finanziarie.
Importante è anche l’adozione di provvedimenti normativi a li-
vello nazionale ed europeo in grado di rafforzare il sistema di con-
trasto e prevenzione.
Pienamente aderenti a tale principio sono le misure che il Go-
verno italiano ha adottato il 10 febbraio scorso, prevedendo nuove
condotte delittuose (tra cui la punibilità dell’auto-addestramento e
quella di reclutatori e reclutati), un’integrazione delle misure di
contrasto delle attività terroristiche condotte con mezzi informatici
e telematici, nuove norme in materia di misure di prevenzione per-
Le implicazioni per l’intelligence 165
sonali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del
terrorismo, nuove norme sui precursori di esplosivi, provvedimen-
ti che ampliano il perimetro giuridico entro cui l’intelligence ita-
liana può operare nell’attività di contro-terrorismo.
A livello europeo, è fortemente auspicabile l’adozione di prov-
vedimenti che garantiscano la libera circolazione all’interno
dell’UE, ma al contempo rafforzino il controllo sulle frontiere
esterne. Tra gli strumenti che possono sicuramente contribuire ad
agevolare il controllo di coloro che vogliono raggiungere le zone
di guerra e di coloro che tornano da tali aree e possono potenzial-
mente condurre azioni violente, rientrano l’implementazione del
Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (Sis II)
e la Direttiva Pnr (Passenger Name Record). Tale iniziativa, pre-
sentata dalla Commissione europea nel 2011, obbligherebbe i vet-
tori aerei a fornire alle autorità competenti (Forze di polizia e Ser-
vizi d’informazione) degli Stati membri i dati dei passeggeri che
entrano in Europa o che lasciano il territorio dell'Unione, per con-
trastare i reati gravi e il terrorismo, garantendo allo stesso tempo la
tutela della privacy. L’analisi dei dati forniti consentirebbe di fo-
calizzare la ricorrenza di voli di determinati passeggeri, ovvero di
tratte ripetutamente utilizzate, in modo da individuare le tratte po-
tenzialmente a rischio o i soggetti suscettibili di ulteriore interesse
informativo. Un segnale importante in questa direzione è rappre-
sentato dalla risoluzione sulla lotta al terrorismo adottata, a lar-
ghissima maggioranza, l’11 febbraio scorso dal Parlamento euro-
peo che prevede, tra l’altro, l’adozione della Direttiva Pnr entro
l’anno.
Il terzo livello di risposta al terrorismo jihadista – necessaria-
mente congiunto agli altri due (militare e prevenzione) – si pone
su un piano politico e dei valori. Deve essere sviluppata un’accorta
politica che eviti facili strumentalizzazioni e muova, al contrario,
verso una dimensione inclusiva e in grado di alleviare frustrazioni
o risolvere problemi di parti della popolazione che possono ali-
mentare scelte estremiste al di là della spinta puramente religiosa.
Il tutto affiancato da programmi di deradicalizzazione per insegna-
re ad apprezzare i valori europei.
166 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Conclusioni
Il terrorismo jihadista, come detto in esordio, è una minaccia irri-
ducibile con cui dovremo confrontarci per un lungo periodo.
L’Europa deve avere la capacità di rispondere come una grande
democrazia, non limitando drasticamente le libertà fondamentali
(come quella di movimento), ma usando tutte le armi tipiche della
democrazia, compresa l’opinione pubblica che, a mio parere, non
rappresenta un punto di debolezza – come ritenuto dalle organiz-
zazioni terroristiche – ma un punto di forza.
La risposta al terrorismo deve, al contempo, muoversi sul ter-
reno militare, della prevenzione e dei valori, puntando a isolare e
colpire la minaccia quando è ancora nel suo stato d’incubazione;
bisogna cioè anticipare la soglia di prevenzione per diminuire il
tasso d’imprevedibilità.
11. Le implicazioni per la politica degli aiuti e dell’immigrazione
Lia Quartapelle
Stati deboli, fragili, falliti, in crisi: un tema affrontato da anni dalla
letteratura internazionale sul nesso tra istituzioni e sviluppo, con
l’obiettivo di capire quali misure possano aiutare il rafforzamento
della capacità degli stati per fare fronte alle sfide multidimensiona-
li del sottosviluppo. Una problematica portata con violenza alla
ribalta del policy-making dalla minaccia jihadista: il terrorismo di
matrice fondamentalista cresce, si addestra, s’insedia in situazioni
di debolezza delle istituzioni statuali e questa debolezza istituzio-
nale ne rende il contrasto endogeno complicato. Al tempo stesso,
l’emergere di un attore che vorrebbe farsi stato come il sedicente
Stato Islamico (IS), o Daesh, avviene in contesti nei quali
l’assenza o lo sgretolarsi delle istituzioni centrali salda
un’ideologia fanatica ai bisogni dei cittadini, altrimenti non corri-
sposti, alimentando con il consenso un estremismo altrimenti de-
stinato a restare confinato in frange assolutamente minoritarie del-
la popolazione. Queste caratteristiche della relazione tra il terrori-
smo di matrice islamica e la fragilità delle istituzioni ha implica-
zioni in particolare per le nostre politiche di cooperazione interna-
zionale. Questo capitolo cercherà di evidenziare come, nel
contrasto al terrorismo, l’Italia debba elaborare strategie
d’intervento in contesti di fragilità che espandano i tradizionali
formati d’interventi di cooperazione internazionale e umanitaria
alla dimensione del sostegno delle istituzioni e alla gestione dei
flussi di migrazione.
168 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Terrorismo e politiche d’aiuto: un dibattito aperto
Gli attacchi dell’11 settembre avevano già presentato in modo
molto evidente che, nelle parole di Colin Powell, «il terrorismo
fiorisce in contesti di povertà, disperazione e mancanza di speran-
za, dove le persone non vedono un futuro. Dobbiamo dimostrare
alle persone che sono tentate dal terrorismo che c’è un altro siste-
ma»1. Per questo, a partire dal 2001, si è sviluppata una vasta lette-
ratura sul legame tra aiuti e terrorismo, con l’obiettivo di legare il
dibattito sull’efficacia degli aiuti al tema non solo della lotta con-
tro la povertà ma anche a quello del contrasto al terrorismo2.
La pratica della cooperazione internazionale, a parte alcune ec-
cezioni – tra cui ad esempio il meccanismo incentivante del Mil-
lennium Challenge Account varato dal presidente americano
George W. Bush – non ha però adattato la capacità d’intervento
alle sfide poste dall’emergere di fenomeni di terrorismo. Questo è
avvenuto per due ordini di fattori: da un lato perché si confidava in
un sicuro quanto lento “trickle down effect” degli aiuti sulle con-
dizioni di vita delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, che
avrebbe favorito il contrasto all’insorgere di fenomeni di estremi-
smo terrorista. Quindi, fintanto che si erogavano aiuti efficaci, si
riteneva che automaticamente questi avrebbero contrastato il terro-
rismo, migliorando le condizioni di vita delle popolazioni.
Dall’altro lato, non c’è stata reale riflessione su come favorire nel-
la pratica la complementarietà e le sinergie tra agenda della coope-
razione internazionale e agenda della lotta al terrorismo perché
condotte da attori molto diversi tra loro, spesso animati da recipro-
co scetticismo se non da diffidenza. Le esperienze di Civil-
Military-Cooperation in Afghanistan, ad esempio, sono state og-
getto di analisi e dibattito acceso non solo tra i practitioners, in vir-
tù proprio della commistione tra strumento militare e intervento
umanitario, che per definizione dovrebbe invece essere un interven-
1 T.S. Purdum, D.E. Sanger, “Forum in New York: The meeting. 2 Top Officials Offer Stern Talk On U.S. Policy”, The New York Times, 2 febbraio 2002. 2 J.P. Azam, A. Delacroix, “Aid and the delegated fight against anti-terrorism”, Re-view of Development Economics, vol. 10, n. 2, maggio 2006, pp. 330-344.
Le implicazioni per la politica degli aiuti e dell’immigrazione 169
to neutrale3. Le critiche più radicali contrastavano l’impianto stesso
della cooperazione civile-militare come modalità che indeboliva gli
effetti positivi di stabilizzazione nel lungo periodo degli aiuti, per-
ché se erogati in un meccanismo legato a interventi militari occiden-
tali questi avrebbero stimolato pulsioni e ideologie radicali piuttosto
che sopirle.
L’emergere del terrorismo jihadista nelle pieghe del fallimento
degli stati, come ulteriore fallimento delle Primavere arabe, ha pe-
rò spostato la necessità di ragionare sulle modalità d’intervento
della cooperazione nel contesto degli stati deboli o fragili. La coo-
perazione internazionale può essere un utile strumento di contrasto
al terrorismo non solo se produce condizioni di benessere econo-
mico che generano speranza, ma soprattutto se rafforza le istitu-
zioni statuali dei paesi a rischio di terrorismo o d’insediamento di
gruppi terroristici. La questione dell’aiuto pubblico allo sviluppo
come strumento di sostegno per le istituzioni non è quindi più un
elemento di discussione solo perché le istituzioni sono fondamen-
tali per la crescita, ma perché istituzioni funzionanti sono il mi-
glior deterrente, la migliore difesa contro minacce terroristiche,
che altrimenti devono essere affrontate dall’esterno con interventi
– non solo strettamente militari, ma anche d’intelligence (si pensi
ad esempio ai casi somalo o pakistano4) – che vengono vissuti più
come intrusione che come azione efficace. Inoltre, gli aiuti (am-
piamente intesi) possono essere uno strumento di leverage in que-
gli stati che sono ambigui nella gestione del fenomeno del terrori-
smo di matrice fondamentalista, come la vicenda nigeriana ha reso
evidente5.
3 D. Rieff, “How NGOs became pawns in the war on terrorism”, New Republic, http://www.newrepublic.com/blog/foreign-policy/76752/war-terrorism-ngo-perversion (12 marzo 2015). 4 V. Nasr, The Dispensable Nation: American Foreign Policy in Retreat, Doubleday, New York, 2013. 5 La gestione del contrasto a Boko Haram da parte del governo nigeriano ha solleva-to molte perplessità sia tra gli alleati regionali che tra i donatori tradizionali del paese, a partire dagli Stati Uniti. Vedi ad esempio J. Campbell, U.S. Policy to Counter Nigeria’s Boko Haram, Council Special Report, 2014, http://www.cfr.org/nigeria/us-policy-counter-nigerias-boko-haram/p33806 (26/03/2015).
170 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Le priorità italiane
Per l’Italia questa riflessione si fa ancora più stringente: la voca-
zione mediterranea del nostro paese pone in modo estremamente
evidente l’urgenza di approntare strumenti per interagire in conte-
sti fragili e in via d’indebolimento, come tutti quei contesti che si
confrontano con le conseguenze delle Primavere arabe. Le nostre
priorità geografiche sottolineano la necessità di elaborare al più
presto politiche d’intervento in situazioni di fragilità: dei venti
paesi prioritari della Cooperazione italiana , infatti, otto (Sudan,
Sud Sudan, Etiopia, Mozambico, Kenya, Somalia, Pakistan, Af-
ghanistan) sono classificati tra i primi venti paesi nell’indice degli
stati fragili, elaborato ogni anno dal Fund for Peace e pubblicato
da Foreign Policy, e sono presenti con sistematicità in altri indici e
studi sulla debolezza delle istituzioni. Inoltre, riteniamo prioritari
altri due paesi, il Libano e la Tunisia, che risentono in modo evi-
dente della situazione di fallimento di stati confinanti (rispettiva-
mente Siria e Libia). La metà dei paesi prioritari dei nostri inter-
venti di cooperazione quindi è interessata dalla problematica della
debolezza o del fallimento degli stati.
Nonostante nella normativa che disciplina la cooperazione in-
ternazionale, la legge 11 agosto 2014, n. 125, all’articolo 1, si dica
che:
La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della
persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria,
persegue, in conformità coi programmi e con le strategie inter-
nazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni
internazionali e dall’Unione europea, gli obiettivi fondamentali
volti a: (...)
b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo,
l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e i princìpi di demo-
crazia e dello Stato di diritto;
prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di ri-
conciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamen-
to e rafforzamento delle istituzioni democratiche,
non è ancora stata sedimentata una riflessione operativa su come
l’Italia possa sostenere le istituzioni dei paesi beneficiari dei nostri
Le implicazioni per la politica degli aiuti e dell’immigrazione 171
interventi, soprattutto in situazioni di post-conflitto. La lacuna ita-
liana è ancora più evidente se si fa riferimento a quanto elaborato
dalla letteratura internazionale in questi anni: vi sono infatti molte
linee guida a proposito, a partire dai Dieci principi per gli stati fra-
gili dell’Oecd-Dac fino a una vasta letteratura “how-to” prodotta
(e utilizzata) soprattutto dal Dfid, il Dipartimento per la coopera-
zione internazionale del Regno Unito.
Il nostro paese si è invece mosso in modo più selettivo: l’Italia
da anni è impegnata a sostenere la crescita delle capacità delle isti-
tuzioni in alcuni ambiti specifici e prevalentemente tecnici. Il pri-
mo settore nel quale essa ha deciso, per esempio, di essere capofila
è quello dell’e-governance. Nel prossimo Documento di pro-
grammazione triennale 2015-2017 della Cooperazione italiana uno
dei settori d’intervento sarà il rafforzamento della capacità dei si-
stemi statistici.
Al di là del sostegno settoriale, c’è stato un intervento di raf-
forzamento istituzionale più propriamente inteso nei paesi post-
conflitto in cui l’Italia è presente. Anche in considerazione delle
ridotte risorse a disposizione della cooperazione internazionale,
l’Italia si è ritagliata un ruolo in alcuni paesi all’interno della divi-
sione del lavoro con gli altri partner internazionali nell’ambito del
rafforzamento delle istituzioni giudiziarie o carcerarie oppure de-
gli enti locali. L’esempio più di successo è il contributo italiano
alla riforma del sistema giudiziario in Afghanistan, dove il nostro
paese è stato capofila dell’intervento internazionale per ricostruire
uno stato di diritto nel paese. Ci sono poi stati gli interventi in
Mozambico nel settore della giustizia minorile, a partire dai primi
anni dopo la fine del conflitto civile, o l’aiuto offerto fin dal 2007
– cioè subito dopo l’avvio dell’operazione Unifil – agli enti locali
libanesi nell’ambito della finanza locale. Si è trattato di impegni
significativi per i risultati ottenuti per i paesi beneficiari e per
l’autorevolezza riconosciuta in loco alla Cooperazione italiana,
che però non ne ha fatto una linea di continuità prioritaria
d’intervento anche in altri paesi o contesti.
Un altro strumento utilizzato per il contrasto all’instabilità (e
quindi al terrorismo di matrice fondamentalista) è stato quello del
172 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
rafforzamento della cooperazione militare e del sostegno alle isti-
tuzioni militari di paesi in transizione, attraverso strumenti di coo-
perazione legati al Ministero della Difesa. L’Italia, insieme al Re-
gno Unito, è stato ad esempio l’unico paese a dare un contributo
alla creazione e all’addestramento di un vero esercito nazionale
libico, che provasse a integrare e amalgamare in un’istituzione na-
zionale le diverse articolazioni tribali e politiche in cui è mano a
mano andata frantumandosi la società libica. Il precipitare della
situazione in Libia ha però interrotto l’addestramento presso
l’accademia di Montecassino di alcune centinaia di soldati libici,
fermando un’azione che certamente avrebbe contribuito al raffor-
zamento di istituzioni unitarie e solide nel paese mediterraneo. La
vicenda della Nigeria è però paradigmatica delle difficoltà connes-
se con questo tipo di assistenza: nel corso della storia nigeriana,
l’esercito è stato un attore di primo piano. Così, negli anni Novan-
ta, sempre l’esercito nigeriano ha svolto un ruolo cruciale di stabi-
lizzazione della regione. Negli ultimi anni, però, questo stesso
esercito si è dimostrato profondamente deficitario e debole nel
contrasto a Boko Haram.
Ripensare la strategia di cooperazione: alcune proposte
L’esperienza nell’ambito del rafforzamento istituzionale della no-
stra cooperazione e le esigenze del contrasto al terrorismo in al-
meno metà dei paesi dove l’Italia è presente suggeriscono quindi
alcune linee d’azione che dovrebbero portare a un ripensamento
della strategia di cooperazione internazionale come tassello della
lotta al terrorismo globale:
l’Italia deve dotarsi al più presto di un documento di riflessio-
ne strategica su come si possa intervenire nei contesti di stati
fragili, deboli o di stati falliti, declinando gli impegni interna-
zionali in questo senso con le lezioni apprese dalla nostra
Cooperazione italiana in contesti quali Afghanistan, Libano e
Libia;
Le implicazioni per la politica degli aiuti e dell’immigrazione 173
in considerazione delle priorità geografiche della nostra coo-
perazione, del posizionamento geografico e della vocazione
mediterranea della nostra politica estera, nonché in considera-
zione delle relativamente ridotte risorse a disposizione della
cooperazione, l’Italia dovrebbe identificare nelle azioni di so-
stegno alle istituzioni una possibile area d’intervento priorita-
rio, con particolare riferimento alle azioni di sostegno al setto-
re della giustizia e a quello del rafforzamento delle capacità di
polizia interna;
l’esperienza italiana, sia politica sia di soluzioni giuridiche e
amministrative, rispetto a situazioni di forte spinta di autono-
mia locale dovrebbe poter essere messa a disposizione in quei
contesti in cui la statualità centrale viene continuamente inde-
bolita da spinte localistiche;
facendo leva sulla grande esperienza maturata in ambito di
peace-keeping internazionale, nel quale viene riconosciuto
uno specifico modo di lavorare italiano, che sa coniugare ope-
razioni militari con cooperazione civile, il nostro paese po-
trebbe produrre riflessioni poi estendibili ad altri paesi alleati
su come associare cooperazione e strumento militare in conte-
sti di fragilità.
Le istituzioni dei paesi del Mediterraneo sono però messe a dura
prova anche dalla gestione di una crisi umanitaria senza preceden-
ti. L’instabilità derivante dalla “Primavera araba” ha infatti deter-
minato movimenti di uomini e donne che sono epocali6 nella re-
gione del Mediterraneo e del Vicino Oriente. La confusione tra
immigrazione e terrorismo portata avanti da alcune forze populiste
europee non deve essere in alcun modo incoraggiata. Resta però il
fatto che la gestione di un’emergenza immigrati senza precedenti
sta pesando su istituzioni statuali già oberate da sforzi per il con-
trasto al terrorismo.
6 O. Karasapan, “The impact of Libyan middle-class refugees in Tunisia”, Brookings, http://www.brookings.edu/blogs/future-development/posts/2015/03/17-libyan-refugees-tunisia-karasapan (23/03/2015).
174 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
La crisi siriana, dichiarata la crisi umanitaria, politica e di svi-
luppo più difficile del nostro tempo da parte del sistema delle Na-
zioni Unite, è la situazione emergenziale più preoccupante: a quat-
tro anni dalle prime rivolte, 11,6 milioni di siriani non hanno ac-
cesso a fonti dirette di acqua corrente e quasi dieci milioni di cit-
tadini siriani hanno bisogno di assistenza alimentare. L’accesso
agli aiuti umanitari, nonostante siano aumentati i bisogni, si è ri-
dotto: rispetto al 2013, solo metà (circa 1,1 milioni) delle persone
che vivono nelle zone di guerra è riuscita ad avere accesso agli
aiuti rispetto al 2013 (2,9 milioni). Non sorprende nessuno quindi
se i rifugiati fuori dalla Siria sono ormai 3,9 milioni di persone,
mentre 7,6 milioni di cittadini hanno lasciato le loro case cercando
possibilità di sopravvivenza nei campi all’interno del paese.
La vicenda libica, in continuo peggioramento, ha prodotto
400mila rifugiati all’interno del paese, cui si sommano almeno
36mila rifugiati da altri paesi in transito verso l’Europa7, e
500mila rifugiati presenti in Tunisia, soprattutto di famiglie libiche
relativamente più abbienti della media tunisina. Il rafforzarsi del
Daesh in Iraq ha prodotto nella seconda metà del 2014 quasi due
milioni di rifugiati all’interno del paese.
La pressione di ondate straordinarie di rifugiati è a tutti gli ef-
fetti un fattore di ulteriore instabilità in contesti già compromessi.
I rifugiati libici, ad esempio, insistono per la maggior parte sul
contesto tunisino dove la loro presenza al momento, pure costi-
tuendo quasi il 10 per cento della popolazione tunisina, è meno
impattante di quanto potrebbe diventare, grazie alla loro capacità
di spesa. L’impatto dei rifugiati siriani in Turchia, Libano e Gior-
dania è invece più marcato: sia in Giordania che in Libano, un abi-
tante su cinque è un rifugiato siriano, con effetti particolarmente
rilevanti rispetto alle capacità di fornitura dei servizi pubblici es-
senziali (in Libano, uno scolaro su due è un rifugiato siriano), o
quello prodotto sulla finanza pubblica (la sola Turchia, ad esem-
pio, spende per i 600mila rifugiati siriani che ospita più del doppio
di quello che spende tutta l’Unione Europea per l’intera emergen-
7 UNHCR, Libya Factsheet, UNHCR Factsheet, febbraio 2015, http://www.unhcr.org/4c907ffe9.pdf (23/03/2015).
Le implicazioni per la politica degli aiuti e dell’immigrazione 175
za Siria, sia a sostegno dei campi profughi nel Vicino Oriente, sia
per l’accoglienza dei rifugiati siriani dentro i confini dell’Unione).
Le situazioni giordana e libanese sono quelle che destano più
preoccupazioni, non solo perché assorbono un numero estrema-
mente alto di rifugiati provenienti dalla Siria, ma perché sono due
paesi che nel passato hanno già dovuto fare i conti con l’ondata di
rifugiati palestinesi, e perché si destreggiano da anni con equilibri
interni molto delicati che tengono anche conto del peso relativo
dei rifugiati palestinesi. A quest’emergenza, che a quattro anni
dalle Primavere arabe si è sostanzialmente trasformata in dato di
fatto strutturale, l’Unione Europea ha risposto con un’operazione
di controllo dei confini, l’operazione Triton, e con l’annuncio di
una revisione delle politiche di accoglienza dei rifugiati che ren-
dano la gestione della problematica davvero europea. Sebbene
l’operazione Triton rappresenti comunque una svolta rispetto
all’operazione Mare Nostrum – solo italiana e che contraddiceva
quello che altri paesi europei facevano (Spagna, Grecia, molto duri
nel contrasto all’arrivo di barconi) –, perché con essa l’Unione Eu-
ropea si è assunta collettivamente la responsabilità delle proprie
frontiere, e quindi della gestione di chi le attraversa scappando da
situazioni inumane, sappiamo che non è abbastanza in termini di
gestione del fenomeno migratorio. L’annuncio di ripensare alle
politiche europee in materia d’immigrazione conferma la tendenza
inaugurata con Triton, ovvero quella di un’assunzione collettiva
europea di responsabilità sui rifugiati. Un impegno che, insieme
alle recenti sentenze della Corte europea dei diritti umani, di fatto
sta smantellando l’idea fondante del Trattato di Dublino, ovvero
che i rifugiati debbano essere gestiti dal primo paese in cui arriva-
no.
Il tema degli stati fragili dovrebbe diventare quindi importante
anche in materia di politiche europee dell’immigrazione. Perché
l’Unione Europea non può a questo punto gestire direttamente una
quota dei rifugiati del conflitto siriano, che scappano da IS, che
fuggono dal regime eritreo, aiutando i paesi limitrofi e gestendo da
lì il loro arrivo in Europa attraverso politiche di reinsediamento?
Sarebbe un gesto che da un lato alleggerirebbe il peso sostenuto in
176 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
questo momento da Turchia, Libano, Giordania, Tunisia ed Egitto,
alleati cruciali nel contrasto al terrorismo che rischiano di collassa-
re sotto il peso della gestione di un’emergenza complessa come
quella dei rifugiati. E sarebbe certamente un aiuto a stati con isti-
tuzioni già fragili, ma messe ancora più a rischio dalle conseguen-
ze delle guerre ai confini. La disponibilità a una più robusta acco-
glienza da parte dei paesi europei potrebbe poi essere un modo per
avere anche una leva nel rapporto con i paesi dell’area, chiedendo
loro maggiore impegno contro traffico e flussi illegali di migranti.
Conclusioni
Le conseguenze delle Primavere arabe sono state molteplici. Tra le
tante, è emerso in modo incontrovertibile il problema di avere a
che fare con attori statuali indeboliti o fragili. Si tratta di un ele-
mento che rende ogni tentativo di contrasto al terrorismo più diffi-
cile da essere perseguito. Le politiche di cooperazione in questi
anni hanno cercato di rispondere alla sfida della debolezza degli
stati come prerequisito per politiche efficaci di crescita e sviluppo
economico e sociale. È nel nesso tra politiche di cooperazione e
rafforzamento delle istituzioni che si apre uno spazio interessante
per l’azione dell’Italia nel contrasto al terrorismo jihadista nel lun-
go periodo. Una volta riconosciuto il problema, ovvero che il ter-
rorismo islamista s’insedia in situazioni di collasso o fragilità de-
gli stati, beneficia d’istituzioni deboli e può essere contrastato ef-
ficacemente solo da istituzioni nazionali comparativamente più
robuste, l’Italia dovrebbe al più presto adeguare le proprie politi-
che di cooperazione internazionale a questa sfida. Con due tipi
d’intervento: da un lato dotandosi di linee guida d’intervento a so-
stegno delle istituzioni, sia come interventi di sviluppo, sia
all’interno di una riflessione sulla cooperazione civile e militare.
Dall’altro, dovrebbe influenzare la costruzione di una politica mi-
gratoria europea che attraverso azioni di reinsediamento contenga
i rischi e i costi dei rifugiati nei paesi con istituzioni messe a dura
prova dalle Primavere arabe e nostri alleati nella lotta al terrori-
smo.
Gli Autori
Andrea Beccaro, Ph.D. in Scienze Strategiche, è DAAD Fellow
presso l’Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft, Freie Univer-
sität di Berlino, già docente a contratto di Relazioni internazionali
(corso avanzato) presso la Scuola Universitaria Interfacoltà di
Scienze Strategiche di Torino. I suoi interessi di ricerca spaziano
dallo studio delle caratteristiche della conflittualità contempora-
nea, alla teoria strategica, dalla guerra irregolare ai conflitti medio-
rientali con particolare riferimento all’area irachena e siriana. Tre
le sue pubblicazioni principali: La guerra in Iraq, il Mulino 2013
e C.E. Callwell, Small Wars. Teoria e prassi dal XIX secolo
all’Afghanistan, LEG, 2012.
Laurentina Cizza studia Relazioni internazionali e i paesi del
Medio Oriente presso la Johns Hopkins School of Advanced In-
ternational Studies (Sais) a Washington DC. In passato ha lavorato
come assistente di ricerca presso il Middle East Institute (Mei), e
Global Policy Advisors (Gpa), società di consulenza sul rischio
politico a Washington DC.
Fabrizio Coticchia è Jean Monnet Fellow all’Istituto Universita-
rio Europeo (Eui) di Fiesole. In precedenza è stato Research Fel-
low alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ha conseguito il tito-
lo di dottore di ricerca in Political Systems and Institutional Chan-
ge presso l’IMT, Lucca. È titolare di corsi di Teoria di Relazioni
Internazionali e Geopolitica in varie università italiane. I suoi temi
di ricerca riguardano in particolare la politica estera e di difesa ita-
liana, la trasformazione militare europea, il rapporto tra opinione
pubblica, retorica politica e operazioni militari. È editor del blog
dedicato ai temi della difesa e della sicurezza “Venus in Arms”.
178 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Giovanni Giacalone è sociologo e islamologo, MA in Islamic
Studies alla Trinity Saint David University of Wales, si occupa da
tempo di Islam politico e radicalismo di matrice religiosa in Italia,
nei Balcani e in Caucaso. Analista per Itstime, Rimse, Serbianna,
ha pubblicato diverse analisi e articoli per istituti e testate naziona-
li e internazionali.
Paolo Maggiolini, Ph.D. in Istituzioni e Politiche presso
l’Università Cattolica di Milano, è Ispi Research Fellow e collabo-
ra con l’Università Cattolica di Milano. Le sue ricerche si focaliz-
zano sul rapporto tra religione e politica in Medio Oriente, con
particolare attenzione alla dimensione del radicalismo islamico e
ai contesti di Israele, Giordania e Palestina.
Karim Mezran è Resident Senior Fellow presso il Rafik Hariri
Center for the Middle East dell’Atlantic Council di Wahington. Si
occupa di Libia, Nord Africa e di tematiche legate alla transizione
araba, alla democrazia e ai diritti umani, e più generalmente di te-
mi di politica e sicurezza del Medio Oriente. È stato a lungo diret-
tore del Centro studi americani di Roma e docente presso il Bolo-
gna Center della Johns Hopkins University e della John Cabot
University (Roma). Ha conseguito un master in Arab Studies pres-
so la Georgetown University (Washington) e un titolo di dottore di
ricerca in Relazioni internazionali presso la Johns Hopkins School
of Advanced International Studies (Sais) di Washington.
Marco Minniti è Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Con-
siglio – Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. È sta-
to Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio nel I Go-
verno D’Alema, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Con-
siglio con delega ai servizi per le informazioni e la sicurezza nel II
Governo D’Alema, Sottosegretario di Stato alla Difesa nel II Go-
verno Amato, Vice Ministro dell’Interno nel II Governo Prodi e
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio – Autorità
delegata per la sicurezza della Repubblica nel Governo Letta.
Wolfgang Pusztai è colonnello dell’Esercito austriaco. Studioso
di tematiche legate alla politica e sicurezza del Nord Africa e del
Medio Oriente, collabora e scrive analisi per diversi think tank in-
Gli Autori 179
ternazionali, tra i quali Atlantic Council, ISPI e IAI, e varie impre-
se. È stato attachè militare per la Libia dal 2008 al 2012.
Lia Quartapelle è Associate Research Fellow del programma
Africa dell’ISPI di cui è stata ricercatrice residente fino al 2012.
Deputata della XVII Legislatura della Repubblica Italiana nella
circoscrizione III Lombardia per il Partito Democratico, fa parte
della Commissione Esteri, di cui è membro dell’Ufficio di presi-
denza. È inoltre membro dell’Assemblea nazionale del Partito
Democratico. È stata cultrice della materia presso la cattedra di
Storia e istituzioni dell’Africa dell’Università di Pavia, dove ha
insegnato presso il corso di Politiche per lo sviluppo. Ha lavorato
presso la Cooperazione Italiana in Mozambico.
Riccardo Redaelli è professore ordinario di Geopolitica e di Sto-
ria e istituzioni dell’Asia presso la Facoltà di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, nonché
direttore del Centro di Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo
Allargato (CRiSSMA) dell’Ateneo. Direttore del master MIMES
(Master in Middle Eastern Studies) dell’Alta Scuola di Economia
e Relazioni Internazionali (ASERI) è inoltre coordinatore scienti-
fico del Centro di studi internazionale di Geopolitica (Cestingeo)
di Valenza e membro del Consiglio Scientifico di Asia Major.
Stefano M. Torelli, Ph.D. in Storia delle Relazioni internazionali
presso l’Università La Sapienza di Roma, è Research Fellow
dell’ISPI. Le sue ricerche si focalizzano sulla politica mediorienta-
le, i movimenti islamisti e le varie forme di islam politico, con
particolare riferimento al Nord Africa e alla Tunisia. È docente a
contratto di Storia e Istituzioni del Medio Oriente allo IULM di
Milano e collabora con la cattedra di Storia e Istituzioni dei paesi
islamici all’Università degli Studi di Milano. Coordina i cicli di
International Lecture per ISPI, dove insegna presso i corsi di for-
mazione sulle nuove forme di terrorismo. Ha pubblicato e curato
diversi volumi e articoli sull’islamismo nell’area nordafricana e
sull’evoluzione del processo di transizione politica in Tunisia, an-
che in chiave comparatistica, per riviste italiane e internazionali e
per l’Osservatorio di Politica Internazionale di Camera e Senato.
180 L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica estera?
Arturo Varvelli è responsabile del Programma Terrorismo
dell’ISPI. È Ph.D. in Storia Internazionale presso l’Università de-
gli Studi di Milano. È docente a contratto di Storia e Istituzioni del
Medio Oriente allo IULM di Milano e coordinatore del corso di
formazione sulle nuove forme di terrorismo presso l’ISPI. Ha
pubblicato diversi volumi e articoli sulle relazioni italo-libiche,
sulla politica interna ed estera della Libia, sulla politica estera ita-
liana nelle regioni del Mediterraneo e del Medio Oriente e sulle
formazioni terroristiche dell’area. Partecipa a progetti di ricerca e
analisi per l’ufficio studi di Camera e Senato, per il Ministero de-
gli Esteri e per il Parlamento europeo.