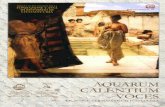Noi, uniti nella preghiera per il piccolo Gianlorenzo - UDI ...
La luna di Lucio Piccolo e i suoi funerali
Transcript of La luna di Lucio Piccolo e i suoi funerali
RIVISTADI LETTERATURA
ITALIANA
Diretta da: Giorgio Baroni
Comitato scientifico: Anna Bellio, Enza Biagini, Giorgio Cavallini, Ilaria Crotti, Davide De Camilli, Željko Djurić,
Corrado Donati, Luigi Fontanella, Pietro Frassica, Pietro Gibellini, Renata Lollo, Alfredo Luzi, Jean-Jacques Marchand, Vicente González Martín,
Bortolo Martinelli, Franco Musarra, Gianni Oliva, François Orsini, Donato Pirovano,Andrea Rondini, Riccardo Scrivano
Redazione: Maria Cristina Albonico, Silvia Assenza, Paola Baioni, Elisa Bolchi,
Cecilia Gibellini, Enrica Mezzetta, Federica Millefiorini, Paola Ponti, Barbara Stagnitti, Francesca Strazzi
Direzione: Prof. Giorgio Baroni, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli 1, i 20123 Milano, tel. +39 02.7234.2574, fax +39 02.7234.2740, [email protected]
*
«Rivista di letteratura italiana» is an International Peer-Reviewed Journal.The eContent is Archived with Clokss and Portico.
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 14 dell’1 luglio 1985Direttore responsabile: Fabrizio Serra
*
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per quasiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il micro-
film, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta dellaFabrizio Serra editore®, Pisa · Roma. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*
Amministrazione: Fabrizio Serra editore®
Casella postale n. 1, Succursale n. 8, i 56123 Pisa, tel. +39 050.542332, fax +39 050.574888, [email protected]
Periodico quadrimestrale Abbonamenti:
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.
Print and/or Online official subscription rates are available at Publisher’s web-site www.libraweb.net.
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550 o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard)
Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa, [email protected]
Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, i 00185 Roma, [email protected]
www.libraweb.net
*
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2012 by Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.
Stampato in Italia · Printed in Italy
issn 0392-825xissn elettronico 1724-0638
SOMMARIO
Francesco Lucioli, Amore alla forca. Una giostra nell’Innamoramento di Rug-geretto di Panfilo de’ Renaldini 9
Serge Stolf, ‘Traduzioni’ e rifacimenti francesi dell’Historia de duobus amanti-bus nel Quattrocento e nel Cinquecento 29
Vincenzo Placella, « Un vero personaggio nella posterità ». Le Commedie e l’ul-timo Alfieri 53
Sergio Portelli, Riscrittura di un tradimento : il Marino Faliero di Lord Byron nel Faliero di Tommaso Zauli Sajani 71
Valentina Marchesi, Esordi di Montale critico. Intorno a Stile e tradizione (1924-1925) 89
Marta Barbaro, La luna di Lucio Piccolo e i suoi funerali 109
ritratti
Riccardo Scrivano, Serge Vanvolsem tra linguistica e critica letteraria 129
rassegne
Assumpta Camps, La ricezione dell’avanguardia storica italiana in Spagna : Marinet-ti e il Futurismo 135
note e discussioni
Bruno Porcelli, « Biligorgne », « tananai », « rages » nelle Ducento novelle del Ma-lespini 149
Rita Zama, La polisemia dell’aggettivo ‘immobile’ nelle opere di Manzoni 153Roberto Salsano, Michelstaedter e Pirandello tra vitalismo e criticismo 165
LA LUNA DI LUCIO PICCOLO E I SUOI FUNERALI
Marta Barbaro
Negli anni delle missioni spaziali e nell’imminen-za dello sbarco dell’uomo sulla luna, Lucio Picco-lo pubblica sulla rivista di Pasolini, « Nuovi Argo-menti », L’esequie della luna, una sorta di racconto fantastico in cui si narra della morte della luna e del suo seppellimento. L’opera, che difficilmente può essere ascritta a un genere particolare, per la contaminazione del discorso narrativo con quello teatrale e lirico, s’interroga sulle conseguenze del-la deflagrazione del mito lunare e sulla posizione dell’arte nel rapporto fra umano ed extraumano.
i . L’esequie della luna : meditazione cosmica e discorso metaletterario
C on una certa ironia, e non senza un qualche compiacimento, Lucio Piccolo, intervistato da Vanni Ronsisvalle per le telecamere della rai, definiva la propria
poesia « difficile », e si appoggiava al nume tutelare Montale per rivendicare la propria estraneità a qualsiasi scuola o movimento letterario. Tale ‘difficoltà’, per il critico che voglia accostarsi all’opera piccoliana, si traduce in due ordini di problemi, di natura differente ma complementari : da una parte, il critico-lettore e interprete si trova di fronte ad una poesia dal carattere fortemente simbolico ed ermetico che non conce-de facili chiavi d’accesso per la sua decodifica ; dall’altra, il critico che da storico della letteratura tenta una sistemazione teorica, pur individuando una molteplicità di refe-renti nel contesto nazionale ed europeo,1 non riesce a collocare la scrittura piccoliana entro una ben individuata tradizione letteraria.
A ciò si aggiunga che del laboratorio poetico, della storia compositiva delle liriche e dei convincimenti profondi che sottendono il suo lavoro creativo, poco è concesso sapere ; sia per ragioni di carattere esterno, concernenti l’inaccessibilità delle carte manoscritte – che permetterebbero al filologo di ricostruire le vicende redazionali e la cronologia interna degli scritti, editi e inediti2 – sia per l’assenza di una qualsia-
1 Montale accosta la poesia di Piccolo a quella di Campana, Dylan Thomas, d’Annunzio (un d’Annun-zio ripulito « da ogni parnassianesimo e dannunzianesimo »), Pea, Hopkins e Yeats, ma cita anche Husserl e i metafisici inglesi (vedi Prefazione a Lucio Piccolo, Canti barocchi e altre liriche, Milano, Mondadori, 1956) ; Sciascia crede che « stia perfettamente collocato in quel gruppo di poeti spagnoli che celebrano Gongora » (Le « soledades » di Lucio Piccolo, in La corda pazza, Milano, Adelphi, 1991, p. 203) ; Natale Tedesco scopre una particolare affinità con Guillien e con lo stesso Montale, e via via gli altri critici hanno ag-giunto i nomi di Rebora, Proust, Pound e di altri grandi autori del Modernismo europeo.
2 Al di là dei noti aneddoti relativi alla pubblicazione delle 9 liriche e alle fortuite circostanze della ricezione da parte di Montale, sarebbe interessante risalire all’effettivo periodo della composizione dei Canti barocchi e capire, ad esempio, se si tratta di testi risalenti al periodo giovanile, conservati nei cassetti del poeta e rielaborati continuamente attraverso gli anni, o se sono il frutto di una riflessione già matura avviata intorno agli anni Cinquanta. La definizione di una cronologia delle opere (nonché l’allestimento di un’edizione critica che comprenda e metta ordine fra le carte e i frammenti pubblicati postumi o mai giunti alla pubblicazione) consentirebbe, infatti, di osservare con più precisione lo sviluppo diacronico della poetica piccoliana e tracciare il percorso di un poeta che, pur mantenendo una cifra inconfondibile, approfondisce continuamente la sua riflessione e si evolve sempre in nuove direzioni. A questo scopo, il
In the years of the spatial missions and in the immi-nence of the landing of the man on the moon, Lucio Pic-colo publishes on Pasolini’s review « Nuovi Argomenti », L’esequie della Luna, a sort of fantastic tale where the death of the moon and its burial are narrated. The work, that can hardly be enrolled in a particular genre, because of its contamination of the narrative discourse with the theatrical and lyrical one, questions itself on the consequences of the deflagration of the lunar myth and on the position of the art in the relation between human and extra-human.
110 marta barbarosi forma di riflessione di carattere poetico o teorico che accompagni la produzione lirica. In un periodo – quello degli anni Sessanta in cui si sviluppa la maggior parte della produzione piccoliana – in cui gli scrittori tendono a enunciare le proprie scelte programmatiche con dichiarazioni e manifesti, e a trovare, per così dire, da sé un posto entro il quadro della letteratura, l’autore dei Canti barocchi si mostra invece re-frattario a esprimersi al di fuori della dimensione lirica. « Sono invincibilmente lirico »1 diceva, e si dichiarava contrario a giustificare le visioni e i simboli della sua poesia nel linguaggio disteso e razionalizzante della prosa.
Ne deriva il ritratto di un poeta aristocratico e visionario che, pur meritando il ri-conoscimento unanime della critica, sembra rimanere isolato nel panorama poetico del secondo Novecento e come estraneo al suo tempo ; uno scrittore romantico e decadente anacronisticamente proiettato alle soglie della postmodernità che preso dal « raptus lirico » – l’espressione è montaliana – insegue i fantasmi della memoria riconducendoli entro il solco di una scrittura misteriosa e autoreferenziale.
Tuttavia, sarebbe semplicistico derubricare Piccolo come un decadente tout court, sebbene il poeta si diverta a nutrire tale convinzione2
; né è legittimo assegnare il suo simbolismo naturalistico, di una straordinaria concretezza ed evidenza empirica, alle regioni evanescenti e allusive dell’arte fin de siècle. A un’osservazione attenta, non può sfuggire che gli slanci fantastici della poesia piccoliana tendano a proiettarsi sul cosmo illuminandone i movimenti segreti, piuttosto che a ripiegarsi sul soggetto ; del resto, Montale non ne sarebbe stato il mallevadore se, al posto delle più avvertite spe-culazioni filosofiche, avesse scorto sogni di mistico abbandono, né Sciascia o Consolo si sarebbero sentiti vicini alla rappresentazione di quel « mondo singolare siciliano »3 senza rintracciarvi un discorso universale. Inoltre, dal punto di vista formale – se è lecito separare il piano concettuale dalla veste stilistica – la scrittura di Piccolo si nutre delle sollecitazioni e delle inquietudini dell’epoca e quei « versi crepuscolari », così li ha definiti Natale Tedesco,4 anche quando rievocano malinconicamente un passato scomparso, nascono da un’esplorazione tutta novecentesca o, come sostiene Flora Di Legami,5 si muovono entro una moderna e smaliziata consapevolezza poetica.
Museo Lucio Piccolo di Ficarra, da poco giunto in possesso delle carte del poeta, ha intrapreso un utilis-simo lavoro di catalogazione e digitalizzazione che ne permetterà la consultazione agli studiosi.
1 Antonio Pizzuto, Lucio Piccolo, L’oboe e il clarino. Carteggio 1965-1969, a cura di Alessandro Fo, Antonio Pane, Milano, Scheiwiller, 2002, p. 33. Le poche dichiarazioni di poetica sono affidate allo scam-bio epistolare con Antonio Pizzuto, al quale Piccolo invia delle « glose » esplicative dei Canti barocchi ; ma, anche in questo contesto privato e confidenziale, la scrittura piccoliana è enigmatica e allusiva, tesa a suggerire immagini piuttosto che a fornire dei chiarimenti in termini descrittivi e analitici.
2 « Spero che ti commuoverai alle decadenterie senza limiti della “Puerta de los noranyes” la quale postulerebbe un de Falla o altri del genere. Cose vecchie penserà uno zelante (e in fondo insincero) modernista come te » (Lucio Piccolo, Lettera a Gioacchino Lanza Tomasi, Capo d’Orlando, 29 giugno 1967, pubblicata in Natale Tedesco, I « versi crepuscolari » del tramonto siciliano alla ricerca dell’assoluto, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2003, p. 62).
3 La definizione è di Piccolo, che così scrive a Montale nella lettera d’accompagnamento alle 9 liriche : « era mia intenzione rievocare e fissare un mondo singolare siciliano, anzi più precisamente palermitano, che si trova adesso sulla soglia della propria scomparsa senza avere avuto la ventura di essere fermato da un’espressione d’arte ». In realtà, la lettera, che ai critici più attenti parve alludere più al Gattopardo che ai Canti barocchi, fu scritta dal cugino Giuseppe Tomasi di Lampedusa, almeno così ci riferisce Sciascia : « [Piccolo] mi rispose, incredibilmente, ma senza sorprendermi, che la lettera era stata scritta da Lampe-dusa. Questa piccola rivelazione conferma la genericità avvertita da Montale e spiega la ragione per cui la “descrittività” promessa o minacciata non trovasse riscontro nelle liriche. Avrebbe avuto riscontro nel Gattopardo, si può dire ora » (Leonardo Sciascia, Le « soledades » di Lucio Piccolo, cit., p. 201).
4 Cfr. Natale Tedesco, I « versi crepuscolari » del tramonto siciliano alla ricerca dell’assoluto, cit., pp. 45-74.5 Cfr. Flora Di Legami, Lettura di Gioco a nascondere, in Lucio Piccolo. La figura e l’opera. Atti del con-
vegno nazionale, a cura di Natale Tedesco, Marina di Patti, Pungitopo, 1990, pp. 195-207.
111la luna di lucio piccolo e i suoi funeraliOccorre, pertanto, approfondire questo nodo problematico perché proprio nel-
la sovrapposizione fra antico e moderno risiede l’originalità del discorso di Piccolo, nell’esplorazione di nuove possibilità della parola e di nuovi spazi dell’immaginazio-ne attraverso l’appropriazione del patrimonio lirico del passato. Non vi è dubbio che, nella rete d’interferenze culturali e letterarie che saturano la pagina piccoliana, par-ticolare predominanza hanno le immagini e i procedimenti poetici della tradizione metafisica romantica, ma ora sono costretti entro la secchezza e la sobrietà dell’‘oc-casione’ montaliana, ora si incrociano con la tensione centrifuga tipica della sensibi-lità barocca. Verificare i modi della rielaborazione dell’immaginario romantico può, quindi, essere una strada fertile per cogliere la ricchezza di una lirica « non facile, non immediata »,1 e per ridisegnare il posto del poeta siciliano all’interno della maggiore tradizione letteraria.
A questo fine, si rivela particolarmente proficuo rivisitare l’ultima opera pubblicata in vita dall’autore, L’esequie della luna,2 l’unica scritta in prosa con un progetto narra-zionale che, a partire da un’immagine, da un simbolo, quello della luna, condensa in un « racconto fantastico » – in questi termini ne parla l’autore a Corrado Stajano3 – una moderna riflessione sulla poesia. Tutt’altro che refrattario alle suggestioni e alle urgenze del suo presente, con L’esequie della luna Piccolo si prova nella difficile sfida di fondere la visione poetica del cosmo con le acquisizioni della scienza e del pensiero contemporanei, traghettando il simbolismo romantico nell’universo copernicano.
ii. I viaggi spaziali e la deflagrazione del mito lunare : un racconto allegorico
L’opera, pubblicata da Pasolini nel 1967 sul numero 7-8 di « Nuovi Argomenti », narra la miracolosa vicenda della luna che, giunta nella sua quinta decima, comincia a sfal-darsi e a piovere sulla terra ; è difficile non legare l’occasione della composizione alle imprese astronautiche del programma Apollo, che proprio in quegli anni sembravano segnare una tappa decisiva del viaggio dell’uomo verso la luna, e che effettivamente sarebbero state coronate con il vero e proprio allunaggio nel luglio del ’69. Piccolo non fece in tempo ad assistere all’evento – morì nel maggio dello stesso anno – ma se ancora in quel 1967 il suolo lunare non era stato toccato, la conquista dello spazio extra-atmosferico era già una possibilità reale che apriva nuovi inquietanti interroga-tivi e imprevedibili scenari conoscitivi.
Si trattava della meta più alta raggiunta dall’intelletto e dalla scienza umani ; l’uo-mo conquistava uno spazio prima d’allora raggiungibile solo attraverso l’immagi-nazione e la poesia, e con l’ausilio delle proprie invenzioni poteva osservare la terra e gli astri al di fuori della limitata prospettiva terrestre. Fra terrori ed entusiasmi, l’avventura inaugurata con il lancio dello Sputnik era destinata a stravolgere il rap-porto dell’uomo con l’universo, ora in termini di « spaesatezza » e « sradicamento » dall’habitat naturale, come temevano Husserl e Heidegger,4 ora nei termini entusia-
1 Eugenio Montale, Prefazione a Lucio Piccolo, Canti barocchi e altre liriche, cit., p. 107.2 Lucio Piccolo, L’esequie della luna e alcune prose inedite, a cura di Giovanna Musolino, Milano, Schei-
willer, 1996. D’ora in poi l’opera sarà indicata come Esequie, seguita dal numero di pagina.3 Idem, Lettera a Corrado Stajano del 12 settembre 1967, in Due lettere inedite di Piccolo a Corrado Staja-
no, « Galleria », xxx, 3-4, 1979, p. 99.4 Di fronte alla conquista spaziale, Heidegger manifestava il proprio turbamento in un’intervista rila-
sciata allo « Spiegel » nel settembre 1966 : « Tutto funziona. Questo è appunto l’inquietante, che funziona, e che il funzionare spinge sempre oltre verso un ulteriore funzionare, e che la tecnica strappa e sradica sempre più dalla Terra. Non so se Lei è spaventato, io in ogni caso lo sono stato appena ho visto le foto-
112 marta barbarostici di estensione delle facoltà conoscitive e materiali dell’uomo tecnologico. Come molti filosofi e intellettuali che si trovavano ad interrogarsi sulle conseguenze della conquista lunare, anche l’autore delle Esequie della luna vide la fine di un mito secolare e interpretò quel trionfo come perdita e come caduta, come una violazione ai danni del cielo che lasciava smarrita la terra.1
Moriva la « graziosa » e « diletta » « Giovinetta immortal », l’« eterna peregrina », la « se-rena / dominatrice dell’etereo campo »2 che con il suo pallido lume e il lontano silenzio diceva ai mortali dell’infinita e costante vita del cosmo ; e mentre la tecnica sottraeva alla poesia l’esclusivo dominio sul mondo extra-terrestre, gli astri e tutto l’universo naturale si svuotavano definitivamente dei loro presupposti metafisici. Nell’era spa-ziale, dell’astro simbolico per eccellenza non rimaneva che il « degravitante sughero, / pomo e potenza della polvere » della puella pallidula di Zanzotto, o i « resti luminosi » della luna di Piccolo conservati rusticamente in un pagliaio, oggetti pari agli altri da studiare e manipolare secondo l’estro degli uomini. Non è un caso che il racconto delle Esequie sia ambientato in un Seicento surreale e grottesco dove una luna pro-strata e indifesa è sottoposta all’ispezione degli araldisti che ne controllano « la specie nobiliare », e dove le stelle trascorrono nel cielo consapevoli di essere osservate da can-nocchiali rudimentali e indiscreti affinché i loro umori siano registrati « negli annali delle pioggie e dei venti ». Come dirà nel corso dell’opera, era giunta un’epoca in cui « in qualche modo si era già sostituita la burocrazia alla leggenda » e, traendo spunto dall’attualità spaziale, rappresentava in una sorta di favola allegorica « l’estinguersi dei residui del romanticismo barocco »3 e della sua concezione di poesia.
Il racconto ha inizio al mattino, alla corte di un Viceré spagnolo che pigramente si sveglia e inizia le rituali operazioni del giorno : « baciamano, ordini segreti a Doña So-spiro », i valletti che portano gli editti e i bandi da firmare. La luce comincia ad illumi-
grafie della Terra scattate dalla Luna. Non c’è bisogno della bomba atomica : lo sradicamento dell’uomo è già cosa fatta. Tutto ciò che resta è una situazione puramente tecnica. Non è più la Terra quella su cui oggi l’uomo vive » (Martin Heidegger, Discorsi e altre testimonianze sul cammino di una vita (1910-1976), Genova, il Melangolo, 2005, p. 597). Sulle prospettive teoretiche aperte dalla fuoriuscita terrestre cfr. Carmelo Colangelo, La verità errante. Viaggi spaziali alla prova del pensiero, Napoli, Liguori, 2009, da cui sono tratte le citazioni heideggeriane.
1 Un « giorno fatale », per Vincenzo Consolo, che sottraeva la luna ai poeti affinché « degli uomini la profanassero danzandovi sopra con i loro scarponi di metallo » (Vincenzo Consolo, Nota dell’autore, in Idem, Lunaria, Milano, Mondadori, 1996, p. 134) ; fastidio, sgomento e ansia per Anna Maria Ortese, che vedeva nell’avanzata dell’uomo verso lo spazio una nuova terrificante colonizzazione : « Anch’io, come altri essere umani, sono spesso portata a considerare l’immensità dello spazio che si apre al di là di qualsiasi orizzonte, e a chiedermi cos’è veramente, cosa manifesta, da dove ebbe inizio e se mai avrà fine. […] Ora, questo spazio, non importa da chi, forse da tutti i paesi progrediti, è sottratto al desiderio di riposo, di ordine, di beltà, allo straziante desiderio di riposo di gente che mi somiglia. Diventerà fra breve, probabilmente, uno spazio edilizio. O nuovo territorio di caccia, di meccanico progresso, di corsa alla supremazia, al terrore » (Anna Maria Ortese, Occhi al cielo, « Corriere della sera », 24 dicembre 1967 ; citato da Italo Calvino in Il rapporto con la luna, in Idem, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società (1980), Milano, Mondadori, 1995, p. 220). Carmelo Colangelo ricorda fra l’altro come già nel 1929 Benjamin avvertiva dei pericoli derivanti dalla mancata «dedizione a un’esperienza cosmica» dell’uomo tecnologico.
2 Le citazioni sono tratte da Leopardi, Alla luna, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia e La vita solitaria (citati da Giacomo Leopardi, Canti, in Idem, Poesie e Prose, i, a cura di Rolando Damiani, Mario Andrea Rigoni, Mondadori, Milano, 1987, pp. 52 e 59). Per un’analisi della lunarità nella poesia di Leopar-di cfr. Federica Frediani, Leopardi. La luna che precede i canti : una nota, « SguardoMobileSaggi » (www.sguardomobile.it), 6 luglio 2003.
3 « La caduta del satellite significa appunto l’estinguersi del romanticismo barocco. Quella Palermo che avevo visto e vissuto e di cui non rimangono che riflessi, ombre. Il quale fatto coincide pure con la crisi della nostra epoca » (Lucio Piccolo, Lettera a Corrado Stajano del 12 settembre 1967, cit., p. 99).
113la luna di lucio piccolo e i suoi funeralinare le fronde e le acque del giardino e poi gradualmente penetra all’interno e indora i marmi e gli argenti barocchi che decorano le stanze del Palazzo Reale. Preso dalla cura maniacale della barba, con « la testa infarcita di prammatiche » e di trofei araldici, il Viceré non si accorge delle piccole metamorfosi del giorno, né avverte che l’aria penetrando dalla finestra « è percorsa da sollecitazioni di siti, richiami di paesaggi ». Eppure, quella mattina « qualcosa deve essere avvenuta », perché lo scettro di smalto non vuole più scivolare sulla mappa dei possedimenti del regno e si blocca, « Malo segno ! », su un arco nero mai notato prima, in corrispondenza di « un luogo tanto remoto e selvaggio da non meritarsi neanche un singolo nome ». All’alba, proprio da quel luogo sconosciuto, partì il Villano e – la narrazione si sposta sui tempi del passa-to remoto – traversò « a galoppo tanto selvaggio da non avere neppure un nome »1 le campagne immobili per recare in città una notizia senza precedenti. Arrivò alle porte del palazzo « quando ormai le ombre notturne erano già del tutto in rotta » e da lì, con una netta cesura narrativa e stilistica, si diparte la descrizione, racconto nel racconto, dell’estinguersi della luna. Radunati in segrete accolite campestri, i Pastori e le Ninfe avevano notato che la luna aveva assunto colorazioni insolite ; invano i medici e i competenti in materia avevano cercato di portare soccorso all’inferma che cominciò a sciogliersi « in innumerevoli falde simili a lievissime garze incandescenti di bianco » e a depositarsi leggera sul suolo. I frammenti luminosi furono raccolti e conservati dai contadini del luogo in un’urna, in attesa che « l’alta Autorità (riflessa) » decidesse il da farsi. Chiuso l’intermezzo bucolico e campestre, la scena si sposta nuovamente in città, a Palermo, dove il Viceré e i sapienti dell’Accademia dei Platoni Redivivi si adoperano in puntigliose ricerche e in farraginose ipotesi, senza però venire a capo del fenomeno. Anche lì accadono fatti inspiegabili, gli almanacchi dell’Accademia che volano dagli scaffali, le ombre dei morti che tornano a farsi vedere fra i vivi, i liquidi dello speziale che si diffondono da soli, le erbe dei cortili che producono strane efflo-rescenze. Nulla però viene deciso e la vicenda termina con il seppellimento dei resti lunari nel borgo campestre e con le vere e proprie « esequie della luna » : « fattucchiere, ubriachi, gufi e simili cose … [della] trita, ovvia tradizione letteraria » sfilano in un corteo funebre insieme ai Cercatori di tesori e alle Volpi, ultima immagine con cui enigmaticamente si chiude il racconto.
Questa la ricostruzione della traccia principale dell’opera, tutta giocata sull’opposi-zione allegorica fra un mondo seicentesco, araldico e dottrinario, a cui appartengono il Viceré, i Medici, gli Astronomi e gli Accademici della città – le maiuscole sono quel-le del testo – , e il mondo arcadico-mitico delle comunità rurali. Ai primi corrisponde un atteggiamento superstizioso e falsamente scientifico che presume di poter inter-pretare le manifestazioni della natura mediante astratti sistemi libreschi – « è inutile dire i tomi scomodati dal sopore degli scaffali. […] Fu ripreso l’Almagesto, fu ripreso Tolomeo, gli altri testi erano ancora un tantino sospetti » – e disamine araldiche ; la terra e il cielo sono solo proprietà da misurare e censire per il proprio vanto, o sim-boli vuoti di un sapere artificioso e insensato, la cui civetteria è grottescamente rap-presentata nella scena delle « gentilizie cornacchie … provviste di occhialetti, nasali e viziose d’esotici tabacchi » :
Le Dame, intanto, le quali come fastidiose e vane erano tenute lontane dal severo statuto dell’Accademia fiutando nell’aria lo stato di confusione, di disordine di quel momento ne
1 La ripresa della formula, che torna uguale a distanza di due capitoli – sebbene qui, con un’ardita ipallage, riferita al galoppo del villano – riconduce la narrazione al punto in cui si era interrotta per dare spazio alla digressione lirica.
114 marta barbaroprofittarono per inoltrarsi curiose nei rispettabili locali aprirono cassetti, osarono porre mani negli archivi più o meno segreti – dove si conservavano le grandi scoperte – rovistarono casse, armadi, cofani, sollevarono su le mani le armille, le squadre, i pendoli cifrati, le bilance che non si sa cosa dovessero pesare, le clessidre. Si dice che l’ardire e la tracotanza giungessero a tal segno da far porre loro come futili adorni su le capigliature più o meno fittizie i simulacri in metallo prezioso dei crescenti dei soli dei pianeti, gli amuleti delle costellazioni immaginarie. (Esequie, pp. 37-38)
A questi « intellettuali affaticati », Piccolo contrappone il sentire ingenuo e compassio-nevole dei Pastori e delle Ninfe, accortisi subito dei perturbamenti lunari dai minimi « indizi » della natura, o la saggezza del « pratico » Alfesibeo – il pastore dell’ottava ecloga virgiliana che sa « carmina vel caelo possunt deducere lunam » ? – che « aveva già da tempo osservato come le erbe in nesso diretto col satellite, avessero perduto le loro virtù curative ». Se di fronte alla malattia della luna falliscono sia l’ipotesi scientista della realtà, sia quella mitico-arcaica di contadini e pastori, il favore dell’autore va senza dubbio – il tono nostalgico e il registro favolistico contrapposto a quello ironi-co-grottesco ne sono un chiaro segnale – a quel mondo campestre che accoglie con canti e danze le miracolose e inquietanti vicende cosmiche. Alle piccole comunità rurali assegna, infatti, il compito pietoso, carico di valenze simboliche, di raccogliere e seppellire i resti lunari vicino alle acque e pone la loro saggezza primitiva a custodia dell’anima dormiente del mondo.1
Una conclusione che, se letta come morale della favola, lascia aperta la via, anche nel vuoto del tempo presente, a una qualche forma di religiosità e sembra prospettare il ritorno dell’immaginazione mitica e della fantasia romantica. Non stupisce – data la familiarità di Piccolo con il filosofo della Krisis – che la soluzione della fabula venga così a coincidere con la proposta husserliana di un « arcaismo ingegnoso » : di fron-te all’ipotesi angosciosa, per Husserl soltanto immaginata, di un’« aeronave » capace di portare l’uomo fuori dall’« Arca originaria Terra », il filosofo compiva una sorta di ‘passo indietro’, di « ripristino calcolato e critico dell’ingenuità antica… presentata come dimensione di senso perfettamente inattaccabile, persino da parte degli sviluppi delle tecnoscienze ».2 Senza addentrarsi oltre nello scritto di Husserl relativo alla per-cezione copernicana del mondo, probabilmente ignoto al poeta siciliano, è indubbio che comune ai due pensatori sia la volontà di contestare l’oggettivazione della realtà fisica indotta dal riduzionismo naturalistico, rilanciando un’esperienza originaria che, nel caso di Husserl è il ‘corpo terrestre’ come « dimora primordiale », per Piccolo si traduce nell’irrinunciabile mediazione mitico-poetica fra l’uomo e il cosmo.
iii. Simbolismo romantico e universo copernicano : la riscrittura del mito
Ma Piccolo non trasforma mai del tutto la favola in allegoria, rendendo il suo discorso lunare più complesso sia nelle strutture narrative sia a livello dei significati trasmessi ;
1 La citata lettera a Stajano faceva esplicito riferimento al significato simbolico del seppellimento dei resti lunari da parte delle « piccole comunità rurali, le quali sono le sole ancora ad intravedere barbagli, lucori zodiacali ecc. in ogni modo il simbolismo vivente – incognito indistinto e non raggelato in signifi-cati precisi » (Lucio Piccolo, Lettera a Corrado Stajano del 12 settembre 1967, cit., p. 99).
2 Carmelo Colangelo, La verità errante, cit., pp. 82-83. L’opera a cui fa riferimento Colangelo è uno scritto inedito del 1934, pubblicato per la prima volta nel 1940 da Marvin Farber, e tradotto in italiano nel 1991 con il titolo Rovesciamento della dottrina copernicana nell’interpretazione della corrente visione del mondo ; in esso Husserl anticipa le elaborazioni teoriche della Krisis e « la critica alla tecnicizzazione delle scienze naturali, alla loro alienazione in quanto “oblio delle origini” » (ivi, p. 74).
115la luna di lucio piccolo e i suoi funeralispinto dalla necessità di ripensare il sistema terra-luna, egli mette in questione la na-tura stessa della luna-poesia e tutto l’ordine del simbolico, e scava nell’immaginario letterario per ridefinire la « posizione cosmica dell’arte ».1
Il tema dell’infermità della luna, infatti, non è nuovo in letteratura e se, da un lato, rievoca la ricca fenomenologia dell’antropomorfismo naturale e delle personi-ficazioni lunari che avevano caratterizzato la poesia ottocentesca, dall’altro si lega a tutta una serie di lune espressionistiche e surreali, dolcissime o malefiche, pallide o insanguinate, che dal teatro alla musica giungono fino alle lune pericolanti di Klee e Chagall2 e alla ‘molle luna’ cadente di Calvino :
Il medico, nel suo costume nero aderentissimo, scarpini a punta sottile e rialzata in sù, sale sul tetto aguzzo del campanile, il piede sovra lo spuntone di ferro come una banderuola girando alla mercé delle aure, e quando queste glielo consentono, dato ch’è leggerissimo, tasta il posto all’inferma, la quale come si è già detto, si trova distesa sovra i colli di levante. In altri tempi era un glorioso tagliere d’oro arroventato al suo primo sorgere piena.
La si può rappresentare come quei disegni infantili : un cerchio la faccia e semplici linee gli arti. (Esequie, p. 33)
Il testo piccoliano mescola, così, difformi registri simbolici e per di più trova precisi riscontri anche nella rappresentazione della morte della luna e della sua deflagrazio-ne. Il referente più immediato è sicuramente Leopardi3 e il frammento Odi o Melisso, in cui la visione della luna che si stacca dal cielo per spegnersi sul prato vomitan-do scintille e nebbia sembra anticipare quella di Piccolo anche nell’ambientazione campestre ; ma non mancano suggestioni dal mondo classico, soprattutto di quello passato al setaccio dal recanatese nel capitolo iv del Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, dove la rosa delle citazioni insiste sulle streghe e gli incantatori della Tessaglia capaci con i loro poteri magici di tirar giù le stelle dal cielo. Egli, però, fa un uso non convenzionale di tutti questi elementi e li mescola, insieme ad altri di più schietta de-rivazione popolare e contadina, come citazioni criptate, in un’architettura composita e discontinua che procede per sequenze giustapposte senza evidente coerenza logica e temporale.
1 L’espressione è di Thomas Mann che, partendo proprio dall’identificazione luna-poesia, definisce il ruolo magico e spirituale dell’arte : « Qui si mostra la missione mediatrice dell’arte, il suo compito magico, ermetico, di intermediaria fra il mondo superiore e inferiore, tra idea e fenomeno, spirito e sensualità. Questa è infatti la posizione cosmica, per così dire, dell’arte. La singolarità del suo posto nel mondo, la dignità del suo gioco che non si possono né spiegare né determinare altrimenti. Il simbolo della luna, questa immagine cosmica di ogni mediatezza, è il più proprio dell’arte. Per l’antica primitiva umanità l’astro era sacro e importante appunto per la sua ambiguità, per la sua posizione media e inter-media tra il mondo solare e terreno, spirituale e materiale. Doppia la sua natura : femminile accogliente, rispetto al sole ; maschile-fecondante rispetto alla terra. La consideravano il più impuro dei corpi celesti, ma il più puro dei terrestri ; appartenente, è vero, al mondo materiale, ma in questo nella posizione più alta, più spirituale, più vicina al sole, sospesa al limite di due mondi, per dividerli e nello stesso tempo congiungerli, mallevadrice dell’unità del tutto, interprete fra il mortale e l’immortale : appunto questa è la posizione dell’arte fra lo spirito e la vita. Androgina come la luna, femminile rispetto allo spirito, maschile e feconda nella vita, la manifestazione più impura, per la materia di cui è composta, della sfera celeste, ma per il suo carattere di transizione la più pura e incorruttibilmente spirituale della sfera terre-stre, l’essenza sua è quella di un’intermediaria lunarmente magica tra le due regioni » (Thomas Mann, Nobiltà dello spirito, in Idem, Tutte le opere, x, a cura di Lavinia Mazzucchetti, Milano, Mondadori, 1953, pp. 742-743).
2 Si rinvia allo studio di Giovanni Macchia, La caduta della luna, in Idem, La caduta della luna, Milano, Mondadori, 1995, pp. 94-99 per un approfondimento del tema.
3 Cfr. Flora Di Legami, L’esequie della luna, cit., e Giuseppe Amoroso, Lucio Piccolo. Figura d’enigma, Milano, Scheiwiller, 1988.
116 marta barbaroInnanzitutto, l’organizzazione formale del testo è in tre sezioni, o atti – indicati con
numerazione romana, eccetto l’ultima che porta il titolo Abbozzo per una conclusione – a loro volta suddivisi in scene e « quadri », secondo una singolare partitura teatrale. L’in-tenzione, infatti, era quella di realizzare un copione per balletto da far musicare proba-bilmente a Gianfranco Malipiero,1 una sorta di ‘schizzo’ – così apprendiamo da un’altra lettera, indirizzata nello stesso anno a Gioacchino Lanza2 – o ‘scenario’ narrativo che avrebbe lasciato completa libertà all’esecutore musicale. Non solo, quindi, la prosa che ne risulta è « intimamente connotata da una misura poetica… sì da poter[la] considerare una variazione sul tema dei Canti barocchi, o di Plumelia »,3 ma l’opera tutta si risolve in un genere ibrido – un « balletto verbale » nella definizione di Piccolo – in cui l’esile strut-tura narrativa viene quasi interamente assorbita e dispersa in molteplici itinerari lirici.
Ciò non significa che nell’Esequie della luna ci sia spazio per lamenti funebri o dialo-ghi del poeta con la luna ; il dialogo-monologo, canonico nella tradizione romantica e simbolista, è qui sostituito da una voce narrante che orchestra con spavalda padro-nanza diversi piani affabulativi, temporali e prospettici. Così, se pur il tratto dominan-te è di accesa liricità, il motivo elegiaco funebre trova un suo immediato correttivo nella partecipazione disinvolta dell’autore-regista alla composizione del testo, che ora si atteggia a ironico cronista della vicenda,4 ora svanisce nella rappresentazione del paesaggio, mutando continuamente tono e registro.
Si parte da una rappresentazione farsesca, in uno scenario barocco e volutamente anacronistico, dove una sorta di capocomico5 dirige i movimenti di scena e con il suo ostentato formulario araldico e « qualche eleganza spagnola disseminata qua e là »6 volge l’atmosfera barocca a esiti grotteschi e caricaturali :
Ora sarebbe utile che non fossero più le parole a cercar di far muovere il Viceré, ma che si mo-vesse lui da sé medesimo. Nella camera grande ove ora è disceso ecco che gli passano dinanzi due a due (adesso i registi sono pregati d’intervenire e provvedere) i valletti – erano scribi ? – che portano spiegati in grandi rotoli di pergamena o carta degli editti, bandi, ecc. ch’egli deve firmare. Questa firma però non avviene nel tempo che sarebbe supponibile, attento egli invece elabora i paraffi, i ghirigori, e le volute di minio e d’azzurro sembrano costringere il reggimento d’un paese che il sole ed il suo seguito di venti meridionali amano troppo. (Ese-quie, pp. 20-21)
1 L’editore Scheiwiller così dice nella Nota alla prima edizione de La seta (a cura di Giovanni Gaglio, Giovanna Musolino, Milano, Scheiwiller, 1984), prospettava, fin dal 1967, un’esecuzione dell’opera alla Piccola Scala di Milano ed egli stesso sarebbe stato l’intermediario con Malipiero per la scrittura della musica e con Fabrizio Clerici per i costumi, ma il progetto non andò in porto per la morte improvvisa del poeta nel maggio del ’69.
2 Lucio Piccolo, Lettera a Gioacchino Lanza Tomasi, Capo d’Orlando, 29 giugno 1967, cit., p. 62.3 Flora Di Legami, L’esequie della luna, cit., p. 181. 4 Formule del tipo « sarebbe del tutto manchevole la nostra relazione se omettessimo quel che se-
gue… » (p. 42), « Ma ci sembra ormai venuto il momento di concludere in modo semplice e breve » (p. 44), e ancora « È doveroso, d’altra parte, a meglio intendere noi stessi e farci intendere dagli altri, render presenti per lo meno altri… » (p. 45), « Per la comprensione completa del racconto è doveroso aggiungere come… » (p. 48), interrompono bruscamente il ritmo lirico della prosa piccoliana, mettendo di continuo in dubbio la gravità dell’evento e le sue implicazioni cosmiche.
5 Non è un caso che Vincenzo Consolo, adattando il testo di Piccolo per una vera e propria esecuzio-ne teatrale, inventi il personaggio di Porfirio, il valletto da camera che muove il Viceré-manichino sulla scena : « Porfirio (regista, comparsa ? Consapevole comunque di questa recitazione), portato il manichino davanti al secondo balcone, si sposta presso l’altro dove ha appena parlato il Viceré. Il quale nascostosi dietro, così fa parlare il manichino » (Vincenzo Consolo, Lunaria, cit., p. 21).
6 La citazione, tratta dall’Introduzione ai Promessi sposi, è usata da Manzoni per definire lo stile artifi-cioso e infarcito di retorica dell’autore seicentesco del manoscritto; Alessandro Manzoni, I promessi sposi (1827), Milano, Mondadori, 2002, p. 7.
117la luna di lucio piccolo e i suoi funerali
Ma dalle sale del Palazzo Reale, complice una finestra aperta da cui s’intravede San Giovanni degli Eremiti,1 lo sguardo si sposta subito all’esterno, sul mare, i giardini e le cupole della Palermo antica, che innescano nella scrittura un cortocircuito tempo-rale e stilistico :
Dalla finestra entra l’aria ed è percorsa da sollecitazioni di siti, richiami di paesaggi, ma il Viceré rimane impassibile, ha per la testa infarcita di prammatiche, ben altro. Torri, palazzo e giardini sono sul bastione che emerge sulla città. Immaginiamo che l’aria faccia dondolare i prevedibili melograni e ligustri ecc. e i fiori ch’è superfluo nominare tenendo presente però che sono di maggior simpatia quelli che non possiedono un nome, pura virtualità di profumi erranti senza etichetta. D’altra parte si vede il mare non più vicino come un tempo ma ancora porta ansietà di veleggi, alghe ed aurore.
Non lontano dai piedi del bastione tra il verde del frondame preponderante è una calotta rossastra che suona ad intervalli regolari come un gong. Era un giardino e l’infermo addor-mentato presso l’acqua fu salvo per gli spiriti liquidi. Poi fu chiostro ed il rettangolo di cielo libero fu attraversato dagli stormi delle campane, dagli uccelli, dai giorni e dalle notti. Il globo d’aria disceso volse intorno alla colonnina del fonte che fu l’asse del mondo, trascorsero in-torno le paci e le guerre degli uomini, per disparire, per sorgere, per disparire ancora. (Esequie, pp. 22-23)
Da questo primo scorcio, la visione sulla città si estende ai due capitoli-scene succes-sivi, La città e il mare e La porta delle arance, che spostano l’azione drammatica su un piano decisamente lirico. Merito dell’« imperizia del poeta » nel genere drammatico – « il quale confida assai poco nelle sue virtù narrative e teatrali. Finirà col togliere i brani lirici e bruciare il resto » – se si vuole prestare fede alle sue dichiarazioni,2 o di una ricercata e « fascinosa simbiosi » fra poesia e narrazione, così invece legge Di Legami, il testo di Piccolo dispiega immagini cariche di un interno dinamismo che, trascorrendo le une nelle altre, ottengono l’effetto della continuità affabulativa senza affidarsi all’azione dei personaggi sulla scena. Nulla più si compie sulla ribalta, e ap-parentemente nulla avviene, se non il diffondersi dell’aria salmastra del mare fin nel cuore della città antica
Un mutamento nel tono della luce e dell’aria ci dice all’improvviso che il mare sta per ripren-dere il suo brusco dominio sulla città, sua forza è la direzione del vento che le banderuole-crescenti, galletti o comete fanno manifesta. Ventate possenti, ininterrotte per la strada mag-giore che va dalla porta del mare a quella di mezzogiorno e ponente, si sente in vortice d’aria nelle piazzette, s’incorpora in mulinelli di polvere. (Esequie, pp. 24-25)
o l’arrivo dell’« ondata d’Occidente » che porta l’oscurità fino all’ultimo orizzonte ma-rino :
1 L’identificazione della « calotta rossastra », prima giardino, poi chiostro (« Era un giardino … Poi fu chiostro e il rettangolo di cielo libero fu attraversato dagli stormi della campane… »), con San Giovanni degli Eremiti è un’ipotesi suggerita dal riscontro fra la descrizione piccoliana e l’effettiva collocazione del chiostro « non lontano dai piedi del bastione », cioè dal complesso monumentale del Palazzo dei Nor-manni. L’attuale chiesa, inoltre, costruita da Ruggero II tra il 1130 e il 1148 per i Benedettini, sorge in un luogo ricco di stratificazioni storiche – all’origine era un monastero gregoriano dedicato a S. Ermete, nel x secolo fu trasformato in edificio islamico d’incerta funzione e in seguito riedificato come monastero dai Normanni – che attestano la vocazione sacra di quest’area, favorita dalla presenza di una fonte sot-terranea. Probabilmente Piccolo allude a tale fonte e all’avvicendarsi dei culti nel plesso architettonico quando ricorda che intorno alla « colonnina del fonte che fu l’asse del mondo » trascorsero « le paci e le guerre degli uomini ».
2 Lucio Piccolo, Lettera a Gioacchino Lanza Tomasi, cit., p. 63.
118 marta barbaro
L’ombra cresce, ancora poco e lo spazio dell’arco si colmerà d’azzurro già notturno, la calma peschiera dove spegnere ogni ansia. […] L’oscurità dinnanzi è vasto letto di fiumara : scende la piena dai poggi d’aranceti, valletta, piega breve rialzo, o dove stringendosi fra ciglione e ci-glione la zolla vorrebbe divenire sorgiva, tutto dona il suo contributo balsamico alla corrente che rasenta ora i parchi tenebrosi dove ha risonanza ancora il motto del Re al guardiacaccia attonito, son rade le dimore con le terrazze distese dove al muro il Tempo ha la sua misura o dispare nell’informe secondo che il sole sia libero o ravvolto, i ritiri pensosi dove alla finestra terrena sporge in curva la grata il rampicante ha un sussulto inspiegabile e la vasca rotonda di pietra è solcata dal minuscolo navigatore, i campanili dove la fune non muove più canto – erano gracili in trafori alle ultime luci. Prende aliti agresti negli orti invasi dal sereno. (Esequie, p. 28)
Le figurazioni barocche, qui associate agli elementi della natura e alle architetture della città, sono ora rievocate senza alcun distacco ironico da una Memoria accesa e vibrante, che riporta alla luce le tracce di un passato lontano :
Cerchi, ripiegamenti che non sono d’acqua di monte nelle vasche dei giardini, le tuberose e le giunchiglie spirano nel salino. Ma nella stanza del piano di su un primo trasalimento alleg-gerisce la penombra dove negli armastemmati ingialliscono i veli, i merletti, i fiori d’arancio di cera, le cortine poi si gonfiano ofane su le ringhiere delle balconate e gli spiriti del catra-me errano giungono fin qui. Dissipano le ceneri d’un dolore d’anni perché possa levarsi una speranza inattesa ? Ancora : se usciamo sul nostro capo delfini candidissimi, orli, smerlature sembrano sempre sul punto di tuffarsi o emergere da impassibile bacino celeste. Sono i mes-saggi freschissimi che il mare ci manda in segno, a prova del suo estro figuratore. (Esequie, pp. 25-26)1
Nelle sequenze descrittive che seguono l’avanzare della natura lungo il Cassaro – dapprima dalla « Porta grande », aperta ad oriente verso mare, fino al bastione che ad occidente riceve i venti dell’Africa, e poi in senso apposto, dalla « porta di mezzo-giorno e ponente » fino al mare – la geografia dei luoghi torna con evidenza concre-ta, senza nulla di astratto o ritratto genericamente. Attento a riprodurre i colori, gli odori, i suoni, e fin quasi la fibra delle cose, Piccolo unisce alla precisione figurativa una capacità visionaria pronta a cogliere i minimi sussulti della materia e del cosmo. Il dettaglio architettonico, il profilo sinuoso dei palazzi, le ceramiche nelle terrazze o il verde rampicante di balconi e conventi, si animano sotto lo sguardo del poeta ; tutta la città, scossa dall’irrompere del buio e del mare, assume un aspetto fantastico e pare compenetrarsi con le forme mutevoli e fluttuanti della natura.
Più che un artificio retorico, il virtuosismo barocco si concilia con la visione di un mondo « in cui qualunque cosa poteva fluire e mutare, e divenire qualunque altra cosa »,2 un tramite necessario – culturale e artistico – con cui il poeta moderno recu-
1 Mirabile è l’intera sequenza – analogica e sinestetica – del calare della notte sulla città : l’oscurità ora è « soffio » che spira dalle montagne d’Occidente, ora « è vasto letto di fiumara » che scende verso il mare, ora una « piena », una « corrente », e poi di nuovo un « flusso », un « alito », per giungere al climax finale dell’« ondata d’occidente » (« Nativi della sera gli Aranci la Notte li accoglie e pone a guardia gli immensi serpenti siderali. /L’ondata d’occidente li portò »), citazione letterale di To night di Percy B. Shelley (« Swiftly walk over the western wave, / Spirit of Night ! ») e contemporaneamente richiamo al « West Wind » dell’ode più famosa del romantico inglese (nostro il corsivo).
2 William Butler Yeats, L’elemento celtico in letteratura (1897), in Idem, Anima mundi, Saggi sul mito e sulla letteratura, a cura di Rosita Copioli, Parma, Guanda, 1988, p. 58. Fra le molte definizioni della dispo-sizione barocca di Piccolo, particolarmente efficace appare quella di Giancarlo Quiriconi : « [è] espres-sione idonea a rendere conto dell’attuarsi continuo di uno scontro irriducibile di tensioni irrisolte ; è il tentativo di dare corpo e voce alla presenza di una enormità insondabile (e poco importa che assuma di
119la luna di lucio piccolo e i suoi funeralipera la primitiva immaginazione degli antichi e l’incanto di fronte alla potenza della Natura. Ecco, allora, che il mistero prende una consistenza fisica e visiva, e la realtà materiale, sollecitata per via poetica, svela la sua vita misteriosa e un’anima palpi-tante.1 Yeats parlava di « magia naturale »2 e la riteneva il tratto distintivo del popolo celtico, per l’autore dei Canti barocchi, invece, l’apertura al soprannaturale parte dai luoghi dell’infanzia, dalla memoria delle strade, dei quartieri, dei vicoli angusti, delle chiese opulente o degli anditi nascosti della città natale : e così, la Palermo di « un tem-po » – espressione che ricorre più volte in queste brevi sequenze – vivificata dalla forza degli elementi, torna presente e come trasportata nel tempo eterno del mito.
Lì dove dal punto di vista narratologico la coerenza del racconto si frantuma, in realtà l’autore fornisce una premessa indispensabile per il seguito dell’opera e apre una diversa chiave di lettura dell’apologo lunare. È in questi momenti d’intensa lirici-tà in cui il racconto diviene canto, che egli dispiega la sua intuizione metafisica della realtà e trova il modo di unirsi e insieme di congedarsi dalla spiritualità romantica. Attraverso Yeats3 Piccolo si collega al simbolismo neoplatonico dei romantici inglesi, al mistico idealismo di Shelley, alla malinconia visionaria di Keats4 – variamente rie-cheggiati nelle pieghe dei due capitoli in esame – e con loro condivide il senso di una Memoria universale e archetipica che pervade il cosmo. In essa confluiscono l’ansia, l’angoscia, il dolore e, alle volte, la quiete e la gioia di un passato che rimane come at-taccato alle cose e ai luoghi, e che ora trova lo spazio della leggenda, ora si ripresenta in sibilline epifanie.
Rispetto ai predecessori romantici, però, la tensione metafisica non si traduce mai in tensione epica, a partire da una distanza ideale fra il soggetto e la Natura, fra la finitezza individuale e lo spirito universale, fra le distinzioni concrete e l’unità astratta dell’Essere. Più che tendere a una ricomposizione originaria con le forze invisibili del cosmo, il soggetto lirico si muove e svanisce in un « universo allargato »5 dove realtà e sogno, spirito e materia, si confondono continuamente assumendo infinite possibili
volta in volta la fisionomia del divino, o quella magico-esoterica di una profondità animistica subjacente alla perdita delle forme, o di una immanente divinità naturale), enormità cui tende inutilmente e con cui si scontra il senso della fragilità umana. È la volontà di non lasciare sfuggire nemmeno il minimo e apparentemente insignificante tassello di una molteplicità dispersa e frastagliata ma al fondo della quale si indovina o si attende la ricomposizione unitaria e totalizzante » (Giancarlo Quiriconi, I « giorni della luce fragile », in Lucio Piccolo. La figura e l’opera, cit., pp. 213-214).
1 « Il soffio ora sale nella stanza poligonale dove se si accende un fiammifero è un inseguimento di luci e quando la volta s’incurva su la parete questa si ritrae in faville come una cortina sui prestigi della notte. Dove trova rifugio l’ultimo granello luminoso, rimbalzando da vetro a vetro come un gioco di xilofono ? » (Esequie, p. 29).
2 « La nostra “magia naturale” non è altri che l’antica religione del mondo, l’adorazione antica della Natura e quell’estasi turbata di fronte a lei, quella certezza che tutti i luoghi splendidi fossero visitati, che essa istillò nella mente degli uomini » (William Butler Yeats, L’elemento celtico in letteratura, cit., p. 56).
3 Così Yeats : « e non dovrebbe essere più possibile ad alcuno negare l’importanza della forma, in tutti i suoi aspetti, giacché per quanta capacità tu abbia di esporre un’idea, o descrivere qualcosa, non potrai dar corpo a ciò che si muove al di là dei sensi se le tue parole non saranno ben scelte, e finché esse non diverranno sottili, complesse, piene di una vita misteriosa come il corpo di un fiore o di una donna. La forma dell’autentica poesia, diversamente da quella della “poesia popolare”, può a volte essere oscura, o inosservante della grammatica, […], ma deve possedere quelle perfezioni che sfuggono all’analisi, le sottigliezze che ogni giorno si colorano di significati nuovi ; e deve contenere tutte queste qualità insie-me… »; William Butler Yeats, Il simbolismo della poesia (1900), in Idem, Anima mundi, cit., p. 78.
4 Si ricordi che di Keats, Piccolo tradusse in giovane età Ode to a Nightingale.5 Alberto Savinio, Prefazione a Tutta la Vita, in Idem, Casa « la Vita » e altri racconti, a cura di Alessan-
dro Tinterri, Paola Italia, Milano, Adelphi, 1999, p. 556.
120 marta barbarocombinazioni. Se la lingua non fosse sommamente elevata, il procedere per accumu-lazione, l’ossessione a nominare, enumerare e quasi catalogare con precisione ogni cosa (con uno scavo minuzioso nel vocabolario tecnico dell’architettura e della bota-nica), potrebbero essere accostati alla scrittura di Gadda, la cui esuberanza barocca testimonia la tensione sempre frustata ad afferrare una realtà incontrollabile e senza centro.
Al pensatore moderno manca il senso stesso delle opposizioni irriducibili : come un ‘platonico’, Piccolo pensa « che l’universo è in qualche modo un cosmo, un or-dine », ma come un ‘aristotelico’ sente che tale ordine « può essere un errore o una finzione della nostra conoscenza parziale ».1 Nessuno sguardo nega o annulla l’altro, sì che la poesia registra, ad un tempo, il fluire dei molteplici oggetti concreti e il loro persistere al di là del tempo come simboli universali. Il cronotopo mitico delle Esequie della luna si configura allora come uno Spazio/Tempo estremamente ambiguo : reale, concreto, eppure aperto, mobile, inquieto, perenne e allo stesso tempo fugace, dove non compaiono né dei né eroi a suprema garanzia della stabilità del Cosmos sul Caos. I romantici invocavano la perduta ingenuità degli antichi, « quell’armonia sensibile » che accordava la vita alla « semplicità naturale »,2 al ritmo ciclico delle stagioni e degli astri ; Piccolo, invece, sposta il suo « romantico sentire » in un mondo senza dei e in « un cielo nudo di stelle ».3
1 « Coleridge osserva che tutti gli uomini nascono aristotelici o platonici. Gli ultimi sentono che le classi, gli ordini e i generi sono realtà ; i primi, che sono generalizzazioni ; per questi, il linguaggio non è altro che un approssimativo giuoco di simboli ; per quelli è la mappa dell’universo. Il platonico sa che l’universo è in qualche modo un cosmo, un ordine ; tale ordine, per l’aristotelico, può essere un errore o una finzione della nostra conoscenza parziale. Attraverso le latitudini e le epoche, i due antagonisti immortali cambiano di lingua e di nome : uno è Parmenide, Platone, Spinoza, Kant, Francis Bradley ; l’altro, Eraclito, Aristotele, Locke, Hume, William James. […] Gli uomini, disse Coleridge, nascono aristotelici o platonici ; della mente inglese è dato osservare che nacque aristotelica. Il reale, per quella mente, non sono i concetti astratti, ma gli individui ; non l’usignuolo generico, ma gli usignuoli concreti. È naturale, forse inevitabile, che in Inghilterra non sia compresa rettamente l’Ode a un usignuolo » ( Jorge Luis Borges, L’usignolo di Keats, in Idem, Altre inquisizioni, Milano, Feltrinelli, 1963, p. 122).
2 Le citazioni sono tratte da Schiller che così definisce il sentimento dei moderni rispetto agli antichi : « Essi [gli antichi] sentivano in modo naturale, noi sentiamo il naturale. […] Il nostro sentimento per la natura è simile a quello che il malato prova per la salute » ; e più oltre « Quando l’uomo ha fatto il suo ingresso nello stato della cultura e l’arte si è impadronita di lui, egli ha perduto quell’armonia sensibile ed è stato in grado di manifestarsi soltanto come unità morale, cioè come aspirazione all’unità. L’armonia fra il suo sentire e il suo pensare, che nel primo stato aveva luogo realmente, esiste ora solo idealmente, non è più in lui bensì fuori di lui e, come pensiero che deve ancora realizzarsi, non esiste più come una realtà attuale della sua vita. Se ora si applica a entrambi gli stati il concetto di poesia, che semplicemente con-siste nel conferire all’umanità la più completa espressione possibile, vediamo che nello stato della semplicità naturale, in cui l’uomo agisce ancora con tutte le sue forze contemporaneamente, come unità armoni-ca, e in cui la totalità della sua natura si esprime compiutamente nella realtà, l’elemento costitutivo della poesia è l’imitazione più perfetta possibile del reale ; invece nello stato della cultura, in cui quell’armo-nico concorso di tutte le forze della propria natura è semplicemente un’idea, ciò che definisce il poeta è la capacità di elevare la realtà all’ideale o, il che è lo stesso, alla rappresentazione dell’ideale »; Friedrich Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale (1795-1796), Milano, Mondadori, 1995, pp. 40-42.
3 Alberto Savinio, Storta la vita sana ?, in Idem, Casa « la Vita », cit., p. 399. Piccolo, pensava Sciascia, « non chiede una certificazione dell’al di là, ma una certificazione della vita, della realtà […], del perfetto, assurdamente perfetto, labirinto della vita », e lo definiva un « mistico della realtà materiale » (Leonardo Sciascia, Le « soledades » di Lucio Piccolo, cit., p. 207). Nella sostanza concettuale, se non proprio nella ricerca formale, il suo mondo lirico è più vicino a quello del ‘metafisico’ Alberto Savinio che al mondo ideale vagheggiato dalla soggettività romantica. Entrambi – Piccolo e Savinio, un binomio che Sciascia soleva formulare – sebbene con una strumentazione filosofica e un’erudizione poetica molto diverse, approdano ad una « metafisica terrena », réelle, tesa a far scaturire il fantastico dentro la realtà materiale, ovvero la metafisica dentro la fisica.
121la luna di lucio piccolo e i suoi funerali
iv. Il « dis-astro » e l’‘erranza’ del testo
La vicenda della luna, che muore e lascia di sé solo un bagliore luminoso, è paradig-matica e mostra le estreme risorse di una scrittura che si regge sulla vanità di ogni « teorema cosmico ».1 La divinità notturna non viene mai citata in questi intermezzi lirici, ma è lei che governa le maree, da lei dipende il movimento di tutte le acque e delle erbe, la quiete della notte e il volgersi del tempo. Ce lo riferirà in seguito la voce narrante che, riprendendo un andamento più discorsivo, espone le vedute di un certo accademico, « poco accreditato per altro a causa delle sue uscite insensate, della incomprensibilità dei suoi scritti » :
Per lui l’ufficio della luna era questo : controllare con i suoi arti invisibili – aggiungeremo che la chiamava coi nomi tolti dal persiano, dall’arabo, ecc. – non solo tutto quanto nel mondo visibile ha effetto da lei come per esempio il tessuto cangiante delle maree che tiene a suo arbitrio per un filo, ma pure durante il tempo del suo magistero, governare tutte quelle cose – attimi, ore, giorni, millenni – seguendo la parabola inesorabile già nascosta dietro l’orizzonte in compagnia dei regni trapassati, degli dei caduti in discredito, acquattati in attesa d’un im-possibile ritorno. (Esequie, p. 40)
Le teorie lunari di questo accademico, un Platone Redivivo, sono « fin troppo cervel-lotiche », e persino il narratore se ne dissocia – « Riferiremo le sue vedute senza però associarci ad esse, dato che ci sembrano fin troppo cervellotiche » – ma è chiaro che qui Piccolo, dietro il distacco con cui la voce narrante conduce la « relazione » dei fatti, vuol richiamare l’attenzione del lettore sulla misura paradossale del suo uni-verso poetico, ed è legittimo credere che dietro la figura dell’accademico screditato si nasconda proprio l’identità del poeta.2 Da un lato conferma l’ufficio mitico della luna quale intermediaria fra tempo umano e tempo cosmico e allude a una rete di invisibili nessi simbolici che dall’astro si diramano verso tutto il mondo fenomenico fino alle argenterie e ai lini delle case ;3 dall’altro sembra svelare l’inganno sotteso ad ogni attribuzione simbolica o investimento sacrale, affermando l’« inesorabile » tran-sitorietà di ogni sistema mitico e di ogni ordine ideale. Così, « riguardo al senso della catastrofe lunare », egli spiega :
Si generava quindi una sorta di oscillazione, un’ambiguità del momento presente (dove è memoria e dove la luna che avanza ?) che tutti sentivano, di cui pochi erano coscienti. (Esequie, p. 40)
La caduta della luna – l’astro errante, che da sempre racconta ai poeti « del cosmo e
1 La formula è di Piccolo e ricorre in L’orologiaio prodigioso, una sorta di poemetto in prosa ritrovato fra le carte del poeta e pubblicato postumo (Lucio Piccolo, L’orologiaio prodigioso, in Idem, L’esequie della luna, cit., pp. 53-56).
2 L’ipotesi è suffragata dal fatto che altre volte Piccolo si cita indirettamente nel testo, alludendo all’autore de L’orto delle Esperidi – « Melodramma di autore poco noto e assai meno ben visto, di cui forse un giorno sarà dato di conoscere i testi poetici » – melodramma incompiuto ritrovato fra le sue carte col titolo Il giardino delle Esperidi e che forse sarebbe dovuto essere parte delle Esequie. Anzi è possibile ipotizzare che tutti gli scritti del periodo, fra cui anche L’orologiaio prodigioso, se non fossero stati pensati proprio per una redazione più ampia del ‘balletto’, costituiscano comunque un insieme unitario gravi-tante intorno allo stesso tema.
3 « Pure sotto l’influsso lunare doveva ritenersi il chiarore interno dei lini nell’oratorio e il volatile lu-cente su per il soffitto, sui sovraporte, nel coro, su lo zoccolo, sempre assente dove si ferma lo sguardo, gioco vagante di specchi da mano instabile, anche quando fuori è il giorno e sui campanili, su le logge su le piazze, s’incurva, palpita in sé, flabelllo immenso dorato di gaggie, un cielo di vigilia » (Esequie, pp. 42-43).
122 marta barbarodella sua armonia, del tempo e della sua regolarità »1 – apre una falla nel costante mec-canismo del cielo e provoca uno sconvolgimento nell’ordine dello spazio e del tem-po, tale da riportare ogni esperienza a un presente ambiguo e oscillante. Dialogando innanzitutto con Leopardi, che aveva posto il binomio ‘memoria-luna che avanza’ al centro della sua costruzione poetica, Piccolo associa la disgregazione lunare a una sorta di ‘presentificazione’ del tempo che – anticipando le teorie postmoderne della crisi della temporalità e della durata – vanifica le consuete categorie interpretative della realtà, non solo quelle logico-razionali, ma principalmente quelle simbolico-poetiche. Leopardi, nello Spavento notturno, non osò immaginare una simile catastro-fe se non in sogno, forse prefigurando la morte delle illusioni e della stessa poesia,2 e lasciò sospeso il suo frammento sull’immagine terrificante della luna carbonizzata e di una nicchia vuota nel cielo : « Ch’io ne agghiacciava ; e ancora non m’assicuro ». Pic-colo, invece, senza rinunciare a forzare per via magica e poetica i segreti dell’univer-so, spinge la propria immaginazione sul vuoto, su quel « vacuo di tempo e per questo colmo di eventi possibili »3 e ne sfida le possibilità di rappresentazione.
Senza giungere alle conclusioni entusiastiche di Maurice Blanchot, che festeggiava « l’atto sacrilego » di Gagarin come provvidenziale liberazione dall’uomo sicuro del proprio rifugio siderale, dall’uomo « melanconico » « incrostato per sempre dove si trova, nella propria tradizione, nella propria verità, nella propria storia »,4 l’autore delle Esequie della luna leggeva ugualmente nel « dis-astro » la fine di una natura sa-cra, della rappresentazione rassicurante del kòsmos in quanto ordinamento stabile e gerarchicamente organizzato. Come per Blanchot, la fine del mito lunare proiettava in un mondo inedito, in uno spazio plurimo che non è cielo né natura « ma è la pura e semplice realtà di un (quasi) vuoto misurabile » : « qualcosa di infinitamente meno rassicurante – commenta Colangelo – ma anche di allusivo a un’eccedenza dall’eco-nomia ristretta dei significati preordinati ».
Così, abbandonato di colpo e senza mediazioni il piglio narrativo, una nuova se-
1 Si segnala lo studio di Pietro Greco, L’astro narrante. La luna nella scienza e nella letteratura, Milano, Springer, 2009, p. 1, che, pur senza la preparazione del filologo di professione, ripercorre con passione quei momenti della letteratura italiana in cui, attraverso la mediazione della luna, « scienza e immagi-nazione s’incontrano ».
2 « Nel saggio sopra gli errori popolari degli antichi […], Leopardi aveva accumulato su quell’ope-razione magica quantità di testi, con scrupolo da erudito. Ma quando volle farne motivo di poesia, la scomparsa dal suo cielo della vereconda giovinetta immortale gettata su di un prato come un immondo oggetto inservibile, risveglia in lui terrore, vuoto, cancellazione. Non è lontana la morte della bellezza e della stessa poesia » (Giovanni Macchia, La caduta della luna, cit., p. 96).
3 Lucio Piccolo, L’orologiaio prodigioso, cit., p. 56. A margine si rileva come la tensione conoscitiva della poesia di Lucio Piccolo si eserciti innanzitutto come interrogazione sul tempo, nel tentativo co-stante e sempre irrisolto di dare una misura – riportare entro categorie umane – all’invisibile, a ciò che esula dalle possibilità conoscitive dei sensi e della razionalità. Una ricerca/recerche che non trova mai una formulazione concettuale ma si traduce sulla pagina nella presenza ossessiva di strumenti di misurazio-ne – meridiane, clessidre, orologi, pendoli, bilance, almanacchi, lunari – oggetti simbolo della mancanza di presa, dello scacco dell’uomo di fronte al tempo.
4 Così Blanchot : « è rimasto sconfitto da Gagarin l’uomo che, in noi, è eternamente sedotto dal pa-ganesimo, che ha come suprema aspirazione di abitare la terra, di insediarsi sulla terra, di soggiornare, fondare, mettere radici, aderire ontologicamente alla razza biologica e al suolo ancestrale ; l’uomo pos-sessivo che vuole avere la terra e che la terra ha, che sa appropriarsi e aggrapparsi, incrostato per sempre dove si trova, nella sua tradizione, nella sua verità, nella sua storia, e non vuole che si attenti alle sedi sacre del bel paesaggio e del grande passato ; il melanconico che si consola della malvagità degli uomini frequentando gli alberi. Gagarin ci ha, per un momento, affrancati da un tale uomo e alleviati della sua suppellettile millenaria » (Maurice Blanchot, La conquista dello spazio, « Il menabò », v, 7, 1964, pp. 10-13). In merito alle posizioni di Blanchot si confronti Carmelo Colangelo, op. cit., pp. 97-125.
123la luna di lucio piccolo e i suoi funeraliquenza si apre su uno scenario scomposto e disgregato, dove eventi, immagini e fi-gurazioni del passato e del presente si mescolano, convergendo in una nuova mitica, caotica configurazione. Il nuovo assetto ha ancora una volta un referente letterario e prende le mosse dall’anticosmo di Erittone 1 e da quella « maledetta luna della Tessaglia » che tanto impressionò la fantasia leopardiana ; ed ecco che « il Caos avido di rimesco-lare mondi innumerevoli »2 si esalta in una serie di fenomeni straordinari culminanti, come nella Pharsalia di Lucano, nell’immagine dei morti che risalgono dalla terra :
Ombre d’ombre come su vetri senza segreti guardati di sbieco, ecco le Regine, i Cancellieri subdoli e violenti donatori di abbazie, i Maestri delle Fontane, quelli dei Palmizi e dei fiori, le Abbadesse sonnolente o quelle ossute cui una pronunziata peluria ombreggiava il labbro superiore tanto da far pensare a qualche irriverente opportuna l’opera del barbitonsore. Nei monasteri femminili benché questi fabbricati vetustissimi non fossero come le campagne pie-namente innanzi alle vicende vaste e silenziose del firmamento, tuttavia i giuochi le astuzie le discrete invadenze lunari erano copiose di risultati singolarissimi con la complicità, s’intende, dell’apertura nei cortili, era lei che scivolava su lo smalto delle fronde delle muse o mutava in gronda luminosa qualche tegola inclinata largiva subite chiarite ai passaggi alle scalette di legno, gli àstrachi, le lunghe grate delle facciate comparivano siepi folte di biancospino, e le murate, prive d’ornamento, eccetto qualche traccia di festoni e di ancore, divenivano esili selve, scalee rampa su rampa in traforo fino alle regioni degli alti venti.
Diremo pure di Suor Crocifissa (nessuno si ricordava quando fosse morta) la quale si fa-ceva presente entrando ed uscendo disinvolta dalle pareti e – perché tacerlo ? – non si può negare che mettesse un talquale brivido al mercurio nelle vene di chi assisteva. Si racconta che qualche volta si rendesse visibile anche nel parlatoio aggiungeremo anzi un dettaglio : nel dileguarsi sul muro, lasciava al pavimento un lembo della sua tonaca che si andava nel disparire restringendo vibratile e discreto come la coda di qualche strano poco rassicurante animaletto. (Esequie, pp. 41-42)
La lievità ironica e il tono colloquiale non sottraggono nulla all’incanto della rappre-sentazione che, come in un gioco di scatole cinesi, fa scaturire nuovi percorsi fantasti-ci proprio quando mostra la fragilità e la morte della più universale delle figurazioni mitiche. Nulla finisce con l’estinguersi della luna e tutto sembra rimanere sospeso in una vaga inquietudine, in una calma primavera che promette ancora altre epifanie ; come per la serva Pasqua, la più colpita dalla catastrofe e, insieme, transfer metafori-co dell’antica « giovinetta immortale » :
Oh il suo volto dietro la grata, nel pomeriggio che ancora non immagina tramonto, perfetta-mente circolare, privo di una ruga, benché fosse tutt’altro che una giovinetta – aprile calmo già insediato – tra la malvetta e il garofano. (Esequie, p. 43)
Nelle Esequie della luna manca del tutto l’aspetto macabro e demoniaco, che da Lu-cano giunge, invece, a Baudelaire – manca la descrizione delle erbe fumanti e schiu-mose, l’arsione velenosa della luna diventa una pioggia di lievissime garze bianche, la terribile rianimazione del soldato morto si trasforma nel lieve episodio di Suor Crocifissa che riappare nel parlatoio – eppure l’oltranza fantastico-lirica implicata nella vicenda lunare esprime un’uguale « tentazione dell’impossibile »,3 la volontà di
1 Cfr. Roberto M. Danese, L’anticosmo di Erittone il capovolgimento dell’inferno virgiliano, « Atti dell’Ac-cademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Memorie », ix, iii, 3, 1992, e Sonia Gentili, La necromanzia di Eritone da Lucano a Dante, in http ://www.disp.let.uniroma1.it.
2 Giovanni Macchia, op. cit., p. 95.3 Nel citato saggio su La caduta della luna, Macchia ricerca la presenza della luna tessala nelle lune
dell’arte e della letteratura successive, e così osserva : « Le trasmutazioni della materia, il turbamento e la rivolta dell’ordine naturale rivelano nella struttura privilegiata di alcuni poeti una fantasia sconvolta dalla tentazione dell’impossibile e del demoniaco » (Ibidem).
124 marta barbaroportare la parola poetica fino al limite massimo della sua estensione conoscitiva. Pic-colo sembra essere ben consapevole che la conoscenza umana, fantastica, mitica o scientifica che sia, poggia sempre su « schemi inflessibili e illusori »1 che, come la luna, possono sfaldarsi e cadere senza schianto ; ma crede anche che ogni morte è rinascita, metamorfosi incessante e che di ogni verità che muore si conservano le tracce – le forme, i sensi – nel rimescolarsi caotico dei tempi.
Riletto in quest’ottica anche il seppellimento dei resti lunari nella terra, vicino le acque di un fonte, assume un significato più profondo e sembra fondare attraverso il sacrificio della divinità un nuovo mito moderno di ordine paradossale. Il rito funebre e la processione surreale con cui si chiude la pièce narrativa lasciano aperta la conclusio-ne ad un continuo proliferare di situazioni e di personaggi – altri « tipi della razza uma-na » – che partendo dalla « trita, ovvia tradizione letteraria » danno avvio ad altre storie, come se la narrazione si ravvivasse, ricominciasse da capo, dove doveva spegnersi.
Poco dopo la pubblicazione delle Esequie della luna, parallelamente Italo Calvino e Andrea Zanzotto s’inserivano nel dibattito in merito agli sbarchi lunari : l’uno soste-neva, sul « Corriere della sera » del dicembre del 1967, che « il fatto che siamo obbligati a ripensare la luna in un modo nuovo ci porterà a ripensare in modo nuovo tante cose »2 e, sulla scia delle Cosmicomiche e di Ti con zero, andava elaborando un progetto narrativo che coniugava l’immaginazione letteraria con il linguaggio delle scienze contemporanee, la cosmologia, la fisica, la genetica e la matematica ; nello stesso anno, Zanzotto, già autore di una lirica occasionata dal lancio dello Sputnik,3 andava componendo i « frammenti di un’imprecisa storia dell’avvicinamento umano alla dea-luna, fino al contatto »4 in un poemetto, che l’anno successivo avrebbe battezzato col titolo Gli sguardi i fatti e i senhal. Di fronte alla violazione del mito lunare, alla defla-grazione della più venerabile illusione cosmica, che rendeva ancora più complesso « il mosaico in cui l’uomo si trova incastrato », entrambi si ponevano il compito di sfatare l’epos millenario che invocando un rapporto sentimentale con la natura finiva con lo ‘strumentalizzarla’ per dare quiete e conforto all’animo umano.5 Calvino si appella-va, allora, ad una mitologia moderna capace di scardinare le « abitudini dell’imma-ginazione »6 e ora ritornava al « vecchio gioco dell’antropomorfismo », ora esplorava
1 Lucio Piccolo, L’orologiaio prodigioso, cit., p. 55.2 Italo Calvino, Il rapporto con la luna, « Corriere della sera », 24 dicembre 1967 ; citato da Idem, Una
pietra sopra. Discorsi di letteratura e società (1980), Milano, Mondadori, 1995, p. 221.3 Andrea Zanzotto, 13 settembre 1959 (variante), in Idem, ix Ecloghe, Milano, Mondadori, 1962. Preme
mettere in evidenza che la plaquette di Zanzotto, ix Ecloghe, era evidentemente conosciuta da Lucio Piccolo che ne possedeva una copia autografata dall’autore, recante la dedica « A Lucio Piccolo il suo affezionatissimo Andrea Zanzotto » ; la copia – nell’edizione citata – si trova oggi conservata presso la Biblioteca del Museo Lucio Piccolo di Ficarra.
4 Così scrive Zanzotto in una nota che accompagna il testo : cfr. Andrea Zanzotto, Gli sguardi i fatti e i senhal, in Idem, Le Poesie e Prose scelte, a cura di Stefano Dal Bianco, Gian Mario Villalta, Milano, Mondadori, 1999.
5 In risposta ad Anna Maria Ortese così scrive Calvino nel citato articolo del « Corriere della sera » : « guardare il cielo stellato per consolarci dalle brutture terrestri ? Ma non le sembra una soluzione troppo comoda ? Se si volesse portare il suo discorso alle estreme conseguenze, si finirebbe per dire : continui pure la terra ad andare di male in peggio, tanto io guardo il firmamento e ritrovo il mio equilibrio e la mia pace interiore. Non le pare di “strumentalizzarlo” malamente questo cielo ? » (Italo Calvino, Il rapporto con la luna, cit., pp. 220-221). Allo stesso modo Zanzotto « ha fatto della fascinazione ambigua dello scrittore per il mondo naturale un tema decisivo di meditazione, indicando in essa il prodotto di un’illusione, nonché l’esito di una sorta di fuga », colpevole in ultima analisi di aver modellato gli stessi « fantasmi di potenza e di appropriazione dell’agire tecnico », cfr. Carmelo Colangelo, op. cit., p. 136.
6 Italo Calvino, Premessa 1968 a Idem, La memoria del mondo e altre storie cosmicomiche, in Idem, Ro-manzi e racconti, ii, a cura di Mario Barenghi, Bruno Falcetto, Milano, Mondadori, 2005, p. 1301.
125la luna di lucio piccolo e i suoi funeraliin un gorgo di congetture le molteplici possibilità combinatorie del linguaggio e del pensiero. Zanzotto, invece, faceva coincidere il franare dell’astro e del suo portato simbolico con l’« apertura di un altro spazio di senso »,1 permeabile al banale, al cao-tico, all’informe, al residuale, tale da ricreare il momento aurorale della manovra idealizzante, e disvelare pertanto la mancanza originaria della soggettività umana.
Sollecitato dalle stesse urgenze e dalla necessità di ripensare la posizione dell’arte nel rapporto fra umano ed extraumano, Lucio Piccolo ripercorre a ritroso le modali-tà simboliche e linguistiche stratificate nell’immaginario letterario approdando a una scrittura « palinsestica »2 e iperletteraria ; egli esprime quella che Blanchot chiamava « l’irrevocabilità, per l’uomo, di un’erranza indefinita » attraverso una struttura die-getica dispersiva e paradossale, che con la lievità di una danza scivola attraverso le ipotesi più contraddittorie, fondendo, talvolta facendo cozzare, modalità scrittorie differenti, per ambientazione, tono, registro, genere, dove si rompono continuamen-te le regole della consecutio temporum e quelle della finzione narrativa. Le Esequie della luna possono così considerarsi come un’opera molteplice che, nell’ansia di trovare un senso ad una realtà sfuggente e smisurata, non esaurisce il proprio discorso e nella leggerezza della sintassi lirica iscrive la propria fiducia nel potere vivificante e rigene-rativo della parola poetica.
1 Andrea Zanzotto, Le Poesie e Prose scelte, cit., p. 1522.2 La formula è usata da Vincenzo Consolo nell’intervista documentario Lucio Piccolo. Mondo lirico di
Marco Battaglia, Comune di Sortino/Associazione culturale clac, 2008.