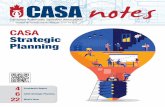LA CASA DEL RE E IL DEPOSITO DELLE TAZZE
-
Upload
wwwuniroma1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LA CASA DEL RE E IL DEPOSITO DELLE TAZZE
1 Il lavoro appassionato di studenti e laureati ha consentito di portare a termine una parte consi-stente dell’indagine, si ringraziano pertanto: i dott. Andrea Di Napoli, Matteo Milletti, Federica Pitza-lis (responsabili sul campo); Milena Basili, Elisa Biancifiori, Carmen Colomba Carraro, Francesca Ro-mana De Castro, Livia Gabbrielli, Giulio Galluzzi, Silvia Martini, Chiara Mottolese, Federico Nomi,Valerio Palone, Silvia Picucci, Veronica Re, Maria Taloni per il loro impegno costante.
LA CASA DEL RE E IL DEPOSITO DELLE TAZZE1
La Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana in collaborazione conla Cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica dell’Università di Roma ‘LaSapienza’ conduce dal 2003 indagini stratigrafiche nell’area sud-orientale dellasommità del Poggio del Telegrafo, a seguito di ricerche di superficie promossenegli anni 1999-2000 dall’Insegnamento di Archeologia dei Paesaggi dell’Uni-versità degli Studi di Siena (prof. Franco Cambi; dott.ssa Maria Aprosio;APROSIO 2002). Il saggio di scavo oggetto del presente lavoro è posto a montedel salto di quota che caratterizza il profilo del poggio sul versante prospicien-te Cala San Quirico e l’isola d’Elba (Fig. 1).
Nel corso delle tre campagne di ricerca condotte fino al 2005 è stata indaga-ta una sequenza stratigrafica, articolata tra la prima età del Ferro e la fine delVII-inizi del VI secolo a.C., cui fa seguito una cesura nella frequentazione chesi estende fino all’avvio del processo di romanizzazione agli inizi del III secoloa.C. (ACCONCIA, DI NAPOLI, GALANTE, MILLETTI, PITZALIS, c.s. a; ACCONCIA,MILLETTI, PITZALIS, c.s.).
1. Lo scavo e il deposito
La campagna di scavo del 2005 ha fatto emergere nella porzione centraledel saggio (Fig. 1) un complesso di evidenze relative alla prima frequentazionedel sito, costituite prevalentemente da tagli realizzati nel banco geologico e dailoro riempimenti, riferibili a varie strutture con alzato sostenuto da pali lignei.Queste risultavano però pesantemente alterate da fenomeni post-deposizionalidi varia natura. L’area, infatti, si trova a ridosso del già citato salto di quota che
12 Valeria Acconci, Gilda Bartoloni
segna le pendici sud-orientali dell’acropoli, ed è quindi soggetta a un intensodilavamento dovuto anche all’estrema friabilità del banco geologico, compostoin superficie da una roccia tipo alberese (cosiddetto “galestro”) scarsamenteresistente e tendente a sfaldarsi per piani foliati. Lo stato di conservazione del-
Fig. 1 - L’acropoli di Populonia. A: il posizionamento del saggio alle pendici sud-orientali(PdT); nel riquadro, estensione dell’area di scavo (PdT): in retino grigio l’area descritta nel pre-sente intervento (campagne di scavo 2003-2005).
La casa del re e il deposito delle tazze 13
le strutture oggetto del presente lavoro risulta ulteriormente compromesso dainterventi di asporto, rasatura e riutilizzo verificatisi a partire dalla metà circadel VII secolo a.C., il più evidente dei quali è l’apertura di una cava per l’estra-zione dell’arenaria (localizzato al di sotto dell’alberese affiorante), avviata inetà repubblicana (Fig. 3).
L’attuale superficie del banco, fortemente danneggiata dal complesso diqueste azioni, presenta quindi una accentuata pendenza da nord verso sud. Ipiani di vita dei periodi in esame sono così stati asportati completamente ed èplausibile che anche i limiti superiori dei tagli per l’alloggiamento dei pali edelle canalette siano stati pesantemente alterati, come dimostra il fatto chequelli posti a sud, a ridosso appunto del limite della cava, presentino unaprofondità inferiore rispetto agli altri a monte.
Fig. 2 - Matrix di attività relativo ai periodi I e II (elaborazione: V. Acconcia).
14 Valeria Acconci, Gilda Bartoloni
La comprensione del complesso così rinvenuto, poi, è resa problematicadalle scarsissime relazioni stratigrafiche dirette che interessano le varie emer-genze. Queste ultime, avendo restituito solo pochi materiali e purtroppo tipo-logicamente non rilevanti, risultano anche difficilmente databili.
Nella porzione sud-orientale del saggio è possibile isolare un complesso dialloggiamenti circolari funzionali al sostegno di pali lignei, gravitanti intorno aun taglio più ampio, di forma pressoché ellissoidale con pareti a profilo inter-rotto (Figg. 3-4). Tale emergenza è stata identificata con una capanna a fondoribassato, che al momento sembra svilupparsi per circa 5 m in senso nord-ove-st/sud-est e per 7 m in senso sud-ovest/nord-est. A favore di tale ipotesi si po-ne la presenza di un tratto di incannucciata conservato lungo il margine setten-trionale del taglio ellissoidale sul fondo, forse il resto di una parete (ACCON-CIA, MILLETTI, PITZALIS, c.s. b). Gli alloggiamenti circolari presentavano am-pio diametro (tra 0.50 e 1 m circa), pareti rettilinee e fondo piano (con unaprofondità variabile tra 1 e 0.3 m, tendente a diminuire come già detto danord verso sud). Al loro interno erano originariamente alloggiati i montanti li-gnei, poi inzeppati da strati compatti di scaglie di galestro, funzionali ad assi-curare maggiore stabilità, come riscontrato ad esempio nel sito di Rondelli, aFollonica (ARANGUREN et al. 1998).
Non essendo ancora stato completato lo scavo di tale struttura e dell’areacircostante, il rapporto tra le evidenze appena descritte risulta al momento in-certo. Se, infatti, si può riconoscere una serie di buchi interni, funzionali forsea sostenere l’intelaiatura del tetto, e una più esterna relativa alle falde, altri taglicircolari non sembrano coerenti con tale sistema, e non si può escludere chedebbano essere attribuiti a restauri della capanna o ad altre strutture. Lo scavodegli alloggiamenti ha del resto messo in evidenza una serie di rifacimenti, rea-lizzati asportando i pali e parte delle inzeppature e apprestandone di nuovi.
Una definizione cronologica puntuale di tale complesso risulta al momentodifficile. Pur avendo infatti restituito l’unico resto di un alzato per le fasi inesame, la cavità ellissoidale è stata interessata da numerose azioni di asporto.Già alla metà del VII secolo a.C., una fossa di grandi dimensioni intaccava pe-santemente i depositi relativi al suo abbandono; in età repubblicana, poi, essaera disturbata dall’impianto di un muro e da varie trincee di spoliazione. L’u-nico elemento cronologico utile per definire la datazione della struttura sem-bra al momento un frammento di impasto bruno non tornito decorato a fascidi linee incise, tipiche del repertorio villanoviano, rinvenuto all’interno di unodei buchi venuti alla luce nella più recente campagna 2006 nell’ampliamentoulteriore dell’area di scavo verso est. Una datazione al IX-VIII secolo a.C. del-la capanna è già stata proposta sulla base della planimetria curvilinea, frequen-
La casa del re e il deposito delle tazze 15
te per questa fase, in anticipo rispetto a quella regolare attestata nello stesso si-to a partire dalla fine dell’VIII secolo a.C. (ACCONCIA, MILLETTI, PITZALIS,c.s.). Andrebbero quindi ascritti alla struttura ellissoidale i numerosi materialiresidui databili alla prima età del Ferro rinvenuti nelle stratigrafie delle fasisuccessive, che attestano l’avvio della frequentazione dell’acropoli populoniesegià nel IX secolo a.C. (periodo I della scansione interna del sito, vedi il matrixdi attività alla Fig. 2; per la formazione dell’abitato populoniese nell’età delFerro, BARTOLONI 2004; BARTOLONI c.s. a).
Se, come già accennato, tale complesso non presenta relazioni dirette con ilresto dei tagli rinvenuti, è invece possibile articolare una sequenza crono-stra-tigrafica per le altre evidenze. Queste ultime sono comunque disturbate dai giàricordati interventi di asporto e dilavamento, ma presentano rapporti stratigra-fici diretti che, associati alla lettura planimetrica della loro distribuzione, con-sentono di individuare alcuni specifici interventi costruttivi, attribuiti comples-sivamente alle prime cinque fasi del periodo II della scansione cronologicaproposta per il sito, corrispondente all’Orientalizzante (Fig. 2).
Fig. 3 - Pianta composita dei tagli relativi ai periodi I e II; in evidenza i rapporti stratigrafici di-retti (elaborazione: V. Acconcia).
16 Valeria Acconci, Gilda Bartoloni
Occupa pressoché l’intera porzione occidentale del saggio di scavo un seriedi alloggiamenti circolari (realizzati con la stessa tecnica descritta per la capan-na ellissoidale) riferibili a una struttura a pianta rettangolare (Figg. 3-6). Que-st’ultima risultava al momento dello scavo interrotta dal taglio della cava, masembra svilupparsi per almeno quattro allineamenti orientati in senso nord-ovest/sud-est. I primi due, da est, sono composti rispettivamente da tre allog-giamenti circolari, solo da due gli altri. Non si può escludere che la cava e l’al-terazione naturale del piano geologico abbaino determinato l’asporto di altribuchi, da localizzare a sud di quelli conservati. L’alloggiamento più a nord del-la seconda fila è collegato a quello centrale da una canaletta e al primo dellaseconda serie da un’altra (che reca tracce di inserzioni di pali sul fondo), fun-zionali a sostenere pareti in incannucciata. L’anomala forma allungata dell’ulti-mo alloggiamento della fila orientale fa ipotizzare l’esistenza di un’altra cana-letta, probabilmente collegata a un altro buco, ambedue completamente rasati.L’andamento ortogonale e convergente delle due canalette conservate, suggeri-sce la presenza di un angolo chiuso.
Fig. 4 - Pianta composita dei tagli relativi ai periodi I e II, i retini definiscono la scansione in fasi(elaborazione: V. Acconcia).
La casa del re e il deposito delle tazze 17
Nella prima fila a est, poi, il taglio centrale risulta in asse con le altre serie,mentre quelli a nord e a sud sembrano lievemente divergenti. Tale discordan-za potrebbe essere legata alla diversa funzione di tali buchi, che potrebberoaver sostenuto i pali di una piccola area porticata, come si riscontra ad esem-pio sulle due fronti brevi della cosiddetta ‘casa di legno’ rinvenuta a Veio neipressi della Porta Nord-Ovest, pressoché coeva alla struttura di Poggio delTelegrafo (WARD PERKINS 1959; BARTOLONI 2003, p. 16; VAN KAMPEN 2003,pp. 24-25).
Quest’ultima (ascritta al periodo II, fase a; Figg. 4-6) doveva essere copertada tetto stramineo e, sulla base dei vari interventi individuati in corrisponden-za degli alloggiamenti dei buchi di palo, sembra essere stata restaurata almenodue volte e dismessa intenzionalmente, nel primo quarto del VII secolo a.C.(infra).
Fig. 5 - La struttura rettangolare, dettaglio (elaborazione: V. Acconcia).
18 Valeria Acconci, Gilda Bartoloni
Successiva sembra un’altra struttura a pianta rettangolare, che potrebbeaver sfruttato in parte gli alzati della prima (periodo II, fase b; Figg. 2, 4). Essasi individua infatti in corrispondenza di due canalette ortogonali tra loro, chepresentano pressoché lo stesso andamento delle precedenti, divergendo di cir-ca 5° verso nord-est. La canaletta orientata in senso nord-est/sud-ovest, termi-na con un alloggiamento che si innesta sulla canaletta della struttura preceden-te, facendo emergere un rapporto di posteriorità rispetto a quest’ultima. Sem-brerebbero pertinenti a tale sistema altri tre alloggiamenti posti in asse tra diloro e con quello precedentemente descritto, il cui andamento risulta paralleloalla canaletta orientata in senso nord-sud. All’interno di questo allineamento ilprimo buco dista circa 1.85 m dal secondo, e questo è separato dal terzo dallastessa misura. Gli ultimi due sono collegati da un breve taglio, localizzati a sudtra i buchi della fase precedente attribuibili a un sistema composto da un paloe dal cardine di una porta (come in NEGRONI CATACCHIO 1995, pp. 324-329,Fig. 127, n. 1).
Tali evidenze sembrerebbero pertinenti a una struttura che planimetrica-mente ripete la prima, probabilmente più ampia, ed è tagliata in corrispon-denza della canaletta con andamento nord-ovest/sud-est da due alloggiamen-ti circolari per pali, allineati rispetto a un terzo posto più a nord. Questa fila
Fig. 6 - La struttura rettangolare a fine scavo (foto: M. Milletti).
La casa del re e il deposito delle tazze 19
2 In corso di analisi presso il Centro di Restauro della Soprintendenza ai Beni Archeologici dellaToscana (Cantiere delle Navi di Pisa).
sembra comporre un sistema ortogonale con un altro alloggiamento localiz-zato a est, che taglia una canaletta orientata ancora in senso sud-ovest/nord-est, ed è sua volta tagliato da una profonda cavità cilindrica, forse utilizzataper contenere derrate. In questo senso, quindi, il sistema composto dai trebuchi allineati e ortogonali al quarto isolato più a est potrebbe individuare lafase successiva (periodo II, fase c; Figg. 2, 4) alla più recente struttura rettan-golare, che statigraficamente risulterebbe coerente con la canaletta isolata,mentre più recente sarebbe il taglio della cavità cilindrica (periodo II, fase d;Figg. 2, 3).
L’ultima fase individuata (periodo II, fase e; Fig. 2) è costituita da alcuni bu-chi per palo di piccole dimensioni, la cui interpretazione è al momento dubbia.
La struttura rettangolare del periodo II, fase a risulta al momento la meglioleggibile del complesso e presenta alcune caratteristiche che fanno propendereper una sua identificazione come dimora di rango elevato. Nell’alloggiamentopiù a sud della terza fila di pali conservata, infatti, al momento dell’abbandonointenzionale del complesso, fu realizzato un taglio bilobato lungo 0.60 m, largo0.40 m e profondo 0.50 m circa (Fig. 9), riempito da un numero cospicuo ditazze-kyathoi con ansa sormontante e fondo ombelicato (presente in poche va-rianti tipologiche e dimensionali) rinvenute prevalentemente integre o comun-que frammentate dopo la deposizione. Le dimensioni ridotte della fossa aveva-no determinato un accumulo serrato degli esemplari, alcuni dei quali sono sta-ti rinvenuti impilati a due o a tre (Fig. 7). Una stima effettuata sui materiali in-tegri e conservati a metà ha consentito di identificare tra le 77 e le 84 unità, cuivanno aggiunti i numerosi frammenti ancora in corso di restauro. La concen-trazione e lo stato di conservazione inducono a ritenere che il deposito si siaformato in un lasso di tempo identificabile in un unico intervento di deposi-zione. La composizione della terra del riempimento della fossa, caratterizzatada colore rossiccio e dalla forte presenza di materiale organico2, e la forma del-la tazza-kyathos suggeriscono inoltre una pratica associata all’assunzione di be-vande o alimenti semi-liquidi. Tale contesto si pone come indizio di un’azionesimbolicamente connotata, realizzata in coincidenza di un momento specifico,ovvero la fine della vita e dell’uso della più antica struttura rettangolare, allaquale segue l’impianto di un’altra simile per tipologia edilizia. Il numero delletazze deposte, che sembra avvicinarsi al centinaio di unità, e la ricorrenza dellaforma suggerisce una partecipazione collettiva all’evento e l’utilizzo di bevan-de a forte valore simbolico, probabilmente il vino.
20 Valeria Acconci, Gilda Bartoloni
Fig. 7 – Il deposito delle tazze/kyathoi in corso di scavo (foto: V. Acconcia).
La casa del re e il deposito delle tazze 21
La maggior parte delle tazze può essere attribuita a un tipo di piccole di-mensioni con labbro lievemente estroflesso e orlo arrotondato o assottigliato,vasca più o meno compressa con spalla distinta, fondo convesso e ombelicato(con cavità spesso non centrata); le anse sono sopraelevate a sezione superiorecircolare e a nastro all’attacco della spalla, e raramente recano tracce di deco-razione a fasci di linee incise. Per quanto riscontrabile sugli esemplari integril’altezza al labbro varia tra i 3 e i 5 cm (Fig. 8, nn. 1-4). Tale forma è abbastan-za diffusa tra gli ultimi decenni dell’VIII e i primi del VII secolo a.C., anche sei confronti più puntuali per gli esemplari dal deposito di Poggio del Telegrafosi concentrano in un’area che dalla fascia litoranea dell’Etruria si estende alterritorio ligure.
A Populonia essa è presente anche in corredi funerari (necropoli del PodereCasone, quattro esemplari dalla tomba 1/1931: ROMUALDI 1994, p. 177, tav.III, 7, p. 178, databili tra fine dell’VIII- non oltre la metà del VII secolo a.C.;vedi anche FEDELI 1983, p. 222 n. 83, con cronologia troppo bassa alla fine delVII secolo a.C., Costone della Fredda, tomba 2: ROMUALDI 1994, p. 180; vedianche FEDELI 1983, p. 308, n. 181, con lo stesso problema per la datazione).Nell’abitato di Casale Marittimo (LI), sono attestati numerosi esemplari anco-ra inediti dai livelli più antichi (notizia in MAGGIANI 2006, p. 436, fig. 4, ascrit-ti alla fine dell’VIII secolo a.C.). A tale proposito, A. Maggiani e M. Bonamicihanno di recente messo in evidenza come questi materiali associati ad altri(imitazioni geometriche dall’area vulcente, impasti bruni e rossi) attestino unacircolazione di merci e modelli diretta appunto tra la fine dell’VIII e il VII se-colo a.C. specificamente verso l’alto Tirreno, includendo i centri di Vetulonia,Populonia, Pisa, il comprensorio a nord di Pisa (San Rocchino) e Chiavari(MAGGIANI 2006, pp. 435-438; BONAMICI 1990, pp. 105-107; 2006, p. 499).
Proprio nella necropoli di Chiavari, in Liguria, nell’ambito della ceramicadefinita di ‘impasto buccheroide’ sono presenti tazze a fondo ombelicato vici-ne agli esemplari da Poggio del Telegrafo associate di solito a olle vuote e iden-tificate come recipienti utilizzati specificamente nel rituale potorio nell’ambitodelle cerimonie funebri (MELLI 1993, pp. 105-106, pp. 114-115; di recente,PALLADINO 2004, Chiavari, tomba 112, pp. 252-253, IV.1.3.6; prima metà delVII secolo a.C.; S. Paltineri in PALTINERI, LEONARDI, MAGRI, 2006, p. 643, cheribadisce la forte influenza etrusca sui materiali della necropoli). In Etruriameridionale, la forma è presente a Vulci (necropoli della Polledrara, tombaGsell XXXVI: MANGANI 1995, p. 396, n. 4.12, figg. 18,2 e 21,2, p. 409, la tom-ba è datata alla fine dell’VIII secolo a.C. Necropoli di Poggio Maremma, tom-ba 6 settembre 1966, cinque esemplari decorati a lamelle metalliche: MORETTI
SGUBINI 2001, p. 196, nn. III.B.1.35-39; la tomba è datata all’ultimo quartodell’VIII secolo a.C.); a Tarquinia (necropoli dei Monterozzi, tre esemplari
22 Valeria Acconci, Gilda Bartoloni
dalla tomba del Guerriero: HENCKEN 1968, p. 216, fig. 191, h. Due esemplaridalla tomba 6134: SPADEA NOVIERO 1986, nn. 603-604, tipi databili tra il villa-noviano IIB e gli inizi del VII secolo a.C.; p. 215, corredo databile al 730-700a.C. Un esemplare dalla tomba 65,6 da Macchia della Turchina: BRUNI 1986,n. 667, datato al 710-700 a.C. Necropoli di Poggio Gallinaro, un esemplaredalla tomba a fossa 8: HENCKEN 1968, p. 346, fig. 346, c; DONATI 1985, p. 75,n. 257; inizio del VII sec. a.C.).
Fig. 8 - Materiali dal deposito delle tazze/kyathoi (disegno: V. Acconcia).
La casa del re e il deposito delle tazze 23
Un frammento di ansa decorata a fasci di solcature incise dal deposito diPoggio del Telegrafo (Fig. 8, n. 7) trova un confronto pressoché puntuale (senon per la decorazione, meno ricca nell’esemplare dall’abitato) con un esem-plare dalla tomba 2/1920 del Poggio della Porcareccia a Populonia, che ha re-stituito frammenti di kotylai e pissidi protocorinzie degli inizi del VII secoloa.C. (MINTO 1921, p. 306, fig. 6; vedi anche MARTELLI 1981, pp. 406-407; FE-DELI 1983, p. 283, n. 160).
Si distinguono dagli altri un esemplare con ansa sagomata (Fig. 8, n. 6) edue con spalla più definita, basso piede ad anello, ansa sopraelevata a nastro(esemplificati a Fig. 8, n. 5). Per questi ultimi il confronto più puntuale al mo-mento sembra con materiali tarquiniesi che si ascrivono alle prime esperienzedel bucchero locale dal corredo del tumulo di Poggio Gallinaro (PETRIZZI
1986, p. 213, n. 591, a p. 209, esemplare in cd. ‘bucchero a superficie marro-ne’, datato al secondo quarto del VII secolo a.C. Sul complesso dei buccheridal tumulo di Poggio Gallinaro: LOCATELLI 2004, p. 50, che inquadra l’esem-plare di confronto come versione semplificata del tipo Rasmussen 1a; da ulti-mo PALMIERI 2001).
Fig. 9 - Il deposito delle tazze/kyathoi a fine scavo (foto: V. Acconcia).
24 Valeria Acconci, Gilda Bartoloni
3 I materiali riferibili ai periodi I-II sono attualmente in corso di studio da parte di Elisa Bian-cifiori.
In associazione sono stati rinvenuti un frammento di parete di olla in impa-sto bruno tornito che all’interno della fossa era stata alloggiata a dividere indue parti pressoché uguali lo spazio utilizzato (Fig. 7), un frammento di incan-nucciata e una forma chiusa, probabilmente miniaturizzata, parzialmente rein-tegrabile da tre frammenti, che presenta fondo piano, ventre compresso conspalla accentuata e resti della tornitura sul fondo (Fig. 8, n. 8). La pasta èestremamente depurata e saponosa al tatto, e potrebbe aver perso parte del ri-vestimento originario delle superfici. Per tali caratteristiche l’esemplare è iden-tificabile come il resto di una brocchetta o di una oinochoe di produzione ita-lo-geometrica locale, e trova confronti non puntuali con una oinochoe miniatu-ristica dalla tomba 24 della necropoli di Canale-Janchina (RC) (MERCURI 2004,con fondo di 3.8 cm, p. 28, n. 19) identificata come redazione ridotta di un ti-po (n. 107 a p. 46), assimilabile a materiali italo-geometrici (CANCIANI 1974, p.28, tav. 20, 8, datato alla fine dell’VIII secolo a.C., vedi anche gli esemplari alletavv. 20, 3-6). La sua presenza all’interno del deposito potrebbe non essere ca-suale, come forma vascolare dal forte connotato simbolico, a rappresentareforme comunemente utilizzate nella pratica del simposio.
Oltre alle valenze simboliche e ai rimandi all’ambito conviviale che si posso-no desumere da tale rinvenimento, esso consente di puntualizzare la datazionedell’abbandono della prima struttura rettangolare, che va quindi collocato nonoltre il primo quarto del VII secolo a.C. Per quanto riguarda invece la vita diquest’ultima, in mancanza di dati materiali sicuri, si può solo ipotizzare una at-tribuzione almeno al venticinquennio precedente.
Per quanto riguarda invece i periodi successivi, il periodo II fase b resta so-stanzialmente muto, mentre le evidenze relative al periodo II fase c e d hannorestituito frammenti di bucchero, che potrebbe orientare una datazione allametà del VII secolo a.C. (ACCONCIA, DI NAPOLI, GALANTE, MILLETTI, PITZA-LIS c.s.3). Quindi, l’intero periodo II sembrerebbe circoscrivibile all’Orientaliz-zante antico e nella prima parte di quello medio.
VALERIA ACCONCIA
2. La casa del re
Gli scavi negli abitati in Etruria stanno mettendo in luce una forte ritua-lità, che sembra precedere o concludere i diversi cambiamenti strutturali ofunzionali.
La casa del re e il deposito delle tazze 25
Emblematico il caso della Civita di Tarquinia, dove sono stati riconosciuteazioni cruente (BONGHI JOVINO c.s.) ed offerte simboliche, relative al cosiddet-to complesso sacro-istituzionale (da ultimo SERRA RIDGWAY 2006). Attestazionistanno emergendo anche in siti minori, come a Campassini (Monteriggioni, SI)nell’abitato di fine VIII-VII secolo a.C. dove diverse fosse appaiono chiuse dadeposizioni rituali di vasi o animali (BARTOLONI 2002, p. 21; ACCONCIA, BIAGI
2002, pp. 90-99, 118).Indubbiamente ad una cerimonia deve riferirsi anche il deposito del centi-
naio di tazze monoansate legato all’obliterazione della struttura rettangolare,edificio indubbiamente di rango elevato.
La tazza ad ansa sormontante appare nell’Orientalizzante antico e mediochiaramente legata al bere vino, sia nella funzione di attingitoio dai crateri oolle, sia in quella di boccale (BARTOLONI et al., c.s.). Prova inconfutabile diquesto uso è la presenza come oggetto importato nella tomba 168 (tomba dellacoppa di Nestore) della necropoli di San Montano a Pithecusa, che per primadocumenterebbe, secondo O. Murray, l’uso del simposio nel Mediterraneocentro-occidentale (MURRAY 1994). Tutti i vasi esportati (anfore, coppe) daPithecusa nei centri indigeni (BARTOLONI 2006) o importati (anforette, tazze)dalle coste tirreniche nel centro greco sono legati al bere vino. L’attestazionepiù famosa per la funzione di questo tipo di tazzina viene dalla presenza di es-sa, accanto al kantharos sia nel servizio metallico, che in quello ceramico dellatomba del Guerriero di Tarquinia (KRISELEIT 1988).
Interessante notare come nei corredi funerari ateniesi il vino sia prerogativamaschile: solo le anfore a collo sono riferibili a individui maschili, generalmen-te guerrieri, le anfore panciute e le hydriai, vasi collegati con l’acqua sono fem-minili (BELLETIER 2003). Indicativa l’attestazione dell’hydria di tipo greco usa-ta come ossuario nella deposizione femminile 160 della necropoli tarquiniesedi Poggio Selciatello (D’AGOSTINO 2006, pp. 338-339), verosimilmente attri-buibile ad una donna di origine greca (BARTOLONI, c.s. b).
Il greco si differenzia nel bere vino dal barbaro, che vi si abbandona in ma-niera eccessiva, per il consumo ritualizzato di questa bevanda, che viene assun-ta allungata con l’acqua e durante occasioni specifiche. “Alcinoo disse all’aral-do: mescola il vino con acqua nel cratere e distribuiscilo a tutti e libiamo aZeus” (Odissea, 7, 178 ss.). Già in Omero, la compostezza di Alcinoo e degliAchei a banchetto “è contrapposta alla disastrosa inumanità di chi ignora chebere è un atto di civiltà” (DELLA BIANCA 2002, p. 29). Il symposion apparequindi come una “pratica d’intrattenimento conviviale centrata sul consumodel vino” (LOMBARDO 1989, p. 311). Tale costume, momento importante di so-cializzazione e di aggregazione, è stato considerato “l’espressione originale traVIII e VII secolo a.C. di uno stile di vita aristocratico legato all’emergere di
26 Valeria Acconci, Gilda Bartoloni
una vera e propria aristocrazia, come ceto (o ordine) sociale che tende a rico-noscersi, definirsi e distinguersi” (VETTA 1983, p. XL).
La localizzazione del buco del palo, riempito dalle tazze, al centro dellastruttura fa pensare ad una cerimonia svoltasi nel vano centrale, adibito a riu-nioni per i rappresentanti della intera comunità, come quello ricostruita dall’é-quipe di Carandini per la Domus Regia presso il tempio di Vesta (CARANDINI
2006, pp. 538-544).Quindi la deposizione delle tazze a Poggio del Telegrafo è l’attestazione di
una cerimonia svoltasi in occasione della distruzione del “palazzo reale”.È suggestivo il richiamo al gioioso brindisi che si consumò in un circolo
esclusivo di Mitilene nell’isola di Lesbo per la morte del tiranno definito daLorenzo Braccasi il primo brindisi con decisa connotazione politica della lette-ratura occidentale (BRACCESI 1991). Alceo invita ad una smodata bevuta icompagni di hetaireia (fr. 332 VOIGT).
Per quanto riguarda il numero delle tazze e quindi dei partecipanti ovvio èil richiamo alle curie di Roma articolate su base decimale. La connessione diqueste tazze con il vino e la pertinenza ad un gruppo verosimilmente di perso-naggi eminenti deve essere considerata più che probabile.
Nella reggia di Ctesio, nell’isola di Siria presso Ortigia (Delo?), Odissea 15,465-468:
Lei per mano prendendomi, mi portò fuori di casa,/ e nell’atrio trovò le tazze e i vassoi/dei convitati, quelli che il padre mio accompagnavano:/ essi erano andati a sedere al consi-glio del popolo.
O nella riunione in cui si decide di inviare l’ambasceria ad Achille, Iliade, 9,96-181:
E i giovani colmarono fino all’orlo i loro crateri di vino, lo versarono in coppe e lo di-stribuirono a tutti per libare.
O ancora nella sala di Alcinoo, Odissea 7, 50:
Questo, ospite padre, è il palazzo che hai chiesto / di farti vedere; qui troverai i capialunni di Zeus/ intenti al banchetto.
Non avendo le genti dell’Italia antica trasmesso testimonianze letterarie coe-ve al periodo protostorico un utile confronto offrono testi prodotti nello stessoperiodo nell’Oriente del Mediterraneo, cioè i poemi omerici (AMPOLO 2000).La maggior parte degli studiosi, pur considerando la tradizione orale dietroOmero piuttosto lunga, concorda nel porre lo sfondo economico e sociale deipoemi omerici all’VIII secolo a.C.: nell’Iliade e nell’Odissea dovevano essereriflessi gli usi e costumi della classe dominante contemporanea.
La casa del re e il deposito delle tazze 27
Le citate figure omeriche, definiti basileus, possono ben rappresentare i per-sonaggi eminenti delle diverse comunità dell’Italia protostorica, che si distin-guono non solo per il corredo funerario, ma per il tipo di abitazione, che sidifferenzia dalle altre, costituite da normali capanne, non solo per le dimensio-ni, ma per la presenza di aree adibite a riunioni pubbliche.
Stesso significato di “casa del re” come ambiente per incontri collettivi po-trebbero avere la struttura più antica di Casalvecchio di Casale Marittimo congrande portico (ESPOSITO 1999) o la casa tonda con recinti di Roselle dell’O-rientalizzante medio (BARTOLONI, BOCCI 2002).
Concludendo con una libagione di cento individui si è voluto testimoniare eritualizzare la distruzione della casa del re e probabilmente celebrare l’assun-zione al potere di una nuova leadership nel comparto di Populonia. Del restonon mancano a Roma nella fase arcaica indizi in cui il vino è legato alla sovra-nità e al potere (COARELLI 1995, p. 202).
GILDA BARTOLONI
Bibliografia
V. ACCONCIA, F. BIAGI, 2002, Lo scavo della cisterna e delle aree circostanti (periodi II e III),in A. CIACCI (a cura di), Monteriggioni-Campassini. Un sito etrusco dell’Alta Valdelsa, Fi-renze, pp. 83-118.
V. ACCONCIA, A. DI NAPOLI, G. GALANTE, M. MILLETTI, F. PITZALIS, c.s. a, Poggio del Tele-grafo (Piombino; LI): saggi di scavo sull’acropoli di Populonia (PdT 2003), «RdA», in cor-so di stampa.
V. ACCONCIA, M. MILLETTI, F. PITZALIS, c.s., Populonia, Poggio del Telegrafo: le ricerche nel-l’abitato degli anni 2003-2004, «Sc. Ant.», in corso di stampa.
C. AMPOLO, 2000, Il mondo omerico e la cultura orientalizzante mediterranea, in PrincipiEtruschi tra Mediterraneo ed Europa, Catalogo della mostra (Bologna 2000-2001), Bolo-gna, pp. 27-36.
M. APROSIO, 2002, Le ricognizioni sull’acropoli di Populonia, in Materiali 1, pp. 43-50.
B.M. ARANGUREN, E. PARIBENI ROVAI 1998, Follonica etrusca. I segni di una civiltà (Catalo-go della Mostra, Follonica 1998), Follonica.
G. BARTOLONI, 2002, Lo scavo di Campassini, in A. CIACCI (a cura di) Monteriggioni-Cam-passini. Un sito etrusco dell’Alta Valdelsa, Firenze, pp. 11-23.
EAD., 2003, Veio e Roma: considerazioni alla luce delle recenti indagini, in I. VAN KAMPEN (acura di), Dalla capanna alla casa. I primi abitanti di Veio, Catalogo della Mostra di For-mello (2003-2004), Formello, pp. 13-23.
EAD., 2004, Populonia: l’insediamento della prima età del Ferro, in Materiali 3, pp. 237-249.
28 Valeria Acconci, Gilda Bartoloni
EAD., 2006, Inizi della colonizzazione nel centro Italia, in Magna Graecia. Archeologia di unsapere, Catalogo della Mostra (Catanzaro 2006), Catanzaro, pp. 345-348.
EAD., c.s. a, Populonia nell’età del Ferro, in «Scienze Antichità», in corso di stampa.EAD., c.s. b, Il consumo del vino nell’Italia centrale tirrenica in Vinum II, in corso di stampa.G. BARTOLONI, V. ACCONCIA, S. TEN KORTENAAR, c.s., La diffusione della vitivinicoltura in
Etruria: il quadro della cultura materiale a partire dall’età del Ferro, in A. CIACCI, A. ZIF-FERERO (a cura di), Archeologia della vite e del vino in Etruria, Atti del Convegno (Scan-sano, 2005), in corso di stampa.
G. BARTOLONI, P. BOCCI PACINI, 2002, Roselle: una rilettura dei dati di scavo nell’abitato ar-caico, in Città e territorio in Etruria. Per una definizione di città nell’Etruria settentriona-le, Atti delle Giornate di studio (Colle Val d’Elsa, 1999), Colle Val d’Elsa, pp. 187-212.
M.P. BELLETIER, 2003, La politique de la mort. Observation sur les tombes attiques aux épo-ques géométrique et archaïque, in Symposium. Banquet et représentations en Grèce et àRome. Colloque international (Université de Toulouse-Le Mirail, 2002), Pallas 61, pp.71-82.
M. BONAMICI, 1990, L’epoca etrusca: dall’età del Ferro alla romanizzazione, in AA.VV. SanGiuliano Terme. La Storia, il Territorio, Pisa, pp. 97-124.
EAD., 2006, Lo scalo portuale di San Rocchino in Versilia, in Gli Etruschi da Genova ad Am-purias, Atti del XXIV Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Marseille-Lattes 2002), Pi-sa-Roma, pp. 497-511.
M. BONGHI JOVINO, c.s., L’ultima dimora. Ritualità e complessità. Nuovi dati sulle sepolturenell’abitato di Tarquinia, in corso di stampa in Sepolti tra i vivi. Evidenza ed interpreta-zione di contesti funerari in abitato, Atti del Convegno Internazionale (Roma 2006), «Sc.Ant.», 14.
L. BRACCESI, 1991, Il brindisi per la morte del tiranno, in Storia del vino. Regimi, miti e pra-tiche dell’alimentazione nella civiltà del Mediterraneo, Homo Edens II, pp. 179-193.
S. BRUNI, 1986, Tarquinia, Monterozzi, t. 65,6, in M. BONGHI JOVINO (a cura di), Gli Etru-schi di Tarquinia, Catalogo della Mostra (Milano 1985), Modena, pp. 228-230.
F. CANCIANI, 1974, Corpus Vasorum Antiquorum, 3, 1974, Italia - Museo Archeologico Na-zionale di Tarquinia, Roma.
A. CARANDINI, 2006, Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani, Torino.F. COARELLI, 1995, Vino e ideologia nella Roma arcaica, in In vino veritas, International
conference on wine and society in the ancient world (Roma, 1991), London, pp. 196-213.
B. D’AGOSTINO, 2006, I primi Greci in Etruria, in M. BONGHI JOVINO (a cura di), Tarquiniae le civiltà del mediterraneo, Milano, pp. 335-346.
L. DELLA BIANCA, S. BETA, 2002, Oinos. Il vino nella letteratura greca, Roma.L. DONATI, 1985, Tarquinia, Poggio Gallinaro, in G. CAMPOREALE (a cura di), L’Etruria mi-
neraria, Catalogo della mostra (Piombino, Portoferraio, Massa Marittima 1985), Milano,pp. 74-81.
A.M. ESPOSITO (a cura di), 1999, Principi guerrieri. La necropoli etrusca di CasaleMarittimo, Catalogo della Mostra (Cecina 1999), Milano.
La casa del re e il deposito delle tazze 29
F. FEDELI, 1983, Populonia. Storia e territorio, Firenze.
H. HENCKEN 1968, Tarquinia, Villanovans and Early Etruscans, Cambridge-Mass.
I. KRIESELEIT, 1988, Das Kriegergrab von Tarquinia, in Die Welt der Etrusker. Archäologi-sche Denkmäler aus Museen der sozialistischen Länder, Berlin, pp. 58-72.
D. LOCATELLI, Tarquinia, in A. NASO (a cura di), Appunti sul Bucchero, Atti delle Giornatedi Studio (Blera 1999-2000), Firenze, pp. 49-89.
M. LOMBARDO, 1989, Pratiche di commensalità e forme di organizzazione nel mondo greco:symposia e syssitia, in O. LONGO, P. SCARPI (a cura di), Homo Edens. Regimi, miti epratiche dell’alimentazione nelle civiltà del Mediterraneo, Verona, pp. 311-325.
A. MAGGIANI, 2006, Rotte e tappe nel Tirreno settentrionale, in Gli Etruschi da Genova adAmpurias, Atti del XXIV Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Marseille-Lattes 2002),Pisa-Roma, pp. 435-449.
E. MANGANI, 1995, Corredi vulcenti degli scavi Gsell al Museo Pigorini, «BPI», 86, pp. 373-428.
M. MARTELLI, 1981, Populonia: cultura locale e contatti con il mondo greco, in L’Etruria mi-neraria, Atti del XII Convegno di Studi Etruschi e Italici (Piombino-Portoferraio 1979),Firenze, pp. 399-427.
Materiali 1 = F. CAMBI, D. MANACORDA (a cura di), Materiali per Populonia 1, Firenze,2002.
Materiali 3 = M.L. GUALANDI, C. MASCIONE (a cura di), Materiali per Populonia 3, Firenze,2004.
P. MELLI, 1993, Buccheri ed ‘impasti buccheroidi’ in Liguria, in M. BONGHI JOVINO (a curadi), Produzione artigianale ed esportazione nel mondo antico. Il bucchero etrusco, Atti delColloquio internazionale (Milano 1990), Milano, pp. 105-126.
A. MINTO, 1921, Populonia - Relazione sugli scavi archeologici governativi eseguiti nell’au-tunno del 1920 nella zona del Porto di Baratti; Scavi governativi eseguiti nella primaveradel 1921, «NSA», pp. 301-336.
A.M. MORETTI SGUBINI 2001, Vulci. Necropoli di Poggio Maremma. Tomba 6 settembre1966, in A.M. MORETTI SGUBINI (a cura di), Veio Cerveteri Vulci. Città d’Etruria a con-fronto, Catalogo della mostra (Roma 2001), Roma, pp. 188-199.
O. MURRAY, 1994, Nestor’s cup and the origin of Greek symposion, in APOIKIA. I più anti-chi insediamenti greci in Occidente: funzioni e modi dell’organizzazione politica e sociale.Scritti in onore di Giorgio Buchner, «Aion», 1.
EAD., 1997, L’uomo greco e le forme della socialità, in J.P. VERNANT, L’uomo greco, Roma-Bari, pp. 219-226.
N. NEGRONI CATACCHIO, 1995, Sorgenti della Nova. L’abitato del Bronzo Finale, Firenze.
V. NIZZO, c.s., Pithekoussai I: analisi della stratigrafia e proposta per una seriazione tipologi-ca dei materiali.
S. PALLADINO, 2004, Necropoli di Chiavari. Tomba 112, in R.C. DE MARINIS, G. SPADEA (acura di), I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e Mediterraneo, Catalogo della mo-stra (Genova 2004), pp. 251-253.
30 Valeria Acconci, Gilda Bartoloni
A. PALMIERI, 2001, Alle origini del bucchero. Contributo al riconoscimento di una fase speri-mentale della produzione tarquiniese, «ArchClass», 52, pp. 175-189.
S. PALTINERI, G. LEONARDI, R. MAGRI, 2006, Progetto necropoli di Chiavari, in Gli Etruschida Genova ad Ampurias, Atti del XXIV Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Marseil-le-Lattes 2002), Pisa-Roma, pp. 641-652.
C. PETRIZZI, 1986, Il tumulo monumentale di Poggio Gallinaro, in M. BONGHI JOVINO (acura di), Gli Etruschi di Tarquinia, Catalogo della Mostra (Milano 1985), Modena, pp.209-214.
A. ROMUALDI, 1994, Populonia tra la fine dell’VIII e l’inizio del VII sec. a.C.: materiali e pro-blemi dell’Orientalizzante antico in La presenza etrusca nella Campania meridionale, Attidel Convegno (Salerno, Pontecagnano 1990), Firenze, pp. 171-180.
F. SERRA RIDGWAY, 2006, La ceramica del “complesso” sulla Civita di Tarquinia, in M. BON-GHI JOVINO (a cura di), Tarquinia e le civiltà del Mediterraneo, Milano, pp. 187-206.
G. SPADEA NOVIERO 1986, Tarquinia, Monterozzi, t. 6134, in M. BONGHI JOVINO (a cura di),Gli Etruschi di Tarquinia, Catalogo della Mostra (Milano 1985), Modena, pp. 215-219.
I. VAN KAMPEN, 2003, Dalla capanna alla casa a Veio, in I. VAN KAMPEN (a cura di), Dallacapanna alla casa. I primi abitanti di Veio (Catalogo della Mostra di Formello 2003-2004), Formello, pp. 23-30.
M. VETTA (a cura di), 1983, Poesia e simposio nella Grecia antica. Guida storica e critica, Ro-ma-Bari.
J.B. WARD PERKINS, 1959, Excavations beside the North-West Gate at Veii, 1957-1958, «PB-SR», XXVII, pp. 38-79.


























![[Salis M.] Casa aragonese](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632402435f71497ea9049a67/salis-m-casa-aragonese.jpg)