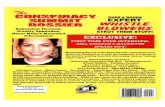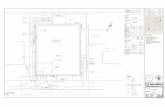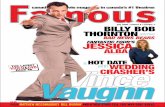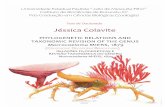Jessica Gritti, RV Schofield, Santa Maria presso San Satiro, ed. F. Repishti, Milan 2012
Transcript of Jessica Gritti, RV Schofield, Santa Maria presso San Satiro, ed. F. Repishti, Milan 2012
Santa Maria presso San SatiroMilano
TraduzioniHuw EvansJessica Gritti
A cura diFrancesco Repishti
Progetto e realizzazione graficaValentina Di Francesco
StampaPinelli Printing srl, Milano
Copertina:Foto di Giovanni Chiaramonte
Finito di stampare maggio 2012© Parrocchia di San Satiro, Milano
Altare maggiore, immagine miracolosa della Madonna col Bambino / High altar, miraculous image of the Madonna and Child
Mons. Gianpietro Crippa Amministratore Parrocchiale / Parish Administrator
Historians have traditionally pointed to the complex of Santa Maria presso San Satiro as one of the most finished products of Renaissance culture in Milan in the second half of the 15th century, as well as one of the most im-portant of Donato Bramante’s works. There is little docu-mentation in the archives of the early phases in its con-struction, and historians have come up with a wide range of hypotheses. The importance of the work, the desire to offer the many visitors, including those from abroad, an up-to-date text on the hypothetical reconstructions of its history and the documentation of the latest campaigns of restoration have prompted the preparation of this bilingual volume in Ital-ian and English published by the parish.The structure of the book follows the chronological order of the work of construction of the sacellum of San Satiro at the behest of Archbishop Ansperto of Biassono in the 9th century, the building of the bell tower in the 11th century, the construction of the church of Santa Maria and the Sacristy, now a Baptistery, to a design by Donato Bra-mante at the end of the 15th century and, finally, the long and numerous works of restoration that have transformed the appearance of this complex several times.It ends with an interesting and useful chronological sum-mary of the principal developments cited by the authors.The text may also be of great assistance to all those who will be visiting Milan on the occasion of major events like the World Meeting of Families (2012), the celebration of the 1700th anniversary of the Edict of Milan (313) and the great Expo of 2015.My special thanks go to all those who have made this pub-lication possible.
Il complesso di Santa Maria presso San Satiro è tradizio-nalmente indicato dalla storiografia come uno dei risultati più compiuti della cultura rinascimentale a Milano nella seconda metà del Quattrocento e come una delle opere più importanti di Donato Bramante. Sulle prime fasi di costru-zione possediamo una scarsa documentazione d’archivio su cui la storiografia ha formulato un variegato numero di ipotesi. L’importanza dell’opera, la volontà di offrire ai molti vi-sitatori anche stranieri un testo aggiornato sulle ipotesi ricostruttive e la documentazione delle ultime campagne di restauro hanno suggerito la preparazione di questo vo-lume con un testo in lingua italiana e inglese edito dalla parrocchia.La struttura del volume segue lo svolgersi cronologico dei lavori di edificazione del sacello di San Satiro promossa dall’arcivescovo Ansperto da Biassono nel IX secolo, la costruzione della torre campanaria nell’XI secolo, la co-struzione della chiesa di Santa Maria e della Sacrestia, oggi Battistero, su disegno di Donato Bramante alla fine del Quattrocento, e, infine, le lunghe e numerose campagne di restauro che hanno più volte trasformato il volto di questo complesso.Chiude un interessante e utile prospetto cronologico che riassume le principali vicende citate dagli autori.Il testo potrà essere di grande aiuto anche per tutti colo-ro che visiteranno Milano in occasione dei grandi eventi quali, l’incontro internazionale delle famiglie (2012), la celebrazione dei 1700 anni dall’editto di Milano (313) e la grande esposizione del 2015.Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione.
Sommario / Contents
Presentazione / PresentationMons. Gianpietro Crippa
Jessica GrittiStoria, architettura, tradizione del sacello di San SatiroHistory, Architecture and Tradition of the Chapel of San Satiro Richard SchofieldBramante e Santa Maria presso San SatiroBramante and Santa Maria presso San Satiro Francesco Repishti I restauriThe restoration Cronologia / Chronology
Bibliografia / Bibliography
5
8
20
68
98
109
8
Santa Maria presso San Satiro, planimetria del complesso / Complex of Santa Maria presso San Satiro, plan (Area Studio)
9
Storia, architettura, tradizione del sacello di San SatiroHistory, Architecture and Tradition of the Chapel of San Satiro
Jessica Gritti
The sacellum or chapel of San Satiro, better known as the chapel of the Pietà following the construction of the church of Santa Maria to a design by Donato Bramante,1 is located on a site of ancient urban improvement, stratified in a com-plex way since long before the 15th century. We have to thank the Milanese guidebooks of the modern era, and in particular that of Paolo Morigia,2 for the systematic dissemi-nation of information about the chapel. However, the earliest indications, handed down by all the old historiographers,3 are cloaked in the mists of legend, like that of a Christian occupation of the site of a temple to Jupiter, with the con-struction of a basilica dedicated to all Christian believers in the place where two residences with a garden used to stand. Likewise, it does not seem possible to find any documentary evidence for the assertion that a church dedicated to Saints Sylvester, Satyrus and Ambrose had already been consecrat-ed in the year 421 by Bishop Euphrasinus. The claim, with the event sometimes said to have occurred in 321 (a date completely inconsistent with a building dedicated to Am-brose, as it precedes his birth), was in all probability derived from a 17th-century source, which states that it is based on documents present in the church itself that can no longer be traced today.4 This also raises the problem of the identifica-
Il sacello di San Satiro, più noto come cappella della Pie-tà in seguito alla costruzione della chiesa di Santa Maria su disegno di Donato Bramante1, si inserisce in un sito di antica qualificazione urbanistica, stratificatosi in modo complesso ben prima del XV secolo. Si deve alla guidistica milanese di età moderna, e in particolare a Paolo Morigia2, la diffusione organica di notizie relative al sacello, sebbene svaniscano nella leggenda le prime indicazioni tramandate da tutta la storiografia antica3, come quella di un’occupa-zione cristiana del sito sopra un tempio dedicato a Giove, con la costruzione di una basilica dedicata a tutti i fedeli cristiani nel luogo dove sorgevano due palazzi con un giar-dino. Allo stesso modo, non sembra verificabile a livello documentario la notizia secondo cui una chiesa dedicata ai Santi Silvestro, Satiro e Ambrogio sarebbe stata consacrata già nell’anno 421 da parte del vescovo Eufrasino. Il fatto, talora segnalato come avvenuto nel 321 (anno del tutto in-congruente con un edificio dedicato ad Ambrogio, poiché ne precederebbe la nascita), è derivato con tutta probabi-lità da una fonte secentesca, che lo vuole desunto da docu-menti presenti presso la chiesa stessa, oggi non reperibili4, creando anche la problematica eventuale identificazione di un vescovo Eufrasino, del quale non si ha alcuna notizia5.
1 «La Aede Sacra di Sancto Satiro» è già citata infatti in Cesariano, 1521, c. IVv.2 Morigia, 1603 (1643, pp. 56-57).3 Torre, 1714, pp. 47-48; Latuada, 1737, II, pp. 243-245; Bianconi, 1787, pp. 183-184.4 ASDMi, Sezione XIV, Libraria dei manoscritti, Studi del canonico Corno, vo-lume 162, pp. 155-165: Compendio delle cose notabili appartenenti alla Madonna presso Santo Satiro in Milano raccolte d’industria delli Signori Priore e Deputati, l’anno 1622. Si tratta di un manoscritto compilato da Giovanni Battista Corno, primicerio dei lettori del Duomo di Milano, il quale dice di averlo copiato a sua volta da un altro di proprietà di Tommaso Ranzetto, curato della chiesa di Santa Maria presso San Satiro, che morì il 27 marzo 1649; del manoscritto consta una copia in stralcio, compilata verosimilmente dall’Archivista di San Satiro Cossali nel XIX secolo (ASMi, Comuni, 46).
1 “La Aede Sacra di Sancto Satiro” had in fact already been cited in Cesariano, 1521, c. IVv.2 Morigia, 1603 (1643, pp. 56-57).3 Torre, 1714, pp. 47-48; Latuada, 1737, II, pp. 243-5; Bianconi, 1787, pp. 183-184.4 ASDMi, Sezione XIV, Libraria dei manoscritti, Studi del canonico Corno, vol-ume 162, pp. 155-65: Compendio delle cose notabili appartenenti alla Madonna presso Santo Satiro in Milano raccolte d’industria delli Signori Priore e Deputati, l’anno 1622. This is a manuscript drawn up by Giovanni Battista Corno, primic-erius of the lectors of Milan Cathedral, who claims to have copied it in turn from another one owned by Tommaso Ranzetto, curate of the church of Santa Maria presso San Satiro, who died on March 27, 1649; an extract from the manuscript also exists, probably compiled by the archivist of San Satiro, Cossali, in the 19th century (ASMi, Comuni, 46).
11
tion of a Bishop Euphrasinus, of whom nothing is known.5The presence of a place of worship prior to the construc-tion of the chapel, whether or not it was the “Basilica Fidelium Christianorum,” would seem to be plausible if nothing else, and at least the statement that houses stood there in the Roman era is true, to judge by the archeologi-cal excavations carried out in the area, which have uncov-ered articles of everyday use from the 2nd and 3rd cen-tury, as well as two small 4th-century oil lamps, adorned with Christian symbols.6 Later sources are not clear in this regard, since they declare only that Ansperto, after being made archbishop (in the year 868), built a church or re-built it from the foundations, and placed the body of St Mauricilio in it.7 The building that we see today, located, just as the guidebook writers described it, on the corner of a crossroads at which the station of the cross known as the cross of St Mauricilio, was erected in the modern era (by Carlo Borromeo in 1576),8 stands on a plot of land sur-rounded by four streets that reflect with few variations the layout of late antiquity, the Via Torino (formerly Contrada della Lupa), Via Speronari and Via dell’Unione (formerly Malcantone), and the medieval Via del Falcone.9 The lat-ter, which determined in part the plan of the new church
La presenza di un edificio ecclesiastico precedente al sacello, sia esso o meno la «Basilica Fidelium Christia-norum», parrebbe essere se non altro plausibile; e ve-ritiera è almeno la notizia di residenze in età romana, a giudicare dagli scavi archeologici effettuati nell’area, con reperti d’uso di II e III secolo e anche due piccole lucerne di IV secolo, ornate di simboli cristiani6. Le fonti successive non sono a questo proposito chiare, poiché segnalano soltanto che Ansperto, dopo essere salito al soglio arcivescovile (nell’anno 868), costruì o ricostruì dalle fondamenta una chiesa e vi collocò il corpo di San Mauricilio7. L’edificio che oggi incontriamo, al pari dei guidisti, all’angolo di un quadrivio nel quale era colloca-ta in epoca moderna la croce stazionale detta appunto di San Mauricilio (posta da Carlo Borromeo nel 1576)8, in-siste su un lotto di terreno circondato da quattro strade, che rispecchiano con poche varianti il tracciato tardo-antico, composto dalle attuali via Torino (già Contrada della Lupa), via Speronari, via dell’Unione (già Malcan-tone), e medievale, via del Falcone9. Quest’ultima, che determinò in parte la forma planimetrica della nuova chiesa di Santa Maria, fu aperta in un momento non pre-cisabile, ma probabilmente già nel basso medioevo.
A. Guidini, Ipotesi di ricostruzione del sacello, 1889 /A. Guidini, Hypothesis for Reconstruction of the Sacellum, 1889
San Satiro, ipotesi di datazione delle murature / San Satiro, possible dating of the walls (G.B. Sannazzaro e A. Vincenti, 1990)
12
of Santa Maria, was opened at a date that is not known precisely, but probably sometime in the late Middle Ages. So it seems possible to identify the small building called the chapel of the Pietà adjoining the left transept of the church of Santa Maria with the sacellum Ansperto had built within the walls of his abode. In fact the little church, despite being renovated in various periods, reconstructed in part in the 15th century and subjected to restoration in the 19th and 20th centuries, still preserves the early medi-eval structure up to the impost of the lantern.The date of Ansperto’s foundation of the sacellum is known from the so-called “Chronicle” of Pseudo-Goffredo da Bussero,10 which places it in the year 876, citing the arch-bishop as client, and says that it was dedicated to Saints Sylvester and Satyrus. We have confirmation of Ansperto’s specific desire for the construction of the church, however, from his two wills, dated September 10, 879, and Novem-ber 11 of the same year:11 documents on which studies have been concentrated, precisely because of the precision with which they provide information on the foundation of the building and the use to which it was put after the archbish-op’s death. The wills make it clear that Ansperto had already completed construction of the church inside his residence, and thus that it began life as a private chapel. In addition, they leave instructions for the establishment of a xenodochi-um or hostel for pilgrims, to which various other assets are made over, and state that the church should be served every day by eight monks from the monastery of Sant’Ambrogio, who were to lead a community life in a cell annexed to the complex. So it was at the behest of Ansperto himself that the link was forged with the monastery of Sant’Ambrogio; a link that survived throughout the Middle Ages at least,
5 Nel 421 il vescovo di Milano era san Marolo; nel 321 sarebbe stato eventualmen-te san Materno. Eufrasino ci riporta casomai alla memoria Eufrasio, fondatore della basilica cosiddetta eufrasiana di Parenzo, tuttavia con una cronologia più tarda, al VI secolo.6 Palestra, 1964, pp. 23-25.7 Di quest’ultima notizia non si è trovata la fonte documentaria di riferimento, ma la collocazione della croce stazionale dedicata al santo nel XVI secolo, la rende almeno probabile.8 Latuada, 1737, II, p. 243.9 Palestra, 1983, pp. 29-42.
5 In 421 the bishop of Milan was St Marolus; in 321 it would have been St Mater-nus. If anything, the name Euphrasinus calls to mind Euphrasius, founder of what is known as the Euphrasian Basilica at Poreç, in Croatia, but this was built later, in the 6th century.6 Palestra, 1964, pp. 23-25.7 The documentary source for this information has not been found, but the loca-tion of the station of the cross dedicated to the saint in the 16th century makes it at least probable.8 Latuada, 1737, II, p. 243.9 Palestra, 1983, pp. 29-42.
Dunque, il piccolo edificio congiunto al transetto sinistro della chiesa di Santa Maria con il nome di Cappella della Pietà, sembra essere identificabile con il sacello fatto eri-gere da Ansperto entro le mura della sua dimora. La pic-cola chiesa, infatti, pur rimaneggiata in epoche diverse, ricostruita in parte nel XV secolo e interessata anche da restauri otto- e novecenteschi, conserva all’interno, fino all’imposta del tiburio, l’impianto altomedievale.La data di fondazione del sacello da parte di Ansperto è nota dalla cosiddetta Cronaca dello Pseudo-Goffredo da Bussero10, che la colloca nell’anno 876, citando l’ar-civescovo come committente e la dedicazione ai Santi Silvestro e Satiro. La conferma della volontà specifica di Ansperto nella costruzione della chiesa l’abbiamo però dai suoi due testamenti del 10 settembre 879 e dell’11 novembre dello stesso anno11, documenti sui quali si sono maggiormente concentrati gli studi, proprio in vir-tù della precisione nel fornire indicazioni rispetto alla fondazione dell’edificio e alla sua destinazione dopo la morte del vescovo. I testamenti specificano che l’arcive-scovo aveva già completato l’edificazione della chiesa, nata dunque come cappella privata, all’interno della sua residenza, inoltre, dispone che si istituisca uno xenodo-chium o ospizio per i pellegrini, al quale assegna diversi altri beni, e che la chiesa sia officiata ogni giorno da otto monaci provenienti dal monastero di Sant’Ambrogio, che conducano vita comunitaria in una cella annessa al complesso. Per volontà di Ansperto stesso, dunque, si struttura il legame con il monastero di Sant’Ambrogio, rimasto vivo almeno per tutto il Medioevo, quando gli abati ambrosiani amministravano le proprietà di San Sa-tiro e, più tardi, nominavano i parroci12.
13
Sacello, interno prima degli interventi di restauro /Sacellum, interior prior to the interventions of restoration (Porter, 1916)
Sacello, interno / Sacellum, interior
14
when the abbots of the monastery administered San Satiro and, later, appointed the parish priests.12
The documents published by Ambrogio Palestra13 give us an idea of the evolution undergone by the complex over the centuries following its foundation, when some of the plots of land with houses, vegetable gardens and court-yards, previously owned by Ansperto, were slowly broken up and sold or rented to private individuals and merchants. Among the most significant documents are undoubtedly a number recording exchanges and leases of property that prove the erection of the cell for the monks had indeed taken place (in 99114), but also reflect the disappearance of the xenodochium, which is not mentioned in later docu-ments either, bearing witness to the short life of the institu-tion. Following the documentary traces between the 10th and 11th century, it is possible to distinguish at least some topographic limits, such as the present-day Via Speronari (indicated in numerous cases in the medieval documents and always cited as the northern boundary; in particular a level of 101715) and a number of properties that extend-ed at least in part as far as the Contrada della Lupa (now Via Torino, indicated as located to the west; in particular a level of 103616 and another of 106617) and were again administered by the abbot of Sant’Ambrogio. In addition, in a deed of 1094 the boundaries in the direction of to-day’s Via dell’Unione appear for the first time: the deed records the sale of several houses built on land belonging to the monastery of Sant’Ambrogio at the church of San Satiro and bordering on the street to the south. In the
10 La Cronaca, edita da Grazioli, 1906, pp. 211-245 (per S. Satiro, p. 235, 237), come Goffredo da Bussero, è in realtà composta da due cronache differenti e pro-babilmente non assegnabili a Goffredo, che oggi sono distinte convenzionalmente in Pseudo Goffredo A e Pseudo Goffredo B e tramandate da due manoscritti, il cod. 1218 della Biblioteca Trivulziana di Milano del XVI secolo e il cod. SQ + I 12 della Biblioteca Ambrosiana, copia ottocentesca del precedente. Si veda in proposito Tomea, 2001, pp. 39-78.11 Codex diplomaticus Langobardiae, 1873, coll. 482-486; coll. 490-495.12 Palestra, 1983; Compendio delle cose notabili…, ms., XVII secolo, cfr. nota 4.13 Palestra, 1983.14 Codex diplomaticus Langobardiae, 1873, coll. 1515-1516.15 Vittani, Manaresi, 1933, I, p. 194.16 Manaresi, Santoro, 1960, II, p. 221.17 Manaresi, Santoro, 1960, II, pp. 230-231.
10 The Cronaca, published by Grazioli, 1906, pp. 211-245 (for San Satiro, pp. 235, 237), as the work of Goffredo da Bussero, is in reality made up of two different chronicles probably not written by Goffredo, whose authors are today distin-guished conventionally into Pseudo Goffredo A and Pseudo Goffredo B and whose work has been handed down in two manuscripts, the 16th-century cod. 1218 of the Biblioteca Trivulziana in Milan and cod. SQ + I 12 of the Biblioteca Ambrosiana, a 19th-century copy of the former. See in this connection Tomea, 2001, pp. 39-78.11 Codex diplomaticus Langobardiae, 1873, cols. 482-6; cols. 490-495.12 Palestra, 1983; Compendio delle cose notabili…, MS., 17th century, see note 4.13 Palestra, 1983.14 Codex diplomaticus Langobardiae, 1873, cols. 1515-1516.15 Vittani, Manaresi, 1933, I, p. 194.16 Manaresi, Santoro, 1960, II, p. 221.17 Manaresi, Santoro, 1960, II, pp. 230-231.
I documenti pubblicati da Ambrogio Palestra13 permet-tono di avere un’idea dell’evoluzione del complesso nei secoli successivi alla fondazione, quando parte dei lotti di terreno con case, orti e cortili, già appartenuti ad An-sperto, sono lentamente frazionati e passano in proprietà o affitto a privati e mercanti. Tra i documenti più rilevanti troviamo senza dubbio alcune permute di terreni e affitti che provano l’avvenuta erezione della cella per i monaci (nel 99114), ma anche la decadenza dello xenodochium, che non compare nemmeno nei documenti successivi, testimoniando una vita breve dell’istituzione. Seguen-do le tracce documentarie tra X e XI secolo, si colgono perlomeno alcuni limiti topografici distinguibili, ovvero l’attuale via Speronari (indicata in numerosi casi nei do-cumenti medievali e citata sempre come confine nord; in particolare un livello del 101715) e alcuni beni che si protendevano almeno in parte fino alla Contrada della Lupa (attuale via Torino, indicata come posta a ovest; in particolare un livello del 103616 e un altro del 106617) sempre amministrati dall’abate di Sant’Ambrogio. Inol-tre, in un atto del 1094 compaiono per la prima volta i confini verso l’attuale via dell’Unione: si tratta della ven-dita di alcune case costruite sopra terreno appartenente al monastero di Sant’Ambrogio presso la chiesa di San Satiro e confinante con la via a sud.Nel frattempo sembra che un nuovo momento edilizio abbia interessato San Satiro nel corso del secolo XI, coincidente del resto con un rinnovato periodo di cul-to del santo18. Si colloca probabilmente qui, infatti, la
15
meantime it seems that San Satiro underwent a new period of construction over the course of the 11th century, and one that coincided with a revival in the cult of the saint.18 It was probably at this time, in fact, that the bell tower was built alongside it, in line with the layout of the roman street (now Via Speronari), possibly but doubtfully on the foundations of an earlier campanile.19 There are no docu-ments recording the erection of the tower, although the old sources do mention a new consecration of the build-ing around the middle of the 11th century, something that might reasonably have followed a phase of construction. The date of the consecration is given by Galvano Fiamma, who places it in October 1036,20 as well as by the Pseudo-Goffredo da Bussero, who dates it to 1045;21 however, both agree on the fact that the ceremony was conducted by Aribert of Intimiano.Once a bishop’s chapel, then, San Satiro became a place of worship served by monks and probably open to the people of the neighborhood, although it is not known when the parish was established. We do know that it had already been in existence for a long time at the moment of the erec-tion of the church of Santa Maria, at the end of the 15th century, and that, according to the 17th-century sources, it continued to use the small chapel even after its incorpo-ration into Bramante’s complex.22 The earliest document that hints at the formation of the parish dates from 1209,23 when the assets of the sacellum are no longer cited as the property of the monastery of Sant’Ambrogio, but directly controlled by a priest of the church, with the consent of the local people. The document also confirms the presence of a canon’s house and of a cemetery next to the building: the wall that faced onto this graveyard was the scene of the miracle of 1242 that involved the image of the Virgin Mary and Child, painted on the outside of the building, on the side facing onto what is now Via del Falcone. The image is said to have begun to bleed, following its stabbing by a certain Massazio da Vigonzone, who on the Feast of the Annunciation, angry at having lost a lot of money gam-bling, jabbed his knife into the Child’s neck.24
The chapel of San Satiro has represented a considerable
costruzione della torre campanaria che lo affianca, alli-neandosi al tracciato della via romana (oggi via Sperona-ri), e solo dubitativamente strutturatasi su un campanile precedente19. Non vi sono documenti che testimoniano l’erezione del campanile, tuttavia le fonti antiche riporta-no una nuova consacrazione dell’edificio circa alla metà del secolo XI, che ragionevolmente può aver seguito una fase edilizia. La data della consacrazione è nota da Gal-vano Fiamma che la colloca nell’ottobre del 103620, op-pure ancora dallo Pseudo-Goffredo da Bussero, che la pone nel 104521; entrambi concordano sul fatto che essa sia stata celebrata da Ariberto da Intimiano.Da cappella vescovile, dunque, San Satiro passò a essere un edificio officiato da monaci e verosimilmente aperto alla popolazione della vicinìa, anche se non è chiaro il momento dell’istituzione della parrocchia, già presente da lungo tempo al momento dell’erezione della chiesa di Santa Maria alla fine del Quattrocento e che, secon-do quanto riportato dalle fonti secentesche, permase nel piccolo sacello anche dopo il suo inglobamento nel complesso bramantesco22. Il primo documento che la-scia intendere la formazione della parrocchia risale al 120923, quando i beni non sono più citati come proprie-tà del monastero di Sant’Ambrogio, ma agisce in prima persona un sacerdote della chiesa, con il benestare dei vicini. Il documento conferma inoltre la presenza di una casa canonicale e di un cimitero limitrofo all’edificio: è proprio il muro che affaccia su quest’ultimo il teatro del miracolo del 1242 che interessò l’immagine della Ver-gine con Bambino, dipinta sull’esterno dell’edificio, sul lato verso l’attuale via del Falcone, e che consistette nel sanguinamento dell’immagine stessa, in seguito a una pugnalata di un certo Massazio da Vigonzone, che nel giorno dell’Annunciazione, adirato a causa della perdita di molto denaro al gioco, scagliò il proprio coltello con-tro la gola del Bambino24.Il sacello di San Satiro ha rappresentato per la storio-grafia sull’architettura altomedievale un notevole nodo problematico e talora una fonte di imbarazzo, a causa della sua sostanziale unicità nel panorama del IX secolo
16
italiano. Numerose sono dunque state le attenzioni dei pionieri del Medioevo, da Cattaneo e ai giorni nostri25. Al piccolo edificio oggi si accede dalla testata del tran-setto sinistro della chiesa di Santa Maria, attraverso un piccolo passaggio, modificato in occasione della costru-zione della chiesa nuova nel XV secolo. Precedentemen-te questo doveva essere l’ingresso dell’edificio, del quale è stato trovato un muro26, ortogonale rispetto all’asse dell’edificio stesso, anche se questa soluzione parrebbe risalire alle accennate modifiche effettuate al sacello nel corso del secolo XI27. Laddove esternamente il sacello presenta un profilo murario circolare, inglobato nelle strutture di epoca moderna, all’interno esso denota an-cora l’articolazione originaria delle murature, restituita dopo il restauro di Gino Chierici. La pianta ha una for-ma a croce greca inscritta in un quadrato, un quincunx, con quattro sostegni centrali e sfondato su tre lati da nic-chie semicircolari, mentre ancora incerta è la presenza originaria, all’epoca di Ansperto, di una quarta nicchia anche sul lato di ingresso, ipotizzata da alcuni studio-si e della quale pochi anni fa parrebbero essersi trovate alcune tracce28. Ciascuna delle campate di spigolo, inol-tre, presenta due ulteriori nicchie che ne articolano le pareti, movimentando quindi il perimetro murario del quincunx di base, che doveva in origine essere visibile
18 Tomea, 1989, pp. 640-641.19 Porter, 1917, II, pp. 642-643; Segagni Malacart, 1990, p. 119; Sannazzaro, 1993, pp. 269-287; Tosco, 1997, p. 78; Schiavi, 2007, pp. 212-213.20 Gualvanei Flammae, 1727, col. 614.21 Grazioli, 1906, p. 237.22 Il manoscritto secentesco dell’Archivio Storico Diocesano (vedi nota 4) preci-sa che la parrocchia è separata dalla chiesa di Santa Maria, essendo soltanto nel sacello di San Satiro.23 APSS, Origine, privilegi e storia, 1; Palestra, 1983, p. 33.24 Colombo, 1992, p. 77 e nota 2. La fonte antica della vicenda è una narrazione latina anonima della fine del XIV secolo, di cui constano diverse copie presso l’Archivio Parrocchiale di San Satiro e presso l’Archivio Storico Diocesano.25 Si citano le voci più note: Cattaneo, 1888, p. 216, fig. 125; Rivoira, 1901, I, p. 272; Kingsley Porter, 1917, I, p. 68; Strzygowski, 1918, II, p. 767, fig. 720; Toesca, p. 37; Giovannoni, 1931, p. 64, fig. 12; Golzio, 1939, p. 92; Chierici, 1942; De Angelis d’Ossat, 1942, p. 52; Verzone, 1942, pp. 128-129; Arslan, 1954, II, pp. 499-608, in particolare pp. 587-594; Degani, 1956, pp. 123-124; Conant, 1959, p. 60; Dimitrokallis, 1968, pp. 127-140; Perogalli, 1980, pp. 155-190; Sannazzaro, 1990, pp. 6-27; Ciotta, 2010, pp. 293-294.
18 Tomea, 1989, pp. 640-641.19 Porter, 1917, II, pp. 642-643; Segagni Malacart, 1990, p. 119; Sannazzaro, 1993, pp. 269-287; Tosco, 1997, p. 78; Schiavi, 2007, pp. 212-213.20 Gualvanei Flammae, 1727, col. 614.21 Grazioli, 1906, p. 237.22 The 17th-century manuscript in the Diocesan Historical Archives (Archivio Storico Diocesano, see note 4, ASDMi) makes it clear that the parish church was not the church of Santa Maria, but the chapel of San Satiro.23 APSS, Origine, privilegi e storia, cart. 1; Palestra, 1983, p. 33.24 Colombo, 1992, p. 77 and note 2. The oldest source of the story is an anony-mous account in Latin from the end of the 14th century, of which there are several copies in the Parish Archives of San Satiro and the Archivio Storico Diocesano.25 To cite the best-known: Cattaneo, 1888, p. 216, fig. 125; Rivoira, 1901, I, p. 272; Kingsley Porter, 1917, I, p. 68; Strzygowski, 1918, II, p. 767, fig. 720; Toesca, p. 37; Giovannoni, 1931, p. 64, fig. 12; Golzio, 1939, p. 92; Chierici, 1942; De Angelis d’Ossat, 1942, p. 52; Verzone, 1942, pp. 128-129; Arslan, 1954, II, pp. 499-608, in particular pp. 587-594; Degani, 1956, pp. 123-4; Conant, 1959, p. 60; Dimitrokallis, 1968, pp. 127-140; Perogalli, 1980, pp. 155-190; Sannazzaro, 1990, pp. 6-27; Ciotta, 2010, pp. 293-294.
problem for the historiography of early medieval archi-tecture and sometimes a source of embarrassment, owing to its essential uniqueness in the panorama of 9th-century Italy. So it has frequently attracted the attention of the pio-neers of medieval history, from the time of Cattaneo down to our own day.25 Today the small building is entered from the end of the left-hand transept of the church of Santa Maria, through a narrow passage that was modified at the time of the construction of the new church in the 15th century. Previously this must have been the entrance of the building, of which one wall has been found,26 at right angles to the axis of the building itself, although this solu-tion seems to date from the aforementioned modifications made to the sacellum over the course of the 11th century.27 While the outer walls of the chapel, incorporated into the structures of the modern era, are circular in shape, on the inside the original articulation of the walls is once again visible, following the restoration by Gino Chierici. The plan has the form of a Greek cross inscribed in a square, a figure known as a quincunx, with four central supports and bounded on three sides by semicircular niches, while it is still uncertain whether there was originally, at the time of Ansperto, a fourth niche on the entrance side as well, as has been suggested by a number of scholars and of which some traces seem to have been found a few years ago.28
17
Each of the corner bays, moreover, has two further niches that articulate the walls, enlivening the perimeter of the basic quincunx, which must originally been visible on the outside too, as samples taken during the restoration work seem to have demonstrated.29 At the center of the sacellum stand four columns that support the roof, made up of four small tunnel vaults converging on the central space, while the bays at the corners present a different solution, a small vault with a diagonal sharp edge in the middle, a sort of quarter of a cross vault (the original vaults were revealed during Gino Chierici’s restoration, after the removal of the cross vaults that simply been inserted beneath them).30 All the niches in the perimeter have apsidal conches, while the much debated central section of the roof, today in the form of a small octagonal tiburio on squinches, is not the original one and there do not seem to be enough elements today for a definitive hypothesis.The central columns and their capitals are from different periods and of uncertain date.31 The two on the entrance side and the one on the right of the altar appear to be made up in part of spolia from the Roman era, while the one on
anche all’esterno, come sembrano aver chiarito saggi ef-fettuati in occasione dei restauri29. Al centro del sacello si impostano quattro colonne che sostengono le copertu-re, costituite da quattro voltine a botte convergenti verso lo spazio centrale, mentre le campate d’angolo presen-tano una soluzione particolare, con una piccola volta con spigolo vivo centrale diagonale, una sorta di quar-to di crociera (le volte originarie sono emerse durante i restauri di Gino Chierici, mentre erano state sostituite da volte a crociera semplicemente innestate al di sotto di esse)30. Tutte le nicchie perimetrali presentano catini absidali, mentre l’assai discussa copertura centrale, oggi nella forma di un piccolo tiburio ottagonale su trombe, non è quella originaria e non sembrano sussistere oggi elementi sufficienti per un’ipotesi definitiva.Le colonne centrali e i rispettivi capitelli sono di epoche diverse e di datazione incerta31. Le due dal lato dell’in-gresso e quella alla destra dell’altare sembrano in parte composte da spolia di epoca romana, mentre quella a sinistra dell’altare potrebbe essere coeva all’età di An-sperto: in ogni caso esse dovrebbero essere state ricom-
Torre campanaria, bifora interna / Bell tower, internal two-light window
Torre campanaria, inserti esterni / Bell tower, external inserts
18
the left of the altar may date from the time of Ansperto: in any case they must have been recomposed in the 15th century, when the floor of the whole chapel was proba-bly raised as well.32 The sacellum still contains, although in fragments, some of the most significant Lombard wall paintings of the Middle Ages, located inside the niches and bearing a painted curtain: figures of Saints and decorative elements with phytomorphic frames, in addition to rare Crosses in two colors, here ringed by floral motifs, that are common elsewhere in Lombardy but with different dates (such as the ones inside the early medieval tombs of Monza Cathedral, the one in the tower of the monastery of Torba at Castelseprio or the ones on the presbyterial arch of the plebana or ancient parish church of Almenno San Salva-tore). Scholars have identified different layers of the wall
poste nel XV secolo, momento in cui probabilmente fu anche rialzato il pavimento dell’intero sacello32. Il sacello conserva inoltre, seppur in lacerti, pitture murali tra le più rilevanti del Medioevo lombardo, disposte all’inter-no delle nicchie e recanti un velario dipinto, figure di Santi ed elementi decorativi con cornici fitomorfe, oltre alle rare Croci bicrome, qui attorniate da motivi floreali, diffuse altrove in Lombardia con cronologie differenti (si ricordano quelle all’interno delle tombe altomedievali del Duomo di Monza, quella della torre del monastero di Torba presso Castelseprio o quelle sull’arco presbite-riale della plebana di Almenno San Salvatore). Le pitture murali si stratificano secondo gli studiosi in diverse fasi, una prima risalente all’originario periodo anspertiano e almeno una seconda corrispondente al supposto mo-
Sacello, interno: frammento di santo (XI sec.) /Sacellum, interior: fragment of saint (11th cent.)
Sacello, interno: Madonna col Bambino (XIII sec.) /Sacellum, interior: Madonna and Child (13th cent.)
19
26 Chierici 1942, p. 17.27 Sannazzaro, 1993, p. 270.28 Sannazzaro, 1993, p. 271.29 Chierici 1942, p. 15.30 Chierici 1942, p. 18.31 Chierici 1942, p. 18; Romanini, 1991, pp. 1-30; Sannazzaro, 1993, p. 272.32 Chierici 1942, pp. 23-26.33 Bistoletti Bandera, 1990, pp. 29-40; Bandera, 1992, pp. 65-73; Rossi, 2011, p. 60.34 Perogalli, 1980, p. 183, p. 190.35 Rossi, 2007, pp. 87-99.
26 Chierici 1942, p. 17.27 Sannazzaro, 1993, p. 270.28 Sannazzaro, 1993, p. 271.29 Chierici 1942, p. 15.30 Chierici 1942, p. 18.31 Chierici 1942, p. 18; Romanini, 1991, pp. 1-30; Sannazzaro, 1993, p. 272.32 Chierici 1942, pp. 23-6.33 Bistoletti Bandera, 1990, pp. 29-40; Bandera, 1992, pp. 65-73; Rossi, 2011, p. 60.34 Perogalli, 1980, p. 183, p. 190.35 Rossi, 2007, pp. 87-99.
paintings belonging to different phases, a first one dating from the original period of its construction by Ansperto and at least a second one corresponding to the supposed moment of redecoration, which may have preceded its consecration in the 11th century.33 The layout of the cha-pel’s plan is undoubtedly the element that has stirred the most debate, as it represents a fairly rare case for the 9th century. So the tendency of scholars has been to see it as a fusion between a Greek cross structure and a tetraconch volume, and above all to indicate a model of provenance or at least a culture of reference. In this connection, some historians have leaned toward a Greco-Byzantine origin, while another current of interpretation has more prudent-ly chosen to link the sacellum to autochthonous phenom-ena, amongst which the most frequent reference is to San Lorenzo, and to ancient or European models linked to the Carolingian culture, such as the oratory of Germigny-des-Prés dating from the beginning of the 9th century. It should be noted in any case that, independently of typo-logical or cultural factors, the sacellum built by Ansperto seems to have been a small structure on a central plan. This is perfectly in keeping with a building created as a private chapel and one which must have contained relics, perhaps in the tradition of the martyria, and which also displays, in its early medieval phase, a particular attention to the ar-chitecture of antiquity,34 to the point of itself becoming a model in various periods. At least this is what is suggested by the cases of the oratory of San Lino in San Nazaro in Milan (10th century), the baptistery of the parish church of San Vincenzo at Galliano (11th century)35 and the ora-tory of Santa Maria della Pusterla at Pavia, dating from after Bramante’s reconstruction.
mento di ridecorazione, che potrebbe aver preceduto la consacrazione di XI secolo33.L’impianto planimetrico del sacello è l’elemento che senza dubbio ha maggiormente acceso la discussione, giacché esso rappresenta un caso piuttosto raro per il IX secolo, per il quale la tendenza degli studiosi è sta-ta quella di individuare una fusione tra un organismo a croce greca e un volume quadriconco, e soprattutto di voler segnalare un modello di provenienza o comunque una cultura di riferimento. A questo proposito, parte della storiografia si è orientata verso una matrice greco-bizantina, mentre un’altra corrente interpretativa ha voluto più prudentemente legare il sacello a fenomeni autoctoni, tra i quali il riferimento più frequente è a San Lorenzo, a modelli antichi, o europei, legati alla cultu-ra carolingia, come l’oratorio di Germigny-des-Prés del principio del IX secolo. Si noti in ogni caso che, indipendentemente dal fatto-re tipologico o culturale, il sacello voluto da Ansperto pare essere stato un piccolo ambiente a pianta centrale, perfettamente consono a un edificio nato come cappella privata e che doveva contenere reliquie, forse nella tra-dizione dei martyria, e che mostra anche, nella sua fase altomedievale, un’attenzione particolare all’architettu-ra antica34, tanto da diventare esso stesso modello per epoche diverse, come parrebbero dimostrare almeno i casi dell’oratorio di San Lino in San Nazaro a Milano (X secolo), del battistero della pieve di San Vincenzo a Gal-liano (XI secolo)35 e quello dell’oratorio di Santa Maria della Pusterla a Pavia, già successivo alla ricostruzione bramantesca.
21
Bramante e Santa Maria presso San SatiroBramante and Santa Maria presso San Satiro
Richard Schofield
Donato Bramante was already in Bergamo in 1477 af-ter a mysterious career as a painter in the Marches, and came to Milan equipped with a considerable knowledge of Urbinate architecture, especially that of Francesco di Giorgio, and of Leon Battista Alberti in Mantua. S. Maria presso S. Satiro is evidently the first church designed by him, at least from 1482 as we whall see, yet almost every aspect of its history remains disputed.The story begins with an ancient image of the Virgin on the outside of the small church of S. Satiro which had been the object of great veneration and generated an in-flux of offerings. In September 1477 another image on S. Satiro commissioned by Vincenzo Gallina, owner of the Falcone pub, was vandalised, according to a complaint sent by him to the Duke and Duchess. But since there was apparently no pre-existing parish church dedicated to S. Maria on the site next to S. Satiro, the time was right to build one.In 1478 the organisation running the project is first docu-mented, the church is described as “begun”, and proper-ty on the site of the future right transept was acquired for demolition. In June 1479 a flood of offerings prompted Bona di Savoia and Gian Galeazzo Maria Sforza to en-sure that work on the new chapel went ahead as fast as possible: by September 1480 a good start had been made and the authorities had asked the Duke and Duchess to approve their constitution. Until November 1479 the wood-sculptors, Pietro da Bussero and Marco Garibaldi had worked together on a tabernacle (maiestas) for the new chapel, but it was not finished. Pietro da Bussero continued with an apprentice, Santino da Corbeta, and by January 1482 the «maiestas seu anchona» was complete and in position at the altar
Donato Bramante giunse a Milano – dopo una miste-riosa carriera di pittore nelle Marche e a Bergamo, dove si trovava nel 1477 – dotato di una buona conoscenza dell’architettura urbinate, specialmente delle opere di Francesco di Giorgio e di Leon Battista Alberti a Man-tova. Nonostante ogni aspetto della storia dell’edificio resti oggi dibattuto, Santa Maria presso San Satiro fu certamente la prima chiesa che egli si trovò a progettare, almeno dal 1482.Un’antica immagine della Vergine posta sul muro esterno della piccola chiesa di San Satiro e divenuta oggetto di venerazione, favorendo un afflusso di offerte, costituisce l’inizio della storia di Santa Maria, come le vicende di un’altra immagine della Madonna nei pressi di San Sa-tiro, commissionata da Vincenzo Gallina, proprietario della taverna del Falcone, che fu oggetto di atti vandalici nel settembre del 1477, secondo quanto testimoniato da una sua supplica inviata al duca e alla duchessa. Così, dal momento che pare non esistesse una precedente chiesa dedicata a Santa Maria sul sito accanto al sacello di San Satiro, si pensò di costruirne una.Nel 1478 è documentata per la prima volta la Scuola che si sarebbe occupata della conduzione del progetto; la chiesa è descritta come già iniziata e la proprietà esistente sul sito del futuro transetto destro venne acquistata per essere demolita. Nel giugno del 1479 si raccolse una gran-de quantità di offerte grazie all’interessamento di Bona di Savoia e Gian Galeazzo Maria Sforza per assicurare la prosecuzione dei lavori nel minor tempo possibile: nel settembre 1480 la fabbrica era già iniziata e i deputati richiesero l’approvazione ducale per la costituzione della Scuola.Intanto, fin dal novembre del 1479 gli scultori in legno
22
Pietro da Bussero e Marco Garibaldi stavano lavorando a un tabernacolo (maiestas) per la nuova cappella, ma il lavoro non venne terminato. Pietro da Bussero proseguì allora con un apprendista, Santino da Corbetta, e nel gennaio 1482 la «majestas seu anchona» fu completata e posizionata sull’altare di Santa Maria. Infine, nell’aprile del 1482 Marco Lombardi e Matteo Fedeli accettarono di dipingere un sontuoso tabernacolo ligneo, presumibil-mente il medesimo a cui si riferiva la maiestas o anchona realizzata da Pietro da Bussero. Il tabernacolo fu rimpiaz-zato nel XVI secolo con uno più piccolo, ma entrambi furono poi dispersi.Il fatto che il tabernacolo si trovasse già sull’altare di San-ta Maria nel gennaio 1482 ci suggerisce che almeno una parte della nuova chiesa aveva raggiunto uno stadio co-struttivo sufficiente per ospitare sia il tabernacolo stesso sia l’altare. In questa fase probabilmente la chiesa com-prendeva il blocco della cupola, non ancora completa-mente coperto dal tetto e la maggior parte, se non tutto, del futuro transetto. L’altare doveva essere originariamen-te collocato sotto la cupola e connesso al muro verso via del Falcone, in corrispondenza del blocco centrale, cosic-ché potesse essere visto dai fedeli, stando nei bracci del transetto, al di fuori del blocco della cupola. Se l’altare e il tabernacolo fossero stati pensati per stare all’interno del blocco della cupola, essi avrebbero formato un com-plesso come quello costruito a Santa Maria del Monte a Varese (ricostruita tra il 1472 e il 1476), anche se a Milano esso sarebbe dovuto essere forse quadrato o rettangolare, anziché ottagonale.
La struttura originariaPer ricostruire la forma originaria della chiesa sono sta-te formulate sostanzialmente due ipotesi: quella che essa comprendesse una cupola collocata al centro di una lun-ga aula rettangolare, corrispondente al presente transetto, o quella che la cappella fosse costituita da una struttura isolata sul sito dell’attuale blocco della cupola, con un ti-burio (una struttura con tetto a falde che racchiude una cupola circolare o una volta) come la nota cappella Por-
Pianta iniziale di Santa Maria: ipotesi / Initial plan of Santa Maria: hypothesis (Schofield, 2000)
23
tinari a Sant’Eustorgio realizzata negli anni Sessanta del Quattrocento.Ricostruire l’aspetto della chiesa precedente al 1482, o di parte di essa, non è per nulla semplice e oggi permango-no ancora dubbi su un discreto numero di questioni. Il grande blocco centrale su via del Falcone, che sorregge la cupola, presenta massicce paraste, capitelli e trabeazioni; tuttavia solo due di queste trabeazioni furono realizzate nella prima fase: una verso via del Falcone, l’altra con-trapposta a questa, verso la navata maggiore e ora nasco-sta nel sottotetto. Gli altri due lati del blocco cupolato, cioè quelli corrispondenti ai bracci del transetto, non pre-sentano trabeazioni e i capitelli dell’ordine gigante sono incompleti. Queste osservazioni sono sufficienti per di-mostrare che originariamente la parte centrale dell’edifi-cio non poteva essere stata progettata come una struttura a sé stante, simile dunque alla cappella Portinari, poiché in quel caso sarebbero state necessarie quattro trabeazio-ni, dal momento che l’edificio sarebbe stato visibile da tutti e quattro i lati.Inoltre, in modo ancora più strano, sulla facciata verso via del Falcone i capitelli e le paraste dell’ordine maggio-re nascondono quattro capitelli più piccoli, dei quali due si trovano accanto ai capitelli maggiori e gli altri due sono collocati più in basso dietro le paraste, lungo il medesimo asse verticale, e sono ora visibili dalla strada. Originaria-mente, quindi, erano stati progettati due ordini di para-ste e capitelli per la facciata su via del Falcone, ma esse sono state in seguito occultate dalle attuali, di maggiori dimensioni.Forse la versione originaria della chiesa di Santa Maria avrebbe potuto includere un blocco con una cupola (mai completato secondo il progetto iniziale) e i bracci del transetto con alte murature perimetrali, decorate inoltre con due ordini di paraste (forse binate) alla stessa altezza di quelle del blocco della cupola, come nella grande chie-sa di Santa Maria presso San Celso, di poco successiva. Tuttavia questa primitiva facciata fu lasciata incompiuta e l’ipotetico progetto con il corpo di fabbrica corrispon-dente all’attuale transetto esternamente organizzato su
of S. Maria. Finally, in April 1482 Marco Lombardi and Matteo Fedeli agreed to paint a sumptuous wooden tab-ernacle, presumably the same object as the maiestas or anchona made by Pietro da Bussero. The tabernacle was replaced in the 16th century with a smaller one and both have disappeared without trace.That the tabernacle was at the altar of S. Maria in Janu-ary 1482 tells us that at least part of the new church was advanced enough to house both it and the altar safely. At this stage the church presumably comprised a cupola-block not yet completely roofed, plus part or all of the transepts. The position originally intended for the altar was probably under the cupola and attached to the Via Falcone wall of the central block so that the prospective congregation, standing in the arms of the transepts being built out from the cupola-block, could have seen it. If the altar and tabernacle were intended to stand in the cupola-block they may have formed a unit like that built at S. Ma-
Pianta iniziale di Santa Maria: ipotesi / Initial plan of Santa Maria: hypothesis (Patetta, 1987)
24
due livelli potrebbe non essere mai stato iniziato oppu-re, se lo fosse stato, sarebbe stato presto soppiantato dal progetto del 1482-83, che prevedeva la costruzione del transetto e del blocco della cupola nella forma attuale. Non è possibile inoltre sapere se il progetto originario contemplasse o meno la costruzione del corpo di fabbrica
ria del Monte at Varese (rebuilt 1472-76) although that at S. Maria seems to have been square or rectangular rather than octagonal.
The Early Structure Two main hypotheses have been advanced to explain the
Santa Maria, fronte su via Falcone / Santa Maria, front onto Via del Falcone (Area Studio)
25
ipotizzato con volte a botte lunghe quanto quelle attuali.Le differenze strutturali tra il blocco centrale originario e quello attuale, con la sua cupola e i suoi pesanti muri perimetrali dotati di massicce paraste, lasciano sospettare che la cupola primitiva potesse essere più leggera e di for-ma differente. Forse l’architetto poteva aver pensato una cupola estradossata, con la curvatura simile a quella oggi racchiusa nel tiburio, o come quella della Cappella Col-leoni di Bergamo, senza guscio esterno o senza tamburo. Forse invece egli intendeva costruire una volta a crociera, come quelle di Santa Maria degli Angeli o di San Pietro in Gessate a Milano. A questo proposito pare utile l’osser-vazione della sorprendente Stampa Prevedari disegnata da Bramante nel 1481, nella quale si può infatti vedere a sinistra una volta a crociera con sezione semicircolare, evidentemente non coperta da alcuna struttura esterna, dal momento che vi si scorgono finestre a forma di oculo aperte nella volta stessa.L’influenza su Bramante delle architetture di Alberti a Mantova suggerisce però anche altre possibilità. Le volte a botte dell’attuale transetto di Santa Maria, con le falde del tetto poggiate direttamente sopra di esse, sono simili a quella della navata di Sant’Andrea a Mantova; Santa Ma-ria è più piccola di Sant’Andrea e quindi non fu necessa-rio contraffortare i lati come a Mantova. Una variante di Sant’Andrea senza cappelle laterali poteva adattarsi al sito milanese e a un modesto edificio, sostanzialmente compo-sto da due lunghe murature di mattoni coperte con le vol-te relativamente basse e leggere, che poteva essere costru-ito velocemente. Infatti, l’idea di collocare due corpi di fabbrica voltati a botte ai lati di uno spazio centrale può essere stata immaginata dal progettista di Santa Maria os-servando il modello del pronao di Sant’Andrea, nel qua-le si trova una struttura genericamente simile. La cupola prevista da Alberti alla fine della navata di Sant’Andrea non era certamente quella che oggi vediamo, in partico-lare egli poteva aver progettato una cupola con un basso tamburo su pennacchi all’incrocio presbiteriale, simile a quelle nelle piccole cappelle laterali della chiesa. Questo tipo di cupola fu adottato da Luca Fancelli nel 1477-78
original form of the church; that it comprised a cupola in the middle of a long rectangular hall corresponding to the present transepts; or that it was an isolated structure on the site of the present cupola-block, with a tiburio (a circular or ottagonal Lombard cupola enclosed by verti-cal walls with a pitched roof) like the famous Portinari Chapel of the 1460’s.Reconstructing what the church, or the part of it built by 1482 looked like is not easy and today it presents a number of perplexing characteristics. The large central block on the via Falcone supporting the cupola has mas-sive pilasters, capitals and entablatures; yet only two such
Santa Maria, fronte su via Falcone: dettaglio /Santa Maria, front onto Via del Falcone: detail
26
nella Cappella dell’Incoronata nel Duomo di Mantova e nel coro di San Francesco a Mantova nel 1487 (?). La Cappella dell’Incoronata, che presenta anche due bracci voltati a botte, costituisce un confronto, se non un prece-dente, per la forma attuale del transetto di Santa Maria e, infatti, la cupola attuale di Santa Maria non è altro che una semisfera impostata su un basso tamburo.Vi è tuttavia un’altra possibilità. La navata della Badia di Fiesole, che Alberti deve aver ben conosciuto, presenta una volta a vela sopra l’incrocio dei bracci dell’edificio, e, come Sant’Andrea, una lunga volta a botte sulla navata. La combinazione di volta a botte e volta a vela ricorre anche negli anni Novanta del Quattrocento nel pronao di Santa Maria Maddalena dei Pazzi a Firenze; inoltre, all’inizio del Cinquecento si possono trovare volte a botte abbinate a una volta a vela nel coro di Santa Maria del Popolo a Roma, di Bramante stesso. È possibile che anche Alberti avesse progettato una volta a vela per Sant’Andrea, collo-cata alla fine della navata voltata a botte, in questo caso la struttura avrebbe avuto molte più somiglianze con gli esempi citati.Individuare chi sia l’autore del primo progetto della chiesa di Santa Maria (1478) è di difficile soluzione per mancanza di prove decisive. I candidati privilegiati sono senza dubbio Bramante, Amadeo o Giovanni Battagio. Se la facciata originaria su via del Falcone (e quindi, l’ipoteti-ca prima versione del corpo dell’attuale transetto) avesse avuto paraste binate agli spigoli, questo permetterebbe di segnare un punto in favore di Bramante, dal momen-to che paraste giganti binate sono poi state usate per il transetto attuale. Al contrario non sussistono altri esempi nell’opera di Bramante di due ordini sovrapposti di pa-raste piccole binate, forse utilizzati nella prima versione della facciata su via del Falcone, è dunque preferibile che la questione resti ancora aperta.
L’ampliamento (1482-1483)La prima versione di Santa Maria era già «facta» e «con-structa» nel gennaio del 1482. Spesso le chiese rinasci-mentali si costruivano per settori necessitando anche di
entablatures were built – one on the Via Falcone, the other opposite it overlooking the nave and now hidden under the roof. The other two faces of the block over-looking the transepts are not provided with entablatures and the giant order capitals of those facades are unfin-ished. These observations alone make it certain that the original central section of the church cannot have been intended to be a free-standing block like the Portinari Chapel, because that would have required four entabla-tures since the building would have been visible from all four sides. Stranger still, on the Via Falcone façade the major order capitals and pilasters almost hide four much smaller capitals, of which there are two next to the great capitals and two others below them on the same vertical axis and now visible from the street. Originally, there-fore, two stories of pilasters and capitals were planned for the Via Falcone facade, but were later hidden by the present large pilasters.Perhaps the original version of S. Maria was to have in-cluded a cupola-block (never completed as originally in-tended) and transepts with high surrounding walls prob-ably also decorated with two orders of pilasters (perhaps coupled) to the same height as those of the cupola-block, as at the great church of S. Maria presso San Celso in Milan built slightly later. But this first facade was left un-finished and the hypothetical plan for two-storied tran-septs suggested above may never have been started; even if it was, it was soon overtaken by the plan of 1482-83 to build the transepts and the cupola block in their pres-ent form. Whether the original plan was to built transepts with barrel vaults to the same length as they are now we cannot tell.The structural differences between the original and the present block with its cupola and heavy surrounding walls supported by massive pilasters suggest that the cupola originally intended may have been lighter and of different configuration than the present one. Perhaps the architect planned a cupola of which the outer curvature was left visible like the one now encased within the tiburio, or like that of Amadeo’s Colleoni Chapel without the outer shell
27
lunghi periodi: si realizzavano inizialmente un progetto e un modello e poi, nel corso degli anni si acquisivano le proprietà necessarie per poi demolirle, in modo da modi-ficare o ampliare progressivamente il nucleo primitivo.Nel dicembre del 1482 Bramante è documentato per la prima volta a Santa Maria presso San Satiro come testimo-ne in un atto notarile concernente l’ampliamento dell’edi-ficio verso via Torino, poi lo sarà per fornire consigli per le sculture della sacrestia (1483), per lo schema dei colori per la facciata (1486) e per la dipintura del Compianto di Agostino Fonduli nel sacello di San Satiro (1491).Bramante fu certamente responsabile del drastico cambia-mento di progetto sviluppato nel 1482, che contemplava l’ampliamento della chiesa verso via Torino, l’aggiunta delle navate minori e della navata centrale, del finto coro e della sacrestia. Le maggiori integrazioni alle strutture originarie furono senza dubbio iniziate entro il gennaio 1482 ed entro la fine del 1483 erano state in gran parte completate le principali decorazioni in terracotta e quelle dipinte del transetto, della sacrestia e della navata mag-giore; il solo importante elemento che attendeva ancora di essere costruito era la facciata, iniziata nel 1486.La struttura finale di Santa Maria è la più singolare che
or drum. Or perhaps he intended to build a cross-vault like that at S. Maria degli Angeli or at S. Pietro in Gessate in Milan. Bramante’s astonishing Prevedari Engraving of 1481 is worth consulting here; at the left we see a cross-vault of semicircular section, which was clearly not cov-ered above with any other structure because the circular windows are open to the sky. But Bramante’s fascination with Alberti’s Mantuan archi-tecture suggests other possibilities. The transepts of S. Maria, which include barrel-vaults with roofs placed im-mediately on top of them, are similar to those of the nave of S. Andrea in Mantua; S. Maria is much smaller than S. Andrea and no side buttressing was needed. A vari-ant of S. Andrea without side chapels would have suited the site in Milan and a modest building, essentially two long brick walls with a relatively low and light vault in the centre could have been built quickly. Indeed the idea of putting two barrel-vaulted transepts on either side of a central space may have occurred to the designer of S. Ma-ria after observing the model of the atrium of S. Andrea, where we find a generically similar internal structure. The cupola intended by Alberti for the end of the nave of S. Andrea was certainly not that which we see today, and
Santa Maria, fronte su via Falcone: capitelli /Santa Maria, front onto Via del Falcone: capitals
Santa Maria, transetto sinistro: dettaglio della trabeazione e del capitello /Santa Maria, left arm of the transept: detail of the entablature and the capital
28
sia possibile vedere in una chiesa del Quattrocento. Essa ha una pianta a “T” orientata a sud-est (e non a est). La navata e il transetto presentano volte a botte, il transetto è articolato da nicchie depresse, non semicircolari o ellitti-che, mentre le navate minori sono prive di nicchie e sono voltate con crociere a sezione semicircolare. Le navate laterali fiancheggiano la navata e girano, inoltre, lungo uno dei lati del transetto. Per ovviare all’inconveniente che la chiesa non possa avere un coro reale costruito die-tro l’altare a causa della presenza della via del Falcone, Bramante inventò il tanto celebrato finto coro prospet-tico, una struttura in mattoni, legno, terracotta e stucco dipinto, che simula tre campate identiche a quelle reali della navata centrale, in una profondità di soli 97 cm. Il finto coro appare perfetto qualora lo si ammiri dalla por-ta principale dell’edificio e lungo l’asse della navata, ma visto dai transetti esso si sfalda scenograficamente come fosse di gelatina.I lavori all’edificio procedettero rapidamente: la struttura della navata, del finto coro e del transetto era già comple-tata nel 1483. In un contratto del marzo 1483 Agostino Fonduli accettò di realizzare il fregio in terracotta per la Sacrestia e un altro lungo 215 braccia (126,8 m) entro il maggio dello stesso anno (126,8 m è quasi esattamente la lunghezza del fregio con le arpie e corone d’alloro, che corre tutt’intorno al transetto, alla navata principale e al finto coro). Agostino doveva inoltre terminare, entro il mese di agosto e sotto la supervisione di Bramante, trenta figure in terracotta – oggi perdute – da porsi all’interno del tiburio. Intanto, nello stesso agosto del 1483 quattro pittori avevano decorato il tiburio di San Satiro e quello di Santa Maria, sia all’esterno sia all’interno, e nel mag-gio dello stesso anno Antonio Raimondi aveva iniziato la decorazione della volta interna alla fine del transetto destro, mentre nel novembre Antonio Raimondi stesso e Antonio da Pandino si sarebbero impegnati a dipingere la volta interna alla fine del transetto sinistro. Dal momento che i pittori stavano decorando le estremità di entrambi i bracci, l’intera struttura del transetto doveva essere già conclusa nel 1483.
he may have planned a cupola with a low drum on pen-dentives at the crossing matching those in the small side-chapels of the church. This type of cupola was used by Luca Fancelli in 1477-78 in the Cappella dell’Incoronata at the Duomo di Mantova and in the choir S. Francesco in Mantua in 1487 (?). The Incoronata, which includes two barrel-vaulted arms, constitutes a parallel, if not a prec-edent for the present form of the transepts of S. Maria: and indeed the present cupola of S. Maria is a hemisphere on a low drum.There may be another possibility. The nave of the Badia Fiesolana, which Alberti knew well, has a sail-vault over the crossing, and, like S. Andrea, a long barrel-vault. The combination of barrel-vault and sail-vault also occurs in the 1490’s in the atrium of S. Maria Maddalena dei Pazzi in Florence; furthermore, at the beginning of the Cinque-cento we find barrel-vaults and a sail-vault in Bramante’s own choir of S. Maria del Popolo in Rome. It may be that Alberti too had projected a sail-vault at S. Andrea at the end of the barrel-vaulted nave. If the architect of the first version of S. Maria presso Satiro planned a sail-vault, then the resulting structure would have had much in common with these examples. The question of the first designer of the church in 1478 is difficult to resolve for lack of decisive evidence and Bramante, Amadeo or Giovanni Battagio are the most likely candidates. If the primitive facade (and indeed, the hypothetical first version of the transepts) had coupled pilasters at the corners then that points to Bramante, since large coupled pilasters were used for the present transepts. Conversely, there would be no other example in Bramante’s work of the superimposed orders of small coupled pilasters perhaps used on the first version of the Via Falcone facade. The question is best left open.
Enlarging the Church 1482-83The first version of S. Maria was «done (facta)» and «built (constructa)» by January 1482. Renaissance churches were often built in sections over a long period: an ini-tial plan and model were made, then over the years the
29
Le navate minori della chiesa devono essere state proget-tate nel 1482, e allo stesso modo costruite, almeno in par-te, tra quella data e il 1486. Il noto finto coro fu progetta-to contemporaneamente alle navate minori e alla navata centrale, giacché esso comprende tre campate di pilastri e archi, e un ordine minore che simula la presenza di navate minori a destra e a sinistra. Anche la Sacrestia fu proget-tata nella stessa fase e fu completata entro il marzo del 1483. Quest’ultima non poteva certamente far parte del primo progetto per la chiesa del 1478-81, perché, se essa fosse stata prevista nella forma in cui la vediamo oggi pri-ma delle navate minori, sarebbe stata staccata dal corpo dell’edificio della primitiva chiesa, una pratica inusuale.
authorities bought up properties for demolition so as to alter or extend the initial nucleus. But in December 1482 Bramante is documented at the church for the first time as a witness to a notarial act about the extension of the church towards the Via Torino, as an adviser for the sculpture of the Sacristy (1483), for the colour-scheme for the facade (1486) and for the painting of Agostino Fonduli’s Lamentation in S. Satiro (1491). Bramante was certainly responsible for the drastic change of plan developed in 1482 to extend the church to the Via Torino, to add the aisles, nave, false choir and sacristy. The major additions to the original structures were no doubt started by January 1482 and by the end of 1483
Sezione trasversale sul transetto / Cross section of the transept (Area Studio)
30
La posizione della sacrestia impone quindi la presenza dei fianchi delle navate minori: essa è collocata nell’angolo d’incrocio tra la navata minore destra e il transetto, come nel Santuario di Loreto o nel Duomo di Pavia, quest’ul-timo progettato in parte da Bramante stesso dal 1487. Originariamente doveva essersi creato un effetto infelice per quanto riguarda l’ingresso dalla chiesa alla sacrestia, poiché data la posizione esso avrebbe in qualsiasi caso de-terminato il taglio di un pilastro nella navata laterale de-stra o nel transetto, difetto rettificato dall’attuale ingresso realizzato nell’Ottocento.Si possono individuare alcune differenze tra l’aspetto attuale della chiesa e quello del 1486. Per prima cosa la facciata verso via Torino non fu mai completata, fino alla ricostruzione ottocentesca, poiché il sito rimase circonda-to da edifici. In secondo luogo oggi la base del triangolo formato dal tetto si imposta all’apice della volta a botte della navata centrale, nascondendo in questo modo alcu-ne delle decorazioni pittoriche del 1483 poste all’esterno del tiburio. In origine le due falde inclinate del tetto era-no poggiate direttamente sulla volta a botte, come accade ancora oggi per quelle del transetto e come mostra un di-segno del 1487-89, recante uno schema per la controfac-ciata. Un terzo elemento di difformità è rappresentato dal fatto che le volte attuali della navata maggiore e del tran-setto, realizzate in mattoni, hanno un intradosso liscio e dipinto a lacunari. Sia il cardinale Federico Borromeo nel 1611 che Venanzio De Pagave negli anni Ottanta del Set-tecento testimoniano che originariamente le volte erano decorate come l’attuale cupola, in altre parole con lacu-nari con rosetta realizzati in stucco e metallo. Una quarta differenza risiede nel fatto che delle tre finestre originarie collocate alle testate del transetto, due avevano forma ret-tangolare e quella al centro aveva terminazione superio-re semicircolare, ma nel 1833 Felice Pizzagalli sostituì le finestre con oculi circolari a imitazione di quelli dipinti in Santa Maria delle Grazie. Curiosamente, comunque, alcune stampe mostrano dall’esterno tutte e tre le finestre originarie con terminazione semicircolare. Infine, l’inter-no della chiesa sarebbe dovuto essere inondato di luce,
the most important terracotta and painted decoration of the transepts, sacristy and nave were all more or less com-plete; the only major element awaiting construction, the facade, was begun in 1486. The final structure of S. Maria is the strangest of that of any church in the Quattrocento. It is T-shaped and orien-tated roughly to south-east, not east. The nave and tran-septs have barrel vaults; the transepts have segmental, not semicircular or elliptical niches, while the aisles are with-out niches and have cross-vaults of semicircular section. The aisles flank the nave but only run down one side of the transept. To compensate for the fact that the church could not have a real choir behind the altar because of the proximity of the Via Falcone at the south-east, Bra-mante devised the celebrated perpectival false choir, a structure of brick, wood, terracotta, stucco and paint that replicates three bays of the architecture of the nave, but is only about 97cm thick. When viewed from the main door of the church down the axis of the nave, it looks perfect; but when seen from the transepts it collapses spectacu-larly like a jelly.Work proceeded rapidly: the nave, false choir and tran-septs were completed structurally in 1483. In a contract of March 1483 Agostino Fonduli agreed to make the ter-racotta frieze for the Sacristy and another one 215 braccia long (126.8m) by May 1483; 126.8m is almost exactly the length of the harpy-and-wreath frieze which runs around the transepts, the whole of the nave and the fictive choir. Agostino also had to complete thirty terracotta figures – now lost – for the inside of the tiburio by August under the supervision of Bramante. By August 1483 four paint-ers had decorated the tiburios of S. Satiro and S. Maria both inside and out and in May 1483 the interior vault of the end of the right transept was to be painted by Antonio Raimondi: in November 1483 Raimondi and Antonio da Pandino undertook to paint the vault at the end of the left transept. Since the painters were decorating the ends of both transepts, the entire structures of both must have been finished in 1483. The aisles of the church must have been planned in 1482
31
poiché Federico Borromeo segnala nel 1611 la presenza di ben 44 finestre. Il suo resoconto descrive il grande ocu-lo della facciata e le finestre del transetto, ma si limita poi a indicare che le restanti finestre erano tonde o quadrate. Oggi la chiesa non raggiunge nemmeno lontanamente un numero di 44 finestre ed è possibile che alcune delle fi-nestre quadrate descritte da Federico Borromeo fossero collocate tra i lacunari delle grandi volte della navata cen-trale e del transetto.
La cappella di San Teodoro e la facciataL’incarico di costruire una cappella dedicata a San Te-odoro fu dato a Bramante dal duca stesso, Ludovico il Moro, probabilmente dopo il maggio del 1496. Il gior-no di San Teodoro, 26 maggio, coincideva con la data dell’investitura ducale di Ludovico nel 1495. Il progetto fu avviato immediatamente e avrebbe contemplato l’uso di pietra, elemento interessante visto che l’attuale chie-sa è costruita interamente in mattoni, stucco e terracotta (fatta eccezione per i capitelli della sacrestia e per quelli esterni), e che lascia sospettare che i materiali ordinati per la costruzione avrebbero determinato un tipo di edificio molto differente. Alcuni studiosi hanno proposto che la cappella dovesse essere un satellite della chiesa maggiore, all’estremità del braccio destro del transetto, pendant di San Satiro. L’ipotesi è verosimile, ma nel 1511 Francesco Brivio lasciò una somma per terminare la cappella, che sembra descritta come interna al braccio destro del tran-setto e non come esterna: probabilmente per mancanza di fondi il progetto originario fu abbandonato e i Brivio dovettero accontentarsi di compiere modifiche in prossi-mità dell’altare di San Teodoro all’interno della chiesa per la collocazione della loro tomba.La facciata della chiesa verso via Torino, sulla base di un contratto del 1486, non fu mai completata eccetto la metà del basamento posto da Giovanni Antonio Amadeo e poi sostituito anch’esso nell’Ottocento. Bramante, che aveva progettato il resto della chiesa, doveva aver dise-gnato anche una facciata esterna e presumibilmente il ba-samento realizzato da Amadeo avrebbe potuto ricalcare il
as well and were constructed, at least in part, between then and 1486. The famous fictive choir was designed simultaneously with the aisles of the nave because it in-cludes three bays of piers and arches and a minor order that suggests illusionistically the presence of aisles to right and left. The Sacristy was also planned simultane-ously with the aisles in 1482 and was completed by about March 1483. It was not part of the original plan for the church of c. 1478-1481 because, if it had been planned before the aisles had been thought of, it would have been left detached from body of the primitive church; but sac-risties, as opposed to baptistries, were not usually sepa-rated from churches in the Quattrocento for practical reasons. The location of the Sacristy implies the presence of the side aisles; it is placed in the angle formed by the nave and transept-aisles as at the Sanctuary at Loreto or the Duomo di Pavia, the latter designed in part by Bra-mante from 1487. There was an unfortunate side-effect in that any entrance to the Sacristy from the church had, originally, to cut through a pilaster in the aisle or in the transept, a fault rectified by the present entrance created by Giuseppe Vandoni in the 19th century. There are a number of differences between the church as it was left in 1486 and now. First: the facades of the aisles towards the Via Torino were never completed until Van-doni’s reconstruction since the site remained so hemmed in by buildings. Second: now the horizontal base of the triangle of the roof starts above the apex of the barrel-vault of the nave, thus preserving some of the painted decoration of 1483 on the outside of the tiburio. Origi-nally the two inclined halves of the roof rested directly over the barrel vault as they do now over the transepts, as is shown in a drawing of 1487-90 illustrating a scheme for the back of the façade. Third: the present vaults of the nave and transepts are made of brick and the soffits are smooth and painted with coffers. But both cardinal Federico Borromeo in 1611 and Venanzio De Pagave in the 1780’s report that originally the vaults were like that of the present cupola, decorated with coffers and rosettes made of stucco and metal. Fourth: of the three original
32
suo progetto. Il disegno per la controfacciata, realizzato probabilmente da Bramante tra il 1487 e il 1490, di poco successivo all’inizio dei lavori al basamento, assume in questo senso una rilevanza decisiva, perché possiamo im-maginare per suo tramite quale tipo di facciata Bramante avesse in mente. Il disegno mostra la sezione trasversale della navata centrale e la volta, nella forma in cui Bra-mante le lasciò: il tetto delle navate, poggiato sopra la volta a botte, doveva essere sorretto a destra e sinistra da murature che arrivavano circa alla metà dell’altezza della volta stessa, sostanzialmente nello stesso modo di quanto accade ora nel transetto.Una delle ipotesi percorribili è quella che Bramante aves-se progettato una facciata per la navata centrale nella quale la sezione centrale includesse un timpano spezzato impostato su paraste binate, come quelle del transetto. Tuttavia l’obiezione a questa ipotesi è che non esistono esempi di una simile facciata nell’architettura ecclesiastica del tardo rinascimento lombardo. Forse, invece, il fron-te della navata progettato da Bramante avrebbe potuto comprendere due paraste giganti, su piedistalli separati, oppure su un basamento continuo, con una trabeazione e un timpano, simili a quelli del blocco della cupola verso via del Falcone. Le navate minori avrebbero potuto esse-re terminate invece da semitimpani a destra e a sinistra e nella parte centrale superiore un archivolto semicircolare avrebbe potuto circondare l’oculo. Questa ipotesi, o una ricostruzione simile a questa, è confermata dalla presenza di alcune facciate di chiese successive che presentano ca-ratteristiche che parrebbero derivare dall’opera milanese di Bramante. La chiesa parrocchiale di Roccaverano, il modello ligneo di Antonio da Lonate per il Duomo di Vigevano e la facciata della Sagra di Carpi di Peruzzi mo-strano tutte un ordine maggiore di paraste in corrispon-denza della navata centrale, un oculo circolare nel livello superiore, e semitimpani in corrispondenza delle navate minori. Similmente a queste facciate, un disegno conser-vato al Louvre, ma anche l’illustrazione di Cesariano per la basilica di Fano (1521) condividono l’oculo circolare incorniciato dall’archivolto e l’ordine maggiore. Questo
windows at the ends of the transepts, two were rectan-gular and that in the centre provided with a semicircular head: in 1833 Felice Pizzagalli replaced them with circular windows imitating the painted ones in S. Maria della Gra-zie; curiously, however, prints show that on the outside all three windows had round heads. Fifth: the interior of the church must have been ablaze with light since Federico Borromeo reports in 1611 that there were forty-four win-dows. His report describes the large circular window of the façade and the transept windows, but says merely that all the rest were round or square. Today the church has nothing like forty-four windows, and it may be that some of the square windows were housed in the coffers of the great vaults of the nave and transepts. The Chapel of San Teodoro and the facadeThe task of constructing a chapel dedicated to S. Theo-dore was given to Bramante by the Duke, Ludovico il Moro, probably after May 1496. S. Theodore’s birthday fell on 26 May which was also the date of the investiture of Ludovico as Duke in 1495. The chapel would have in-
Bramante, disegno per la controfacciata, 1487-90 / Bramante, drawing of retrofacciata, 1487-90
34
tipo di facciata fu poi usata ripetutamente nel XVI secolo e raggiunse il suo apice nelle facciate delle chiese venezia-ne di Palladio.Il disegno per la controfacciata mostra anche un progetto incompiuto per la balconata dell’organo. Esso illustra una struttura architettonica da costruirsi entro il semicerchio ricavato entro la volta a botte della navata centrale, com-prendente parti di trabeazioni a sinistra e a destra, con un arco al centro, motivo che diventerà uno dei più noti dell’architettura italiana con il nome di serliana o finestra palladiana. Allora questo elemento non era ancora pre-sente nell’architettura lombarda e il disegno costituisce una soglia cronologica importante per la sua reintrodu-zione nell’architettura del Rinascimento. La serliana può derivare in questo caso dall’osservazione dall’interno della Cappella Portinari o dalla facciata verso il mare del Palazzo di Diocleziano a Spalato e, ugualmente, un’altra fonte potrebbe essere il Miracolo del cuore dell’avaro (Pa-dova, Basilica del Santo) dove la serliana è dotata di pi-lastri, come nel disegno, ma non di paraste addossate. Il tratto rapido e sicuro del disegno sembra avere termini di confronto nei disegni di Bramante per San Pietro di molti anni successivi; gli indizi raccolti, considerati nella loro globalità, sembrano quindi suggerire che sia Bramante l’autore del disegno, invece che Amadeo.
L’interno La forma della Sacrestia è propria della tradizione mila-nese, con un’alternanza di nicchie semicircolari e rettan-golari nell’ordine inferiore e una loggia superiore, ispira-ta alla cappella di Sant’Aquilino in San Lorenzo. Nella sacrestia si trovano una serie di elementi decisamente bramanteschi, impiegati anche nella Stampa Prevedari. Al piano terreno della sacrestia Bramante inserisce un ordine minore con archivolti senza fasce, ma solo una modanatura esterna, omettendo capitelli e basi; al primo piano similmente realizza un ordine minore senza ca-pitelli e con archivolti lisci. Bramante, inoltre, avrebbe poi impiegato l’archivolto semplice, racchiuso da mo-danatura esterna, per l’arcone del cortile della Canonica
cluded a considerable amount of stone, which is inter-esting because all the present church was constructed of brick, stucco and terracotta (except for the capitals of the Sacristy and exterior), which suggests that the materials ordered were for a very different type of building; ac-cording to the documents, the project was actually be-gun. Some scholars have proposed that the chapel was to have been a satellite outside the wall of the west transept matching that of S. Satiro at the east. This may be so, but in 1511 Francesco Brivio left money to finish the chapel which was then described as inside, not outside the right transept; presumably for lack of funds, the original plan was abandoned and they had to content themselves with making adjustments to the chapel of S. Theodore inside the church for Brivio’s tomb. The facade of the church, contracted for in 1486, was never completed above the level of Giovanni Antonio Amadeo’s plinth: all of it was replaced by Giuseppe Van-doni in the 19th century. Bramante, who had planned the rest of the church, must have designed an external façade and presumably Amadeo’s plinth matched his project. The project for the back of the façade, made perhaps by Bramante in ca. 1487-90 and just after Amadeo had started his plinth, is of great interest here because we can use it to envisage what type of external façade Bramante had in mind. The drawing shows a cross-section of the nave and vault as they were left by Bramante: the roof over the barrel-vault was to be supported to right and left by walls that arrived about half-way up the height of the barrel-vault, in much the same way as those over the transepts do today. One possibility is that Bramante planned a nave-facade of which the central section included a large split-tympa-num resting on coupled pilasters like those of the tran-septs. But the objection to this hypothesis is that there is no trace of such a facade in later Lombard Renaissance church architecture. Perhaps instead, the nave-facade planned by Bramante comprised two giant order pilasters, on separate pedes-tals or a continuous plinth, with an entablature and tym-
36
panum like those of the cupola-block of the Via Falcone façade. The aisles could have been fronted by half-tympa-nums to left and right. In the upper storey a semicircular archivolt could have enclosed a circular window. This hy-pothesis, or something like it, is confirmed by some later church-facades with characteristics which seem to origi-nate in Bramante’s Milanese work. The parish church at Roccaverano, Antonio da Lonate’s wooden model for the Duomo at Vigevano and Peruzzi’s Sagra at Carpi all share major order pilasters in front of the nave, a circular win-dow in the upper level and aisles with half-tympanums. In common with these facades, a drawing in the Louvre as well as Cesariano’s illustration of the Basilica at Fano (1521) all share the hooded circular window and major order. This type of façade was used repeatedly in the 16th century and reached its apogee with Palladio’s Venetian church facades.The drawing for the back of the façade (ca. 1487-90) shows an unexecuted project for the organ-loft. It illus-trates an architectural unit to be built within the semi-circle of the nave-vault comprising sections of entabla-ture at left and right with an arch in the centre which became one of the most famous motifs in the history of architecture from the 16th century, when it was called a serliana or Palladian window. The form was non-existant in Lombard architecture at this date and the drawing rep-resents an important moment when the form was rein-troduced into Renaissance architecture. It could derive from the interior of the Portinari Chapel or the sea-front of Diocletian’s Palace at Split; as likely a source is Dona-tello’s Miracle of the Miser’s Heart (Santo, Padua) where the serliana has piers, as in the drawing, but no applied pilasters. The assured, rapid style of the drawing seems to have counterparts among Bramante’s drawings for S. Pe-ter’s many years later; taken together these hints suggest that Bramante was the author rather than Amadeo.
The Interior The form of the sacristy is traditionally milanese with al-ternating semicircular and rectangular niches below and
di Sant’Ambrogio e in entrambi gli ordini del chiostro dorico di Sant’Ambrogio, ma questo motivo fu anche uno dei preferiti di Francesco di Giorgio Martini (pre-sente nelle chiese di San Bernardino di Urbino e di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio presso Cortona). Forse i due architetti scelsero questo elemento perché potevano apprezzarlo all’interno di molte architetture antiche, ma anche nelle opere di artisti del Quattrocento strettamente legati al recupero dell’antico, in particolare nei rilievi di Donatello con il Banchetto di Erode (nel fonte battesimale del battistero di Siena), e nel Cristo davanti a Pilato e Cristo davanti a Caifa nel pulpito della Passione in San Lorenzo a Firenze.La conchiglia nelle nicchie della sacrestia e del transetto della chiesa di Santa Maria appare, sebbene al contrario, nella nicchia a sinistra della Stampa Prevedari e deriva probabilmente dall’assai nota pala di Brera di Piero della Francesca, che Bramante doveva aver studiato attentamen-te. Anche i tondi racchiusi da archivolti semicircolari delle restanti nicchie dell’ordine inferiore sono presenti nella Stampa, ma forse derivano dal rilievo del Miracolo del neo-nato che parla e Miracolo del cuore dell’avaro di Donatello a Padova, che Bramante aveva certamente visto. Un elevato interesse per il recupero di motivi dalla scultura antica in chiave cristiana è evidente nei bellissimi rilievi di Fonduli della sacrestia. Il significato delle otto teste clipeate resta inspiegabile, ma la presenza di putti musicanti trova la sua fonte di ispirazione nel Salmo 150, utilizzato anche per la cantoria di Luca della Robbia per la cattedrale di Firen-ze. Nell’ordine superiore della sacrestia, una delle scene in stucco e metallo della balaustrata mostra due putti con un grande vaso, ispirati al Trono di Cerere (?) del Museo Arcivescovile di Ravenna e usati anche da Donatello nella parte inferiore della sua cantoria in Santa Maria del Fiore a Firenze. La scena del putto che ne sculaccia un altro è invece tratta da un tipo diffuso nei sarcofagi, del quale si trovano diversi esempi a Roma e Pisa.La navata centrale della chiesa è caratterizzata da due im-portanti elementi a grande scala: anzitutto la volta a botte, originariamente decorata con lacunari a stucco con roset-
37
te, derivata presumibilmente dal pronao di Sant’Andrea di Mantova. I pilastri e le paraste sono senza basi, moti-vo che ha molti precedenti, tra i quali il più vicino cro-nologicamente è quello della cripta di San Sebastiano di Mantova, che poteva aver ispirato Bramante anche per le volte a crociera delle navate laterali. Anche il progetto di Francesco di Giorgio per il Duomo di Urbino, oggi am-piamente trasformato, fu per Bramante molto importante nella progettazione di Santa Maria, visto che i due edifici condividono cinque importanti caratteristiche, alcune del-le quali più rilevanti di altre: (1) in entrambi gli edifici i pilastri dell’ordine maggiore sono privi di basi; (2) a Urbi-no compare la trabeazione con architrave a due fasce (di diverso dettaglio), come accade nell’ordine minore della navata centrale di Santa Maria, nell’ordine minore della Sacrestia e nell’esterno di San Satiro; (3) le nicchie hanno una pianta depressa anziché semicircolare; (4) entrambi gli edifici hanno la navata centrale di cinque campate, voltata a botte, e navate laterali con volte a sezione semicircolare, sebbene quest’ultima caratteristica potrebbe provenire an-che dal sorprendente progetto di Filarete per il Duomo di Bergamo della fine degli anni Cinquanta del XV secolo; e (5) entrambe le chiese presentano paraste molto ampie con trabeazione aggettante, applicate ai pilastri che separano la navata dal transetto.Ovviamente, l’effetto visivo globale del Duomo di France-sco di Giorgio, austero, slanciato e lineare, non potrebbe contrastare maggiormente con quello di Santa Maria, che appare tozza e pesantemente decorata, ma i due edifici condividono così tante importanti caratteristiche, che sem-bra inevitabile concludere che Bramante avesse una certa conoscenza del progetto iniziale di Francesco di Giorgio.All’interno di Santa Maria, l’importanza differente degli spazi è espressa anche mediante una gerarchia nell’ela-borazione degli ordini architettonici, come accade nella Stampa Prevedari e nella canonica di Sant’Ambrogio. Nelle navate laterali la trabeazione comprende un archi-trave con una sola fascia, fregio e cornice, ma l’ordine è privo di capitello; l’ordine minore della navata centrale ha un architrave a due fasce, separate da modanature a se-
a loggia above adapted from the chapel of S. Aquilino at S. Lorenzo. Here we can identify a number of decisively bramantesque elements also used in the Prevedari En-graving which Bramante designed in 1481. For the mi-nor order of the ground-floor Bramante used archivolts without fascias, only exterior rims, omitting the capitals and bases; on the first floor, a capitalless minor order and similar, smooth archivolts. Bramante also used the archivolt with outer rim for the arcone of the Canonica di S. Ambrogio and in both orders of the Doric cloister
Santa Maria, cupola / Santa Maria, dome
38
of S. Ambrogio. But the motif was also a favourite of Francesco di Giorgio Martini’s as well (S. Bernardino, Urbino and S. Maria delle Grazie al Calcinaio, Cortona). Perhaps the two architects liked it because it was often used in Roman antique architecture but also by Quattro-cento artists concerned with re-expressing antique forms, particularly Donatello in The Feast of Herod (Baptistery, Siena) and in the Christ before Pilate and Christ before Caiaphas in the S. Lorenzo pulpits in Florence. The shells in the niches in the Sacristy and transepts ap-pear, though the other way up, in the niche to the left of the Prevedari Engraving, and are probably derived from Piero della Francesca’s celebrated Brera Altarpiece which Bramante had studied intently. The circles enclosed by semicircular archivolts of the other ground-floor niches are also present in the Engraving, but perhaps derive from Donatello’s reliefs of The Speaking Child and The Heart of the Miser in Padua, which Bramante had almost certainly seen. An intense interest in appropriating motifs from antique sculpture for use in a Christian context is demonstrated in Fonduli’s beautiful reliefs in the sacristy. The meaning of the eight spectacular heads remains unexplained, but the presence of the music-making putti results from Psalm 150, which was inscribed on Luca Della Robbia’s Canto-ria for the Cathedral in Florence. In the upper storey one of the wire and stucco scenes in the balustrade includes two putti with a large vase, adapted from the fragment of the Throne of Ceres (?) (Museo Arcivescovile, Ravenna), and used by Donatello below his cantoria in Santa Maria del Fiore in Florence too. The scene of one putto spank-ing another derives from a celebrated sarcophagus type of which examples were then visible at Roma and Pisa. The nave of the church is characterised by two impor-tant large-scale features: the barrel vault, originally deco-rated with stucco coffers and rosettes, was presumably derived from that in the portico of S. Andrea in Mantua. The piers and pilasters are baseless; a form with many precedents, of which the closest in time were those in the crypt of S. Sebastiano at Mantua, which could also have
zione semicircolare, ma anche lunghi e bassi capitelli e la trabeazione. L’ordine maggiore della navata centrale im-piega invece una trabeazione completa con capitelli, una cornice senza dentelli, architravi a tre fasce digradanti e modanature a sezione semicircolare; poi, nella posizione più importante di tutte – ovvero sopra i due pilastri alla
Santa Maria, navata sinistra del transetto / Santa Maria, left-hand aisle of the transept
39
Santa Maria, navata laterale sinistra /Santa Maria, left-hand aisle of the nave
destra e alla sinistra dell’altare e nello stesso finto coro (oltre che nel blocco della cupola verso via del Falcone) – l’ordine è il medesimo rispetto alla navata, eccettuata l’aggiunta dei dentelli alla cornice.Gli angoli del transetto sono dotati di lesene piegate sulla parete in modo asimmetrico e i quattro angoli della nava-ta centrale recano invece lesene filiformi. Vi sono davvero pochissimi esempi di questi tipi di lesene nell’architettura del Quattrocento, dopo la loro comparsa nella Cappella Pazzi e nella Sacrestia Vecchia di San Lorenzo a Firenze di Filippo Brunelleschi, nell’albertiana cappella Rucellai in San Pancrazio a Firenze e nelle cappelle di San Fran-cesco a Rimini. Dovremmo quindi domandarci se questi elementi possano provare un’influenza diretta, o indiret-ta, su Bramante, di elementi dell’architettura fiorentina. Agli angoli della cappella Pazzi, Brunelleschi aveva co-struito una lesena completa, con sei scanalature, lungo l’asse longitudinale dell’edificio, accostata ad angolo retto con un segmento di lesena, con singola scanalatura, in corrispondenza del lato breve, ponendo un solo capitello stirato sopra di entrambi. Una soluzione simile è presen-te in Santa Maria, dove uno stretto segmento di lesena era necessario lungo le testate del transetto, per lasciare spazio sufficiente alle nicchie. L’architetto di Santa Maria ha così usato un’unica lesena piegata asimmetricamente sull’angolo, non una lesena completa accostata a un seg-mento di lesena come Brunelleschi, ma anche in questo caso entrambe le parti sono coronate da unico capitello. Dunque possiamo ritenere l’uso che fece Bramante di le-sene angolari e filiformi sostanzialmente identico a quello che ne fece Brunelleschi.L’ipotesi che Bramante sia stato a Firenze prima del 1482 non può essere dimostrata, salvo che questo doveva esse-re un viaggio ovvio per chi risiedeva a Urbino, tuttavia, se la comparsa di questi elementi in Santa Maria dipendesse realmente da una visita a Firenze, resterebbe da spiegare il motivo per cui nel 1483 in questo edificio compaiano dunque così pochi altri elementi inequivocabilmente de-rivati dal ricco repertorio decorativo delle architetture brunelleschiane.
supplied Bramante with the cross-vaults in the aisles. But Francesco di Giorgio’s plans for the Duomo at Urbino (now entirely transformed) were clearly impor-tant for Bramante when he designed S. Maria since the two structures share five characteristics, some more tell-ing than others: (1) in both, the piers of the major order
41
Bramante prese l’inconsueta e interessante decisione di aggiungere capitelli ai piedritti senza basi dell’ordine minore, i quali, nell’antico e nell’architettura del Quat-trocento, ricorrono comunemente dotati da sole cornici d’imposta. I capitelli dell’ordine minore di Santa Maria sono inoltre stirati orizzontalmente, una forma già usata a Milano per l’ingresso del cortile della Rocchetta del Ca-stello Sforzesco. Quasi tutti i particolari decorativi utiliz-zati nei capitelli trovano origine nella tradizione lombar-da: per esempio il putto che siede su un’anfora deriva da quelli dei portali di San Francesco a Piacenza di Guiniforte Solari e da alcuni dei peducci del chiostro piccolo della Certosa di Pavia. I capitelli bipartiti agli angoli dell’esterno del transetto includono delfini affrontati che si abbevera-no a un’anfora con al di sotto cornucopie. I grifoni che si voltano le spalle sono presenti nella tomba realizzata da Rosselli nella chiesa del Santo di Padova nel 1465 (ricor-rono inoltre nella tomba Della Torre in Santa Maria delle Grazie a Milano del 1484); capitelli bipartiti con scanala-ture e volute a “S” nella parte superiore e tre foglie se-parate nella parte inferiore, come gli esempi sulla via del Falcone, ricorrono molte volte prima della costruzione di Santa Maria, per esempio nella navata centrale della Cer-tosa di Pavia e nel Castello Sforzesco. Inoltre, in sostanza tutte queste forme sono presenti, anche se composte di-versamente, nella Cappella Colleoni di Bergamo degli anni Settanta del XV secolo. I capitelli bipartiti della sacrestia contemplano altri motivi dall’antico derivati da disegni di sculture e architetture romane: uno di questi è una variante del celebre capitello con teste equine del tempio di Marte Ultore; un altro esempio contiene una corazza recante al di sotto una variante del fregio con grifoni presente nel fregio del Tempio di Antonino e Faustina a Roma; vi è inoltre uno splendido capitello sulla facciata ovest del transetto, recante una corazza alata, con tre testine di putti impiegate come fregio sottostante, prese in prestito dalla Cappella Colleoni di Amadeo; un ulteriore esempio mostra un cra-nio di ariete con le volute a S che nascono dalle cavità degli occhi, già usato da Amadeo per una lesena della Certosa di Pavia e nella Cappella Colleoni.
are baseless; (2) at Urbino, the entablatures had archi-traves with two fascias (of varying design), as does the minor order of the nave of S. Maria, the minor order of the Sacristy and the exterior of S. Satiro; (3) they share depressed, not semicircular niches; (4) both have five-bay naves with barrel-vaults and aisles with vaults of semicir-cular section, although this characteristic may equally de-rive from the spectacular project for the Duomo of Ber-gamo by Filarete of the late 1450’s; and (5) both include extra-large pilasters with salient entablatures applied to the piers separating the nave and transepts. Obviously the general visual effect of Francesco di Gior-gio’s Duomo, austere, slim and spare, could not contrast more markedly with that of S. Maria, which is squat and heavily decorated; yet the two structures share so many other important characteristics that the conclusion that Bramante knew a great deal about the initial plans for Francesco’s church seems inevitable.The relative importance of the different areas of the church is expressed by a hierarchy in the elaboration of the orders, as in the Prevedari Engraving and the Canon-ica di S. Ambrogio. In the aisles, the entablature compris-es an architrave with one fascia, a frieze and cornice, but no capitals; the minor order of the nave has an architrave with two fascias separated by mouldings of semicircular section, but also long, low capitals and an entablature. The major order of the nave boasts a full entablature with capitals, a cornice without dentilation and three-stepped architraves with mouldings of semicircular section; and in the most important position of all – on the two piers to right and left of the altar and in the false choir itself (and on the via Falcone cupola block) – the order is the same except for the addition of dentilation to the cornices. The corners of the transepts are provided with pilasters folded unequally and the four corners of the nave are equipped with fillet pilasters. There are very few exam-ples of these types of pilaster in Quattrocento architec-ture after their occurrence in Brunelleschi’s Pazzi Chapel and Old Sacristy of S. Lorenzo, in Alberti’s Rucellai cha-pel in Florence and the chapels of S. Francesco at Rimini.
43
Sacrestia, planimetria /Sacristy, plan (Area Studio)
L’esternoSanta Maria contrasta apertamente con la Cappella Col-leoni di Bergamo, ovvero la maggiore impresa dell’archi-tettura lombarda degli anni Settanta del XV secolo, che Bramante dovette studiare nel 1477. La Cappella era la tomba di un condottiero, ornata con quindici diversi tipi di pietre e con la maggior quantità possibile di decora-zioni architettoniche e figurative. Il suo aspetto dipende da fattori totalmente diversi da quelli di Santa Maria, una chiesa parrocchiale, molto più modesta dal punto di vista estetico e finanziario e che non necessitava di tutta la pletora di elementi iconografici e figurativi presenti a Bergamo. Solo i plinti, le basi e i capitelli sono realizzati con pietra locale (serizzo), mentre le trabeazioni sono in terracotta. Il suo effetto non dipende solo dalla moltitudine e bel-lezza dei dettagli, eccettuati i capitelli, ma da un uso più coerente degli ordini architettonici rispetto alla Cappella Colleoni. L’architetto della chiesa di Villa di Castiglione Olona (anni Trenta del XV secolo) e Amadeo nella cap-pella Colleoni avevano usato lesene alte quanto l’intera struttura, ma senza un ordine minore, invece, la facciata su via del Falcone presenta un ordine maggiore e un or-dine minore usati insieme per la prima volta in una chiesa del Rinascimento lombardo. Bramante cercò di creare una perfetta rispondenza tra la struttura interna e gli ordini architettonici dell’esterno, anche se appare chiaro che in questo momento l’urbinate, come Amadeo, nutriva uno scarso interesse per certe altre caratteristiche degli ordini architettonici. In Santa Maria le paraste sono allungate o accorciate e i capitelli stirati lateralmente sui pilastri adia-centi secondo le esigenze della struttura; le basse paraste dell’ordine minore interno non hanno basi e sono dotate di lunghi e bassi capitelli; le paraste dell’ordine maggiore sono alte e strette e quelle dell’esterno sono ancora più alte; le proporzioni degli ordini, insomma, sono regolate dalle dimensioni della struttura alla quale sono applicati e non viceversa.Alcuni elementi sulla facciata verso via del Falcone sem-brano essere nuovi o molto differenti rispetto a quelli af-
Do they prove Bramante’s exposure, direct or indirect, to Florentine architecture? In the Pazzi Chapel Brunelleschi built a full pilaster with six flutes along the long axis of the building joined at right angles to a pilaster-segment with one flute along the short wall with one single capital stretched over both pilasters. A similar arrangement is used at S. Maria, where a short section of pilaster was re-quired by the need to leave space for the bays at the ends of the transepts. At S. Maria the architect used a single pilaster folded unequally in the corners, not a whole pi-laster next to a segment of a pilaster; but here too both pilaster segments are supplied with a single stretched capital. So Bramante’s use of corner pilasters and fillet pilasters is almost identical to those of Brunelleschi. The possibility that Bramante had been to Florence be-fore c. 1482 cannot be ruled out, since it would have been
44
Sacrestia, dettagli dell’ordine superiore /Sacristy, details of the upper order
fini già noti precedentemente nell’architettura lombarda. In primo luogo una struttura composta da un ampio bloc-co con pilastri angolari era già stata usata nella cappella Portinari e nella cappella Colleoni, sebbene il tiburio del-la prima sia a sedici lati e quello della seconda ottagonale. Santa Maria ha invece un tiburio circolare, per il quale il solo precedente lombardo è rappresentato da quello del-la chiesa di Villa di Castiglione Olona. In secondo luogo gli alti plinti impiegati nella facciata su via del Falcone sono molto semplificati rispetto a quelli iniziati da Ama-deo per la facciata della chiesa verso via Torino, oppure i suoi spettacolari plinti binati della cappella Colleoni, della Certosa di Pavia negli anni Settanta del XV seco-lo, o quelli del Duomo di Pavia o di Santa Maria delle Grazie negli anni Ottanta e Novanta. Il terzo elemento di novità può essere rappresentato dalla base continua che corre sotto le paraste. Amadeo aveva impiegato una base continua nella Cappella Colleoni, ma la base aveva pro-porzioni e forma differenti. Quarto elemento nuovo sono le paraste binate con lo spezzone di trabeazione piegata intorno agli spigoli del transetto. L’idea di collocare para-
an obvious trip to make from Urbino. But if the appear-ance of these elements at S. Maria does result from a visit to Florence, it remains perplexing that by 1483 there is so little other, unequivocal evidence here of exposure to the rich decorative vocabulary of Brunelleschi’s architecture. Bramante took the unusual and interesting decision to add capitals to the baseless, minor-order piers, which, in antique and Quattrocento architecture, were usually equipped only with impost mouldings. The minor-order capitals in S. Maria are stretched horizontally, a form al-ready used in Milan at the entrance to the Cortile of the Rocchetta of the Castello Sforzesco. Nearly all the deco-rative forms employed for the capitals originate in the Lombard tradition: eg. the baby sitting on an amphora derive from those on the doors of S. Francesco at Piacen-za by Guiniforte Solari and some of the corbels in the Small Cloister at the Certosa di Pavia. The bipartite capi-tals at the corner of the exterior of the transept include dolphins en face diving into an amphora; below them we find cornucopiae. The griffins imperiously ignoring each other had appeared spectacularly on the Rosselli Tomb
46
Santa Maria, prospetti ovest sul cortile / Santa Maria, west elevations on the courtyard (Area Studio)
ste binate da un lato e una parasta singola dall’altra parte dello spigolo è di origine fiorentina, presente nel rilievo di Ghiberti con L’incontro della Regina di Saba con il Re Sa-lomone della Porta del Paradiso e nella porta realizzata da Leon Battista Alberti per la chiesa di Santa Maria Novella a Firenze. L’arco romano di Pola presenta semicolonne binate agli angoli (non paraste) con basi correnti e tra-beazione sporgente: se questo fosse il modello di riferi-mento, il passaggio dalle semicolonne alle paraste e l’uso di paraste di ribattuta su un lato dell’edificio sembrano essere un’invenzione di Bramante. Infine, alcuni prece-denti si pongono come fonti per lo splendido timpano spezzato dei transetti, per esempio, quelli delle terme di Tito a Roma, o quello dell’Arco dei Leoni a Verona. È altrettanto probabile, comunque, che queste forme rap-
in the Santo at Padua in 1465 (they recur on the Della Torre Tomb in S. Maria delle Grazie of 1484); bipartite capitals with fluted S-volutes above and three separate leaves below, such as the large ones on the Via Falcone facade, occur many times before S. Maria, for example, in the nave of the Certosa di Pavia and in the Castello Sforzesco. Practically all these forms had been included in one way or another in the Colleoni Chapel in Bergamo of the 1470’s. The bipartite capitals of the Sacristy include other mo-tifs derived from drawings of Roman sculpture and ar-chitecture: one is an adaptation of the celebrated equine capitals of the Temple of Mars Ultor; another includes the cuirass found on ancient capitals with a version of the griffin frieze of the Temple of Antoninus and Faus-
47
tina in Rome below it: there is also a splendid capital on the west facade of the transept with a winged cuirass with three putto-heads used as a frieze below borrowed from Amadeo at the Colleoni Chapel; another presents a ram’s-skull with S-volutes growing through the eye-sock-ets, already used by Amadeo on a pilaster at the Certosa di Pavia and on the Colleoni Chapel.
The ExteriorS. Maria contrasts strongly with the Colleoni Chapel in Bergamo, the greatest achievement of Lombard archi-tecture of the 1470’s, which Bramante will have stud-ied in 1477. The Chapel was the tomb of a condottiere decorated with fifteen types of stone and the maximum amount of figurative and architectural decoration. Its im-pact depends on qualities entirely different from those of S. Maria, a parish church, which was much more modest aesthetically and financially and did not need the pletho-ra of figurative and iconographical decoration present in Bergamo. Only the plinths, bases and capitals are made of the local limestone [sarizzo]; the entablatures are terra-cotta. Its effect depends not on the density and beauty of the detail, apart from the capitals, but on a more coherent use of the orders than at the Colleoni Chapel. The archi-tect of the Chiesa di Villa at Castiglione Olona (1430’s) and Amadeo at the Colleoni Chapel had used pilasters extending the height of the whole structure but without a minor order; by contrast, the Via Falcone facade pres-ents major and minor orders used together for the first time on a Lombard Renaissance church. Bramante tried to ensure that the interior of the structure was reflected accurately by the exterior orders; equally though, it is clear that at this point Bramante, like Amadeo, had little interest in certain other characteristics of the orders. At S. Maria pilasters are elongated or shrunk and capitals stretched sideways over adjacent pilasters depending on the requirements of the structure; the low pilasters of the internal minor order have no bases and long, low capitals; the major order pilasters are tall and thin and those of the exterior are even taller: the proportions of the orders
presentino versioni su scala maggiore dei timpani spezzati preesistenti di San Satiro.Le principali caratteristiche di Santa Maria – le volte a botte, i pilastri senza basi, la cupola, gli ordini della fac-ciata su via del Falcone – furono inventati da Bramante dopo una attenta analisi degli sviluppi dell’architettura a Mantova e Urbino. Cosa potremmo allora dire degli altri elementi, soprattutto i capitelli di terracotta della navata maggiore e quelli di serizzo e le decorazioni in terracotta della facciata su via del Falcone?Agostino Fonduli, un esperto plasticatore e più tardi un architetto, lavorò con Bramante in Santa Maria, ma anche altri due esperti terracottai furono attivi nel cantiere della chiesa, Giovanni Battagio (suocero di Fonduli) e suo fra-tello Gabriele. La prima apparizione di Giovanni Batta-gio a Milano risale al dicembre del 1477, come testimone in un atto rogato nel palazzo di Gian Giacomo Trivulzio. Egli compare in Santa Maria come testimone in un con-tratto del maggio del 1483, nel quale Antonio Raimondi si impegnava a dipingere le volte del braccio destro del transetto, almeno in questa occasione egli dovette essere presente come esperto di terracotta e decoratore. Negli anni Novanta, inoltre, egli progettò la chiesa di Santa Ma-ria della Croce a Crema, che dimostra la sua conoscen-za delle opere di Alberti e dell’architettura mantovana. Quindi due architetti, Bramante e Giovanni Battagio, en-trambi influenzati da Alberti, sono documentati contem-poraneamente in Santa Maria presso San Satiro. È possibile che Battagio fosse stato chiamato ad affianca-re Bramante in Santa Maria presso San Satiro dal 1482 (al più tardi) o anche prima, precisamente in virtù della sua conoscenza degli sviluppi dell’architettura mantovana?In Santa Maria della Croce a Crema (1490-99) gli inte-ressi di Battagio sono per molti aspetti simili a quelli di Bramante. Entrambi gli architetti stavano riflettendo sulla riattualizzazione di forme paleocristiane: Bramante si era ispirato alla pianta e all’alzato della cappella di Sant’Aqui-lino in San Lorenzo a Milano per la sacrestia di San Sati-ro e le cappelle satelliti poste da Battagio a Santa Maria della Croce derivano da quella di Sant’Ippolito, sempre
48
a San Lorenzo. Santa Maria della Croce mostra inoltre con evidenza l’interesse di Battagio per Alberti, poiché all’interno della chiesa egli inserì un architrave a guilloche o treccia e copie delle tipologie di capitelli che si trovano all’interno della chiesa di Sant’Andrea di Alberti; anche per le basi delle colonne dell’interno egli usò un motivo a tessuto per i tori inferiori e rosette nelle scozie, che sono molto simili a quelle impiegate da Alberti per le basi del pronao di Sant’Andrea.In ogni caso sembra chiaro che Battagio e Bramante tras-sero elementi diversi da Alberti e che questo produsse quindi un effetto d’insieme molto differente nelle loro ar-chitetture, sebbene i materiali fossero gli stessi. Bramante derivò da Alberti elementi architettonici a grande scala, come le volte a botte con lacunari da Sant’Andrea e i pi-lastri senza basi e le volte a crociera dalla cripta di San Sebastiano o dal progetto di Filarete del Duomo di Berga-mo o dal Duomo di Urbino. A Crema Battagio impiegò, invece, elementi albertiani per lo più di piccole dimensio-ni, secondari e decorativi. In secondo luogo, osservando gli edifici di Battagio, e in particolare la loro cronologia, è chiaro che egli fu un vicinissimo seguace di Bramante e non viceversa: sia Santa Maria della Croce che la chiesa dell’Incoronata di Lodi (dal 1488) presentano cappelle la-terali con pareti smussate, derivate dal noto falso coro di Bramante, e la seconda presenta anche una serie di teste in terracotta entro clipei come quelli della Sacrestia di Santa Maria presso San Satiro; inoltre, Battagio intendeva usare le medesime teste nella cappella maggiore della chiesa di Santa Maria della Passione di Milano, progettata nel 1486, con una volta a botte cassettonata, e per il fregio in Santa Maria della Croce a Crema. Non sembra invece si possa-no individuare influenze di Battagio su Bramante. Que-ste considerazioni confermano che il ruolo predominante nella progettazione della navata centrale e delle navate la-terali di Santa Maria presso San Satiro dal 1482 in poi sia da assegnare a Bramante, piuttosto che a Battagio.Giacché Bramante fu un architetto progettista e non un plasticatore, cosa si può dire a proposito della decora-zione delle trabeazioni della facciata su via del Falcone
are governed by the dimensions of the structure to which they are applied and not the other way round. Bramante also follows the standard Lombard Renaissance practice of placing capitals of different design next to each other.A number of elements on the Via Falcone facade seem to be new or heavy variations on similar elements appearing in previous Lombard architecture. First: the large block with corner pilasters had already been used for the Porti-nari and Colleoni Chapels, though the tiburio of the for-mer is hexadecagonal and of the latter, octagonal. But the tiburio at S. Maria is circular for which the only Lombard precedent is the Chiesa di Villa at Castiglione Olona. Sec-ond: the tall plinth used on the via Falcone facade is very simplified compared to that begun by Amadeo on the Via Torino facade of the church or his spectacular double plinths at the Colleoni Chapel, the Certosa at Pavia in the 1470’s, or those at the Duomo of Pavia or S. Maria delle Grazie in the 1480’s and 1490’s. Third: the running attic base below the pilasters. Amadeo used a plinth and running base at the Colleoni Chapel, but the base was different scale and form. Fourth; the coupled pilasters with the break-outs in the entablature wrapped around the corners of the transepts. The idea of placing paired pilasters on one side of a corner and a single pilaster on the other side was Florentine, exempli-fied in Ghiberti’s relief of The Meeting of Salomon and Sheba on the Porta del Paradiso and on Alberti’s door of S. Maria Novella. The Roman Arch at Pola includes coupled half-columns (not pilasters) at the corners with running bases and a break-out in the entablature: if that is the source, the conversion of half-columns to pilasters and the superimposition of the pilasters on one side of the corner of the building seems to be an invention by Bramante. Finally; several precedents suggest themselves for the spectacular split tympanums of the transepts, for example, those at the Baths of Titus in Rome and else-where, or that of the Arco dei Leoni at Verona. It is just as likely, however, that these forms are grander versions of the pre-existing split-tympanums of S. Satiro. The major design features of S. Maria – the barrel vault,
49
Santa Maria, fronte su via Falcone: dettaglio / Santa Maria, front onto Via del Falcone: detail
e dei lacunari del finto coro, della navata maggiore e del transetto? Agostino Fonduli, il genero di Giovanni Batta-gio, fu plasticatore e più tardi un architetto, a dire il vero un po’ ingenuo. La sua prima comparsa milanese si deve al settembre del 1482, quando egli era già in società con Battagio; Fonduli è documentato per la prima volta nel 1483 come realizzatore del fregio della sacrestia e della navata centrale e del transetto di Santa Maria.Infine, sappiamo che Gabriele Battagio, fratello di Gio-vanni, era già a Milano nel novembre del 1476 ed è do-
the baseless piers, the cupola, the orders of the Via Fal-cone facade – were devised by Bramante after a careful consideration of developments at Mantua and Urbino. What then of the other elements, especially the terracotta capitals of the nave and the sarizzo capitals and terracotta decoration on the Via Falcone facade? Agostino Fonduli, a terracotta-expert and later, a design-ing architect, worked at S. Maria with Bramante; but two other terracotta-experts were active at the church as well, Giovanni Battagio (Fonduli’s father-in-law), and
50
Sezione trasversale delle coperture sulla navata /Cross section of the roofing of the nave
cumentato in Santa Maria tre volte: la prima volta come testimone nel contratto per l’acquisto di una proprietà con cortile di fronte alla chiesa, da demolire per la co-struzione (1482); la seconda volta come testimone in un contratto in cui il prete, Protasio Lonate, accettava di ce-lebrare messa nella chiesa (1483); infine nel febbraio e nel marzo del 1487, quando fu pagato per lavori non meglio specificati eseguiti nella chiesa. La presenza di Gabriele nel documento del 1482 suggerirebbe che egli possa aver
his brother Gabriele. Giovanni Battagio’s first known ap-pearance in Milan was in December 1477 as a witness in the palace of Gian Giacomo Trivulzio. He was present at S. Maria as a witness to the contract of May 1483 for An-tonio Raimondi to paint the vault of the right transept; at the minimum, then, he was present because he was a terracotta-expert and decorator. But in the 1490’s he also designed S. Maria della Croce at Crema, which dem-onstrates that he too had studied Alberti and Mantuan
51
avuto un ruolo di consulenza nella progettazione dell’edi-ficio, ma egli non è documentato altrove come architetto. Invece egli lavorò come plasticatore e lapicida nel cantie-re dell’ospedale di Lodi dal 1467 al 1475. Possiamo però individuare un suo ruolo specifico nella chiesa di Santa Maria da un successivo contratto datato 8 agosto 1500 in cui accettava di realizzare i lacunari in stucco della cupola di Santa Maria presso San Celso a Milano, con la supervi-sione di Gian Giacomo Dolcebuono. È quindi probabile che il suo compito in Santa Maria fosse quello di realiz-zare parte o anche la totalità dei lacunari della cupola, quelli del finto coro, della navata centrale e del transetto, insieme a suo fratello Giovanni e ad Agostino Fonduli.Dunque tre plasticatori, due dei quali anche architetti, sono documentati nel cantiere della chiesa. Sappiamo esattamente cosa abbia fatto Agostino Fonduli all’inter-no dell’edificio, e abbiamo dubitativamente assegnato un ruolo a Gabriele Battagio, ma possiamo andare oltre e identificare gli autori dei capitelli della chiesa e delle decorazioni in terracotta sulla trabeazione della facciata verso via del Falcone? Rispetto alla trabeazione, ma non ai capitelli, della faccia-ta su via del Falcone, si potrebbe avere il sospetto, sen-za possibilità di prove, che siano stati i fratelli Battagio e Fonduli ad aver disegnato e realizzato le modanature in terracotta, probabilmente sulla base di indicazioni di-mensionali fornite da Bramante. Il motivo più rilevante per questa ipotesi risiede nel fatto che questo tipo di de-corazioni non ricorrono altrove nelle opere documentate di Bramante, mentre al contrario, esse compaiono più tardi nelle architetture di Agostino Fonduli a Crema e Castelleone ad infinitum. Bramante fu l’architetto che se-guì il cantiere della canonica di Sant’Ambrogio, dove le decorazioni delle trabeazioni non hanno nulla in comune con quelle di San Satiro. Se l’ipotesi che Fonduli abbia disegnato e realizzato questi elementi in Santa Maria fosse vera, ne consegue che l’uso di dettagli provenienti dall’ar-chitettura antica veronese (per esempio l’uso di scana-lature nelle fasce degli architravi tratto da monumenti romani di Verona) e altri motivi all’antica presenti nella
architecture. So two architects, Bramante and Giovanni Battagio, both influenced by Alberti, are documented si-multaneously at S. Maria presso S. Satiro. Is it possible that Battagio was commissioned to work with Bramante at S. Maria presso S. Satiro from 1482 (at the latest) or before precisely because of his knowledge of develop-ments in Mantua? At S. Maria della Croce (1490-99), Battagio’s interests are certainly similar in some respects to Bramante’s. Both architects were concerned with the modernisation of early Christian forms: Bramante took over the plan and elevation of S. Aquilino at S. Lorenzo for the Sacristy of S. Satiro and similarly Battagio’s satellite chapels at S. Maria della Croce derive from the plan of S. Ippolito at S. Lorenzo. S. Maria della Croce also provides evidence of Battagio’s interest in Alberti; inside the church he re-produces the guilloche pattern or treccia and copies a capital type from the interior of Alberti’s S. Andrea, and for the bases of the columns inside used a woven pattern for the lower toruses and rosettes in the scotias which are very similar to those used by Alberti for the bases of the portico of S. Andrea. However, it is equally clear that Battagio and Bramante took different things from Alberti and therefore pro-duced very different overall effects in their architecture, although the materials are the same. Bramante took the large architectural elements such as the barrel-vaults with coffers from S. Andrea and the baseless piers and cross-vaults from the crypt of S. Sebastiano, or from Fi-larete’s project for the Duomo at Bergamo or the Duomo di Urbino. At Crema, Battagio took the relatively small incidental, decorative elements. Second, observing Battagio’s build-ings and particularly their dating, it is clear that he was a close follower of Bramante rather than vice-versa: both S. Maria della Croce and the Incoronata at Lodi (1488-) include chamfered side-chapels derived from Bramante’s famous false choir and the latter has series of terracotta heads in roundels like those in Bramante’s Sacristy: and Battagio intended to use such heads in the cappella mag-
52
Sacrestia, tiburio / Sacristy, tiburio
trabeazione su via del Falcone, sia forse da assegnare a lui piuttosto che a Bramante.
ConclusioniNon esiste alcun elemento decisivo che provi o dinieghi la paternità di Bramante, con o senza la collaborazione di Giovanni Battagio, del progetto della chiesa tra il 1478 e il 1481-82. Che il primo progetto prevedesse una strut-
giore of S. Maria della Passione in Milan projected in 1486, along with a barrel vault and coffers, and for the frieze in S. Maria della Croce. There seems to be no evi-dence of influence going from Battagio to Bramante. All this confirms that the predominating role in the design of the nave and aisles of S. Maria presso S. Satiro from 1482 was played by Bramante rather than Battagio.Since Bramante was a designer and not a terracotta ex-pert, what of the decoration of the entablatures of the Via Falcone facade, and the coffering of the finto coro, nave and transepts?Agostino Fonduli, Giovanni Battagio’s son-in-law, was a terracotta expert and later a somewhat naive designing architect. His first known appearance in Milan was in September 1482 when he was in business with Battagio; he is first recorded in 1483 as the executor of the friezes of the Sacristy and of the nave and transepts of S. Maria. We now know that Gabriele Battagio, Giovanni’s broth-er, was in Milan in November 1476 and is documented at S. Maria three times: as a witness for the acquisition of property for demolition for the construction of a courtyard in front of the church (1482), as a witness to a contract in which a priest, Protasio Lonate, agreed to celebrate masses in the church (1483): in February and March 1487 when he was paid for unspecified work at the church. The presence of Gabriele in the document of 1482 suggests that he had some advisory role in the plan-ning of the church but he is not recorded elsewhere as a designing architect. Instead he had worked as a terra-cotta expert or stonecutter at the Hospital in Lodi from 1467 until 1475. We can, however, suggest a specific role for him at S. Maria: according to a contract of 8 August 1500 he agreed to make the stucco coffers for the cupola of S. Maria presso S. Celso under the supervision of Dol-cebuono. Perhaps therefore his task at S. Maria was to make some or all of the coffers of the cupola, the finto coro and the nave and transepts at S. Maria in Milan, along with his brother Giovanni and Agostino Fonduli.Three terracotta experts, two of whom became design-ing architects, are documented at the church. We know
53
Sacrestia, tiburio: dettaglio delle aperture / Sacristy, tiburio: detail of the openings
tura simile alla Cappella Portinari sembra essere oggi inaccettabile, il problema è dunque capire quale fosse la forma originaria della cupola, del blocco sotto di essa e dell’attuale transetto. La chiesa che oggi vediamo, esclusa la facciata, fu terminata, almeno nella struttura, e in par-te decorata dalla fine del 1483. Bramante fu il progettista e supervisore del cantiere e questo spiega i riferimenti a Sant’Andrea di Mantova e alle opere di Francesco di Giorgio a Urbino, sia per un certo numero di elementi architettonici a grande scala, sia per alcuni a scala mi-nore. La presenza di almeno due elementi rilevanti di origine brunelleschiana non sembra alterare l’immagine di Bramante come architetto prevalentemente influen-zato dall’architettura urbinate e mantovana degli anni Settanta del XV secolo. Disegni esecutivi di Bramante possono aver previsto gli spazi per i capitelli (come nella canonica di Sant’Ambrogio) e per i lavori seriali in ter-racotta, ma egli può non averli disegnati personalmente nel dettaglio. I fratelli Battagio si trovavano a Milano nel 1476-77 e Fonduli al più tardi dal 1482. Gabriele Battagio e Fonduli erano esperti plasticatori, e il primo può aver realizzato il finto coro e i lacunari della cupo-la, mentre il secondo, certamente, realizzò il fregio della sacrestia e quello della navata maggiore e del transetto; essi possono aver inoltre condiviso il lavoro sull’esterno verso via del Falcone. A ogni modo Fonduli ripeté alcuni degli elementi decorativi presenti nella chiesa, eccettuati i capitelli, una moltitudine di volte nelle sue più tarde opere a Crema e altrove. Il ruolo di Giovanni Battagio è più difficile da definire; la sua carriera successiva di architetto dimostra una grande dipendenza da Bramante per quanto concerne le forme architettoniche maggiori e un atteggiamento completamente diverso rispetto ad Alberti; ma al di là di questo, tutto resta ancora oscuro. In ogni caso, la maggior parte delle varietà di capitel-li esistenti nella navata centrale e nelle navate laterali e all’esterno dell’edificio restano molto lombardi e poiché questi non ricorrono nelle opere successive di Battagio e Fonduli, questo fatto dovrebbe indicare la presenza di altri maestri.
exactly what Agostino Fonduli did in the interior and we have tentatively allocated a role to Gabriele Battagio. But can we go further and identify the authors of the capitals of the church and of the terracotta entablatures of the Via Falcone façade? With respect to the entablatures, but not the capitals, of the Via Falcone facade, one suspects, but can never prove, that it was indeed the Battagios and Fonduli who designed as well as executed the terracotta mouldings having received instructions about the dimen-sions from Bramante. The strongest reason for this sup-position is that such decoration never recurs in Braman-te’s documented works whereas, by contrast, it appears later in Fonduli’s architecture at Crema and Castelleone ad infinitum. Bramante was the supervising architect at the Canonica of S. Ambrogio where the decoration of the entablatures has nothing in common with that at S. Sat-iro. If the hypothesis that Fonduli designed and executed these elements at S. Maria is true, it may follow that the use of details from Veronese antique architecture (eg. the use of fluting in the fascias of the architraves taken from Roman antiquities in Verona) and other all’antica motifs on the Via Falcone entablatures was due to him rather than to Bramante.
54
San SatiroL’antica cappella di San Satiro subì due radicali trasfor-mazioni nel corso della sua lunga storia: la prima nella se-conda metà del XV secolo e la seconda negli anni Trenta del XX secolo, da parte di Gino Chierici.La cappella originaria si presentava esternamente polilo-bata; l’interno formava un quadrato con ciascuno dei lati dotato di un’ampia nicchia semicircolare e avente due pic-cole nicchie a ognuno degli angoli del quadrato; quattro colonne supportavano la parte superiore della struttura, della quale resta discussa la forma originaria. La struttu-ra primitiva fu però ampiamente alterata. Le nicchie più piccole furono tamponate per lasciare all’interno dell’edi-ficio un quadrato regolare, con tre nicchie semicircolari, ovvero un triconco; inoltre, fu costruito un fregio cor-rispondente a quello dell’ordine minore di Santa Maria lungo tutto il perimetro interno. Non compaiono tracce nel corso del XVIII e XIX secolo di un intervento di re-stauro che possa aver determinato questi cambiamenti e l’ipotesi più semplice resta quella che ne sia responsabile l’architetto che si occupò anche della ricostruzione di San Satiro nel Quattrocento.Negli anni Trenta del Novecento Chierici, per ricostru-ire quello che si credeva fosse l’edificio nel suo stato pre-quattrocentesco, rimosse il fregio e il tamponamento delle nicchie interne e ricostruì l’ingresso, cosicché esso oggi tange obliquamente il transetto della chiesa di Santa Maria.Cosa sappiamo dunque delle trasformazioni quattrocen-tesche del sacello di San Satiro? Nel tardo Quattrocen-to l’esterno della cappella fu reso circolare e dotato di quattro nicchie semicircolari lungo la superficie esterna, mentre una quinta nicchia fu aggiunta quando nel XIX secolo furono rimosse le costruzioni intorno alla cappel-la. Le basi, i capitelli e le paraste, le nicchie e i pannelli rettangolari sottostanti, e le teste di putti del fregio, che si trovano all’esterno del sacello, sembrano essere stati sosti-tuiti integralmente nel corso degli interventi di restauro. È noto che i capitelli dell’ordine del pian terreno siano ri-produzioni di quelli degli anni Ottanta o Novanta del XV
ConclusionsNothing decisively proves or disproves the proposition that Bramante, with or without the Battagio’s assistance, was the architect of the church from 1478 to 1481/2. That the first plan involved a structure like the Portinari Chapel seems to be inadmissable; rather the problem is what the original forms of the cupola, the block below it and the transepts were. The present church, apart from the facade, was com-plete, in terms of structure and some decoration, by the end of 1483. Bramante was the supervising designer and his points of reference were S. Andrea in Mantua and Francesco di Giorgio’s work in Urbino for a number of the large-scale architectural elements and some of the small ones too. The presence of at least two elements of Brunelleschian origin seems not to alter the characterisa-tion offered above of Bramante as an architect influenced predominantly by Urbinate and Mantuan architecture of the 1470’s. Bramante’s technical drawings must have al-located spaces for the capitals (as at the canonica of S. Ambrogio) and for the serial terracotta work, but he may not have designed them personally. The Battagios were in Milan in 1476-77 and Fonduli by 1482 at the latest. Gabriele Battagio and Fonduli were terracotta experts, and the former may have made the finto coro and coffers of the cupola, the latter certainly made the friezes of the Sacristy and of the nave and tran-septs; they may have shared the work on the Via Falcone exterior as well. At any rate, Fonduli repeats some of the decorative elements found in the church, apart from the capitals, again and again in his later work in Crema and elsewhere. Giovanni Battagio’s role is more difficult still to assess; his later career as an architect demonstrates great depen-dence on Bramante for major forms and a very different attitude towards Alberti; but beyond this all is obscure. However, the mass of varied capitals in the nave, aisles and exterior remains stoutly Lombard and, since they do not recur in Battagio or Fonduli’s later architecture, indi-cate the presence of different workmen.
55
secolo, ma la loro fedeltà di dettaglio agli originali non è certa. In ogni caso non sembrano esserci motivi esclusivi per dubitare che questi elementi ricalchino pressapoco le decorazioni originarie: mentre essi potrebbero essere stati variati nei dettagli per assecondare mutamenti del gusto, non vi sono evidenze che li individuino come invenzioni integrali del XVIII o XIX secolo, aggiunte alla struttura tardo-quattrocentesca.Qualche indicazione in merito può venire dai disegni di Leonardo dei tardi anni Ottanta del Quattrocento: nel-la nota pianta contenuta nel manoscritto B, f. 19r e nel Codice Ashburnham 2037, f. 5v, egli aveva disegnato una serie di cappelle satellite triconche come San Satiro. L’esterno del secondo disegno presenta dei rettangoli al di sotto delle nicchie (ma separate da semicolonne) come quelle costruite in San Satiro negli anni Ottanta del XV secolo. Entrambi i disegni di Leonardo recano una pianta affine a San Satiro, un semplice quadrato con tre nicchie semicircolari, ovvero senza le nicchie interne piccole agli angoli che connotavano la planimetria originaria del sa-cello. Questa potrebbe essere una prova indiretta che a San Satiro il tamponamento delle nicchie interne e la co-struzione delle nicchie esterne, separate da paraste (e ipo-teticamente la collocazione del fregio interno), possono essere avvenuti nei tardi anni Ottanta del Quattrocento.La singolare struttura superiore della cappella presenta quattro timpani spezzati e un tiburio ottagonale impo-stato su un blocco quadrato. Tutti i capitelli del tiburio hanno volute a “S”, alte foglie angolari e abaco conca-vo e sembrano potersi credere originari del XV secolo o comunque riproduzioni fedeli; alcuni dei capitelli quat-trocenteschi e la decorazione dipinta della cappella fu registrata da Enrico Strada nel 1887. La strana trabea-zione del tiburio contempla elementi che possono essere rintracciati nell’architrave del tiburio di Santa Maria. La parte sommitale del fregio comprende una fascia a den-telli, utilizzata anche sull’esterno di Santa Maria per la trabeazione dell’ordine maggiore; mentre nella cornice sono state poste semplici mensole. Stranamente la lanter-na diminuisce di diametro dalla base alla trabeazione, nel-
S. Satiro The ancient chapel of S. Satiro was drastically transformed twice during its long history: in the second half of the Quattrocento and during the 1930’s by Gino Chierici. The original chapel was polilobate outside; the interior formed a square with each side supplied with a large semircular niche and each of the corners of the square with two small niches; four columns supported the su-perstructure, of which the original configuration is much disputed.But the original configuration was drastically altered. The smaller niches were filled in leaving the interior as a square with three semicircular lobes, a triconch; a frieze matching that of the minor order of S. Maria was built around the interior. There is apparently no record in the 18th or 19th century of a restoration that could have pro-duced these changes and the most economic hypothesis is that the architect who reconstructed S. Satiro in the Quattrocento was responsible for them. In the 1930’s Chierici removed the frieze and rubble fill-ing the minor niches and reconstructed the passageway so that it now meets the transept of S. Maria at a more oblique angle in order to return the building to what he believed was its pre-Quattrocento state.What do we know of the Renaissance transformations of S. Satiro? In the late Quattrocento, the exterior of the chapel was made circular and supplied with four semicir-cular niches in the outer wall surface, a fifth being added in the 19th century when buildings around the chapel were removed. On the exterior, the bases, capitals and pilasters, the niches and rectangular panels below, and the putto heads in the frieze all seem to have been re-stored or replaced at one time or another. The capitals of the ground-floor storey are known to be replacements of originals from the 1480’s or 1490’s and their fidelity to the originals is not certain in all respects. Yet there seems to be no compelling reason to doubt that in their present state these elements represent, grosso modo, the original decoration: while they may have been altered in detail to suit later tastes, there seems no reason to think they are
56
la quale si trova a una curiosa fascia inclinata tra i dentelli e la cornice.L’architettura dei timpani sotto il tiburio è piuttosto par-ticolare, poiché non vi è alcun tentativo di uso di ordini, ma solo la presenza di pilastri lisci sormontati da timpani spezzati. Le modanature in terracotta, comunque, com-prendenti una gola decorata a foglie più ampia, posta sopra una più piccola, trovano repliche nella facciata su via del Falcone di Santa Maria. Il fatto che le modanatu-re in terracotta del tiburio e dei timpani abbiano esempi affini in quelle della chiesa maggiore può significare una contemporaneità di esecuzione, oppure che gli architetti della chiesa maggiore abbiano adattato alcuni dettagli a quelli della chiesa piccola, oppure ancora che questi ele-menti provengano tutti dalla medesima tradizione deco-rativa. Le caratteristiche architettoniche della struttura superiore del sacello non consentono tuttavia di ipotizza-re la presenza di un architetto in particolare.La storia si complica con un documento del 27 novembre del 1458 che sembra dimostrare che la parte superiore del sacello era già stata ricostruita prima della parte infe-riore esterna, e che le motivazioni della ricostruzione di San Satiro nel tardo quattrocento furono sia strutturali che estetiche. Il documento segnala che un certo Mirono Girani aveva lasciato una quantità di denaro alla chiesa di San Satiro nelle sue volontà testamentarie del 1404, specificamente dedicata alla riparazione della cupola (tro-num). Nel 1458 le autorità avevano finalmente ricevuto il denaro, per un ammontare di 80 lire, corrispondenti agli 11.000 mattoni consegnati alla chiesa di San Satiro: i mat-toni avrebbero dovuto essere impiegati nella riparazione del tronum e delle volte. Sembra chiaro che i problemi strutturali al tronum, emersi già nel 1404, dovevano es-sere relativamente banali, dal momento che essi furono trascurati per mezzo secolo. I mattoni erano già stati con-segnati alla chiesa nel novembre del 1458, pertanto i lavo-ri al tronum e alle volte iniziarono probabilmente subito dopo. Il numero totale dei mattoni – 11.000 – certamente impone di pensare a una ricostruzione della struttura, più che a una semplice riparazione, e la precisione nel segna-
complete inventions of the 18th or 19th century added to the late Quattrocento structure. Leonardo’s drawings from the later 1480’s may help at this point. On several occasions he drew ground-plans similar to that of S. Satiro: in the celebrated plans on MS. B 19r and Cod. Ashburnham 2037, fol. 5v, he includes a series of peripheral triconch chapels like S. Satiro. The exterior of the latter includes rectangles below niches (but sepa-rated by half-columns) like those built at S. Satiro when it was altered in the 1480’s. And in both drawings Leonardo expresses the plan of S. Satiro as a simple square with three semicircular niches, omitting the minor recesses characterising the original plan. This may indicate that at S. Satiro the filling-in of the minor niches and the con-struction of the exterior niches divided by pilasters (and possibly the application of the internal frieze) did take place in the later 1480’s.The strange superstructure of the chapel includes four split tympanums and an octagonal tiburio standing on a square block. All the capitals of the tiburio have S-vo-lutes, tall corner leaves and concave abacuses, and seem credible as 15th century work or accurate replacements thereof; some of the Quattrocento capitals and painted decoration were recorded by Enrico Strada in 1887. The strange entablature of the tiburio does include elements that can be found on the architrave of the tiburio of S. Maria. The top of the frieze includes a row of dentils, also used on the exterior of S. Maria in the major order entab-lature; simple brackets have been placed in the cornice. Strangely the lantern diminishes in diameter from base to entablature and there is a curious inclined fascia between the dentils and cornice. The architecture of the gables below the tiburio is some-what different because there is no attempt to use an order, only plain pilasters surmounted by split tympanums. The terracotta mouldings, however, comprising a large foliate gola above a small foliate gola, are repeated on the Via Falcone facade of S. Maria. The fact that the terracotta mouldings in the tiburio and gables have counterparts on the main church could imply simultaneity of execution
57
G. Levati e G. Moretti, Progetto di restauro, 1884 /G. Levati and G. Moretti, Restoration Project, 1884
lare il numero dei pezzi lascia sospettare che un lapici-da o un ingegnere avesse esaminato l’edificio e che fosse stato sviluppato un progetto per la cupola già prima del 1458. Sfortunatamente la parola tronum è generica e non consente di formulare ipotesi sulla forma specifica della struttura, ma, nonostante sia arduo immaginare l’aspet-to di questa costruzione da realizzarsi con 11.000 matto-ni, ci si può domandare se la parte superiore del sacello ora visibile, con il tiburio, possa essere stata ricostruita
or that the architects of the main church adapted some of the forms from the small church, or rather that they were all working within the same tradition of decoration. The character of the architecture of the superstructure is not such as to suggest an attribution to any particular architect. The story is made all the more bizarre by a document of 27 November 1458 that apparently shows that the up-per storey of the chapel was reconstructed before the
59
interamente subito dopo il 1458. Se una parte o anche tutti gli 11.000 mattoni fossero stati posti in opera in un tempo immediatamente successivo al 1458, il risultato dovette essere chiaramente non soddisfacente, poiché nel 1476 i parrocchiani erano nuovamente preoccupati per un eventuale imminente pericolo di crollo della chiesa e degli alloggi del presbitero. È probabile che il peso della nuova struttura di San Satiro, costruita dopo il 1458, fos-se eccessivo rispetto al sacello originario sottostante, con le sue quattro colonne, o forse dovremmo immaginare che i mattoni documentati nel 1458 non siano stati usati immediatamente, o che il lavoro non fosse stato concluso, cosicché la chiesa si trovava ancora a rischio di crollo nel 1476. È possibile comunque che la nuova struttura supe-riore del sacello fosse stata progettata e iniziata nel 1458 e poi solamente conclusa dopo il 1476.Almeno un punto sembra certo: la ricostruzione del tibu-rio oggi esistente e delle volte di San Satiro – qualunque essi fossero – erano conclusi nell’agosto del 1483. A par-tire da questa data, infatti, quattro pittori presero l’inca-rico di dipingere sia il tiburio di San Satiro che quello di Santa Maria, sia all’interno che all’esterno. Due contratti, inoltre, ci segnalano che nel marzo del 1483 si richiese ad Agostino Fonduli il completamento del sepulchrum (il noto Compianto) e della nicchia che avrebbe dovuto acco-glierlo all’interno del sacello; sappiamo poi che il gruppo si trovava già in posizione nel 1483 e che sia il Compianto stesso che la volta superiore erano stati dipinti da Antonio Raimondi entro il Natale del 1491.Il fatto che già dall’agosto del 1483 il tiburio di San Sa-tiro doveva essere dipinto all’interno e all’esterno e che il complesso e delicato gruppo di terracotta di Fonduli fosse già stato posto nella cappella nello stesso anno, e che il Compianto e la nicchia in cui è allocato erano pronti per essere dipinti nel 1491 certamente significa che non erano previsti lavori strutturali alle volte o alla cupola tra il marzo del 1483 e il 1491.Se è vero che nel tardo Quattrocento furono tamponate le piccole nicchie interne e fu inserito il fregio continuo all’interno di San Satiro, allora forse questi lavori possono
ground-floor exterior and that the reasons for the trans-formation of S. Satiro in the later Quattrocento were as much structural as aesthetic. The document tells us that a certain Mirono Girani had left money to the church in his will of 1404 specifically for the repair of the cupola (tro-num). Now, in 1458, the authorities had finally received the money, described as the «80 lire, that is the 11,000 bricks delivered to the church of S. Satiro»: the bricks were to be used to repair (reparare) the tronum and vaults. Clearly the structural problems with the tronum that had emerged as early as 1404 were relatively trivial since they were left unrepaired for over half-a-century. The bricks had been delivered to the church in Novem-ber 1458 so presumably work on both the tronum and vaults ensued soon afterwards. The sheer number of bricks – 11.000 – surely implies that reconstruction rather than repair was to be undertaken and the mention of a specific number of bricks tells us that a lapicida or engi-neer had examined the building and that a design for the cupola had been developed before 1458. Unfortunately the word tronum is generic and provides no information about the structure envisaged and, although we cannot imagine what type structure could be built with 11,000 bricks, one wonders whether the whole of the present su-perstructure with the tiburio, inside and out, was rebuilt soon after November 1458.If they did make use of some or all of the 11,000 bricks immediately after 1458, then the work was clearly unsat-isfactory, for in 1476 the parishioners were again worried that the church and lodgings of the priest would collapse. Perhaps the weight of the new superstructure of S. Satiro built after 1458 proved too heavy for the original sub-structure with its four columns. Or perhaps the bricks documented in 1458 were not, in fact, used immediately, or the work was not finished, and that was why the church was still in danger of collapse in 1476. It may be, there-fore, that the new superstructure was designed and begun in 1458, but only concluded at some time after 1476. One thing is certain: the reconstruction of the existing tiburio and vaults of S. Satiro – whatever it was – was
60
essere stati anch’essi completati dal 1483. Non possiamo però accertare quest’ultimo punto, poiché il tampona-mento delle nicchie e l’inserimento di un fregio in stucco con i capitelli dovevano essere attività fisicamente possi-bile anche con il gruppo in terracotta di Fonduli già stato collocato nella cappella. Dunque, il fatto che a Fonduli fosse richiesta la conclusione del Compianto e della sua nicchia nel 1483 e che essi furono dipinti al più tardi nel 1491, forse può indicare che proprio in periodo si attuò la realizzazione di tutta la decorazione interna del sacello.Bramante è documentato come consulente nei contratti di Fonduli del 1483 e del 1491 e probabilmente la sua presenza è spiegabile con la necessità di accertarsi che la decorazione architettonica della nicchia per il Compianto di Fonduli fosse soddisfacente, piuttosto che pensare a un suo parere sul gruppo scultoreo. La presenza del suo nome nei documenti del Compianto costituisce la prima attestazione di un architetto impegnato nel cantiere di San Satiro nel tardo Quattrocento. Ovviamente se la struttura superiore del sacello fosse stata ricostruita nella sua for-ma attuale tra i tardi anni Cinquanta del XV secolo e gli anni Settanta, Bramante non potrebbe aver preso parte a questa fase dei lavori, e ugualmente, se la ricostruzione fosse stata anche solo completata dopo il 1476 e prima del 1483, parrebbe molto difficile ipotizzare un coinvolgi-mento di Bramante, posto che il progetto per la struttura superiore sia stato sviluppato nel 1458, o prima di questa data, e che, in ogni caso, l’architettura del tiburio sembra avere davvero poco in comune con la sua.Dal marzo del 1483, al più tardi, la ricostruzione della struttura superiore di San Satiro sembra essere conclusa, ma cosa possiamo invece dire della ricostruzione del pri-mo livello esterno? La decisione di aggiungere la navata centrale e le navate laterali alla chiesa di Santa Maria era stata presa prima della fine dell’anno 1482 e il transetto sinistro a ridosso di San Satiro già completato dal mar-zo del 1483. All’inizio del 1483 dunque dovrebbe essersi presentato il problema fondamentale di connettere le due strutture tra loro, costruendo un passaggio, ma anche di assicurare la stabilità di San Satiro inglobandolo nell’at-
finished by August 1483. By that date four painters had painted the tiburios of both S. Satiro and S. Maria inside and out. And two contracts tell us that in March 1483 Ag-ostino Fonduli was required to finish his sepulchrum (the celebrated Lamentation) and the niche which contained it in S. Satiro; we are told that the group was already in position in 1483 and that both it and its vault were to be painted by Antonio Raimondi by Christmas 1491. The fact that by August 1483 the tiburio of S. Satiro had been painted inside and outside and that Fonduli’s elabo-rate, fragile terracotta group was in position in the chapel in 1483 and that both it and its alcove were only ready to be painted in 1491 surely means that no major structural work was being carried out on the vaults or cupola be-tween March 1483 and 1491.If it is true that the smaller interior niches were filled-in and a continuous frieze constructed in the interior of S. Satiro in the late Quattrocento, then perhaps that opera-tion too was complete by 1483. But it is not easy to be cer-tain about this point because inserting a frieze of stucco with capitals and filling in niches may have been physi-cally possible even during the time when Fonduli’s group was in position in the chapel from 1483. Indeed the fact that Fonduli was required to complete his Lamentation and its niche in 1483 but that they were, in fact, painted as late as 1491 perhaps suggests that it was exactly dur-ing the period 1483-91 that the interior decor was being prepared. Bramante was recorded as an expert advisor in the Fon-duli contracts of 1483 and 1491 and perhaps that was because he had to ensure that the architectural decora-tion of the niche for Fonduli’s Lamentation was satisfac-tory rather than because of any expertise in sculpture. The occurrence of his name in the documents about the Lamentation are the first mentions that we have of any designing architect being involved in the work at S. Satiro in the late Quattrocento. Obviously, if the superstructure was indeed rebuilt in its present form between the late 1450’s and the 1470’s then Bramante took no part in that process: but equally, if the reconstruction was completed
62
San Satiro, tiburio: dettaglio della decorazione /San Satiro, tiburio: detail of the decoration
tuale perimetro murario circolare, che maschera inoltre l’angolo in cui il passaggio tra i due edifici aderisce al transetto di Santa Maria. Queste considerazioni sembra-no suggerire che l’esterno del piano terreno del sacello sia stato realizzato dopo il 1483.Nel 1485 G.A. Visconti lasciò una somma di denaro da usarsi per la costruzione di San Satiro; inoltre, un docu-mento del 1491 indica che il maestro Domenico da Ro-sate era impegnato nella costruzione della chiesa – pre-sumibilmente intendendo l’esterno – e che esistevano pietre tagliate accanto a essa. In un momento imprecisato tra il 1490 e il 1504 Bartolomeo della Valle, uno dei più attivi ingegneri del Comune, eseguì una stima dei lavori eseguiti: la decorazione della cappella era costata 2200 ducati, ridotti di 200 grazie all’impiego di materiali, pro-babilmente mattoni, recuperati dalla struttura preesisten-te. Il costo fu dieci volte superiore di quello speso per l’acquisto dei mattoni per la struttura superiore della cap-pella nel 1458 e meno della metà di quello anticipato ad Amadeo nel 1486 per l’intero lavoro alla facciata di Santa Maria verso via Torino, dunque, sembra difficile immagi-nare che la somma possa essere servita per costruire altro rispetto all’imponente nuovo muro circolare attorno alla vecchia cappella e per dotarlo di basi, trabeazioni, nicchie e paraste.Il tiburio e i timpani spezzati di San Satiro condividono motivi in terracotta con Santa Maria e i tipi di capitelli risalgono plausibilmente al tardo Quattrocento, tuttavia nessuna di queste forme architettoniche suggerisce ine-quivocabilmente il nome di Bramante piuttosto che quel-lo di qualsiasi altro progettista lombardo. Questa consi-derazione, sommata all’apparente datazione del progetto del coronamento di San Satiro e della sua costruzione a un momento compreso tra il 1458 e il 1483, al più tar-di, sembra precludere la possibilità di un intervento di Bramante. La parte bassa dell’esterno, tuttavia, proba-bilmente costruita dopo il 1483, comprende un blocco circolare, posto su basamento, con paraste che affiancano nicchie a sezione semicircolare molto distanziate tra loro. Bramante sembra essere stato responsabile del progetto
after 1476 and before 1483, it seems highly unlikely that Bramante could have been involved given the fact that the design of the superstructure must have been evolved in or before 1458 and that in any case, the architecture of the tiburio seems to have very little in common with his. By March 1483 at the latest, then, the reconstruction of the superstructure of S. Satiro seems to have been com-pleted. What then of the reconstruction of the ground-floor exterior? The decision to add the nave and aisles to S. Maria had been taken well before the end of 1482 and the left transept looming over S. Satiro was complete by March 1483. In early 1483, therefore, it would have be-come essential to connect the two structures by building a corridor between them but also to ensure the stability of S. Satiro by encasing it in its present, circular wall-mass, which also conceals the angle at which the corridor joins the transept of S. Maria. All told, this suggests that the exterior ground-floor was rebuilt after 1483. In 1485 G.A. Visconti left money to be used for ‘building, constructing or organising’ S. Satiro; a document of 1491 tells us that the stone-mason Domenico da Rosate was
63
di questa parte della chiesa. I capitelli attuali potrebbero essere plausibili riproduzioni degli originali, anche se non necessariamente accurate nei dettagli. L’architrave ha due fasce, quella superiore più alta di quella inferiore e non vi sono elementi decorativi tra le due fasce. Architravi si-mili compaiono all’interno dell’architettura antica, dotati o meno di decorazione tra le fasce (Templi di Serapide e Adriano; parte sommitale dell’arco dei Leoni a Verona) e questo tipo di architrave era comune anche nell’architet-tura del Quattrocento fiorentino, ricorrendo inoltre nel primo piano del cortile del palazzo ducale di Urbino, così come all’interno del Duomo di Urbino e nel bagno di pa-lazzo ducale di Francesco di Giorgio.Un modello possibile per il piano terreno del sacello, un cilindro con nicchie semicircolari distanziate tra loro e in-quadrate da paraste, è piuttosto difficile da individuare. Giuliano da Sangallo registra esemplari antichi di strut-ture simili, sebbene modificate nei particolari rispetto al suo gusto personale. Nel Codice Barberiniano al f. 1v compare per esempio un tempio circolare di Tivoli, re-cante nicchie semicircolari ma prive di paraste; un altro edificio circolare, il sepolcro dei Servilii sulla via Appia, è presente nel Codice Barberiniano al f. 39r e mostra colon-ne libere e nicchie alternate rettangolari e semicircolari, ma senza alcuno spazio libero tra le nicchie. Bramante potrebbe soltanto aver visto i disegni di alcuni di questi edifici antichi nel 1492, quando Giuliano da Sangallo vi-sitò Milano.Tuttavia anche Francesco di Giorgio disegnò strutture circolari ispirate al Teatro Marittimo della Villa Adriana di Tivoli e, dal momento che Bramante fu apparentemen-te in contatto con lui nei tardi anni Settanta del XV seco-lo e nei primi anni Ottanta, questi disegni, o forse i loro precedenti nei taccuini e schizzi di Francesco di Giorgio, possono rappresentare una fonte ulteriore per la struttura cilindrica di San Satiro. Anche in questo caso la differen-za tra San Satiro e gli edifici disegnati da Francesco di Giorgio è che in questi ultimi è lasciato molto poco spazio tra le nicchie.La chiesa di Santa Maria degli Angeli di Firenze, di Fi-
building the church – presumably meaning the exterior – and that there was a pile of cut-stone near it. At some point between 1490 and 1504 Bartolomeo Della Valle, one of the busiest engineers of the Comune, wrote an estimate of the work done at S. Satiro: «ornamenting» the chapel had cost 2,200 ducats, which had been reduced by 200 ducats by using old material, presumably bricks, from the pre-existing structure. The cost was ten times more than that spent on the bricks for the superstructure of the cha-pel in 1458 and just under half that anticipated for the whole of the facade to be built by Amadeo in 1486, so it is difficult to imagine that it concerned anything other than the large operation of building the thick new circular wall around the old chapel and providing it with its bases, en-tablatures, niches and pilasters. The tiburio and split-tympanums of S. Satiro share ter-racotta decorative motifs with S. Maria and the capitals types are plausible as late Quattrocento work: but none of these architectural forms points unequivocally to Bra-mante rather than to a Lombard designer: this, coupled with the apparent date of its design and construction be-tween 1458 and 1483 at the very latest, seem to preclude the intervention of Bramante. But the lower exterior, apparently built after 1483, comprises a drum on a base with pilasters flanking widely-spaced semicircular niches. Bramante seems to have been responsible for the design of this part of the church. The present capitals are not necessarily accurate replacements of the originals, but it is not impossible. The architrave has two fasciae, the upper taller than the lower and there is no decoration between the fasciae. Ancient architecture provides examples of such architraves with and without decoration between the fasciae (Temples of Serapis and Hadrian, top section of the Arco dei Leoni in Verona) and this type of archi-trave was common enough in Florentine Quattrocento architecture and occurs on the first floor of the courtyard of the Ducal Palace in Urbino; Francesco di Giorgio also used it in the interior of the Duomo di Urbino and in the bagno in the Palazzo Ducale. The origin of the design of the groundfloor, a cylinder
64
San Satiro: A. de Fondulis, Compianto, 1483 c.
lippo Brunelleschi, è stata spesso chiamata in causa nella discussione sul sacello di San Satiro, ma al di là di una connessione generica, cioè un’alta struttura a impianto centrale con un esterno più basso dotato di nicchie semi-circolari, la chiesa fiorentina ha sedici lati e non presenta paraste all’esterno. In ogni caso, è possibile che Leonar-do, arrivato a Milano prima del 25 aprile 1483, possa aver
with widely spaced semicircular niches and pilasters, is difficult to pin down. Giuliano da Sangallo recorded antique examples of such structures, though he altered much to conform with his own tastes. In the Cod. Bar-beriniano, fol. 1v he drew a circular temple with semi-circular niches and half-columns on the exterior; and on 30v, a circular temple at Tivoli with semicircular niches
65
informato Bramante sulla chiesa di Brunelleschi, disegna-ta nel suo manoscritto B, dal momento che la ricostruzio-ne del piano terreno di San Satiro sembra iniziata in un momento successivo al 1483. Allo stesso modo si può considerare il legame con le tri-bune morte di Brunelleschi per il Duomo di Firenze, che comprendono sezioni di cilindro con nicchie fiancheggia-te da coppie di semicolonne, ma senza spazio murario tra di esse.Nell’architettura ecclesiastica accade talora che vi siano allusioni al Santo Sepolcro di Gerusalemme, tramite ele-menti di natura diversa, spesso combinati fra loro senza particolare riguardo alla dedicazione della chiesa. Per esempio un basso edificio circolare o poligonale dotato di un alto elemento cupolato centrale può costituire un riferimento al Santo Sepolcro (si vedano la chiesa di San Lorenzo o San Sepolcro di Mantova e quella di San Se-polcro di Bologna). Altre chiese racchiudono all’interno piccoli edifici o cappelle che rappresentano il Santo Se-polcro (per esempio San Lanfranco di Pavia). Una terza via è quella di alludere alla presenza del Santo Sepolcro inserendo nell’edificio un Compianto scultoreo, spesso associato con una delle caratteristiche architetto-niche sopra menzionate. La chiesa di San Sepolcro di Mi-lano, costituita già dal Medioevo da un triconco presbite-riale, accoglieva al suo interno un gruppo realizzato da un anonimo plasticatore vicino ad Agostino Fonduli alla fine del Quattrocento o all’inizio del Cinquecento. Anche la chiesa dei Santi Santa Maria Maddalena e Spirito a Crema (1521), forse disegnata da Fonduli, originariamente mo-strava una pianta a triconco e ospitava un Compianto del-lo stesso artista. Il gruppo è testimoniato da un contratto del 1510 come sepolcro simile a quello di Cristo e nello stesso documento Agostino si impegnava a visitare un al-tro Sepulchrum Domini, «come quello di Gerusalemme», presente nell’ospedale di Crema.La nuova versione bramantesca della cappella di San Sa-tiro presentava un triconco interno, forma peraltro fre-quentemente impiegata nel Quattrocento per indicare la presenza di un mausoleo. Edifici che includono triconchi
but without pilasters; another circular building, the Sep-olcro dei Servilii on the Via Appia appears on Cod. Barb. 39r, and includes detached columns and alternating rect-angular and semicircular niches, but leaves no free wall-space between the niches. Bramante could only have seen drawings of any of these ancient structures in 1492 when Giuliano da Sangallo visited Milan.So too Francesco di Giorgio drew circular structures based on the Teatro Marittimo in Hadrian’s Villa at Tivoli, and since Bramante was apparently in contact with him in the late 1470’s and early 1480’s, these drawings, or rather their antecedents in Francesco’s notebooks and sketches, are a possible source for the drum of S. Satiro: but the difference between S. Satiro and the structures drawn by Francesco is that the latter leave very little wall space be-tween the niches. Brunelleschi’s S. Maria degli Angeli is often been brought into discussions of S. Satiro. Beyond a generic likeness, that is, a high centre and low exterior with semicircular niches, it is hexadecagonal and does not include pilas-ters on the exterior. In any case, it may be that Leonardo, who arrived in Milan before 25 April 1483 and drew the Angeli in MS B, could have informed Bramante about Brunelleschi’s church since the reconstruction of the ground-floor of S. Satiro was begun at some time after 1483. More or less the same applies to Brunelleschi’s ‘tri-bune morte’ of the Cathedral in Florence, which include drums with niches flanked by coupled half-columns, but with no blank wall-space between them. The architecture of churches could allude to the Holy Sepulchre in Jerusalem in several ways, often combined and often regardless of the particular dedication of the church. A low circular or polygonal building with a tall domed element in the centre, could refer to the Holy Sep-ulchre (eg. S. Lorenzo or S. Sepolcro in Mantua, S. Sepol-cro in Bologna). Other churches included small buildings within them representing the Holy Sepulchre (eg. S. Lan-franco in Pavia). A third way of alluding to the presence of the Holy Sepulchre was by including groups of the Lamentation, often combined with one of the architec-
67
associati a una destinazione sepolcrale sono testimoniati per esempio dalla Certosa di Pavia, intesa come luogo di sepoltura di Gian Galeazzo Visconti, oppure la chiesa di San Bernardino di Urbino per Federico da Montefeltro e Santa Maria delle Grazie a Milano per la famiglia di Ludovico Sforza. Nel caso delle Grazie la funzione funeraria viene raddop-piata poiché il profondo coro fu progettato per accogliere la tomba della famiglia ducale e, inoltre, un gruppo con Compianto fu donato alla chiesa nel 1503 e sembra esse-re stato collocato sotto il sepolcro appeso contenente il corpo di Beatrice d’Este. La tribuna quindi non divenne solo la tomba ducale, ma anche un Sepulchrum Domini. San Satiro presentava un impianto triconco contenuto in una struttura con un basso esterno circolare e un centro poligonale. Negli anni Ottanta del XV secolo le autorità della chiesa e Bramante dovevano comprendere perfetta-mente il significato di queste forme archetipe e decisero così di aggiungere all’architettura del sacello un potente indicatore scultoreo di quel significato, il Compianto o se-pulchrum.
tural features just mentioned. For example, the medieval church of S. Sepolcro in Milan includes a triconch and housed such a group made by an unknown artist close to Agostino Fonduli at the end of the Quattrocento or early Cinquecento. So too SS. Maddalena and Spirito in Crema (1521), perhaps designed by Fonduli, originally included a triconch and housed a Lamentation by the same art-ist. The group was referred to in a contract of 1510 as a «sepulchre like that of our Lord»; in the same contract, Agostino was required to visit another Sepulchrum Do-mini «like that in Jerusalem» in the hospital in Crema. The chapel of S. Satiro and the new Bramantesque version of it comprise a triconch, another form often used in the Quattrocento to indicate the presence of a mausoleum. The Certosa di Pavia was intended as the burial place of Gian Galeazzo Visconti, S. Bernardino at Urbino as that of Federigo da Montefeltro and S. Maria delle Grazie as that of the family of Ludovico Sforza: all include triconches. In the case of the Grazie, the funerary function became two-fold. The deep choir was designed as the tomb of the ducal family, but a group of the Lamentation was donated to the church in 1503 and apparently placed below the raised casket containing the body of Beatrice D’Este. The tribuna therefore became not only a ducal tomb but also a Sepulchrum Domini. S. Satiro includes a triconch con-tained within a structure with a circular lower exterior and high polygonal centre. In the 1480’s the church au-thorities and Bramante understood perfectly the meaning of these archetypal forms and decided to add a powerful sculptural indicator of that meaning to the architecture, the Lamentation or sepulchrum.