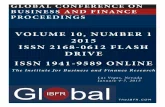Il "cammino comunitario" di Regioni e Comunidades Autónomas
Transcript of Il "cammino comunitario" di Regioni e Comunidades Autónomas
Distribuzione 702 - Volume CCXXX Fascicolo 4 - 2010 I.S.S.N. 0391 - 5646
ARCHIVIO GIURIDICOFilippo Serafi ni
dal 1868
diretto da
GIUSEPPE DALLA TORREOrd. Lumsa di Roma
MARIO CARAVALEOrd. Università
di Roma “La Sapienza”
FRANCESCO P. CASAVOLAPres. Em.
Corte Costituzionale
FRANCESCO D’AGOSTINOOrd. Università
di Roma “TorVergata”
GIUSEPPE DE VERGOTTINIOrd. Università
di Bologna
LUCIANO EUSEBIOrd. Università
Cattolica di Piacenza
VITTORIO GASPARINI CASARIOrd. Università di
Modena e Reggio Emilia
LUIGI LABRUNAProf. Em. Università
di Napoli “Federico II”
PASQUALE LILLOOrd. Università della“Tuscia” di Viterbo
FERRANDO MANTOVANIOrd. Università
di Firenze
MANLIO MAZZIOTTIProf. Em. Università
di Roma “La Sapienza”
PAOLO MENGOZZIOrd. Università
di Bologna
FRANCESCO MORANDIOrd. Università
di Sassari
ALBERTO ROMANOOrd. Università
di Roma “La Sapienza”
MASSIMO STIPOOrd. Università
di Roma “La Sapienza”
Estratto
Mucchi Editore
archivio giuridico – volume ccXXX – Fascicolo 4-2010
497
daniele coduti
Il “cammIno comunItarIo” dI regIonI e Comunidades autónomas*
Sommario: 1. Premessa. – 2. i ‘primi passi’ di Regioni e ccaa nel processo di integrazione comunitaria – 3. La c.d. fase ascendente: la partecipazione di-retta. – 3.1. Segue: la partecipazione indiretta. – 3.2. Segue: il coordinamento orizzontale. – 4. La c.d. fase discendente. – 4.1. Segue: gli strumenti regionali di partecipazione comunitaria. – 4.2. Segue: gli strumenti statali per fronteg-giare la mancata attuazione degli obblighi comunitari. – 5. il ‘cammino comu-nitario’ di Regioni e ccaa tra numerose analogie e significative differenze.
1. Premessa
il presente lavoro si occupa della partecipazione delle re-gioni italiane e delle Comunidades autónomas spagnole (d’ora in avanti CCaa) al processo di integrazione comunitaria, com-parando separatamente i singoli aspetti di tale partecipazio-ne. a tale scopo, si esamineranno innanzitutto i primi passi mossi dagli Enti infrastatali nel loro ‘cammino comunitario’, seguendone il coinvolgimento nella fase ascendente prima e in quella discendente poi, analizzando, altresì, le conseguenze dell’eventuale inadempimento comunitario provocato da tali Enti; l’esame si concluderà con il raffronto tra le modalità di partecipazione comunitaria dei due tipi di Enti e l’individua-zione di analogie e differenze nel percorso seguito.
* il presente lavoro ripropone – con integrazioni e aggiornamenti – il te-sto della relazione tenuta presso la Facoltà di giurisprudenza dell’universi-tà LuMSa di roma il 13 ottobre 2007, nell’ambito del seminario intitolato La riforma degli statuti delle Comunità autonome e le riforme del regionali-smo italiano.
daniele Coduti
498
2. i ‘primi passi’ di Regioni e ccaa nel processo di integrazio-ne comunitaria
La costituzione italiana – prima della riforma del 2001 – non faceva alcun riferimento alle comunità europee, né un ri-ferimento del genere poteva esservi, considerato che la costi-tuzione italiana è antecedente alla istituzione della cEca 1; un silenzio analogo si riscontra tuttora nella costituzione spa-gnola del 1978 2. La partecipazione dei due Paesi al processo di integrazione comunitaria, di conseguenza, si è basata sul-l’interpretazione di due disposizioni contenute nelle rispetti-ve costituzioni: l’art. 11 cost. italiana 3 e l’art. 93 cost. spa-gnola 4. L’originaria assenza di un espresso riferimento alla (odierna) unione europea (ue) nelle costituzioni dei due Pae-si 5, peraltro, non ha impedito un coinvolgimento delle regio-
1 … il cui Trattato istitutivo fu firmato nel 1951.2 Tanto che a.M. Carmona ContreraS, La europeizzazione delle Comunità
Autonome spagnole: una sfida (ancora) costituzionalmente pendente, in Le Regioni, 2006, n. 4, 655, parla di una «sorta di autismo europeo che affligge la norma fondamentale spagnola».
3 cfr. c. cost., sentt. 14/1964, punto 6 del considerato in diritto, e 183/1973, punti 4 ss. del considerato in diritto. al riguardo è opportuno ri-cordare che la dottrina era divisa sulla norma costituzionale considerata ido-nea a garantire la copertura costituzionale alla partecipazione italiana al si-stema comunitario: infatti, mentre parte della dottrina riteneva che tale fon-damento fosse rinvenibile nell’art. 11 cost., altra parte di essa proponeva di fare riferimento all’art. 10 cost. cfr., in proposito, F. modugno, L’invalidità della legge, ii, Milano, giuffrè, 1970, in part. 114 ss.; P. Barile, il cammino comunitario della Corte, in Giurisprudenza costituzionale, 1973, 2406 ss.; r. monaCo, La costituzionalità dei regolamenti comunitari, in il Foro italiano, 1974, i, 315 ss.; C. mortati, istituzioni di diritto pubblico, ii, Padova, cedam, 1976, in part. 1497.
4 cfr. stC 28/1991, FJ 4. Sull’argomento si rinvia a S. muñoz maChado, el estado, el derecho interno y la Comunidad europea, Madrid, civitas, 1986, e. garCía de enterría, La participación de las Comunidades autónomas en la formación de las decisiones comunitarias, in Revista Española de Derecho Constitucional, 1991, n. 33, 3 ss., a. lóPez CaStillo, a. Saiz arnaiz, V. FerrereS Comella, Constitución Española y Constitución Europea, Madrid, cEPc, 2005, e P. Cruz Villalón (coord.), Hacia la europeización de la Constitución española, Bilbao, Fundación BBva, 2006.
5 … e la speculare «cecità federale» dei Trattati istitutivi delle comunità europee, come è stata definita da a. d’atena, il doppio intreccio federa-
il “cammino comunitario” di Regioni e comunidades autónomas
499
ni e delle CCaa nel processo normativo comunitario. Questo coinvolgimento, infatti, è stato il frutto della graduale apertu-ra agli Enti substatali da parte delle corti costituzionali dei due Paesi.
Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, la corte costi-tuzionale ha riconosciuto un ruolo delle regioni, dapprima nei rapporti internazionali 6 e, in seguito, anche nell’ambito dei
le: le Regioni nell’unione europea, in Le Regioni, 1998, 6, 1401, ripren-dendo la Landesblindheit di cui parla h.P. iPSen, als Bundesstaat in der Gemeinschaft, in e.V. Caemmerer, h.J. SChloChauer, e. SteindorFF, Probleme des europäischen Rechts, Frankfurt a.M., Klostermann, 1966, (248 ss.) 256; nello stesso senso, e. alBertí roVira, Las Regiones en la nueva Unión europea. el largo camino hacia una presencia directa de las Regiones en la unión europea, in autonomies, 2003, n. 29, 178, utilizza i termini «neutra-lidad» e «ceguera». Sulla evoluzione del ruolo progressivamente riconosciuto agli enti infrastatali nel processo di integrazione comunitaria si v. a. d’atena, Le Regioni e l’europa, in id., Le Regioni dopo il big bang, Milano, giuffrè, 2005, 213 ss., id., Sovranazionalità ed autonomie regionali: linee evolutive di un rapporto difficile, ivi, 231 ss., nonché e. di SalVatore, L’identità costituzio-nale dell’unione europea e degli stati membri, Torino, 2008, 55 ss.
6 cfr. c. cost., sent. 179/1987, in part. punti 6 ss. del considerato in dirit-to. in effetti, prima della riforma del Titolo v, la cost. italiana non faceva rife-rimento neanche al c.d. potere estero delle regioni, salvo dei cenni agli obbli-ghi internazionali contenuti negli statuti delle regioni ad autonomia speciale: art. 4, st. Friuli-venezia giulia; art. 3, st. Sardegna; art. 4, st. Trentino-alto adige; art. 2, st. valle d’aosta. Sul potere estero delle regioni, che esula dalla trattazione del presente lavoro, ci si limita a rinviare a: a. rePoSo, autonomie locali e potere estero (spunti comparatistici), in diritto e società, 1983, 1, 145 ss., V. liPPoliS, Regioni, treaty-making power e giurisprudenza della Corte co-stituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, 5, 1206 ss., P. de Sena, In tema di attività «internazionali» delle Regioni, in il Foro italiano, 1989, 2121 ss., P. FoiS, obblighi internazionali e competenze regionali: una questio-ne ancora aperta, in Rivista di diritto internazionale, 1999, 4, pp. 909 ss., F. Palermo, Il potere estero delle Regioni. Ricostruzione in chiave comparata di un potere interno alla Costituzione italiana, Padova, 1999, id., titolo V e po-tere estero delle Regioni. I vestiti nuovi dell’imperatore, in Le istituzioni del fe-deralismo, 2002, n. 5, 709 ss., id., il potere estero delle regioni, in t. groPPi, m. oliVetti (a cura di), La Repubblica delle autonomie, 2ª ed., Torino, 2003, 165 ss., r. CaFari PaniCo, La nuova competenza delle Regioni nei rapporti in-ternazionali, in diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, 3, 1325 ss., P. Caretti, Potere estero e ruolo «comunitario» delle Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2003, 4, 555 ss., a. ruggeri, Riforma del Titolo V e “potere estero” delle Regioni (notazioni di ordine metodico-ricostrut-tivo), in diritto e società, 2003, 1, 1 ss., d. Florenzano, L’autonomia regiona-
daniele Coduti
500
rapporti comunitari. inizialmente, peraltro, il processo comu-nitario ha comportato una compressione delle prerogative re-gionali: le attività volte all’assunzione e all’esecuzione degli obblighi comunitari, infatti, erano riservate allo Stato, indi-pendentemente dalla ripartizione interna delle competenze, perché nell’ordinamento interno non erano previsti strumen-ti che – in caso di inerzia delle regioni nell’attuazione degli obblighi comunitari – consentissero allo Stato di attivarsi per impedire l’insorgere di una sua responsabilità comunitaria 7. La corte costituzionale ha gradualmente cercato di tutelare l’autonomia regionale di fronte alle esigenze dell’integrazio-ne comunitaria 8, sfruttando anche le aperture offerte dalla normativa statale 9, sino alla riforma del Titolo v della Par-te ii della costituzione. Tale riforma costituzionale ha intro-dotto in costituzione espressi riferimenti all’ue e ai rappor-ti di questa con l’italia e le regioni negli artt. 117, co. 1, 2, 3, 5, e 120, co. 2 10, che hanno favorito, altresì, la riforma della normativa statale in materia, attuata con l’approvazione del-
le nella dimensione internazionale, Padova, 2004, m. oliVetti, il potere estero delle Regioni italiane, in prospettiva comparata, in aa.VV., scritti in memoria di Livio Paladin, iii, Napoli, 2004, 1407 ss., F. CoVino, art. 117, co. 9, in r. BiFulCo, a. Celotto, m. oliVetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, iii, Torino, 2006, 2323 ss., e o. SPataro, il potere estero delle Regioni, Soveria Mannelli, 2007.
7 cfr. c. cost., sent. 142/1972, punto 9 del considerato in diritto.8 cfr. c. cost., sent. 126/1996, in part. punti 5 ss. del considerato in di-
ritto.9 Si v., in part., d.p.r. 616/1977, 183/1987 (c.d. legge Fabbri), e l. 86/1989
(c.d. legge La Pergola).10 Secondo, B. CaraVita, La Costituzione dopo la riforma del titolo V,
Torino, giappichelli, 2002, 120, peraltro, «la riforma del Titolo v ha intro-dotto ben sei riferimenti all’Unione europea, senza tuttavia definire i princi-pali problemi sul tappeto, né porre i principi per salde soluzioni legislative»; al riguardo r. BiFulCo, Le Regioni, Bologna, il Mulino, 2004, p. 103, osser-va che, relativamente ai rapporti con l’unione europea, la riforma del Titolo v «rappresenta senz’altro un passo in avanti, anche se compiuto con estre-ma, inevitabile lentezza». Sulle disposizioni costituzionali citate nel testo si rinvia ai commenti di g. SergeS, art. 117, co. 1, (2213 ss.), id., art. 117, co. 5, (2263 ss.), l. antonini, art. 117, co. 2, 3 e 4, (pp. 2227 ss.), e C. mainardiS, art. 120, (pp. 2379 ss.), tutti in r. BiFulCo, a. Celotto, m. oliVetti (a cura di), Commentario, iii, cit., nonché a. CoSSiri, F. Benelli, art. 117, in S. Bartole,
il “cammino comunitario” di Regioni e comunidades autónomas
501
le leggi 131/2003 (c.d. legge La Loggia) 11 e 11/2005 (c.d. leg-ge Buttiglione) 12.
analogamente a quanto accaduto in italia, in Spagna il tribunal Constitucional ha gradualmente riconosciuto alle CCaa degli spazi di intervento nei rapporti comunitari e in quelli con l’estero. La giurisprudenza costituzionale, in primo luogo, ha delimitato la riserva statale in materia di rappor-ti internazionali, consentendo alle CCaa di dare esecuzione agli obblighi derivanti dai trattati internazionali aventi per oggetto materie di loro competenza 13; poi, ha distinto i rap-
r. Bin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione Paladin-Crisafulli, 2ª ed., Padova, 2008, 1044 ss., e F. Belletti, art. 120, ivi, 1089 ss.
11 Su tale legge si rinvia ai commenti citati infra, nt. 19.12 Sulla legge di riforma della l. 86/1989 si v., tra i tanti, T. groPPi, Regioni
e diritto comunitario: il disegno di legge di modifica della legge La Pergola, in Le istituzioni del federalismo, 2002, n. 2, 259 ss., P. gamBale, ‘Prima lettu-ra’ del Parlamento per le modifiche alla “Legge La Pergola”: una nuova cor-nice normativa per definire la partecipazione del “sistema Italia” nelle politi-che ue?, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 1 ss., M. CartaBia, l. Violini, Le norme generali sulla partecipazione dell’italia al processo norma-tivo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comu-nitari. Commento alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, in Le Regioni, 2005, 4, 475 ss., E. Cannizzaro, La riforma della «legge La Pergola» e le competenze di Stato e Regioni nei processi di formazione e di attuazione di norme dell’unione eu-ropea, in Rivista di diritto internazionale, 1, 2005, 153 ss., L. CaliFano, stato, Regioni e diritto comunitario nella Legge n. 11/2005, in Quaderni costitu-zionali, 2005, 4, 860 ss., d. girotto, L’ordinamento italiano ed il diritto del-l’unione europea: dalla legge La Pergola alla legge n. 11 del 2005, in studium iuris, 2006, n. 7/8, 818 ss., e g. CarPani, t. groPPi, m. oliVetti, a. SiniSCalChi (a cura di), Le Regioni italiane nei processi normativi comunitari dopo la leg-ge n. 11/2005, Bologna, 2007.
13 cfr. sstC 153/1989, FJ 8, e 165/1994, FFJJ 3 ss. Sul potere estero delle CCaa si v. a. remiro BrotónS, La acción exterior del estado, Madrid, Tecnos, 1984, g. Jáuregui BereCiartu, estatuto de autonomía del País Vasco y relaciones internacionales, in Revista de Estudios Políticos, 1985, 46-47, 455 ss., m. Pérez gonzález, La «onda regional» en Bruselas y el ámbito del poder exterior, in Revista de Instituciones Europeas, 1994, n. 21, 899 ss., m.ªa. ariaS martínez, Las relaciones internacionales y las Comunidades autónomas, in Revista Española de Derecho Constitucional, 1995, 45, 381 ss., id., Comunidades autónomas y relaciones internacionales. un estudio de juris-prudencia constitucional, in autonomies, 1996, 21, 359 ss., r. BuStoS giSBert, Relaciones internacionales y Comunidades autónomas, Madrid, cEc, 1996, e F. Fernández Segado, La riserva di competenza statale in materia di relazio-
daniele Coduti
502
porti internazionali da quelli comunitari, riconoscendo l’inte-resse delle CCaa allo sviluppo della dimensione comunitaria; infine, ha ammesso che le CCaa possano porre in essere de-terminate attività al di là del loro territorio e degli stessi con-fini della Spagna 14. Per quanto attiene alla responsabilità, inoltre, il tribunal Constitucional ha confermato che lo Stato è l’unico responsabile nei confronti dell’ue per eventuali ina-dempimenti comunitari causati dalle CCaa 15.
3. La c.d. fase ascendente: la partecipazione diretta
La rappresentanza diretta degli Enti infrastatali in ambi-to comunitario si è sviluppata attraverso modalità differen-ti, sebbene sia opportuno ricordare che le regioni e le CCaa sono rappresentate nelle stesse sedi comunitarie: la conferen-za delle assemblee legislative dell’ue (caLrE) e il comitato delle regioni.
Passando, nello specifico, alle Regioni italiane, queste sono rappresentate a Bruxelles attraverso proprie sedi di rappre-sentanza e operative 16. dopo la riforma dei fondi struttura-
ni internazionali nella giurisprudenza del tribunale costituzionale, in diritto pubblico comparato ed europeo, 2005, 3, 1479 ss.
14 ancora stC 165/1994, FFJJ 3 ss.15 cfr., ad es., sstC 252/1988, FJ 2, e 148/1998, FJ 8.16 Cfr., al riguardo, l. 52/1996, art. 58, co. 4, come modificato dalla l.
128/1998. Sugli uffici regionali a Bruxelles si v. l. Badiello, Ruolo e funzio-namento degli uffici regionali europei a Bruxelles, in Le istituzioni del federa-lismo, 2000, 1, 89 ss. come osservano a. anzon demmig, Regioni e unione eu-ropea, in S. mangiameli (a cura di), diritto costituzionale, Milano, il Sole 24 ore, 2008, 1070-1071, e P.l. Petrillo, Unione europea, Governo nazionale e Regioni nella c.d. «fase ascendente» tra azioni di filtro e tentativi di coordi-namento, in g. CarPani, t. groPPi, m. oliVetti, a. SiniSCalChi (a cura di), Le Regioni, cit., 18 e 28, queste modalità di presenza a Bruxelles non consentono alle regioni di partecipare in forma istituzionale alle attività di decisione del-le istituzioni comunitarie; le regioni, tuttavia, esercitano delle vere e proprie pratiche di lobbying attraverso le quali possono influenzare – di fatto – l’atti-vità comunitaria. cfr., in proposito, anche P.l. Petrillo, Parlamento europeo e gruppi di pressione. Spunti di riflessione per il caso italiano, in Rassegna parlamentare, 2006, 2, 583 ss.
il “cammino comunitario” di Regioni e comunidades autónomas
503
li, inoltre, le regioni hanno rafforzato le proprie relazioni con l’ue in relazione alla gestione di tali fondi 17. delegazioni re-gionali, poi, partecipano alle riunioni del comitato dei rappre-sentanti permanenti (corEPEr) e ai comitati consultivi del-la commissione europea. Per quanto riguarda la rappresen-tanza permanente dello Stato italiano presso il corEPEr, all’interno di questa operano quattro esperti nominati dalla conferenza dei Presidenti delle regioni. è prevista, inoltre, la partecipazione di rappresentanti regionali alle delegazioni del governo 18 nel consiglio dei ministri dell’ue (purché siano in grado di impegnare la volontà dello stato), secondo modalità da concordare in sede di conferenza Stato-regioni. Merita di essere evidenziato, a tal riguardo, che il capo della delegazio-ne può anche essere un Presidente di regione o di Provincia autonoma, qualora l’atto comunitario di cui si discute rientri nella competenza residuale delle regioni 19.
in merito alle CCaa, invece, occorre considerare che que-ste hanno degli uffici regionali di rappresentanza a Bruxelles, che fanno parte dell’amministrazione regionale 20. relativa-
17 in proposito, g. iurato, L’ue e la rappresentanza territoriale regionale, in Le Regioni, 2006, 4, 689 ss.
18 critico, al riguardo, r. maStroianni, il contributo delle Regioni italiane all’elaborazione del diritto dell’unione europea, in il diritto dell’unione euro-pea, 2006, 2, 427, che riterrebbe più opportuno fare riferimento alla delega-zione “italiana” piuttosto che a quella “del governo”.
19 cfr. l. 131/2003, art. 5, co. 1, nonché l. Violini, il potere estero delle Regioni e delle Province autonome, in g. FalCon (a cura di), stato, Regioni ed enti locali nella legge 5 giugno 2003 n. 131, Bologna, il Mulino, 2003, 111 ss., L. Ciaurro l., art. 5, in aa.VV., Legge “La Loggia”, rimini, 2003, 98 ss., E. CriVelli, m. CartaBia, art. 5, in P. CaValeri, e. lamarque (a cura di), L’attuazione del nuovo Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, Torino, 2004, 113 ss. Sulla citata disposizione si è espressa anche la corte costituzio-nale con la sent. 239/2004, punti 5 ss. del considerato in diritto, sulla quale si v. i commenti di l. Violini, Legge «La Loggia» e partecipazione delle Regioni ai processi decisionali comunitari: la Corte (a buon diritto) assolve le scelte legi-slative, benché incompiute, in Le Regioni, 2005, 1/2, 226 ss., F. ghera, La par-tecipazione delle Regioni ai processi decisionali comunitari alla luce del nuo-vo art. 117, comma 5, Cost., e della legge n. 131 del 2003, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, 2519 ss., e m. BarBero, La Corte costituzionale intervene sulla legge “La Loggia”, in www.forumcostituzionale.it.
20 cfr. stC 165/1994, FFJJ 9 e 10.
daniele Coduti
504
mente alla rappresentanza permanente a Bruxelles, la Spa-gna ha previsto, dal 1996, la figura del consejero autónomi-co 21, volto ad integrare la rappresentanza spagnola in tale or-gano comunitario, essenzialmente con il compito di informa-re le CCaa delle questioni di loro interesse discusse in sede comunitaria. Nel 2004 tale sistema è stato riformato, preve-dendo la nomina di un numero maggiore di consiglieri propo-sti dalle CCaa. occorre considerare, poi, che dal 1998 rappre-sentanti delle CCaa partecipano ai gruppi e comitati di la-voro della commissione europea quando sono trattate mate-rie che presentino un interesse specifico per tali Enti. Di par-ticolare rilievo nella partecipazione diretta delle CCaa alla fase ascendente del processo normativo comunitario è la rap-presentanza diretta nel consiglio europeo. dal 2004, infatti, si prevede la partecipazione di un rappresentante regionale ai gruppi di lavoro del consiglio europeo nella maggior par-te delle materie di competenza delle CCaa 22, con la possibili-tà, altresì, di ampliare ulteriormente i gruppi di lavoro a cui i rappresentanti regionali possono partecipare. rappresentan-ti delle CCaa, poi, possono partecipare alle sedute del consi-glio europeo all’interno della delegazione spagnola quando si trattano questioni che incidono sulle competenze di tali Enti. il rappresentante regionale deve essere un assessore o un con-sigliere autonomico, eletto dalla Conferencia sectorial compe-tente per materia. Sebbene sia considerato un membro di pie-no diritto della delegazione spagnola, il rappresentante auto-nomico occupa comunque una posizione subordinata rispetto al capo della delegazione (che deve sempre essere un rappre-
21 Una figura che la dottrina spagnola paragona all’osservatore dei Länder tedeschi: P. Pérez tremPS, Profili costituzionali dell’ingresso della Spagna nella Comunità europea, in Quaderni costituzionali, 1988, 2, 413, e J. SalaS hernández, a. BetanCor rodríguez, La incidencia organizativa de la integra-ción europea en la administración española, in Revista de Administración Pública, 1991, 125, 527-528; nello stesso senso anche r. SCarCiglia, d. del Ben, spagna, Bologna, 2005, 136.
22 Si tratta di quattro ambiti: agricoltura e pesca; tutela dell’ambiente; la-voro, politiche sociali, sanità e tutela dei consumatori; educazione, cultura e tutela dei giovani.
il “cammino comunitario” di Regioni e comunidades autónomas
505
sentante dello Stato), considerato che a quest’ultimo spetta anche la funzione di portavoce degli interessi regionali 23.
Le indicate modalità di partecipazione diretta degli Enti substatali garantiscono senz’altro una maggiore rappresen-tanza delle istanze regionali presso gli organi comunitari, con-testualmente, però, rendono particolarmente rilevante la ne-cessità di un coordinamento delle posizioni statali e regiona-li, da concretizzarsi attraverso gli strumenti di partecipazio-ne indiretta.
3.1. segue: la partecipazione indiretta
Per quanto riguarda la partecipazione indiretta delle re-gioni italiane alla c.d. fase ascendente del processo normati-vo comunitario, occorre considerare alcuni organi all’interno dei quali si persegue il coordinamento delle diverse posizioni in merito agli affari comunitari. in primo luogo, l’apposito di-partimento istituito presso la Presidenza del consiglio dei mi-nistri e la nomina di un ministro senza portafoglio per le poli-tiche comunitarie. il dipartimento ha il compito di coordinare le amministrazioni dello Stato competenti per settore, le re-gioni e le Province autonome, gli operatori privati e le parti sociali interessate, al fine di definire la posizione italiana da sostenere in sede comunitaria, d’intesa con il Ministero degli affari esteri 24. un ruolo essenziale nel coinvolgimento delle regioni nella fase ascendente del processo normativo comuni-tario, in ogni caso, continua ad essere svolto dalla conferenza Stato-regioni 25, poiché, in questa sede le istituzioni nazionali
23 così a.M. Carmona ContreraS, La europeizzazione, cit., 668-669; su tali modalità di partecipazione delle CCaa ai processi decisionali comunitari si rinvia a J.m.ª CaStellà andreu, Las Comunidades autónomas en Bruselas: la dimensión externa de la participación autonómica en la unión europea, in Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 2008, 6, 37 ss.
24 Sul ministro per le politiche comunitarie e il suo dipartimento si rinvia al d.m. 9 ottobre 2006, nonché a P.l. Petrillo, unione europea, cit., 21 ss.
25 Si v., al riguardo, m. PoSilliPo, La Conferenza stato-Regioni nei pro-cessi decisionali comunitari, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2006, 2, 155 ss.
daniele Coduti
506
e regionali possono confrontarsi anche in merito alle questioni comunitarie, secondo modalità differenti. di particolare rilie-vo è la c.d. sessione comunitaria della conferenza, che deve te-nersi con cadenza almeno semestrale per la «trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e pro-vinciale» 26. La l. 11/2005, poi, ha istituito il comitato inter-ministeriale per gli affari comunitari europei (ciacE). Esso è presieduto dal Presidente del consiglio dei ministri o dal mi-nistro per le politiche comunitarie e ai suoi lavori partecipano il ministro degli affari esteri, quello per gli affari regionali e gli altri ministri competenti per le materie poste all’ordine del giorno. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le Province autonome, inoltre, possono chiedere di partecipare alle riunioni dell’organo il presidente della confe-renza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome o un suo delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti lo-cali, i presidenti delle associazioni rappresentative di tali enti. il ciacE si avvale di un comitato tecnico permanente istitui-to presso il dipartimento per le politiche comunitarie, coordi-nato e presieduto dal ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato; quest’organo tecnico, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le Province auto-nome, è integrato dagli assessori regionali competenti o loro delegati, così da garantire un’ampia rappresentanza regiona-le. Per quanto riguarda le sue funzioni, il ciacE, nel rispet-to delle competenze del Parlamento, del consiglio dei ministri e della Conferenza Stato-Regioni, è istituito al fine di concor-dare le linee politiche del governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’ue e di consentire il puntuale adempimento dei relativi compiti 27.
26 cfr. art. 17, l. 11/2005; è opportuno ricordare che l’art. 18 della stessa legge prevede anche una sessione comunitaria della conferenza Stato-città, con cadenza almeno annuale.
27 Cfr. l. 11/2055, art. 2, come modificato dalla l. 34/2008 (legge comuni-taria 2007), nonché d.p.c.m. 9 gennaio 2006, d.m. 9 gennaio 2006 e il già ci-tato d.m. 9 ottobre 2006. Su tale comitato interministeriale si rinvia a M. CartaBia, l. Violini, Le norme, cit., in part. 482 ss., M. gentile, nasce il Ciace
il “cammino comunitario” di Regioni e comunidades autónomas
507
Passando alla Spagna, occorre premettere che la sede isti-tuzionale nella quale le CCaa avrebbero dovuto partecipare alla determinazione della volontà statale (anche) in materia comunitaria, il senado, non è stato capace di configurarsi alla stregua di una vera e propria camera di rappresentanza ter-ritoriale, rendendo necessaria la creazione di canali di dialo-go tra centro e periferia alternativi. a tal proposito, nel 1994 è stata creata una nuova commissione senatoriale – la Comisión General de las Comunidades autónomas –, la quale, tuttavia, non è riuscita a mantenere il dialogo tra Stato e CCaa all’in-terno del circuito parlamentare 28. Questo dialogo, infatti, si è spostato a livello intergovernativo grazie alla creazione del-le Conferencias sectoriales 29 e alla configurazione della Con-ferencia para asuntos Relacionados con las Comunidades eu-ropeas (CaRCe) come conferenza a carattere generale 30. La partecipazione indiretta delle CCaa alla fase ascendente del processo comunitario, dunque, pur non escludendo relazioni bilaterali tra Stato e CCaa, si dovrebbe svolgere prevalente-mente attraverso le Conferencias sectoriales, che si occupano,
per concordare le strategie di Governo, in Guida al diritto, 2005, 9, 39 ss., M.E. Puoti, L’attuazione degli strumenti di partecipazione alla fase ascen-dente di formazione della normativa comunitaria previsti dalla legge 4 feb-braio 2005, n. 11: il comitato interministeriale per gli affari comunitari eu-ropei (CIACE), il comitato tecnico permanente e i tavoli di coordinamento, in diritto e società, 2006, n. 3, 481 ss., F. tuFarelli, art. 2, in g. Brenna, S. StaBile, a. trotta, m. de Vita, F. tuFarelli, Commento alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, in g. CarPani, t. groPPi, m. oliVetti, a. SiniSCalChi (a cura di), Le Regioni, cit., 220 ss.
28 Si v. anche la Comisión mixta para la unión europea, istituita dalla Ley 8/1994 e modificata dalla Ley 24/2009.
29 Sulle quali si rinvia a e. aJa, el estado autonómico, 2ª ed., Madrid, alianza Editorial, 2003, 228 ss., anche per un elenco delle principali conferenze, e J.c. duque VillanueVa, Las Conferencias sectoriales, in Revista Española de Derecho Constitucional, 2007, 79, 113 ss.
30 Sulla CaRCe si v. Ley 2/1997, nonché e. roig moléS, La Ley 2/1997 y la posición de la Conferencia para los asuntos relacionados con las Comunidades europeas, in Cuadernos de derecho Público, 1997, 2, 265 ss., e m. CienFuegoS mateo, La intervención de las Comunidades Autónomas en cuestiones rela-tivas a las Comunidades Europeas a través de la Comisión general de las Comunidades autónomas y la Conferencia para los asuntos relacionados con las Comunidades europeas, in autonomies, 1997, 22, 155 ss.
daniele Coduti
508
nelle materie di loro competenza, anche degli affari comuni-tari, e la CaRCe, che si occupa delle questioni comunitarie in termini generali, senza rappresentare un organo gerarchica-mente sovraordinato alle Conferencias sectoriales 31. Tale si-stema, tuttavia, non appare particolarmente efficace, ad esem-pio, perché la convocazione delle Conferencias sectoriales di-pende dalla sensibilità del ministro competente, o, ancora, per-ché il sistema delle conferenze non sembra capace di garantire un effettivo coordinamento orizzontale tra le CCaa, così che la mancata definizione di una posizione comune tra le CCaa fini-sce inevitabilmente per rafforzare il ruolo dello Stato 32.
3.2. segue: il coordinamento orizzontale
è opportuno ricordare, dunque, che in italia esistono stru-menti che consentono a regioni e Province autonome di con-cordare una posizione comune (anche) in materia comunita-ria: la conferenza delle regioni e delle Province autonome; la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative dei con-sigli regionali e delle Province autonome 33.
Nell’ordinamento spagnolo, invece, le relazioni orizzonta-li tra CCaa sono caratterizzate da una certa «debilidad» 34, essendo privilegiate le relazioni bilaterali tra Stato e singo-
31 Sulla partecipazione delle CCaa alle decisioni “comunitarie” attraver-so le conferenze, si v. l’accordo approvato dalla CaRCe il 30 novembre 1994, sul quale r. BuStoS giSBert, Un paso más hacia la participación autonómi-ca en asuntos europeos, in Revista Española de Derecho Constitucional, 1995, 45, 153 ss.
32 in proposito, si v. le osservazioni di e. aJa, el estado, cit., 216-217, nonché E. exPóSito gómez, el principio de leal colaboración en el sistema re-gional español, in teoria del diritto e dello stato, 2005, 3, 393.
33 il ruolo di questi organismi è riconosciuto anche dalla l. 11/2005 ne-gli artt. 2, 5 e 8; cfr., altresì, V. antonelli, i raccordi interistituzionali nel-la dialettica con l’unione europea, in g. CarPani, t. groPPi, m. oliVetti, a. SiniSCalChi (a cura di), Le Regioni, cit., 60 ss.
34 così e. aJa, m.J. garCía moraleS, Las relaciones entre Comunidades Autónomas: problemas y perspectivas, in informe Comunidades autónomas 2000, Barcelona, idP, 2001, 9; si rinvia, inoltre, anche per un parallelo con il sistema italiano, a r. BiFulCo, La cooperazione nello stato unitario composto, Padova, cedam, 1995, 257 ss.
il “cammino comunitario” di Regioni e comunidades autónomas
509
le CCaa o di queste ultime tra loro per affrontare e risolvere problemi specifici 35. costituisce un’eccezione la creazione – nel 2004 – della Conferencia de Presidentes, che, tuttavia, può avere sia una dimensione orizzontale (quando riunisce i soli Presidenti delle CCaa) sia verticale (quando vi partecipa an-che il Presidente del governo) 36.
4. La c.d. fase discendente
Passando alla fase discendente del processo normativo co-munitario, per l’italia vengono in questione il novellato art. 117 cost., e la già citata l. 11/2005. L’art. 117, co. 5, cost., in particolare, dispone che le regioni e le Province autonome provvedano all’attuazione e all’esecuzione del diritto comuni-tario, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato. Le regioni, dunque, possono dare attuazione al di-ritto comunitario in materia concorrente nel rispetto delle di-sposizioni di principio dettate dallo Stato e delle norme di pro-cedura ex art. 117, co. 5, cost.; per quanto riguarda, invece, le materie di competenza residuale, le regioni possono prov-vedere direttamente all’attuazione dei relativi obblighi comu-
35 cfr., su tali aspetti, e. alBertí roVira, Las relaciones de colabora-ción entre el estado y las Comunidades autónomas, in Revista Española de derecho Constitucional, 1985, 14, in part. 135 ss., a.e. naVarro munuera, Las relaciones interautonómicas de colaboración: mecanismos y posibilidades de articulación orgánica, in Revista de Administración Pública, 1989, 120, 401 ss., m. SalVador CreSPo, L’esperienza spagnola, in r. SCarCiglia (a cura di), Unione europea e autonomie regionali. Prospettive per una Costituzione eu-ropea, Torino, 2003, 138-139, g. Cámara Villar, el principio y las relaciones de colaboración entre el estado y las Comunidades autónomas, in Revista de derecho Constitucional europeo, 2004, 1, in part. 225, E. exPóSito gómez, el principio, cit., 359 ss., e x. arBóS marín (coord.), Las relaciones interguberna-mentales en el estrado autonómico, Barcelona, iEa, 2009.
36 Sul tale organo si v. E. aJa, La conferencia de Presidentes en el estado autonómico, in aa.VV., Constitución, estado de las autonomías y justicia con-stitucional, valencia, Tirant lo Blanch, 2005, 823-839, e J. taJadura teJada, La Conferencia de Presidentes, in X. arBóS (coord.), La cooperación intergu-bernamental en los estados compuestos, Barcelona, iEa, 2006, 115-168, J.a. montilla martoS, El marco normativo de las relaciones intergubernamentales, in m.J. garCía moraleS, J.a. montilla martoS, x. arBóS marín, Las relaciones intergubernamentales en el estado autonómico, Madrid, cEPc, 2006, 92 ss.
daniele Coduti
510
nitari senza dover rispettare il limite delle disposizioni stata-li di principio ma solo quello delle norme di procedura. Nel-la c.d. fase discendente, inoltre, si prevede il coinvolgimento della conferenza Stato-regioni sia per il soddisfacimento de-gli obblighi di informazione sia per concordare le iniziative da assumere in relazione alle misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi comunitari 37.
Le CCaa, a loro volta, sono coinvolte nell’esecuzione de-gli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario inerenti sia alle materie di competenza esclusiva regionale sia a quel-le di competenza concorrente. Secondo il tribunal Constitu-cional, infatti, l’adesione della Spagna all’Ue non modifica, in via di principio, la distribuzione delle competenze tra Stato e CCaa 38, nonostante l’eventuale inadempimento degli ob-blighi comunitari comporti l’insorgere di una responsabilità statale, indipendentemente dall’Ente territoriale substata-le competente. il tribunal Constitucional, inoltre, ha chiari-to che la normativa intermedia statale per l’esecuzione del di-ritto comunitario è necessaria solo nelle materie di competen-za concorrente e non anche in quelle di competenza esclusiva delle CCaa 39. Occorre considerare, infine, che per stabilire le modalità concrete di applicazione della normativa comunita-ria, la sede del confronto tra centro e periferia è rappresenta-ta dalle già citate Conferencias sectoriales 40.
37 cfr., al riguardo, artt. 8 e 16 l. 11/2005. Sul coinvolgimento delle regioni nella c.d. fase discendente sia consentito rinviare a d. Coduti, La partecipazione delle Regioni al processo normativo comunitario, con particola-re riferimento alla c.d. fase discendente, in g. CarPani, t. groPPi, m. oliVetti, a. SiniSCalChi (a cura di), Le Regioni, cit., in part. 85 ss., e alla bibliografia ivi citata.
38 cfr., tra le tante, stC 252/1988, FJ 2, sulla quale o. CaSanoVaS y la roSa, Las competencias de las Comunidades autónomas en la aplicación del derecho comunitario europeo, in Revista de Instituciones Europeas, 1989, 16, 767 ss.
39 cfr. stC 102/1995, FJ 14; sui problemi relativi alla emanazione di una normativa statale intermedia si v. J.a. montilla martoS, La articulación nor-mativa bases-desarrollo al incorporar el Derecho europeo en el Estado autonó-mico, in Revista de Derecho Constitucional Europeo, 2004, 2, 207 ss.
40 La dottrina spagnola si è occupata ampiamente del tema; in questa sede ci si limita a rinviare a S. muñoz maChado, La ordenación de las relacio-
il “cammino comunitario” di Regioni e comunidades autónomas
511
4.1. segue: gli strumenti regionali di partecipazione comuni-taria
La disciplina statale italiana in tema di partecipazione re-gionale al processo normativo comunitario sembra presuppor-re la necessità di interventi regionali volti alla concretizzazio-ne di tale attività, in particolare, per indicare compiutamen-te le norme di procedura che le regioni devono seguire nel-l’adempimento degli obblighi comunitari 41. disposizioni rela-tive all’ue si riscontrano in tutti i nuovi statuti regionali, an-che se – in non pochi casi – si tratta di affermazioni dal tenore del tutto generico 42. Non mancano, tuttavia, disposizioni sta-
nes del estado y las Comunidades autónomas con la Comunidad europea, in Revista Española de Derecho Constitucional, 1985, 14, 9 ss., a. lóPez CaStillo, Creación y aplicación del derecho comunitario europeo y Comunidades autónomas, in Revista Española de Derecho Constitucional, 1992, 35, 111 ss., F. ruiz ruiz, Las competencias de las Comunidades autónomas en el de-sarrollo normativo y la ejecución del derecho comunitario europeo, in Revista Española de Derecho Constitucional, 1995, 45, 279 ss., P. Pérez tremPS, m.a. CaBelloS eSPiérrez, e. roig moléS, La participación europea y la acción exte-rior de las Comunidades autónomas, Madrid, Marcial Pons, 1998, e. alBertí, l. ortega álVarez, J.a. montilla martoS, Las Comunidades autónomas en la unión europea, Madrid, cEPc, 2005, g. Jáuregui, La participación de las Comunidades autónomas en la unión europea, in Revista catalana de dret públic, 2005, 31, 137 ss.
41 un margine di intervento regionale in tale settore, d’altro canto, è ri-conosciuto dalla stessa corte costituzionale: cfr. sent. 372/2004, punto 7 del considerato in diritto, e i commenti di a. ruggeri, Gli statuti regionali alla Consulta e la vittoria di Pirro, in www.forumcostituzionale.it, 9 dicem-bre 2004, par. 4, e g. d’alBerto, La Corte dà il via libera allo Statuto del-la Regione toscana, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 23 dicembre 2004.
42 cfr. art. 2, co. 1, st. Marche («La regione opera nel quadro dei princi-pi fondamentali e delle norme dell’unione europea perseguendo la valorizza-zione delle politiche comunitarie e la collaborazione con le altre regioni d’Eu-ropa, garantendo altresì la propria partecipazione alla vita dell’unione e al processo di integrazione della stessa, nel rispetto delle diverse culture»), art. 9, co. 1 e 2, st. Puglia («La regione opera nel quadro dei principi e delle nor-me dell’unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comu-nitarie regionali, cooperando con le regioni d’Europa e sostenendo opportu-ni e più ampi processi d’integrazione, nel rispetto delle diverse culture. // La regione partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazio-ne di decisioni degli organismi comunitari e, nelle materie di sua competen-
daniele Coduti
512
tutarie volte a determinare concretamente le modalità di par-tecipazione regionale all’ue, quali la previsione di obblighi di informazione tra Legislativo ed Esecutivo regionali in tema di relazioni tra regione e ue 43, la possibilità di promuovere ri-corsi dinanzi alla corte di giustizia 44 o la costituzione di com-missioni consiliari permanenti per gli affari comunitari 45. di particolare rilievo, poi, appaiono le disposizioni che configura-no una vera e propria legge comunitaria regionale 46, essen-
za, nei casi e con le forme disciplinati dallo Stato, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato»), art. 1, co. 4, e art. 2, st. umbria (rispettivamente «La regione promuove il progresso civile, so-ciale, culturale ed economico della comunità regionale e favorisce il processo democratico della riforma dello Stato e la piena realizzazione politica e socia-le dell’unione Europea, fondata su principi e valori condivisi», e «La regione assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni: (…) la vocazione europeista (…)»).
43 cfr. st. abruzzo, art. 44, co. 4, e st. Toscana, art. 70, co. 2. Sulla generi-cità di quest’ultima previsione statutaria, peraltro, si v. F. donati, Rapporti con l’unione europea, in P. Caretti, m. Carli, e. roSSi (a cura di), statuto del-la Regione toscana. Commentario, Torino, 2005, 365.
44 cfr. st. Lazio, art. 41, co. 4, e st. Puglia, art. 44, co. 4, lett. c.45 Si pensi, ad es., all’art. 28, co. 1, st. calabria, o all’art. 32, co. 1, st. Lazio.
Sugli strumenti regionali di partecipazione all’ordinamento comunitario si v. P. mazzina, Gli statuti regionali e l’ordinamento comunitario: uno sguardo ad un sistema ancora in “costruzione”, in r. BiFulCo (a cura di), Gli statuti di seconda generazione, Torino, 2006, 285 ss., e C. BaSSu, Regioni e unione europea, in m. Carli, g. CarPani, a. SiniSCalChi (a cura di), Bologna, 2006, 415 ss., V. antonelli, Consigli regionali e unione europea, in il Filangieri, Quaderno 2009, in part. 239 ss., e, per il periodo anteriore all’approvazione della l. 11/2005 e dei nuovi statuti regionali, P. BilanCia, Regioni ed attuazio-ne del diritto comunitario, in Le istituzioni del federalismo, 2002, 1, 49 ss.
46 Si v., in particolare, st. Lazio, art. 11, co. 2, st. Lombardia, art. 39, st. Piemonte, art. 42, nonché l. reg. Emilia-romagna 6/2004, art. 3, e, tra le regioni a statuto speciale, l. reg. Friuli-venezia giulia 10/2004, art. 3. Sulle leggi comunitarie regionali si rinvia a r. de liSo, una proposta: la legge comu-nitaria regionale, in www.federalismi.it, 23 gennaio 2003, 1 ss., a. adinolFi, Nuove procedure per l’attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale: verso le «leggi comunitarie regionali»?, in Rivista di diritto internazionale, 2004, 3, 759 ss., m. FragaSSi, La partecipazione delle Regioni alla «fase discendente» del processo normativo comunitario: la legge comunitaria regionale, in g. CarPani, t. groPPi, m. oliVetti, a. SiniSCalChi (a cura di), Le Regioni, cit., 111 ss., g. PaStore, L’adempimento degli obblighi co-munitari nella Regione Friuli Venezia Giulia: le leggi comunitarie regionali, ivi, pp. 133 ss., a. di SteFano, esecuzione degli obblighi comunitari e ordina-
il “cammino comunitario” di Regioni e comunidades autónomas
513
ziale per una corretta e tempestiva attuazione degli obblighi comunitari a livello regionale, sebbene si riproponga anche in questo caso la preminenza dell’Esecutivo in materia comu-nitaria, considerato che l’iniziativa e l’attuazione delle legge sono rimesse – di solito – alla giunta regionale. occorre sotto-lineare, inoltre, che, di solito, gli statuti regionali sottraggono la normativa di attuazione ed esecuzione degli obblighi comu-nitari al referendum abrogativo 47.
Per quanto riguarda le CCaa, i nuovi estatutos de auto-nomía (eeaa) fanno ampio riferimento alla partecipazione al processo di integrazione comunitaria e al relativo procedimen-to normativo, sia enunciando disposizioni che genericamen-te collocano le CCaa all’interno dello spazio (giuridico e geo-grafico) europeo 48, sia complessi di disposizioni volti a garan-tire e disciplinare in maniera organica le relazioni tra CCaa e Ue. Relativamente a tale ultimo profilo, occorre considera-re, in primo luogo, quelle previsioni che si occupano del coin-volgimento della singola comunità nelle fasi c.d. ascendente e
menti regionali: il disegno di legge della Regione siciliana, in Rivista giuridi-ca del mezzogiorno, 2006, 1, 75 ss., P. ViPiana, Le leggi comunitarie regionali: un innovativo strumento per l’attuazione delle direttive comunitarie da parte delle Regioni, in Quaderni regionali, 2007, 1/2, 449 ss., nonché alle osserva-zioni problematiche di r. manFrellotti, sistema delle fonti e indirizzo politico nelle dinamiche dell’integrazione europea, Torino, 2004, in part. 276.
Sempre in merito all’attuazione regionale del diritto comunitario, si con-sideri lo st. Toscana, art. 41, secondo il quale, in mancanza di assenso comuni-tario, anche parziale, sulle leggi regionali che lo richiedono, il consiglio regio-nale è tenuto al riesame della legge stessa. Su tale previsione si v. C. BaSSu, Regioni, cit., 427, e g. tarli BarBieri, Promulgazione, in P. Caretti, m. Carli, e. roSSi (a cura di), statuto, cit., 205, nonché le osservazioni critiche di e. di SalVatore, Le relazioni delle regioni italiane con l’unione europea: fondamen-to costituzionale, normativa statale e disciplina statutaria, in J.m.ª CaStellà, m. oliVetti (a cura di), Nuevos Estatutos y reforma del Estado, Barcelona, atelier, 2009, 358.
47 Si v., tra le numerose disposizioni di questo tenore, il primo e l’ulti-mo tra i nuovi statuti ordinari sinora approvati: st. Puglia, art. 18, co. 2, e st. campania, art. 13, co. 4.
48 cfr., ad es., ea Castilla y León, art. 1, co. 2, che definisce la Comunità «región de europa»; analogamente ea Comunidad Valenciana, art. 1, co. 4, che all’art. 61, co. 3, specifica ulteriormente che si tratta di una «región de la unión europea».
daniele Coduti
514
discendente del processo normativo comunitario, ad esempio, prevedendo delegazioni e uffici propri presso l’Ue 49, oppure definendo le modalità di riparto delle competenze tra Stato e CCaa in relazione agli obblighi comunitari 50; in secondo luo-go, le norme che riguardano la gestione dei fondi comunita-ri 51; infine, una serie di previsioni che riguardano altri profi-li del coinvolgimento delle CCaa nel processo di integrazione comunitaria, quali, ad esempio, le azioni dinanzi agli organi giurisdizionali dell’ue 52 o il rispetto dei principî di sussidia-rietà e proporzionalità 53. La nuova stagione statutaria spa-gnola, dunque, ha indotto a disciplinare in maniera dettaglia-ta – nei nuovi eeaa – il coinvolgimento delle CCaa nel pro-cesso normativo comunitario 54.
4.2. segue: gli strumenti statali per fronteggiare la mancata attuazione degli obblighi comunitari
il rischio di una responsabilità comunitaria dello Stato per l’inadempienza degli obblighi comunitari da parte degli Enti infrastatali rende necessario prevedere strumenti idonei a ga-rantire il corretto e tempestivo adempimento di tali obblighi.
in italia, già prima della riforma del Titolo v, si riconosce-va allo Stato la possibilità di esercitare il potere sostitutivo
49 cfr., ad es., ea Castilla y León, art. 64; ea Comunidad Valenciana, art. 61, co. 1 e 2; ea illes Balears, art. 107.
50 cfr., ad es., ea andalucía, art. 42, co. 2, n. 4; EA Cataluña, artt. 113 e 189 (al riguardo, peraltro, si v. stC 31/2010, in part. FJ 123); ea Comunidad Valenciana, art. 49, co. 4; ea illes Balears, art. 109.
51 cfr., ad es., ea andalucía, art. 185; EA Cataluña, art. 190; ea illes Balears, art. 115.
52 Si v., ad es., ea andalucía, art. 238; ea aragón, art. 95; EA Cataluña, art. 191 (sul quale si v. stC 31/2010, in part. FJ 124).
53 cfr., ad es., ea andalucía, art. 237, ea aragón, art. 93, co. 3.54 Si v., al riguardo, d. ordóñez SolíS, Las relaciones entre la unión
Europea y las Comunidades Autónomas en los nuevos Estatutos, in Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 2007, 4, 69 ss., e m.á. CaBelloS eSPiérrez, La Regulación de las Relaciones con la unión europea y la acción exterior en los nuevos Estatutos de Autonomía, in J.m.ª CaStellà, m. oliVetti (a cura di), Nuevos Estatutos, cit., 323 ss.
il “cammino comunitario” di Regioni e comunidades autónomas
515
nei confronti delle regioni 55. Tale potere è oggi espressamen-te disciplinato – (anche) per garantire l’adempimento degli ob-blighi comunitari – dalla costituzione (artt. 117, co. 5, e 120, co. 2) e dalle già citate leggi 131/2003 e 11/2005. La previsione costituzionale di tale potere dovrebbe contribuire a garantir-ne l’esercizio nel rispetto del principio di leale collaborazione; tuttavia, la disciplina disseminata nei diversi testi normativi configura ipotesi e procedure di esercizio del potere sostitutivo tanto numerose da rendere necessaria una attenta – e non fa-cile – operazione di coordinamento delle differenti ipotesi pre-figurate 56. Occorre aggiungere che la l. 11/2005, come modifi-cata nel 2008, prevede espressamente il diritto di rivalsa del-lo Stato nei confronti delle regioni, delle Province autonome, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici e dei sogget-ti equiparati responsabili della violazione degli obblighi deri-vanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempesti-va esecuzione alle sentenze della corte di giustizia 57.
Nell’ordinamento spagnolo, invece, non sono previsti stru-menti volti specificamente ad evitare l’insorgere di una re-sponsabilità comunitaria in caso di inadempienza delle CCaa: diventa necessario, di conseguenza, ricorrere ad istituti predi-sposti per finalità differenti. In primo luogo, il tribunal Con-stitucional consente allo Stato di intervenire – ai sensi dell’art. 149, co. 3, cost. – in via suppletiva rispetto alle CCaa, adot-
55 c. cost., sent. 182/1976, punti 2 ss. del considerato in diritto, sulla qua-le si v. i commenti di P. Caretti, Potere sostitutivo dello Stato e competenze regionali, in Giurisprudenza costituzionale, 1976, 12, 2223 ss., r. monaCo, L’esecuzione delle direttive comunitarie nell’ordinamento italiano, in il Foro italiano, 1976, 10, col. 2326 ss., e F. BaSSanini, attuazione regionali di diret-tive comunitarie e intervento sostitutivo del governo, in Le Regioni, 1977, 1/2, 148 ss.
56 Per l’approfondimento di tali difficoltà esegetiche e applicative, non-ché del potere sostitutivo statale come rimedio all’inadempimento comunita-rio, sia consentito rinviare a d. Coduti, La partecipazione, cit., 99 ss., e alla bibliografia ivi citata, oltre a q. Camerlengo, Potere sostitutivo (dir. cost.), in digesto delle discipline pubblicistiche, agg.***, ii, Torino, 2008, in part. 661.
57 cfr. art. 16-bis, l. 11/2005, introdotto dalla già citata l. 34/2008. Si v., al riguardo, C. Bertolino, il ruolo delle Regioni nell’attuazione del diritto co-munitario. Primi passi significativi e profili problematici, in Le Regioni, 2009, 6, 1249 ss.
daniele Coduti
516
tando norme volte ad impedire l’inadempienza degli obblighi comunitari 58. Lo Stato, poi, potrebbe fare riferimento all’art. 150, co. 3, cost., ai sensi del quale può dettare delle norme di principio per l’armonizzazione legislativa delle CCaa. Questo istituto, però, oltre a richiedere la sussistenza di un interesse generale e l’approvazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna camera, necessita di un successivo intervento nor-mativo delle stesse CCaa, così da sollevare dubbi sulla sua ef-fettiva capacità di impedire un inadempimento comunitario. Infine, il Governo potrebbe ricorrere all’adempimento forzato previsto dall’art. 155 cost., che, però, richiede la necessità di proteggere un interesse generale dello Stato e l’approvazione a maggioranza assoluta da parte del senado 59. occorre sotto-lineare, infine, che, sebbene non sia espressamente previsto, il tribunal Constitucional ha fornito aperture alla possibili-tà che – qualora l’inadempimento comunitario dipenda dal-le CCaa – lo Stato possa rivalersi nei confronti della ammini-strazione autonomica responsabile 60.
58 Si v. stC 79/1992, FJ 3, nonché J.F. SánChez Barillao, La supletorie-dad del derecho estatal como garantía en la ejecución del derecho europeo por las Comunidades autónomas, in Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2004, 1, 241 ss.; dubitano della effettiva capacità di tale istituto di far fronte alle ipotesi di inadempimento ‘commissivo’ E. Ciardelli, l.e. amezCua alCalà, spagna, in amministrare, 2007, 1/2, 120.
59 Sugli strumenti a disposizione dello Stato per garantire la corret-ta applicazione del diritto comunitario da parte delle CCaa si v. r. BuStoS giSBert, Cuestiones planteadas por la jurisprudencia constitucional referen-te al la ejecución y garantía del cumplimiento del derecho comunitario, in Revista de Instituciones Europeas, 1993, 20, 583 ss., F. ruiz ruiz, La fun-ción de garantía del cumplimiento autonómico del derecho comunitario euro-peo, in Revista española de derecho constitucional, 1997, 51, 159 ss., g. ruiz-riCo ruiz, Problemi costituzionali nell’esecuzione dell’ordinamento comuni-tario da parte delle Comunità autonome in spagna, in diritto pubblico com-parato ed europeo, 1999, 4, 1749 ss., e id., L’integrazione del diritto comuni-tario nello stato autonomico spagnolo. esame della giurisprudenza costitu-zionale, in l. Pegoraro, a. rinella, r. SCarCiglia (a cura di), I vent’anni del-la Costituzione spagnola nella giurisprudenza del tribunale costituzionale, Padova, 2000, 188 ss.
60 cfr. sstC 96/2002, FJ 10, e 148/98, FJ 8; al riguardo si v. m. CienFuegoS mateo, Comunidades autónomas, tribunales de la unión europea y re-sponsabilidad por el incumplimiento autonómico del derecho comunitario.
il “cammino comunitario” di Regioni e comunidades autónomas
517
5. il ‘cammino comunitario’ di Regioni e ccaa tra numerose analogie e significative differenze
in conclusione, si può osservare che in entrambi i Paesi, stante l’originaria assenza di disposizioni costituzionali rife-rite espressamente all’ue, l’adesione all’ordinamento comuni-tario e il successivo coinvolgimento degli Enti territoriali sub-statali nel processo di integrazione comunitaria sono stati il frutto della giurisprudenza delle rispettive corti costituziona-li, che hanno delineato un cammino comunitario delle regioni e delle CCaa per molti versi analogo 61.
allo stato attuale, si notano ancora numerose similitudi-ni tra i due ordinamenti: la partecipazione diretta alla fase ascendente del processo normativo comunitario, ad esempio, si svolge attraverso strumenti analoghi, il che appare tutto som-mato ovvio, se si considera che le sedi comunitarie nelle quali gli Enti substatali sono rappresentati sono comuni. il coordi-namento tra centro e periferia, inoltre, si è sviluppato – in en-trambi i Paesi – al di fuori delle assemblee legislative a causa dell’assenza di un ramo del Parlamento effettivamente rappre-sentativo delle istanze regionali, privilegiando le relazioni in-tergovernative e il ricorso allo strumento della conferenza. in italia, peraltro, appare più marcato il tentativo di garantire il coordinamento orizzontale tra le Regioni, al fine di consentire a queste ultime di presentare una posizione comune dinanzi allo Stato; in Spagna, invece, questo tipo di cooperazione tra le CCaa è piuttosto carente, essendo privilegiato, al contrario, il confronto bilaterale tra Stato e singole CCaa.
differenze di rilievo, invece, si riscontrano nella fase di at-tuazione del diritto comunitario. in italia, la riforma del Ti-
Reflexiones a partir de la práctica reciente, in Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 2007, 5, in part. 77 ss., nonché m. gómez Puente, La responsabi-lidad por incumplimiento del derecho comunitario, in m. CienFuegoS mateo, e. alBertí roVira, d. ordóñez SolíS, m. gómez Puente, estatuto y unión europea, Barcelona, iEa, 2006, in part. 176 ss.
61 in questo senso, t. groPPi, Unione europea e Regioni: una prospettiva comparata, in g. CarPani, t. groPPi, m. oliVetti, a. SiniSCalChi (a cura di), Le Regioni, cit., 191.
daniele Coduti
518
tolo v e i successivi interventi normativi, pur riconoscendo espressamente un ruolo comunitario delle regioni, appaiono volti a garantire soprattutto il rispetto degli obblighi comuni-tari da parte dello Stato italiano nel suo complesso piuttosto che il recepimento del diritto comunitario attraverso modali-tà adeguate alle specificità regionali 62. Nello stesso tempo, le regioni sono state piuttosto timide nel prevedere negli statuti specifici strumenti per il rispetto degli obblighi comunitari. In Spagna, invece, la riforma degli eeaa iniziata nel 2006 con l’approvazione del nuovo ea catalano pare voler valorizzare il ruolo delle CCaa nell’ambito delle relazioni comunitarie, con-siderato anche il ruolo determinante delle disposizioni statu-tarie nella definizione dei rapporti con l’Ue.
in effetti, il diverso peso riconosciuto ai rapporti con l’ue nelle carte statutarie italiane e spagnole è sicuramente il ri-flesso della differente natura dei due tipi di fonti 63. Nell’ordi-namento italiano, lo statuto delle regioni ordinarie è una fon-te regionale rinforzata «a competenza riservata e specializza-ta» 64, che si presenta – prevalentemente – come un atto di au-tonomia organizzativa (almeno in parte) gerarchicamente so-vraordinato alla legge regionale, ma che non rappresenta una sorta di costituzione regionale, sebbene possa derogare alla Costituzione nella definizione della forma di governo regiona-le 65. gli eeaa, invece, fanno pienamente parte del c.d. bloque
62 …probabilmente a causa della «non brillante performance delle regioni nell’attuare le direttive comunitarie», come afferma m. SaVino, Regioni e unione europea: il mancato «aggiramento» dello Stato, in Le Regioni, 2007, 3/4, 458.
63 Per una lettura comparata si v. g. d’elia, l. Panzeri, i contenuti ul-teriori degli statuti d’autonomia delle Regioni italiane e delle comunidades autónomas, in diritto pubblico comparato ed europeo, 2009, 4, 1581 ss.
64 cosi, c. cost., sent. 372/2004, punto 2 del considerato in diritto.65 L’impossibilità di considerare lo statuto ordinario alla stregua di una
sorta di costituzione regionale trova una conferma nella giurisprudenza costi-tuzionale sulle c.d. enunciazioni di principio contenute negli statuti regiona-li: c. cost., sentt. 372, 378 e 379/2004, sulle quali si rinvia a m. BenVenuti, Le enunciazioni statutarie di principio nella prospettiva attuale, in r. BiFulCo (a cura di), Gli statuti, cit., 21 ss., e all’ampia bibliografia ivi citata; queste senten-ze sono state ‘evocate’ nella prima pronuncia del tribunal Constitucional sui nuovi eeaa: cfr. stC 247/2006, il voto particular del giudice J. delgado Barrio, punto 4, nonché m. iaCometti, La “prima volta” di un nuovo Statuto (quello
il “cammino comunitario” di Regioni e comunidades autónomas
519
de la constitucionalidad 66, tanto da non poter essere modifica-ti – né direttamente, né indirettamente – da leggi statali 67; le disposizioni statutarie, inoltre, contribuiscono ad integrare le disposizioni costituzionali, concorrendo a determinare e defini-re il riparto di competenze tra Stato e singole CCaa, nonché la stessa forma di stato della Spagna 68 (sebbene l’articolata
valenciano) di fronte al Tribunale costituzionale, in diritto pubblico compara-to ed europeo, 2008, 2, in part. 717, J. tornoS maS, La sentencia del tribunal constitucional 247/2006 y el sistema constitucional de distribución de compe-tencias entre el estado y las Comunidades autónomas, in Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 2008, 7, 79 ss., e m.á. CaBelloS eSPiérrez, La relación derechos-Estado autonómico en la sentencia sobre el Estatuto valenciano, ivi, pp. 106 ss. Sulla natura degli statuti regionali dopo la riforma del Titolo v si rinvia, ex plurimis, a r. Bin, Riforma degli statuti e riforma delle fonti regiona-li, in Le Regioni, 2000, 3/4, 519 ss., a. d’atena, La nuova autonomia statuta-ria delle Regioni, in Rassegna parlamentare, 2000, 3, 603 ss., id., I nuovi statu-ti regionali ed i loro contenuti programmatici, in id. (a cura di), I nuovi Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria, Milano, 2008, 55 ss., r. BiFulCo, Nuovi statuti regionali e («nuovi») diritti regionali, in Giurisprudenza italiana, 2001, 1757 ss., m. oliVetti, Nuovi statuti e forma di governo delle Regioni, Bologna, 2002, in part. 176 ss., F. drago, L’incerta qualificazione giuridica dello statu-to regionale: atto avente forza di legge della regione?, in www.federalismi.it, 23 marzo 2006, 1 ss., g. d’aleSSandro, I nuovi statuti delle Regioni italiane, Padova, 2009, in part. 255 ss., e F. ghera, Lo statuto regionale ordinario: con-tenuti, funzione e posizione nel sistema delle fonti del diritto, in J.m.ª CaStellà, m. oliVetti (a cura di), Nuevos Estatutos, cit., 85 ss.
66 Sul quale ci si limita a rinviare a F. ruBio llorente, el bloque de consti-tucionalidad, in Revista Española de Derecho Constitucional, 1989, n. 27, 9 ss.
67 cfr. stC 76/1983, FJ 4, sulla quale S. muñoz maChado, La interpre-tación de la Constitución, la armonización legislativa y otras cuestiones, in Revista Española de Derecho Constitucional, 1983, 9, 117 ss., l. PareJo alFonSo, Algunas reflexiones sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, de 5 de agosto de 1983, relativa al proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso autonómico, ivi, pp. 147 ss., e. garCía lóPez, estado de las au-tonomías, Constitución económica y tribunal Constitucional, in Revista de estudios Políticos, 1984, 39, 107 ss.
68 in questo senso la già citata stC 247/2007, FJ 6. Sulla natura e il contenuto degli eeaa si v. C. aguado renedo, el estatuto de autonomía y su posición en el ordenamiento jurídico, Madrid, cEc, 1996, J.m.ª CaStellà andreu, La función constitucional del Estatuto de Autonomía de Cataluña, Barcelona, iEa, 2004, F. domínguez garCía, Los estatutos de autonomía de las Comunidades autónomas: una aproximación a los principales deba-tes doctrinales, in Revista catalana de dret públic, 2005, 31, 1 ss., J. Ferret JaCaS, estatutos de autonomía: función constitucional y límites materiales, ivi, 1 ss., nonché J.m.ª CaStellà andreu, e. martín nuñez, estatuto de auto-
daniele Coduti
520
sentenza sul nuovo ea catalano – la già citata stC 31/2010 – sia parsa, almeno a parte della dottrina spagnola, fornire una lettura riduttiva del ruolo degli eeaa 69). La differenza tra le due fonti “regionali”, aiuta a comprendere perché, diversamen-te da quanto accaduto in italia, i nuovi eeaa riservino molta attenzione alla disciplina dei rapporti con l’ue e con lo Stato in materia comunitaria, dedicandovi parti organiche e piutto-sto dettagliate del testo statutario 70. Nonostante ciò, sembra evidente che le regioni italiane non abbiano saputo sfruttare l’occasione della riforma costituzionale del Titolo v e delle con-seguenti riforme statutarie per valorizzare il loro “ruolo comu-nitario”, predisponendo negli statuti un adeguato complesso di strumenti di partecipazione al processo di integrazione comu-nitaria, ai quali solo alcune regioni fanno riferimento 71, pe-raltro in maniera disorganica (si pensi, ad esempio, a quelle disposizioni che riguardano l’apertura di uffici regionali presso le sedi comunitarie, gli obblighi di informazione tra gli organi di vertice dell’ordinamento regionale, o la creazione di commis-sioni consiliari per gli affari comunitari; ecc.).
nomía y sistema de fuentes autonómico, in J.m.ª CaStellà, m. oliVetti (a cura di), Nuevos Estatutos, cit., 47 ss., e e. exPóSito, Las competencias en los nue-vos Estatutos de Autonomía, ivi, 105 ss.
69 cfr., ad es., J.mª CaStellà andreu, La sentencia del tribunal Constitucional 31/2010, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y su si-gnificado para el futuro del Estado Autonómico, in www.federalismi.it, 6 ot-tobre 2010, 20-21, nonché e. alBerti roVira, Concepte i funció de l’estatut d’autonomia en la stC 31/2010, de 28 de Juny, sobre l’estatut d’autonomia de Catalunya, 1 ss., e e. FoSSaS, el estatuto como norma y su función consti-tucional. Comentario a la stC 31/2010, 1 ss., entrambi pubblicati nel nume-ro speciale della Revista catalana de dret públic dedicato alla sentenza e con-sultabile in www.rcdp.cat.
70 J.m.ª CaStellà andreu, Las Comunidades, cit., 39, definisce tale nor-mativa statutaria «novedosa y prolija».
71 al riguardo, si rinvia alle osservazioni di S.m. CarBone, P. iValdi, La partecipazione delle Regioni agli affari comunitari e il loro potere estero, in Quaderni regionali, 2005, 3, 716, secondo i quali la sfiducia nei confronti degli esiti della riforma del Titolo v «potrebbe di fatto determinare una sorta di “fe-deralismo a più velocità”, nell’ambito del quale soltanto alcune regioni avran-no interesse e saranno in grado di esprimere e realizzare una propria autono-ma “politica di attuazione” della normativa comunitaria», mentre le altre po-trebbero essere tentate di abdicare a tale ruolo in favore dello Stato.
il “cammino comunitario” di Regioni e comunidades autónomas
521
in conclusione, si può osservare che la comparazione tra l’ordinamento italiano e quello spagnolo in merito ai rapporti tra Enti infrastatali e ue offre utili elementi di valutazione.
Tra i due ordinamenti vi sono state e persistono ancora si-gnificative analogie nella partecipazione al processo di inte-grazione comunitaria dei loro Enti substatali: il ruolo deter-minante delle rispettive corti costituzionali; le graduali aper-ture da parte dell’ordinamento statale; l’assenza di una vera e propria camera di rappresentanza delle regioni; il conse-guente sviluppo di relazioni intergovernative attraverso il si-stema delle conferenze, col conseguente rafforzamento degli Esecutivi statali e regionali in materia comunitaria.
a tali analogie si contrappongono importanti differenze. da un lato, la riforma del Titolo v della costituzione italiana, anche se non ha portato alla previsione di un vero e proprio europa-artikel, ha fissato in Costituzione riferimenti espressi all’ue e alla partecipazione delle regioni al relativo processo di integrazione. Si tratta si una riforma che può offrire spun-ti di riflessione utili a quella parte della dottrina spagnola che ritiene necessaria una riforma costituzionale volta ad intro-durre nella costituzione del 1978 espliciti riferimenti all’ue e al coinvolgimento delle CCaa nel processo di integrazione co-munitaria 72. dall’altro, la nuova stagione statutaria spagno-la ha evidenziato una maggiore sensibilità al fenomeno comu-nitario dei riformatori statutari spagnoli rispetto ai loro omo-loghi italiani, che, sebbene appaia favorita dalla natura degli eeaa, pone comunque in evidenza una sottovalutazione del-l’importanza di tali processi da parte delle classi dirigenti re-gionali italiane 73.
72 appare utile ricordare che un’ipotesi di riforma costituzionale era stata formulata dal governo spagnolo nel 2005 e soggetta al parere del Consejo de estado (l’informe del Consejo de estado su tale ipotesi di riforma, datato feb-braio 2006, è consultabile in www.consejo-estado.es): essa riguardava la suc-cessione al trono, il recepimento in costituzione del processo di integrazione comunitaria, l’inclusione nel testo costituzionale della denominazione delle CCaa, nonché la riforma del senado.
73 i due fenomeni, peraltro, appaiono collegati: come osserva m.á. CaBelloS eSPiérrez, La Regulación, cit., pp. 338, infatti, l’assenza di previsioni riferite ai rapporti con l’ue nella costituzione spagnola rende utili le numerose previsio-
daniele Coduti
522
Infine, occorre evidenziare un elemento di criticità comu-ne ad entrambi gli ordinamenti e al quale si è fatto cenno più volte in queste pagine: l’assenza di una vera e propria ca-mera delle regioni 74. infatti, poiché le camere alte di italia e Spagna non sono strutturate in maniera tale da coinvolge-re direttamente regioni e CCaa (anche) nelle fasi ascenden-te e discendente dei processi decisionali comunitari, lo Stato e gli Enti infrastatali devono trovare sedi di confronto ester-ne al Parlamento, contribuendo, così, a rafforzare il ruolo dei rispettivi Esecutivi a discapito di quello delle assemblee rap-presentative 75.
ni statutarie in materia, in attesa di una riforma costituzionale «que parece que no haya de llegar nunca»; di converso, si potrebbe osservare che, laddove vi sia una disciplina costituzionale e legislativa statale piuttosto dettagliata, l’esigen-za di un intervento normativo regionale viene meno avvertita.
74 L’esigenza di provvedere ad una riforma che configuri una delle due camere come effettivamente rappresentativa degli interessi regionali è avver-tita sia in italia sia in Spagna; tra i numerosi contributi sul tema ci si limita a rinviare, rispettivamente, a l. Paladin, Problemi e strumenti attuativi di un possibile federalismo italiano, in Le Regioni, 1996, 4, in part. 615, a. d’atena, Prefazione, in t. groPPi, m. oliVetti (a cura di), La Repubblica delle autono-mie, 1ª ed., Torino, 2001, 2-3, r. BiFulCo, in attesa della seconda camera fede-rale, ivi, 211 ss., S. mangiameli (a cura di), un senato delle autonomie per l’ita-lia federale, Napoli, 2003, g. riVoSeCChi, art. 55, in r. BiFulCo, a. Celotto, m. oliVetti (a cura di), Commentario, ii, cit., in part. 1127-1128, e x. arBóS marín, el senado: marco constitucional y propuestas de reforma, in Revista de las Cortes Generales, 1991, 23, 7 ss., e. aJa, Principales líneas de la refor-ma constitucional del senado, in autonomies, 1995, 20, 51 ss., J.a. alonSo de antonio, estudio sobre la reforma del senado, Madrid, Ed. dykinson, 1999, e. aJa, e. alBertí roVira, J.J. ruiz ruiz, La reforma constitucional del senado, Madrid, cEPc, 2005, J.m.ª CaStellá andreu, the spanish senate after 28 years of constitutional experience. Proposals for reform, in J. luther, P. PaSSaglia, r. tarChi (ed.), a world of second chambers, Milano, 2006, 902 ss., m. Fraile ortiz, il problema del senato in spagna, in Le Regioni, 2008, 6, 1157 ss.
75 Si v., al riguardo, le osservazioni di m. oroFino, La partecipazione del-le Comunità autonome spagnole all’integrazione europea, in diritto pubblico comparato ed europeo, 2001, 3, 1185; sia consentito anche un rinvio alle osser-vazioni svolte in d. Coduti, P. gamBale, il “dialogo polifonico” tra Parlamenti ed Esecutivi nazionali nella fase ascendente dei processi comunitari, in C. deCaro, n. luPo (a cura di), Il “dialogo” tra parlamenti: obiettivi e risultati, roma, Luiss university Press, 2009, 463.
Amministrazione: Mucchi editore - Via emilia est, 1527 - 41100 ModenaGrafica e impaginazione, Mucchi editore (Mo) - Stampa, d. Bluprint (Mo)Direzione, Redazione: Via della traspontina, 21 - 00193 roma
Direzione scientificagiuseppe dalla torre - ord. lumsa di romaMario caraVale - ord. università di roma “la sapienza”francesco paolo casaVola - pres. em. corte costituzionalefrancesco d’agostino - ord. università di roma “tor Vergata”giuseppe de Vergottini - ord. università di BolognaVittorio gasparini casari - ord. università di Modena e reggio emilialuciano euseBi - ord. università cattolica di piacenzaluigi laBruna - prof. em. università di napoli “federico ii”pasquale lillo - ord. università della “tuscia” di Viterboferrando MantoVani - ord. università di firenzeManlio Mazziotti - prof. em. università di roma “la sapienza”paolo Mengozzi - ord. università di Bolognafrancesco Morandi - ord. università di sassarialBerto roMano - ord. università di roma “la sapienza”MassiMo stipo - ord. università di roma “la sapienza”
Redazione
prof.ssa Maria pia Baccari prof. angelo Mangioneprof. paolo caVana prof.ssa laura palazzaniprof.ssa eManuela giacoBBe prof.ssa iolanda piccininiprof.ssa Monica lugato prof. angelo rinella
Mucchi editore s.r.l.Via emilia est, 1527 - 41122 Modenatel. 059.37.40.94 - fax 059.28.26.28
internet: WWW.Mucchieditore.ite-mail: [email protected]
l’abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell’annata, com-presi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell’invio dei fascicoli gli abbonamen-ti si intendono rinnovati per l’anno successivo se non disdettati con apposita segnalazione entro la scadenza. i fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal rice-vimento del fascicolo successivo. decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell’importo. per ogni effetto l’abbonato elegge domicilio presso l’amministrazione della rivista. le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell’anno in corso. si ac-cordano speciali agevolazioni per l’acquisto in contanti di più annate arretrate, anche non conse-cutive, della stessa rivista. il cliente ha la facoltà di revocare eventuali ordini unicamente median-te l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax o telegramma (seguiti da una raccomandata con ricevuta di ritorno entro le successive 48 ore) atti a consentire l’identifica-zione del cliente e dell’ordine revocato (merce, data, luogo, etc.) alla sede della casa editrice. la disdetta deve essere spedita entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.
archiVio giuridico “Filippo Serafini”