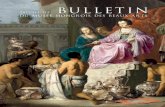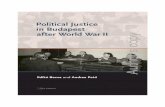I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság....
Transcript of I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság....
I.
I SACERDOTI CONOSCIUTI – note alle fonti –
D 1
Adde bar Semei
Colonna. Ampelum. CIL, III, 1301b; CIL, III, 7835; ILS, 4299; Kerényi 2126; Kan II, 30; Merlat 29; Hettner 4; Merlat 29; Russu 1969, 177-182; Angyal-Balla 1972, 94 n. 5; Tóth I. 1976, 16, n. 22; Noeske 1977, 370, nr. 71; Berciu-Popa 1978, nr. 11; IDR, III/3, 299; CCID, 148; Sanie 1989, 1246, nr. 5; Wollmann 1996, 183-184; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) et | Deo Com|aceno | Aurel(ius) | Marinus | [et] Adde bar Seme|i et Ocea|nus So|cratis sa|cerdotes | v(otum) l(ibentes) p(osuerunt). L’epigrafe è databile alla fine del II e all’inizio del III secolo d.C., per ragioni formali. Il gentilicium Aurelius di uno dei dedicatori senza praenomen rinvia la datazione dell´iscrizione agli anni dopo il 212 d. C. Adde bar Semei fu – in base al nome – di origine siriaca o palmirese.i Oltre la carica sacerdotale in onore di Iuppiter Dolichenus (sacerdos) non gli si conoscono altre diginità. Il nome non ci rinvia, ma anche lui poté ricevere la cittadinanza romana dopo la Constitutio Antoniniana. La sua funzione con altri due colleghi [D 35, 69] può essere in rapporto con l’esistenza, oppure eventualmente con la fondazione di un dolichenum [cfr. D 81]. Se esisteva una comunità cultica – per es. un collegium – e se il Dolichenum di Ampelum stava in area pubblica, i sacerdoti potevano esercitare un sacerdotium ufficiale [cfr. D 37]. Della carriera di Adde bar Semei (in un´altra pubblicazione Adde Barsemei) possono essere schizzati i seguenti in base ai dati conosciuti: (cittadino romano?), dopo il 212 d. C. sacerdos.
D 2
[?P(ublius) oppure T(itus) Ae]l(ius) Ael[ianu]s ? Altare. Apulum. Marosportó (Partoş), CIL – „ in ruderibus templi”. Sparito. CIL, III, 6262; Kerényi 8; Ardevan 345; IDR, III/5, 123; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | [?P(ublius) o T(itus) ? Ae]l(ius) Ael[ia]|[nu]s pont[ifex] | [col(oniae)] Apul(ensis) e[q(uo) p(ublico)] | [pr]o salut[e sua] | [suo]rum[q]u[e v(otum) s(olvit?]. L’epigrafe è databile agli anni dopo il 180 d. C., in base alla presenza del rango coloniale di Apulum nel testo. All’inizio della seconda riga, nella parte mancante si possono inserire precisamente un praenomen abbreviato con una lettera e le due lettere del nomen, che aderiscono alla “L”. In questa costruzione non si può ipotizzare altro nomen che Ael(ius), davanti a cui poteva stare il praenomen P(ublius) oppure T(itus). I nomen e praenomen completati – e perciò ipotizzati – di [? P(ublius) oppure ? T(itus) Ae]l(ius) Ael[ianu]s rinviano ad una cittadinanza romana ottenuta dall’antenato con questo nome sotto Hadrianus oppure Antoninus Pius. Il cognomen è conosciuto nelle province occidentali, tranne Germania, ed ha analogie in Italia settentrionale.ii In base al luogo del ritrovamento possiamo affermare che fu il pontifex della colonia di Apulum. Come pontifex salì nell’ordine equestre. Nella stessa epoca fu eretto un altro altare con un’iscrizione di struttura molto simile [v. D 3], con l’indicazione uguale della carica e con l’identica formula finale, in cui il praenomen è rimasto: P(ublius). Le comuni caratteristiche formali e contestuali dei due testi supporrebbero la loro attribuzione alla stessa persona. I. Piso nella sua ultima competente pubblicazione sull´epigrafe ha preso in considerazione questa possibilità, ma non teneva i dati sufficienti per l’identificazione delle due persone.iii Però con le possibili integrazioni a causa della condizione frammentaria, ci possono essere più dati per l’identificazione, i quali però non significano sicurezza. Al momento della dedica il sacerdote non poteva essere molto anziano, in base alle poche cariche indicate, oppure era così vecchio, che non occupava nessun ufficio pubblico, per questo poteva indicare solo le sue cariche a vita e il rango sociale. Dunque non si può stimare la sua età. È poco probabile, che fece segnalare solo questi due elementi della sua carriera, che indicavano praticamente il suo rango e stato, se ne aveva anche altri. Riassumendo la sua carriera in base al testo fino alla dedica dell’epigrafe: dopo il 180 d. C. – pont[ifex] [col(oniae)], e[q(uo) p(ublico)].
D 3
P(ublius) Ae[l(ius) ? ---]us
Altare.
MANUSCRIPT
Apulum. CIL – „Eisenbahnlinie zwischen Carlsburg und Maros-Portó”. CIL, III, 12560; Kerényi 9; AÉ, 1983: 816; Petolescu 1984, 378, nr. 234; Ardevan 352; Mrozewicz 1999, 72, nr. 14; IDR, III/5, 374; ---] | P(ublius) Ae[l(ius) ---]us | po[ntifex co]l(oniae) | Apu[lensis eq(uo)] p(ublico) | pro sa[lute s]u[a] | suor[umqu]e | votum solvit. In base alla fondazione della colonia l’epigrafe fu eretta dopo il 180 d. C. Benché l’identificazione con il dedicatore dell’iscrizione precedente [D 2] sembri evidente, I. Piso non lo ritiene probabile.iv Si possono elencare, però, più argomenti per l’identità, mentre solo la condizione frammentaria delle due epigrafi e la mancanza del cognomen, e perciò più integrazioni possibili, sono contro. Però in mancanza di punto d’appoggio diretto, i dedicatori delle due iscrizioni devono essere trattati come due persone diverse. Secondo il suo nomen e praenomen egli fu il discendente di una famiglia, che aveva ottenuto la cittadinanza romana sotto Hadrianus. Dopo esser eletto pontifex salì nell’ordine equestre. Per quanto riguarda la sua carriera, il testo dell’iscrizione contiene solo gli elementi attuali del momento della dedicazione, per questo dovette appartenere ad una generazione giovane. Riassumendo gli elementi conosciuti ed ipotizzati della sua carriera in base all´iscrizione: dopo il 180 d. C. – po[ntifex co]l(oniae), [eq(uo)] p(ublico).
D 4
T(itus) Ael(ius) T(iti) Ael(i) Zeuxi fil(ius) Pa[p(iria tribu)] Aelianus
Base. Drobeta. AÉ, 1959: 317; Tudor 1968 (Olt), nr. 47; IDR, II, 13; AÉ, 1981: 718; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 17; ILD 57; T(ito) Ael(io) T(iti) Ael(i) Zeuxi fil(io) Pa[p(iria tribu)] | Aeliano IIvir(o) fla[m(ini)] | patrono col(oniae) Drob(etae) eq(uo) [p(ublico)] | [praef(ecto) coh(ortis) I] Noric[orum ---] | [---. L’epigrafe fu eretta dopo il 235 d. C. In base al cognomen del padre T(itus) Ael(ius) Aelianus venne dall’area linguistica greca.v Il suo antenato, che aveva preso questo nome, ottenne la cittadinanza romana nell’epoca di Antoninus Pius. È appariscente, che appartenne alla tribus Papiria, il che era caratteristico nella Dacia solo nella colonia di Sarmizegetusa a causa della sua fondazione. In base a ciò suo padre o lui poteva trasferirsi a Drobeta possibilmente da Sarmizegetusa. L’iscrizione contiene il suo cursus in due parti, e in ogni parte verosimilmente in ordine cronologico. Prima sono indicati gli elementi in connessione con la città e il suo rango equestre che rispecchiava lo stato sociale, poi il testo dell’epigrafe continua a descrivere la sua carriera militare. Il patronatusvi dovette seguire cronologicamente le cariche militari indicate nella parte mancante dell’epigrafe. Questo scioglimento sembra più accettabile rispetto alla soluzione precedente, ripubblicata sotto il numero ILD 57, in cui dalla fine della terza riga il testo è: „...eq(uestrem) | [statuam pos(uit). Ho]nor(e) c[ont(entus)] | [sumptum remisit]”. Per esempio in questo caso le dimensioni della base dovrebbero corrispondere a quelle di una base per una statua equestre.vii Le stazioni della sua carriera municipale cominciano con il IIviratus.viii Prima, come decurio oppure come eques dovette rivestire anche altri uffici del cursus municipale, precedenti al IIviratus, ma non li fece segnalare. Dopo o durante il IIviratus fu eletto il flamen della colonia.ix Gli elementi della carriera militare segnalati nel testo dopo le cariche municipali sono sicuramente precedenti nella cronologia. Come eques dovette fare carriera militare e dopo il congedo divenne un magistrato municipale. Un ordine inverso è molto meno probabile. In base al testo si può identificare della sua carriera militare solo la militia prima: praefectus cohortis I Noricorum. Non è da escludere che rivestì anche le altre due cariche degli ufficiali della militia equestris. La statua che stava una volta sulla base dovette esser eretta per lui dalla città sotto il suo patronatus. Riassumendo la sua carriera in base ai dati indicati nel testo dell´iscrizione: dall’inizio del III secolo D. C. – eq(uo) [p(ublico)], [praef(ectus) coh(ortis) I] Noric[orum], (militia secunda, militia tertia?, quaestor e/o aedilis?), IIvir, fla[m(en)], patronus col(oniae).
D 5
P(ublius) Ael(ius) Antipater
a. Base. Apulum. Marosportó (Partoş). AÉ, 1930: 7; Cucuiu 1929, 25; Daicoviciu 1929, 304, nr. 6; Kerényi 56, 72, 270, 1840, 1841; Daicoviciu 1966, 153; Daicoviciu 1969, 388-389 nr. 6; Daicoviciu-Piso 1977, 76-77, nr. 1; Ardevan 1984, 95-110; Devijver 1986, A 22; IDR, III/5, 215; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Cust(odi) | Iunoni Miner|vae ceteris|que dis deabus|que P(ublius) Ael(ius) Anti|pater IIvira(lis) | col(oniae) Apul(ensis) et An|tonia Iulia | eius et Aelii An|tipater Iulia|nus Genialis | deccc(uriones) col(oniae) eq(uo) p(ublico) e(t) Iu<l>ia | filii eor(um) pro salute | sua suorumque.
MANUSCRIPT
Fine del II, inizio del III secolo d. C. b. Epigrafe votiva. Apulum. La cittadella di Gyulafehérvári (Alba Iulia, Karlsburg – Cetate). Sparita. CIL, III, 1104; Kerényi 59, 79, 1840; Daicoviciu 1969, 143, nr. 6; Daicoviciu-Piso 1977, 76; Devijver 1986, A 22; Ardevan 332; IDR, III/5, 259; Minerv(ae) | P(ublii) Ael(ii) An|tipater | Iulianus | Genialis | eq(uo) p(ublico) dec(uriones) | col(oniae) Apuli q(uaestoricii?). Inizio del III secolo d. C. Dato che tutti e tre figli pervennero al duumviratus, avevano dovuto rivestire prima almeno la carica della quaestura. Probabilmente a questo, alla quaestura rivestita per un anno da tutti e tre, rinvia l’abbreviazione Q, che non si può sciogliere in altro modo. Come una formula finale del voto non la si può identificare. c. Altare. Tibiscum. Sparito (?). CIL, III, 1573; Tudor 1957, 270, nr. 124; IDR, III/1, 65; Herculi sancto Eutyches act(or) | P(ubli) Aeli Antipatri ex voto posuit. Inizio del III secolo d. C. d. Base. Apulum. CIL, III, 1181; EE, IV, nr. 155; Groag 1913, 18, nr. VI; Kerényi 89, 1633, 1843, 1968; Tudor 1957, 252, nr. 55; Balla 2000, 116, nr. 2, 7; Devijver 1986, A 22; Daicoviciu–Piso 1977, 77, nr. 5; Fitz 1992-1995, 938-940, nr. 648; Mrozewicz 1999, 69, nr. 3; Ardevan 295; IDR, III/5, 439; P(ublio) Ael(io) Antipat|ro Marcello | eq(uiti) R(omano) dec(urioni) col(oniae) Ap(ulensis) | fil(io) P(ubli) Ael(i) Antipa|tri a mil(itis) et IIvir(i) | col(oniae) s(upra) s(criptae) et adoptivo | P(ubli) Ael(i) Marcelli v(iri) | e(gregi) ex praef(ecto) legi|on(um) VII Claud(iae) et | I Adiut(ricis) Dades et | Filetus actor(es). Primo quarto del III secolo d. C. e. Altare. Apulum. Marosportó (Partoş). AÉ, 1930: 8; Cucuiu 1929, 31; Daicoviciu 1929, 305, nr. 7; Daicoviciu 1969, 143, nr. 7; Daicoviciu 1969, 388, nr. 5; Kerényi 1839, 2035; Tudor 1957 252, nr. 54; AÉ, 1959: 304; Birley 1969, 82; Daicoviciu – Piso 1977, 76, nr. 1; Devijver 1976-1980, A 22; Devijver 1986, A 22; Devijver 1989, 54; Ardevan 358; Szabó Á. 2001, 99-103; Szabó Á. (1999) 2000, 119-150; IDR, III/5, 210; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 109, 4; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Cons(ervatori) | pro salute | P(ubli) Ael(i) Antipatri(s) | sac(erdotis) Arae Aug(usti) | sua suorumque | omniu(m) Onesimus || actor | v(otum) s(olvit). Seconda metà del primo terzo del III secolo d. C. f. Tavola del piedistallo per una statua. Sarmizegetusa. Area sacra. AÉ, 1977: 689; Daicoviciu – Piso 1977, 75-76; IDR, III/2, 217; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 183; Szabó Á. 2001, 99-103; AÉ, 2001: 1718; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 109, 4.b; ILD 246; [[---]] | [[--- et]] | Geni[o Daciar(um)] | P(ublius) Ael(ius) A[ntipater] | flame[n colon(iae)] | Apulen[sis sac(erdos)] | Arae A[ugusti] | ex s(uis?) mu[neribus?] | donu[m dedit]. Seconda metà del primo terzo del III secolo d. C. Egli è conosciuto tramite sei epigrafi databili al periodo dalla fine del II secolo, quindi dal 180, e al primo terzo del III secolo d. C.. Per ragioni formali e contestuali tutte e sei epigrafi possono essere attribuite a lui. Si conoscono anche altri membri della famiglia, di tre generazioni. Benché siano di Apulum, a causa dell´appartenenza alla tribus Papiria di suo fratello [D 7] la famiglia poté essere originalmente di Sarmizegetusa. Da qui si trasferirono ad Apulum, dopo la fondazione. Dunque il IIvir apulense di una volta [a.] e la moglie ebbero tre figli e una figlia. I figli del IIvir della colonia,x magistrato quindi al più tardi dopo il 180, nacquero in rango di decurio, e dovettero diventare i membri dell’ordine equestre molto presto per ragioni censuarie e occuparono varie cariche municipali nella colonia di Apulum, dopo l’ufficio del padre nella colonia, circa negli ultimi decenni del II secolo. I loro praenomen e gentilicium rinviano a Hadrianus: l’antenato della famiglia, che prese questo nome, aveva ottenuto la cittadinanza romana probabilmente da questo imperatore tra il 117 e 138 d. C. Lo storico cognomen Antipater del padre e del figlio più grande suggerisce una connessione con la parte greca dell’impero.xi Allo stesso rinvia il
MANUSCRIPT
gentilicium Antonia della madre. Non è da escludere una parentela tramite la madre con il sommo sacerdote della provincia, M(arcus) Antonius Valentinus [D 27], e eventualemente con L. Antonii di Sarmizegetusa,xii ma non si può neanche provarla. P(ublius) Ael(ius) Antipater fu nato nell’ordo decurionum e divenne il membro dell’ordine equestre già nella prima gioventù [a., b.]. Da giovane poté fare anche il servizio militare, a cui rinvia l’indicazione del rango equestre in forma militis nell’epigrafe d. Dato che il suo rango era già segnalato precedentemente in forma equo publico, la parola militis può rinviare al rivestimento delle tres militiae [d.]. Della carriera municipale si leggono nelle iscrizioni il decurionatus e il IIviratus. Quest’ultimo si trova prima della parola militis [d.], che dimostra il fatto altrimenti logico, che, se egli fece servizio militare, lo fece prima delle alte funzioni municipali, e, secondo l’interpretazione possibile dell’epigrafe b., dopo la quaestura. Perché nessuna iscrizione suggerisce unanimamente, che egli rivestì anche la bassa magistratura municipale, solo la lettera Q dell’epigrafe b., che si può sciogliere con grande riserva come q(uaestores) alla luce della carriera posteriore di tutti e tre figli [v. D 6 e 7]. Dato che il IIviratus presupponeva la bassa magistratura, si doveva rivestire la quaestura o l’aedilitas, ma a volte tutte e due. Dopo la bassa magistratura e – probabilmente – il servizio militare egli fu eletto IIvir nella colonia di Apulum [d]. Occupò due uffici sacerdotali: quello di flamenxiii nella colonia Aurelia Apulensium, e un altro di sommo sacerdote della provincia, con il titolo di sacerdos Arae Augusti [e., f.]. Fu eletto flamen dopo il IIviratus e prima della carica del sommo sacerdote [cfr. d., f.]. Fece erigere la base con l’indicazione della carica di flamen come sacerdote e perciò fece segnalare solo due uffici sacerdotali. L’epigrafe d. e quella sulla figlia di suo fratello [D 6, c.] furono erette dalle stesse persone con lo stesso testo, e forse nello stesso tempo. A quel tempo suo fratello fu già il flamen della colonia, benché degli uffici di Antipater sia indicato nel testo solo il duumviratus. Egli divenne flamen nella colonia di Apulum probabilmente dopo il fratello (eventualmente dopo la morte del fratello) che si conosce solo tramite questa fonte [D 6]. Il flaminatus di Antipater sta cronologicamente più vicino alla sua carica di sommo sacerdote che al IIviratus. Rivestì il summus honor,xiv l’ufficio di sommo sacerdote per un anno, come l’apice della sua carriera. In base al titolo di sommo sacerdote questo accadde nei primi due decenni (eventualmente nel terzo decennio) del III secolo d. C., fino ai primi anni del regno di Severus Alexander. L’inizio del dominio dell’imperatore nel 222 d. C. non significa automaticamente la riorganizzazione immediata della struttura del consiglio provinciale e del culto dell’imperatore nella Dacia. Ma l’unico punto d’appoggio per la data è l’inizio del suo regno.xv Secondo la base, la statua fu eretta per Antipater nell’anno della carica di sommo sacerdote [e.], ed egli fece incidere l’iscrizione della base f. similmente in quest’anno. Uno dei suo figli, insieme alla figlia di suo fratello [D 6, c.], fu adottato da P(ublius) Aelius Marcellus [D 8], che fu il suo parente, probabilmente il suo cugino [d], ma in nessun modo suo fratello, dato che il suo nome non si trova nelle epigrafi “della famiglia” [a., b.]. Per interessi pubblici o commerciali ebbe in servizio actores,xvi che poterono essere anche i liberti della famiglia [cfr. anche d.]. Due di loro sono conosciuti tramite lui, altri due tramite suo figlio. Riassumendo la sua carriera: negli ultimi due decenni del II secolo d. C., dopo il 180 - decurio col(oniae), e(quo) p(ublico), q(uaestor?), (? carriera militare equestre - militia prima, secunda, tertia?), a cui rinvia probabilmente l’espressione a mil(itis), IIvir, flame[n] col(oniae), alla fine degli anni ‘210 e all’inizio degli anni ‘220 - sac(erdos) Arae Aug(usti), (sacerdotalis Arae Augusti).
D 6
P(ublius) Ael(ius) Iulianus a. Base. Apulum. Marosportó (Partoş). AÉ, 1930: 7; Cucuiu 1929, 25; Daicoviciu 1929, 304, nr. 6; Kerényi 56, 72, 270, 1840, 1841; Daicoviciu 1969, 143, nr. 6, 388-389; Daicoviciu-Piso 1977, 76-77, nr. 1; Ardevan 1984, 95-110; Devijver 1986, A 22; IDR, III/5, 215; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Cust(odi) | Iunoni Miner|vae ceteris|que dis deabus|que P(ublius) Ael(ius) Anti|pater IIvira(lis) | col(oniae) Apul(ensis) et An|tonia Iulia | eius et Aelii An|tipater Iulia|nus Genialis | deccc(uriones) col(oniae) eq(uo) p(ublico) e(t) Iu<l>ia | filii eor(um) pro salute | sua suorumque. Fine del II secolo, inizio del III secolo d. C. b. Epigrafe votiva. Apulum. La cittadella di Gyulafehérvári (Alba Iulia, Karlsburg – Cetate). Sparita. CIL, III, 1104; Kerényi 59, 79, 1840; Daicoviciu 1966, 153; Daicoviciu 1969, 143, nr. 6, 388-389; Daicoviciu-Piso 1977, 76; Devijver 1986, A 22; Ardevan 332; IDR, III/5, 259; Minerv(ae) | P(ublii) Ael(ii) An|tipater | Iulianus | Genialis | eq(uo) p(ublico) dec(uriones) | col(oniae) Apuli q(uaestoricii?). Inizio del III secolo d. C. c. Base. Apulum. Marosportó (Partoş). CIL – „Ad portam archidiaconi Dobocensis”. Sparita. Bongarsius 1600, 623; CIL, III, 1182; Kerényi 78, 89, 179, 1633, 1968; Tudor 1957, 253, nr. 56; Daicoviciu-Piso 1977, 77, nr. 6; Ardevan 1984, 95-110; Devijver 1986, A 22; Ardevan 1992, 47-53; Kajava 1994, 183; Fitz 1992-1995, 938-940, nr. 648; Mrozewicz 1999, 70, nr. 7; Ardevan 296; IDR, III/5, 441;
MANUSCRIPT
Publiae Aeli|ae Iulianae | Marcellae s(plendidissimae) p(uellae) | fil(iae) P(ubli) Ael(i) Iuliani | eq(uitis) R(omani) flam(inis) et IIvi|ral(is) col(oniae) Ap(ulensis) et ad|optiv(a)e P(ubli) Ael(i) Mar|celli v(iri) e(gregi) ex pr|aef(ecto) legg(ionum) VII Cl(audiae) | et I Adiut(ricis) Dades || et Filetus actor(es). III secolo d. C. L’aggettivo s(plendidissima) p(uella) indica l’appartenenza della ragazza ad una famiglia dell’ordine equestre.xvii Egli è conosciuto tramite tre epigrafi di Apulum, tutte databili dopo il 180 d. C. Si conoscono parecchi membri della sua vasta famiglia di cittadinanza adrianea e della sua parentela estesa,xviii di tre generazioni [cfr. D 5, 7]. Secondo l´indicazione della tribus di suo fratello [D 7] la famiglia venne eventualmente da Sarmizegetusa. Il cognomen latino di P(ublius) Ael(ius) Iulianus è in generale frequente nelle province occidentali.xix Per la discendenza e lo stato finanziario fu il membro dell’ordo decoriunum, e salì presto nell’ordine equestre, dimostrato nelle epigrafi dalle formule eq(uo) p(ublico) [a., b.] ed eq(ues) R(omanus) [c.]. Le diverse forme per descrivere la sua apprtenenza all’ordine equestre significano in sostanza lo stesso, le due forme diverse possono essere spiegate probabilmente con gli eventi sconosciuti della carriera, come anche nel caso del fratello, Antipater [D 5]. Il suo primo ufficio municipale fu probabilmente la q(uaestura?) [b.]. Poi divenne il flamen della colonia,xx in seguito fu eletto IIvir.xxi Dopo il IIviratus continuò a lavorare per un certo tempo come flamen, che è dimostrato dal IIviratus indicato in tempo passato nell’epigrafe [c.]. Non gli sono conosciute altre cariche, è possibile che morì nel primo quarto del III secolo. Sua figlia fu adottata da P(ublius) Ael(ius) Marcellus, come ci tramanda l’iscrizione della base di statua eretta dagli actores appartenenti alla famiglia [c.]. Riassumendo la sua carriera secondo le iscrizioni: alla fine del II secolo d. C. - dec(urio) col(oniae), eq(uo) p(ublico), q(uaestor?), eq(ues) R(omanus), flam(en), (IIvir) IIviral(is) col(oniae).
D 7
P(ublius) Ael(ius) P(ubli) fil(ius) Pap(iria) Genialis
a. Base. Apulum. Marosportó (Partoş). AÉ, 1930: 7; Cucuiu 1929, 25; Daicoviciu 1929, 304, nr. 6; Kerényi 56, 72, 270, 1840, 1841; Daicoviciu 1966, 153; Daicoviciu 1969, 143, nr. 6; Daicoviciu-Piso 1977, 76-77, nr. 1; Ardevan 1984, 95-110; Devijver 1986, A 22; IDR, III/5, 215; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Cust(odi) | Iunoni Miner|vae ceteris|que dis deabus|que P(ublius) Ael(ius) Anti|pater IIvira(lis) | col(oniae) Apul(ensis) et An|tonia Iulia | eius et Aelii An|tipater Iulia|nus Genialis | deccc(uriones) col(oniae) eq(uo) p(ublico) e(t) Iu<l>ia | filii eor(um) pro salute | sua suorumque. Fine del II secolo d. C. b. Epigrafe votiva. Apulum. La fortezza di Gyulafehérvári (Alba Iulia, Karlsburg – Cetate). CIL, III, 1104; Kerényi 59, 79, 1840; Daicoviciu 1969, 143, nr. 6; Daicoviciu-Piso 1977, 76; Devijver 1986, A 22; Ardevan 332; IDR, III/5, 259; Minerv(ae) | P(ublii) Ael(ii) An|tipater | Iulianus | Genialis | eq(uo) p(ublico) dec(uriones) | col(oniae) Apuli q(uaestoricii?). L’inizio del III secolo d. C. c. Base. Apulum. Sparita. CIL, III, 1208; Kerényi 60, 1656; Tudor 1957, 193, 213, 255, nr. 70; Daicoviciu-Piso 1977, 76; Devijver 1986, A 22; Ardevan 298; IDR, III/5, 440; P(ublio) Ael(io) P(ubli) fil(io) Pap(iria tribu) | Geniali dec(urioni) | et pontifici | col(oniae) Apul(ensis) pa|tron(o) colleg(i) | cent(onariorum) P(ublius) Ael(ius) | Euthymus | libert(us). III secolo d. C. d. Colonna. Apulum. Sparita. Reinbold 1842, pl. XIII; CIL, III, 974; Igna 1935, 73, nr. 3; Kerényi 56, 58, 59, 60; Daicoviciu 1966, 156; Daicoviciu-Piso 1977, 76; Balla 2000, 116, nr. 4; Ardevan 1984, 95-110; Devijver 1986, A 22; Ardevan 310; IDR, III/5, 2; Numini | Aesculapi | et Hygiae | P(ublius) Ael(ius) Geni|a[li]s [I]Ivira|[lis c]ol(oniae) Apu[l(ensis)] | [---].
MANUSCRIPT
L’inizio del III secolo d. C. Per lo stato frammentario dell’iscrizione non si può dire, se contenesse la carica di pontifex o meno. È possibile che anche essa fu indicata. Il nome di P(ublius) Ael(ius) Genialis si legge in quattro epigrafi ritrovate ad Apulum, databili dopo il 180 d. C. Sono conosciuti parecchi membri della sua vasta famiglia di cittadinanza adrianea e della sua parentela estesa,xxii di tre generazioni. La famiglia fu originalmente di Sarmizegetusa e da qui si trasferì ad Apulum, il che è dimostrato proprio dall´indicazione della tribus di P(ublius) Ael(ius) Genialis. Il deceduto IIvir di Apulum ebbe tre figli e una figlia. I figli nati nell’ordo decurionum diventarono i membri dell’ordine equestre e rivestirono varie cariche municipali nella colonia di Apulum [cfr. D 5,6]. Il cognomen di P(ublius) Ael(ius) Genialis è frequente soprattutto nelle province occidentali.xxiii Egli cominciò la carriera come decurio e salì presto nell’ordine equestre per motivi censuali. La prima magistratura fu probabilmente la q(uaestura?), se l’ultima lettera dell’epigrafe b. – in mancanza di un’altra soluzione più convincente – è interpretata così, alla luce della carriera posteriore. Probabilmente dopo questo fu eletto il pontifex della colonia di Apulum [c.]. Il magistrato di notevole riguardo fu eletto il patronus del collegium centonariorum,xxiv come ci racconta il testo della base di una statua con iscrizione, eretta da uno dei suoi liberti [c.]. In seguito fu eletto IIvirxxv nella colonia di Apulum, dopo cui sembra di non aver avuto altri uffici. Riassumendo la sua carriera: dalla fine del II secolo d. C. - dec(urio) col(oniae), eq(uo) p(ublico), q(uaestor?) (coloniae), pontifex col(oniae), patron(us) colleg(i) cent(onariorum), (IIvir) [I]Ivira[lis c]ol(oniae).
D 8
P(ublius) Aelius P(ubli) f(ilius) Papir(ia) Marcellus
a. Base. Fulginiae. Italia. CIL, XI, 5215 (5216); ILS, 2650; Tudor 1968, 166-167; Pflaum 1970, 373-375; Dobó 847; Daicoviciu-Piso 1977, 75-78, 77, nr. 9; Dobson 1978, 318-319, nr. 226; Fitz 1992-1995, nr. 648, 938-940; Ardevan 499; P(ublio) Aelio P(ubli) f(ilio) Papir(ia tribu) | Marcello cent(urioni) | frum(entario) subprincipi <pe> | peregrinorum adstato | et principi et primipilo | leg(ionis) VII Gem(inae) Pi(a)e Fel(icis) adle[c]|to ad munera praefe[c(torum)] | legg(ionum) VII Claud(iae) et primae | Adiutricis v(iro) e(gregio) flamini | luculari Laurent(ium) Lavina[t(ium)] | patrono et decurioni co|loni(a)e Apule(n)sium patrono | civitat(um) Forofla(miniensium) Fulginia(tium) | itemque Iguvinorum splen|didis[sim]us ordo Foroflam(iniensium) | cuius dedicat(ione) decurionibus | et liberis [---] eorum panem | et vinum et (sestertios) XX(vicenos) n(ummos) item | [m]unicipibus (sestertios) IIII(quatenos) n(ummos) dedit. abis. La CIL, XI, 5216, un’altra epigrafe di Fulginiae contiene frammentariamente lo stesso testo. La prima metà del III secolo d. C. b. Lastra frontale di un piedistallo. Apulum. CIL - Nella casa del cancelliere. CIL, III, 1180; CIL, III, 7795; EE, IV, n. 154; Daicoviciu 1929 (1930), 306; Kerényi 89; Daicoviciu 1966, 15825; Daicoviciu 1969, 390; Balla 2000, 116, nr. 7; Daicoviciu-Piso 1977, 77, nr. 11; Clauss 1973, 112, n. 198; Dobson 1978, 318, nr. 2; AÉ, 1980: 736; Saulnier 1984, 526, nr. 5; Devijver 1986, A 22; Mrozewicz 1993, 219, nr. 2; Fitz 1992-1995, 938-940, nr. 648; Ardevan 303; Mrozewicz 1999, 71. nr. 9; IDR, III/5, 442; P(ublio) Aelio P(ubli) f(ilio) P(a)p(iria tribu) Marcello | v(iro) e(gregio) p(rimi)p(ilo) ex praef(ecto) leg(ionum) VII | Cl(audiae) et I Adiut(ricis) s[u]b prin|cipe peregr(inorum) Y(centurioni) frum[ent(ario)] | sacer(doti) Lauren[t(ium) Lavi]|<nat(ium) patr(ono) et dec(urioni) colo>5bis|niae patr(ono) [rerum publi]|car(um) Fu[lgin(atium) Forofla]|min(ensium) [itemq(ue) Iguvinor(um)] | [---. La prima metà del III secolo d. C. c. Base. Apulum. Marosportó (Partoş). CIL – „Ad portam archidiaconi Dobocensis”. Sparita. Bongarsius 1600, 623; CIL, III, 1182; Kerényi 78, 89, 179, 1633, 1968; Tudor 1957, 253, nr. 56; Daicoviciu-Piso 1977, 77, nr. 6; Ardevan 1984, 95-110; Devijver 1986, A 22; Kajava 1994, 183; Fitz 1992-1995, 938-940, nr. 648; Mrozewicz 1999, 70, nr. 7; Ardevan 296; IDR, III/5, 441; Publiae Aeli|ae Iulianae | Marcellae s(plendidissimae) p(uellae) | fil(iae) P(ubli) Ael(i) Iuliani | eq(uitis) R(omani) flam(inis) et IIvi|ral(is) col(oniae) Ap(ulensis) et ad|optiv(a)e P(ubli) Ael(i) Mar|celli v(iri) e(gregi) ex pr|aef(ecto) legg(ionum) VII Cl(audiae) | et I Adiut(ricis) Dades || et Filetus actor(es). III secolo d. C. L’aggettivo s(plendidissima) p(uella) segnala l’appartenenza della ragazza ad una famiglia dell’ordine equestre.xxvi
MANUSCRIPT
d. Base. Apulum. CIL, III, 1181; EE, IV, nr. 155; Groag 1913, 18, nr. VI; Kerényi 89, 1633, 1843, 1968; Tudor 1957, 252, nr. 55; Balla 2000, 116, nr. 2, 7; Devijver 1986 (1976-1993), A 22; Daicoviciu – Piso 1977, 77, nr. 5; Ardevan 1984, 95-110; Fitz 1992-1995, 938-940, nr. 648; Mrozewicz 1999, 69, nr. 3; Ardevan 295; IDR, III/5, 439; P(ublio) Ael(io) Antipat|ro Marcello | eq(uiti) R(omano) dec(urioni) col(oniae) Ap(ulensis) | fil(io) P(ubli) Ael(i) Antipa|tri a mil(itis) et IIvir(i) | col(oniae) s(upra) s(criptae) et adoptivo | P(ubli) Ael(i) Marcelli v(iri) | e(gregi) ex praef(ecto) legi|on(um) VII Claud(iae) et | I Adiut(ricis) Dades et | Filetus actor(es). III secolo d. C. Le sue epigrafi sono databili all’inizio del III secolo d. C., così le stazioni conosciute della sua carriera risalgono all’ultimo decennio del II secolo e all’inizio del secolo seguente. È conosciuto tramite cinque iscrizioni, di cui tre sono state ritrovate ad Apulum, due invece a Fulginiae nell’Italia. Nonostante le radici italiche, nella Dacia fu di origine probabilmente apulense, in base alla sua tribus fu il discendente di una persona insediata da Traianus a Sarmizegetusa. La sua carica sacerdotale – secondo i dati a disposizione – non fu in connesione con la Dacia, perciò si conta solo con riserva tra i sacerdoti della provincia. Come persona sacerdotale visse anche nella Dacia, per questo lo studiamo.xxvii Si conoscono numerosi membri della sua famiglia nella provincia [D 5, 6, 7]. Cominciò il servizio militare alla fine del II secolo d. C., e salì velocemente nella gerarchia. Agì verosimilmente tra il 193 e 197 d. C.xxviii come centurio frumentarius, poi come subprinceps e princeps peregrinorum. In seguito fu primus pilus nella legio VII Gemina, poi salì nell’ordine equestre. Occupò la carica seguente contemporaneamente presso le due legioni indicate: fu praefectus legionum (adlectus ad muneram) nella legio VII Claudia di Viminacium e nella legio I Adiutrix di Brigetio. Aveva questa carica probabilmente durante una guerra, quando le due legioni erano di stanza allo stesso posto.xxix Alla fine del II e all’inizio del III secolo d. C. ci sono più possibilità per una tale situazione sia durante la campagna di Septimius Severus nella Britannia che durante quella di Caracalla in Oriente.xxx La sua carriera militare finì probabilmente qui.xxxi Il suo rango equestre fu indicato con la formula di vir egregius. Dopo gli uffici militari rivestì una carica sacerdotalexxxii riservata per gli equites: divenne il membro della corporazione dei sacerdoti Laurentes Lavinates. Nell’epigrafe di Fulginiae questo ufficio sacerdotale fu indicato come flamen lucularis Laur. Lavinatium, mentre in quella di Apulum come sacerdos Laurentium Lavinatium. Il sacerdos, come nome comune, significava in generale anche una persona sacerdotale,xxxiii così sembra improbabile che si tratti di due gradi diversi. Forse i magistratus di Apulum non seppero precisamente il nome della funzione, perciò la nominarono in generale, come vedremo anche nel caso di Procilius Niceta [D 70]. Nel cursus segue il patronatus e il decurionatus nella colonia di Apulum. Poté diventare patronusxxxiv allo stesso tempo, quando, per il suo rango, occupò un posto anche nell’ordo decurionum della propria città natale oppure in quello del paese dei parenti. In seguito, altre tre città italiche – umbre – gli chiesero di diventare il loro patronus: Fulginiae, Forum Flamini e Iguvium. Non sappiamo più della sua carriera. Nei primi due decenni del III secolo d. C. adottò due figli di due parenti, di P(ublius) Ael(ius) Antipater e Iulianus, i quali presero il suo cognomen come supranomen. Si ipotizzava, che P. Ael. Marcellus fosse il fratello di Antipater e di Iulianus.xxxv È quasi sicuro, che furono parenti, ma non fratelli. P(ublius) Ael(ius) Antipater seniore ebbe tre figli e una figlia, dei quali conosciamo tutti [D 5, 6, 7a.]. P. Ael(ius) Marcellus poté essere solo il cugino dei figli di P. Ael(ius) Antipater seniore, e questo corrisponde meglio al fatto, che fu lui l’adottante, il cugino di età simile, senza figli, che aveva passato la sua vita in accampamenti militari. Le epigrafi sulla famiglia furono erette in diversi momenti e indicarono sempre gli uffici attuali, per questo non si legge ad esempio nell’iscrizione sul figlio di P. Ael(ius) Antipater junior [d.] la carica di sommo sacerdote della provincia e quella di flamen del padre. Possiamo dire lo stesso dell’epigrafe eretta per la figlia di P. Ael(ius) Iulianus [c.]. Nella sua carriera egli divenne sacerdote dopo il congedo, con il titolo sacer(dos) Lauren[t(ium) Lavi]nat(ium), oppure più precisamente come flamen lucularis Laurent(ium) Lavina[t(ium)], poi divenne il decurio e il patronus di tre città umbre. Non si può dire, in che modo esercitò la funzione sacerdotale. È possibile che ogni anno andasse a Roma, o al posto delle feste latine, oppure si può ipotizzare anche un rapporto finora non scoperto tra alcune città di diritto italico (Ius Italicum) nella Dacia e l’alleanza delle città latine, che spiegherebbe anche la frequenza di questa carica sacerdotale nella Dacia. La sua carriera è riassunta nell’iscrizione della base di Fulginiae [a.]: dopo il servizio militare diventò flamen lucularis Laurentium Lavinatium nel primo quarto del III secolo d. C., prima di divenire il patronus di Apulum. Per adesso non si conta tra i sacerdoti in rapporto diretto con la provincia di Dacia.
D 9
P(ublius) [Ael(ius) Art]emidorus
Altare. Sarmizegetusa (Ardevan). Hosszútelek (Dorstadt, Doştat), nr. 151. CIL, III, 7728; EE, IV, n. 142; CIL, III, 12555; CIMRM 2008; IDR, III/4, 30; Tóth I. 1970, 278-281; Ardevan 420; [Invic]to S[oli Deo] | [Ge]nitori P(ublius) [Ael(ius) Art]|emidorus de[c(urio) col(oniae)?] | sacer(dos) creatus a Pal[myre]|nis do(mo) Macedonia et adve[n]|tor huius templi pro se | et suis fecit [l(ibens)].
MANUSCRIPT
Nella 3ª riga, accanto al dec(urio) si può inserire anche l’abbreviazione legata col., che deve per forza precisare il decurionatus, similmente alla 5ª riga, dove sono legate più lettere nella parola Macedonia: C+E, D+O. Lo stile del testo, il pullulamento delle legature fa datare l’altare almeno al secondo quarto del III secolo d. C. Il cognomen del committente rinvia già in sé stesso all’origine dall’area linguistica greca, ma è rafforzato anche dall’indicazione dell’origo. Il suo cognomen si trova in diverse province occidentali,xxxvi ma l’indicazione dell’origo rende chiara la sua origine. Il praenomen e il gentilicium dimostrano una cittadinanza romana della famiglia ottenuta sotto Hadrianus. Probabilmente fu il decurio di Sarmizegetusa, solo così si può spiegare l’abbreviazione dec. Si identificò come un sacerdote nominato-delegato per i palmiresi, e come un forestieroxxxvii nel tempio dove stava il suo altare dedicato ad un dio chiamato per nome, che è quasi unico, conosciuto almeno solo nella Dacia. A Sarmizegetusa un’immagine cultica di grandi dimensioni dedicata a Mithras ha un testo similexxxviii: Io. S. Invi. | Deo Genitori | r. n. || L. Ael. Hylas XXI pr. sua et Horientis fil. sui. et Apuleia eius sig. numinis cum absidata | ex voto pos. Quest’iscrizione, similmente all’altare di Artemidorus, faceva parte della collezione di Doştat – Hosszútelek. A causa delle dedicazioni speciali potevano stare originalmente nello stesso santuario, e anche l’altare di Artemidorus poteva essere dedicato a Mithras.xxxix In base alla causa della dedicazione dell’altare egli venne nel territorio di Sarmizegetusa probabilmente con la famiglia, perché fu nominato il sacerdote per gli abitanti palmiresi del paese, che furono verosimilmente i soldati congedati del numerus Palmyrenorum Orientalium (di stanza nel paese dell’odierna Voislova, accanto a Sarmizegetusa), e per i loro familiari.xl Secondo un’altra possibilità meno probabile l’espressione “i suoi” significa la comunità del culto. In base al testo è evidente che nel santuario esistente egli fu un forestiero, quindi una persona nata altrove, che stava originalemente fuori la comunità, dunque con parole chiare: un sacerdote invitato o integrato, delegato per la comunità di un culto, organizzata etnicamente. Fu nominato sacerdos probabilmente dal collegio che dirigeva l’amministrazione del paese: se il santuario stava nel territorium di Sarmizegetusa, allora dall’ordo decurionum di Sarmizegetusa,xli di cui anche egli divenne sicuramente il membro. Gli elementi indicati della carriera sono verosimilmente in ordine cronologico discendente, così Artemidorus di Macedonia, aderito alla comunità dei fedeli, divenne prima sacerdote, poi, ottenuti autorità e un notevole patrimonio, il decurio della città. Riassumendo la sua carriera: nella prima metà del III secolo d. C. – adventor huius templi, sacer(dos) creatus a Pal[myre]nis, de[c(urio) col(oniae)?].
D 10
P(ublius) Ael(ius) P(ubli) f(ilius) Fab[ianus]
Epigrafe votiva. Altare? Apulum. CIL – „Alba Iulia, auf einem Ziegelschlag”. Sparita. CIL, III, 1141; Kerényi 42; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 340; IDR, III/5, 330; Silvano [Aug(usto) sac(rum)?] | P(ublius) Ael(ius) P(ubli) f(ilius) Fab[ianus] | augur pont(ifex) [?II]v[?iral(is)] | dec(urio) col(oniae) Sarm[iz(egetusae)] | dec(urio) col(oniae) Napo[cens(ium)] | augur col(oniae) eius[dem] | dec(urio) mun(icipi) Apul[ens(ium)] | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Per quanto riguarda le possibilità dell’interpretazione della 3ª riga, in quest’ordine contestuale l’integrazione [?II]v[?ir et] dec(urio) è meno plausibile. Il duumviratusxlii rende evidente che fu anche decurio, perciò l’uso della congiunzione et sembra superfluo. Nello spazio rimasto doveva stare piuttosto una formula del duumviratus al tempo passato con la frequente abbreviazione del [?II]v[?iral(is)]. L’epigrafe è databile dopo il 197 d. C. a causa della menzione del municipium Apulensium. Th. Mommsen ha suggerito il [q]u[inq(ennalis)] al posto del testo mancante nella 3ª riga, ma per l’ordine dell’elenco è più accettabile la proposta di I. Piso, anche perché l’abbreviazione della funzione quinquennalis è più frequente nella forma semplice qq. Il dedicatore non sembra identico al beneficiarius consularis, dedicatore di un altare a Napoca, con il simile nome integrato.xliii Egli fu il figlio di una famiglia di cittadinanza romana ottenuta sotto Hadrianus, con ogni probabilità originalmente di Sarmizegetusa, in base al cursus intero. La sua carriera iniziò nell’ultimo terzo del II secolo d. C. e finì nei primi decenni del secolo seguente. La carriera è incorniciata dal cursus intero percorso a Sarmizegetusa, nel frattempo poté ottenere anche il decurionatus e la funzione sacerdotale, che sono inoltre indicati. I singoli uffici possono esser messi in relazione alla fondazione delle città. Qundi, non poté diventare decurio nel municipium Apulensium prima del 197 d. C. La colonia Napocensium esisteva versosimilmente sin dall’epoca di Marcus Aurelius, mentre Sarmizegetusa era la città più vecchia della provincia, così le funzioni in queste due città non ci forniscono punti precisi di riferimento cronologico. Non indicò cariche temporanee, solo quelle a vita, tranne il duumviratus, che, se al momento della dedicazione dell’epigrafe egli fu già un duumvir emerito, segnalò solo l’autorità. Se prendiamo in considerazione la cronologia possibile suggerita dal sistema del testo, dobbiamo mettere all’ultimo posto il decurionatus apulense indicato alla fine dell’elenco, il cui acquisto poteva essere possibilmente più o meno contemporaneo al IIviratus a Sarmizegetusa. La parte del cursus percorso a Sarmizegetusa, che incornicia la carriera, contiene le funzioni in ordine discendente. Sembra evidente che fu nato in una famiglia dell’ordo decurionum di Sarmizegetusa, dove, dopo una o ambedue le cariche (la quaestura e/o l’aedilitas) della magistratura bassa, divenne IIvir. Pare che come duumvir oppure successivamente fu eletto prima pontifex e poi augur, in tale veste poteva far erigere per esempio un altare a Silvanus. Intanto fu eletto il membro dell’ordo decurionum di Napoca, poi divenne augur nella colonia di Napoca. I due auguratus possono essere eventualmente contemporanei, ma non si deve scartare l’ipotesi, che fu augur prima a Napoca e poi a Sarmizegetusa. Dopo il 197 d. C. divenne decurio nel municipium Apulensium. Lui è un buon esempio dei cumulatori di funzioni municipali, frequenti nella Dacia.xliv In base ai dati disponibili non si possono mettere in ordine cronologico i singoli elementi della carriera.
MANUSCRIPT
Riassumendo la sua carriera in base ai dati della sua iscrizione: nell’ultimo terzo del II, all’inizio del III secolo d. C. - dec(urio), (quaestor e/o aedilis?), (IIvir) [?II]v[?iral(is)], pont(ifex), augur col(oniae)(1). Nel frattempo decurio, augur col(oniae)(2), e dopo il 197 dec(urio) mun(icipi).
D 11
T(itus) Ael(ius) Lupus
Altare sepolcrale. Apulum. CIL – „In aedibus principis”. CIL, III, 1213; Groag 1913, 21-22, nr. IX; Kerényi 87, 506; Ardevan 1984, 95-110; Balla 2000, 116, nr. 6; Ardevan 300; Mrozewicz 1999, 70, nr. 8; IDR, III/5, 504; Aureliae | Apolloniae | T(itus) Ael(ius) Lupus | eq(ues) R(omanus) pontif(ex) | et IIviral(is) | coloniae | Apulensis | matri ca|rissimae. L’epigrafe trovata ad Apulum è databile dopo il 180 d. C. in base al rango coloniale della città. Il praenomen e il gentilicium rinviano all’epoca di Antoninus Pius: suo padre dovette ottenere la cittadinanza romana da Antonius Pius tra il 138-161 d. C. Il cognomen è conosciuto in generale nelle province occidentali di lingua latina, dovette diffondersi da questi paesi anche nelle province danuviane.xlv Secondo il cognomen sua madre venne da una delle province orientali di lingua greca. Il gentilicium della madre – Aurelia – rinvia alla cittadinanza romana degli ascendenti, ottenuta al più presto sotto Marcus Aurelius. Dei gradi e delle funzioni, che indicano il suo stato sociale, e che sono elencati nell’epigrafe cronologicamente, è indicata prima l’appartenenza all’ordine equestre, poi la carica sacerdotale di pontifex della colonia di Apulum. Dopo egli fu eletto IIvir, di nuovo nella colonia di Apulum.xlvi Fu sicuramente anche decurio, ma questo non è segnalato, l´indicazione della magistratura più alta nella città significa in sé stessa l´appartenenza all´ordo decurionum, similmente anche l´indicazione dell´appartenenza all´ordine equestre, dato che il rango legato ad un census alto presuppone automaticamente quello di census basso in relazione locale. Tra il decurionatus e il duumviratus dovette essere quaestor o aedilis, oppure tutti e due. L’iscrizione fu eretta dopo la carica del IIviratus. Riassumendo in ordine cronologico alcune parti della sua carriera secondo i dati dell´iscrizione: dopo il 180 d. C. - eq(ues) R(omanus), (quaestor e/o aedilis?), però poteva occupare la bassa magistratura anche dopo il pontificatus, ma per la frequenza è più probabile, che prima, pontif(ex), (IIvir) IIviral(is) coloniae.
D 12
Ael(ius) Habibis
Altare sepolcrale. Tibiscum. CIL, III, 7999; IDR, III/1, 154; Ardevan 41a; Kaizer 2004, 565; D(is) M(anibus) (et) M(emoriae) | Ael(i) Guras Iiddei | [op]tio ex N(umero) Palmur(enorum) | [vi]xit ann(os) XXXXII mil(itavit) | [an]n(os) XXI Ael(ius) Habibis | [pon]tif(ex) et h(eres) b(ene) m(erenti) p(osuit) |’gwr’ ydy hptyn (Gura Yidi fia optio’) – riga in lingua palmirese. L’epigrafe è databile alla prima metà del III secolo d. C. La seconda sigla M della 1ª riga non è un errore dello scalpellino, come si legge nella bibliografia citata, ma l’abbreviazione della parola memoriae, che cominciò a diffondersi alla fine del II secolo d. C. nelle province europee e nell’Africa.xlvii Tra Dis Manibus e memoriae manca spesso la congiunzione et. Nella Pannonia fu usata questa formula ad Aquincum, a Brigetio e ad Intercisa, dove le varianti senza et sono relativamente frequenti.xlviii Si può ritenere caratteristico, che la formula si legge piuttosto sui monumenti sepolcrali di persone orientali del III secolo d. C.xlix Una notevole parte degli abitanti di Tibiscum era anche di origine orientale, per la vicinanza del numerus Palmyrenorum Tibiscensium.l La formula è seguita dal nome del defunto in genitivo. In questo caso l’abbreviazione Ael. si scioglie senza problemi, integrata con una desinenza in genitivo. La forma del cognomen Guras non è un nominativo, ma il genitivo greco del nome orientale, come anche nel caso di Aelia Nice, in un’epigrafe ritrovata similmente a Tibiscum,li in cui il nome fu scritto in forma Aeliae Nices dopo la formula pro salute. Tutto ciò è confermato dall’ultima riga dell’iscrizione in lingua palmirese, in cui il nome del defunto è scritto in forma Gura, che è il nominativo. Il testo palmirese ci fa inoltre sapere, che il defunto fu il figlio di Yidi o Iaddai, che nel testo latino fu scritto come Iddei, cioé si sfruttò la possibilità, che la forma originale del nome poteva essere un genitivo in latino, soprattutto se la parola si leggeva con una i lunga alla fine. Il nome Habibis si può interpretare sia come una forma in genitivo sia come nominativo. Quindi il nome del defunto fu Aelius Gura, figlio di Idde (Yidi o Iaddai). Questa forma del nome porterebbe con sé anche la parola quondam, dopo cui verrebbero le cariche, ma il quondam fu trascurato, come anche in altre iscrzioni già citate di Intercisa, dove non lo troviamo dopo la parola memoriae.lii Il dedicatore, Aelius Habibis fu di origine palmirese, secondo il suo cognomen, mentre il suo gentilicium rinvia alla cittadinanza romana ricevuta sotto Hadrianus o Antoninus Pius, cioé dovette essere il discendente di un soldato congedato al più tardi nel 161 d. C. di una delle truppe palmiresi (numerus Palmyrenorum Tibiscensium?) della Dacia.liii Fu il pontifex del
MANUSCRIPT
municipium Tibiscensium. Il suo pontificatus ha senso solo in relazione con il municipium, non lo si può legare ad un altro posto, non solo nella Dacia, ma nemmeno nei paesi danubiani. Il suo cursus intero non è ricostruibile in base alla sua unica funzione conosciuta, si può affermare solo il fatto, che nella prima metà del III secolo d. C. fu [pon]tif(ex) (municipi).
D 13
P(ublius) Ael(ius) Malachu(s)
Altare. Porolissum. Da un posto secondario dal muro della fortezza di Pomet. Gudea 1980, 89-90, nr. 3; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 489; Sanie 1989, nr. 1; ILD 680; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | P(ublius) Ael(ius) M|alachu(s) | flamen | q(uin)q(uennalis) mun(icipi) | S(eptimi) Por(olissensis) et sa|cerdos | Dei n(umeri) P(almyrenorum) P(orolissensium) | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). L’epigrafe è databile al periodo dall’inizio del III secolo d. C., tra il 200-211 e 235 d. C. Il praenomen e il gentilicium rinviano alla cittadinanza romana della famiglia ottenuta sotto Hadrianus. Secondo il cognomen egli fu di origine palmirese, il che è confermato anche da una delle sue cariche sacerdotali.liv Nel municipium di Porolissum occupò uffici amministrativi e sacerdotali, di cui sono indicati solo il flaminatus e il quinquennalitas, evidentemente in ordine discendente. Il suo ufficio quinquennalis dimostra che fu non solo decurio di Porolissum, ma dopo le magistrature basse, oppure dopo almeno una delle magistrature, divenne prima probabilmente il IIIIvir della città, secondo il sistema amministrativo del municipium.lv Se questo cadde ad un quinquennio, possiamo contare con un solo IIIIviratus. Prendendo in considerazione però il carattere di prestigio alto della carica quinquennale, possiamo supporre anche un altro IIIIviratus. Dopo il tempo ufficiale di quinquennalitas fu eletto il flamen del municipium di Porolissum.lvi Indipendentemente dalle magistrature municipali occupò una carica sacerdotale, presso il numerus Palmyrenorum Porolissensium: fu il sacerdote del dio innominato – innominabile – del numerus. Questo sacerdotium presso il numerus poteva precedere anche la sua carriera municipale. Riassumendo la sua carriera secondo il testo dell´iscrizione: dal secondo decennio del III secolo d. C. – (decurio, aedilis e/o quaestor, IIIIvir ?), q(uin)q(uennalis), flamen mun(icipi), sacerdos dei n(umeri) P(almyrenorum), questo però poteva essere una carica occupata sin dall’inizio della sua carriera, che poteva appoggiare il curricolo municipale.
D 14
T(itus) Ael(ius) Marius o Marus Altare. Sarmizegetusa. Billak (Domneşti). AÉ, 1930: 10; Daicoviciu 1929, 308; Kerényi 91; AÉ, 1957: 273; AÉ, 1967: 388; Ardevan 1992, 47-53; Balla 2000, 135-143, nr. 2; Ardevan 481; ILD 804; [I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) et T(errae) M(atri) | [p]ro sal(ute) T(iti) Ael(i) | Mari fl(aminis) col(oniae) | conduc(toris) pas(cui) | et salina(rum) At|ticus act(or) eius | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Secondo R. Ardevan egli si chiamava Ael. Marius. Per il caotico aspetto grafico lui riteneva l’abbrevazione del praenomen la T della parola salute in forma di sal(u)t(e). Nelle ILD si legge in forma integra di salute. Questa forma della salute è molto rara, si legge piuttosto abbreviata come sal. oppure in forma intera. Perciò si deve ritenere la T l’abbreviazione del praenomen T(itus) (il quale altrimenti manca davanti al gentilicium Ael(ius)) senza di supporre un errore dello scalpellino. L´autore delle ILD pubblica un’altra variante delle righe 5 e 6. Un conduttore di nome P. Ael Marus è conosciuto anche a Micia.lvii Per le incertezze della lettura dell’epigrafe sopracitata l’identificazione delle due persone è problematica, soprattutto per i praenomina che sembrano diversi. L’epigrafe, originalmente eretta a Sarmizegetusa, è databile largamente tra il 138 e 180 d. C. Il nome rinvia all’epoca di Antonius Pius, il suo antenato dovette ottenere la cittadinanza romana da questo imperatore. Il suo cognomen fu portato da persone sia dall’Oriente, che dall’Occidente.lviii T(itus) Ael(ius) Marius fu il conduttore di pascoli e di miniere di sale, cioè appartenne al ceto benestante della società. L’actor, dedicatore alla sua salute, fu probabilmente il suo libertus. Si conosce solo una delle sue cariche municipali: fu il flamen della colonia.lix In base al territorium questa colonia può essere solo Sarmizegetusa.lx Riassumendo gli elementi della sua carriera indicati nell´iscrizione: nei due terzi centrali del II secolo d. C. e dopo – fl(amen) col(oniae), conduc(tor) pas(cui) et salina(rum).
D 15
P(ublius) Ael(ius) Maximus
MANUSCRIPT
a. Altare. Napoca. CIL, III, 855; Buday 1911, 266; Kerényi 97, 98; Székely 1946, 5-7; Macrea 1949, 227, 231-232; Devijver 1976, A 47; Balla 2000, 116-117, nr. 8; Macrea 1978, 132; Bărbulescu 1984, 154, nr. 13; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | ex visu | P(ublius) Aelius Maximus. Inizio del III secolo d. C. b. Altare. Napoca. Csomafája (Ciumăfaia), villa rustica. AÉ, 1977: 702; Buday 1911, 266; Kerényi 97, 98; Székely 1946, 5-7; Macrea 1949, 227, 231-232; Devijver 1976, A 47; Balla 2000, 116-117, nr. 8; Bărbulescu 1977, 179, nr. 51; Macrea 1978, 132; ILD 582; Deo Invicto | Herculi Magu|sano pro salu|te sua et suorum | P(ublius) Ael(ius) Maximus | a {a} mil(itis) | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Prima del 222 d. C., ma dopo la dedicazione dell’epigrafe precedente [a.]. c. Altare. Napoca. Kolozsvár (Cluj-Napoca, Klausenburg), il centro della città (Piaţa Libertăţii nr. 22); AÉ, 1971: 395; Macrea 1949, 249-254; Kerényi 97, 98; Bodor 1957, 90; Daicoviciu 1967, 469-470; AÉ, 1969/70: 548; Devijver 1976, A 47; Balla 2000, 116-117, nr. 8; Macrea 1978, 148-152; Piso 1980, 125-127; Ardevan 1984, 95-110; Bărbulescu 1984, 154, nr. 13; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 463; Szabó Á. 1998 (1999), 171-176; AÉ, 1999: 1279; ILD 554; [Gesahe]nis pro | [se et suis P(ublius) A]el(ius) Maxi|[mus IIvir q(uin)]q(uennalis) et fla|[men col(oniae) Nap(ocensium)] a militis | [sacerdot(alis?) Ar]ae Aug(usti) n(ostri) | [coronatus Dac(iarum) I]II dec(urio) col(oniae) | [?Metropoli]s | [v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)?] Integrando le proposte precedenti, sembra razionale indicare la forma passata del titolo sacerdotale nella 4ª riga. È molto verosimile che P(ublius) Ael(ius) Maximus non eresse l’epigrafe nella città natale come sommo sacerdote attivo, perché in quel caso il cursus finirebbe con maggior probabilità con il titolo sacerdotale. Il testo invece finisce con il decorionatus alla sede del sommo sacerdote, secondo la cronologia sopraddetta: quindi egli poté diventare il decurio della colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa il più presto come sommo sacerdote. Tra il 222 e 235 d. C. Le iscrizioni trovate a Napoca riferiscono senza dubbio alla stessa persona e sono databili ai primi decenni del III secolo d. C. Solo una di loro fornisce una datazione approssimativa: quella che – in base al titolo sacerdotale e all’elemento “Metropolis” del nome della cittàlxi – fu scolpita tra il 225 e 235 d. C. Recentemente la 6ª riga è stata pubblicata dall´autore delle ILD secondo le varianti precedenti. Naturalmente non è da escludere tematicamente lo scioglimento [Apulensi]s, ma è per la variante [Metropoli]s il fatto, che nel testo uniforme e ben scolpito quest’ultima soluzione si inserisce precisamente, non come la variante di sopra. Inoltre, è più probabile, che dopo esser nominato sommo sacerdote, egli fu eletto il membro dell’ordo decurionum della sede. Suo padre fu Aelius Iulius vet(eranus) ex Y(centruione), conosciuto tramite le iscrizioni di sei altari eretti da luilxii e ritrovati nel territorio della sua villa a Csomafája (Ciumăfaia).lxiii Il padre, ormai con l’anello degli equites per il centurionatus, si stabilì nel territorio di Napoca, oppure tornò a casa dopo il servizio militare come il postero di cittadini romani adrianei di Napoca. Suo figlio poté diventare il membro dell’ordo decurionum dal momento della nascita. Il cognomen di P(ublius) Ael(ius) Maximus fu generalmente diffuso nelle province latine.lxiv Solo due delle epigrafi [b., c.] forniscono informazioni sulla carriera di P(ublius) Aelius Maximus: la più dettagliata c. contiene il cursus mescolato. Dovette cominciare il servizio militare all’inizio del III secolo. Tramite questo servizio al Reno salì nell’ordine equestre con il titolo a militis [b., c.]. Non si sa, se occupò anche una o più cariche militari equestri. È possibile, che nel titolo a militis fossero incluse anche le tres militiae. Dopo rivestì una o più magistrature basse municipali (quaestura e/o aedilitas) probabilmente come il membro dell’ordo decurionum, poi divenne il IIvir quinquennalislxv e nel frattempo anche il flamenlxvi della colonia di Napoca. Dopo il 222 d. C. fu eletto il sommo sacerdote della provincia e il capo del consiglio provinciale. Occupò questo ufficio con il titolo sacerdos Arae Augusti nostri, coronatus Daciarum III. Come sommo sacerdote della provincia poté diventare il decurio della città di Sarmizegetusa, quindi della propria sede. Dopo la carica sacerdotale visse probabilmente a Napoca, a questo rinvia l'ultima epigrafe (anche cronologicamente) [c.], un altare dedicato ad una dea germanica, eretto da lui come persona privata. Riassumendo la sua carriera secondo i dati dell´iscrizione: dall’inizio del III secolo d. C. – (servizio militare, tramite cui salì nell’ordine equestre e occupò una o tutte e tre cariche delle tres militiae ?), a militis, (quaestor e/o aedilis ?), (IIvir?) IIvir q(uin)]q(uennalis), fla[men col(oniae)(1), dopo il 222 - sacerdos Arae Augusti nostri, coronatus Daciarum III), dec(urio) col(oniae)(2), [sacerdot(alis) Ar]ae Aug(usti) n(ostri), [coronatus Dac(iarum) I]II.
MANUSCRIPT
D 16
P(ublius) Ael(ius) Maximianus
Altare. Napoca (Ardevan). Potaissa (Bărbulescu, Téglás). Gorbó (Regione di Kolozs - Agărbiciu, jud. Cluj). AÉ, 1910: 132; Téglás I. 1909, 161-162; Kerényi 94; Bărbulescu 1994, 48; Ardevan 473; ILD 604; Téglás 2005, 147 nr. 1906 fig. 32/79. I(ovi) O(ptimo) M(aximo) F(ulguratori) | P(ublius) Ael(ius) Ma|ximia|nus augu[r] | col(oniae) v(otum) s(olvit). Per motivi formali l’epigrafe fu scolpita dopo che Napoca divenne una colonia, cioé dopo il 161-180 d. C.lxvii È databile al periodo tra la fondazione dellla colonia di Napoca e quella del municipium di Potaissa, cioé tra il 161-180 e 193-197 d. C., per questo l’ufficio indicato è sicuramente napocense.lxviii L’auguratus è sicuro: la carica sacerdotale si legge nell’iscrizione in forma di augur, la V è piccola e scolpita nella G, la R finale della parola è consumata, come lo ha osservato anche I. Téglás nella pubblicazione originale. Nel caso dell’augustalis la parola sarebbe stata sicuramente abbreviata come Aug., come è pubblicato questo altare erroneamente anche nella letteratura scientifica recente. P(ublius) Ael(ius) Maximianus discese da una famiglia di cittadinanza romana ottenuta sotto Hadrianus. Il suo cognomen viene dall’Italia settentrionale e fu molto frequente nella società militare dell’area danubiana.lxix L’unico dato su di lui è ciò, che fu l’augur della colonia. Poté avere anche altre magistrature municipali, che non si leggono nell’unica iscrizione rimasta, perché egli la dedicò come augur semplice a I. O. M. F(ulgurator), a causa di un procedimento ufficiale, su una collina (Szakállashegy) accanto a Torda, dove i colpi di fulmine furono frequenti fin all’inizio del secolo XX.lxx L’auguratus coloniale presuppone che fu il membro almeno dell’ordo decurionum, anche se non rivestì altre magistrature. La sua carriera, secondo gli elementi conosciuti e supponibili, svolse così: tra il 161-180 e 193-197 d. C. – (decurio?), augu[r] col(oniae).
D 17
Ael(ius) Nisa
Altare. Apulum, la parte meridionale della colonia Aurelia. Gyulafehérvár (Alba Iulia, Karlsburg), davanti alla parocchia cattolica (oggi: bulevardul Republicii). L’AÉ – in base alle pubblicazioni precedenti – la ha messa erroneamente a Porolissum. AÉ, 1977: 661; Băluţă 1977, 238, nr. 3; Sanie 1989, 1238 a2, 1265, nr. 106; IDR, III/5, 102; Deo | [H]ierhibol(i) | Ael(ius) Nisa | sacerd(os) | posuit. L’altare – in base alla fondazione della colonia – è databile dall’epoca di Marcus Aurelius, cioé dal 161-180 d. C. Secondo il gentilicium egli ebbe la cittadinanza romana, ottenuta da uno dei suoi antenati sotto l’imperatore Hadrianus oppure Antoninus Pius. La mancanza del parenomen è frequente nelle iscrizioni del III secolo d. C., ma capita anche nel caso delle epigrafi precedenti. Alcuni esempi del cognomen si conoscono nelle province occidentali, ma dimostra piuttosto l’origine eventualmente sirio-palmirese degli antenati.lxxi Quest’ipotesi è sostenuta anche dal nome del dio nella dedicazione dell’altare: Deus [H]ierhibol (Hierobulos oppure Yarhibol).lxxii Benché la possibilità sia molto evidente, non è sicuro, che Ael(ius) Nisa fu il sacerdote di questa divinità, dato che l’iscrizione non ci rinvia direttamente. Non è conosciuto neanche il santuario della divinità ad Apulum, solo un altro sacerdote del dio [D 28]. Può darsi, che Ael(ius) Nisa dedicò un altare al dio della sua patria o degli suoi antenati solo per ragioni etniche, oppure per la religiosità personale, ma a causa dei due sacerdoti non è da escludere nemmeno l’esistenza di un santuario. Dal punto di vista sociale egli fu un cittadino romano, da quello della professione fu un sacerd(os), che ottenne il titolo e la carica sacerdotale probabilmente dalla comunità. Non è da escludere, che egli fu impiegato dalla direzione della città al servizio del santuario di uno o più culti non tradizionali. Riassumendo possiamo affermare, che – non solo in questo caso, ma anche nei casi simili – il dedicatore non deve essere necessariamente il sacerdote della divinità menzionata nell’iscrizione. Con questa logica potremmo trovare parecchi sacerdoti di molte divinità tradizionali, come per es. di Iuppiter Optimus Maximus, sebbene i dedicatori volessero esprimere con gli altari solo la loro lealtà allo stato [cfr. anche D 60, 72, 73]. In base al testo dell´iscrizione si può affermare i seguenti della sua carriera: nell´ultimo quarto del II secolo d. C. e nel primo quarto del III secolo d. C. – cittadino romano, sacerdos.
D 18
[P(ublius) Ae]lius Probus
Stele. Napoca. Kolozsvár (Cluj-Napoca, Klausenbeurg). CIL - „Ziegeunergasse”. CIL, III, 7664; EE, II, n. 377; Kerényi 70, 110, 184; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 466; ILD 564;
MANUSCRIPT
[---] | [--- vix(it) ann(os)] XXXV Aelia Proba vix(it) an[n(is)---] | m[ensibus---?] d[iebus--?]XI P(ublius) Aelius Ingenus vix(it) [ann(is) ---] | [P(ublius) Ae]lius Probus flame┌n┐ muni[cipi] | [suis] pientissimis et sibi vi[vo fec(it)]. L’integrazione dei frammenti dell’M e D nella 2ª riga del testo è sicuramente m[ensibus ---?] e d[iebus---?]. Le pubblicazioni precedenti però hanno tralasciato di proporre questa soluzione. Nel caso di Aelia Proba anche i giorni sono indicati precisamente, forse perché la sua età fu facilmente rintracciabile: morì verosimilmente molto giovane. Nella 3ª riga si legge flamem invece di flamen. L’integrazione della rottura all’inizio dell’ultima riga forse non è [filiis], come si legge nelle pubblicazioni precedenti, perché così la moglie, che fu la madre dei figli, mancherebbe nel testo. In base al carattere del monumento sepolcrale l’iscrizione dovette contenere tutta la famiglia, se egli la dedicò pure a se stesso. Perciò propongo la soluzione [suis] invece di [filiis] all’inizio della riga, il cui significato corrisponde meglio alla parola sibi. Quindi i XXXV anni della 1ª riga rimasta dell’iscrizione si riferiscono verosimilmente alla moglie del flamen, il quale fu all’inizio della carriera municipale. La moglie morì, eventualmente insieme ai figli, in un’epidemia, oppure durante le devastazioni delle guerre marcomanniche.lxxiii Il monumento sepolcrale della famiglia di [P(ublius) Ae]lius Probus è databile – considerando le date più estreme – tra il 117 e 180 d. C., cioé dalla fondazione del municipium da parte di Hadrianus fino alla nascita della colonia sotto Marcus Aurelius, o eventualmente Commodus.lxxiv Secondo il praenomen e il gentilicium egli fu un cittadino adrianeo, se non lui, allora il padre, e da lui ereditò la cittadinanza romana. Il suo cognomen fu diffuso nell’Italia settentrionale e nella Dalmatia.lxxv Fu il flamen del municipium di Napoca,lxxvi non gli sono conosciute altre cariche. Secondo i dati conosciuti della carriera in base all´iscrizione fu flamen muni[c(ipi)] largamente nei due quarti centrali del II secolo d. C.
D 19
P(ublius) Ael(ius) P(ubli) f(ilius) Pap(iria tribu) Silvanus
Epigrafe sepolcrale. Apulum. Sparita. CIL, III, 1207; Kerényi 131, 717; Ardevan 1984, 95-110; Balla 2000, 116-117, nr. 9; Ardevan 297; IDR, III/5, 483; P(ublio) Ael(io) P(ubli) f(ilio) Pap(iria tribu) | Silvano | IIvir(ali) et sa|cerd(otali) [co]l(oniae) A[p(ulensis)] | eq(uo) R(omano) e(gregiae) m(emoriae) v(iro) | Fabia Lucil|la e(gregiae) m(emoriae) v(iri) filia | mater coll(egiorum) | fabr(um) et cent(onariorum) | coloniae s(upra) s(criptae) | socero sui | amantissi|mo. Il monumento sepolcrale, databile al primo terzo del III secolo d. C. fu eretto da Fabia Lucilla egregiae memoriae viri filia al suocero. Non si può dire, se il defunto fu il parente di P(ublius) Ael(ius) Antipater o della sua famiglia [D 5-8], oppure di P(ublius) Ael(ius) Strenuus [D 20]. La sua tribus Papiria, che rinvia alla sua origine di Sarmizegetusa, è invece identica a quella di P(ublius) Ael(ius) Genialis [D 7] (e della sua famiglia), di cui potrebbe essere anche il discendente. Il rango indicato di sua nuora fa pensare che egli discese da una famiglia dell’ordine equestre con il gentilicium Fabius. Sono conosciute molte persone con il gentilicium Fabius di Apulumlxxvii dai II-III secoli d. C., ma tramite loro non si può identificare indubbiamente la famiglia di Fabia Lucilla. L’unica persona di Apulum con lo stesso rango con il gentilicium Fabius è T(itus) Fabius Aquileiensis, che fu il commandante del n(umerus) Sing(ulariorum) Brit(annicorum) di Csigmó (Cigmău) tra il 208 e 209/210 d. C.lxxviii Tra le persone conosciute, lui poté essere potenzialmente il padre di Fabia Lucilla. Secondo il praenomen e il gentilicium P(ublius) Ael(ius) Silvanus fu il discendente di una famiglia con cittadinanza romana ottenuta sotto Hadrianus. Il suo cognomen è conosciuto in territori sia orientali che occidentali.lxxix In base agli elementi conosciuti della carriera, egli fu decurio nella colonia di Apulum, sicuramente per diritto di nascita, e occupò una o ambedue le magistrature basse, cioé dovette essere quaestor e/o aedilis. Poi divenne il IIvir della colonia,lxxx poi ebbe una carica sacerdotale con il titolo sacerdos coloniae. Sembra che dopo questo divenne il membro dell’ordine equestre. Dato che si tratta della sua epigrafe sepolcrale conosciamo tutta la carriera, sia la magistratura alta che la magistratura bassa presupposta da quella alta. Nel testo dell’iscrizione il IIviratus e la carica sacerdotale furono indicati in forma passata, che è ovvio in caso di un defunto. Mentre il duumviratus doveva durare un anno, la durata della carica sacerdotale è sconosciuta. Egli la poté rivestire per tutta la vita e divenne sacerdotalis per la morte, oppure ebbe una carica sacerdotale per un periodo determinato al servizio della colonia con il titolo sacerdos coloniae nel santuario di uno o più culti cd. “stranieri” nel territorio della colonia. Non è da escludere, che ebbe il titolo sacerdotalis già nella sua vita se rivestì una carica sacerdotale di una durata determinata. Dopo la morte divenne sicuramente sacerdotalis, e questo è un dato sicuro. Riassumendo la sua carriera in base al testo dell´iscrizione: dopo il 180 d. C. – (? decurio, quaestor e/o aedilis, IIvir) IIvir(alis), (sacerdos) sacerd(otalis) [co]l(oniae), eq(ues) R(omanus).
D 20
P(ublius) Ael(ius) P(ubli) fil(ius) P(apiria tribu) Strenuus
a. Base. Apulum. Marosportó (Partoş)? Sparita.
MANUSCRIPT
Fodor VII, pl. 19 u.; CIL, III, 1209; ILS 7147; Kerényi 132, 1204; Tudor 1957, 123, nr. 57; Daicoviciu 1966, 158; Daicoviciu 1969, 390; Balla 2000, 116-117, nr. 10; Ørsted 1985, 347; Ardevan 1993, 234; Ardevan 1998, 338; Ardevan 299; Mrozewicz 1999, 71, nr. 12; IDR, III/5, 443; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 110-111 nr. 5.a; P(ublio) Ael(io) P(ubli) fil(io) P(apiria tribu) | Strenuo equo | p(ublico) sacerd(oti) Arae | Aug(usti) auguri et | IIvirali col(oniae) | Sarm(izegetusae) augur(i) | col(oniae) Apul(ensium) dec(urioni) | col(oniae) Drob(etensium) pat|ron(o) collegior(um) | fabr(um) cento|nar(iorum) et naut|ar(um) conduc(tori) pas|cui salinar(um) | et commer|cior(um) Rufinus | eius. Il secondo e terzo decennio del III secolo d. C., dopo il 212. b. Tre frammenti di una tavola. Sarmizegetusa, accanto al forum. Piso 2006, nr. 43; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 110-111 nr. 5.b; ---] | [?P(ublius) Aelius P(ubli) f(ilius) Pap(iria tribu) Stre]nuu[s ?eq(uo) p(ublico)] | [?sac(erdos) Arae Aug(usti) aug]ur e[t II]vira[l(is) col(oniae) S]arm(izegetusae)] | [---. Il secondo e terzo decennio del III secolo d. C., dopo il 212 d. C. Egli è conosciuto tramite due iscrizioni, una ritrovata ad Apulum, l’altra a Sarmizegetusa, databili al primo quarto del III secolo. Una fu dedicata a lui [a.], l’altra fu eretta da lui, molto probabilmente nell’anno quando egli fu sommo sacerdote [b.]. Secondo il praenomen e il gentilicium fu il discendente di una famiglia con la cittadinanza romana ottenuta sotto Hadrianus, insediata originalmente a Sarmizegetusa secondo la tribus. Il suo cognomen raro è conosciuto sporadicamente nell’Italia settentrionale, nella Gallia meridionale e nella Pannonia.lxxxi Fu il membro dell’ordine equestre e verosimilmente il decurio della città natale. Percorse il suo cursus intero municipale in una sola città, a Sarmizegetusa, cioé dovette essere nato là. Le sue cariche municipali indicate in ordine discendente sono incorniciate dal cursus a Sarmizegetusa. Fu probabilmente il decurio di Sarmizegetusa, e dovette occupare una o ambedue le magistrature basse in questa città, cioé fu quaestor e/o aedilis. Queste non sono indicate nell’iscrizione, ma il IIviratus nella data città le presupponeva con ogni probabilità. Ebbe cariche anche in due altre città. Si pensa che anche in questo caso l’epigrafe abbia una cronologia discendente per quanto riguarda gli uffici municipali, quindi dopo una o due magistrature basse a Sarmizegetusa la sua carriera continuò con le cariche ad Apulum, poi a Drobeta. Dunque, prima divenne augur nella colonia di Apulum. Il decurionatus non fu semplicemente una carica amministrativa, ma segnala anche la sua posizione sociale, perciò quando egli venne eletto augur, divenne augur come decurio. L’auguratus ad Apulum fu seguito da un decurionatus a Drobeta. Poi fu eletto il IIvir di Sarmizegetusa,lxxxii poi, nell’anno della carica di IIvir oppure successivamente divenne augur nella stessa città. Ebbe anche una funzione di carattere economico, fuori il cursus honorum: fu patronus,lxxxiii indicato alla fine dell’iscrizione, cioé fuori l’elenco. È meno probabile, che la sua carriera iniziò con questa funzione economica, dato che, evidentemente, neanche i collegia offrirono la posizione di patronus come esordio. Fu conductor pascui et salinarum, similmente a T. Ael(ius) Marius di Sarmizegetusa [D 14], quindi questa impresa poté essere in connessione con Sarmizegetusa. Inoltre fu anche conductor commerciorum e il patronus del collegium fabrum centonariorum e di quello nautarum. Quasi in ogni città ci fu un collegium fabrum e/o centonariorum, così anche a Drobeta, ad Apulum e a Sarmizegetusa.lxxxiv In mancanza di altre iscrizioni non si può decidere, in quale delle tre città fu il patronus dei collegia soprannominati. Poté patrocinare i collegia di nomi e profili simili di più città. Il patronatus di più collegia può essere riferito a diverse città, come in certi casi anche i collegia erano connessi tra di loro solo tramite la persona del patronus.lxxxv Egli dovette occupare il patronatus del collegium nautarum in una città che aveva un porto. Ad Apulum si navigava sul Maros, a Drobeta sul Danubio. Secondo R. Ardevan P(ublius) Ael(ius) Strenuus fu il patronus del collegium di Apulum, il che si base alla navigazione attiva sul Maros e al fatto, che l’epigrafe [a.] è stata ritrovata ad Apulum.lxxxvi Il patronatus del collegium e la conduzione non si possono inserire cronologicamente nella sua carriera, il loro inizio si ipotizza tra il decurionatus e il IIviratus a Sarmizegetusa, più probabilmente alla prima metà della sua carriera. Comunque, il suo patronatus e la conduzione erano attuali anche durante la carica di sommo sacerdote. Il suo ultimo ufficio conosciuto (anche cronologicamente) è il “summus honor”lxxxvii, cioé fu il sommo sacerdote della provincia. Occupò questo posto con il titolo sacerdos Arae Augusti nel primo quarto del III secolo. Tra il 198 e 212 d. C. regnarono più Augusti contemporaneamente, perciò – in base al titolo di sommo sacerdote con un solo Augustus – dovette avere questa carica dopo il 212 d. C. Sotto Severus Alexander (222-235 d. C.) dopo il 222 d. C. il titolo del sommo sacerdote cambiò,lxxxviii per questo lo dovette essere il più strettamente tra il 212 e 222 d. C., oppure verosimilmente anche negli anni ‘220 d. C. Non abbiamo nessun dato sulla parentela con P. Ael(ius) Antipater [D 5-8] e della sua famiglia, oppure con P. Ael(ius) Silvanus [D 19]. Riassumendo la sua carriera municipale: probabilmente dopo il 180 d. C. - equo p(ublico), (? decurio, quaestor és/vagy aedilis coloniae(1)), augur col(oniae)(2), dec(urio) col(oniae)(3), patron(us) collegior(um) fabr(um) centonar(iorum) et nautar(um), conduc(tor) pascui salinar(um) et commercior(um), (IIvir) IIviralis, augur col(oniae)(1) dopo il 212 d. C. - sacerd(os) Arae Aug(usti), (sacerdotalis Arae Augusti).
D 21
Ael(ius) Valentinus(1)
Tavola commemorativa di una costruzione.
MANUSCRIPT
Apulum. Koslárd (Coşlar). CIL - „Rep. fortasse Apuli extat in vico Koslárd”. CIL, III, 7760; EE, II, 400; Kerényi 143; Demirčioglu 1939, 89, nr. 20; Kan II, nr. 26; Merlat nr. 25; Russu 1969, 182; Speidel 1978, nr. 29; Berciu-Popa 1978, 7-8, nr. 4; Sanie 1989, 1176 b, 1246 nr. 2; CCID, 156; IDR, III/5, 217; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Doliche|no pro salute imperator(is) | Ael(ius) Valentinus vet(eranus) | sacerdos | templ(um) impendio suo | restituit. L’iscrizione è databile al periodo dopo il 212 d. C. in base al modo della scrittura e della composizione, e al fatto, che fu dedicata alla salute di un imperatore. Il gentilicium dimostra la cittadinanza romana della famiglia ottenuta sotto Hadrianus o Antoninus Pius, mentre il cognomen, un nome diffuso dall’Occidente, fu frequente nella Gallia meridionale e nell’Africa settentrionale, ma fu portato occasionalmente anche da persone orientali.lxxxix La mancanza del praenomen (benché capitasse anche nel II secolo d. C.) fu frequente nel III secolo, e anche il culto di I. O. M. Dolichenus si diffuse notevolmente durante il III secolo d. C., così anche nella Dacia. Egli fece il servizio militare in una truppa innominata. In base al posto di ritrovamento dell’epigrafe e al gentilicium non in connessione con Caracalla, poté essere anche il veteranus della legio XIII Gemina, ma senza dubbio come cittadino romano. Dopo il congedo agì come sacerdote. Rinnovò un tempio, ma non indicò quale. Similmente, segnalò la carica sacerdotale, ma non indicò in quale città la occupò. Secondo la dedicazione però è sicuro che il tempio era di Iuppiter Dolichenus, e il sacerdos dovette essere il sacerdote del santuario. Riassumendo la sua carriera: nel primo terzo del III secolo d. C. – miles (- - - ?), veteranus, sacerdos (Iovis Optimi Maximi Dolicheni).
D 22
Ael(ius) Valent[inus](2)
Stele sepolcrale. Micia. CIL, III, 7868; Kerényi 145; Tudor 1957, 270-271, nr. 127; IDR, III/3, 159; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 267; D(is) M(anibus) | Aelia Hygia vixit | annis XVIII | Ael(ius) Valent[inus dec(urio)?] | col(oniae) Apul(ensis)? fl(amen)? | libertae et coniugi | gratae | quam tempus durum | rapuit familiam | qu(a)e simul Dacia te | voluit possedit | Micia secum have | puella multum adque | in aevum vale. Nelle 4ª e 5ª righe la lettura è ipotetica per la superficie rotta. L’epigrafe è databile al periodo dopo il 180 d. C. Il gentilicium dimostra la cittadinanza romana della famiglia, ottenuta sotto Hadrianus o Antoninus Pius, mentre il cognomen, diffuso dall’Occidente, era frequente nella Gallia meridionale e nell’Africa settentrionale, portato a volte anche dalle persone orientali.xc Egli fu il decurio della colonia Aurelia Apulensium, e come decurio fu il flamen della colonia.xci Non può essere identico al dedicatore dell’epigrafe precedente. Non è da escludere, che nell’8ª riga l’espressione “tempus durum” rinvia alle devestazioni delle guerre marcomanniche che decimarono molte famiglie danubiane.xcii
D 23
Ael(ius) Vitalianus Stele sepolcrale. AÉ, 1944: 48b; AÉ, 1977: 663; Daicoviciu 1941, 324, nr. 4; Ardevan 1984, 95-110; Gudea 1989, 769, nr. 39; Ardevan 491; ILD 700; Ael(ia) Nice vix(it) annis XC Ael(ius) | Victor vix(it) annis IIII Ael(ia) M(a)m|mutio vix(it) annis XXIII Ael(ius) Vitalia|nus augur [po]ntif(ex) q(uin)q(uennalis) matri et filio | neptiae b(ene) m(erentibus). L’iscrizione è databile il più presto al secondo decennio del III secolo d. C. in base alla fondazione della città e alla tarda età della madre che ottenne la cittadinanza romana sotto Hadrianus oppure Antoninus Pius. Il nome di Aelia Nice è conosciuto anche tramite un’altra epigrafe di Tibiscum,xciii ma non abbiamo nessun punto d’appoggio per l’identificazione sicura delle due persone. Il gentilicium del dedicatore è quello della madre (la madre fu probabilmente la liberta del padre, oppure la discendente di un’altra famiglia con il nomen Aelius), il cognomen derivato da Vitalis, frequente nelle province occidentali, è raro nell’area danubiana.xciv Fu l’augur del municipium di Porolissum, poi divenne pontifex e alla fine quinquennalis. (L’autore delle ILD prescinde da quest’interpretazione pubblicando la 4ª riga come augu(r) NMOOO (?)). L’ufficio amministrativo e le due cariche sacerdotali presuppongono non solo il decurionatus del dedicatore, ma anche almeno una magistratura bassa. Sul rapporto cronologico tra le magistrature e le cariche sacerdotali si può solo affermare, che ricevette queste ultime tra il decurionatus e la carica quinquennalis. L’ufficio quinquennalis può suggerire anche un IIIIviratus precedente.xcv L’epigrafe fu eretta nell’anno quinquennalis. Riassumendo la sua carriera: dagli anni 210 d. C. - (decurio), augur, [po]ntif(ex), q(uin)q(uennalis) (municipi). Nel frattempo (quaestor o aedilis), probabilmente anche (IIIIvir?).
MANUSCRIPT
D 24
Cn(aeus) Aem[ilia]nus I[---?]
Altare. Drobeta. Dal castro romano. AÉ, 1959: 313a; Daicoviciu 1944, 293-294; Tudor 1968 (Olt), nr. 14; Petolescu 1982, 119-120, nr. 1; Ardevan 1984, 95-110; Petolescu 1986, 347, nr. 326; IDR, II, 21a; AÉ, 1983: 843; Ardevan 18; ILD 59; Gen(io) ord(inis) | mun(icipi) H(adriani) [Dr(obetensium)] | Cn(aeus) Aem[ilia]|nus I[Ivir et?] o I[Iviral(is)] | pont[ifex] | pos[uit] | quod [Aemilia]|nus F[---]|O EOI[---]. L’integrazione intera più recente del testo partendo dalle 3ª e 4ª righe: „Cn(aeus) Aem[ilia]|nus I[Ivir et] | pont[ifex] | pos[uit] | quod Cn(aeus) [Aemilia]|nus f[ec(it) de su]|o eod[em(que) dedic(avit)]”,xcvi e secondo la variante pubblicata ultimamente (ILD 59) la 7ª riga è senza Cn(aeus) (? non vidi). Nella 4ª riga – in base agli spazi – qualcosa poteva appartenere al IIviratus – se non fu indicato il cognomen – che può essere la congiunzione et, ma anche il I[Iviral(is)] in forma passata. Il testo è frammentario dalla 7ª riga, gli scioglimenti e le integrazioni nelle forme proposte strutturalmente non hanno nessun senso. Se si legge veramente un nome, allora la F nell’8ª riga può rinviare ad esempio al figlio del dedicatore. L’autore delle ILDxcvii ha ragione, che il testo dovette contenere il motivo della dedicazione dell’altare, ma probabilmente non nella forma pubblicata nell’AÉ. La parte mancante del testo – in base al quod – dovette raccontare, che il dedicatore adempié ciò, che aveva promesso ad esempio suo figlio (?). L’iscrizione è databile al II secolo d. C., dopo il 117-138 e fino almeno al 193 d. C., secondo la fase municipale della città.xcviii Il gentilicium di Cn(aeus) Aem[ilia]nus si trova nella maggior parte delle province europee, cioé rinvia all’origine occidentale del portatore.xcix Egli fu probabilmente IIvir e pontifex nel municipium di Drobeta. La carica sacerdotale durò a vita, mentre il IIviratusc si riferisce all’anno dato, perciò sono indicati solo queste due uffici, mentre mancano le stazioni precedenti del suo cursus. Fu, ovviamente, il decurio del municipium, e occupò anche le magistrature basse, oppure almeno una, quindi fu quaestor o aedilis o ambedue. Dopo questo fu eletto IIvir. L’iscrizione non ci dice, da quando fu anche pontifex. Ma se l’integrazione, che fece erigere l’epigrafe come duumvir, è giusta, allora era diventato pontifex prima. La dedicazione Genio ordinis rinvia piuttosto ad un duumviratus attuale. Riassumendo la sua carriera fino alla dedicazione dell’altare: tra il 117-138 e 193 – (? decurio, probabilmente ma non sicuramente già prima della carica sacerdotale quaestor e/o aedilis), pont[ifex], I[Ivir] mun(icipi).
D 25
L(ucius) Ant(onius) Rufus
a. Altare sepolcrale. Sarmizegetusa. CIL, III, 1491; Groag 1913, 77, nr. V; IDR, III/2, 440; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 199; Piso 2001 (BMN), 363-370; D(is) M(anibus) | Quintiniae | Magnillae | vix(it) an(nis) XXX | Ant(onius) Rufus | IIviral(is) col(oniae) | maritus et | Antonii Pris|cus Rufus | Rufinus dec(uriones) | col(oniae) filii. II secolo d. C. b. Altare sepolcrale. Sarmizegetusa. CIL, III, 1490; IDR, III/2, 376; Ardevan 198; Piso 2001 (BMN), 363-370; D(is) M(anibus) | L(ucius) Ant(onius) Ru[fus] | IIviral(is) [col(oniae)] | Sarm[iz(egetusae)] | vix(it) an(nis) [---] | L(ucii) Anton[i(i) Pris]|cus eq(uo) [pub(lico)] | et Rufu[s et Ru]finus decur(iones) | co[l(oniae)] | fili(i) et [heredes]. II. secolo d. C. c. Tavola. Sarmizegetusa, decumanus maximus, vicino al tetrapylon. AÉ, 2001: 1719; Piso 2001 (BMN), 365-370, nr. 8; ILD 248; Piso 2006, nr. 42; A[--- ?Fl]av[?iae] | s[tolat]ae femi|[nae so]crui | L(ucius) Ant(onius) Rufus ? e[q(uo) p(ublico)] | p[o]ntif(ex) col(oniae) Sar[m(izegetusae)] | [?fisci a]dvoc[?atus] | [---?]. Fine del II secolo d. C.
MANUSCRIPT
Egli e la sua famiglia sono conosciuti tramite otto iscrizioni ritrovate a Sarmizegetusa, databili al II secolo d. C.ci Il loro gentilicium Antonius si trova dappertutto nelle province occidentali, ma c’erano molti all’Oriente che portavano questo nome, però soprattutto con il praenomen M(arcus).cii I cognomina della famiglia rinviano all’origine occidentale dell’antenato, che si era trasferito nella Dacia. Il nonno Priscusciii (I. O. M. | Anto|nius | Priscus | ex votociv; I. O. M. | Ant. Pris. | ex votocv), dalla tribus Papiria, uno dei cittadini della prima (al massimo della seconda) generazione di Sarmizegetusa, morì all’età di 62 e non rivestì nessuna carica. Ebbe una figlia, Priscilla e un figlio, Rufus, il quale divenne decurio: D. M. | L. Ant. Pap. | Prisco vi|xit ann. LXII | Antonius Ru|fus dec. col. | et Antonia | Priscilla | patri.cvi Suo padre, Rufus fu decurio, aedilis e IIvir di Sarmizegetusa: L. [Antonio L. f.] | Pa[p. Rufo dec.] | col. Sarmiz. | aedi[l. II]v[i]ral. | L. Ant. Epaga|thus | patrono | l. d. d. d.cvii e qui l’epigrafe b. Oltre la sua attività amministrativa egli si occupò anche dell’industria: secondo un bollo laterizio Ant. Ruficviii ebbe una fabbrica di laterizi. Sua madre, Quintina Magnilla morì all’età di 30 [a.]. Ebbero tre figli: Priscus, Rufus e Rufinus, i quali, alla morte della madre, furono già decuriones. I cognomina degli ultimi due sono frequenti nell’Italia settentrionale e nella Dalmatia, ma capitano anche nelle province occidentali.cix Alla morte del padre il figlio più grande, Priscus, fu già il membro dell’ordine equestre, mentre gli altri due furono ancora decuriones [b.]. Il figlio medio, L(ucius) Antonius Rufus junior, il decurio di Sarmizegetusa, salì – similmente a suo fratello – nell’ordine equestre alla fine del II secolo d. C. [c.]. Nella sua epigrafe, dove comunicò che divenne il membro dell’ordine equestre, non si legge più il rango di decurio, similmente all’iscrizione precedente di suo fratello. Fu il pontifex di Sarmizegetusa e poi verosimilmente advocatus fisci.cx Per lo stato frammentario dell’epigrafe non si sa più degli altri suoi uffici [c.]. La stolata femina nel testo poté essere sua cognata, la moglie del fratello, L. Antonius Priscus.cxi Gli elementi della sua carriera tramandati dalle epigrfai: alla fine del II secolo d. C. - dec(urio) col(oniae), e[q(uo) p(ublico)], p[o]ntif(ex) col(oniae), [?fisci a]dvoc[?atus], [---?], poté avere possibilmente anche cariche municipali amministrative.
D 26
M(arcus) Ant(onius) Maximu[s]
Epigrafe commemorativa di una costruzione in forma di altare. Porolissum. II. Dolichenum, al lato meridionale del municipium, entro le mura. AÉ, 2001: 1706-1707; Gudea-Tamba 2001, 25, 97; Piso 2001 (AMN), 224-228, 225, nr. 2; Piso 2005 (Weber Fs.), 325; ILD 683; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) [D(olicheno)] | pro salute et [incolu]|mitate Imp(eratoris) C(aesaris) M(arci) [Ant(oni)] | Gordiani Pii Fel(icis) Aug(usti) | et coh(ortis) III Camp(estris) M(arcus) Aur(elius) Fla|(v)us IIIIvir m(unicipi) S(eptimi) P(orolissensis) M(arcus) Ant(onius) Maximu[s] | vet(eranus) et dec(urio) o[rnat]us ornam(entis) IIIIvir(alibus) | m(unicipi) s(upra) s(cripti) et Aure(lius) Fla(v)us dec(urio) m(unicipi) vegesi[m]a[r(ius)] | sacerdotes dei et coh(ortis) s(upra) s(criptae) [t]emp[l(um) cum] | tabernis (a)ere suo feceru[nt]. L’iscrizione è databile tra il 238 e 244 d. C. Secondo il gentilicium egli poté venire sia dalle province latine, che da quelle greche,cxii e anche il cognomen ha le stesse caratteristiche,cxiii cioé non rinvia ad un’origine orientale, come si aspetterebbe in base alla carica sacerdotale. Fu il veteranus di una truppa innominata (probabilmente della coh. III Camp. menzionata nell’epigrafe), e il decurio del municipium con il diritto di portare le insegne di un IIIIvir. Inoltre, si deduce chiaramente dal testo, che fu il sacerdote della divinità menzionata nell’iscrizione, quindi sacerdos I. O. M. Dolicheni nel secondo santuario di Porolissum,cxiv e fu il sacerdote anche presso la coh(ors) III Camp(estris) menzionata. Il santuario fu costruito entro le mura,cxv verosimilmente non su un’area privata, ma pubblica.cxvi In quest’ultimo caso fu un sacerdos impiegato dalla città. La carica sacerdotale presso la coorte non deve significare necessariamente lo stesso impegno come la carica sacerdotale per Dolichenus, ma è molto probabile. In questo caso anche la coorte impiegava sacerdoti propri per Dolichenus [v. anche D 30, 31, 90, 91, 92], i quali dirigevano il culto militare di Dolichenus – che svolgeva parallelemente a quello ufficiale del campocxvii – praticamente come persone civili avendo invece – essendo veterani – connessi con la milizia. Il Dolichenum e le tabernae furono costruiti da lui e da due colleghi, che furono similmente sacerdoti di Dolichenus e magistrati municipali. Le tabernae possono essere in connessione la presenza di un sacerdote di Dolichenus a Porolissum, in servizio un paio di anni prima, che commerciava in vino. Dunque una parte dei sacerdotes Iovis Dolicheni di Porolissum si poteva specializzare anche in commercio di vino [cfr. D 37]. Il Dolichenum menzionato è il secondo di Porolissum,cxviii anche cronologicamente. Il suo predecessore, conosciuto tramite alcuni oggetti piccoli, fu distrutto possibilmente nel 235, all’inizio del regno di Maximinus Thrax.cxix Riassumendo gli elementi della sua carriera tramandati dal testo dell’iscrizione: dal secondo decennio del III secolo d. C. – (soldato, ma non si sa, in quale funzione, siccome non menzionò il rango possibile di sottufficiale, fu possibilmente miles), vet(eranus), tra il 238-244 fu già - dec(urio) o[rnat]us ornam(entis) IIIIvir(alibus) m(unicipi), sacerdos dei (I. O. M. Dolicheni), sacerdos coh(ortis). La carica sacerdotale poté precedere gli uffici municipali.
D 27
M(arcus) Antonius Valentinus
a. Tavole in più pezzi. Sarmizegetusa, anfiteatro.
MANUSCRIPT
CIL, III, 13790 + 13786 + 12593; Piso 1977b, 647-650; IDR, III/2, 326; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 113-114, nr. 10 (b); [Deae?] Neme[si Augustae?] | [?Omnip]o[tenti sacrum?] | [M(arcus)?Ant]oni[us Valentinus ?] | [pat]ronus co[ll(egi) f]abr(um) | [?dec(urio) mu]nicip[i A]pul(ensis) | [templ]um v[etustate?] | [?conlapsum renovavit o restituit --- ------]NA[.] | [---] Apul(ensis?). Prima metà del III secolo d. C. Le 1ª, 2ª, 3ª e 4ª righe sono integrate da me. I. Piso riteneva possibile,cxx che il dedicatore fosse M(arcus) Antonius Valentinus. L’anfitetaro di pietra di Sarmizegetusa fu costruito nel 158 d. C., sotto il regno di Antoninus Pius,cxxi perciò M. Antonius Valentinus poté solo restaurare il santuario di Nemesis appartenente,cxxii se l’epigrafe tramanda veramente questo fatto. In base alla b. la parola municipium della 5ª riga dovette essere preceduta da decurio. b. Altare o base. Di autenticità incerta. Apulum. Sparita. Draskovich, ms. Luxemburg, 17-18, nr. 40. Marti Aug(usto) | pro salute Imp(eratoris) | Caes(aris) M(arci) Antonii | Gordiani Pii | Felicis Aug(usti) | M(arcus) Antonius | Valentinus | eq(ues) R(omanus) dec(urio) col(oniae) Apul(ensis) | sacerdos Arae | Aug(usti) n(ostri) | d(ono) d(edit). Tra il 238 e 244 d. C. L’epigrafe, se non è la variante interpolata della c., è un’altra iscrizione con testo simile del sommo sacerdote di Sarmizegetusa. Ci sono due differenze tra questa e la c., disegnata in buono stato e tramandata senza dubbio autenticamente. M. Antonius Valentinus qui è il decurio della colonia Apulensium, e non è menzionato il titolo coronatus Daciarum III. Le due differenze e i due posti diversi di ritrovamento sono sufficienti per ritenerle due epigrafi diverse. Una riserva potrebbe essere causata dal fatto, che N. Draskovich ha copiato l’iscrizione da un manoscritto, quindi non la ha vista, similmente alla maggior parte delle sue epigrafi. La datazione tra il 238 e 244 d. C. rende molto probabile, che nei testi si tratti della stessa persona. c. Altare. Sarmizegetusa. Nagyosztró o Várhely. Affondatosi nel Tibisco a Szeged. Marsigli 1726, II. pl. 57; CIL, III, 1433; ILS 7129; Kerényi 272; Deininger 1965, 118-119; Daicoviciu 1966, 155-163; IDR, III/2, 266; Fishwick 1987, 302; Ardevan 148a; Szabó Á. (1999) 2000, 119-150; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 113-114, nr. 10; Marti Aug(usto) | pro salute Imp(eratoris) | Caes(aris) M(arci) Antoni | Gordiani Pii | Felic(is) Aug(usti) | M(arcus) Antonius | Valentinus | eq(ues) R(omanus) dec(urio) m(unicipi) Apul(ensis) | sacerdos Arae | Aug(usti) n(ostri) | coronatus Dac(iarum) | III d(ono) d(edit). Tra il 238 e 244 d. C. Le sue due iscrizioni [b., c.] sono databili tra il 238 e 244 d. C. L’epigrafe a., attribuita a lui con certi dubbi, si data al periodo prima del 238 d. C. in base alle cariche.cxxiii Il gentilicium Antonius si trova dapperttutto nelle province occidentali, ma conosciamo parecchie persone orientali con questo nome.cxxiv Il praenomen M(arcus) davanti al gentilicium Antonius rinvia al “regno” orientale di Marcus Antonius, circa 300 anni prima, quando donò la cittadinanza romana a molta gente. Gli antenati di M(arcus) Antonius Valentinus poterono venire alla Dacia veramente dalla parte orientale dell’impero. Il suo cognomen fu in uso sia all’Occidente che all’Oriente.cxxv Fu eques romano, il decurio della colonia Aurelia (?) e del municipium Septimium Apulensium, poi il sommo sacerdote della provincia tra il 238 e 244 d. C., sotto Gordianus III. Fu nato probabilmente ad Apulum, ma non si può decidere, se fu il cittadino originalmente del municipium oppure della colonia. Se supponiamo una connessione tra il patronatus frammentario del collegiumcxxvi indicato nell’iscrizione a. e la parola municipium seguente, possiamo legare la persona del sommo sacerdote piuttosto al municipium, e così anche tutto il suo cursus municipale, dato che fino alla carica di sommo sacerdote dovette percorrere un cursus intero almeno in una delle città. Dovette occupare queste magistrature basse negli anni ’20 e ’30 del III secolo d. C. secondo il periodo relativamente breve della carica di sommo sacerdote. Nello stesso tempo poté divenire il patronus del collegium fabrum. Il testo di un altare molto frammentario ritrovato nell’anfiteatro di Sarmizegetusa e ormai sparito, conosciuto tramite solo copie cattive, menziona probabilmente il suo nome e il suo ufficio: ---?] | pro sal[---] | An. Val[---] | Aug. P R P[---]|rum [---].cxxvii In base alla seguente parte rimasta, e dato che si tratta di un altare, il testo dell’orlo perso dovette menzionare il nome di una divinità. A causa dei frammenti pro sal. e Aug. e in base alle lettere supposte della 3ª riga rimasta si pensava prima ad un luogotenente, e quest’ipotesi influenzava anche l’interpretazione. Finora non è conosciuto nessun luogotenente con questo nome, le lettere arrotondate sopra possono essere anche le prime tre lettere del titolo coronatus di Valentinus, a cui apperteneva la desinenza ---]|rum della 4ª riga integrata per es. come Dacia]|rum [III --. Il testo poteva avere anche ligature. Il posto del ritrovamento favorizza l’identificazione della persona come sommo sacerdote, al cui salute l’iscrizione fu dedicata. Le 3ª e 4ª righe potevano contenere anche il nome del consiglio provinciale in forma di concilium provinciarum Dac. III, dunque la desinenza ---]|rum può appartenere sia a provinciarum, che a Daciarum. In questo caso si tratta di un altare dedicato alla salute del sommo sacerdote dalla parte del consiglio provinciale [cfr.
MANUSCRIPT
Addendum 2.2]. Il titolo di sommo sacerdote è stato tramandato in due variazioni [b., c.], di cui si accetta la variazione di Sarmizegetusa (la sede ufficiale) come forma intera [c.], perché qui è indicato anche il titolo di capo del consiglio delle tre province daciche, il coronatus Daciarum III.cxxviii Ad Apulum questo non fu così importante [cfr. b.], qui egli fece scolpire solo il titolo di sommo sacerdote. Quest’ultima può essere cronologicamente la prima delle due iscrzioni erette come sommo sacerdote. Si deve menzionare anche la possibilità finora non dimostrabile, che M(arcus) Antonius Valentinus di Apulum fu eletto prima sommo sacerdote, poi fu insediato anche come il capo del consiglio provinciale, e questo si vede nelle diverse varianti del titolo. Riassumendo la sua carriera in base alle iscrizioni rimaste: dall’inizio del III secolo d. C. – eq(ues) R(omanus), e solo dopo il 197: dec(urio), (probabilmente quaestor e/o aedilis, IIIIvir ?) [pat]ronus co[ll(egi) f]abr(um) (?) m(unicipi), (dec(urio) col(oniae)?, tra il 238 e 244 sacerdos Arae Aug(usti) n(ostri), coronatus Dac(iarum) III, (sacerdotalis Arae Augusti).
{Atennais → D 90}
D 28
Aur(elius) Bassinus Altare? Base? Epigrafe votiva. Apulum. CIL – „Alba Iulia in domo principis”. CIL, III, 1108; EE, IV, 150; ILS 4344; Kerényi 2147; Sanie 1989, 1265, nr. 105; IDR, III/5, 103; Kaizer 2004, 567; Deo Soli | Hierobolo | Aur(elius) Bas|sinus dec(urio) | col(oniae) Aequens(is) | sacerd(os) nu|minum v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). L’iscrizione ritrovata ad Apulum è databile alla prima metà del III secolo d. C., presumibilmente dopo il 212. In base al gentilicium la cittadinaza romana poté essere ottenuta da uno dei suoi antenati sotto Marcus Aurelius, ma sembra più probabile, che la ricevette lui nel 212, tramite la Constitutio Antoniniana.cxxix Il suo cognomen è diffuso nella maggior parte delle province europee, ma per la dedicazione non è da escludere l’origine siriaca.cxxx Fu il decurio della colonia Aequum nella Dalmatia e il sacerdos di più numina singolarmente non precisati, a cui poteva appartenere probabilmente anche il Deus Sol Hierobulos – [H]ierhibol – Yarhibol palmirese.cxxxi La causa della dedicazione dell’altare poté essere un semplice atto religioso oppure la memoria di un viaggio d’affari, perciò il dedicatore si conta con riserva tra i sacerdoti della provincia, benché come decurio di Aequum nella Dalmatia poté vivere e agire da sacerdote anche nella Dacia. Si conosce un altro sacerdote apulense di Deus Sol Hierobulos [D 17], perciò l’esistenza di un santuario ha grande probabilità ad Apulum. Sulla sua carriera conosciamo i seguenti: nella prima metà del III secolo d. C. - dec(urio) col(oniae), sacerd(os) numinum.
D 29
M(arcus) Aur(elius) Comat(ius) Super a. Tavola. Apulum. Sparita. Ariosti 1722 ms. 3., 17; CIL, III, 1002; ILS, 3268a; Kerényi 656; Gostar 1965, 241-; Bărbulescu 1972, 204, nr. 7, 207; IDR, III/5, 62; Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 797-800; Dianae | Mellificae | sacrum | Com(atius) Su|per. Tra il 193 e 211 d. C. b. Tavola. Apulum. Dal muro della fortezza di Gyulafehérvár. CIL, III, 1095; ILS, 3268b; Kerényi 369; Bodor 1963, 217, nr. 40; IDR, III/5, 241; Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 797-800;
[Libero p]atri et Liberae | [---iu]s | [---]tus | [---]?CF | [---?eq(uo)] p(ublico). M(arcus) Aur(elius) Co|mat(ius) Super | antistes.
Dopo il 212 d. C. c. Tavola. Apulum. Dal muro della fortezza di Gyulafehérvár (Alba Iulia, Karlsburg – Cetate). CIL, III, 1096; ILS, 5552; Kerényi 368, 655, 1144, 1954; CIMRM II 1978; Tudor 1964, 288-; IDR, III/5, 242; Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 797-800;
MANUSCRIPT
Pro salute [sua? et suorum] | M(arcus) Aur(elius) Comat(ius) Super de[c(urio) antist(es)] M(arcus) | Comat(ius) Exsuperatus Petr[o]nia Celerina mater Herennia Euresis eius | filior(um) Superiani Exsuperanti|ani Superstitis Superes cryptam | cum porticibus et apparatori|o et exedra pec(unia) sua fec(erunt) l(ibenter). Dopo il 212. d. C. d. Epigrafe votiva. Altare? Apulum. Sparita. CIL, III, 1154; CIL, III, 7775; ILS, 3268; Bărbulescu 1972, 204, nr. 14; Ardevan 350; IDR, III/5, 349; Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 797-800; Silvano Silve|stri et Dianae | M(arcus) Aur(elius) Comat(ius) | Super dec(urio) an[t]is|tes pro salute | sua et Comatior(um) | Superiani Supe|res Exsupera|tiani Super|stitis filior(um) | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Dopo il 212. d. C. Egli è conosciuto tramite quattro iscrizioni, ritrovate ad Apulum, databili al periodo dalla fine del II secolo d. C. e al III secolo d. C. Comatius Super, con i diritti da peregrino, attivo già dalla fine del II – inizio del III secolo d. C., dovette ottenere la cittadinanza romana tramite la Constitutio Antoniniana, così cambiò il suo nome in M(arcus) Aur(elius) Comat(ius) Super. Della famiglia, oltre Comatius Super, sono conosciuti anche suo padre, sua madre e i suoi figli, che, oltre il gentilicium insolito nella Dacia, ebbero cognomina ancora più strani. Il loro gentilicium originale, Comatius, che fu in uso anche nella Pannonia, è di origine celtica.cxxxii Il cognomen Super è frequente nei territori delle province occidentali abitate da una popolazione inidgena celtica,cxxxiii la forma con il nome Comatius rinvia alla discendenza da una delle province occidentali (Gallia?). Secondo il suo primo impegno, fu – già come cittadino romano – antistes, cioé il superiore di un santuario oppure di un’area sacra, probabilmente quello di Locus di Apulum.cxxxiv Come cittadino romano e antistes salì nell’ordo decurionum, negli anni ’10-’20 del III secolo d. C. L’iscrizione dedicata a Liber Pater e a Libera appartiene verosimilmente al santuario o al centro di riunione di Marosportó (Partoş), scoperto negli anni 1990,cxxxv perciò egli poté essere decurio nella colonia Aurelia di Apulum. È da notare, che anche lui, come gli antistites danubiani, dedicò alla sede della provincia o a quella del consiglio provinciale – a volte insieme ai sommi sacerdoti – iscrizione a Nemesis, oppure a Fortuna di carattere simile a Nemesis, o a Diana, che, come si vede in uno dei casi di Aquincum, sotto certi aspetti è identificabile con Nemesis [cfr. D 40, 59].cxxxvi Secondo i dati della sua vita tramandati dalle iscrizioni la sua carriera si svolse così: alla fine del II. secolo d. C. – peregrinus, dopo il 212 cittadino romano, antistes, dec(urio) (coloniae).
D 30
Aure(lius) Fla(v)us Iscrizione commemorativa di una costruzione, in forma di altare. Porolissum. II. Dolichenum. Gudea-Tamba 2001, 25, 97; Piso 2001, 224-228, 225, nr. 2; AÉ, 2001: 1706-1707; Piso 2005 (Weber Fs.), 325; ILD 683; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) [D(olicheno)] | pro salute et [incolu]|mitate Imp(eratoris) C(aesaris) M(arci) [Ant(oni)] | Gordiani Pii Fel(icis) Aug(usti) | et coh(ortis) III Camp(estris) M(arcus) Aur(elius) Fla|(v)us IIIIvir m(unicipi) S(eptimi) P(orolissensis) M(arcus) Ant(onius) Maximu[s] | vet(eranus) et dec(urio) o[rnat]us ornam(entis) IIIIvir(alibus) | m(unicipi) s(upra) s(cripti) et Aure(lius) Fla(v)us dec(urio) m(unicipi) vegesi[m]a[r(ius)] | sacerdotes dei et coh(ortis) s(upra) s(criptae) [t]emp[l(um) cum] | tabernis (a)ere suo feceru[nt]. L’iscrizione commemorativa è databile tra il 238 e 244 d. C. Secondo il gentilicium dovette ottenere la cittadinanza romana sotto Caracalla. Il cognomen è conosciuto nell’ambiente germanico,cxxxvii portato da perecchie persone, tutte sacerdotes di Iuppiter Dolichenus.cxxxviii Fu il decurio del municipium di Porolissum e vegesimarius, inoltre il sacerdos di Iuppiter Dolichenus e della cohors III Campestris. Iuppiter Dolichenus non faceva parte della religione ufficiale del campo militare,cxxxix perciò si dovettero impiegare sacerdoti esterni per lui [D 26, 31]. I. Piso ha proposta la possibilità,cxl che egli fosse identico ad Aurelius Fla(v)us commerciante siriaco dell’iscrizione apulense I. O. M. D. | Aurelii | Alexan|der et Fla|(v)us suri | negotia|tores ex | voto l. p.cxli, oppure fosse il suo discendente. Quest’ipotesi è reale, ma finora non ne abbiamo nessuna prova diretta. Se erano identici, anche egli fu commerciante, similmente al suo collega, che alcuni anni prima ebbe ristabilito il Dolichenum ad Augusta Traiana [D 37]. Il Dolichenum e le tabernae furono costruiti da lui, e da due altri colleghi, ambedue sacerdoti di Dolichenus e magistrati della città. Il santuario fu costruito entro le mura,cxlii probabilmente non in un’area privata, ma pubblica. Perciò egli dovette essere un sacerdos con impiego ufficiale nel territorio della città.cxliii Questo Dolichenum, alla cui costruzione prese parte anche lui, è il secondo a Porolissum,cxliv anche cronologicamente. Il suo predecessore fu distrutto possibilmente nel 235 d. C., all’inizio del regno di Maximinus Thrax.cxlv
MANUSCRIPT
Secondo i suoi impegni e uffici conosciuti tramite le iscrizioni, la sua carriera si svolse così: tra il 238 e 244 d. C. - dec(urio) m(unicipi), vegesi[m]a[r(ius)], sacerdos dei, sacerdos coh(ortis). La sua carica sacerdotale può precedere la carriera municipale.
D 31
M(arcus) Aur(elius) Fla(v)us a. Altare. Majdanište. AÉ, 1968: 415; CCID, 125; Piso 2001 (AMN), 233; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) | et Castor(ibus) M(arcus) Aur(elius) Fla(v)us s(acerdos) I(ovis) [O(ptimi)] | M(aximi) D(olicheni) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito). La prima metà del III secolo d. C. b. Iscrizione commemorativa di una costruzione, di calcare, in forma di altare. Porolissum. II. Dolichenum. AÉ, 2001: 1706-1707; Gudea-Tamba 2001, 25, 97; Piso 2001 (AMN), 224-228, 225, nr. 2; Piso 2005 (Weber Fs.), 325; ILD 683; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) [D(olicheno)] | pro salute et [incolu]|mitate Imp(eratoris) C(aesaris) M(arci) [Ant(oni)] | Gordiani Pii Fel(icis) Aug(usti) | et coh(ortis) III Camp(estris) M(arcus) Aur(elius) Fla|(v)us IIIIvir m(unicipi) S(eptimi) P(orolissensis) M(arcus) Ant(onius) Maximu[s] | vet(eranus) et dec(urio) o[rnat]us ornam(entis) IIIIvir(alibus) | m(unicipi) s(upra) s(cripti) et Aure(lius) Fla(v)us dec(urio) m(unicipi) vegesi[m]a[r(ius)] | sacerdotes dei et coh(ortis) s(upra) s(criptae) [t]emp[l(um) cum] | tabernis (a)ere suo feceru[nt]. Tra il 238 e 244 d. C. Nel suo caso sembra giusta l’ipotesi di I. Piso,cxlvi che le due persone delle iscrizioni sopracitate siano identiche. L’epigrafe b. è databile tra il 238 e 244 d. C., mentre la a. può precedere la b. In base al gentilicium M(arcus) Aur(elius) Fla(v)us ottenne la cittadinanza romana sotto Caracalla. Il suo cognomen è conosciuto nell’ambiente germanico,cxlvii portato da parecchie persone, tutte sacerdotes di Iuppiter Dolichenus.cxlviii Nell’anno della costruzione del Dolichenum fu il IIIIvir del municipium. Il IIIIviratuscxlix presuppone, che, oltre al decurionatus del municipium, rivestì anche almeno una magistratura bassa, cioé fu quaestor o aedilis. Contemporaneamente alle magistrature municipali era il sacerdote di Iuppiter Dolichenus. Il santuario fu costruito entro le mura,cl probabilmente non in un’area privata, ma pubblica. Perciò dovette essere un sacerdos con un impiego ufficiale,cli il che è appoggiato dal suo IIIIviratus. Allo stesso tempo fu il sacerdos della cohors III Campestris, verosimilmente al servizio della stessa divinità. Dato che Iuppiter Dolichenus non faceva parte della religione tradizionale del campo militare,clii potevano essere impiegati sacerdoti esterni per lui [v. anche D 26, 30]. Il Dolichenum e le tabernae furono costruiti da lui, e da due altri colleghi, ambedue sacerdoti di Dolichenus e magistrati della città. Questo Dolichenum è il secondo a Porolissum,cliii anche cronologicamente, il suo predecessore fu distrutto possibilmente il 235 d. C., all’inizio del regno di Maximinus Thrax (235-238 d.C.).cliv Riassumendo la sua carriera in base al testo dell’iscrizione: probabilmente dal 212 d. C. – cittadino romano, s(acerdos) I. [O.] M. D. e dei, fino al 238-244 (decurio, quaestor e/o aedilis) e verosimilmente sacerdos coh(ortis), tra il 238 e 244 IIIIvir m(unicipi).
D 32
Aur(elius) Gaianus Altare. Porolissum. AÉ, 1944: 50; AÉ, 1977: 662; Daicoviciu 1941, 325, nr. 6; Russu 1969, 183; Gudea 1989, 768, nr. 37; Sanie 1989, 1253, nr. 40; Ardevan 486; ILD 694; De(ae) Suri|ae Aur(elius) | Gaianus dec(urio) m(unicipi) P(orolissensis) | sace(r)do[s]. L’epigrafe è databile al III secolo d. C., dopo il 200-211. Aurelius ricevette il suo nomen tramite la Constitutio Antoniniana nel 212, mentre il cognomen dimostra la sua origine siriaca,clv appoggiata anche dal nome della divinità nella dedicazione. Nella Dacia si conosce un veteranus di nome simile da Potaissa.clvi Aur(elius) Gaianus fu il decurio di Porolissum, ed ebbe il titolo di sacerdos. In base alla dedicazione non si può decidere, di quale divinità fu sacerdos. In generale si può dire, che fu sacerdote nel santuario di un culto orientale, presente anche a Porolissum, verosimilmente al servizio del municipium, se il santuario stava in area pubblica. È molto probabile però, che fu il sacerdos di Iuppiter Dolichenus, ed in questo caso eresse un altare alla Dea Suria appartenente allo stesso panteon.
MANUSCRIPT
Secondo gli elementi conosciuti della sua carriera: nel 212 d. C. cittadino romano, dopo il 212 - dec(urio) m(unicipi), sace(r)do[s] (municipi?).
D 33
Aur(elius) Gai(u)s Altare. Potaissa. CIL - Torda (Turda), via Kis n. 6. CIL, III, 7681; Kerényi 397, 404; Bărbulescu 1994, 160; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | et H(e)rquli Invicto et Liber(o) Pa[t(ri)] | Aur(elius) Gai(u)s et Aur(elius) Ingenu(u)s [frat(res) vagy fili(us)?] | sacer(dotes) ex vot(o) p(osuerunt). L’epigrafe è databile dopo il 193 d. C., ma il nomen Aurelius senza il praenomen restringe la datazione al periodo dopo la Constitutio Antoniniana.clvii Il suo cognomen non fornisce nessuna informazione per l’identificazione dell’origine etnica, capita anche nell’ambiente celtico.clviii È verosimile che fu sacerdos nella colonia Septimia Potaissensium. Non indicò, di quale divinità fu il sacerdote con il suo collega (verosimilmente suo fratello), con cui eresse l’altare. Nella dedicazione dell’altare si leggono i nomi di tre divinità: Iuppiter Optimus Maximus, Hercules Invictus e Liber Pater. Nella triade insolita sono menzionati quindi i Di Auspicesclix della patria di Septimius Severus, dunque le due divinità preferite dell’epoca Severiana, insieme alla divinità suprema della religione di stato. Benché conosciamo sacerdoti di Hercules e quelli di Liber Pater, il loro culto tradizionale con Iuppiter Optimus Maximus con un solo sacerdote è impossibile. I sacerdoti dedicatori possono essere ritenuti – soprattutto per Hercules e Liber Pater – i sacerdoti della città, cioé sacerdotes coloniae. Nel retroscena della dedicazione dell’altare alle divinità sopranominate poteva stare la religione dello stato insieme al culto delle divinità di patria di Septimius Severus, diffuso in tutto l’impero a causa della persona dell’imperatore.clx Della sua carriera si possono identificare riassumendo solo la cittadinanza romana e il sacerdotium, nel primo terzo del III. secolo d. C.
D 34
Aur(elius) Ingenu(u)s Altare. Potaissa. CIL - Torda (Turda) via Kis n. 6. CIL, III, 7681; Kerényi 397, 404; Bărbulescu 1994, 160; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | et H(e)rquli Invicto et Liber(o) Pa[t(ri)] | Aur(elius) Gai(u)s et Aur(elius) Ingenu(u)s [frat(res) vagy fili(us)?] | sacer(dotes) ex vot(o) p(osuerunt). L’iscrizione di Potaissa è databile dopo il 193 d. C., ma il nomen Aurelius restringe la datazione al periodo dopo la Constitutio Antoniniana.clxi Il cognomen ci dice solo che egli poté essere nato nella Dacia, ma l’origine etnica è inidentificabile.clxii Probabilmente fu sacerdos della colonia Septimia Potaissensium. Non indicò, di quale divinità furono i sacerdoti con il suo collega (verosimilmente suo fratello), insieme a cui eresse l’altare. Nella dedicazione dell’altare si leggono i nomi di tre divinità, ben conosciuti nella religione tradizionale dello stato: Iuppiter Optimus Maximus, Hercules Invictus e Liber Pater. Nella triade insolita sono menzionate quindi le due divinità preferite dell’epoca Severiana, gli dei di casa e dell’auspicio di Septimius Severus,clxiii insieme alla divinità suprema della religione di stato. Benché conosciamo sacerdoti di Hercules e quelli di Liber Pater, il loro culto con Iuppiter Optimus Maximus in forma tradizionale della religione romana con un solo sacerdote è impossibile, soprattutto Hercules e Liber Pater, menzionati insieme alla somma divinità della religione statale. I loro sacerdoti dedicatori possono essere ritenuti anche persone sacerdotali con competenza generale, sacerdoti della città, cioé sacerdotes coloniae. Nel retroscena della dedicazione dell’altare alle divinità sopranominate poteva stare la religione dello stato insieme al culto delle divinità di patria di Septimius Severus, diffuso in tutto l’impero a causa della persona dell’imperatore.clxiv Della sua carriera si possono identificare riassumendo solo la cittadinanza romana e il sacerdotium, nel primo terzo del III. secolo d. C.
D 35
Aurel(ius) Marinus Colonna. Ampelum.
MANUSCRIPT
CIL, III, 1301b; CIL, III, 7835; ILS, 4299; Kerényi 2126; Kan II, 30; Merlat 29; Hettner 4; Merlat 29; Russu 1969, 177-182; Angyal-Balla 1972, 94 nr. 5; Noeske 1977, 370, nr. 71; Berciu-Popa 1978, nr. 11; Sanie 1989, 1246, nr. 5; IDR, III/3, 299; CCID, 148; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) et | Deo Com|aceno | Aurel(ius) | Marinus | [et] Adde bar Seme|i et Ocea|nus So|cratis sa|cerdotes | v(otum) l(ibentes) p(osuerunt). L’epigrafe è databile alla fine del II secolo d. C., ma piuttosto all’inizio del III secolo d. C. Manca il praenomen, ed egli poté ottenere il gentilicium anche per adozione. Gli altri due sacerdoti – in base ai nomi – ottennero la cittadinanza romana non con la Constitutio Antoniniana. Egli, secondo il cognomen eloquente, frequente tra i fedeli di Iuppiter Dolichenus,clxv dovette venire nella Dacia da una delle province orientali dell’Impero, ma questo nome capita anche nell’Africa settentrionale e nelle province occidentali.clxvi Gli è conosciuta una sola carica: fu sacerdote con il titolo di sacerdos, e, sebbene non lo indicò, dovette essere il sacerdos di Iuppiter Dolichenus a causa della dedicazione. La sua azione insieme a due colleghi [D 1, 69] fu in connessione probabilmente con la fondazione di un Dolichenum ad Ampelum [cfr. D 81]. I. Piso ha proposta la possibilità,clxvii che egli fosse identico a Marinus Marian(i filius) Bassus. Se Aurelius Marinus è identico al dedicatore di una colonna votiva probabilmente dolicheniana di Apulumclxviii (Aurelius Marinus Bassus, Polydi filius), il che è più probabile, ma non certo, allora la sua identificazione con Marianus Bassus, figlio di Marinus non è sostenibile. In ambedue i casi i nomi differiscono, nell’iscrizione di Ampelum manca anche il cognomen Bassus. Della sua carriera si possono menzionare riassumendo solo la cittadinanza romana e il sacerdotium per Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus, alle fine del II e all’inizio del III secolo d. C.
D 36
M(arcus) Aur(elius) Maximus Rilievo votivo con la scena tauroctona di Mitra. Apulum. Magyarlapád (Lopadea Nouă). AÉ, 1988: 952; IDR, III/4, 63; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 425; M(arcus) Aur(elius) Maximus flam(en) m(unicipi) A(pulensis) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). L’iscrizione è databile dopo il 193-197 d. C., in base alla fondazione della città. Tutti i tre elementi del nome sono tipici nomi romani. La sua famiglia, secondo il praenomen e il gentilicium, poté avere la cittadinanza romana il più presto dal regno di Marcus Aurelius. Il suo cognomen capita dappertutto, perciò non è adatto all’identificazione dell’origine etnica.clxix Fu il flamen del municipium Septimium Apulensium.clxx Dato che ebbe una sola carica, dovette essere all’esordio. Al più presto circa il 197 – flam(en) m(unicipi). Riassumendo si può affermare, che all’inizio della sua carriera fu flam(en) m(unicipi) il più presto negli anni attorno al 197 d. C.
D 37
Aur(hlioj) Sabeinoj Qeiofilou Suroj Tavola commemorativa di una costruzione. Augusta Traiana, Thracia. SEG, III, 537; IGBulg, III/2, 1590; Dobó 848; CCID, 50; Ardevan 513; Gudea-Tamba 2001, 43-44, 115-116; Agaqhi tuchi | qew Dolichnw uper thj tou kuriou hmwn | anikhtou kai ewniou dianonhj kai nhkhj | Autokratori Kaisari Markw Aur(hliw) Seouhrw | Alexandrw Eusebouj Eutukouj Sebastou | kai Ioulia Mamaia Sebasthj kai iera sunklhtou | kai dhmw Rwmaiwn kai ierwn strateumatwn kai | boulhs kai demou Augousthj Traianhj || Aur(hlioj) Sabeinoj Qeiofilou Suroj iereuj kai | unemporoj thj Dakiaj kai Aur(hlioj) Primoj | Astew tw kai Iouliw {---} b(ou)l(eutej) thj Dakiaj | Septimia(j) Porolissou qiw {analabon ton naon} | analaboutej ton naon kata ton nomon | kai diskiplinan twn ierwn eutucwj. In base al nome dell’imperatore l’epigrafe è databile tra il 222 e 235 d. C. In base al gentilicium, il dedicatore ottenne la cittadinanza romana probabilmente nel 212 con la Constitutio Antoniniana. Ha un cognomen e un supranomen. Il cognomen è generalmente diffuso sia nell’ambiente occidentale che in quello orientale, ma fu frequente soprattutto nell’Italia settentrionale.clxxi Il supranomen fu in uso tra gli orientali, ma per lo più nella Pannonia orientale, nella Dalmatia, nel Noricum e nell’Italia settentrionale.clxxii Solo il nome greco del padre può rinviare all’origine da una delle province greche della parte orientale dell’Impero, che non deve significare necessariamente Siria. Nemmeno il testo greco ci fornisce aiuto, dato che la composizione contiene molte particolarità ed errori: è molto probabile che il testo fu tradotto dal latino, perché anche al posto lo si capisse. Inoltre, contiene una formula che rinvia ad una costruzione, mentre la prima parola della penultima riga riferisce ad un rinnovamento.clxxiii In base alla dedicazione dovette essere il sacerdote (iereuj) di Iuppiter Dolichenus a Porolissum, e si identificò anche come commerciante in vino (unemporoj thj Dakiaj) della Dacia. Assunse la costruzione indicata nel testo insieme ad un decurio di Porolissum, che dimostra il suo rapporto stretto con la direzione della
MANUSCRIPT
città.clxxiv Il suo stato come commerciante in vino fu in contatto versoimilmente con le tabernae costruite alcuni anni dopo, tra il 238 e 244 d. C., aggiunte al Dolichenum nuovo di Porolissum, sponzorizzate in parte dai sacerdoti di Dolichenus, i quali appartenevano alla direzione della città [cfr. D 26, 30, 31].clxxv È particolarmente importante la parte finale del testo, in cui è enunciato, che il tempio fu inaugurato, oppure piuttosto ri-inaugurato secondo le leggi e le prescrizioni religiose (kata ton nomon kai diskiplinan). L’espressione rinvia non alle prescrizioni locali, ma alle norme della legge romana, che è evidente nel caso di una colonia. Sarebbe stato inutile riferirsi al regolamento fuori la legge romana, dato che questo non obbligava i magistrati delle colonie a niente.clxxvi Nello stesso tempo il fenomeno illustra anche il fatto, che nell’epoca di Severus Alexander anche il culto di Iuppiter Dolichenus fu regolato dalle prescrizioni della religione romana, che spiega anche per esempio il retroscena giuridico dell’esistenza del Dolichenumclxxvii entro le mura di Sarmizegetusa, costruito nell’epoca.
D 38
Q(uintus) Aurelius Q(uinti) f(ilius) Pap(iria tribu) Tertius
a. Epigrafe donativa. Sarmizegetusa. Sparita. CIL, III, 1448; Kerényi 470; Daicoviciu 1969, 257; IDR, III/2, 72; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 83; [Imp(eratori) Caesari | Divi Hadriani fil(io)] | Divi Tr[aiani Parth(ici)] | ne[p(oti)] Divi [Nervae] | pron(epoti) T(ito) Ael(io) Had[riano] | Antonino Aug(usto) | Pio pont(ifici) max(imo) tr(ibunicia) | pot(estate) V co(n)s(uli) II[I] p(atri) p(atriae) | Q(uintus) Aurelius Q(uinti) f(ilius) | Ter[t]ius Pap(iria) Sarm(izegetusae) | dec(urio) col(oniae) ob honor(em) | flamoni et HS(sestertium) LXXX | n(ummum) ad annonam | dedit | l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum). Il 142 d. C. b. Altare sepolcrale. Sarmizegetusa. Alla strada romana a Nalácz (Nălaţvad). CIL, III, 6269; CIL, III, 7981; AÉ, 1913: 53; AÉ, 1914, 2, nr. 9; Kerényi 458, 470; Daicoviciu 1969, 256; IDR, III/2, 388; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 222; D(is) M(anibus) | Q(uinto) Aurelio Q(uinti) f(ilio) | Pap(iria tribu) Tertio | dec(urionali) et flamin(ici) | col(oniae) Sarm(izegetusae) | Q(uintus) Aurelius | Saturninus | Aug(ustalis) col(oniae) | et Proshodus | et Logismus | lib(erti) et hered(es) | f(aciendum) c(uraverunt). L’epigrafe sepolcrale è databile forse già agli anni ‘140-150, dato che mancano gli altri uffici del defunto. Una delle iscrizioni, databile al 142 d. C., fu eretta da lui [a.], l’altra è il suo monumento sepolcrale [b.], che, dato che non contiene altri impegni, è databile già agli anni ’40-’50. Secondo la datazione dell’epigrafe votiva, dovette essere un cittadino romano di seconda generazione di Sarmizegetusa. Il praenomen e il gentilicium rinviano ad un discendente di una famiglia di cittadinanza antica, possibilmente dell’Italia.clxxviii Il cognomen,clxxix diffuso nell’ambiente latino delle province occidentali può indicare anche il fatto, che egli fu nato come figlio terzo della famiglia. Nel 142 d. C., come decurio di Sarmizegetusa, diede 80.000 sesterzi nell’annona per la carica del flamen coloniae. Non conosciamo altri suoi uffici. Occupò la carica di flamen fino alla morte.clxxx La parola ipotizzabile flamin(icius) rinvia al fatto, che egli fu ex flamen, e si legge in questa forma per la morte. Nell’iscrizione [a.] non si legge, dove fu collocata la tavola, è indicato solo, che ad un posto ufficiale. Riassumendo la sua carriera breve secondo il testo delle due iscrizioni: prima del 142 d. C. - dec(urio) col(oniae), dal 142 flamen col(oniae).
D 39
Tib(erius) Cl(audius) Augustianus a. Altare o base. Apulum. IDR, III/5, 394; Balla 2000, 117, nr. 16; Petolescu 1983, 377, nr. 159; Ardevan 373; Mrozewicz 1999, 74, nr. 25; Ardevan 2004, 350, nr. 7; ---] | [---]io[---] | Maxima [Ti(berius) Cl(audius] | Augustia[nus] | augur m(unicipi) Ap(ulensis) eq(uo) p(ublico) [fil(ia)? ---] | [---. Il primo quarto del III secolo d. C. b. Tavola del piedistallo di una statua. Sarmizegetusa.
MANUSCRIPT
AÉ, 1903: 69; Kerényi 610; Deininger 1965, 118-119; Balla 2000, 117, nr. 16; Daicoviciu 1969, 388, nr. 1; IDR, III/2, 79; Piso 1982, 26614; Ardevan 91; Mrozewicz 1999, 74, nr. 25; Ardevan 2004, 351, nr. 15; ---] | [--- pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) | M(arci) Aur(eli) Severi Alexan|d]ri Pii [Fel(icis) Aug(usti)] | concilium p[ro]|vinciarum Dac(iarum) I[II] | [[dedicante Iasdio | Domitiano co(n)s(ulari)?]] | sacerdot(io) Tib(eri) Cl(audi) | Augustiani eq(uo) p(ublico). Il 222-235 d. C. Le due iscrizioni sono databili tra il 193-197 e 235 d. C. Il nome non rinvia concretamente all’origine, ma è senza dubbio, che la sua famiglia, la quale ottenne la cittadinanza romana verosimilmente nella prima metà del I secolo d. C., venne da una delle province occidentali, eventualmente dalla Dalmatia. Il suo cognomen relativamente raro si trova nell’Italia, nella Hispania, nella Gallia, nella Dalmatia e nella Moesia Superior, ma solo in pochi casi.clxxxi Come il membro dell’ordine equestre, fu l’augur del municipium Septimium Apulensium, prima del regno di Severus Alexander, poi divenne sommo sacerdote tra il 222 e 235 d. C. Non gli conosciamo altri impegni, ma dovette essere decurio almeno nel municipium Septimium di Apulum, ed omnibus honoribus functus possibilmente nella stessa città, dato che i sommi sacerdoti percorrevano in generale un intero cursus municipale. Nel frattempo fu eletto augur, ma l’anno non è identificabile. L’epigrafe di Sarmizegetusa [b.], eretta durante il suo tempo ufficiale come sommo sacerdote, è la prima menzione in iscrizione del consiglio provinciale comune delle tre Dacie. Quest’epigrafe ha un altro elemento importante: oltre la menzione del sommo sacerdote, indica la cooperazione del sommo sacerdote e il tempo della sua carica. Negli altri due casi daciciclxxxii il concilium provinciarum non fece scolpire il nome del sommo sacerdote sulla base della statua dell’imperatore. Il sommo sacerdote fu eletto per un anno,clxxxiii così il suo nome in sé stesso indicò l’anno secondo la cronologia locale. In questa iscrizione però dovette essere tramandato un evento speciale in ablativus temporis, che accadde proprio sotto Tib(erius) Cl(audius) Augustianus come sommo sacerdote e con la cooperazione del luogotenente investito con il diritto della dedicatio. Ricostruendo e riassumendo la sua carriera: nel primo quarto del III secolo d. C. - eq(uo) p(ublico), (decurio, quaestor e/o aedilis, IIIIvir ?) augur m(unicipi), sacerdos (Arae Augusti o Arae Augusti nostri, coronatus Daciarum III) poi sacerdotalis (Arae Augusti o Arae Augusti nostri?).
D 40
Cl(audius) Marcellus Tavola a rilievo. Apulum. CIL, III, 1126; ILS 3744; Kerényi 1941, nr. 622; Hornum 1993, 251, nr. 172; Ardevan 337; IDR, III/5, 296; Ardevan 2004, 350, nr. 8; Nemesi Exaudientis|simae Cl(audius) Marcellus an(tistes?). La 2ª riga è modificata da me. La AN è legata. Nel CIL e nelle IDR si propone ? Au(gustalis), ma in questo contesto la dedicazione a Nemesis rinvia piuttosto ad un antistes.clxxxiv Tutti gli antistites danubiani dedicarono alla sede della provincia o a quella del consiglio provinciale – a volte insieme ai sommi sacerdoti – iscrizioni a Nemesis, oppure a Fortuna di carattere simile a Nemesis, o a Diana, che sotto certi aspetti è identificabile con Nemesis [cfr. D 29, 59].clxxxv L’iscrizione è databile al III secolo d. C. Il preanomen manca, il gentilicium imperatorio è molto frequente anche nell’area danubiana.clxxxvi Il suo cognomen capita spesso nelle province occidentali, nell’Italia settentrionale e nella Dalmatia.clxxxvii Ebbe anche la cittadinanza romana. In base all’unica carica conosciuta fu antistes ad Apulum, molto probabilmente nella colonia Aurelia.clxxxviii Ricostruendo la sua carriera in base al testo dell’iscrizione: nella prima metà del III secolo d. C. – cittadino romano, an(tistes?).
D 41
Tib(erius) Cl(audius) Rufus(1)
Altare. Apulum. Sparito. CIL, III, 1064; Kerényi 630; IDR, III/5, 186; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 324; Ardevan 2004, 350, nr. 1; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | dis et de|abus | Tib(erius) Cl(audius) Ru|fus fla|men col(oniae). L’iscrizione è databile dopo il 180 d. C., in base al rango coloniale di Apulum. Il gentilicium imperatorio del dedicatore capita in gran numero anche nell’area danubiana.clxxxix Il suo cognomen è frequente nell’Italia settentrionale e nella Dalmatia, ma capita spesso anche nelle province occidentali.cxc Secondo il nome, la sua famiglia venne nella Dacia da una delle province occidentali. In base all’unica carica conosciuta, egli fu flamen della colonia Apulum.cxci Anche se dedicò l’altare
MANUSCRIPT
solo come flamen, poté avere anche altre cariche, ma è più probabile che fu all’inizio della sua carriera. La sua identificazione con la persona sotto il numero seguente [D 42] non è provata. In base al testo dell’iscrizione l’unico elemento conosciuto della carriera: dopo il 180 d. C. - flamen col(oniae).
D 42
Tib(erius) Cl(audius) Rufus(2)
Altare? Apulum. CIL – „Ad forum in suburbio lapis parieti domus insertus”. Sparito. Zamosius f. 56; CIL, III, 1065; Kerényi 630; Ardevan 325; IDR, III/5, 238; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 2004, 350, nr. 3; Libero Patri | Tib(erius) Cl(audius) Rufus | dec(urio) col(oniae) et | flamen | mun(icipi) Apul(ensium). L’epigrafe è databile dopo il 193-197 d. C., in base alla menzione del municipium Apulensium. Il gentilicium imperatorio del dedicatore è conosciuto in gran numero anche nell’area danubiana,cxcii il suo cognomen è frequente nell’Italia settentrionale e nella Dalmatia, ma capita spesso anche nelle province occidentali.cxciii Il suo antenato venne nella Dacia da una delle province occidentali. Egli fu il decurio della colonia Aurelia di Apulum e il flamen del municipium Septimium.cxciv Se le cariche sono inidcate cronologicamente, dovette concorrere al flaminatus del municipium come il decurio della colonia. A causa della sua fondazione tarda, poté essere lui uno dei primi flamines del municipium Septimium. Concorse nel municipium forse perché nella colonia non c’era posto libero per un flamen, dall’altra parte può darsi che nella società militare della nuova città ci fossero poche persone adatte ad una carica sacerdotale. Riassumendo la sua carriera secondo il testo dell’iscrizione: dopo il 180 d. C. – dec(urio) col(oniae), dopo il 197 – flamen mun(icipi).
D 43
M(arcus) Co[cce]ius Alexander
Tavola. Porolissum. Porta principalis sinistra. AÉ, 1979: 499; Tóth E. 1978, 32, nr. 29; Gudea 1989, 770, nr. 44; Ardevan 493; ILD 712; [---] | Ael(iae) [---]sin[---] vixit | an(nos) XL M(arcus) Co[cce]ius | Alexander vet(eranus) | ex Y(centurione) augur m(unicipi) Sep(timi) | Por(olissensis) coniugi | [---]. L’autore delle ILD ha pubblicato l’iscrizione con alcune piccole differenze formali. L’epigrafe sepolcrale è databile alla prima metà del III secolo d. C., dopo il 200-211, in base al rango della città. Il dedicatore ha un gentilicium imperatorio, diffuso nell’area danubiana e nelle province africane della parte latina.cxcv Il cognomen storico, conosciuto e usato dappertutto anche nelle province europee non è adatto per l’identificazione dell’origine, tenendo in considerazione anche l’epoca Severiana.cxcvi La sua carriera poté cominciare già alla fine del II secolo d. C. Secondo il testo dell’epigrafe fu congedato dalle armi come centurio, poi fu l’augur del municipium di Porolissum. Quello che non specificò sono i gradi precedenti al centurionatus e almeno un decurionatus a Porolissum, il quale dovette spettare ad un centurio congedato, con l’anello dell’ordine equestre. Non è da escludere, che fu uno dei primi (se non il primo) augur del municipium di Porolissum. Gli elementi conosciuti e supponibili della sua carriera: dalla fine del II secolo d. C. – (cittadino romano, servizio militare, gradi da sottoufficiale, centurio), nel primo terzo del III secolo – vet(eranus) ex Y(centurione), augur m(unicipi).
D 44
Cocceius Umbria[n]us
Monumento sepolcrale. Nedinum. Dalmatia. CIL – „Prope castrum Nadini”. CIL, III, 2866; Dobó 846; Ardevan 502; Cocceio Umbria[n]o | decurioni auguri et pontifici | civitatis Paralis(s)ensium | provinciae Daciae | Cocceius Severus | filius patri pientissimo. L’iscrizione è databile al periodo dalla metà del III secolo d. C., in base all’espressione civitas della città.cxcvii Il monumento fu eretto da Cocceius Severus a suo padre, Cocceius Umbrianus, il già magistrato di Porolissum della Dacia. Il suo gentilicium imperatorio fu diffuso nell’area danubiana e nelle province africane della parte latina.cxcviii Nella Dacia capita solo in pochi casi.cxcix La radice del cognomen non è senza parenti, ma in questa forma è l’unico nel materiale onomastico delle
MANUSCRIPT
province europeecc e rinvia probabilmente all’Umbria nell’Italia centrale. Nella prima metà del III secolo d. C. fu Cocceius Umbrianus il decurio, poi l’augur e il pontifex del municipium di Porolissum. L’iscrizione elenca gli uffici verosimilmente in ordine cronologico, benché nel caso delle due cariche sacerdotali sia possibile anche l’ordine alfabetico. Per il gentilicium raro nella Dacia e per la residenza fu probabilmente il parente di M(arcus) Cocceius Alexander [D 43] di Porolissum, che fu l’augur del municipium di Porolissum come veteranus ex centurione. La distanza cronologica tra la datazione dell’iscrizione dedicata dal figlio e la data supponibile della carica di Cocceius Alexander fa pensare, che Cocceius Umbrianus, il padre di Cocceius Severus, fu il figlio o il nipote di Cocceius Alexander. La terminologia dell’iscrizione di Nedinum è così tarda, che si può ritenere Cocceius Severus uno degli emigranti dalla Dacia in fase decadente. Riassumendo la sua carriera secondo il testo dell’iscrizione: nel secondo quarto del III secolo d. C. - decurio, augur, pontifex civitatis (= municipi).
D 45
(Marcus) Cominius Celerinus
Sarcofago. Sarmizegetusa. Affondatosi nel Tibisco a Szeged. Marsili 1726, II. 57; CIL, III, 1473; Kerényi 657; Devijver 1976, C 221; Balla 2000, 117, nr. 17; IDR, III/2, 371; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1993, 227-235; Ardevan 193; Ardevan 1998, 197; D(is) M(anibus) | quod Aelia Adiuta mater sibi et Comi|nio Celerino pontif(ici) col(oniae) eq(uiti) R(omano) trib(uno) leg(ionis) facere | [consti]tuerat Cominius Quintus pontif(ex) et q(uin)q(uennalis) | [et Cominia] Sperata et Cominia Caecilia fili(ae) | [c]onsummaverunt. L’epigrafe sepolcrale è databile alla fine del II secolo d. C. Il suo gentilicium è frequente nell’Italia settentrionale e nella Gallia meridionale, mentre il cognomen nella Dalmatia.cci Deve essere il discendente di una famiglia romanizzata da lungo. Gli uffici nell’iscrizione sono indicati molto probabilmente in ordine cronologico. Benché il rango di decurio non sia menzionato, è molto probabile, che – in base agli elementi conosciuti della carriera – fu nato in una famiglia che, per quanto riguarda lo stato sociale, corrispondeva alle condizioni dell’ordo decurionum. Come decurio poté divenire pontifex, poi, salito nell’ordine equestre, si dedicò alla carriera militare. Della militia equestris è indicata sul monumento solo la militia secunda. Come legiotribunus poté morire in una delle guerre alla fine del secolo. La maggior parte della sua carriera è databile all’ultimo terzo del II secolo d. C. Il monumento fu cominciato dalla moglie e fu terminato dal figlio [D 46] e dalle figlie. Il gentilicium Aelia della moglie è frequente, il cognomen Adiuta è caratteristico per i celti romanizzati del Noricum.ccii Una delle figlie, la sorella di M(arcus) Cominius Quintus fu sposata da T(itus) Varenius Probus [D 75a.], il padre di T(itus) Varenius Pudens [D 46d.]. Riassumendo gli elementi della sua carriera, tramandati dal testo dell’iscrizione: nel terzo quarto del II secolo d. C. (decurio?), pontif(ex) col(oniae), eq(ues) R(omanus), (militia prima – praefectus cohortis), trib(unus) leg(ionis).
D 46
M(arcus) Cominius M(arci) f(ilius) Pap(iria tribu) Quintus a. Sarcofago. Sarmizegetusa. Affondatosi nel Tibisco a Szeged. Marsili 1726, II. 57; CIL, III, 1473; Kerényi 657; Devijver 1976, C 221; Balla 2000, 117, nr. 17; IDR, III/2, 371; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1993, 227-235; Ardevan 193; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 111 nr. 6. a; D(is) M(anibus) | quod Aelia Adiuta mater sibi et Comi|nio Celerino pontif(ici) col(oniae) eq(uiti) R(omano) trib(uno) leg(ionis) facere | [consti]tuerat Cominius Quintus pontif(ex) et q(uin)q(uennalis) | [et Cominia] Sperata et Cominia Caecilia fili(ae) | [c]onsummaverunt. La fine del II secolo d. C. b. Tavola. Sarmizegetusa. CIL, III, 7907; Kerényi 286, 648, 657, 658, 659, 660; Daicoviciu 1966, 156-157; IDR, III/2, 19; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1993, 227-235; Ardevan 54; Ardevan 2004, 351, nr. 14; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 111 nr. 6c; Deae [Re]ginae | M(arcus) Com(inius) Q[u]intus eq(uo) p(ublico) | pon(tifex) et q(uin)q(uennalis) col(oniae) et Anto|nia Valentina eius | pro salute Claudi|ae Valentinae || templ(um) a solo fecerunt. L’inizio del III secolo d. C.
MANUSCRIPT
c. Tavola. Sarmizegetusa. Demsus (Densuş). CIL, III, 1497; ILS 7133; Kerényi 657, 658, 660; Daicoviciu 1969 (= 1966), 389-390, nr. 6; Balla 2000, 117, nr. 18; IDR, III/2, 107; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1993, 227-235; Ardevan 118; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 111 nr. 6. b; M(arco) Comin(io) M(arci) f(ilio) | Pap(iria tribu) Quinto | pontif(ici) col(oniae) Sar(mizegetusae) | et praef(ecto) q(uin)q(uennali) pro | Antonino imp(eratore) | patr(ono) coll(egi) fab(rum) eq(uo) p(ublico) | ordo col(oniae) ob mer(ita) | ipsius. L’autore delle IDR ha identificato l’imperatore con Marcus Aurelius, al cui posto fu M(arcus) Cominius Quintus il praefectus quinquennalis, in base alla D 87.cciii Ma anche Caracalla ed Elagabalus ebbero il nome Antoninus, anzi, loro furono nominati solo con questo nome, mentre quello di Marcus Aurelius si legge nelle iscrizioni anche in altre forme. Dato che Cominius Quintus ebbe la carica di sommo sacerdote della provincia con il titolo sacerdos Arae Augusti [d.], si intende piuttosto Caracalla o Elagabalus come Antoninus imp. D. Fishwick ha dimostrato,cciv che i sacerdoti dell’Ara sono menzionati solo dall’epoca Severiana e prima nella Gallia, così anche la datazione tra il 180 e 200 d. C., suggerita da R. Ardevan,ccv sembra troppo presto. L’istituto indipendente dell’Ara Augusti poté esistere al più presto dal 193 d. C., ma è più probabile, che fu inaugurato nella Dacia solo dopo l’inizio del nuovo secolo.ccvi Perciò la datazione dell’iscrizione si sposta chiaramente all’epoca Severiana, e più precisamente dopo l’inaugurazione di Caracalla come Augustus, cioé dopo il 197,ccvii fino all’assassinio di Elagabalus punito con damnatio memoriae, cioé fino al 222 d. C.ccviii Dato che Caracalla non ebbe questa punizione, è più probabile, che sia lui l’imperatore con il nome Antoninus, al cui posto fu Cominius Quintus il q(uin)q(ennalis). Questo ci fornisce anche la datazione dell’iscrizione: l’epoca di Caracalla Augustus, e più precisamente con ogni probabilità all’epoca di Caracalla come monarca. In questo caso, prendendo in considerazione la fondazione di Sarmizegetusa tra il 106 e 108 d. C.ccix e il primo (212 d. C.) e l’ultimo anno (217 d. C.) della monarchia di Caracallaccx, gli anni possibili per il quinquennalis, cioé per la dedicazione dell’iscrizione sono 212, 213, 216 e 217 d. C. d. Base (?). Sarmizegetusa. Sparita. CIL, III, 1513; ILS, 7131; Kerényi 657, 658, 659, 660, 1531; Trynkowski 1965, 375-376; Ardevan 1984, 95-110; Balla 2000, 117, nr. 18; IDR, III/2, 108; Ardevan 1993, 227-235; Ardevan 121; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 111 nr. 6. d; ---] | [Cominiae ---] | [--- coniugi] | T(iti) Vareni Probi | q(uin)q(uennali) col(oniae) Sarm(izegetusae) | M(arcus) Cominius | Quintus pontif(ex) | et bis q(uin)q(uennalis) col(oniae) eq(ues) R(omanus) | sacerdos Arae | Aug(usti) | sorori pientissimae | l(oco) d(ato) d(ecurionum) d(ecreto). L’inizio del III secolo d. C. Egli è conosciuto tramite quattro iscrizioni di Sarmizegetusa, databili alla fine del II – inizio del III secolo d. C., la [b.] tra il 212 e 217 d. C., tranne gli anni 214 e 215. Il gentilicium fu frequente nell’Italia settentrionale e nella Gallia meridionale.ccxi Suo padre fu il pontifex di Sarmizegetusa, eques romano e legiotribunus. M(arcus) Cominius Quintus, salito similmente nell’ordine equestre, fu il pontifex, poi il (IIvir) quinquennalis di Sarmizegetusa [a-d.]. Le due cariche indicate presuppongono come primi uffici il decurionatus e una o ambedue le magistrature basse, cioé poté essere quaestor e/o aedilis. Non è menzionato un IIviratus semplice, cioé non quinquennale. Se il suo primo anno come IIvirccxii cadde proprio al quinto anno, divenne subito quinquennalis. Ma prendendo in considerazione il rango più alto della quinquennalitas, possiamo contare eventualmente anche con un altro IIviratus precedente. Poi fu di nuovo duumvir quinquennalis in sostituzione dell’imperatore Caracalla (212-217 d. C.) [c.] con il titolo praefectus quinquennalis, menzionato in generale anche nell’iscrizione dedicata alla sorella [d.] semplicemente con la parola bis, rinviando anche alla carica rivestita già precedentemente. Poi fu eletto il patronus del collegium fabrum.ccxiii Alla fine ebbe la carica di sommo sacerdote della provincia almeno per un anno, prima del 222 d. C. Uno dei pilastri del suo benessere dovette essere l’industria, il più probabilmente la fabbricazione dei mattoni, se, come si suppone, i bolli laterizi di M(arci) C(omini) Q(uinti) riferiscono a lui, quindi alla sua fabbrica di mattoni.ccxiv Finì il monumento di suo padre cominciato dalla madre come pontifex e quinquennalis. Se il padre morì alla metà, alla fine dell’ultimo decennio del II secolo d. C., nemmeno il completamento del monumento cominciato poté durare lungo. Perciò M. Cominius Quintus fu pontifex e la prima volta quinquennalis già nell’ultimo decennio del II secolo d. C. Contando gli anni quinquennali dalla fondazione di Sarmizegetusa, cioé dal 106-108 d. C.,ccxv poté essere duumvir quinquennale nell’ultimo decennio del II secolo d. C. solo nel 191-193 d. C. oppure nel 196-198 d. C., oppure la prossima volta nel 201-203 d. C. La data circa il 190 d. C. sembra troppo presto considerando la carriera futura e l’età media dell’epoca, per questo dovette avere il primo ufficio quinquennalis dal 196-198 d. C. Al posto di Caracalla poté essere praefectus quinquennalis teoricamente già dal 197 d. C.,ccxvi ma sembra più probabile, che questo evento cadde alla monarchia di Caracalla, tra il 212 e 217 d. C. La carica di pontifex è menzionata da tutte e quattro iscrizioni. Sul monumento sepolcrale del padre, che è probabilmente la prima iscrizione cronologicamente, non è indicato, che egli fu il membro dell’ordine equestre, solo la carica di pontifex e l’ufficio quinquennalis, rivestito per la prima volta. Lo stato equestre del padre poté dimostrare magari anche il posto sociale del figlio, oppure egli divenne eques solo succesivamente. Nella – in teoria – prossima iscrizione cronologicamente, dedicata probabilmente alla salute della suocera, è indicato – oltre le cariche di pontifex e di quinquennalis – anche il rango equestre, che non aveva un posto fisso nel suo cursus. Le cariche delle due iscrizioni [a., b.] possono essere considerate come semplici liste di cursus, le quali contengono cronologicamente solo i nomi degli uffici occupati da lui e il rango ricevuto nel frattempo. L’iscrizione seguente [c.] invece tramanda verosimilmente fenomeni attuali. L’ordo decurionum gli dedicò un’epigrafe onoraria nel secondo anno della carica
MANUSCRIPT
quinquennalis con l’indicazione degli uffici e degli impegni dell’anno attuale: quelli con elezione e quelli continui. Se avessero voluto indicare il suo cursus, avrebbero rinviato anche al primo ufficio quinquennalis. Nell’iscrizione – oltre al secondo impegno quinquennale – è menzionata di nuovo la continua carica di pontifex. Contando dal primo ufficio quinquennalis, prima di cui era già stato pontifex, poté divenire quinquennalis di nuovo al più presto dopo cinque anni, ma è possibile, che questo accadde solo dopo dieci anni. Questo significa, che aveva la carica di pontifex, che aveva avuto già prima del primo ufficio quinquennalis, continuamente anche dopo cinque anni, cioé non fu indicata nel cursus come una carica di tempo determinato. Così è provato, che il suo pontificatus durò a vita, come è stato affermato anche nel caso dei colleghi di alto rango nella città di Roma, e nei casi delle province occidentali.ccxvii Il quinquennalis veniva eletto in ogni cinque anni, perciò l’anno del suo ufficio può cadere al 212, 213, 216 e 217 d. C. a causa della data incerta della fondazione della città. M. Cominius Quintus ricevette la carica di sommo sacerdote della provincia successivamente, cioé tra il 215-217 d. C. e uno degli anni del regno di Severus Alexander (222-235 d. C.), in base al suo titolo di sommo sacerdote.ccxviii Sua moglie, Antonia Valentina fu la sorella probabilmente di M. Antonius Valentinus [D 27], a causa del ceto sociale e della cronologia. Una delle sue due sorelle fu la moglie di T. Varenius Probus [D 75 a.].ccxix Riassumendo la sua carriera secondo gli impegni conosciuti e presumibili in base al testo delle iscrizioni: nell’ultimo decennio del II secolo d. C. - eq(uo) p(ublico), (decurio, quaestor e/o aedilis, IIvir ?), pontif(ex), q(uin)q(uennalis), tra il 212 e 217 - praef(ectus) q(uin)q(uennalis) pro imp(eratore) rinviando alle due quinquennalitates bis q(uin)q(uennalis) col(oniae), patr(onus) coll(egi) fab(rum), eq(ues) R(omanus), circa prima del 222, ma al più tardi all’inizio del regno di Severus Alexander, sacerdos Arae Aug(usti) poi (sacerdotalis Arae Augusti).
D 47
F[a]b(ius) Pulcher a. Monumento sepolcrale. Apulum. Sparito. Ariosti 1722 ms. 2, 9; CIL, III, 1214; ILS, 7154; Kerényi 715, 717, 1662; Macrea 1978, 141, nr. 62; Ardevan 446; IDR, III/5, 527; D(is) M(anibus) | T(ito) Fabio Iblio|maro domo Augus(ta) Treve[r(orum)] | quond(am) dec[ur(ioni)] | [k]anabar(um) vix(it) | annis LX | Fabii Pulcher | Romana Aqui|leiensis per tu|tores suos pos(uerunt). Dopo il 180 d. C. b. Altare. Apulum. Gyulafehérvár (Alba Iulia, Karlsburg), Kutyamál (Dealul Furcilor, Galgenberg). CIL, III, 1157; Opriş 1931, XI, nr. 87; Kerényi 714; Ardevan 343; IDR, III/5, 363; Veneri | Aug(ustae) | Fab(ius) Pulcher | [?decuri]o aug|[ur ---] col(oniae) | [vot(um) sol]vit. Il 193-211 d. C. Egli è probabilmente identico a Pulcher dell’iscrizione precedente. Non poteva essere Aug(ustalis) nenanche a causa dei rapporti familiariccxx come è stato proposto per la lettura sbagliata del testo. In questo caso sarebbe l’unico Augustalis in questo stato sociale, e non solo nella Dacia. Il titolo dell’impegno continua probabilmente nella riga seguente, il che è meno irregolare del decurionatus scritto in forma intera e delle parole della formula finale del voto, una abbreviata con tre lettere, l’altra scritta con parola intera, invece della solita abbreviazione con una singola lettera. Questo modo di scrittura è in contrasto con la pratica severamente regolare degli auguri dell’area danubiana, che indicavano la loro carica sempre con una parola intera. Le parti mancanti (l’inizio della 4ª e la parte centrale della 5ª riga) offrono più soluzioni possibili per quanto rigurada l’abbreviazione col. alla fine della 5ª riga, che rinvia all’impegno o agli impegni del dedicatore rivestiti nella colonia, così anche all’auguratus, e inoltre anche ad almeno un’altra carica. Il compositore del testo collocò nello spazio questi ultimi con una sola parola: col(oniae). Possiamo supporre un rango equestre, ma sicuramente il decurionatus, che è appoggiato dal frammento della O davanti all’aug| [ur nella 4ª riga. Nella 5ª riga poté esser indicata una carica pontificale in forma abbreviata, ma piuttosto un IIviratus. Egli è conosciuto tramite due iscrizioni di Apulum, che sono databili alla fine del II – inizio del III secolo d. C. Il padre, Titus Fabius Ibliomarus venne da Augusta Treverorum e morì all’età di 60 ad Apulum. Fu il decurio delle canabae della legio XIII Gemina, del futuro municipium Septimium Apulensium. Il monumento sepolcrale fu eretto dai due figli, Fabius Pulcher e Fabius Aquileiensis, e dalla figlia, Fabia Romana. Il figlio piccolo, Aquileiensis si dedicò alla carriera militare, ed ebbe una funzione che presupponeva il rango equestre.ccxxi Il figlio grande, Pulcher, fu prima decurio, poi augur nella colonia di Apulum, verso la fine del II secolo d. C. Per la condizione frammentaria dell’iscrizione non gli conosciamo altri uffici. Riassumendo la sua carriera in base al testo delle due iscrizioni: alla fine del II secolo d. C., al più presto dal 180 – [?decuri]o, aug[ur ---?] col(oniae).
{Flavius → D 91}
MANUSCRIPT
D 48
Flavius bar Hadadi
Altare. Apulum. Gyulafehérvár (Alba Iulia, Karlsburg), bd. Încoronării (già 6. Martie) nr. 32, accanto al campo della legione. AÉ, 1965: 30a; Russu 1969, 177; Angyal 1971b, 5-26; AÉ, 1972: 460; AÉ, 1975: 719; Speidel 1978, 50-52, nr. 28; Berciu-Popa 1978, 4-7, nr. 3; Bărbulescu 1984, 176; CCID, 154; Sanie 1989, 1176 d, 1246, nr. 4; IDR, III/5, 221; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) et Deae | Suriae Magnae | Caelesti pro salu|te perpetui Imperi | Romani et leg(ionis) XIII | Gem(inae) Flavius bar | Hadadi s(acerdos) I(ovis) D(olicheni) ad | leg(ionem) s(upra) s(criptam) v(otum) l(ibens) m(erito) p(osuit). La i alla fine della parola Hadad deve essere la desinenza del genitivo, e questo conferma il significato semitico del nome: Flavius, figlio di Hadad. L’iscrizione scoperta ad Apulum è databile tra il 193 e 211 d. C. Secondo il nome egli fu siriaco, più precisamente con ogni probabilità palmirese.ccxxii Fu il sacerdote di Iuppiter Dolichenus presso la legio XIII Gemina.ccxxiii La sua cittadinanza romana è incerta. Come sacerdote non dovette avere la cittadinanza come i soldati della legione, ma non si può affermare nemmeno il contrario, solo in base al nome. Nella sua persona è conosciuto un nuovo sacerdote – oltre quelli di Porolissum e di Drobeta [D 26, 30, 31, 90, 91, 92] –, che agì nell’esercito in connessione con il culto di Iuppiter Dolichenus. Questo fenomeno rinvia al fatto, che molti seguaci della divinità dolichena facevano il miltare, e benché la divinità tradizionalmente non facesse parte della religione ufficiale del campo,ccxxiv il culto esisteva nel campo, oppure nel tempio o nel santuario nel territorio del campo, con l’aiuto dei sacerdoti venuti dall’infuori. La dedicazione dell’epigrafe alla salute dell’impero forma un gruppo speciale insieme per esempio con le dedicazioni delle iscrizioni di C. Iulius Valens [D 59]. In base al testo dell’iscrizione si può affermare sulla carriera solo ciò, che fu il sacerdos di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus con uno stato personale-giuridico sconosciuto (peregrinus ?, cittadino romano ?), e agì come sacerdote presso la legione XIII Gemina di Apulum.
D 49
Fl(avius?) M[arianus?]
Tavola. Sarmizegetusa, l’angolo Sud-occientale della città, l’area del cd. Dolichenum. AÉ, 1927: 56; Daicoviciu 1924, 250; Sanie 1977, 146; AÉ, 1977: 668; IDR, III/2, 20; Szabó Á. 2004 (HPS), 139-161; AÉ 2004: 1212; [I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Dolicheno pro salute] | [D(omini) N(ostri) Imp(eratoris) Caes(aris) Divi Severi Pii nep(otis)] | [Divi Magni Ant]on[ini f(ili) M(arci) Aur(eli) Sev]|[eri [[Alexandri]]] Pii [Fel(icis) Inv(icti) Aug(usti)] | [et num(eri) P]almyr(enorum) O[rientali(um)] | [---]i Abraen(us) Fl(avius) M[arianus] | [----] Cassi(us) Marinu[s ---] | [Ma]ximus Gora Lu[cianus] | [---] Maximus bar S[emon?] | [sace]rdot(es) templum [a solo] | ex suo fecer(unt). L’iscrizione di una costruzione è databile tra il 222 e 235 d. C. Il nomen imperatorio (in questo caso interpretato come gentilicium) del sacerdote, Fl(avius?) M[arianus?] fu diffuso dappertutto nell’impero.ccxxv Il cognomen supposto, derivato dal nomen Marius, si trova anche nel materiale onomastico delle province europee, tranne la Britannia, la Moesia e la Raetia.ccxxvi A causa dell’ambiente però venne verosimilmente da una delle province orientali dell’impero, ma non è da escludere, che fu nato in una delle province occidentali. Fu cittadino romano, dopo il 212 d. C. sicuramente, e in base alla dedicazione il sacerdote di Iuppiter Dolichenus. Fece costruire – con altri colleghi – il Dolichenum entro le mura, il pomerium di Sarmizegetusa. Questo fenomeno si può spiegare con il fatto, che nell’epoca di Severus Alexander (222-235 d. C.) il culto di Iuppiter Dolichenus fu regolato già dalle prescrizioni e regole della religione romana e del pontificatus [cfr. per es. D 37]. Il luogo del tempio rinvia anche a ciò che i sacerdoti della divinità avevano un impegno di carattere ufficiale nella città. Quindi Fl(avius) M[arianus?] poteva essere un sacerdos coloniae. La sua attività nella Dacia cominciò presumibile negli anni ’10-’20 del III secolo d. C., secondo la datazione dell’epigrafe. Non si può riassumere la sua carriera a causa dei pochi dati frammentari. Si può affermare, che come una persona di origine orientale e come cittadino romano fu il sacerdos di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus, nel secondo terzo del III secolo d. C., nella Dacia.
D 50
L(ucius) Fl(avius) Valens
a. Altare. Sarmizegetusa (Ardevan) – Gyulafehérvár (Alba Iulia, Karlsburg), nel palazzo episcopale (CIL).
MANUSCRIPT
CIL, III, 1134; Kerényi 767; Sanie 1989, 1209; Ardevan 1992, 4919; Ardevan 142; L(ucius) Fl(avius) Valens | ob honorem flamonii | B(---) p(ublico) d(edit). Seconda metà del II – inizio del III secolo d. C. Nella 3ª riga lo scioglimento B(ono) P(uero) d(edit) sembra forzato e poco ragionevole. Pare improbabile, che egli dedicò qualcosa al Bonus Puer di nessun interesse pubblico per ottenere la carica di flamen, che fu invece in rapporto stretto con l’elezione, con il culto dell’imperatore e con la città, e menzionò questa donazione in forma abbreviata e solo alla fine dell’iscrizione. L’abbreviazione di due lettere dovette indicare piuttosto un dono pubblico, oppure egli usò una formula hapax finale. Come un’altra possibilità si può supporre, che fece un dono con la B – b(asilica), b(alneum) ? – per il p(ublico). Il dono menzionato fu sicuramente evidente a causa del posto dell’iscrizione, perciò era superfluo descriverlo più dettagliatamente. b. Altare sepolcrale. Sarmizegetusa. Sparito. CIL, III, 1501; IDR, III/2, 410; Sanie 1989, 1209; Ardevan 204; D(is) M(anibus) | L(ucio) Fl(avio) Valenti | vix(it) an(nos) LXXX | coll(egium) fabr(um) patr(ono) | p(osuit). II-III secolo d. C. Ambedue le iscrizioni sono databili ai II-III secoli d. C. L’identificazione delle due persone è stata supposta da S. Sanie, senza spiegazione. Ma a causa del posto di ritrovamento e del nome la si può accettare ipoteticamente. Dato che l’iscrizione b. fu dedicata da un collegium al loro patronus,ccxxvii la carica di flamen non dovette essere indicata. Comunque, l’identificazione si accetta solo ipoteticamente. Ebbe un gentilicium imperatorio,ccxxviii diffuso generalmente, e anche il suo cognomen, che venne dall’Italia settentrionale, si trova dappertutto come nome latino.ccxxix Fu il flamen di Sarmizegetusaccxxx e il patronus del collegium fabrum. Gli si suppone anche almeno un decurionatus a Sarmizegetusa. Secondo l’epigrafe sepolcrale morì all’età di 80. Per l’età tarda la morte poté cadere anche all’inizio del III secolo d. C. Il suo flaminatus però è databile già dalla seconda metà del II secolo d. C. Per quanto rigurada la carriera, in base al testo delle due iscrizioni si può affermare riassumendo che dopo la metà del II secolo d. C. egli fu un flamen (coloniae), patr(onus) coll(egi) fabr(um).
D 51
C(aius) Gaur(ius) Gaurianus
Altare. Sarmizegetusa. Alsó-Telek (Teliucu Inferior, oggi Vajdahunyad-Hunedoara). AÉ, 1909: 112; Kerényi 798; IDR, III/3, 37; Ardevan 245; Numini | domini n(ostri) | M(arci) Aur(eli) Antonin(i) | Pii Fel(icis) Aug(usti) | C(aius) Gaur(ius) Gauri|anus sacerd(os) col(oniae) | Apul(ensis) et Fl(avius) Sotericus | Aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae) cond(uctores) | ferrar(iarum). L’iscrizione, dedicata insieme con un socio, uno degli Augustales di Sarmizegetusa, è databile tra il 212 e 217 d. C. Il suo cognomen deriva probabilmente dal gentilicium del padre, portato anche da lui. Per la sua rarità, non è adatto all’identificazione dell’origine. Fu sicuramente un cittadino romano, se non prima, allora dal 212 d. C. Fu il sacerdos della colonia di Apulum e uno dei conduttori delle miniere di ferro, insieme al Flavius Sotericus. Il suo sacerdotium non è precisabile, si sa solo, che fu impegnato dalla colonia, così fu un sacerdote ufficiale.ccxxxi Fu in servizio al santuario oppure all’altare di un culto, a cui i sacerdoti coloniali della religione tradizionale dello stato non furono adatti. Si può trattare di un culto straniero oppure allignato, di origine orientale o greca, che esisteva tramite i seguaci nel territorio della colonia o di un culto imperiale. In base alla dedicazione e al co-dedicatore Augustalis si può ipotizzare, che Gaurianus prese parte anche al culto dell’imperatore. Secondo il testo dell’iscrizione sono conosciuti i seguenti della sua carriera: nel primo terzo del III secolo d. C. sacerd(os, sacerdotalis?), cond(uctor) ferrar(iarum).
D 52
Q(uintus) Ianuarius Q(uinti) f(ilius) Collina (tribu) Rufus Tavius Base. Sarmizegetusa. Demsus (Densuş).
MANUSCRIPT
CIL, III, 1503; ILS, 7134; Kerényi 832; IDR, III/2, 112; Ardevan 1981, 437-442; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 120; Q(uinto) Ianuario Q(uinti) f(ilio) | Collina (tribu) Rufo | Tavio flamini | q(uin)q(uennali) prim(o) pro imp(eratore) | ordo col(oniae) Ulp(iae) Trai(anae) | Dacic(ae) Sarmizeg(etusae). L’iscrizione è databile alla prima metà del II secolo. Se non si tratta di un supranomen, ricevuto per l’attività oppure per l’origine materna sconosciuta, venne nella Dacia da Tavium dell’Asia Minore. In questo caso fu il discendente di una famiglia dell’Occidente, che visse là. Il suo gentilicium è generale come cognomen, di origine e con legami all’Italia settentrionale nell’epoca.ccxxxii Il suo cognomen fu diffuso piuttosto nelle province occidentali, e soprattutto nell’Italia settentrionale e nella Dalmatia, da dove molti immigravano nella Dacia.ccxxxiii Q(uintus) Ianuarius Rufus fu il flamen di Sarmizegetusa, poi (praefectus) quinquennalis prim(us) pro imperatore. Ebbe l’ufficio quinquennalis al posto dell’imperatore. Fu il primo che rivestì questo impegno invece del sovrano, o fu per la prima volta quinquennalis, oppure fu il primo quinquennalis di Sarmizegetusa. Ma è già dimostrato, che l’aggetivo primus ha un significato semplicemente cronologico.ccxxxiv Secondo R. Ardevan dovette rivestire la carica invece di Antoninus Pius, tra il 138 e 161 d. C., quindi il primus significa, che lui fu il primo nella città, che fu quinquennalis al posto dell’imperatore. La grafia dell’epigrafe non contraddice alla datazione ad un periodo precedente. L’ufficio quinquennalis presuppone almeno una delle magistrature basse, perciò come decurio fu quaestor oppure aedilis, dato che a Sarmizegetusa bastava solo una delle magistrature basse per il IIviratus.ccxxxv Ma non è da escludere la possibilità di ambedue le magistrature. L’ufficio quinquennalis, poiché si tratta di un rango più alto del IIviratus, e anche perché lo occupò invece dell’imperatore, rende molto probabile, che fu prima almeno anche IIvir.ccxxxvi Non si sa da quando fu flamen, dato che i dedicatori fecero indicare sulla base della statua solo gli uffici attuali, così anche la carica continua di flamen.ccxxxvii È probabile, che divenne flamen almeno come decurio. Riassumendo la sua carriera secondo il testo dell’iscrizione: dal primo terzo del II secolo - (decurio, quaestor e/o aedilis, IIvir), flamen, q(uin)q(uennalis) prim(us) pro imp(eratore). In base a questa carriera sembra probabile, che anche lui raggiunse il rango del sommo sacerdote della provincia, quindi il summus honor.
D 53
L(ucius) Iu[l(ius)] [B]assinus
Tavola. Apulum. Gyulafehérvár (Alba Iulia, Karlsburg) dalla fondazione della chiesa di Báthory, insieme alle iscrizioni CIL, III, 14471, 14476-14478, 14481-14483. CIL, III, 14468; AÉ, 1901: 28; ILS 7149; Opriş 1931, XXI, nr. 1060; Igna 1935, 83, nr. 26; Kerényi 1872, 2148; Birley 1969, 82; Balla 2000, 118, nr. 19, 122; Devijver 1976-1980, J 34; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 353; Mrozewicz 1999, 75, nr. 29; IDR, III/5, 14; [Aes]c[ul]apio et Hygiae L(ucius) Iul(ius) | [B]assinus dec(urio) col(oniae) Apul(ensis) IIvir | col(oniae) Nap(ocensis) flam(en) col(oniae) Drob(etensis) flam(en) | munic(ipi) Dier(nensis) dec(urio) munic(ipi) Apul(ensis) | et Por(olissensis) trib(unus) leg(ionis) IIII Fl(aviae) pro sa|lute Iuliae Beronices con|iugis | v(otum) l(ibens) s(olvit). L’iscrizione è databile al III secolo d. C., partendo dall’inizio del secolo, a causa del suo decurionatus a Porolissum, indicato come l’ultima carica municipale, rivestita il più tardi dal 211 d. C. Il suo gentilicium fu diffuso generalmente nel materiale onomastico dell’Europa e dell’Impero: nell’area danuviana fu portato da molte persone di origine nord-italica.ccxxxviii Il cognomen, che capita in molte province europee, non indica necessariamente un’origine orientale o greca.ccxxxix In base al IIviratusccxl a Napoca percorse un cursus intero in questa città, quindi poté essere nato lì. L’elenco degli uffici municipali è in un certo ordine cronologico discendente, in cui le cariche napocensi incorniciano quelle seguenti. Non indicò il suo stato equestre per il rango militare, che egli dovette avere già all’inizio della carriera, dato che sicuramente cominciò il servizio militare non come un aristocrata emerito della provincia, ma da giovane. Similmente non si legge il decurionatus a Napoca, e l’eventuale magistratura o le magistrature basse nella stessa città, che furono le condizioni per il IIviratus. Sembra che la quaestura o l’aedilitas bastasse in se stessa,ccxli ma egli, facoltativamente, poté avere ambedue. Contemporaneamente poté assumere un decurionatus e una carica sacerdotale nelle altre città indicate della provincia, poi divenne il IIvir di Napoca,ccxlii dopo cui, ultimamente, fu eletto decurio anche nella colonia di Apulum. Cominciò invece la sua carriera verosimilmente come eques e decurio a Napoca, al più presto all’inizio dell’epoca Severiana, oppure possibilmente nel primo decennio del III secolo d. C. Come eques assunse un servizio militare, di cui fino agli anni ’10 fece la militia prima, la cohorspraefectura e la militia secunda, cioé la legiotribunatus nella legio IIII Flavia a Singidunum.ccxliii Dopo fu congedato, dato che in base alla struttura dell’iscrizione indicò l’ufficio militare più alto che avesse. Dopo il congedo poté divenire quaestor o aedilis a Napoca. È poco probabile, che rivestì tutte e due, benché ne avesse la possibilità. Contemporaneamente, in parte per i suoi interessi economici, assunse cariche in altre città, che non è un fenomeno straordinario nella Dacia.ccxliv Così dopo il 200-211, quindi probabilmente già negli anni ’10 del III secolo divenne il decurio di Porolissum, eventualmente in conseguenza di una cohorspraefectura fatta in questa città. Poi fu eletto il membro dell’ordo decurionum anche nel municipium Septimium Apulensium, dopo cui divenne flamen nel municipium di Dierna, poi nella colonia di Drobeta,ccxlv quindi nelle città vicine al campo della legio IIII Flavia.ccxlvi Se volle assolvere tutte le cariche, dovette passare tutta la vita con viaggi. Ad esempio Porolissum si trovava alla confine settentrionale della provincia, mentre Drobeta e Dierna erano a quella meridionale. Alla
MANUSCRIPT
fine rivestì il IIviratus a Napoca e il decurionatus della colonia apulense. Presumibilmente poté essere il parente di un decurio di Drobeta, L(ucius) Iul(ius) L(uci) fil(ius) Sergia (tribu) Bassus.ccxlvii Riassumendo la carriera secondo la lista nel testo dell’iscrizione: alla fine del II – inizio del III secolo d. C. – (?decurio coloniae(1), equo publico o eques Romanus, nel primo e secondo decennio del III secolo d. C. militia prima – prafectus cohortis), militia secunda - trib(unus) leg(ionis), (quaestor o aedilis coloniae(1)), dec(urio) munic(ipi)(1), dec(urio) munic(ipi)(2), flam(en) munic(ipi)(3) flam(en) col(oniae)(2), IIvir col(oniae)(1), dec(urio) col(oniae)(3). La carriera poté durare anche negli anni ’30 del secolo. Non sarebbe sorprendente, se nel futuro lo rivedessimo come sommo sacerdote della provincia in un’iscrizione nuova.
D 54
C(aius) Iul(ius) Con[s]tans
Altare. Napoca. È stato ritrovato nella vicinanza durante la costruzione della ferrovia (CIL). CIL, III, 6253a; CIL, III, 7658; Kerényi 872; Ardevan 458; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | pro salute | C(ai) Iul(i) Con|[s]tantis | pont(i)f(icis) C(aius) Iul(ius) | Marcus | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). L’iscrizione è databile sia al II che al III secolo d. C. Il praenomen e il gentilicium formano uno dei nomi romani più frequenti. A causa della donazione della cittadinanza da parte di Caesar nell’Italia settentrionale una parte delle persone nella Dacia con nome simile può avere origine nord-italica.ccxlviii Il cognomen è latino, capita in molte parti delle province europee, in numero relativamente basso. Nella Pannonia ad esempio dopo l’epoca di Marcus Aurelius.ccxlix Lo stesso vale per il cognomen del dedicatore dell’iscrizione, C. Iul(ius) Marcus.ccl Il fenomeno permette l’ipotesi, ma non la sicurezza, che venisse nella colonia Aurelia Apulensium al tempo della fondazione della città. Teoricamente poté essere pontifex anche nel municipium di Napoca, ma in base ai sopraddetti è più probabile che fu il sacerdote della colonia, quando l’iscrizione fu eretta. Secondo i dati nel testo dell’iscrizione: dall’ultimo terzo o quarto del II secolo d. C. – pont(i)f(ex) (coloniae?).
D 55
C(aius) Iul(ius) Diocletianus Colonna. Apulum. Marosportó (Partoş). AÉ, 1947: 22; Betz 1960, 33; Balla 2000, 118, nr. 20; Sanie 1989, 1260, nr. 82; Ardevan 361; Mrozewicz 1999, 75, nr. 30; IDR, III/5, 29; Aeterno | sanctissi|mo pientis|simoque | C(aius) Iul(ius) Diocle|tianus eq(uo) p(ublico) | dec(urio) et augur | col(oniae) Sarmiz(egetusae) | dec(urio) col(oniae) Apu(lensium) | patronus | causarum | ex voto. La sua iscrizione di Apulum è databile dopo il 180 d. C. Il praenomen e il gentilicium formano uno dei nomi romani più frequenti. A causa della donazione della cittadinanza romana da parte di Caesar nell’Italia settentrionale, anche una parte delle persone nella provincia con nome simile può avere un’origine nord-italica.ccli Il suo cognomen si trova in quest’epoca anche nell’Italia.cclii Durante la carriera municipale come eques fu prima il decurio di Sarmizegetusa, poi fu eletto l’augur della colonia. In seguito divenne il membro dell’ordo decurionum della colonia di Apulum. L’ultimo ufficio indicato è il patronus causarum, che fu una carica in connessione con una questione giuridica occasionaleccliii di una città. La città non è indicata nell’iscrizione, ma dato che la carica segue il decurionatus ad Apulum, anche questo ufficio può essere considerato apulense. Riassumendo la sua carriera secondo il testo dell’iscrizione: dalla fine del II secolo d. C. – eq(uo) p(ublico), dec(urio) col(oniae)(1), augur col(oniae)(1), dec(urio) col(oniae)(2), patronus causarum col(oniae)(2).
D 56
M(arcus) Iul(ius) Pap(iria tribu) Iustus Tavola. Sarmizegetusa. Sparita. CIL, III, 7983; EE, IV, n. 438; ILS, 5390; IDR, III/2, 9; Ardevan 57;
MANUSCRIPT
M(arcus) Iul(ius) Pap(iria tribu) Iustus dec(urio) | col(oniae) ob hon(orem) pontif(icatus) | campum cum suis | aditibus clusit et statuam posuit. L’iscrizione poté essere eretta ugualmente sia nel II che nel III secolo d. C., ma il nome con l’indicazione della tribus avvicina la datazione al II secolo d. C. Il gentilicium è uno dei nomi più frequenti nelle province latine. A causa della donazione della cittadinanza da parte di Caesar nell’Italia settentrionale, una parte delle persone con nome simile che si stabilirono qui dopo la fondazione della provincia può avere anche un’origine nord-italica.ccliv Anche il cognomen è un nome latino che si trova dappertutto.cclv Fu il decurio di Sarmizegetusa, e venne eletto il pontifex della colonia. Per la carica pontificale fece una costruzione di pietra, una piazza con porte e ci fece erigere una statua. Dovette concorrere al posto sacerdotale all’inizio della sua carriera. Riassumendo gli elementi della carriera tramandati dal testo dell’iscrizione: probabilmente durante il II secolo d. C., nella seconda metà del secolo – dec(urio), pontif(ex) col(oniae).
D 57
C(aius) Iul(ius) Metrobianus a. Altare. Apulum. AÉ, 1986: 607; Petolescu 1987, nr. 372; IDR, III/5, 325; Deo Silv[a]|no C(aius) Iul(ius) Metro|bianus | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Dopo il 180 d. C. b. Base. Apulum. CIL, III, 1028; Kerényi 167, 1802, 2018; Tudor 1957, 257, nr. 77; Bărbulescu 1977, 177, nr. 4; IDR, III/5, 100; [Herculi | Invict(o)] | pro salut(e) | C(ai) Iul(i) Metro|biani et | Aeliae Bo|nae con|iug(is) Ada|mas ex vot(o). Dopo il 180 d. C. c. Altare Apulum. CIL – Secondo Zamosius, Analecta f. 57: „Brettae in aed. dom. Ostrohiensium”. Bretea (regione Hunyad – jud. Hunedoara). Sparito. CIL, III, 972; Igna 1935, 84, nr. 30; Kerényi 2018; Ardevan 1984, 98; 102-; Ardevan 308; IDR, III/5, 1; Numini | [A]esculapi | C(aius) Iul(ius) Metro[bi]|anus II[vir(alis)] col(oniae) | Sarm(izegetusae) sacerd(os) | dei eius(dem) pon|tif(ex) q(uin)q(uennalis) IIvir col(oniae) | Apuli ex voto. Databile dal 180 d. C. d. Altare. Apulum. CIL – Secondo Reinbold 1842, pl. VI. - „Alba Iulia in civitate inferiore”. Sparito. CIL, III, 973; Drexler, 54, nr. 1; SIRIS 694; Kerényi 2018; Ardevan 1984, 98; 102-; Takács 1995, 199; Ardevan 309; IDR, III/5, 316; Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 78815; Numini Serapi s[acrum?] | G(aius) Iul(ius) Metrobianus IIviral[is] | col(oniae) Zarmiz(egetusae) sacerdos | dei Aes[cul(api) po]┌n┐t(ifex) q(uin)q(uennalis)| [IIvir col(oniae) Apuli ...] | [---. Benché il finora usato Numini Serapis dell’iscrizione d. abbia parecchie analogie, qui non è sostenibile in base epigrafica. La 1ª riga comincia all’orlo del campo epigrafico (e non al centro), e l’angolo destro superiore è rotto dopo la S. Secondo il disegno rimasto di Reinbold (pubblicato anche nelle IDR) la S segue la parola Serapi senza spazio. Poté esser scolpita così vicina per motivi costruttivi, poiché così c’è posto precisamente per un altro gruppo di cinque lettere fino all’orlo destro del quadro dell’iscrizione. Anche il IIviratus di Metrobianus a Sarmizegetusa è stato molto discusso, dato che secondo il disegno tramandato da I. Szamosközi (Zamosius) dell’iscrizione c. (pubblicato anche nelle IDR) il numero II della 2ª riga non è seguita da VIR. R. Ardevan era per il IIviratus a Sarmizegetusa,cclvi mentre I. Piso ultimamente ha scartato l’ipotesi dicendo, che Metrobianus non poté percorrere l’intera carriera necessaria per il IIviratus in ambedue città.cclvii Anche nella 2ª riga dell’iscrizione d. si vede il numero II seguito dalla lettera V (IIVIII[.]), che I. Piso, in base all’argumentazione sopraddetta non ha accettato come IIviratus. In base ai disegni rimasti si può affermare, che i testi di ambedue le iscrizioni furono già danneggiati quando vennero disegnati. Szamosközi [c.] non indicò le parti rotte, ma disegnò continuamente le lettere viste (cfr. l’inizio della 2ª e la fine della 3ª riga), e mise un punto alla fine delle abbreviazioni riconosciute (3ª, 5ª, 6ª riga). Mise punti anche alla fine del testo (frase) intero, interpretando quasi l’iscrizione. Reinbold invece, trattando le cose viste come
MANUSCRIPT
immagine, pinse tutto il monumento al naturale, con tutte le rotture [d.], quindi tramandò i fenomeni visti. Szamosközi non indicò la parola rotta VIR dopo il II, nemmeno la parte mancante della fine della 3ª riga nel caso del nome Metrobi|anus nelle 3ª e 4ª righe, ma pubblicò il testo con la forma abbreviata Metrop., interpretando la parte inferiore della I. come un punto e la seconda parte del nome come una parola indipendente nella riga seguente. In base a questo si può pensare di giusta ragione, che egli nella 4ª riga dell’iscrizione c. negligasse semplicemente lo spazio tra le parole e le rotture della pietra e disegnasse continuamente il testo, per questo mancasse il VIR dopo il II. Nel disegno di Reinbold dell’iscrizione d. al posto trattato si vedono tracce di alcune lettere in più, rispetto a quante ci vorrebbero per la parola IIVIR – IIVIII[.]. Le lettere dopo il IIV non si vedevano bene, per questo Reinbold le ha indicate solo con linee, ed è indacata anche la mancanza totale dell’ultima lettera. La variante IIV[---] di Reinbold, insieme al disegno cattivo di Szamosközi, è epigraficamente abbastanza convincente dall’aspetto, che rinvia molto probabilmente al IIviratus, e per questo condivido anch’io l’opinione di R. Ardevan e di Th. Mommsen, contro il dubbio di I. Piso. Il IIviratus di Sarmizegetusa si legge senza dubbio nella 2ª riga sia nell’iscrizione c., che in quella d. L’estensione grande della parola nell’iscrizione d. (è più lunga dello spazio occupato delle lettere di IIVIR) è spiegata dalla forma passata del IIviratus, quindi la parola originale dovette essere sicuramente IIviral(is), la quale, in questa forma abbreviata, riempieva lo spazio, e con le linee dirette e oblique delle lettere corrisponde meglio al disegno di Reinbold. È meno possibile la soluizone IIvir i(ure) d(icundo), perché nella Dacia non si soleva indicare questa carica nelle iscrizioni, e nemmeno le linee disegnate la appoggiano. Il q(uin)q(uennalis) è scritto davanti al IIviratus, che è similmente irregolare nella Dacia. Formalmente questo potrebbe significare un IIviratus dopo la quinquennalitas, ma è più probabile, che fu eletto direttamente IIvir quinquennalis, a cui, dopo il IIviratus a Sarmizegetusa, ebbe anche l’autorità. Questo rende spiegabile in questo senso anche il fenomeno II nel disegno di Szamosközi. La 3ª riga si legge bene. La superficie è rotta alla metà della 4ª riga, si vedono solo i frammenti DEI AES[---]TT QQ, che dall’autore delle IDR sono stati integrati e sciogliati in forma dei Aes[culapi(i) po]┌n┐t(ifex) q(uin)q(uennalis). In questo posto invece passano solo quattro, oppure strettamente al massimo cinque lettere. Reinbold ha visto la lettera N del pontifex come T. La linea orizzontale sopra quelle verticali può essere anche la traccia di una linea ausiliare preliminare. Se la correggiamo in N, ci vogliono davanti ancora due lettere per la parola pontifex. Nello spazio rimasto passano al massimo tre lettere senza intervallo, oppure due con intervallo. Quindi il nome della divinità doveva essere abbreviata in forma AESCUL, cioé per le otto lettere e un intervallo della soluzione Aes[culapi(i) po]┌n┐t(ifex) dell’autore delle IDR non c’è abbastanza posto. L’integrazione moderata dell’ulteriore parte rotta dell’iscrizione è senza dubbio corretta, in base all’iscrizione c. Metrobianus dovette erigere ambedue epigrafi [c., d.] nell’anno del suo IIviratus ad Apulum. È una domanda, se egli dovette percorrere un intero cursus honorum per il IIviratus e per la IIvir quinquennalitas in tutte e due città, quindi a Sarmizegetusa e ad Apulum. Il fatto, che in ambedue le iscrizioni con il cursus apulense, che in base al testo e al posto di ritrovamento è un cursus ascendente, la carica di Sarmizegetusa sta al primo posto, dimostra, che egli fu impegnato prima là, quindi dovette percorrere i livelli del cursus honorum municipale in quella città, i quali non sono indicati come informazioni inutili, secondo la moda nella Dacia, poi si trasferì ad Apulum, dove partecipò similmente alla vita municipale. Non si può dire, se anche ad Apulum percorse un cursus intero. Nella Hispania, ad esempio, sono conosciuti sommi sacerdoti, che furono “omnibus honoribus in rebus publicis suis functis”, e “omnib(us) honorib(us) in utraque re p(ublica) funct(us)”.cclviii È conosciuta una persona di Sigus nella Numidia, che fu “omnibusq(ue) honoribus IIII coloniar(um) funct(us)”.cclix La possibilità non è da escludere nemmeno nella Dacia, come neanche quella, che fu già decurio, quando si trasferì ad Apulum. Neanche il decurionatus di Apulum fu inidcato, ma questo è fuori di dubbio in base al IIviratus. Come decurio di Apulum poté già divenire pontifex di Apulum. La sua elezione come pontifex poté essere influenzata dalla sua carica sacerdotale per Aesculapius, di grande autorità, che poté fare nel Locus Asklépion di Apulum.cclx Come decurio e pontifex poté concorrere al IIviratus, forse anche senza magistratura bassa, se l’ordo decurionum ritenne soddisfacente quella fatta a Sarmizegetusa, secondo le prescrizioni della legge della città. È conosciuto tramite quattro iscrizioni di Apulum, databili dopo il 180 d. C., dato che ebbe cariche nella colonia di Apulum. Il praenomen e il gentilicium sono molto frequenti in tutte le province.cclxi Benché siano conosciuti cognomina nelle province europee dell’Impero, che cominciano similmente, il suo è conosciuto solo nella Dacia,cclxii e rinvia evidentemente all’origine dalla parte greca dell’impero.cclxiii Le iscrizioni non contengono tutti gli elementi del cursus. Prima delle cariche ad Apulum fu il IIvir di Sarmizegetusa come il discendente, il parente dei numerosi C. oppure G. Iulii di Sarmizegetusa, quindi anche il membro dell’ordo decurionum della città e dovette rivestire anche una delle magistrature basse.cclxiv Lasciò Sarmizegetusa per un motivo sconosciuto e si trasferì ad Apulum. Sua moglie si chiamò Aelia Bona, che poté essere il membro di una delle famiglie numerose degli Aelii di Apulum. Le iscrizioni a. e b. possono risalire al periodo, quando non fu ancora impegnato ad Apulum, ebbe solo interessi nella città. Dopo il IIviratus a Sarmizegetusa, tutte le cariche sono da intendere nella colonia Aurelia Apulensium, il che è rinforzato anche dal posto di ritrovamento delle iscrizioni. Ad Apulum apparve come il sacerdote di Aesculapius, il che è spiegato dalla fondazione dell’Asklépieion e del Locus ad Apulum,cclxv contemporaneamente con l’innalzamento della città al rango di colonia. Come sacerdote di grande autorità di Aesculapius e evidentemente come decurio fu eletto prima pontifex, dirigente della vita religiosa della città, poi IIvir quinquennalis. In questo caso non dovette avere una magistratura bassa, forse per la magistratura coloniale ad Apulum bastava anche il decurionatus locale non indicato, ma sicuramente esistente. Le cariche rivestite nella colonia di Sarmizegetusa gli fornirono abbastanza esperienza per salire – sebbene in un’altra città – al livello seguente del cursus municipale. Poté eventualmente fare anche un IIviratus prima della quinquennalitas, ma non è probabile. Questo modo di fare carriera è raro, ma non si può menzionare una causa esclusiva: in una vita si potevano fare tranquillamente anche due interi cursus municipali. In base alle cariche apulensi, si datano quelle di Sarmizegetusa prima alla fondazione della colonia Aurelia, quindi prima del 180 d. C. Divenne il sacerdos di Aesculapius sicuramente già precedentemente, e forse non nella Dacia, ma in uno degli grandi Asklépieiones greci – ad Epidauros, a Pergamon oppure a Smyrna,cclxvi dove, in quel tempo proprio Galenos insegnava la medicina.cclxvii La paura causata dall’epidemia di pestecclxviii poté rendere grande l’autorità del sacerdote dotto di Aesculapius, il che si vede bene anche nei cursus nelle due città. Dall’altro lato, anche come medico poté avere una condizione finanziaria per esser capace di coprire le spese degli honores.cclxix
MANUSCRIPT
Riassumendo la sua carriera secondo i testi delle iscrizioni: prima del 180 d. C. - (decurio, quaestor e/o aedilis, IIvir), II[vir(alis)] col(oniae)(1), dopo il 180 (ufficialmente anche ad Apulum) - sacerd(os) dei Aes[cul(api)], pontif(ex), q(uin)q(uennalis) IIvir col(oniae)(2).
D 58
C(aius) Iul(ius) Naesus Sabinus Tavola. Drobeta. Donje Butorke, fu incastrata nella fortezza tardoimperiale. AÉ, 1979: 520; AÉ, 1983: 867; Petolescu 1983, 67-70; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 507; ILD 54; C(aius) Iul(ius) Sabinus bis IIviralis | et patr(onus) m(unicipi) H(adriani) D(robetae) ob honor(em) | flamoni C(ai) Iul(i) Naesi Sabini | nepotis sui cryptam vetus|tate dilapsam pecunia su|a reformavit et exalti|avit. L’iscrizione è databile al II secolo d. C., in base al rango municipale della città, tra il regno di Hadrianus e Septimius Severus (117/138-193/211 d. C.), nel caso dell’ultimo probabilmente fino agli anni 190 d.C.cclxx Il praenomen e il gentilicium del dedicatore e del nipote sono molto frequenti in tutte le province dell’impero.cclxxi Il cognomen del nonno è frequente nelle province occidentali e nell’Italia settentrionale, sembra che furono i suoi portatori italici che li fecero diffondere nell’area danubiana.cclxxii Il cognomen del nipote è più raro, ma deriva dall’ambiente latino. Secondo il suo supranomen il nonno lo adottò proprio. Il nonno fu due volte duumvir nel municipium di Drobetacclxxiii e il patronus della città,cclxxiv così anche il nipote adottato poté essere candidato nell’ordo decurionum. Presumibilmente non fu ancora maggiorenne e finanziariamente indipendente, per questo fece il nonno una donazione per il flaminatus invece di lui. Sono conosciuti casi simili anche nella Pannonia, non solo con il flaminatus, ma anche con l’auguratus.cclxxv C(aius) Iul(ius) Naesus Sabinus divenne il flamen del municipium da giovane,cclxxvi quindi la sua carriera cominciò così: verso la metà del II secolo d. C., forse nella seconda metà - flamen m(unicipi).
D 59
C(aius) Iul(ius) Valens a. Tavola. Apulum. CIL - „Albae Iuliae in area arcis”. IDR, III/5: Marosportó (Partoş). Sparita. CIL, III, 1117; Kerényi 1941, nr. 933, 1195, 2043; Ardevan 336, IDR, III/5, 388; Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 794-795; C I [-]I[---] | LV[---] | I[-] p[ro] sal(ute) | [I]m[p(eri) et S(enatus) P(opuli)q(ue) R(omani)?] | e[t] or[dinis col(oniae)?] | A[p]u[l]e[nsium] | C(aius) Iu[l(ius)] Vale[ns] | cl[?inic]us l(oci) | sacerdo[s] | d[ei e]ius[dem] | A[ur]el[i]a[e] | Quinta[e] | coniuge [-]I [-] C[-] | [e]t Caiis Iuli|is Val[ente] et | Pasinico | filis | v(otum) l(ibens) p(osuit). Il primo terzo del III secolo d. C. b. Tavola. Apulum. Sárd (Şard). Sparita. CIL, III, 1114; CIMRM 1998; Sanie 1989, 1256, nr. 61; Ardevan 333; IDR, III/5, 356; Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 792-793; [?Marti In]|victo pro sa|lute Imp(eri) P(opuli)q(ue) R(omani) | et ordinis col(oniae) | Apul(i) C(aius) Iul(ius) Va|lens har(uspex) col(oniae) s(upra) s(criptae) | et antistes hu|iusque loci | v(otum) l(ibens) p(osuit). Eretta probabilmente tra il 222 e 235 d. C. c. Tavola. Apulum. Marosportó (Partoş). CIL, III, 1115; ILS, 3174; RD, 349; Kerényi 929; Speidel 1984, 2227; Ardevan 334; IDR, III/5, 364; Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 792-793; Veneri Vic|trici pro sal(ute) | Imperi et S(enatus) P(opuli)q(ue) R(omani) | et ordinis col(oniae) | Apul(i) C(aius) Iul(ius) Va|le(n)s haruspex | col(oniae) s(upra) s(criptae) et antis|tes huiusce | loci | [v(otum) l(ibens)] p(osuit). Eretta probabilmente tra il 222 e 235 d. C. d. Statua votiva. Apulum. Marosportó (Partoş). AÉ, 1930: 6; Cucuiu 1929, 24, 30; Daicoviciu 1929, 303, nr. 5; Daicoviciu 1969, 143, nr. 5; Kerényi 929; Hornum 1993, 253, nr. 175; Ardevan 356; IDR, III/5, 297;
MANUSCRIPT
[Ne]mesi Reginae | C(aius) Iul(ius) Valens harus(pex) | col(oniae) Apuli et ant(istes) huiusc(e) loci | somnio monitus l(ibens) p(osuit). Eretta probabilmente tra il 222 e 235 d. C. ? e. Iscrizione votiva. Apulum. Marosportó (Partoş). Sparita. CIL, III, 1116; ILS, 3802; IDR, III/5 367; Virtuti Ro|manae pr(o) sa[l(ute)] | Imper(i) et S(enatus) [P(opuli)q(ue) R(omani)] | et ord(inis) co[l(oniae) Apul(ensis)] | [?C(aius) Iul(ius)] Vale[ns har(uspex)?] | [?col(oniae) s(upra) s(criptae) an]t[istes?] | [huiusque loci?] | [---. L’iscrizione frammentaria è connessa con C(aius) Iul(ius) Valens a causa della dedicazione particolare e del frammento di nome VALE nella 5ª riga. Della 6ª riga dell’iscrizione presentata sopra è rimasta una sola T. Secondo la sua pratica epigrafica, è molto probabile, che dopo il nome fece indicare anche le cariche. Nell prime due righe poteva stare il nome della divinità, con lettere più grandi, similmente alle tavole per Venus e Mars [b., c.], mentre le parole sotto furono scolpite con lettere più piccole. Così una riga poteva conetenere in media 12-13 lettere. Perciò nella 5ª riga il suo nome dovette essere seguito dall’indicazione di una carica oppure di un ufficio, che continuò anche nella prossima riga. L’haruspicatus, in forma intera, con il nome della città non avrebbe avuto abbastanza posto, solo abbreviato a tre lettere oppure con le lettere s(upra) s(criptae) rinviando alla città, usate anche in altre epigrafi attribute a lui. In base alle sue iscrizioni intatte, solo il nome della carica di antistes contenne la lettera T, così la T della 6ª riga dovette appartenere alla parola antistes e fu la prima T, altrimenti ci sarebbe stato appena posto per qualsiasi cosa tra il nome e la carica. La parola antistes dovette essere seguita da huiusce oppure huiusque loci. Tematicamente anche la Virtus era compatibile alla figura di Venus Victrix e [?Mars In]victus, e fu menzionata sicuramente insieme con Honos, e non mancava neanche l’epigrafe dedicata a quest’ultimo, con testo simile a quello dell’iscrizione a Virtus, che finora non è stata ritrovata, ma può ancora comparire. La datazione dell’iscrizione è similmente il primo terzo del III secolo d. C. fino al regno di Severus Alexander (222-235 d. C.). ? f. Frammento di un’epigrafe votiva. Apulum. Marosportó (Partoş). Sparita. CIL, III, 14475; IDR, III/5, 357; [---]i Invicto | [pro salute] Imperi | [---. L’attribuzione a C(aius) Iul(ius) Valens è incerta, suggerita solo dalla dedicazione particolare. La divinità con l’attributo Invictus può essere anche Hercules,cclxxvii di cui sono conosciute altre statue su basi simili, erette per voti piccoli. Lo conosciamo per nome tramite quattro iscrizioni apulensi [a., b., c., d.] e gli si possono attribuire forse anche due altre [e., f.], e un’ultimacclxxviii incertacclxxix: --- ? h]arus[pex ? ---] | [---] ob ho[norem ---. Le iscrizioni sono databili dopo il 180 d. C., ma per la carica ufficiale come haruspex coloniale piuttosto tra il 222 e 235 d. C.cclxxx Il suo parenomen e gentilicium sono molto frequenti in tutte le province,cclxxxi il suo cognomen diffuso dall’Italia settentrionale è similmente un nome latino che si trova dappertutto.cclxxxii Benché il nome non dica molto sull’origine, a causa della professione e della carica di haruspex dovette venire dall’Etruria. Fu sicuramente un cittadino romano. La prima carica conosciuta fu l’ufficio suggerito di cl[inicus] l(oci). Nel Locuscclxxxiii ci svolgeva un’attività curativa a causa dell’Asklépieion locale, perciò logicamente potè essere impiegato anche un clinicus in uno degli ospedali del santuario. La professione relativamente rara di clinicus (quindi una specie di medico) poté essere pragmaticamente in connessione con la scienza di haruspex.cclxxxiv All’inversa, ovviamente fu prima haruspex, dato che lo studiò sin dall’infanzia, ma nel periodo prima dell’epoca di Severus Alexander non ne aveva potuto guadagnare ufficialmente, perciò utilizzò le conoscenze mediche e anatomiche acquistate durante lo studio della haruspicina. Dopo divenne il sacerdos di una divinità non identificabile [a.]. Delle altre due cariche indicate la prima fu quella dell’haruspex coloniae ad Apulum. Fece indicare nelle iscrizioni l’haruspicatus probabilmente solo dopo dopo il 222 d. C., quando fu impiegato dalla città.cclxxxv La prossima carica di antistes fu in connessione di nuovo con il Locus di Apulum, dove furono erette le sue iscrizioni, e dove era stato precedentemente clinicus. Il Locus, dove fu antistes, dovette essere lo stesso istituto, dove poco prima aveva agito anche M. Aur(elius) Comatius Super [D 29]. È da notare, che tutti gli antistites dell’area danubiana, anche se a volte insieme ai sommi sacerdoti, fecero erigere iscrizioni nella sede della provincia oppure del consiglio provinciale a Nemesis, oppure a Fortuna di carettere simile, o a Diana, che, come si vede anche in un caso di Aquincum, sotto certi aspetti è similmente identificabile a Nemesis [cfr. anche D 29, 40].cclxxxvi Secondo il testo citato frammentario dell’epigrafe incertamente attribuita a lui, se si tratta di lui, concorse anche ob ho[norem - - -?]. Dato che non fu il membro dell’ordo decurionum, volle acquistare logicamente prima questo oppure una delle magistrature basse. Anche il suo predecessore, M(arcus) Aur(elius) Comatius Super [D29] divenne decurio dopo la carica di antistes. Le ambizioni di Valens sono illustrate anche dalle iscrizioni per la salute dello stato e per l’ordo decurionum di Apulum [a., b., c., e.]. Lui è l’unico haruspex conosciuto nella Dacia nell’epoca romana. Riassumendo la sua carriera in base al testo delle sue iscrizioni: nel primo terzo del III secolo d. C. – (cittadino romano) cl[?inic]us l(oci), sacerdo[s] d[ei] [?], har(uspex) col(oniae), antistes loci, [---?
MANUSCRIPT
D 60
Iulius Valentin[us] Altare. Tibiscum. CIL, III, 7997; EE, II, n. 443; Kerényi 935; Tudor 1957, 264, nr. 111; IDR, III/1, 139; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 41; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) | Iulius | Valentin[us] | [f]lamen m(unicipi) T(ibiscensium) | pro salutem | suam suorum|que omnium | contubernium | v(otum) l(ibens) m(erito) p(osuit). Il contubernium dell’8ª riga non può essere un’errore di stesura invece di contubern<al>ium, come è stato supposto nelle pubblicazioni precedenti del testo. Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus aveva un forte aspetto curativo, così poté appartenere al santuario un ambiente, in cui potevano per esempio incubare anche più persone pro salutem. Il p(osuit) alla fine del testo non rinvia al carattere del contubernium; lo si poteva collocare o eventualmente ‘fondare’ attorno al santuario. Nel caso di contubern<al>ium si dovrebbe supporre che il personale di un intero contubernium appartenesse alla definizione ‘i suoi’ (!), il che è poco versimile. L’iscrizione è databile alla prima metà del III secolo d. C. Il praenomen del dedicatore è sconosciuto, il gentilicium imperatorio è molto frequente in tutte le province.cclxxxvii Il cognomen fu usato sia nell’ambiente occidentale che in quello orientale.cclxxxviii In base al nome non si può identificare l’origine, ma viene piuttosto dall’ambiente latino. Fu il flamen del municipium Tibiscensium.cclxxxix Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus dovette avere un grande culto nell’ambiente orientale di Tibiscum, onorato possibilmente anche dal flamen come persona privata. Il suo caso dimostra bene il fenomeno, che la dedicazione e la carica sacerdotale non devono essere sempre in connessione stretta. Nell’mbito della sua religiosità privata poté pregare la divinità dolichena anche di un oracolo oppure di guarigione.ccxc Dovette essere all’inizio della sua carriera, secondo i dati del testo dell’iscrizione fu nella prima metà del III secolo d. C. – [f]lamen m(unicipi).
D 61
Lu[cianus?] [---] Tavola. Sarmizegetusa, l’angolo sud-occidentale della città, la zona del c.d. Dolichenum, AÉ, 1927: 56; Daicoviciu 1924, 250; Sanie 1977, 146; AÉ, 1977: 668; IDR, III/2, 20; Szabó Á. 2004 (HPS), 139-161; AÉ 2004: 1212; [I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Dolicheno pro salute] | [D(omini) N(ostri) Imp(eratoris) Caes(aris) Divi Severi Pii nep(otis)] | [Divi Magni Ant]on[ini f(ili) M(arci) Aur(eli) Sev]|[eri [[[Alexandri]]] Pii [Fel(icis) Inv(icti) Aug(usti)] | [et num(eri) P]almyr(enorum) O[rientali(um)] | [---]i Abraen(us) Fl(avius) M[arianus] | [----] Cassi(us) Marinu[s ---] | [Ma]ximus Gora Lu[cianus] | [---] Maximus bar S[emon?] | [sace]rdot(es) templum [a solo] | ex suo fecer(unt). L’iscrizione è databile tra il 222 e 235 d. C. Il nome ricostruito dai frammenti (e per questo supposto), il quale qui sta al posto del gentilicium, fu frequente nella Dalmatia e nell’Africa settentrionale,ccxci ma fu in uso anche nell’ambiente orientale, se pensiamo per esempio al caso di Lukianos di Samosata. In questo periodo egli poté avere già la cittadinanza romana. Fu il sacerdote di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus, con il titolo di sacerdos. Fecero costruire, insieme agli altri colleghi, il Dolichenum di Sarmizegetusa entro le mura della città. Il fenomeno si può spiegare con il fatto, che nell’epoca di Severus Alexander (222-235 d. C.) – se non già precedentemente – il culto di Iuppiter Dolichenus fu regolato dalle prescrizioni della religione romana [cfr. anche D 37]. Il luogo del santuario rinvia anche alla presenza di carattere ufficiale del sacerdote, il quale dunque poté essere sacerdos coloniae. La sua attività nella Dacia cominciò negli anni ’10-’20 del III secolo d. C. La sua carriera non può essere riassunto totalmente in base ai pochi dati frammentari. Fu il sacerdos di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus come cittadino romano, nel secondo terzo del III secolo d. C., nella Dacia.
D 62
Marinus Marian(i filius) Bas(sus) Colonna. Ampelum. CIL, III, 1301a; CIL, III, 7834; ILS, 4298; Kerényi 1056; Kan II, nr. 29, Merlat 28; Russu 1969, 177-182; Angyal-Balla 1972, 94, nr. 4; Noeske 1977, 370, nr. 70; Sanie 1989, 1247, nr. 6; Berciu-Popa 1978, nr. 12; IDR, III/3, 298; CCID, 147; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | Commagenorum [Ae]|terno Ma|rinus Ma|rian(i filius) Bas(sus) | sacerdos I(ovis) | O(ptimi) M(aximi) D(olicheni) pro s(alute) s(ua) | suorumq(ue) o|mnium vot(um) | V H.
MANUSCRIPT
Le ultime lettere della 2ª riga sono forse i frammenti della parola [sol]vit, scolpita imperfettamente, la quale, dopo il votum, finì la frase, oppure possono essere anche le lettere di un’indeterminabile formula hapax finale. L’epigrafe è databile alla fine del II – prima metà del III secolo d. C. Il dedicatore, che poté avere anche la cittadinanza romana, fu probabilmente di origine orientale. Secondo il nome frequente tra i sacerdoti di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus, derivabile anche dalla Siria,ccxcii dovette venire nella Dacia da una delle province orientali dell’Impero, ma il nome si trova spesso anche nell’Africa settentrionale e nelle province occidentali.ccxciii Al posto del gentilicium si trova la filiatio, il nome del padre ha le stesse caratteristiche. Il cognomen non è adatto alla definizione etnica, dato che fu portato sia dagli orientali che dagli italici, nella Pannonia dopo l’epoca di Marcus Aurelius piuttosto dagli orentali.ccxciv Si è presentata l’idea,ccxcv che sia identico all’uno dei dedicatori di una colonna votiva di Apulum.ccxcvi Secondo il testo questa colonna fu eretta alla memoria dell’evento, quando alcuni salvarono un’aquila (aquila) da un serpente (draco). Uno dei dedicatori della colonna fu Aurelius Marinus Bassus, che non menzionò nessuna carica. Nominò però il padre, Polydes, quindi non Marianus, perciò questo fatto nega l’identificazione delle due persone. Lo stesso vale anche all’identificazione con Aurelius Marinus. Fu il sacerdos di Iuppiter Dolichenus, che agì anche ad Ampelum, nel II secolo d. C. ufficialmente solo nel caso di un santuario in area pubblica, e nel III secolo d. C. il più presto dopo il 212 d. C. verosimilmente secondo le iscrizioni delle leggi religiose romane. Secondo i dati nel testo dell’iscrizione egli fu cittadino romano e il sacerdos Iovis Optimi Maximi Dolicheni negli anni dello scorcio del II secolo e dell’inizio del III d. C.
D 63
Fl(avius) Maximu[s] Surus Epigrafe sepolcrale. Ampelum. AÉ, 1988: 959; Lipovan 1988, 63, nr. 6; Wollmann 1996, 185; ILD 338; D(is) M(anibus) | Fl(avius) Maximu[s] | Surus sace[r]|dos vix(it) ann(os) | XLV Casto[r] | et Foebus(!) pi(entissimi) | b(ene) m(erenti) p(osuerunt). L’epigrafe è databile alla fine del II – inizio del III secolo d. C. Dopo la parola sacerdos non c’è nè una città, nè una divinità, perciò non sappiamo, che sacerdote fu egli. Il gentilicium non rinvia all’origine. Il praenomen fu originalemente gentilicium, ma già nel II secolo d. C. non fu raro che si applicavano come praenomen elementi usati precedentemente solo nel gentilicium. Il cognomen fu diffuso nell’Italia settentrionale, nel Noricum, nella Dalmatia e nella Pannonia tra gli italici e gli indigeni, ma fu portato anche dagli orientali.ccxcvii Si può contare con la possibilità che fu il sacerdote di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus, ma questo non è dimostrabile. Non ci aiuta la dedicazione, e neanche l’origine fornisce nessun punto di riferimento. Quest’ultima, comunque, non è per lo stato sacerdotale di Dolichenus, dato che la maggior parte degli sacerdotes Dolicheni fu di origine orientale.ccxcviii I nomi Castor e Foebus dei suoi schiavi (?), che gli fecero erigere il monumento sepolcrale rinviano solo al loro origine e alla schiavitù, eventualmente il nome Castor si può collegare al culto di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus.ccxcix Nemmeno la presenza del Dolichenum oppure quella dei sacerdoti attivi della divinità dolichena ad Apulum può provare la carica di sacerdos Iovis Dolicheni di Flavius Maximus Surus, anche se questa possibilità si presenta la più probabile. Ampelum fu probabilmente un municipium Septimium,ccc e come questo poté, anzi dovette avere anche altri sacerdoti, i quali con il titolo sacerdos servirono i culti fuori la tradizionale religione romana. Secondo i dati dell’iscrizione egli fu cittadino romano e sacerdos (Iovis Optimi Maximi Dolicheni ? o municipi ?) negli anni attorno il forduló dei secoli II e III d. C.
D 64
Maximus bar S[emon?] Tavola. Sarmizegetusa, l’angolo sud-occidentale della città, la zona del cd. Dolichenum. AÉ, 1927: 56; Daicoviciu 1924, 250; Sanie 1977, 146; AÉ, 1977: 668; IDR, III/2, 20; Szabó Á. 2004 (HPS), 139-161; AÉ 2004: 1212; [I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Dolicheno pro salute] | [D(omini) N(ostri) Imp(eratoris) Caes(aris) Divi Severi Pii nep(otis)] | [Divi Magni Ant]on[ini f(ili) M(arci) Aur(eli) Sev]|[eri [[[Alexandri]]] Pii [Fel(icis) Inv(icti) Aug(usti)] | [et num(eri) P]almyr(enorum) O[rientali(um)] | [---]i Abraen(us) Fl(avius) M[arianus] | [----] Cassi(us) Marinu[s ---] | [Ma]ximus Gora Lu[cianus] | [---] Maximus bar S[emon?] | [sace]rdot(es) templum [a solo] | ex suo fecer(unt). L’iscrizione è databile tra il 222 e 235 d. C. Egli venne da una delle province orientali dell’impero, il nome (in altri luoghi Bars[emon]) rinvia a Palmyra.ccci Fu il sacerdote di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus, ed ebbe sicuramente anche la cittadinanza romana nell’epoca. Fece costruire, insieme ai colleghi, il Dolichenum di Sarmizegetusa, all’interno del pomerium. Il suo sacerdotium dovette essere ufficiale secondo il luogo del tempio. La sua attività cominciò negli anni ’10-’20 del III secolo d. C.
MANUSCRIPT
Secondo i dati dell’iscrizione egli fu cittadino romano e sacerdos Iovis Optimi Maximi Dolicheni nel secondo terzo del III secolo d. C., verosimilmente a Sarmizegetusa.
D 65
[Ma]ximus Gora
Tavola. Sarmizegetusa, l’angolo sud-occidentale della città, la zona del cd. Dolichenum. AÉ, 1927: 56; Daicoviciu 1924, 250; Sanie 1977, 146; AÉ, 1977: 668; IDR, III/2, 20; Szabó Á. 2004 (HPS), 139-161; AÉ 2004: 1212; [I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Dolicheno pro salute] | [D(omini) N(ostri) Imp(eratoris) Caes(aris) Divi Severi Pii nep(otis)] | [Divi Magni Ant]on[ini f(ili) M(arci) Aur(eli) Sev]|[eri [[[Alexandri]]] Pii [Fel(icis) Inv(icti) Aug(usti)] | [et num(eri) P]almyr(enorum) O[rientali(um)] | [---]i Abraen(us) Fl(avius) M[arianus] | [----] Cassi(us) Marinu[s ---] | [Ma]ximus Gora Lu[cianus] | [---] Maximus bar S[emon?] | [sace]rdot(es) templum [a solo] | ex suo fecer(unt). L’epigrafe è databile dopo il 222, all’epoca di Severus Alexander, fino al 235 d. C. Egli ebbe sicuramente la cittadinanza romana nell’epoca. Venne da una delle province orientali dell’Impero, in base al nome probabilmente dalla Siria, da Palmira.cccii Fu il sacerdote di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus, con il titolo di sacerdos e rivestì un sacerdotium ufficiale secondo il luogo del tempio. Fece costruire, insieme ai colleghi, il Dolichenum di Sarmizegetusa, entro le mura. Il suo sacerdotium cominciò negli anni ’10-’20 del III secolo d. C. Secondo i dati dell’iscrizione egli fu cittadino romano e sacerdos Iovis Optimi Maximi Dolicheni nel secondo terzo del III secolo d. C., nella Dacia, verosimilmente a Sarmizegetusa.
D 66
M(arcus) Munatius M(arci) f(ilius) [---]* Iscrizione commemorativa di una costruzione. Apulum. Sparita? CIL, III, 56*; AÉ, 1972: 455; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 288; Mrozewicz 1999, 76, nr. 33; IDR, III/5, 1*; M(arcus) Munatius M(arci) f(ilius) [---] | [?e]qu{a}es [Romanus pa]|t[r]onu[s] causarum q(uin)[q(uennalis)] | [I]Iv[ir] e[t] flam(en) d[ec(urio)] | mun(icipi) [et] col(oniae) Apul(ensis) | [---] ex v[etust(ate)] | [diru]tu[m] p[ec(unia) sua ---] | [?--- Nella 2ª riga si tratta verosimilmente di una copia o di un’interpretazione sbagliata. Nell’iscrizione si leggono le stazioni di un cursus discendente, a cui non corrisponde il frammento della parola quaes[---] della 2ª riga e l’integrazione proposta. In questo caso, forse per lo stato frammentario dell’iscrizione è stato letto, interpretato e copiato erroneamente un altro ufficio o un altro rango nell’epoca moderna. In ogni riga c’è posto per 12-16 lettere secondo la larghezza delle singole lettere. Quindi nella parte rotta della 1ª riga e all’inizio della 2ª dovette stare il cognomen, magari la tribus in forma abbreviata e un cognomen corto. Dopo il nome dovette venire il più probabilmente il rango equestre in forma eques Romanus. La lettura QVAES è stata sforzata dalle lettere V e E molto vicine una all’altra (VE). La sua iscrizione di Apulum, ritenuta come falsificazione, è databile dopo il 193-197 d. C. Il suo gentilicium è di origine italica.ccciii In base allo stato sociale, egli dovette avere il rango dei decuriones all’inizio della carriera. Rivestì cariche in due città. In base al [I]Iv[ir]atus fece il cursus intero nella colonia, dato che nel municipium vigeva il sistema IIIIvirale.ccciv Quindi il decurionatus municipale si inserisce nella cronologia del suo cursus dopo il decurionatus coloniale. Il d[ec(urio)] nella 4ª riga si riferisce sia al municipium, che alla colonia. Dopo i due decurionatus si legge l’indicazione di una carica di flamencccv e una di IIvir, ambedue si intendono nella colonia. È molto probabile, che fece una magistratura bassa prima del IIviratus, la quale non è indicata separatamente, quindi fu anche quaestor e/o aedilis. Dopo il IIviratus rivestì anche la carica quinquennalis. È improbabile, che il IIviratus fosse insieme alla carica quinquennalis, dato che quest’ultima era indicata nella Dacia nella maggior parte dei casi, ma non sempre, senza il IIvir [cfr. D 57]. Dopo ebbe l’ufficio occasionale del patronus causarum, apparentemente al servizio della sua città.cccvi Salì nell’ordine equestre verosimilmente dopo la carriera municipale. La ricerca recente accetta il suo rango equestre, l’iscrizione è pubblicata nelle opere rilevanti. Riassumendo la sua carriera secondo i dati nell’iscrizione: dopo il 180 - d[ec(urio)] col(oniae), dopo il 193-197 d[ec(urio)] mun(icipi), flam(en) (quaestor e/o aedilis coloniae?), [I]Iv[ir], q(uin)[q(uennalis)] col(oniae), pa]t[r]onu[s] causarum col(oniae), [?e]qu{a}es [Romanus].
D 67
C(aius) Numm(ius) Certus
MANUSCRIPT
Epigrafe sepolcrale. Apulum. Sparita. CIL, III, 1217; Kerényi 1106, 1755; Balla 2000, 118, nr. 21; Ardevan 301; Mrozewicz 1999, 76, nr. 34; IDR, III/5, 599; Verzoviae Sa|turninae [e]q(uitis) R(omani) f(iliae) | C(aius) Numm(ius) Certus | eq(ues) R(omanus) augur col(oniae) | Apul(ensium) patr(onus) coll(egi) | fab(rum) et dendr(ophorum) col(oniae) | s(upra) s(criptae) suadente ad|fectione ma|tri posuit. L’epigrafe eretta per la madre è databile dopo il 180 d. C. Il suo gentilicium è italico, ma è conosciuto anche – oltre la Dacia – anche nella Hispania.cccvii Il suo cognomen è frequente nella Dalmatia, ma capita anche nell’Italia e nelle province occidentali.cccviii Anche sua madre venne da una famiglia equestre. Come il membro dell’ordine equestre fu l’augur della colonia di Apulum e il patronus del collegium fabrum et dendrophorum,cccix secondo il testo dell’iscrizione. Quest’ultimo unì in società i fedeli di Cybele Magna Mater.cccx Apparentemente fu il membro anche dell’ordo decurionum, in base al suo stato finanziario come eques. Non è dimostrabile, ma per il raro gentilicium, per il praenomen uguale, per l’appartenenza all’ordine equestre, e per la stessa città ed epoca si presuppone, che C(aius) Nummius Certus fosse il parente di C(aius) Nummius Verus. Secondo i dati concordanti vennero dalla Dalmatia. Riassumendo gli elementi della sua carriera, tramandati dal testo dell’iscrizione: il più presto dopo il 180 d. C. - eq(ues) R(omanus), augur col(oniae), patr(onus) coll(egi) fab(rum) et dendr(ophororum) col(oniae).
D 68
C(aius) Nummius Verus Altare. Apulum. Marosportó (Partoş)? CIL – „In arce, in aedibus canonici Becke”. Sparito. CIL, III, 7739; Domaszewski 1885, 245, nr. 1; Kerényi 1107; Balla 2000, 118, nr. 22; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 346; Mrozewicz 1999, 76, nr. 35; IDR, III/5, 2; C(aius) Nummius | Verus eques | Romanus | IIviral(is) col(oniae) Apul(ensis) | et sacerdos | num(inis) Aescu|lapi consecr(avit). L’iscrizione è databile dopo il 180 d. C. Il suo gentilicium ecccxi il cognomen possono derivare dall’Italia settentrionale, quest’ultimo si trova in tutte le province europee, ma capita anche nelle province orientali.cccxii Fu il membro dell’ordine equestre, e nel momento dell’inaugurazione dell’altare il già IIvir della colonia di Apulum e il sacerdos di Aesculapius. La carica sacerdotale per Aesculapius non si può inserire cronologicamente nella carriera, ma non è da escludere, che lo si deva mettere proprio dove è indicato, quindi dopo il IIviratus. Malgrado ciò egli aveva potuto impadronarsi della scienza dei sacerdoti di Aesculapius in uno dei centri importanti già da giovane [cfr. anche D 57]. Per il IIviratus si presuppone con ragione non solo l’appartenenza all’ordo decurionum, ma anche la carica di una o ambedue delle magistrature basse. Quindi poté essere quaestor e/o aedilis nella colonia di Apulum. Non si può provare, ma in base al gentilicium raro e al praenomen identico, all’appartenenza all’ordine equestre, alla stessa città e alla stessa epoca si suppone, che C(aius) Nummius Verus fu il parente di C(aius) Nummius Certus. Secondo i dati concordanti vennero dalla Dalmatia. Riassumendo la sua carriera secondo il testo dell’iscrizione: il piú presto dal 180 d. C. – eques Romanus, (decurio, quaestor e/o aedilis, IIvir) IIviral(is) col(oniae), sacerdos num(inis) Aesculapi.
D 69
Oceanus Socratis Colonna. Ampelum. CIL, III, 1301b; CIL, III, 7835; ILS, 4299; Kerényi 2126; Kan 30; Hettner 4; Merlat 29; Russu 1969, 177-182; Angyal-Balla 1972, 94 nr. 5; Noeske 1977, 370, nr. 71; Berciu-Popa 1978, nr. 11; Sanie 1989, 1246, nr. 5; IDR, III/3, 299; CCID, 148; Wollmann 1996, 183-184; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) et | Deo Com|aceno | Aurel(ius) | Marinus | [et] Adde Barseme|i et Ocea|nus So|cratis sa|cerdotes | v(otum) l(ibentes) p(osuerunt). L’iscrizione è databile alla fine del II – inizio del III secolo d. C. Secondo il suo nome Oceanus Socratis venne nella Dacia dalla parte orientale con popolazione di lingua greca dell’Impero Romano e ci si stabilì. L’elemento cognominale al posto del gentilicium si conosce come cognomen in pochissimi casi in alcune province europee.cccxiii Il suo cognomen capita nella Gallia Narbonensis e nella Moesia tra le province europee.cccxiv A causa della dedicazione è probabile che fu il sacerdote di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus con altri due colleghi [D 1, 35], portando il titolo di sacerdos. La loro presenza comune può essere in connessione con la fondazione e costruzione di un Dolichenum archeologicamente finora scoperta ad Apulum, dove collocarono anche le loro iscrizioni [cfr. D 81]. Se il santuario stava sull’area pubblica, la loro carica
MANUSCRIPT
sacerdotale era ufficiale già alla fine del II secolo d. C. Similmente, se la comunità dei fedeli formava un’associazione registrata, per esempio un collegium. Non abbiamo dati a nessuna delle due possibilità. Nel III secolo d. C. egli poté già rivestire una carica sacerdotale ufficiale [cfr. per es. D 37], il più presto dal 212 d. C. Secondo i dati nel testo dell’iscrizione egli fu cittadino romano e sacerdos (Iovis Optimi Maximi Dolicheni ? o municipi ?) negli anni dello scorcio del II secolo e nel primo quarto del III secolo d. C.
D 70
M(arcus) Proc(ilius) M(arci) fil(ius) Pap(iria tribu) Niceta
a. Tavola. Sarmizegetusa. CIL, III, 6270; ILS 7136; Daicoviciu 1924, 246-247; Kerényi 1178, 1179; Balla 2000 (1977), 118, nr. 24-25; IDR, III/2, 2; Noll 417; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 53; Ardevan 1998, 198; Piso 2006, nr. 37; M(arcus) Proc(ilius) M(arci) fil(ius) Pap(iria tribu) Niceta | IIvir et flamen col(oniae) Sarmiz(egetusae) | item sacerd(os) Laurentium | Lavinat(ium) aedem Augustalibus | pecunia sua faciend(am) instituit | eandem M(arcus) Proci[l(ius)] Regulus | dec(urio) col(oniae) eq(uo) publ(ico) filius et here[s] | eius per[fec]it dedicav[itq(ue)]. Tra il 161-193 d. C. b. Cinque frammenti della tavola commemorativa di una costruzione. Sarmizegetusa. Zám (Zam). CIL, III, 1509; CIL, III, 1016; Kerényi 1178, 1179; Ardevan 1992, 47-53; Balla 2000, 118, nr. 24, 25; IDR, III/2, 3; Ardevan 1984, 95-110; Piso 2006, nr. 38; M(arcus) Proc(ilius) M(arci) fi[l(ius) Pap(iria tribu) Niceta] | IIvir et flam[en col(oniae) Sa]rm[iz(egetusae)] | item sacerd(os) [Lauren]ti[um] | [Lavinat(ium) ---?pecunia sua] | [faciend(am) instituit eandem] | [M(arcus) Proc]il(ius) [Regulus dec(urio) col(oniae) ---] | eq(uo) publ(ico) filiu[s et] her[es eius perfecit] | dedicavitqu[e]. Tra il 161-193 d. C. c. Frammenti di una tavola. Sarmizegetusa. Forum vetus. Piso 2006, nr. 39 ?M(arcus) Pro[c(ilius) M(arci) fil(ius) Pap(iria tribu) Niceta] | [---] | [--- sacerd(os) L]aur[entium] | [Lavi]nat[ium ---] | [---? pe]cu[nia sua ---] | [--- Tra il 161-193 d. C. d. Frammento di una tavola. Sarmizegetusa. Forum vetus. Piso 2006, nr. 57; M(arco) Pro[cilio] | Nicet[ae...] | [- - - - -.
È conosciuto tramite quattro iscrizioni di Sarmizegetusa (due erette da suo figlio), le quali si datano tra il 161 e 193 d. C. Il suo gentilicium è conosciuto nelle province europee esclusivamente solo nella Dacia, mentre il suo cognomen si trova anche nell’Italia, nella Gallia meridionale e nella Dalmatia.cccxv È probabile, che ebbe rapporti familiari con le aree greche, ma lui ebbe un’origine italica.cccxvi Fu lui che cominciò a far costruire l’Aedes Augustaliumcccxvii a Sarmizegetusa, finito e inaugurato poi da suo figlio, Regulus. Tramite queste iscrizioni si conosce anche il padre. Il figlio non inidcò tutte le cariche del padre, e anche quelle indicate sono scritte in modo irregolare. Le iscrizioni ci tramandano due uffici: egli fu IIvir e flamen a Sarmizegetusa.cccxviii In base alla sua carica IIvirale fu anche decurio, e poté rivestire almeno una delle magistrature basse, ma eventualmente tutte e due, quindi fu anche quaestor e/o aedilis. Inoltre ebbe anche la carica sacerdotale di Laurens Lavinas, riservata ai membri dell’ordine equestre,cccxix perciò è quasi sicuro, che fu anche eques, benché questo non sia indicato in nessuna iscrizione. Secondo R. Ardevancccxx ebbe solo le condizioni per diventare eques, a cui contraddice il fatto, che tra i nobili dacici ci sono parecchi, che rivestirono cariche militari dell’ordine equestre, ma il loro rango equestre non fu mai indicato, dato che le cariche lo rendevano evidente. La carica di sacerdos Laurentium Lavinatium sarebbe correttamente flamen Laurentium Lavinatium, in altri casi dacici si legge in questa forma [D 8a., 76]. Alla definizione di sacerdos appartengono anche i flamines, benché questa indicazione non può essere considerata formale invece di flamen. Nella provincia anche il flaminatus di P(ublius) Aelius Marcellus fu scritto dai magistrati di Apulum come sacerdotium [D 8]. Anche M(arcus) Varenius Sabinianus [D 76] divenne flamen Laurentinus come flamen di Sarmizegetusa. Il fatto, che anche
MANUSCRIPT
Niceta ebbe questa carica ci fa pensare, che l’iscrizione del figlio non tramandò tutti gli elementi della sua carriera, quindi mancano cariche, impieghi oppure uffici, che, oltre alla carriera municipale, risultarono l’onore dell’ufficio sacerdotale di Laurens Lavinas. Conosciamo i suoi due figli: Regulus [a., b.]cccxxi e Iulianus.cccxxii Tutti e due furono equites e i membri dell’ordo decurionum di Sarmizegetusa. È probabile, che anche M(arcus) Procilius Theodorus, il decurio, il IIvir, e poi il (IIvir) quinquennalis di Sarmizegetusa, appartenne alla famiglia.cccxxiii Riassumendo la sua carriera secondo il testo delle iscrizioni: circa alla metà del II secolo d. C. – (decurio, quaestor e/o aedilis), IIvir (IIviralis), flamen col(oniae), possibilmente dopo la carriera municipale (equo publico o eques Romanus), (---?), sacerd(os) (= flamen) Laurentium Lavinat(ium).
{Silvanus → D 92}
D 71
C(aius) Spedius Hermias Altare. Sarmizegetusa. Sparito. CIL, III, 1417a; ILS, 3854; IDR, III/2, 164; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 143; Aescul(apio) Pergam(eno) | et Hygiae | sacrum | C(aius) Spedius Hermias | flamen col(oniae) Sarm(izegetusae) | pos(uit). L’iscrizione è databile sia al II che al III secolo d. C., ma se prendiamo in considerazione la possibilità della diffusione di Aesculapius di Pergamon nella Dacia, sembra più probabile la datazione al periodo dall’ultimo terzo del II secolo d. C.cccxxiv Il suo gentilicium è di origine italica, ma capita anche nella Hispania, nella Dalmatia, nella Pannonia, nella Moesia Superior e nella Gallia Lugdunensis.cccxxv Il suo cognomen è greco.cccxxvi Tra le persone di Sarmizegetusa conosciute con il praenomen e gentilicium C(aius) Spedius solo C(aius) Spedius Clemens,cccxxvii IIvir coloniae ebbe il rango simile come C(aius) Spedius Hermias, con cui potevano essere anche parenti. Quest’ultimo dedicò alla moglie una stele funeraria con lettere monumentali, il che rinvia piuttosto al II secolo, all’epoca degli Antonini. Gli altri C(aii) Spedii dovettero essere i liberti di Hermias o di Clemens. Fu il flamen di Sarmizegetusa, altre sue cariche non sono conosciute, quindi la sua carriera pubblica cominciò poco prima della dedicazione dell’epigrafe. Secondo il testo dell’iscrizione è conosciuto il seguente dato della sua carriera: dall’ultimo terzo del II secolo d. C. (?) – flamen col(oniae).
D 72
[.] Statorius [---]ianus Altare. Apulum. Dalla riva del Maros, a 200 m dal ponte di Marrosportó (Partoş) verso Est. AÉ, 1998: 1079; Moga-Piso-Drîmbǎrean 1998, 114-117, nr. 3; IDR, III/5, 709; [D]eo Invicto | [Mi]t(h)rae sac(rum) | [.] Statorius | [....]anus dec(urio) | [et] flamen m|[uni]c(ipi) Sep(timi) Ap[ul(ensis)] | [in]victi templum pr[o] [sal]utem sua suorum|[que p]ecunia mea feci. In base alla fondazione della città l’iscrizione è databile dopo il 193-197 d. C., secondo la data dell’acquisto del rango di città (di municipium) da parte delle canabae presso la legio XIII Gemina (posto di ritrovamento nella parte di Sárd di Gyulafehérvár), donato dal Septimius Severus (193-211 d. C.), quindi piuttosto alla prima metà del III secolo d. C. Il gentilicium del dedicatore fu in uso in Italia e anche in altre province occidentali con popolazione di lingua latina e all’Oriente, nelle province con popolazione di lingua grecacccxxviii, perciò è inadatto ad identificare l’origine della persona. Il cognomen non è identificabile, ci sono molti nomi con questa desinenza.cccxxix Come il membro dell’ordo decurionum del municipium Septimium Apulensium fu il flamen della città. Secondo l’iscrizione formulata insolitamente, fece costruire un mithraeum (menzionato come tempio), sicuramente come persona privata, dunque fu iniziato nei misteri di Mithras. Quest’ultimo e il suo rango di iniziazione, inoltre eventualmente la sua carica sacerdotale non sono indicati, dato che non attenevano al mondo. Anche lui è un buon esempio del fenomeno, che la carica sacerdotale e il nome della divinità nella dedicazione non sono necessariamente in connessione [cfr. anche D 60, 73]. Riassumendo gli elementi conosciuti della carriera, tramandati dal testo dell’iscrizione: all’inizio del III secolo d. C. – fu dec(urio), flamen m[uni]c(ipi).
D 73
Val(erius) Celsus
MANUSCRIPT
Altare. Potaissa. CIL, III, 903; Kerényi 1460; Ardevan 1992, 47-53; Bărbulescu 1994, 48; Ardevan 430; Silvano | sac(rum) | Val(erius) Celsus | flamen | municipii | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). L’iscrizione si data al periodo dal 193-197 d. C. fino al primo decennio del III secolo d. C., alla breve fase municipale di Potaissa.cccxxx Il suo gentilicium fu usato dappertutto nella parte latina dell’Impero, questo nome si diffuse dall’Italia settentrionale nell’Occidente latino tramite i suoi portatori.cccxxxi Il suo cognomen è conosciuto nell’Italia e nelle province occidentali.cccxxxii Quindi, per quanto rigurada la sua origine, è probabile, che la sua famiglia venne nella Dacia dalla parte occidentale dell’Impero. Fu il primo oppure piuttosto l’unico flamen del municipium di Potaissa,cccxxxiii prendendo in considerazione l’esitenza breve di uno, uno e mezzo decennio del municipium sotto il regno di Septimius Severus.cccxxxiv Dedicò l’altare a Silvanus apparentemente non in connessione con la sua carica di flamen. Secondo l’unico elemento della sua carriera menzionato nell’iscrizione egli fu tra il 193-197 e 211 d. C. flamen municipii.
D 74
Sex(tus) Val(erius) Sex(ti) fi[l(ius) Pap(iria tribu)] Fronto
Stele funeraria. Sparita. Sarmizegetusa. Szászváros (Orăştie). CIL – „Schustergasse 165”; nel 1912 via Varga 22. CIL, III, 1398; IDR, III/2, 455; Ardevan 1986-1987, 127-132; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 190; D(is) M(anibus) | Sex(ti) Val(eri) Sex(ti) fi[l(i) Pap(iria tribu)] | Frontoni d[ec(urioni) col(oniae)] | Sarmiz(egetusae) ae[d(ili)] | flamini p[raef(ecti)?] | collegii [fab(rum) vix(it)] | [ann(is)] XXXVI [---. La sua epigrafe funeraria è databile al II secolo d. C., probabilmente partendo dalla metà del secolo, alla seconda metà del secolo. Il suo gentilicium è conosciuto dappertutto nella parte latina dell’Impero, questo nome diffuse dall’Italia settentrionale.cccxxxv Il suo cognomen di origine illirica è frequente nella Dalmatia.cccxxxvi Dovette essere un cittadino di seconda o terza generazione a Sarmizegetusa, dalla tribus Papiria traianea di Sarmizegetusa. La sua epigrafe funeraria contiene gli elementi della sua carriera in ordine cronologico, quindi tutte le cariche che aveva portato fino alla morte all’età di 36 anni. Come il membro dell’ordo decurionum di Sarmizegetusa fu aedilis,cccxxxvii poi flamen, poi fu eletto il praefectus oppure il patronus del collegium fabrum. Riassumendo la sua carriera secondo il testo dell’iscrizione: nella seconda metà del II secolo d. C. – d[ec(urio), ae[d(ilis)], flamen, p[raef(ectus)?] collegi [fab(rum).
D 75
T(itus) Varen(ius) T(iti) fil(ius) Pap(iria tribu) Pudens a. Base Sarmizegetusa. Zám (Zam). CIL III, 1482; ILS, 7132; Trynkowski 1965, 373-375; AÉ, 1966: 309a; IDR, III/2, 129; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1992, 47-53; Balla 2000, 118, nr. 29; Ardevan 112; T(ito) Varenio | Probo | IIviral(i) item | q(uin)q(uennali) col(oniae) | Varen(ius) Pudens | fl(amen) coloniarum | eq(uo) p(ublico) praef(ectus) coh(ortis) pa|tri ob stratam ab | eo aream dimidiam | in honorem suum | ex s(e)s(tertium) L (milibus) n(ummum) l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum). La fine del II – inizio del III secolo d. C. b. Base. Sarmizegetusa. Zám (Zam). CIL, III, 1486; AÉ, 1957: 196; Trynkowski 1965, 373-375; AÉ, 1966: 309a; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1992, 47-53; Balla 2000, 118, nr. 29; AÉ, 1966: 309c; IDR, III/2, 128; Ardevan 114; [T(ito) Vare]nio T(iti) fil(io) Pap(iria tribu) | [Pude]nti eq(uo) p(ublico) a mil(itis) | [dec(urioni)] et flam(ini) colo|[n(iae) Sa]r(mizegetusae) q(uin)q(uennali) col(oniae) s(upra) s(criptae) dec(urioni) | [mu]nic(ipi) Apul(ensis) patro|[no m]unic(ipi) Porol(issensis) et | [colle]gior(um) itemque | [cau]sarum. L’inizio del III secolo d. C. c. Base.
MANUSCRIPT
Sarmizegetusa. Zám (Zam). Sparita. Fodor, pl. 65; CIL, III, 1514; Trynkowski 1965, 366-377; Balla 2000, 118, nr. 29/a; IDR, III/2, 130; Ardevan 237; T(ito) Varenio [T(iti) f(ilio)] | Pap(iria tribu) P[udenti] | eq(uo) [p(ublico) [---] | [---. Probabilmente l’inizio del III secolo d. C. È conosciuto personalmente tramite tre iscrizioni ritrovate a Sarmizegetusa, databili alla fine del II e ai primi due decenni del III secolo d. C. Il gentilicium della famigliacccxxxviii è conosciuto – oltre la Dacia – solo nella Gallia.cccxxxix I cognomina del padre e del figlio si trovano dappertutto in diverse quantità nelle province europee, tranne nella Germania e nella Raetia.cccxl In base al gentilicium di una decisa diffusione si può rischiare che la famiglia venne dalla Gallia nella Dacia. Suo padre, T(itus) Varenius Probus fu il IIvir e il quinquennalis di Sarmizegetusa, sua madre fu probabilmente una delle sorelle – Sperata oppure Caecilia – di M(arcus) Cominius Quintus [D 46].cccxli Il padre di Pudens fu IIvir e quinquennalis a Sarmizegetusa [a.], il che rende evidente, che il figlio nacque in una famiglia con il rango di decuriones. Le sue cariche dell’epigrafe a. sono inidicate molto verosimilmente in ordine cronologico fino al momento della dedicazione dell’iscrizione. Secondo il testo egli fu il flamen di più, quindi almeno di due colonie,cccxlii il membro dell’ordine equestre e cohorspraefectus. Dovette essere eletto alle cariche di flamen come decurio. È dubitoso, se fu flamen in più di due colonie. Nel momento presumibile della dedicazione Apulum, Napoca e probabilmente Drobeta aveva il rango di colonia nella Dacia. Uno dei flaminatus però riguarda senza dubbio la sua città, quindi Sarmizegetusa. A causa della vicinanza geografica e visto che ambedue le colonie erano nella Dacia Apulensis, l’altra colonia, dove egli fu flamen, poteva essere la colonia di Aurelia Apulensium. Dato che nel testo dell’iscrizione posteriore [b.] manca l’indicazione di un altro decurionatus coloniale, per un flamintaus in un’altra città (più precisamente per il flamintaus coloniale ad Apulum) bastava verosimilmente il decurionatus attuale in qualsiasi città. Poi salì nell’ordine equestre, ovviamente per lo stato finanziario e forse per i suoi meriti. Questo significa una promozione della famiglia, dato che non rinvia niente allo stato equestre del padre. Dopo esser salito nell’ordine equestre, entrò in servizio militare. L’iscrizione [a.] fu eretta da Pudens come soldato attivo, durante la militia prima, quindi la cohorspraefectura. L’iscrizione [b.] contiene altri dettagli della carriera. Al momento della dedicazione stette Pudens già all’apice della sua carriera municipale a Sarmizegetusa, quindi fu quinquennalis. Il testo dell’epigrafe elenca le cariche in ordine cronologico e il testo tematicamente armonizza con l’iscrizione [a.]. L’epigrafe [b.] comincia con l’indicazione dello stato equestre di Pudens in forma particolare: eq(uo) p(ublico) a mil(itis). L’integrazione dello stato equestre con l’espressione del servizio militare equestre rinvia al fatto, che si voleva riassumere il suo servizio militare in una parola. Così l’espressione a militis rinvia verosimilmente a tutte le tre cariche militari equestri, cioé alle tres militiae. Al momento della dedicazione dell’epigrafe [a.] fece come eques la militia prima, la cohorspraefectura, mentre l’espressione a militis dell’epigrafe [b.] rinvia probabilmente – oltre la militia prima – alla militia secunda e tertia, quindi al legio-tribunatus e all’ala-praefectura. Poi si leggono gli elementi della carriera municipale, prima il decurionatus a Sarmizegetusa, il quale possedette già all’inizio della sua carriera. Dopo questo è indicata la carica di flamen a Sarmizegetusa, che si legge similmente anche già nell’iscrizione [a.]. In confronto all’epigrafe [a.] il flaminatus seguente manca nell’iscrizione [b.]. Questo può rinviare indirettamente al fatto, che ebbe veramente solo un altro flaminatus, quindi in tutto due, al momento della dedicazione dell’epigrafe [a.]. Si domanda però, che in caso di un’eventuale assenza lunga come poteva esercitare la sua funzione di flamen. E l’esercito di due funzioni era ancora più problematico. La mancanza del secondo flaminatus nell’iscrizione [b.] conferma indirettamente l’ipotesi, che egli rinunciò almeno a uno dei flaminatus e così il posto del flamen in una delle città divenne libero. Quest’ipotesi non spiega però, come poteva esercitare la funzione del flaminatus rimasto, oppure chi la esercitava invece di lui, se c’era un solo flamen nella città. Non rinvia niente direttamente all’esistenza contemporanea di due flamines, ma i flamines cronologicamente vicini, conosciuti tramite iscrizioni, potevano essere in carica anche contemporaneamente, e così uno di loro poteva essere assente anche per lungo tempo. L’ipotesi, che è indicato solo un flaminatus, perché l’iscrizione fu eretta a Sarmizegetusa, è da esculdere, dato che il testo contiene anche cariche rivestite in altre città. Il quinquennalis a Sarmizegetusa dopo il flaminatus dell’iscrizione [b.] presuppone un intero cursus municipale. Qunidi Pudens, come decurio, fu queastor e/o aedilis a Sarmizegetusa. Poiché a Sarmizegetusa bastava una sola magistratura bassa per il IIviratus,cccxliii possiamo ritenere meno probabile e piuttosto facultativo l’incarico di ambedue le magistrature basse. Non sembra probabile, che Pudens, dopo la carriera militare, perdesse tempo con tutte e due magistrature basse, ma non è da escludere, dato che non si conosce nessun regolamento che vietasse l’incarico di ambedue le magistrature. Se il duumviratus non cadde al quinto anno, allora prima della quinquennalitas fu anche IIvir. Quest’ultimo sembra più probabile, perché la quinquennalitas fu una carica di maggior importanza, che si rivestiva dopo il duumviratus, come si vede anche nel caso del padre di Pudens [a.]. In certi casi, però, si ipotizza con ragione, che esistessero persone, che diventavano direttamente quinqennales, se avevano l’autorità debita. La quinquennalitas è seguita dall’indicazione di un decurionatus nel municipium di Apulum. Non è da escludere nenache ciò, che egli divenne decurio nel municipium Septimium Apulensium dopo il cursus a Sarmizegetusa, ma poté diventare il membro dell’ordo decurionum anche durante il cursus. Lo stesso vale anche per il patronatus a Porolissum, benché questo, per il suo carettere, poté accadere piuttosto dopo il cursus a Sarmizegetusa. Fu il patronus di più collegia, ma non si sa, di quali e dove, e nenache in quali città dell’elenco del cursus. Si ipotizzava, che fu il patrono magari dei collegia della colonia Aurelia Apulensium.cccxliv La costruzione del testo rende possibile anche l’idea, che patrocinasse più collegia di più città. Per una delle città esercitò anche la funzione occasionale di patronus causarum. Anche il patrocinio dei collegia si può inserire in un cursus municipale,cccxlv quindi cominciò a patrocinare collegia possibilmente non come ex quinquennalis. La carica del patronus causarum bisognava un’autorità grande e sicuramente anche professionalità e esperienze,cccxlvi cioé si può mettere cronologicamente dove è indicato nel cursus. Naturalmente non è da escludere la possibilità, che i compositori dell’iscrizione [b.] indicarono tutto in ordine cronologico, ma anche l’altra possibilità ha una probabilità simile, e quest’ultima sarebbe più realistica. Secondo i sopraddetti è da affermare, che i limiti cronologici per gli elementi della carriera dell’iscrizione [b.] – tranne per i due patronatus delle città e per il patronatus causarum – sono forniti dal cursus a Sarmizegetusa. La terza
MANUSCRIPT
iscrizione [c.] è solo l’inizio di una base eretta per il suo onore, su cui sono rimasti solo il suo nome e l’indicazione del rango equestre. Fu il parente dei M(arcii) Cominii di Sarmizegetusacccxlvii [D 45, 46] e di T. Varenius Sabinianus [D 76], la cui sorella si chiamava Varenia Probina. Il nome di Varenia Probina rinvia al nome di Probus, il padre di Pudens, quindi loro tre potevano essere fratelli, oppure, in base all’iscrizione relativamente tarda, i figli di Probina e Sabinianus Pudens. In base al flaminatus a Sarmizegetusa di Sabinianus [D 76] quest’ultima possibilità è più probabile. Riassumendo la sua carriera secondo i testi delle iscrizioni: dall’ultimo decennio del II secolo d. C. - [dec(urio)] colo[n(iae)(1)], fl(amen) coloniarum(1, 2), eq(uo) p(ublico), praef(ectus) coh(ortis) (militia secunda, militia tertia?) - eq(uo) p(ublico) a mil(itis), flam(en) colo[n(iae)(1)]. (rinunciato a uno dei flaminatus - flaminicius coloniae(2)), forse già dall’iinizio del III secolo d. C. (quaestor e/o aedilis, IIvir), q(uin)q(uennalis) col(oniae)(1), possibilmente già durante il cursus precedente dec(urio) [mu]nic(ipi)(1), patro[nus m]unic(ipi)(2), patro[nus] [colle]gior(um) (municipi/orum o colonia/e/rum?), patro[nus] [cau]sarum (municipi o coloniae?). Non ci sorprenderebbe, se un’iscrizione futura ci fornisse dati sul suo stato come sommo sacerdote della provincia.
D 76
T(itus) Varen(ius) T(iti) f(ilius) Pap(iria tribu) Sabinianus Sarcofago. Apulum. (Si presupponeva anche Sarmizegetusa come posto di ritrovamento). Allo sbocco di Ompoly nel fiume Maros, nel territorio della colonia Aurelia. Marosportó (Partoş). Sparito. Marsigli 1726, pl. 61; CIL, III, 1198; ILS, 8113; Kerényi 681, 1533; Trynkowski 1965, 377, nr. 4; Daicoviciu 1969, 389; Birley 1969, 82; Devijver 1976-1980, T 49; Balla 2000, 118, nr. 30; Ardevan 1992, 47-53; AÉ, 1993: 1333; Mrozewicz 1993, 219, nr. 3; Ardevan 365; Mrozewicz 1999, 78; IDR, III/5, 596; T(ito) Varen(io) T(iti) f(ilio) Pap(iria tribu) Sabiniano eq(uo) R(omano) | flam(ini) Laurentino item flam(ini) | col(oniae) Sarmiz(egetusae) dec(urioni) col(oniarum) Sar(mizegetusae) et Apul(ensis) | e(gregiae) m(emoriae) v(iro) omnib(us) milit(is) perfunc(to) | Cornel(ia) Lucilla coniux. Pila extruc|ta sarcofagum in quo Varenia | Probina q(uondam) Sabiniani soror condita | erat etiam eius corpore conloca|to superposuit. L’epigrafe sepolcrale è databile al secondo quarto del III secolo d. C. Il suo gentilicium capita oltre la Dacia solo nella Gallia, mentre il suo cognomen fu in uso in tutte le province europee tranne nella Germania.cccxlviii L’epigrafe sepolcrale contiene il suo cursus in un ordine più o meno discendente,cccxlix la cui cronologia è turbata dall’indicazione del rango equestre, dalla separazione della carriera civile da quella miltare, e dall’indicazione dei decurionatus all’inizio della sua carriera civile, davanti alla carriera miltare. È senza dubbio, che nacque a Sarmizegetusa in una famiglia di rango almeno di decuriones,cccl ma non è da escludere, che similmente all’evidente parente (forse il padre?) Pudens [D 75] fu il membro dell’ordine equestre già all’inizio della carriera. Per quanto riguarda i suoi decurionatus, l’elenco dell’epigrafe ci fornisce un punto di riferimento solo per quello, che era altrimenti evidente, cioé che divenne un vero partecipante delle attività dell’ordo decurionum dopo il servizio militare. Quindi all’inizio della carriera fu – in base all’indicazione del rango sociale – il membro dell’ordo decurionum e probabilmente anche di quello equestre, con questo stato cominciò il servizio militare. L’espressione omnibus militis perfunctus rinvia ipoteticamente – oltre la carica sicura delle tres militae – ad una militia quarta, rivestita in occasioni eccezionali. Dopo il servizio militare poté avere anche il titolo vir egregius, se non solo per pietà fecero incidere i suoi posteri quest’espressione, inserita in una formula. Durante la sua carriera municipale fu il decurio di due città. A Sarmizegetusa divenne il membro dell’ordo decurionum per la nascita, mentre ad Apulum poté diventare decurio dopo il servizio militare. Come decurio dell’ordine euqestre fu eletto il flamen di Sarmizegetusa,cccli poi divenne flamen Laurentinus. Quest’ultimo è sicuramente il nome semplificato della carica sacerdotale del flamen Laurentium Lavinatium di altre iscrizioni [cfr. D 8]. Nel caso di M. Procilius Niceta [D 70] la carica fu indicata come sacerdos Laurentium Lavinatium, ma nel suo caso il sacerdos sta per il flamen come una parola di significato generale per il sacerdote, altrimenti anche Niceta divenne il sacerdote di Laurens Lavinas dopo il flaminatus a Sarmizegetusa.ccclii La sua carriera promettente si rompe all’improvviso qui per la sua morte. Sua moglie, Cornelia Lucilla lo fece sepellire in un sarcofago comune con sua sorella, Varenia Probina. Il nome di Varenia Probina rinvia a Varenius Probus, che fu il padre anche di Varenius Pudens. Perciò è molto probabile che egli fu veramente un parente prossimo di Varenius Pudens [D 75]. In base all’epoca e al luogo potevano essere anche fratelli, ma sembra più probabile, che furono i figli di Probina e Sabinianus Pudens, in base alla datazione tarda della loro epigrafe sepolcrale. Riassumendo la sua carriera secondo il testo dell’epigrafe: dall’inizio del III secolo d. C. – dec(urio) col(oniae)(1), eq(ues) R(omanus), omnib(us) milit(is) perfunc(tus) - (tres militiae; militia quarta?), v(ir) e(gregius)?, dec(urio) col(oniae)(2), flam(en) col(oniae)(1), flam(en) Laurentinus.
D 77
[---]i Abraen(us?) Tavola. Sarmizegetusa, l’angolo sud-occidentale della città, l’area del cd. Dolichenum.
MANUSCRIPT
AÉ, 1927: 56; Daicoviciu 1924, 250; Sanie 1977, 146; AÉ, 1977: 668; IDR, III/2, 20; Szabó Á. 2004 (HPS), 139-161; [I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Dolicheno pro salute] | [D(omini) N(ostri) Imp(eratoris) Caes(aris) Divi Severi Pii nep(otis)] | [Divi Magni Ant]on[ini f(ili) M(arci) Aur(eli) Sev]|[eri [[[Alexandri]]] Pii [Fel(icis) Inv(icti) Aug(usti)] | [et num(eri) P]almyr(enorum) O[rientali(um)] | [---]i Abraen(us) Fl(avius) M[arianus] | [----] Cassi(us) Marinu[s ---] | [Ma]ximus Gora Lu[cianus] | [---] Maximus bar S[emon?] | [sace]rdot(es) templum [a solo] | ex suo fecer(unt). L’iscrizione è databile dopo il 222 d. C. In base all’elemento rimasto del nome, al posto del cognomen, venne da una delle province orientali dell’Impero, eventualmente dalla Palmyra.cccliii L’elemento nominale del gentilicium, che manca per lo stato frammentario dell’iscrizione, poteva essere una filiatio in base alla desinenza, quindi ci stava il nome del padre. In base alla dedicazione è probabile che fu il sacerdote di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus, e nell’epoca di Severus Alexander (222-235 d.C.) possedette sicuramente già anche la cittadinanza romana, anche se il suo nome non lo dimostra direttamente. Fecero costruire, insieme agli altri colleghi sacerdotali, il Dolichenum di Sarmizegetusa entro le mura, quindi entro il pomerium della città. Il fenomeno, che prima sarebbe stato impossibile, è spiegato con il fatto, che, anche se prima questo non è dimostrabile, nel secondo quarto del III secolo d. C., nell’epoca di Severus Alexander (222-235 d.C.) il culto di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus, interpretato come una delle forme della somma divinità del panteon romano, fu regolato dalle prescrizioni pontificali, cioé secondo la religione romana [cfr. per es. D 37]. Il luogo del tempio in sé stesso rinvia al sacerdotium ufficiale dei suoi sacerdoti. La sua attività nella Dacia, a Sarmizegetusa cominciò dagli anni ’10-’20 del III secolo d. C. Secondo i dati nell’iscrizione egli fu nel secondo terzo del III secolo d. C. cittadino romano e sacerdos Iovis Optimi Maximi Dolicheni nella Dacia, verosimilmente a Sarmizegetusa.
D 78
Antiochu(s) Altare. Apulum. Gyulafehérvár (Alba Iulia, Karlsburg), CIL - „Sárd Gasse in aedibus Iulii Turka”. CIL, III, 7791; Kerényi 1837; Angyal-Balla 1972, 93 nr. 2; CCID, 152; IDR, III/5, 223; Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 796; [I(ovi) O(ptimo) M(aximo)?] | Co[ns(ervatori)?] | [s]acrum per An|tiochu(m) sa|cerdos | loci. Sviluppando l’integrazione di Angyal-Balla, gli autori del CCID hanno pubblicato l’integrazione seguente: [I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) et Deo?] | Co[mmageno?] | [s]acrum per An|tiochu(m) sa|cerdos | loci. L’integrazione, in base al nome Antiochus e al titolo di sacerdos accanto al frammento CO, non è convincente. Il Locus dei santuari delle divinità curative,cccliv dove anche Antiochus fu sacerdos, è menzionato anche da altre iscrizioni. Nel Locus si trovava anche un santuario per Iuppiter Conservator:ccclv I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | Conservat(ori) | L(ucius) Ant(onius) Secun(dus, -dinus, -dianus?) | Aug(ustalis) col(oniae) Ap(ulensis) | in eis aedib(us) | natus cum | Celsina fil(ia) || v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito). In quest’epoca vissero nella Dacia molte persone dalla parte gerca, che portarono nomi greci. Tra di loro c’erano alcuni, che portavano il titolo sacerdos, mentre rivestivano anche altre cariche romane sacerdotali e amministrative [cfr. per es. D 12, 13]. Anche C(aius) Iul(ius) Metrobianus [D 57] fu il sacerdote di Aesculapius nel Locus. In base ai sopraddetti si deve modificare l’integrazione dell’iscrizione nella lettura sopraproposta. Inoltre è da notare, che il nome di Iuppiter Optimus Maximus D(olichenus) capitava anche con l’attributo Conservator.ccclvi L’iscrizione è databile al III secolo d. C. Il sacerdote fu al momento della dedicazione, se non già prima, un cittadino romano, il più tardi dopo il 212 d. C. Il suo nome di origine greca usato come cognomenccclvii è frequente nell’Italia settentrionale e capita in ogni provincia europea, tranne la Raetia, in gran numero nella Hispania, ma fu usato anche nell’Africa settentrionale.ccclviii Già nell’epoca romana era un nome storico, perciò non è adatto per la definizione sicura dell’etnico o dell’origine. Ebbe una carica sacerdotale nel Locus di Apulum, probabilmente presso l’istituto dell’aedes Iovis Conservatori. Secondo il testo dell’iscrizione conosciamo un elemento sicuro e un elemento presupposto della sua carriera: nel primo terzo del III secolo d. C. – (cittadino romano), sacerdos loci.
D 79
Marinu[s ---] Tavola. Sarmizegetusa, l’angolo sud-occidentale della città, l’area del cd. Dolichenum. AÉ, 1927: 56; Daicoviciu 1924, 250; Sanie 1977, 146; AÉ, 1977: 668; IDR, III/2, 20; Szabó Á. 2004 (HPS), 139-161; [I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Dolicheno pro salute] | [D(omini) N(ostri) Imp(eratoris) Caes(aris) Divi Severi Pii nep(otis)] | [Divi Magni Ant]on[ini f(ili) M(arci) Aur(eli) Sev]|[eri [[[Alexandri]]] Pii [Fel(icis) Inv(icti) Aug(usti)] | [et num(eri) P]almyr(enorum) O[rientali(um)] | [---]i Abraen(us) Fl(avius) M[arianus] | [----] Cassi(us), Marinu[s ---] | [Ma]ximus Gora Lu[cianus] | [---] Maximus bar S[emon?] | [sace]rdot(es) templum [a solo] | ex suo fecer(unt).
MANUSCRIPT
L’iscrizione commemorativa di una costruzione è databile dopo il 222 d. C. Secondo il suo nome freqeunte nell’ambito dolicheno, il quale qui sta al posto del gentilicium,ccclix venne nella Dacia da una delle province orientali dell’Impero, ma il nome è frequente anche nell’Africa settentrionale e nelle province occidentali.ccclx Fu il sacerdote di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus con il titolo di sacerdos, ma non si può dimostrare l’identificazione con gli altri sacerdoti della divinità di origine dolichena con il nome Marinus. Nell’epoca di Severus Alexander (222-235 d. C.) fu già sicuramente cittadino romano. Insieme agli altri colleghi sacerdotes fece costruire il Dolichenum di Sarmizegetusa entro il pomerium, cioé entro le mura della città. Il fenomeno si spiega con il fatto, che nell’epoca di Severus Alexander il culto di Ba’al–Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus, interpretato come una forma della somma divinità del panteon romano fu regolato probabilmente dalle prescrizioni amministrative o pontificali della religione romana [cfr. D 37]. Il posto del tempio rinvia all’impiego in circostanze ufficiali del sacerdote con il titolo di sacerdos, interpretabile anche dal punti di vista giuridica. La sua attività nella Dacia cominciò negli anni ’10-’20 del III secolo d. C. Secondo i dati dell’iscrizione egli fu nel secondo quarto o terzo del III secolo d. C. cittadino romano e sacerdos Iovis Optimi Maximi Dolicheni, verosimilmente a Sarmizegetusa.
D 80
[---] [---] Reginus Altare. Apulum. La fortezza (Cetate)di Gyulafehérvár (Alba Iulia, Karlsburg). CIL – „In aedibus Loew”. CIL, III, 7751; Domaszewski 1885, 246, nr. 4; ILS 7139; Opriş 1931, XV, nr. 137; Kerényi 806, 1197; Bărbulescu 1977, 175, nr. 8; Daicoviciu 1966, 161, nr. 32; Daicoviciu 1969, 393, nr. 32; Ardevan 347a; Szabó Á. (1999) 2000, 125-127; IDR, III/5, 94; [H]erculi | Aug(usto) | [---] Reginus | s[ac]erdos | [i]n[s]titutus ab | Hel(vio) Pertinace | [c]o(n)sulari. L’iscrizione è databile tra il 178 e 180 d. C. in base al periodo del luogotenente che lo investí.ccclxi Non conosciamo né il suo praenomen, né il gentilicium. Il cognomen è conosciuto nelle province occidentali, nella Pannonia per esempio fu portato da una persona di origine treveriana.ccclxii Verosimilmente ebba la cittadinanza romana. Secondo il suo titolo fu sacerdos, ma non indicò, il sacerdos di chi o di che cosa. La dedicazione a Hercules Augustus non significa automaticamente, che fu il sacredote di Hercules, una dedicazione simile può esser ben spiegata dalla simpatia del nuovo imperatore, Commodus, verso la divinità. È molto importante, che egli fu investito nella carica dal luogotenente, Publius Helvius Pertinax.ccclxiii In base a questo poté essere un sacerdos coloniaeccclxiv e l’investitura ebbe senza dubbio circostanze particolari. Rispetto alla data presumibile di fondazione della colonia Aurelia Apulensium,ccclxv egli dovette essere uno dei primi sacerdoti di uno dei culti in quel tempo cd. estranei della città, a quale carica i sacerdoti della tradizionale religione romana non furono adatti. Non si può escludere la possibilità, che esercitò una funzione proprio nel Locus di Apulum,ccclxvi dove oltre i santuari degli dei tradizionali c’erano anche quelli delle divinità integrate. L’inizio dell’unico elemento della sua carriera, quindi quello della carica sacerdotale è precisamente databile: come cittadino romano cominciò a portare il titolo s[ac]erdos (coloniae) e ad occupare quest’ufficio tra il 178 e 180 d. C.
D 81
[---]do[rus] Colonna. Ampelum. AÉ, 1983: 821; IDR, III/3, 299a; Wollmann 1996, 184; ---] | [---]do[rus?] | sacerdos te[mpli] | I(ovis) O(ptimi) M(aximi) D(olicheni) pro se et | suorumq(ue) o|mnium vot|um pos(uit). L’iscrizione è in parte integrabile. La sua lettura precedente dev’essere modificata, perché il tempio viene costruito, fatto, ecc., e non posto, senza paragone, come un altare, come si legge nelle letture precedenti, che ritenevano il gruppo di lettere ---]do[--- della 1ª riga il nome della divinità e integravano il frammento della 2ª riga come te[mplum]. Similmente, è molto rara l’indicazione della causa della dedicazione in caso della costruzione di un tempio. Il dedicatore fu ovviamente il sacerdos del Dolichenum locale. Il frammento DO della 1ª riga rimasta deve essere la parte del cognomen del sacerdote dedicatore e non l’inizio della parola ---] Do[lichenus. Come nome offre più possibili integrazioni, come ad es. Artemi]do[rus, Metro]do[rus, Helio]do[rus, ecc.ccclxvii Conformemente, anche lo scioglimento del nome della divinità cambia e diventa la parte di un’iscrizione composta in modo generale. L’iscrizione è databile alla fine del II e all’inizio del III secolo d. C. Il dedicatore dovette venire da una delle province di lingua greca, secondo la desinenza possibile del nome integrata in base alle due lettere rimaste: ---]do[rus]. In base al testo dell’iscrizione l’unico ufficio conosciuto è la carica sacerdotale nel Dolichenum di Ampelum: sacerdos te[mpli], possibilmente all’inizio del III secolo d. C.
D 82
MANUSCRIPT
[---] [---] Pap(iria tribu) [---]o ? Tavola. Sarmizegetusa. CIL, III, 7891; IDR, III/2, 131; Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 122; [---] Pap(iria tribu) | [---]o | [--- col(oniae) S]arm(izegetusae) | [--- e]quit(i) | [Rom(ano) ---]pri|[---s]acr | [---]is | [?---ob h]onor. | [?--- flam]oni | [?---IIvi]ral(i) | [---]lli | [---]mi | [---]os | [--- or]nam. | [?dec. col. --- Sar]miz(egetusae) | [--- patrono? opti]mo L’iscrizione è databile sia al II che al III secolo d. C., ma in base al tipo di scrittura piuttosto alla prima metà del III secolo. Fu un eques romano sconosciuto e verosimilmente decurio, che ebbe diverse cariche a Sarmizegetusa. Tra l’altro rivestì la carica del flamen coloniaeccclxviii e poi probabilmente quella del IIvir coloniae. Quest’ultima presuppone, che fece anche una magistratura bassa, quindi fu quaestor o aedilis. L’indicazione della carica di flamen in forma [flam]oni rinvia verosmilmente al fatto, che donò qualcosa ob honorem [flam]oni, il che egli riteneva degno rendere immortale ripetutamente (se la lettura del testo è corretta nella pubblicazione). Ma lo spazio grande tra il [?---ob h]onor e il [?--- flam]oni rende incerta anche questa interpretazione. La larghezza rimasta di 25 cm del frammento e quella proposta della ricostruzione di ca. 50 cm sembra troppo sproporzionata rispetto all’altezza originale di 150 cm, perciò l’iscrizione dovette essere in realtà più larga. Per la ricostruzione totale del testo mancante non c’è attualmente nessuna proposta. Fu probabilmente il patronus del dedicatore dell’iscrizione. Il cognomen del dedicatore ha una desinenza ---]os, quindi si tratta di una persona della parte greca dell’impero,ccclxix un libertus oppure Augustalis, che acquistò il diritto di portare l’ornamenta decurionalia a Sarmizegetusa. In base ai frammenti si ricostruisce ipoteticamente la seguente carriera: nella prima metà del III secolo d. C. – [?(decurio) col(oniae)], [e]ques [Rom(anus], [(quaestor e/o aedilis?)], [flam]en, (IIvir) [IIvi]ral(is) col(oniae).
D 83
[---] [---] [---] Tavola (?). Sarmizegetusa. Sparita. CIL, III, 7962; ILS 7130; Daicoviciu 1969, 388 nr. 4; IDR, III/2, 353; Ardevan 166; ---] | [--- municip]|iorum Porolis(sensium) et | Tibisc(ensium) sacerdotal(is) | provinciae | donum dedit. La sua iscrizione è databile all’inizio del III secolo d. C. in base alla fondazione dei due insediamenti menzionati. Non si può determinare, che cariche rivestì nel municipium Septimium Porolissensium e nel municipium Septimium Tibiscensium, fondati all’inizio del III secolo d. C. Secondo l’unico ufficio leggibile fu il sommo sacerdote della provincia con il titolo di sacerdos provinciae. Poiché la parola sacerdotalis dell’iscrizione rinvia alla carica di sommo sacerdote già finita, egli dovette agire come sommo sacerdote precedentemente, e non è da escludere, che ancora prima della fondazione di Porolissum e Tibiscum, all’inizio del III secolo d. C.ccclxx Il posto di ritrovamento dell’iscrizione è Sarmizegetusa. Naturalmente, un sommo sacerdote poté dedicare un’iscrizione nella sede del consiglio provinciale durante l’anno dell’ufficio, ma qui si tratta di un ex sommo sacerdote, che fece erigere quest’iscrizione dopo la sua carica, ma non si sa, quanto dopo. Il fenomeno può rinviare a ciò, che egli visse e fu impegnato originalmente a Sarmizegetusa, e divenne là sommo sacerdote, e acquistò cariche nei due municipia menzionati dopo la loro fondazione. Se con il rimando alla carica di sommo sacerdote volle indicare solo il suo rango, è naturale, che questo sta alla fine del testo, come la carica più alta che egli avesse: nel momento della dedicazione questo fu un elemento, che indicava soprattutto il suo rango e l’appartenenza eterna al consiglio provinciale. I sommi sacerdoti erano in generale omnibus honoribus functi, perciò anche lui dovette avere un cursus intero almeno in un insediamento, quindi dal decurionatus attraverso la quaestura e/o aedilitas fino al IIviratus, magari fino all’ufficio quinquennalis, e poté rivestire anche altre cariche sacerdotali municipali. Inoltre poté accettare impieghi anche in altre città, che era frequente nella Dacia. Non è da escludere nemmeno la sua appartenenza all’ordine equestre, in base a ciò, che la maggior parte dei sommi sacerdoti conosciuti fu il membro dell’ordo equester. In base al frammento dell’iscrizione nel suo caso si può schizzare solo un modello di carriera, secondo ciò dall’ultimo terzo del II secolo d. C.: (decurio, quaestor e/o aedilis, IIvir, magari quinquennalis, pontifex o augur o flamen coloniae ?, equo publico ?, sacerdos provinciae, possibilmente già durante il cursus precedente decurio e magistratus?) --- municip]iorum(1,2), sacerdotal(is) provinciae.
D 84
[---] [---] [---] Altare. Samum.
MANUSCRIPT
CIL, III, 828; Balla 2000, 173-176; AÉ, 1982: 835; Sanie 1989, 1258, nr. 69; Ardevan 479; Gudea-Tamba 2001, 44, 116 nr. 3, 48 120, nr. 6; ILD 770; [I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D]ol(icheno) pro sal(ute) d(omini) n(ostri) Aug(usti) | [---] pont(ifex) m(unicipi) S(eptimi) P(orolissensis) et Antiochian┌u┐s | [---]p? [---]sae | [--- Nella 2ª riga Antiochiands invece di Antiochianus. Nell’insediamento sono conosciute altre tre iscrizioni in connessione con il culto di Iuppiter Optimis Maximus Dolichenus.ccclxxi Due di loro sono databili precisamente al 243 d. C.ccclxxii e al periodo verso il 224 d. C.,ccclxxiii dato che il dedicatore di quest’ultima fece erigere un’altra iscrizione verso il 224 d.C.ccclxxiv Anche l’altare del pontifex sconosciuto dovette esser eretto nello stesso periodo, più precisamente dopo il 212 d. C., secondo il testo che menziona un solo imperatore, e in base alle iscrizioni sopramenzionate similmente forse durante il regno di Severus Alexander (222-235 d.C.). Fu il pontifex del municipium Septimium Porolissensium nei primi decenni del III secolo d. C. È molto probabile che fu il membro anche dell’ordo decurionum della città. Secondo il testo dell’iscrizione gli elementi conosciuti e presupposti della sua carriera sono i seguenti: nel secondo quarto del III secolo d. C. – (decurio?) [---?], pont(ifex) m(unicipi).
D 85
[---] [---] [---] Tavola. Potaissa. Rotta in due (tre?). CIL, III, 7688; EE, IV, n. 138; Bărbulescu 1994, 50; Ardevan 427a; Szabó Á. 1999 (2000), 119-150; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 108-109, nr. 3; Nemeti 2007, 229-234;
[- - - sac]erdotalis Daciae - - - ]ius ex dup Aur Iulianus Aur Anici
- - - ]nes Aur Statilius ex dup Aur Firmidiu
- - - ]nus Aur Valens Ael Aufidius
ex dup Aur Valens Aur Victorinus ex eq
- - - ]us Sep Alexander ex dup Aur Verus ex eq
- - - ]s Val Valens Aur Firmus ex dup
Aur Vict - - - ]us ex dup Aur Flavianus ex imm Aur Maximinus
Aur Farnax - - - ]ex dup Aur Viatorinus Aur Sedatus ex mil be
ex c]a Aur Lucilius ex opt Aur Vital[ - ]ex dup Aur Crispus Aur Crescens
Aur Gaianus Aur Celsus [ - ]ex dup Aur Verus Aur Iulius ex betri
ex s]pec Aur Mucianus ex ca Aur Valeria[ - ]em g n Aur Maximus ex arc Aur Quintillianus
ex ] dup Aur Maximus ex ca Aur Sabin [ - - - ] Aur Petr Marcianus ex lib
ex ] opt Ael Cassius ///il Sep Crisi[ - - - - ]cad Ael Valerius ex ca Aur Valetinus ex tui
ex ] opt Aur Lucius ex c a Ael Lu[ - - - - ]oup Aur Domnio ex imm Ael Maximia ex tess
ex ] dup Aur Agrippa ex c a [ - - - - ]opt Aur Valerius Sfi Volusius
[?eq(ues) Roman]us vet(eranus) ex b(ene)f(iciario) leg(ati) m[- - - ]ra ex suo posuit Per l’integrazione b(ene)f(iciarius) leg(ati) dell’ultima riga è un’ottima analogia un altare di Potaissa dedicato a Iuppiter Dolichenus, il cui dedicatore indicò la sua carica allo stesso modo: I. O. M. | Do. Ti. | Tint. bf. leg. | v. s. l. m.ccclxxv . L’integrazione dell’inizio della riga inferiore è proposta solo in base al titolo di sommo sacerdote della riga superiore, tenendo in considerazione anche le caratteristiche della costruzione del testo e in base a ciò, che la maggior parte dei sommi sacerdoti fu il membro dell’ordine equestre. L’iscrizione è databile all’inizio del III secolo d. C., al massimo all’inizio del secondo decennio in base ai gentilicia delle singole persone elencate. Il dedicatore indicò solo alcuni elementi del proprio cursus, in parte quelli, che mostravano il suo stato sociale (l’indicazione del rango della sua carica di sommo sacerdote di una volta, e in connessione con esso la sua appartenenza presupposta all’ordine equestre) e in parte quello, che fu in connessione con la causa della dedicazione, cioé il suo stato veteranus ex beneficiario legati, che dovette essere in rapporto con i sottoufficiali veterani e con i soldati elencati. La riga superiore e quella inferiore contengono gli elementi indicati della carriera in ordine discendente. In base a questo e al posto di ritrovamento dell’iscrizione fu verosimilmente il beneficiarius del legatus della legio V Macedonica di Potaissa e molto più tardi, al momento della dedicazione, il membro dell’ordine equestre. Quest’ultimo è l’elemento più incerto dell’integrazione proposta, presupponibile però con ragione. In base al suo stato di sommo sacerdote dovette diventare il membro dell’ordine equestre durante la carriera intera municipale oppure piuttosto dopo, ma è improbabile, che come veteranus ex beneficiario legati. Non è lui l’unico beneficiarius, che percorse una carriera municipale, e poi riuscì a salire nell’ordine equestre.ccclxxvi Nella Dacia, a Sarmizegetusa si conosce un ex beneficiarius consularis, che dopo il suo congedo salì fino al IIviratus.ccclxxvii Nella sua carriera quindi si può inserire anche un cursus intero municipale, tenendo in considerazione il fatto, che i sommi sacerdoti furono omnibus honoribus functi. Il luogo delle magistrature municipali fu possibilmente Potaissa secondo il posto di ritrovamento dell’iscrizione, il che è sostenuto anche da ciò, che fece erigere l’iscrizione come ex sommo sacerdote, quindi molto probabilmente come un abitante vicino al posto della sua funzione di una volta. La dedicazione in connessione con un ambiente militare e la costruzione della
MANUSCRIPT
m[armo]ra con iscrizione rese superflua qualsiasi indicazione di cariche municipali, ma proprio per questo fu indicato il suo stato di veteranus. Secondo la carica indicata prima, che fu l’ultima cronologicamente, salì fino alla carica di sommo sacerdote della provincia con il titolo sacerdos Daciae, ma questo accadde prima della dedicazione, poiché nella 1ª riga del testo si presentò come ex sommo sacerdote (sacerdotalis). La sua carica di sommo sacerdote cadde alla fine del II secolo, al massimo all’inizio del III secolo d. C.ccclxxviii Lo stato sacerdotale di una volta esprimeva il suo rango, come anche il rango equestre acquistato prima del titolo di sommo sacerdote esprimeva il suo stato sociale raggiunto. Secondo una recente teoria un terzo frammento aderisce ai due precedenti conosciuti. Secondo l’interpretazione di tutti i tre frammenti insieme, l’autore propone la datazione dell’iscrizione alla seconda metà del III secolo d. C. I due frammenti precedenti e il nuovo terzo possono formare una possibilità epigrafica, ma la connessione tematica dei primi due e del nuovo terzo accompagnato non è chiara.ccclxxix Ricostruendo e riassumendo la sua carriera secondo gli elementi conosciuti: nell’ultimo terzo del II secolo d. C. – (servizio militare, beneficiarius) vet(eranus) ex b(ene)f(iciario) leg(ati), (decurio, quaestor e/o aedilis, IIvir municipi o coloniae?), [?eq(ues) Roman]us (?); alla fine del II secolo, magari all’inizio del III secolo d. C. – (sacerdos Daciae = sacerdos provinciae); all’inizio degli anni ’10 del III secolo d. C. – [sac]erdotalis Daciae. Con il nuovo frammento la datazione si metterebbe al tempo dopo la metà del III secolo d. C. A quest’epoca converrebbe anche il titolo del sommo sacerdote, v. sotto.
D 86
[---] [---] [---] Epigrafe sepolcrale. Potaissa. Sóvárad. CIL, III, 7717a; Ardevan 1992, 47-53; ---] | [---]luc[---] | [---Fla?]viae [---] | [---] fl(amen) Na[p(ocensium) ---] | [b(ene)] m(erenti) p(osuit) [---. L’epigrafe è databile al II secolo d. C. L’iscrizione della persona napocense è stata ritrovata nel territorio di Potaissa. Se non in un altro modo, questo si può spiegare con ciò che il territorio di Sóvárad si trovava nel territorium di Napoca oppure il defunto rivestì cariche anche a Potaissa oppure ebbe poderi là. Il dedicatore fu il flamen di Napoca.ccclxxx Nel II secolo d. C. poté essere sacerdote sia nel municipium che nella colonia, in base al testo non lo si può decidere. Il nome Na[p(ocensium)] senza il rango di città rinvia forse al periodo municipale, dato che conosciamo parecchi flamines, che indicavano lo stato coloniale, mentre il numero di quelli del municipium, i quali lo facevano similmente, è insignificante. Malgrado tutto ciò in base ai dati disponibili non si può decidere la domanda. Sembra più probabile però il suo impiego municipale. Schizzando gli elementi presupposti e conosciuti della carriera, secondo il frammento del testo: durante il II secolo d. C., dal regno di Marcus Aurelius – fl(amen) (municipi?).
D 87
[---] [---] [---] Altare. Germisara (IDR, Ardevan). AÉ – Almaşu de Mijloc. AÉ, 1971: 367; IDR, III/3, 245; Ardevan 1981, 437-442; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 274; ---] | decurialis tri|bunicius trib(unus) | leg(ionis) XII Fulmin(atae) | praef(ectus) coh(ortis) III Cyr(enaicae) | flamen col(oniae) praef(ectus) | q(uin)q(uennalis) pro Impp(eratoribus) | Antonino et Vero | Augg(ustis) aedilic(ius) dec(urio) | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). L’iscrizione è databile tra il 161-169 d. C., oppure magari un po’ dopo. Il dedicatore sconosciuto fu il membro dell’ordo equester. Questo deriva dalle cariche militari indicate. Possibilmente fu di Sarmizegetusa. Nell’iscrizione frammentaria il cursus si legge diviso in due gruppi, in cui sono separati gli elementi della carriera municipale, elencati in ordine discendente, e gli uffici militari elencati in ordine discendente, e poi la funzione nella città di Roma, probabilmente posteriore. I due gruppi invece sono sistemati in ordine ascendente, poiché è da escludere, che cominciò la sua carriera militare dopo il cursus intero municipale. Così le cariche di carattere militare e fuori la Dacia sono anteriori, seguite dalle stazioni elencate del cursus municipale. Di tutti e due gruppi si distinguono gli elementi che indicano il suo stato sociale, quindi il decurionatus e l’appartenenza all’ordine equestre. Egli li dovette avere già da giovane, a causa del retroscena familiare, ma fece scrivere lo stato equestre evidentemente dopo il nome, come l’indice dello stato appartenente al dato gruppo di cursus. In base ai sopraddetti dovette nascere in una famiglia dell’ordo decurionum di Sarmizegetusa e salire presto nell’ordine equestre. Intraprese la carriera militare e rivestì le due cariche della militia equestris: la cohors-praefectura e il legio-tribunatus. Poi segue una carica civile secondo la lettura possibile del testo, quindi non continuò il servizio militare, oppure se lo continuò, queste cariche erano sulla parte rotta dell’elenco, in base alla cronologia dell’iscrizione. Ma lui non è l’unico tra i sacerdoti dacici, che fece solo due militiae, così non è da escludere, che fu congedato anche lui dopo la legio-tribunatus [cfr. ad es. D 53]. Anche la struttura del testo dell’iscrizione appoggia questa possibilità, dato che dopo il servizio militare divenne
MANUSCRIPT
decurialis tribunicius, quindi diventò il membro del corpo dei decuriones della città di Roma. In questa qualità dovette assumere uffici a Sarmizegetusa, quindi prima divenne aedilis, poi, tra il 161 e 169 d. C. sostenne la carica quinquennalis della città con il titolo di praefectus al posto degli imperatori eletti quinquennales.ccclxxxi Sembra che precedentemente non fu IIvir, dato che lo avrebbe fatto indicare nell’iscrizione, come lo fece con l’aedilitas. È possibile, che il suo IIviratus cadde proprio all’anno quinquennalis, e così divenne direttamente quinquennalis, quindi un superiore della città con il titolo di praefectus al posto degli imperatori eletti. Benché la carica quinquennalis fosse un onore più grande del IIviratus, e la quinquennalitas fosse spesso preceduta dal IIviratus, in questo caso il IIviratus non fu – verosimilmente – la condizione giuridica della carica quinquennalis, oppure questa regola, se esisteva, non lo riguardava per il suo stato speciale come sostitutore. Non è da escludere, che una persona con certa autorità e rango potesse essere eletta direttamente quinquennalis, dopo aver adempiuto le condizioni del IIviratus. Sono conosciute parecchie iscrizioni nella Dacia, dove il IIviratus prima della carica quinquennalis non è indicato nel cursus relativamente dettagliato.ccclxxxii La quinquennalitas della sua iscrizione rinvia a due persone, quindi fu praefectus al posto di due quinquennales. Il fenomeno rinvia al fatto, che a Sarmizegetusa ambedue i duumviri del quinto anno si chiamavano quinquennales, come più tardi anche ad Aquincum.ccclxxxiii Secondo la fondazione di Sarmizegetusa tra il 106 e 108 d. C.ccclxxxiv egli poté essere quinquennalis nel 161-162-163 oppure nel 166-167-168. Dopo la carica quinquennalis fu eletto il flamen della colonia.ccclxxxv Riassumendo la sua carriera: verosimilmente dagli anni ‘140 d. C. – dec(urio) col(oniae), [equo publico o eques Romanus], praef(ectus) coh(ortis), trib(unus) leg(ionis), decurialis tribunicius [---?], (aedilis) aedilic(ius) col(oniae), tra il 161 e 169 d. C. praef(ectus) q(uin)q(uennalis), poi flamen col(oniae), (---?). Non ci sorprenderebbe un’iscrizione che dimotrasse la sua carica di sommo sacerdote.
D 88
[---] [---] [---] Frammento di una tavola. IDR, III/2, 146; Daicoviciu 1924, 245; Ardevan 1992, 47-53; Ardevan 140; ---] | [--- de]c(urio) flam[en ---] | [--- L’iscrizione è databile sia al II che al III secolo d. C. Nel frammento si possono leggere solo il rango di decurio e la carica di flamenccclxxxvi del dedicatore sconosciuto, sicuramente in ordine cronologico. Versomilmente aveva anche altri uffici. Riassumendo le due stazioni del cursus frammentario, nell’ordine delle sue indicazioni anche nell’iscrizione: nel II o nel III secolo d. C. (?) – [de]c(urio), flam[en], [---?] [coloniae].
D 89
[---][---][---]
Frammento di un’epigrafe sepolcrale. Napoca. Kolozsvár. In posizione secondaria, sparita. CIL, III, 6252; Ardevan 2000, 113-117, nr. 2. Abb. 3; AÉ, 2000: 1241; ILD 570; ---] | [?--- fla]m[en col(oniae)] | [Nap(ocensis) d]ec(urio) et patro[n(us) coll(egi)?] | [--- ? vi]xit anni[s ---?] | [Val]entina mar[ito suo] | [f]aciendum [curavit]. L’epigrafe è databile al primo terzo del III secolo d. C., in base ad argumenti epigrafici. Il testo contiene solo alcuni elementi del cursus, e non in ordine cronologico. Fu il decurio e il flamenccclxxxvii della colonia di Napoca. L’integrazione patro[n(us) col(oniae)? | s(upra) s(criptae) v]ixit finora presupposta delle 2ª e 3ª righe si può mettere in dubbio, dato che si conoscono relativamente poche e basse cariche per il patronatus di una città. I patroni locali della Dacia avevano in generale una ricca carriera municipale e la maggior parte di loro rivestiva anche cariche militari equestri.ccclxxxviii A causa della struttura dell’iscrizione non ci poteva essere un testo lungo prima del [--- fla]m[en col(oniae), e per questo non si può presuporre l’indicazione di molti uffici e ranghi. Le cariche leggibili bastano al massimo per ipotizzare il patronatus di un collegium. A Napoca c’erano parecchi collegia, egli poteva patrocinare qualunque di loro.ccclxxxix La lettura invece rimane incerta, l’elenco di cursus, schizzato in base alle integrazioni, differisce notevolmente dalla forma solita. L’integrazione e la lettura delle 2ª e 3ª righe devono essere modificate secondo i sopraddetti: : patro[n(us) coll(egi)? | ---? v]ixit anni[s - - -. In base agli elementi ricostruabili dal testo frammentario una parte della sua carriera si svolse come segue: nel primo terzo del III secolo d. C. – d]ec(urio) (coloniae), patro[n(us) coll(egi)?---?], [fla]m[en col(oniae)] [---?.
D 90
Atennais
MANUSCRIPT
Tavola. Drobeta. ILD 53; Petolescu 2004, pp. 38-45; Petolescu 2003-2004, 1001; AÉ 2004: 1222; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) [D(olicheno)] | pro sal(ute) im|pp(eratorum) et c(o)hor|tis pri(mae) Sag(ittariorum) | Silvanus | Flavius et A|tennais sa|cer(dotes) c(o)ho(rtis) s(upra) s(criptae) | ex v(oto) p(osuerunt). L’iscrizione si data all’inizio del III secolo, fino al 209 d. C. La truppa menzionata fu di stanza a Drobeta nella prima metà del III secolo d. C..cccxc I due imperatori, a cui salute l’iscrizione fu dedicata, sono Septimius Severus (193-211 d. C.) e Caracalla (212-217 d. C.), quindi l’altare venne eretto nel tempo comune del loro regno, tra il 197 e 209 d. C.cccxci Il nome di Atennais meno frequente è orientale, e dimostra verosimilmente la sua origine dalla parte greca dell’Impero.cccxcii Verosimilmente non ebbe la cittadinanza romana. Poteva essere impegnato ufficialmente con altri due colleghi nel santuario costruito per Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus nel vicus presso il campo della truppa menzionata, similmente ai tre colleghi posteriori a Porolissum [D 26, 30, 31].
Secondo il testo dell’iscrizione si conoscono i seguenti della sua carriera: alla fine del II secolo e all’inizio del III secolo d. C. fino al 209 d. C. – peregrinus, sacer(dos) c(o)ho(rtis).
D 91
Flavius Tavola. Drobeta. ILD 53; Petolescu 2004, 38-45; Petolescu 2003-2004, 1001; AÉ 2004: 1222; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) [D(olicheno)] | pro sal(ute) im|pp(eratorum) et c(o)hor|tis pri(mae) Sag(ittariorum) | Silvanus | Flavius et A|tennais sa|cer(dotes) c(o)ho(rtis) s(upra) s(criptae) | ex v(oto) p(osuerunt). L’iscrizione si data all’inizio del III secolo d. C., fino al 209 d. C. La truppa menzionata fu di stanza a Drobeta nella prima metà del III secolo d. C.,cccxciii quindi l’abbreviazione impp. può rinviare solo a Septimius Severus e Caracalla, quando furono insieme Augusti tra il 197 e 209 d. C.cccxciv Il nome del sacerdote è verosimilmente un elemento cognominale, che fu diffuso nell’area danubiana.cccxcv La causa dell’indicazione del nome di un solo elemento può essere la mancanza della cittadinanza romana, oppure – meno probabilmente – il suo uso come nome sacerdotale. Non è adatto a determinare l’origine etnica. Solo il fatto, che conosciamo altri sacerdoti di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus con lo stesso nome può rinviare ad un origine siriaca.cccxcvi Poteva essere impegnato ufficialmente con altri due colleghi nel Dolichenum del vicus presso il campo della truppa menzionata con il titolo di sacerdos, similmente ai tre colleghi posteriori a Porolissum [D 26, 30, 31]. Secondo il testo dell’iscrizioni sono conosciuti i seguenti della sua carriera: alla fine del II secolo e all’inizio del III secolo d. C. fino al 209 d. C. – peregrinus, sacer(dos) c(o)ho(rtis).
D 92
Silvanus Tavola. Drobeta. ILD 53; Petolescu 2004, 38-45; Petolescu 2003-2004, 1001; AÉ 2004: 1222; I(ovi) O(ptimo) M(aximo) [D(olicheno)] | pro sal(ute) im|pp(eratorum) et c(o)hor|tis pri(mae) Sag(ittariorum) | Silvanus | Flavius et A|tennais sa|cer(dotes) c(o)ho(rtis) s(upra) s(criptae) | ex v(oto) p(osuerunt). L’iscrizione si data all’inizio del III secolo d. C., fino al 209 d. C. La truppa menzionata fu di stanza a Drobeta nella prima metà del III secolo d. C.,cccxcvii quindi i due imperatori menzionati generalmente sono Septimius Severus e Caracalla, e più precisamente durante il loro regno comune tra il 197 e 209 d. C.cccxcviii Il nome del sacerdote è conosciuto sia nell’ambiente orientale-greco che in quello occidentale-latino.cccxcix In questo caso non è adatto a determinare l’origine etnica. Come sacerdote di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus, egli poté venire con maggior probabilità da un ambiente orientale, ma poté essere nato anche al posto. Poteva essere impegnato ufficialmente con altri due colleghi nel Dolichenum del vicus presso il campo della truppa menzionata – quindi giuridicamente appartenente al campo –, con il titolo di sacerdos, similmente ai tre colleghi posteriori a Porolissum [D 26, 30, 31]. Secondo il testo dell’iscrizione sono conossciuti i seguenti della sua carriera: alla fine del II secolo e all’inizio del III secolo d. C. fino al 209 d. C. – (peregrinus), sacer(dos) c(o)ho(rtis).
MANUSCRIPT
D 93
Quattro frammenti di una tavola. Sarmizegetusa. Forums vetus. Piso 2006, nr. 61; [- - -] | [- - -] dec(urio)? c]ol(oniae) ex? [- - -] | [- - -]tus C?[- - -] [fla]men et q(uin)q(uennalis [col(oniae) - - -] | [praef(ectus) c]o[l]l(egii) fa[b]ru[m - - -] | [- - -] co[- - - - - -. In base alla forma delle lettere, più precisamente alle aste inferiori lunghe delle lettere Q l’iscrizione è databile alla seconda metà del II secolo d. C. Il sacerdote sconosciuto con il rango di decurio divenne flamen prima della carica quinquennalis, quindi verosimilmente dopo un cursus intero. Se il suo IIviratus cadde proprio al quinto anno, divenne quinquennalis, ma può darsi, che fu eletto quinquennalis come ex IIvir. Dopo la carica quinquennalis indicò l’ufficio di praefectus del collegium fabrum. Siccome quest’ultimo non apparteneva al cursus honorum, non si può determinare la sua cronologia. È possibile, che l’elenco segua una cronologia vera e il magistratus di Sarmizegetusa con grande rispetto venne eletto praefectus dopo l’ufficio quinquennalis. Riassumendo la sua carriera secondo i frammenti del testo dell’iscrizione: nella seconda metà del II secolo d. C. – dec(urio)? c]ol(oniae) (quaestor e/o aedilis, IIvir?), [fla]men [col(oniae)], q(uin)q(uennalis [col(oniae)] (- - -?), [praef(ectus) c]o[l]l(egii) fa[b]ru[m - - -].
MANUSCRIPT
Iscrizioni incerte
- cariche sacerdotali indimostrabili -
D a
(H)ermio Sicaus* Altare. Potaissa. Torda (Turda). CIL – „Ex Harkányanis”. Sparito. CIL, III, 45*; ZAMOLXI? | [I(ovi)?] O(ptimo) M(aximo) | G o C et P(---?)P(---?) o R(---?) | (H)ermid(o, -us, -ius?) o (H)ermio Sigaus o Sicaus | sac(erdos) eiu(s) | v(otum) s(olvit) Contiene troppi sbagli e troppe accidentalità formali per essere una falsificazione. Si può trattare di un originale interpolato. La dedicazione e le ultime due righe dell’iscrizione sono totalmente formali. Non conosciamo invece nessun’altra dedicazione a Zamolxis dacico-geta, i suoi fedeli non arrivarono teoreticamente alla fondazione della provincia romana. Il copiatore istruito poté sostituire qualsiasi nome illegibile con Zamolxis in base agli autori antichi, se la 1ª riga esisteva e non solo il copiatore vide lettere inesistenti per esempio sul bordo. Le abbreviazioni O. M. sono le abbreviazioni degli attributi O(ptimus) M(aximus) di Iuppiter indicato caratteristicamente con una sola I. La 3ª riga offre varie possibili integrazioni, ma la più probabile è che le lettere difficilmente leggibili di uno degli attributi della divinità menzionata nella riga precedente, le quali furono scritte continuamente, vennero copiate in questa forma, oppure almeno la prima lettera, la G o C poté appartenere ad un altro attributo, seguito da un et e poi il nome di un’altra divinità. Secondo ciò la 4ª riga sarebbe il nome del sacerdote dedicatore. L’Ermid desidera un’H che lo precede, così riceviamo anaolgie per vari nomina reali. Se riteniamo la D come la copia sbagliata di una O, le possibili interpretazioni del nome reale si moltiplicano tramite gli esempi della Moesia Inferior, Moesia Superior, Dalmatia, Italia e Gallia Narbonensis.cd Cognomina con la radice Sic- o Sig- sono conosciuti dalla Moesia Inferior, Moesia Superior, Dalmatia, Italia e Gallia Narbonensis, ecc.cdi A Potaissa capitano anche i nomi Hermadiocdii e Hermias.cdiii L’iscrizione si trova nel CIL tra le falsificazioni di Potaissa. Se si tratta di un originale interpolato, il testo menziona un sacerdos di Potaissa. Il suo sacerdotium appartiene alle divinità ? [I.] O. M. ? G. o ? C. et ? P(---) ? P(---) o ? R(---). Con l’attributo con C si conosce nella Dacia ad esempio il I. O. M. Cimisthenus dell’Asia Minore, ma la divinità suprema aveva anche altri attributi con C, come Conservator, Culminalis, ecc. Sono conosciute similmente molte divinità con la P. L’iscrizione è databile sia al II che al III secolo d. C. Il nome si può autenticare con un’interpretazione giusta, il titolo sacerdotale è accettabile in questa forma. Verosimilmente ebbe la cittadinanza romana, e fu il sacerdos di una divinità con nome inidentificabile. Il testo tramanda i seguenti della sua carriera: sac(erdos) [I(ovis)] O(ptimi) M(aximi) - - -?
D b
T(itus) Laelius T(iti) f(ilius) Vet(urius)* Iscrizione di un altare. Apulum. CIL – „Albae Iuliae in suburbio ad fanum Valachorum”. Sparito. Zamosius, Analecta (ed. 1598 sine l.) 26; CIL, III, 55*; T(itus) Laelius T(iti) f(ilius) Vet(urius) | flamen | sac(erdos) R(omae) | col(oniae) Apul(ensium) aram | hanc Romae con(plevit) | p(ecunia?) s(ua?) f(ecit?) c(onsecravit?). Benché l’iscrizione si trovi nel CIL tra le falsificazioni, è ben interpretabile. Si conosce solo tramite una copia, per questo non si può affermare quanto è frammentaria. Secondo la pubblicazione del CIL, nella 3ª riga è persa la seconda sigla Q dopo la visibile Q presupposta, per una rottura oppure durante la copia, se si tratta dell’abbreviazione del quinquennalis. Se si tratta di quella di quaestor, basterebbe una sola Q, ma sarebbe strana questa abbreviazione. È un’ipotesi meno possibile, che questa Q precisasse l’abberviazione sac. In questo caso dovremmo presupporre il nome di una divinità inidentificabile. Il testo notato da Szamosközi (Zamosius) invece offre una variante più plausibile di quella pubblicata nel CIL, che contiene lo scioglimento della variante di Szamosközi. Nella 3ª riga Szamosközi ha copiato le abbreviazioni sac. R., che nel testo sciolto ha interpretato come sacerdos Quirinalis, che si capisce bene: considerando la R come la prima lettera di Romulus ha interpretato le abbreviazioni del testo come flamen Quirinalis, quindi del culto del primo re nella città di Roma, adorato come dio con il nome Quirinus. La lettera R invece può essere sciolta come R(oma), così riceviamo uno scioglimento sacerdos R(omae), una funzione sacerdotale reale nella provincia. La possibilità è chiaramente appoggiata anche dalla dedicazione dell’altare a Roma. Il paragone più vicino della funzione si conosce in un’iscrizione di Serdica, nella Thracia.cdiv Verosimilmente la funzione sacerdotale non è in connessione con il culto di Urbs Roma Aeterna dell’epoca Severiana,cdv neanche l’esempio della Thracia, anche se si conosce un altare di Sarmizegetusa, la cui dedicazione contiene anche Roma Aeterna.cdvi Le tre funzioni indicate possono essere localizzate tramite la parola coloniae. Secondo ciò si può ipotizzare in base all’iscrizione un culto municipale di Roma in connessione con il culto imperiale nella colonia di Apulum, cioé dopo il
MANUSCRIPT
180 d. C. Per l’identificazione del nome del dedicatore si può menzionare un nome femminile simile in un’iscrizione di Apulum,cdvii Lael{l}ia Cu|rill<i>a che è sta vicino a Laelius della pubblicazione di CIL in confronto alla variante Laevius secondo Szamosközi. Inoltre si conoscono un L. Lael(ius) Terentia|nus dec. col. in un’iscrizione di Napocacdviii e una persona chiamata Lelius in un’epigrafe di Alsó-Ilosva (Ilişua).cdix La sua iscrizione ritenuta falsificazione, è databile dopo il 180 d. C. Il gentilicium è italico,cdx il cognomen è forse celtico.cdxi Ebbe due cariche sacerdotali e una amministrativa nella colonia di Apulum, che sono flamen coloniae, sac(erdos)R(omae) coloniae Apulensium. È sorprendente, che nella Dacia i flamines non avevano più cariche sacerdotali nella stessa città, solo un sacerdozio sopra il sistema municipale o in connessione con il culto imperiale, quindi una carica compatibile con il flaminatus. In questo caso il culto di Roma corrisponde a tutte e due esigenze.cdxii Nella Dacia non sono conosciute altre iscrizioni sul culto di Dea Roma, solo l’altare sopramenzionato di Sarmizegetusa, su cui si legge la simile ma non identica Roma Aeterna. Come funzionario municipale dovette essere il membro dell’ordo decurionum. Riassumendo la sua carriera in base agli elementi conosciuti tramite il testo: dopo il 180 – (decurio?), flamen col(oniae), sac(erdos) R(omae).
D c
[---] [---Lo]ngi[nus? ---]
Frammento di una tavola. Sarmizegetusa. IDR, III/2, 132; Piso 1975, 677; Ardevan 135; ---] | [---fil]ius [---] | [---Lo]ngi[nus? ---] | [---] dec(urio) [---] | [--- sac(erdos) Arae Aug(usti)?] n(ostri?) | [?coronatus Daciarum III ---. Lo si può ritenere sommo sacerdote solo ipoteticamente in base al decurio nella 4ª riga e la lettera Ñ della 5ª riga, che si sciogle con riserva in forma ñ(ostri).cdxiii Se, in base a ñ(ostri), egli è un sommo sacerdote, dovette possedere anche il titolo coronatus Daciarum III, e l’iscrizione fu eretta dopo il 222 d. C.cdxiv Secondo il posto di ritrovamento fu decurio a Sarmizegetusa, oppure poté essere decurio anche a Sarmizegetusa. Ma poté far erigere la sua iscrizione nella sede sacerdotale anche durante il periodo della funzione di sommo sacerdote. Se fu veramente sommo sacerdote della provincia, dovette percorrere almeno un intero cursus municipale, ed ebbe uffici possibilmente anche in altre città. Nel caso, se fu veramente sommo sacerdote, la sua carriera si può schizzare secondo i frammenti del testo più o meno come segue: dec(urio) [coloniae o municipi], (omnibus honoribus functus?), [sac(erdos) Arae Aug(usti)?] n(ostri?), [?coronatus Daciarum III?]. * I dati delle iscrizioni di classificazione incerta non vengono trattati nei capitoli seguenti.
MANUSCRIPT
Addendum - passi di leggi -
1.
Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensiscdxv
Tre tavolette di bronzo. Urso. Hispania. (Osuna, Andalusia, Spagna). CIL II, 5439; CIL II, 5439a; EE II, 105-151, 221-232; EE III, 87-112; EE IX, 83, 91; ILS, 6087; FIRA I, 177-198, nr. 21; Mallon 1944, 213; AÉ, 1946: 123; AÉ, 1951: 32; Girard - Senn 1977, 200-222, nr. 3; CIL II2, 5, 1022; a. I passi riguardanti gli augures e i pontifices: LXVI || Quos pontifices quosque augures G(aius) Caesar quive | iussu eius colon(iam) deduxerit fecerit ex colon(ia) Ge|net(iva) ei pontifices eique augures c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) sunto | eiq(ue) | ponti[fi]ces auguresque in pontificum augu|rum conlegio in ea colon(ia) sunto ita uti qui | optima lege optumo iure in quaque colon(ia) | pontif(ices) augures sunt iisque pontificibus | auguribusque qui in quoque eorum collegio | erunt liberisque eorum militiae munerisq||ue public<i=E> vacatio sacro sanctius esto uti pon|tifici Romano est erit (a)e(r)aque militaria ei omni|a merita sunto de auspiciis quaeque ad eas res per|tinebunt augurum iuris dictio iudicatio esto eis|que pontificib(us) auguribusque ludis quot publice ma|gistratus facient et cum ei pontific(es) augures sa|cra publica c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) facient togas praetextas haben|di ius potestasq(ue) esto eisque pontificib(us) augurib(us)|q(ue) ludos gladiatoresq(ue) inter decuriones spec|tare ius potestasque esto | LXVII || Quicumque pontif(ices) quique augures c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) | post h(anc) l(egem) da|tam in conlegium pontific(um) augurumq(ue) in demor|tui damnative loco h(ac) l(ege) lectus cooptatusve erit | is pontif(ex) augurq(ue) in c(olonia) Iul(ia) in conlegium pontifex | augurq(ue) esto ita uti qui optuma lege in quaque | colon(ia) pontif(ices) auguresq(ue) sunt erunt neve quis quem in conlegium pontificum kapito suble|gito cooptato nisi tunc cum minus tribus pon|tificib(us) ex iis qui c(oloniae) G(enetivae) sunt erunt neve quis quem in conlegium augurum sublegito cooptato ni|si tum cum minus tribus auguribus ex eis qui | colon(iae) G(enetivae) I(uliae) sunt erunt LXVII(I) || IIviri praef(ectus)ve comitia pontific(um) augurumq(ue) quos | h(ac) l(ege) | facere oportebit ita habeto prodicito ita uti | IIvir(um) creare <fac=HAB>ere sufficere h(ac) l(ege) o(portebit) LXXXII || Qui agri quaeque silvae quaeq(ue) aedificia c(olonis) c(oloniae) | G(enetivae) I(uliae) | quibus publice utantur data adtributa e|runt ne quis eos agros neve eas silvas ven|dito neve locato longius quam in quinquen|nium neve ad decuriones referto neve decu|rionum consultum facito quo ei agri eaeve | silvae veneant aliterve locentur neve si ve|nierint it circo minus c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) sunto quique iis | rebus fructus erit quot se emisse dicat is in | iuga sing(ula) inque annos sing(ulos) HS C c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) | [esto eiusque pecuniae qui volet petitio persecutiove ex h(ac) l(ege) esto || si quis ex h(ac) l(ege) decurio augur pontifex c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) factus creatusve] | erit tum quicumque decurio augur pontifex huiusque | col(oniae) domicilium in ea col(onia) oppido propiusve it oppidum p(assus) | | (mille) | non habebit annis V proxumis unde pignus eius quot satis | sit capi possit is in ea col(onia) augur pontif(ex) decurio ne es|to qui(q)ue IIviri in ea col(onia) erunt eius nomen de decurio|nibus sacerdotibusque de tabulis publicis eximendum | curanto u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olent) idq(ue) eos IIvir(os) | s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) Sul modello di Roma, anche nelle città delle province nacquero i collegia degli augures e pontifices. Sugli augures e pontifices delle città provinciali disponeva la legge comunale, la lex municipii oppure la lex coloniae. Tra le leggi comunali conosciute ci sono rimasti certi passi solo delle disposizioni riguardanti gli augures e pontifices della lex coloniae Iuliae Genetivae seu Ursonensis di tono arcaico. Il testo della legge tratta insieme gli augures e i pontifices. Gli garantisce localmante diritti simili a quelli dei pontifices della città di Roma. Riassumendo: § 66 – I diritti e privilegi dei pontifices e augures erano uguali ai diritti e privilegi degli augures e pontifices delle altre colonie. I pontifices e augures avevano il loro proprio collegium nella città, in cui tutti i pontifices e augures avevano posto. Erano esenti dal servizio militare, dagli obblighi della belligeranza e dagli oneri pubblici, similmente anche i loro figli. Avevano il diritto di portare la toga praetexta ai giochi e ai sacrifici pubblici ufficiali. Avevano il diritto di sedersi tra i decuriones durante i giochi e i combattimenti gladiatorici. § 67 – Ogni pontifex e augur eletto o cooptato aveva il diritto di occupare un posto nel collegium, vacante per caso di morte oppure condanna, con gli stessi diritti che avevano i pontifices e gli auguri nelle altre colonie. Non si poteva eleggere o ammettere una persona ad un posto del collegium di pontifices o augures, che era già occupato. Si poteva occupare il posto di un pontifex o augur nel caso, se c’erano meno di tre nel collegium. § 68 – L’elezione del pontifex o augur era condotto dai duumvir o dal praefectus, che ne doveva redigere un verbale nell’ambito della sua competenza, come era prescritto dalla legge. § 91 – Se un pontifex o augur in cinque anni tralasciava di acquistare una residenza nella città oppure entro un miglio dalla città, il cui valore forniva una garanzia sufficiente, il suo pontificatus o auguratus cessava nella città. I duumvir facevano cancellare il suo nome dalle liste pubbliche nell’ambito della loro competenza, in base alla delibera dei decuriones. Agivano similmente nel caso di condanna. Secondo i passi della legge i diritti e i privilegi degli augures nelle colonie erano uguali a quelli degli augures e pontifices nelle altre colonie, quindi si può attribuire alla legge un valore generale almeno nel I secolo, e non solo per quanto riguarda la Hispania, ma almeno anche nelle province della parte occidentale dell’impero con popolazione di lingua latina. Secondo le
MANUSCRIPT
disposizioni della legge una colonia poteva avere almeno tre pontifices e augures, che formavano un collegium. Non era prescritto, che dovevano essere obbligatoriamente in tre. Probabilmente in pratica non erano in tre in ogni città per le condizioni personali (beni ed erudizione) del pontificatus e soprattutto dell’auguratus, le quali solo pochi potevano soddisfare. Come vedremo, nelle province daciche non conosciamo più di due augures contemporanei nella stessa città, anzi, la maggior parte delle città ne aveva solo uno. Non è chiaro, se un augur o pontifex era da solo in una città, come poteva formare un collegium, cioé una corporazione, ma è molto verosimile, che in qualche modo rappresentasse la corporazione. Alla corporazione dei pontifices appartenevano anche i flamines, come anche nella città di Roma. La situazione doveva essere simile al caso dei decuriones, con cui loro avevano molti diritti comuni. Tutti che soddisfacevano le condizioni, potevano diventare decuriones, similmente anche pontifices o augures. Se le persone che potevano soddisfare le condizioni, erano poche, i posti rimanevano vacanti. Benché le poche fonti rimaste sugli augures parlino delle difficoltà dell’acquisto dell’auguratus, la legge menziona un’unica condizione, quella della residenza o casa adeguata. Lo stesso riguarda anche i pontifices. Il fenomeno, che la legge parla degli uguali diritti dei sacerdoti e dei decuriones rinvia a ciò, che al momento della stesura della legge bastavano la cittadinanza romana e i beni per la carica sacerdotale. In pratica questo poteva funzionare diversamente, quindi piuttosto i decuriones avevano le condizioni finanziarie, con cui potevano assumere un auguratus o pontificatus. Così il numero dei sacerdoti rispecchia anche il livello di vita della società. Come si è letto, la legge garantisce esenzione dal servizio militare e dagli onori pubblici per i figli dei rappresentanti delle cariche sacerdotali sopramenzionate. Questo poteva essere una ragione sufficiente per rendere più difficile l’acquisto della carica sacerdotale, ma anche per l’ambizione di rivestire cariche sacerdotali. L’attività dei pontfices e degli augures era controllato dai duumviri. La legge menziona tre possibilità di perdere l’ufficio dell’auguratus e del pontificatus: caso di morte, condanno e tralasciamento dell’acquisto di residenza. Altrimenti questi uffici duravano a vita. I diversi magistrati dovevano esistere in dieci giorni dopo la fondazione della città, così anche le autorità supreme, i IIviri [cfr. anche ibidem § 64], che determinavano le feste e le ceremonie sacre, in cui potevano cooperare anche i sacerdoti, così anche i membri del collegium augurum e pontificum.cdxvi Vari passi menzionano uguali diritti con i decuriones, la cui corporazione doveva esistere in sessanta giorni dopo la fondazione della città [cfr. ibid. § 69], quindi se non nei primi dieci giorni, allora nei primi due mesi funzionavano sicuramente anche le corporazioni sacerdotali. La legge è stata datata prima tra il 47 e 44 a. C., recentemente all’epoca tibero-claudia. Per la sua datazione questa legge è adatta piuttosto come punto di riferimento per lo studio delle circonstanze nel II secolo d. C.cdxvii Non si può dichiarare, che le prescrizioni della legge rappresentavano un sistema generale per tutte le città delle province occidentali, dato che a volte le città impiegavano più di tre augures, secondo le prescrizioni della legge locale, altre città invece solo due.cdxviii b. La parte riguradante gli haruspices: LXII || IIviri quicumque erunt iis IIviri(s) in eos singulos | lictores binos accensos sing(ulos) scribas bi|nos viatores binos librarium praeconem haruspicem tibicinem habere ius potestas|que esto quique in ea colonia aedil(es) erunt | iis aedil(ibus) in eos aedil(es) sing(ulos) scribas sing(ulos) publi|cos cum cincto limo IIII praeconem haruspi|cem tibicinem habere ius potestasq(ue) esto ex eo | numero qui eius coloniae coloni erunt habe|to iisque IIvir(is) aedilibusque dum eum mag(istratrum) ha|bebunt togas praetextas funalia cereos ha|bere ius potestasq(ue) esto quos quisque eo|rum ita scribas lictores accensos viatorem | tibicinem haruspicem praeconem habebit iis | omnibus eo anno quo anno quisque eorum | apparebit militiae vacatio esto neve quis e|um eo anno quo mag(istratibus) apparebit invitum | militem facito neve fieri iubeto neve eum | cogito neve ius iurandum adigito neve a|digi iubeto neve sacramento rogato | neve rogari iubeto nisi tumultus Italici Gallici|ve causa eisque merces in eos singul(os) qui IIvi|ris apparebunt tanta esto in scribas sing(ulos) | HS MCC in accensos sing(ulos) HS DCC in lictores | sing(ulos) HS DC in viatores sing(ulos) HS CCCC in libra|rios sing(ulos) HS CCC in haruspices sing(ulos) HS D prae|coni HS CCC qui aedilib(us) appareb(unt) in scribas | sing(ulos) HS DCCC in haruspices sing(ulos) HS C in ti||bicines singul(os) HS CCC in praecones sing(ulos) HS CCC | iis s(ine) f(raude) s(ua) kapere liceto Riassumendo: § 62. Ogni duumvir ha il diritto e la facoltà di impiegare un haruspex tra altre persone ausiliari con compiti speciali (apparitores). Ogni aedilis aveva il diritto e la facoltà di impiegare un haruspex tra gli apparitores. Gli impiegati dovevano essere scelti dagli abitanti della colonia. Nell’anno di servizio gli impiegati, così anche gli haruspices, erano esenti dal servizio militare, oppure non ci potevano essere sforzati, tranne nel caso di un allarme militare nell’Italia o nella Gallia. Per l’esercizio delle funzioni ricevevano un salario di somma precedentemente determinata. Come si legge nel testo, nella prima metà del I secolo d. C. gli haruspices erano impiegati per tempo determinato nelle colonie provinciali. In pratica, per le condizioni speciali c’erano pochi che erano pratici dell’haruspicina, perciò non si aspetta molti nuovi dati su di loro nel futuro.cdxix Dall’epoca di Severus Alexander (222-235 d. C.) gli haruspices erano pagati dallo stato.cdxx
2.
Lex Narbonensis de flamonio provinciae Tavola di bronzo. Narbo. Gallia Narbonensis. (Narbonne, Francia). CIL XII, 6038; ILS, 6964; FIRA I. 1941, 199-202, nr. 22. Il testo della legge sul sommo sacerdote della provincia nacque tra il 27 a. C. e il 14 d. C., nell’epoca di Augustus. Secondo la storia dell’istituto del culto dell’imperatore intordotto nella parte occidentale dell’Impero, è databile al massimo dagli anni
MANUSCRIPT
’10 del I secolo d. C. Recentemente hanno spostato la datazione fino all’epoca flavia.cdxxi L’antecedente del culto dell’imperatore nelle province, introdotto nella Gallia Narbonensis, era il culto nella città di Narbo, il cui documento epigrafico è databile al 11 d. C. [vedi sotto 5.], così il testo della legge sul sommo sacerdote della provincia dovette nascere successivamente: (1.) [De honoribus flaminis] . . . [Na]rbone [. . . . flamen | cum rem divinam faciet sacrificab]itque, lictores [qui magistratibus apparent, ei apparento | . . . . secundum lege]m iusque eius provinciae. . . | . . . ei in decurionibus senatuve [sententiae dicendae signandique . . . item | . . . inter decuriones s]enatoresve subsellio primo spectan[di ludos publicos eius provinciae ius esto | . uxor fla]minis veste alba aut purpurea vestita f[estis diebus . . .] | . . . neve invita iurato neve corpus hominis mor[tui attingito neve . . . . | nisi necessa]rii hominis erit eique spectaculis publicis eius [provinciae loco . . interesse liceto]. | (2.) De honoribus eius qui flamen f[uerit] | [Si qui flamen fue]rit adversus hanc legem nihil fecerit, tum is qui flamen erit c[urato per duoviros ut . . | . . decurione]s iurati decernant placeatve ei qui flamonio abierit permitti sta[tuam sibi ponere. Cui ita decreverint | ius esse sta]tuae ponendae nomenque suum patrisque et unde sit et quo anno fla[men fuerit inscribendi ei | Narbo]ne intra fines eius templi statuae ponendae ius esto, nisi cui imperator [Caesar Augustus interdixerit. Eidem | i]n curia sua et concilio provinciae Narbonesis inter sui ordinis secundum le[gem . . . . . ]| sententiae dicendae signandique ius esto, item spectaculo publico in provincia [edendo inter decuriones interesse prae]|textato eisque diebus quibus cum flamen esset, sacrificium fecerit, ea veste pu[blice uti, qua in eo faciendo usus est]. | (3.) Si flamen in civitate esse des[ierit] | Si flamen in civitate esse desierit neque ei subrogatus erit, tum uti quis[que flamen ? . . Narbone erit] | in triduo quo certior factus erit et poterit, Narbone sacra facito [eaque omnia secundum hanc legem per reliquam] partem eius anni eo ordine habeto quo annuorum flamin[um sacra habentur, eique si ea habuerit per dies non minus] XXX siremps lex ius causaque esto quae flamini augus[tali ex hac lege facto erit]. (4.) Quo loco conciliu[m provinciae habendum sit]. Qui in concilium provinciae convenerint N[arbonem, ibi id habento. Si quid extra Narbonem finesve Narbone]|sium concilio habito actum erit, id ius ra[tumque ne esto]. | (5.) De pecu[nia sacris destinata] | Qui flamonio abierit, is ex ea pecunia [quae sacris destinata erit quod eius superfuerit statu]|as imaginesve imperatoris Caes[aris Augusti . . arbitratu eius qui eo anno pro]|vinciae praeerit intra idem t[emplum dedicato . . . . . seque omnia sic, ut hac lege cautum est de] | ea re, fecisse apud eum qui ra[tiones provinciae putabit probato] | . . . . . . templ . . . . . . . I passi rimasti contengono i seguenti ordini (compendiosamente): (1.) Sugli onori, diritti e doveri del flamen in carica – sul suo posto ai consigli e ai giochi tra i senatores e decuriones; sul suo diritto di voto nel consiglio provinciale; sulla veste sacerdotale con striscia di porpora; sulla sua apparenza ai sacrifici accompagnato da lictores; su sua moglie, la flaminica – il suo posto agli atti cultici; sul suo comportamento nei riguardi di un uomo morto – sul divieto di toccare. (2.) Sugli onori e diritti del flamen emerito – se non c’era nessuna querela contro di lui durante il periodo della carica, il flamen emerito aveva il diritto di avere una statua con l’indicazione del nome, dell’origine, del periodo della carica, nel territorio del tempio per il culto dell’imperatore,cdxxii se l’imperatore non glielo aveva vietato, inoltre aveva l’onore di portare la veste sacerdotale all’occasione di sacrifici, feste e giochi, poteva sedersi al suo posto vecchio, poteva prendere parte al consiglio provinciale e votare; (3.) Sull’impedimento del flamen – sulle faccende nel caso dell’impedimento temporaneo del flamen nella sua attività – in questo caso lo sostitusice il flamen comunale, che si trova nella città. Se il flamen eletto non torna in trenta giorni, questo occupa il suo posto fino alla fine dell’anno;cdxxiii (4.) Sulla riunione del consiglio – la legge dispone, che il consiglio provinciale si può riunire solo alla sede, a Narbo. Le disposizioni create in un altro posto sono invalide.cdxxiv (5.) Sul resto del bilancio del consiglio provinciale alla fine dell’anno – la legge dispone sulla sorte del resto del bilancio del consiglio, cioé il flamen uscente deve fare scolpire con questa somma la statua oppure l’imago dell’imperatore, nel territorio del tempio, e deve dedicarla con l’approvazione del luogotenente. Questo passo parla anche di ciò, che il flamen deve rispettare questa legge sotto ogni aspetto.cdxxv
3.
Dig. 50. 5. 8pr. Papinianus 1 resp.
MANUSCRIPT
In honoribus delatis neque maior annis septuaginta neque pater numero quinque liberorum excusatur. sed in asia sacerdotium provinciae suscipere non coguntur numero liberorum quinque subnixi: quod optimus maximusque princeps noster severus augustus decrevit ac postea in ceteris provinciis servandum esse constituit. La disposizione nacque tra il 193 e 211, in base all’epoca del regno di Septimius Severus, che rilasciò il decretum, e all’anno della morte di Papinianus. Secondo il frammento di Papinianus, Septimius Severus dispose, che una persona oltre settanta e un padre con cinque figli non poteva assumere una funzione pubblica, ma nell’Asia Proconsularis la carica del sommo sacerdote della provincia era libera anche per i padri con cinque figli. Successivamente questo diventò la pratica anche nelle altre province. Quindi dalla disposizione di Septimius Severus non si poteva assumere una carica di sommo sacerdote della provincia oltre settanta. Siccome questa pratica si diffondeva anche nelle altre province, era in vigore nelle province illiriche. Nel testo si usava per il sommo sacerdote l’espressione sacerdos provinciae, perché contemporaneamente nelle singole province si usava nel testo la definizione generale e intelligibile, non solo per quanto riguarda le province orientali e occidentali, ma anche nel caso solo delle province occidentali (archiereus, flamen provinciae, sacerdos provinciae, sacerdos ad Aram provinciae, sacerdos Arae Augusti ecc.)
4.
Dig. 50. 4. 17pr. Hermogenianus 1 iuris epit. Sponte provinciae sacerdotium iterare nemo prohibetur. Secondo la disposizione, nessuno poteva ostacolare la carica rinnovata del sommo sacerdote, se qualcuno voleva e poteva diventare di nuovo sommo sacerdote. Hermogenianus raccolse disposizioni quasi esclusivamente di Diocletianus, così questo passo presentato è praticamente posteriore all’epoca del principatus. Ma cronologicamente è molto vicino al principatus, e dall’altro lato la carica rinnovata del sommo sacerdote della provincia capitava anche nel II e III secolo. Così il passo di Hermogenianus diventa attuale anche per l’epoca del principatus. Non è da escludere, che in certi casi la rinnovazione della carica del sommo sacerdote avesse non solo ostacoli finanziari.
5.
Leges Arae Augusti Narbonensis Testo di un altare. Narbo. Gallia Narbonensis (Narbonne, Francia). CIL XII, 4333; T(ito) Statilio Taur[o] | L(ucio) Cassio Longino | co(n)s(ulibus) X K(alendas) Octobr(es) | numini Augusti votum | susceptum a plebe Narbo|nensium in perpetuom | quod bonum faustum felixque sit Imp(eratori) Caesari | divi f(ilio) Augusto p(atri) p(atriae) pontifici maximo trib(unicia) potest(ate) | XXXIIII coniugi liberis gentique eius senatui | populoque Romano et colonis incolisque | c(oloniae) I(uliae) P(aternae) N(arbonensis) M(artii) qui se numini eius in perpetuum | colendo obligaverunt plebs Narbonen|sium aram Narbone in foro posuit ad | quam quot annis VIII K(alendas) Octobr(es) qua die | eum saeculi felicitas orbi terrarum | rectorem edidit tres equites Romani | a plebe et tres libertini hostias singu|las inmolent et colonis et incolis ad supplicandum numini eius thus et vinum | de suo ea die praestent K(alendis) quoque Ianuar(iis) thus et vinum | colonis et incolis praestent VII quoq(ue) | Idus Ianuar(ias) qua die primum imperium | orbis terrarum auspicatus est thure | vino supplicent et hostias singul(as) in|molent et colonis incolisque thus vi|num ea die praestent et pridie K(alendas) Iunias quod ea die T(ito) Statilio | Tauro M(anio) Aemilio Lepido co(n)s(ulibus) iudicia | plebis decurionibus coniunxit hostias | singul(as) inmolent et thus et vinum ad | supplicandum numini eius colonis et | incolis praestent exque iis tribus equitibus Roman[is tribusve] | libertinis unu[s || [Plep]s Narbonesis a[ram] | numinis Augusti de[di]cavit [---] | [------] | [---] legibus iis q(ae) i(nfra) s(criptae) s(unt) numen Caesaris Aug(usti) p(atris) p(triae) quando tibi | hodie hanc aram dabo dedicabo|que his legibus hisque regioni|bus dabo dedicabo quas hic | hodie palam dixero uti infimum | solum huiusque arae titulorum|que est si quis tergere ornare | reficere volet quod beneficii | causa fiat ius fasque esto sive | quis hostia sacrum faxit qui | magmentum nec protollat id|circo tamen probe factum esto si | quis huic arae donum dare au|gereque volet liceto eademq(ue) | lex ei dono esto quae arae est | ceterae leges huic arae titulisq(ue) | eadem sunto quae sunt arae | Dianae in Aventino hisce legi|bus hisque regionibus sicuti | dixi hanc tibi aram pro Imp(eratore) | Caesare Aug(usto) p(atre) p(atriae) pontifice maxi|mo tribunicia potestate XXXV coniuge liberis genteque eius | senatu populoque R(omano) colonis | incolisque col(oniae) Iul(iae) Patern(ae) Narb(onensis) Mart(ii) qui se numini eius in per|petuum colendo obligaverunt | doque dedicoque uti sies volens | propitium Il testo è databile al 11 d. C. Cfr. anche le iscrizioni CIL XII, 392 e 4393. Gli abitanti della città si obbligarono al culto eterno del numen di Augustus. A questa occasione posero l’altare al forum della città. Nel testo si menzionano anche le circonstanze della collocazione. La seconda parte del testo tratta i sacrifici e le regole riguardanti l’altare e le cerimonie, il che è uguale alla legge riguardante l’altare di Diana sull’Aventino. Quest’ultima circostanza è molto importante, dato che l’altare di Diana sull’Aventino e il tempio di Roma era il luogo sacro dell’alleanza delle città latine. Rappresentava lo stesso nelle città, dove questa forma del culto era introdotto prima dell’epoca imperiale.cdxxvi Perciò il culto imperiale introdotto a Narbo, che poi
MANUSCRIPT
diventò generale in tutta la provincia, dimostra il rafforzo dell’alleanza di tradizione sacrale simile tra Roma e la provincia. Inoltre, per quanto rigurda il tipo della cerimonia, il culto introdotto nella città provinciale è interpretato come un culto simile a quelli nuovi o integrati dell’epoca. Si legge un’allusione simile su un’iscrizione di Illyricum, più precisamente della Dalmatia (6).
6.
Lex Arae Iovis Salonitanae Testo su un altare. Dalmatia. Salona. (Croazia, Salona). CIL III, 1933; ILS, 4907; FIRA II, 286-287, nr. 107; FIRA III, 229-230, nr. 74; L(ucio) Aelio Caesare II P(ublio) Coelio Balbino Vibullio Pio co(n)s(ulibus) | VII Idus Octobres | C(aius) Domitius Valens IIvir i(ure) d(icundo) praeeunte C(aio) Iulio Severo pontif(ice) | legem dixit in ea verba quae infra scripta sunt | Iuppiter Optime Maxime quandoque tibi hodie hanc aram dabo dedicaboque ollis legib(us) | ollisque regionibus dabo dedicaboque quas hic hodie palam dixero uti infimum solum huius arae est | si quis hic hostia sacrum faxit quod magmentum nec protollat it circo tamen probe factum esto ceterae | leges huic arae eaedem sunto quae Arae Dianae sunt in Aventino monte dictae hisce legibus hisce regionib(us) | sic uti dixi hanc tibi aram Iuppiter Optime Maxime do dico dedicoque uti sis volens propitius mihi collegisque | meis decurionibus colonis incolis coloniae Martia[e I]uliae Salonae coniugibus liberisque nostri[s] L’altarecdxxvii è datato all’8 di ottobre del 137. Similmente al testo di Narbo, anche questo è una legge, che tratta similmente le corcostanze della dedicazione dell’altare. È molto importante, che tramanda il processo totalmente formale della dedicazione in una città provinciale. Il sommo magistratus dedicò l’altare secondo l’indicazione del pontifex, con le parole pronunciate in ordine fisso, secondo una formula arcaica.cdxxviii Varro descrisse la cerimonia similmentecdxxix: „sic enim aedis sacra a magistratu, pontifice praeeunte, dicendo dedicatur”. Le dedicazioni nelle città daciche dovevano acacdere ugualmente. Il nuovo culto introdotto nella città, che era legato all’altare o al tempio, era determinato secondo il testo della legge dell’altare e tempio di Diana sull’Aventino,cdxxx come anche nel nel caso di Narbo, presentato al numero precedente. Il testo dell’Aventino, che non è sopravvisuto, doveva essere ben conosciuto generalmente. Il testo illustra bene il rapporto particolare tra le città delle province e Roma, che era regolato sul modello dell’alleanza tra le città latine e Roma, legata sacralmente per le radici comuni nell’epoca repubblicana.
iRussu 1969, 177; v. anche una sintesi e i nomi in ordine alfabetico: Sanie 1970, 236; Sanie 1973, 151-170; Russu 1975 (1977), 13. ii Cfr. Mócsy 1959, 162 con riferimento a CIL, V, 1134; cfr. OPEL I2, 25-26. iii IDR, III/5, 96. iv IDR, III/5, 96. v Cfr. Russu 1977, 9. vi Per una sintesi cfr. Engesser 1957. vii Cfr. Bergemann 1992, 315-324. viii Cfr. la sintesi di Ardevan 1984, 95-110. ix Per i flamines della Dacia v. anche Ardevan 1992, 47-53. x Cfr. Ardevan 1984, 95-110. xi Cfr. Barkóczi 1964, 305; Russu 1975 (1977), 7; v. anche OPEL I2, 59. xii Cfr. da ultimo Piso 2001 (BMN), 363-370. xiii Cfr. Ardevan 1992, 47-53. xiv V. Apul. flor 16, 73. xv Cfr. Szabó Á. (1999) 2000, 119-150. xvi Cfr. DE I, 66; v. anche Habel, 1893, 329-330. xvii Cfr. Demougin 1975, 174-187. xviii Cfr. Daicoviciu – Piso 1977, 78. xix Cfr. Mócsy 1959, 177; Barkóczi 1964, 315.
MANUSCRIPT
xx Cfr. Ardevan 1992, 47-53. xxi Cfr. Ardevan 1984, 95-110. xxii Cfr. Daicoviciu-Piso 1977, 78. xxiii Cfr. Mócsy 1959, 175; Barkóczi 1964, 313. xxiv Per una sintesi cfr. Clemente 1972, 142-229. xxv Cfr. Ardevan 1984, 95-110. xxvi Cfr. Demougin 1975, 174-187. xxvii Cfr. anche Ardevan 1998, 236. xxviii V. Fitz 1992-1995, 939. xxix V. Pflaum 1970, 375. xxx V. Fitz 1992-1995, 939. xxxi V. Pflaum 1970, 375. xxxii Cfr. Saulnier 1984, 517-533; Mrozewicz 1993, 217-225. xxxiii V. Berger 1953, 687. xxxiv Per una sintesi cfr. Engesser 1957. xxxv V. Fitz 1992-1995, 939. xxxvi Cfr. Mócsy 1959, 164; Barkóczi 1964, 306; cfr. OPEL I2, 77-78. xxxvii Cfr. TLL I, 836 – Adventor. xxxviii Cfr. CIL, III, 968; CIL, III, 7729; ILS, 4241; IDR, III/2, 306a. xxxix Cfr. Tóth I., 1970, 278-281, inoltre sul culto di Sol Invictus v. la sintesi di Halsberghe 1972. xl Cfr. IDR, III/2, 348, 366, 367, 416; v. anche Piso 1987-1988, 163-164. xli Cfr. Berger, 687-688. xlii Cfr. Ardevan 1984, 95-110. xliii Piso 1980, 124-125, nr. 2, Napoca: [I. O.] M.? | [P. Aelius? F]abi|[anus?] bf. cos. | [leg. XIII] Gem. | [v. s. l. m.]; cfr. anche Piso in IDR, III/5, 261.Cfr. Ardevan 1984, 95-110. xliv Sul fenomeno cfr. Piso 1992 (1995), 435-444. xlv Cfr. Mócsy 1959, 179; Barkóczi 1964, 316; v. anche OPEL III, 39. xlvi Cfr. Ardevan 1984, 95-110. xlvii Cfr. Mráv 1997, 36-37. xlviii Da Brigetio e dintorni RIU, 516, 524, 543, 558, 587, 617, 676, 707, da Aquincum e dintorni CIL, III, 3358, 3376, 3529, 3533, 3540, 3557, da Intercisa e dintorni cfr. RIU, 1167, 1179, e cfr. anche con l’epigrafe di numero CIL III, 13378 di posto di ritrovamento sconosciuto. xlix Cfr. anche ad es. Fitz 1972. l Cfr. Russu 1969, 175. li V. CIL, III, 1548; IDR, III/1, 141. lii Cfr. RIU, 1167, 1179; CIL, III, 13378. liii Cfr. Russu 1969, 172-175 e 178; Russu 1975 (1977), 13. liv Cfr. Russu 1969, 178; cfr. Sanie 1970, 240 – Malchus. lv Cfr. Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1998, 149. lvi Cfr. Ardevan 1992, 47-53. lvii Cfr IDR III/3, 119. lviii Cfr. Barkóczi 1964, 317. lix Cfr. Ardevan 1992, 47-53. lx Cfr. Ardevan 1998, 74-81. lxi Cfr. Daicoviciu 1969, 368-385; Daicoviciu 1969, 386-402; Szabó Á. 1999 (2000), 119-150. lxii V. ILD 578-581, 583-584. lxiii Cfr. Buday 1911, 261-266; Kerényi 82; Devijver 1976-1981, K 82; Bărbulescu 1984, 153, nr. 12. lxiv Cfr. Mócsy 1959, 181; Barkóczi 1964, 318; OPEL III, 70-72. lxv Cfr. Ardevan 1984, 95-110. lxvi Cfr. Ardevan 1992, 47-53. lxvii Cfr. Ardevan 1998, 84-88. lxviii Cfr. Ardevan 1998, 55-65. lxix Cfr. Barkóczi 1964, 318. lxx Cfr. Téglás 1909, 161-162 lxxi Cfr. OPEL III, 102; Russu 1977, 13. lxxii Cfr. Bărbulescu 1984, 135, 177; Sanie 1989, 1237-1238. lxxiii Per una sintesi cfr. Kovács 2005. lxxiv Cfr. Ardevan 1998, 147-148. lxxv Cfr. Mócsy 1959, 186; Barkóczi 1964, 321; OPEL III, 164-165. lxxvi Cfr. Ardevan 1992, 47-53. lxxvii V. IDR, III/5, 45, 252, 363, 527, 694. lxxviii V. IDR, III/3, 213. lxxix Cfr. Mócsy 1959, 190; Barkóczi 1964, 324; cfr. anche OPEL IV, 82. lxxx Cfr. Ardevan 1984, 95-110. lxxxi Cfr. Barkóczi 1964, 325; OPEL IV, 96. lxxxii Cfr. Ardevan 1984, 95-110. lxxxiii Cfr. Clemente 1972, 142-229. lxxxiv Cfr. Ardevan 1998, 285, 296-302, 303-307. lxxxv Cfr. Harmand 1957, 345-356; v. anche Ardevan 1998, 280-281. lxxxvi V. Ardevan 1998, 306-307. lxxxvii V. Apul. flor 16, 73. lxxxviii Cfr. Szabó Á. 1999 (2000), 119-150. lxxxix Cfr. Mócsy 1959, 194; Barkóczi 1964, 326. xc Cfr. Mócsy 1959, 194; Barkóczi 1964, 326.
MANUSCRIPT
xci Cfr. Ardevan 1992, 47-53. xcii Cfr. Kovács 2005. xciii V. CIL, III, 1548. xciv Cfr. Barkóczi 1964, 328; Mócsy 1959, 197. xcv Cfr. Ardevan 1984, 95-110. xcvi V. le precedenti proposte sotto IDR, II, 21a. xcvii V. IDR II, 33. xcviii Cfr. Ardevan 1998, 36. xcix Cfr. OPEL I2, 29. c Cfr. Ardevan 1984, 95-110. ci Piso 2001, 363-370. cii Cfr. Mócsy 1959, 151; OPEL I2, 61-62. ciii Cfr. OPEL III, 163. civ V. IDR, III/2, 234 = CIL, III, 7909. cv V. IDR, III/2, 234a = CIL, III, 1430. cvi V. IDR, III/2, 375 = CIL, III, 1489. cvii V. IDR, III/2, 104; cfr. anche Ardevan 1986-1987, 127-132; cfr. anche Ardevan 1993, 21-27. cviii V. IDR, III/2, 542 = CIL, III, 8075, 4 a-b = ILD 298. cix Cfr. Mócsy 1959, 188; Barkóczi 1964, 322-323. cx Cfr. Berger, 352. cxi Sulla famiglia v. Piso 2001 (BMN), 363-370. cxii Cfr. OPEL I2, 61-62. cxiii Cfr. Mócsy 1959, 181; Barkóczi 1964, 318; OPEL III, 70-72. cxiv Cfr. Gudea - Tamba 2001, 62. cxv V. Gudea-Tamba 2001, fig. 5, LM 1 e fig. 11. cxvi Cfr. Wissowa 1912, c. 65., 467/8-468/1-7-469/5. cxvii Cfr. la sintesi di Domaszewski 1895, 110-113 e di E. Birley 1978, 1506-1541; v. anche Helgeland 1978, 1470-1505; Richmond 1963, 185-197. cxviii Cfr. Gudea-Tamba 2001, 19-46, 51-64. cxix Cfr. Tóth I. 1976, 69-88. cxx V. IDR, III/2, 277. cxxi Cfr. Alicu 1978, 173-177; Alicu 1997, 101.
cxxii Per una sintesi v. Hornum 1993. cxxiii Cfr. anche Piso 1977, 647-650. cxxiv Cfr. Mócsy 1959, 151; OPEL I2, 61-62. cxxv Cfr. Mócsy 1959, 194; Barkóczi 1964, 326. cxxvi Cfr. Clemente 1972, 142-229. cxxvii CIL, III, 12582 = IDR, III/2, 354. cxxviii Cfr. Szabó Á. 1999 (2000), 119-150. cxxix Cfr. la sintesi di Wolff 1976. cxxx V. Sanie 1989, 1265; cfr. anche OPEL I2, 114. cxxxi Cfr. Bărbulescu 1984, 135, 177; Sanie 1989, 1237-1238. cxxxii Cfr. Barkóczi 1964, 301; Gostar 1965, 253; Bărbulescu 1984, 206 sg. cxxxiii Cfr. Weisberger 1968, 259; v. anche Mócsy 1959, 159; Barkóczi 1964, 325. cxxxiv Cfr. Á. Szabó 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. cxxxv IDR, III/5, 190; Rusu-Pescaru – Alicu 2000, 50. cxxxvi Cfr. anche per es. nella Pannonia AÉ 1929: 226 = Vorbeck 1980a, 101 = Szabó 2006, P 51 – Pannonia Superior, Carnuntum; CIL III, 10440 = Szabó 2006, P 60 – Pannonia Inferior, Aquincum; CIL III, 10911 = RSS, 37 = RIU 21 = Szabó 2006, P 62 – Pannonia Superior, Savaria. cxxxvii Cfr. Mócsy 1959, 174; Barkóczi 1964, 312. cxxxviii Cfr. Tóth I. 1976, 15-39. cxxxix Cfr. la sintesi di Domaszewszki 1895, 110-113; E. Birley 1978, 1506-1541. cxl V. Piso 2001 (AMN), 233. cxli V. CIL, III, 7761 = ILS, 4304; Sanie 1989, 1246, nr. 3 = CCID, 153; cfr. anche Balla 2000, 103-113. cxlii V. Gudea-Tamba 2001, Fig. 5, LM 1 e Fig. 11. cxliii Cfr. Wissowa 1912, c. 65, 467/8-468/1-7-469/5. cxliv Cfr. Gudea-Tamba 2001, 19-46, 51-64. cxlv Cfr. Tóth I. 1976, 69-88. cxlvi Piso 2001 (AMN), 233. cxlvii Cfr. Mócsy 1959, 174; Barkóczi 1964, 312. cxlviii Cfr. Tóth I. 1976, 15-39. cxlix Cfr. Ardevan 1984, 95-110. cl V. Gudea-Tamba 2001, Fig. 5, LM 1 e Fig. 11. cli Cfr. Wissowa 1912, c. 65., 467/8-468/1-7-469/5. clii Cfr. la sintesi di Domaszewszki 1895, 110-113; E. Birley 1978, 1506-1541. cliii Cfr. Gudea-Tamba 2001, 19-46, 51-64. cliv Cfr. Tóth I. 1976, 69-88. clv Cfr. Wuthnow 1930, 39; Barkóczi 1964, 313 – nel caso delle persone siriache. clvi V. CIL, III, 7688; cfr. Kerényi 396. clvii Cfr. Wolff 1976. clviii Cfr. Mócsy 1959, 175; Barkóczi 1964, 313. clix A. Birley 1971, 176-177, 228. clx Cfr. anche Bărbulescu 1984, 144-145. clxi Cfr. Wolff 1976.
MANUSCRIPT
clxii Cfr. Mócsy 1959, 176-177; Barkóczi 1964, 314. clxiii V. per es. A. Birley 1971, 176-177, 228. clxiv Cfr. anche Bărbulescu 1984, 144-145. clxv Cfr. CCID, 62, 147, 229, 231, 305, 307, 330, 350 (?), 408-410, 520, 550, 615. clxvi V. Mócsy 1959 , 180; Barkóczi 1964, 317; cfr. OPEL III, 58. clxvii V. IDR, III/5, 105. clxviii V. IDR, III/5, 136; CIL, III, 7756; ILS, 3007; AÉ, 1980: 734. clxix Cfr. OPEL III, 70-72. clxx Cfr. Ardevan 1992, 47-53. clxxi Cfr. Mócsy 1959, 188; Barkóczi 1964, 323. clxxii Cfr. Mócsy 1959, 192; Barkóczi 1964, 325. clxxiii Cfr. CCID, 52. clxxiv Cfr. anche Ardevan 1988, 291-295. clxxv Cfr. Gudea-Tamba 2001, 19-42. clxxvi Cfr. Plin. epist 10, 49-50; cfr. anche per es. Gell. Noct. Att. 16, 13 clxxvii Cfr. Á. Szabó 2004 (HPS), 139-162. clxxviii Cfr. OPEL I2, 99-105. clxxix Cfr. Mócsy 1959, 192; Barkóczi 1964, 325. clxxx Cfr. Ardevan 1992, 47-53. clxxxi V. OPEL I2, 95. clxxxii V. IDR, III/2, 80, 81. clxxxiii V. Deininger 1965, 150. clxxxiv Cfr. IDR, III/5, 297 – Apulum; CIL, III, 10911 = RSS 37 = RIU 21 – Savaria e CIL, III, 10440 – Aquincum. clxxxv V. anche AÉ 1929: 226 = Vorbeck 1980a, 101 = Szabó 2006, P 51, Pannonia Superior, Carnuntum; CIL III, 10440 = Szabó 2006, P 60, Pannonia Inferior, Aquincum; CIL III, 10911 = RSS, 37 = RIU 21 = Tóth E. 2001 (ArchÉrt), p. 29, nr. 9 = Szabó 2006, P 62, Pannonia Superior, Savaria. clxxxvi Cfr. Mócsy 1959, 147, 149. clxxxvii Cfr. Mócsy 1959, 180; Barkóczi 1964, 317; OPEL III, 54-55. clxxxviii Cfr. Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. clxxxix Cfr. Mócsy 1959, 147, 149. cxc Cfr. Mócsy 1959, 188; Barkóczi 1964, 322-323. cxci Cfr. Ardevan 1992, 47-53. cxcii Cfr. Mócsy 1959, 147, 149. cxciii Cfr. Mócsy 1959, 188; Barkóczi 1964, 322-323. cxciv Cfr. Ardevan 1992, 47-53. cxcv Cfr. Mócsy 1959, 148, 149; cfr. anche Barkóczi 1964, 298-300. cxcvi Cfr. OPEL I2, 41-42; cfr. Russu 1975 (1977), 7. cxcvii Cfr. Borhy 2003, 415-424. cxcviii Cfr. Mócsy 1959, 148, 149; cfr. anche Barkóczi 1964, 298-300. cxcix Cfr. Kerényi 650-653: il 651 è il procuratore della Dacia Porolissensis, il 650 è un speculator di Apulum in un’iscrizione datata al 205 d. C., il 652 morì verosimilmente senza parenti, il 653 è un lapidarius probabilmente di Sarmizegetusa. cc Cfr. OPEL IV, 181. cci Cfr. Mócsy 1959, 153, 169. ccii V. Mócsy 1959, 162. cciii Cfr. anche Ardevan 1981, 437-442. cciv V. Fishwick 1987, 335. ccv V. Ardevan 1998 , 610. ccvi Cfr. Szabó Á. 1999 (2000), 119-150; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 83-119. ccvii V. Kienast 1996, 162-165. ccviii V. Kienast 1996, 172-173. ccix V. Piso 1997 (1999), 126-127. ccx Precedentemente la datazione ha risultato 215-217 contando con periodi del quinto anno, cfr. Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 111, ma secondo gli anni controllabili tramite le iscrizioni degli quinquennales di Aquincum [194, 259, 284 d. C.] si deve contare con periodi di precisamente cinque anni cfr. Alföldi 1942, 274-275; Szilágyi 1968, col. 75 nel caso degli anni quinquennales. ccxi V. Mócsy 1959, 153. ccxii Cfr. Ardevan 1984, 95-110. ccxiii Cfr. Clemente 1972, 142-229. ccxiv V. IDR, III/2, 427 e 549. ccxv Cfr. Piso 1997 (1999), 125-137. ccxvi Cfr. Kienast 1996, 162-165. ccxvii Cfr. Ladage 1971, 78-80. ccxviii Cfr. Szabó Á. 1999 (2000), 119-150. ccxix V. anche Ardevan 1998, 197. ccxx Cfr. IDR, III/5, 213; 527; 283. ccxxi V. IDR, III/3, 213; AÉ, 1992: 1487; IDR, III/5, 283. ccxxii Cfr. Russu 1969, 177. ccxxiii Cfr. Angyal 1971, 5-26. ccxxiv Cfr. la sintesi di Domaszewszki 1895, 110-113; E. Birley 1978, 1506-1541. ccxxv Cfr. Mócsy 1959, 147-148. ccxxvi Cfr. Mócsy 1959, 180; Barkóczi 1964, 317; OPEL III, 57. ccxxvii Cfr. Clemente 1972, 142-229. ccxxviii Cfr. Mócsy 1959, 147-148. ccxxix Cfr. Mócsy 1959, 194; Barkóczi 1964, 326. ccxxx Cfr. Ardevan 1992, 47-53.
MANUSCRIPT
ccxxxi Cfr. Berger, 687-688. ccxxxii Cfr. Mócsy 1959, 176; Barkóczi 1964, 314. ccxxxiii V. Mócsy 1959, 188; Barkóczi 1964, 322-323. ccxxxiv V. AÉ, 1960: 158; Pflaum 1978, 105; Ardevan 1998, 151. ccxxxv Cfr. Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1998, 135. ccxxxvi Cfr. Ardevan 1984, 95-110. ccxxxvii Cfr. Ardevan 1992, 47-53. ccxxxviii Cfr. Mócsy 1959, 148; Barkóczi 1964, 298. ccxxxix Cfr. OPEL I2, 114. ccxl Cfr. Ardevan 1984, 95-110. ccxli V. Ardevan 1998, 148. ccxlii Cfr. Ardevan 1984, 95-110. ccxliii Cfr. Birley 1969, 82; Devijver 1976-1980, J 34. ccxliv Cfr. Piso 1992 (1995), 435-444. ccxlv Cfr. Ardevan 1992, 47-53. ccxlvi Cfr. Le Bohec – Wolff 2000, vol. 1., 239-242. ccxlvii V. CIL, III, 1579; cfr. anche Devijver 1976, J. 34. ccxlviii Cfr. Mócsy 1959, 148; Barkóczi 1964, 298. ccxlix Cfr. Mócsy 1959, 170; Barkóczi 1964, 309. ccl Cfr. Mócsy 1959, 180; Barkóczi 1964, 317. ccli Cfr. Mócsy 1959, 148; Barkóczi 1964, 298. cclii Cfr. OPEL II, 101. ccliii Cfr. IDR, III/2, 128; IDR, III/5, 446; inoltre Spitzl 1984, 116-119; Ardevan 1998, 156-159. ccliv Cfr. Mócsy 1959, 148; Barkóczi 1964, 298. cclv Cfr. Mócsy 1959, 177; Barkóczi 1964, 315. cclvi Cfr. Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1998, 520, nr. 4, Kat nr. 308. cclvii V. Piso, IDR, III/5, 2001, nr. 1, 1. cclviii V. CIL, II, 4218 = ILS 6935; cfr. Alföldy 1973, 73, nr. 28; v. CIL, II, 4249 = ILS 6933, cfr. Alföldy 1973, 89, nr. 66. cclix V. AÉ, 1982: 954 – Numidia, Bon Hadjar accanto a Sigus. cclx Cfr. Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. cclxi Cfr. Mócsy 1959, 148; Barkóczi 1964, 298. cclxii Cfr. OPEL III, 80. cclxiii Cfr. Kerényi 2018; Russu 1977, 9. cclxiv Cfr. Ardevan 1998, 135 cclxv Cfr. Crişan 1971, 341-347 ed Alicu - Crişan 2003, 89-94; Alicu - Pescariu 2000, 123-125; Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. cclxvi Cfr. Kerényi K. 1999. cclxvii Cfr. HA, Marcus Aurelius 19, 15. cclxviii Cfr. Gilliam 1979, 144-175. cclxix Cfr. Liebenam 1900, 102-105. cclxx Cfr. Ardevan 1998, 36. cclxxi Cfr. Mócsy 1959, 148; Barkóczi 1964, 298. cclxxii Cfr. Mócsy 1959, 188; Barkóczi 1964, 323. cclxxiii Cfr. Ardevan 1984, 95-110. cclxxiv Cfr. Engesser 1957. cclxxv V. CIL III, 4495 = Vorbeck 1980a, 76 = Szabó 2006, P 45; probabilmente il figlio nell’iscrizione CIL III, 3979 = Szabó 2006, P 61; CIL III, 12739 + 12740 = AÉ, 1948: 243 = Dobó 558 = Szabó 2006, P 84. cclxxvi Cfr. Ardevan 1992, 47-53. cclxxvii V. Piso IDR, III/5, 279. cclxxviii V. AÉ, 1983: 805; IDR, III/5, 411. cclxxix Cfr. Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 79589. cclxxx V. HA, Severus Alexander 44, 4 e 27, 6. cclxxxi Cfr. Mócsy 1959, 148; Barkóczi 1964, 298. cclxxxii Cfr. Mócsy 1959, 194; Barkóczi 1964, 326. cclxxxiii Cfr. Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. cclxxxiv Cfr. Lact. divin. inst. 1, 10, 2. cclxxxv Cfr. Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 791-794. cclxxxvi Cfr. anche per es. nella Pannonia AÉ 1929: 226 = Vorbeck 1980a, 101 = Szabó 2006, P 51 – Pannonia Superior, Carnuntum; CIL III, 10440 = Szabó 2006, P 60 – Pannonia Inferior, Aquincum; CIL III, 10911 = RSS, 37 = RIU 21 = Szabó 2006, P 62 – Pannonia Superior, Savaria. cclxxxvii Cfr. Mócsy 1959, 148; Barkóczi 1964, 298. cclxxxviii Cfr. Mócsy 1959, 194; Barkóczi 1964, 326. cclxxxix Cfr. Ardevan 1992, 47-53. ccxc Cfr. Merlat 1960, 208 sg. ccxci Cfr. Mócsy 1959, 178; Barkóczi 1964, 316. ccxcii Cfr. CCID, 62, 147, 148, 229, 305, 307, 330, 350 (?), 408-410, 520, 550, 615. ccxciii Cfr. Mócsy 1959, 180; Barkóczi 1964, 317; cfr. OPEL III, 58. ccxciv Cfr. Mócsy 1959, 166; Barkóczi 1964, 307. ccxcv V. Piso IDR, III/5, 105. ccxcvi V. CIL, III, 7756 = ILS, 3007 = AÉ, 1980: 734 = IDR, III/5, 136. ccxcvii Cfr. Mócsy 1959, 192; Barkóczi 1964, 325; Russu 1969, 179. ccxcviii Cfr. Tóth I. 1976, 15-39. ccxcix Cfr. Tóth I. 1976, 115-132. ccc V. Ardevan 1998, 54-55. ccci Cfr. Russu 1969, 177-178; Russu 1975 (1977), 13.
MANUSCRIPT
cccii Cfr. Russu 1969, 178; Russu 1975 (1977), 13. ccciii Cfr. Mócsy 1959, 157; Barkóczi 1964, 302. ccciv Cfr. Ardevan 1998, 144. cccv Cfr. Ardevan 1992, 47-53. cccvi Cfr. Ardevan 1998, 156-159. cccvii V. OPEL III, 107. cccviii V. Mócsy 1959, 168. cccix Cfr. Clemente 1972, 142-229. cccx Cfr. Schillinger 1979, 398-406. cccxi V. OPEL III, 107. cccxii V. Mócsy 1959, 196; OPEL III, 107. cccxiii V. OPEL III, 109. cccxiv V. OPEL IV, 86. cccxv V. OPEL III, 165, 100. cccxvi V. Piso 1993, 323; cfr. anche Mrozewicz 1993, 220-221. cccxvii Cfr. Piso – Diaconescu 1985-1986, 161-183. cccxviii Cfr. Ardevan 1984, 95-110; Ardevan 1992, 47-53. cccxix V. Saulnier 1984, 517; Mrozewicz 1993, 217-225. cccxx V. Ardevan 1998, 236, 239. cccxxi Cfr. anche AÉ, 1927: 54; IDR, III/2, 118; Piso 2006, nr. 58. cccxxii V. AÉ, 1927, 55; IDR, III/2, 119; Piso 2006, nr. 59. cccxxiii V. CIL, III, 13783; IDR, III/2, 318. cccxxiv Sul tema ha scritto una sintesi Kádár 1989, 1038-1061. cccxxv Cfr. Mócsy 1959, 159; OPEL IV, 90. cccxxvi Cfr. Russu 1977, 8. cccxxvii V. CIL, III, 1498; IDR, III/2, 403. cccxxviii Cfr. Mócsy 1959, 159; Barkóczi 1964, 325; OPEL IV, 94. cccxxix Cfr. Mócsy 1983, 378-382 – Anus – Dazanus. cccxxx Cfr. Ardevan 1998, 55-61. cccxxxi Cfr. Mócsy 1959, 160; Barkóczi 1964, 303. cccxxxii Cfr. Mócsy 1959, 169. cccxxxiii Cfr. Ardevan 1992, 47-53. cccxxxiv V. Ardevan 1998, 57-58. cccxxxv Cfr. Mócsy 1959, 160; Barkóczi 1964, 303. cccxxxvi Cfr. Mócsy 1959, 175; Barkóczi 1964, 313. cccxxxvii Cfr. Ardevan 1986-1987, 127-132. cccxxxviii Cfr. Trynkowski 1965, 369-387. cccxxxix Cfr. OPEL IV, 147. cccxl Cfr. Mócsy 1959, 186; Barkóczi 1964, 321; OPEL III, 164-165, 171. cccxli V. anche Ardevan 1998, 197. cccxlii Cfr. Ardevan 1992, 47-53. cccxliii V. Ardevan 1998, 135. cccxliv V. Ardevan 1998, 158184. cccxlv Cfr. Clemente 1972, 142-229. cccxlvi Cfr. Ardevan 1998, 156-159. cccxlvii Cfr. anche Ardevan 1998, 197. cccxlviii Cfr. OPEL IV, 147, 39. cccxlix Cfr. anche Ardevan 1998, 236. cccl Cfr. Trynkowski 1965, 369-387. cccli Cfr. Ardevan 1992, 47-53. ccclii Cfr. Saulnier 1984, 517-533; Mrozewicz 1993, 217-225. cccliii Cfr. Russu 1969, 177; Russu 1975 (1977), 13. cccliv Cfr. Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. ccclv V. CIL, III, 1084 = ILS, 3015 = Ardevan 375 = IDR, III/5, 211. ccclvi Cfr. CCID, 385 - Roma, 455 – Ravenna. ccclvii Cfr. Kerényi 1837; Russu 1977, 7. ccclviii Cfr. Barkóczi 1964, 305; OPEL I2, 59. ccclix Cfr. CCID, 62, 147, 148, 229, 305, 307, 330, 350 (?), 408-410, 520, 550, 615. ccclx Cfr. Mócsy 1959, 180; Barkóczi 1964, 317; OPEL III, 58. ccclxi V. Piso 1993, 117-130. ccclxii Cfr. CIL, III, 143498; Mócsy 1959, 187. ccclxiii Cfr. Balla 2000, 49-53; Piso 1993, 117-130. ccclxiv Cfr. Szabó Á. (1999) 2000, 125-127; Piso, IDR, III/5, 77. ccclxv Cfr. Ardevan 1998, 48; Piso, IDR, III/5, XV-XXI. ccclxvi Cfr. Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. ccclxvii Cfr. Mócsy 1983, 390 – Da Dorus a Polydorus. ccclxviii Cfr. Ardevan 1992, 47-53. ccclxix Cfr. Mócsy 1983, 344-345. ccclxx Cfr. Szabó Á. 1999 (2000), 119-150. ccclxxi Cfr. CCID, 130-132. ccclxxii V. CCID, 131. ccclxxiii V. CCID, 132.
MANUSCRIPT
ccclxxiv Cfr. Sanie 1989, 1179, 1247 nr. 11-12. ccclxxv V. Sanie 1989, 1248, nr. 13; CCID, 145. ccclxxvi Cfr. ad es. Schallmayer – Eibl – Ott – Preuß 1990, 589; inoltre cfr. Haensch 2003, 135-139; per una sintesi sui beneficiarii v. Ott 1995. ccclxxvii V. CIL, III, 1485 = IDR, III/2, 452. ccclxxviii Cfr. Szabó Á. 1999 (2000), 119-150. ccclxxix Cfr. Nemeti 2007, 229-234. ccclxxx Cfr. Ardevan 1992, 47-53. ccclxxxi Cfr. Ardevan 1981, 437-442. ccclxxxii Cfr. Ardevan 1998, 542-566, Tavv. XIX-XXVI. ccclxxxiii V. AÉ 2003, 1420 = Szabó 2006, P 22. ccclxxxiv V. Piso 1999, 126-127. ccclxxxv Cfr. Ardevan 1992, 47-53. ccclxxxvi Cfr. Ardevan 1992, 47-53. ccclxxxvii Cfr. Ardevan 1992, 47-53. ccclxxxviii Cfr. Ardevan 1998, 607-609, Tavv. LV-LVI; v. anche la sintesi Engesser 1957. ccclxxxix Cfr. Ardevan 1998, 601, Tav. L. cccxc V. Petolescu 2002, 120-121, nr. 55. cccxci Cfr. Kienast 1996, 156-165. cccxcii Nelle province europee non capita in questa forma: le forme Aten*, Atenius, Atennius, Atenus sono conosciute dall’Aquitania, dalla Hispania e dalla Dacia – cfr. OPEL I2, 83. cccxciii V. Petolescu 2002, 120-121, nr. 55. cccxciv Cfr. Kienast 1996, 156-165. cccxcv Cfr. Mócsy 1959, 147-148. cccxcvi Cfr. Tóth I. 1976, 15-39. cccxcvii V. Petolescu 2002, 120-121, nr. 55. cccxcviii Cfr. Kienast 1996, 156-165. cccxcix Cfr. Mócsy 1959, 190; Barkóczi 1964, 324; cfr. anche OPEL IV, 82. cd Cfr. Mócsy 1983, 143. cdi Cfr. OPEL IV, 80. cdii V. CIL, III, 7691. cdiii V. CIL, III, 897-898. cdiv V. AÉ, 1957: 295 - Thracia (?), Serdica (?); da più lontano v. per es. l’iscrizione CIL, III, 399 da Pergamon, che fu un sacerdos Romae et Saluti. cdv Cfr. Szabó Á. 2005 (2006), 181-210. cdvi V. CIL, III, 1422 = IDR, III/2, 206 – Dacia, colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa. cdvii V. CIL, III, 1136; Kerényi 991; IDR, III/5, 305. cdviii V. CIL, III, 858; Kerényi 990. cdix V. CIL, III, 801; Kerényi 994. cdx Cfr. Mócsy 1959, 155. cdxi Cfr. Mócsy 1959, 196; Barkóczi 1964, 327. cdxii Cfr. Szabó Á. 2005 (2006), 181-210. cdxiii V. Piso 1975, 677, nr. 1. cdxiv Cfr. Szabó Á. (1999) 2000, 119-150; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 83-119, dove lo ho inserito con riserva nella lista dei sommi sacredoti (nr. 11), ma in realtà non si può provare ancora la sua carica di sommo sacredote. cdxv Cfr. anche Dessau 1876, 74-76; Hübner 1876, 87-90; Mommsen 1876, 91-112; Gonzáles ed. 1989 cdxvi Cfr. Rüpke 1995, 533-537; inoltre Canto 1981, 143-146. cdxvii Cfr. anche Liebenam 1900, 342-343; v. anche Ladage 1971, 32-41. cdxviii Cfr. Ladage 1971, 78-80. cdxix Cfr. Marquardt 1885, 410-415; Bouché – Leclercq in DA III.1 (1893), 17-33; Thulin 1968 (1906), 12-29; Thulin 1906 (1968); Wissowa 1912, 534-549; Ladage 1971, 18-19. cdxx Cfr. Historia Augusta, Severus Alexander 44, 4 e 27, 6. cdxxi Cfr. Fishwick 1987, 240-256. cdxxii Intra fines, quindi il territorium della città e non entro le mura della città, cioé dove si trovavano il forum provinciae e il tempio del culto imperiale. cdxxiii La disposizione ingrandì notevolmente l’importanza del flaminatus. cdxxiv L’indicazione del nome della città non significava proprio la città entro le mura, ma la sede del consiglio provinciale costruita intra fines – quindi nel territorium –, il forum provinciae, dove stava anche il tempio menzionato nel (5.) paragrafo. cdxxv È un fatto molto importante che il consiglio provinciale aveva un proprio bilancio. Il suo reddito poteva venire dagli insediamenti della provincia. Si deve sottolineare inoltre, che il sommo sacerdote poteva fare la dedicazione all’impertore solo con l’approvazione del luogotenente con il diritto di dedicazione – sopra il sommo sacerdote non poteva stare gerarchicamente un magistratus municipale. cdxxvi Cfr. Wissowa 1912, 39, 250, 473. cdxxvii Cfr. anche CIL VIII, 11796. cdxxviii Cfr. Wissowa 1912, 385, 472-477, 515; v. anche Köves-Zulauf 1995, 65-75. cdxxix V. Varro ling. lat. 6, 61. cdxxx Cfr. Wissowa 1912, p. 39, 250, 473.
MANUSCRIPT
CARICHE SACERDOTALI
ANTISTES Conosciamo tre presone con la carica di antistes nella Dacia [D 29, 40, 59]. Tutti e tre furono uomini, vennero da un ambiente latino, uno di loro possibilmente dalla Gallia [D 29], e tutti e tre rivestirono la carica nella stessa città. Il titolo della carica In due casi il nome della carica fu scritto semplicemente in forma antistes nell’iscrizione [D 29, 40], di cui l’ultimo abbreviato in forma an(tistes). In uno dei casi anche il luogo fu indicato oltre al titolo, in forma antistes huiusque loci o antistes huiusce loci [D 59]. La diffusione e la cronologia della carica nella provincia Nella Dacia l’antistitium capita solo in contesti religiosi. Tutti e tre antistetes lavorarono nella città di Apulum, la sede del luogotenente, più precisamente nel territorio della colonia Aurelia, determinato sia dal posto di ritrovamento delle iscrizioni, che dall’indicazione della città nel testo. Il periodo ufficiale di uno degli antistites [D 29] risale il più presto al 212 d. C., un altro rivestì la carica tra il 222 e 235 d. C. e dopo [D 59]. Nel terzo caso [D 40] non abbiamo un punto di riferimento cronologico, così la sua funzione è databile solo grossamente alla prima metà del secolo. Di quest’ultimo si conosce una sola iscrizione, in confronto a quelle erette dagli altri due, per questo non è da escludere che occupò l’ufficio solo per breve tempo. I reperti epigrafici e i loro posti La maggior parte dei reperti epigrafici dei tre antistetes è tavole commemorative di costruzioni [D 29 b., c., d.] e tavole incastrate nella lastra frontale del piedistallo di statue [D 50 b., c., e.]. Di uno è rimasto anche un rilievo [D 40], di un altro due statuette decorative in un santuario [D 59, d., f.]. Le tavole con iscrizione con i nomi delle diverse divinità potevano essere collocate nelle mura di diversi santuari, similmente alle statuette con iscrizioni. Le divinità menzionate dalle iscrizioni e i motivi della dedicazione Il primo antistes [D 29] nella cronologia dedicò iscrizioni a Diana Mellifica [a.], a Liber Pater e Libera [b.] e a Silvanus Silvestris e Diana [d.]. È rimasta un’altra sua iscrizione sulla costruzione di una crypta, la quale poteva essere in connessione con la coppia divina di Silvanus Silvestris e Diana, ma poteva indicare anche un edificio religioso o profano.1 Il seguente antistes [D 40] fece erigere un’iscrizione a Nemesis Exaudientissima. Per quanto riguarda il terzo antistes conosciuto [D 59], gli possono essere attribuite iscrizioni dedicate a Mars Invictus [b.], a Venus Victrix [c.], a Nemesis Regina [d.], a Virtus Romanus [e.] e a due divinità inidentificabili [f., a.]. L’attributo di una delle divinità inidentificabili è Invictus [f.]. È da notare, che due su tre antistites fecero erigere iscrizione a Nemesis [D 40, D 59 d], il che può avere motivi particolari in connessione con il carattere della carica. Non si può determinare il motivo della dedicazione di tutte le iscrizioni, e ci sono alcune, dove questo motivo non è indicato affatto. Nel primo quarto del III secolo, un antistes dedicò due iscrizioni alla salute propria e a quella della famiglia [D 29 c., d.]. Un altro fece erigere una statua a causa di un sonno [D 59 d.]. Il resto fu dedicato soprattutto alla salute dell’Impero, del senatus e dell’ordo decurionum di Apulum [D 59 a., b., c., e.], tutto per voto. Il carattere dell’antistitium dacico Nessuna delle iscrizioni erette dai tre antistites di Apulum è dedicata ad una sola divinità, perciò nel caso di Apulum la competenza della carica non era ristretta al territorio del santuario di una sola divinità. Benché anche il motivo personale della dedicazione capiti spesso nelle iscrizioni, i motivi di tono ufficiale rafforzano la teoria del carattere ufficiale dell’antistitium. Tramite gli antistites conosciuti esclusivamente per le manifestazioni religiose e tramite il caso dell’antistitium di una persona, che aveva anche una carica sacerdotale [D 59], l’antistitium di Apulum sembra una funzione religiosa in città. Il rappresentante della carica non doveva essere il sacerdote di una certa divinità, ma – come lo illustra anche il significato del titolo della carica – era piuttosto un superiore religioso, che poteva essere anche sacerdote. Per quanto riguarda lo stato sociale delle persone con questo ufficio, l’antistitium non era la carica più alta di Apulum, ma aveva una grande responsabilità. I rappresentanti avevano la possibilità di entrare nell’ordo decurionum [D 29] o di ottenere un honor [D 59]. Il mondo delle divinità menzionate è assai eterogeneo, ma si può affermare, che l’area sacra sotto la direzione degli antistites non aveva un carattere orientale, ma era piuttosto una forma religiosa di origine occidentale con la presenza di divinità apparentemente nuove e assunte, il che nel III secolo d. C. non ebbe più grande importanza. Il luogo della carica La rarità della carica nella provincia e il fatto che capita in una sola città, rende possibile – oltre alle dedicazioni a Nemesis – che la riteniamo una funzione appartenente ad un dato istituto. Si può identificare ad Apulum un’area sacra con più santuari, menzionata da varie iscrizioni come Locus. In questo Locus c’erano santuari di divinità curative, di divinità profetiche e anche quelli della religione statale.2 Solo uno degli antistites menzionava il Locus in tutte le sue iscrizioni [D 59]. Il Locus, secondo la sua posizione geografica localizzabile,3 apparteneva al territorio della colonia Aurelia Apulensium. L’antistes era il direttore amministrativo del Locus.
Il posto della carica nella carriera – le condizioni della carica Nell’ordine degli elementi conosciuti della carriera dei tre antistites, la carica aveva i posti seguenti: D 40 - an(tistes). D 29 - antistes, dec(urio). D 59 - cl[?inic]us l(oci), sacerdo[s] d[ei --- ?], har(uspex) col(oniae), antistes loci, [---?. L’unico elemento comune della loro carriera prima dell’antistitium è ciò, che tutti e tre erano cittadini romani. Perciò come condizione fondamentale per la carica si definisce la cittadinanza romana. I due antistites ben conosciuti [D 29, 59] avevano agito prima verosimilmente là, dove più tardi divennero antistites. Di uno non si sa, che facesse precisamente, secondo una delle sua iscrizioni, prima dell’antistitium, raccoglieva probabilmente miele curativo [cfr. D 29 a.]. Un’altro era impiegato come medico praticante presso il Locus dell’antistitium, e fu anche il sacerdos di una divinità per noi sconosciuta e il haruspex della colonia [D 59]. Oltre alla cittadinanza romana, solo nei casi apulensi (e per questo anche nei casi dacici conosciuti), un’altra condizione per la carica poteva essere il servizio locale precedente, che poteva significare anche il servizio della città. Uno di loro divenne decurio come antistes [D 29], un altro concorse come antistes ad un honor [D 59], che – considerando il suo stato – doveva essere una delle magistrature basse coloniali oppure il decurionatus. La durata dell’antistitium Non conosciamo nessun antistes emerito, e non abbiamo nessun dato di ciò, se uno di loro avesse deposto la carica già in vita. Ciononostante si può affermare il carattere a vita dell’antistitum nella Dacia, ad Apulum solo con riserva, con il commento, che questa definizione può essere vera solo nei casi apulensi.
AUGUR Nella Dacia sono conosciute dieci persone, che furono anche augures [D 10, 16, 20, 23, 39, 43, 44, 47, 55, 67]. Due [D 10, 20] agirono in due città, perciò il numero degli augures conosciuti è praticamente dodici. Secondo i nomi, tutti vennero da un ambiente latino. Il titolo della carica In tutti i casi il titolo della carica è augur, nella maggior parte di questi casi il titolo rinvia anche alla città con l’indicazione del rango dell’insediamento, in forma augur municipi oppure augur coloniae. Il nome della carica sacerdotale era scritto in generale senza abbreviazione, che può essere considerato come regola, a cui non può essere eccezione nemmeno la persona dell’iscrizione D 47, il cui titolo continua nella prossima riga dell’iscrizione composta comunque insolitamente. La cronologia della carica nella provincia Si considera naturale, che con la nascita di una città4 nacque anche la funzione dell’augur che continua ad esistere fino alla fine della città oppure fino all’epoca del cristianesimo. Quindi il periodo dell’auguratus della provincia comincia dopo la conquista della Dacia nel 106 d. C., cioé nell’epoca di Traianus e finisce con l’evacuazione della provincia nel 270-271 d. C. sotto l’imperatore Aurelianus. In realtà la cronologia delle iscrizioni erette dagli augures, quindi quella dei documenti della loro esistenza, dura dall’epoca di Commodus (180-192 d. C.) fino alla metà del III secolo d. C., la maggior parte risale all’epoca dei Severi. Questo fenomeno dimostra solo la situazione generale epigrafica e ciò, che la maggior parte delle iscrizioni di augures risale ad un’epoca, quando furono erette le più delle iscrizioni nell’area danubiana. La diffusione della carica nella provincia Quattro degli augures conosciuti rivestirono l’auguratus in municipia [D 23, 39, 43, 44], sei invece in coloniae [D 10, 16, 20, 47, 55, 67], due di cui in due diverse coloniae [D 10, 20]. Quindi conosciamo quattro augures municipali e otto coloniali dal punto di vista del rango della città. In questo caso i doppi auguratus contano due volte, dato che questi augures occuparono la carica nella data città indipendentemente dalla carica simile in un’altro insediamento. Conosciamo augures nelle città seguenti: municipium Septimium Apulensium [D 39] e municipium Septimium Porolissensium [D 23, 43, 44]; colonia Aurelia Apulensium [D 20, 47, 67], colonia Aurelia Napocensium [D10, 16] e colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa [D 10, 20, 55]. Tutto sommato conosciamo augures meno dalla metà delle città daciche, il che è dovuto soprattutto alle fonti a disposizione. I reperti epigrafici e il loro posto I reperti epigrafici che documentano le persone con la carica degli augures formano un gruppo svariato. Abbiamo quattro iscrizioni votive, di cui tre si trovavano su altari [D 10, 16, 47b], la quarta su una colonna [D 55]; quattro sono monumenti sepolcrali, eretti dall’augur per un membro della famiglia, oppure eretti proprio per l’augur stesso [D 23, 43, 44, 67]; e ci sono due basi, una ricevuta dagli augures come magistratus, l’altra eretta da loro [D 20 a., b., 39. a.]. Solo una delle iscrizioni è stata ritrovata al luogo dell’auguratus [D 16], eretta dal sacerdote ad un posto, dove il fulmine spesso cadeva. I motivi della dedicazione e le divinità delle iscrizioni votive I monumenti sepolcrali [D 23, 43, 44, 67] – oltre all’affermazione semplice dell’esistenza dell’auguratus – non ci forniscono informazioni sulla carica, neanche le basi [D 20 a., b., 39 a.]. Le altre [D 10, 16, 47 b., 55] sono iscrizioni votive, che dicono solo, che il dedicatore adempié il suo voto. Solo due epigrafi possono essere in eventuale connessione con l’auguratus. Due delle iscrizioni votive sembrano esser erette dai dedicatori come persone private – che erano anche augures – a (Deus) Aeternus Sanctissimus [D 55] e a Venus Augusta [D 47]. Nell’iscrizione votiva dedicata da uno di loro si legge il nome di Iuppiter Optimus Maximus. Oltre che gli augures erano i mediatori della volontà di Iuppiter, il posto dell’iscrizione ritrovata sulla cima colpita da fulmine, fa pensare che in questo caso il dedicatore agisse là veramente come augur [D 16]. Anche nel testo dell’altare fu indicato solo l’auguratus. La seguente e l’ultima iscrizione votiva eretta da un augur dacico [D 10] fu dedicata a Silvanus. Silvanus fu una divinità anche profetica,5 perciò anche in questo caso si ipotizza che il dedicatore coltivasse la divinità anche come augur. Il luogo della carica e dell’attività Tutti gli augures conosciuti della Dacia agivano in città, molti di loro rivestivano anche un magistratus, perciò possiamo ritenerli sacerdoti ufficiali statali, in nessun caso si può ipotizzare la possibilità dell’augur privato. Come augures dovevano avere la loro sede nella città, vicino al santuario capitolino, mentre il luogo dell’attività augurale6 era un cd. locus liberatus et effatus entro o fuori la città, in certi casi marcati occasionalmente. Non si può localizzare precisamente questo luogo o luoghi in nessuna città dacica. Ad Apulum questo posto poteva essere ipoteticamente la collina cd. Kutyamál (Galgenberg, Dealul Furcilor), separata da ambedue le città tramite la necropoli su uno dei lati.7 Il posto della carica nella carriera Nel caso degli augures municipali l’auguratus sta al seguente posto nella carriera: D 23 – augur, [po]ntif(ex), q(uin)q(uennalis). D 43 – vet(eranus) ex Y(centurione), augur m(unicipi).
D 44 – decurio, augur, pontifex. D 39 – eq(uo) p(ublico), augur m(unicipi), sacerdos (Arae Augusti o Arae Augusti nostri, coronatus Daciarum III). Nel caso apulense [D 39] non si può precisare se egli portasse le magistrature prima dell’acquisto dell’auguratus oppure dopo. Similmente non è indicato neanche il decurionatus nell’iscrizione, ma siccome per acquistare lo stato equestre ci voleva un patrimonio più grande rispetto al decurionatus, poteva essere anche decurio. Nel suo caso si può affermare solo il fatto, che divenne augur come il membro dell’ordine equestre. Similmente, nenache il D 23 indica il decurionatus, ma in base alle cariche posteriori era sicuramente il membro dell’ordo decurionum, possibilmente già prima dell’auguratus. Il D 43 fu congedato come centurio, il che in quell’epoca gli diede il diritto di portare l’anello equestre. Nenache lui indicò se fosse stato decurio, ma il suo stato sociale nella città fu assai alto, perciò lo si può ritenere praticamente uno dell’ordine equestre. Il D 44 fu senza dubbio decurio prima dell’aguratus. Due degli augures municipali conosciuti divennero pontifices dopo l’acquisto dell’auguratus [D 23, 44], che significa la metà dei casi conosciuti, e i due terzi dei casi della stessa città. Perciò possiamo ritenere questo fenomeno come una particolarità di Porolissum. L’augur del municipium di Apulum divenne il sommo sacerdote della provincia, già come augur [D 39]. Nel caso degli augures coloniali l’auguratus sta al posto seguente nella carriera: D 16 – augu[r] col(oniae). D 10 – dec(urio), [?II]v[?iral(is)], pont(ifex), augur col(oniae)(1). Nel frattempo decurio, augur col(oniae)(2), dec(urio) mun(icipi). Fu augur in due luoghi, perciò l’auguratus locale deve essere trattato nella struttura delle cariche rivestite nelle singole città:
1. – dec(urio), augur col(oniae)(2). 2. – dec(urio), [?II]v[?iral(is)], pont(ifex), augur col(oniae)(1).
D 20 – equo p(ublico), augur col(oniae)(2), dec(urio) col(oniae)(3), patron(us) collegior(um) fabr(um) centonar(iorum) et nautar(um), conduc(tor) pascui salinar(um) et commercior(um), IIviralis, augur col(oniae)(1), 212 után sacerd(os) Arae Aug(usti). Fu augur in due luoghi, perciò l’auguratus locale deve essere trattato nella struttura delle cariche rivestite nelle singole città per definire le condizioni locali dell’ufficio: 1. – equo p(ublico), augur col(oniae)(2). 2. – equo p(ublico), IIviralis, augur col(oniae)(1). D 47 – [?decuri]o, aug[ur ---?] col(oniae). D 67 – eq(ues) R(omanus), augur col(oniae), patr(onus) coll(egi) fab(rum) et dendr(ophorum) col(oniae). D 55 – eq(uo) p(ublico), dec(urio), augur col(oniae)(1), dec(urio), patronus causarum col(oniae)(2). In tutti i casi l’auguratus si può mettere in relazione alle cariche e funzioni rivestite nella stessa città. Il D 16 non indicò nessuno stato sociale prima dell’auguratus. Due indicarono solo il decurionatus [D 10, 47]. In due casi si legge solo l’appartenenza all’ordo equestre prima dell’auguratus nella data città [D 20, D 67]. Uno di loro giunse al IIviratus come decurio, poi divenne pontifex e dopo augur [D 10]. La persona seguente non indica nel dato luogo il decurionatus, ma fu il membro dell’ordine equestre e giunse al IIviratus, che presuppone anche il decurionatus. Divenne augur dopo il IIviratus [D 20]. L’ultimo augur coloniale conosciuto fu il membro dell’ordine equestre e decurio, da questa posizione sociale venne eletto sacerdote [D 55]. In base ai sopraddetti l’auguratus non aveva una posizione fissa nel cursus honorum. Gli augures coloniali conosciuti furono almeno decuriones e i membri dell’ordine equestre prima dell’auguratus. Il D 55 indicò – oltre allo stato equestre – anche il decurionatus, il che dimostra, che lo stato equestre, con la condizione di un patrimonio grande, presuppone praticamente il decurionatus (con limite finanziario più basso), ma quelli che erano equestri non sempre menzionavano quest’ultimo, perché l’alto rango sociale rendeva evidente anche quello basso. Perciò l’unico caso eccezionale, l’auguratus del D 16, presuppone anche il decurionatus. Le cariche rivestite potevano essere al massimo vantaggi, mentre lo stato equestre poteva essere un vantaggio finanziario in confronto dei decuriones. Uno di loro fu già pontifex prima dell’auguratus [D 10]. Il D 20 divenne sommo sacerdote della provincia all’apice della sua carriera. L’auguratus e altre cariche sacerdotali nella Dacia Secondo i dati conosciuti, l’auguratus era compatibile con il ponificatus ed è molto verosimile che tra le due cariche non c’era una differenza di autorità, al massimo un rapporto gerarchico strutturale [v. D 10, 23, 44]. Oltre al pontificatus, l’auguratus era compatibile anche con la carica di sommo sacerdote della provincia, che stava fuori il sistema dei sacerdoti municipali [D 20, 39]. Non conosciamo nessun augur nella Dacia con un sacerdotium piccolo, un flaminatus o altra carica sacerdotale nella stessa o in un’altra città.
Le condizioni sociali dell’auguratus nella Dacia Secondo le poche iscrizioni rimaste, le condizioni sociali dell’auguratus municipale nella Dacia era – oltre alla cittadinanza romana – il decurionatus, uno stato equestre che era gerarchicamente più alto, o uno stato sociale più o meno equivalente. La condizione fondamentale dell’auguratus coloniale era similmente il decurionatus. Si può dedurre inoltre, che l’auguratus, sia municipale che coloniale, non ha una posizione fissa all’interno del cursus honorum. In generale si può definire solo il decurionatus come una condizione fondamentale sociale dell’auguratus nella Dacia, e sembra che da questo punto di vista non ci sia differenza tra gli augures dei municipia e quelli delle coloniae. Verosimilmente anche il decurionatus, come condizione documentata dalle iscirzioni, può rispecchiare piuttosto la pratica e non le prescrizioni delle leggi di città. Il numero degli augures Nessuno dei pochi dati rimasti rinvia direttamente all’esitenza contemporanea di più di un augur nella stessa città. Il materiale epigrafico non permette conclusioni larghe. Si conoscono augures in numero relativamente grande solo a Porolissum. Loro rivestivano la carica nel municipium uno dopo l’altro [D 23, 43, 44]. La datazione larga di alcune iscrizioni della stessa città si coincidono in parte, perciò, considerando anche il carattere a vita della carica, possiamo presupporre in fin dei conti più di uno, ma al massimo due augures contemporanei nella stessa città, più precisamente nelle colonie. La durata della carica Non conosciamo il limite inferiore d’età per l’auguratus nella Dacia. Nella Pannonia si conosce una persona, il cui concorso fu sponzorizzato dal padre invece di lui stesso,8 per questo è verosimile, che si potesse concorrere all’auguratus prima dell’indipendenza giurdica o prima dell’età maggiore, ovviamente da un’adeguata posizione sociale. Nella Dacia non conosciamo augures emeriti. È conosciuto il testo del monumento sepolcrale di un augur, il quale non fa pensare, che egli non fosse stato augur fino alla morte [D 44]. Per questo, in base ai dati a disposizione, possiamo ritenere l’auguratus come una carica sacerdotale a vita anche nella Dacia, quindi la situazione dacica corrisponde a quella descritta nella lex Ursonensis [cfr. Addendum 1.].
FLAMEN Conosciamo trentatre flamines nella Dacia, di cui trenta erano flamines di città, e portavano la loro carica proprio in città,9 mentre gli altri tre erano i flamines del culto locale con interesse imperiale di una città italica.10 Due dei flamines di città rivestivano il flaminatus in due insediamenti, perciò il numero dei flamines locali conosciuti nelle città è trentadue. La parte decisiva veniva da un ambiente latino, ma, in base ai nomi, alcuni erano sicuramente orientali, tutti però cittadini romani. Il titolo della carica Nelle iscrizioni si leggono due diversi tipi della carica di flamen. Uno è il flaminatus nelle città della provincia, l’altro è la carica fuori la provincia. Questi ultimi non contano tra i sacerdoti dacici, sono però menzionati, perché vivevano nella Dacia. Nelle città della provincia la carica sacerdotale fu indicata a volte semplicemente flamen, perché questo era chiaro a tutti [D 22, 38, 50, 52, 58, 74], senza l’indicazione del luogo e del soggetto. È frequente, che l’indicazione municipi o coloniae si trova dopo più cariche elencate, la quale però riferisce a tutte le singole cariche, così anche al flaminatus [D 4, 6c, 13, 15c, 66, 72, 93]. A volta fu abbreviata in forma fl(amen) [D 14, 75a, 86] o flam(en) [D 75b, 76]. La forma ufficiale del titolo sacerdotale era flamen municipi o flamen coloniae [D 5f, 14, 18, 36, 41, 42, 53, 60, 70, 71, 73, 93], eventualmente seguito dal nome dell’insediamento. In base a questo, anche la semplice forma flamen – soprattutto se la data persona rivestiva anche un’altra magistratura nella città – indica sacerdoti con il titolo flamen municipi oppure flamen coloniae. L’altro flaminatus rintracciabile nella Dacia è la carica sacerdotale di una città italica, riservata agli equites. Le iscrizioni contengono il titolo sacerdotale in varie forme, forse perché nella provincia lontana non si conosceva sempre il preciso titolo ufficiale. Perciò si legge le seguenti forme nelle iscrizioni: flamen lucularis Laurent(ium) Lavina[t(ium)] – prendendo in considerazione, che questa forma si trova in un’iscrizione italica di Fulginae, non lontano dal luogo del culto, la si ritiene la forma ufficiale. [D 8a]. Lo stesso ad Apulum si legge nell’iscrizione eretta dai magistrati locali come segue [D 8b]: sacer(dos) Lauren[t(ium) Lavi]nat(ium). Un eques dacico [D 70] fece scrivere il titolo sacerdotale nella stessa forma a Sarmizegetusa: sacerd(os) Laurentium Lavinat(ium). Nel suo caso è molto probabile, che era l’esempio apulense che influenzava la semplificazione del titolo della carica, dato che l’espressione sacerdos era adatto ad esprimere tutte le cariche sacerdotali. La terza forma conosciuta della carica è il flam(en) Laurentinus [D 76]. L’esistenza dei due flamines, uno scritto come sacerdos secondo l’usanza locale, dimostrano, che anche il D 70 era veramente un flamen. Il flamen emerito aveva il titolo flaminicius oppure flaminicus, come si suppone in base all’iscrizione votiva e sepolcrale di un flamen emerito defunto [D 38b] e a quella di un flamen pannonico che si ritirò dall’ufficio.11 La cronologia dei dati sui flamines nella provincia Conosciamo flamines nel II secolo d. C. praticamente quasi dalla fondazione, cioé la carica esisteva già nel primo terzo del secolo. La cronologia delle fonti sulla carica sacerdotale dura fino alla metà del III secolo d. C., secondo la situazione generale delle iscrizioni e delle fonti nella Dacia. La diffusione dei flamines nella provincia Oltre ai sacerdotes, abbiamo le più numerose iscrizioni sui flamines, anzi, se separiamo i singoli sacerdotia, il flaminatus è la carica più documentata della provincia. Conosciamo dieci flamines municipali e ventuno coloniali. Abbiamo fonti sui flamines nelle seguenti città: Apulum - colonia Aurelia [D 5, 6, 8, 22, 41, 66, 75] e municipium Septimium [D 36, 42, 72], Dierna [D 53], Drobeta [D 4, 53, 58], Napoca [D 15, 18, 89], Porolissum [D 13], Potaissa [D 73], Sarmizegetusa [D 14, 38, 50, 52, 70, 71, 74, 75, 76, 82, 88, 93], Tibiscum [D 60], quindi dalla maggior parte delle città daciche. Dobbiamo sottolineare la colonia di Sarmizegetusa, dove conosciamo nove flamines nel II secolo d. C. Il posto dei reperti epigrafici e i motivi della dedicazione Prendendo in considerazione, che alcuni flamines rivestivano più cariche, e c’erano tra di loro parecchie persone di alto rango, le iscrizioni su di loro non sono in rapporto con il flaminatus. Si può affermare lo stesso anche sulle iscrizioni erette per ragioni private. Anche i posti delle iscrizioni sono svariati. Nessuna di loro è rinvenuta al posto originale, ma le basi erette dalla comunità stavano sicuramente in area pubblica, le iscrizioni di costruzione sugli edifici menzionati, le epigrafi sepolcrali nelle necropoli. Nessuna delle dedicazioni è collegabile al compito del flamen nel culto imperiale. È conosciuta una sola iscrizione, la cui dedicazione è per Iuppiter Optimus Maximus, per gli dei e le dee, e il dedicatore indicò solo il suo flaminatus, e non scrisse, se l’epigrafe fosse un voto [D 41]. Perciò verosimilmente questa è l’unica iscrizione eretta dal sacerdote come flamen, il che, però, non mostra nessun rapporto evidente con l’attività di flamen e con il culto imperiale nella città. Dunque l’attività di flamen non è rintracciabile tramite le iscrizioni. In opposizione, si conoscono tre iscrizioni, i cui testi riferiscono una donazione fatta per il flaminatus ricevuto. Il D 38 ob honorem flamonii et HS LXXX nummum ad annonam dedit; il D 50 ob honorem flamonii B(---?) p(ublico?) dedit; il D 58 ob honorem flamoni cryptam vetustate dilapsam pecunia sua reformavit et exaltiavit. Da questi tre esempi in tre diverse città si può trarre la conclusione, che conocorrevano contemporaneamente più persone alla carica del flamen, perciò non bastava lo stato sociale [vedi sotto] se qualcuno voleva divenire flamen, era ragionevole fare qualcosa anche per il bene pubblico.12 Questo fenomeno dimostra senza dubbio l’importanza del flaminatus nella vita della città e della data persona, e nella sua carriera, e rinvia anche alla concorrenza in questo periodo. Inoltre sembra, che la grandezza e il carattere del dono non fossero determinati, probabilmente il luogo e la situazione influivano la somma e la donazione dedicate dalla persona per la sua elezione alla posizione sacerdotale.
La carica e il luogo e la forma dell’attività del flamen Abbiamo visto precedentemente, che non esiste una fonte dacica, che documentasse l’attività dei flamines. Perciò si può affermare in generale anche sulla Dacia, che l’attività dei flamines era in connessione con il santuario locale del culto imperiale nella città (di cui non sappiamo niente) e con i giorni festivi. L’attività dei flamines svolgeva sicuramente sotto il controllo dei pontifices anche nelle città daciche. Il luogo del flaminatus nella carriera Il flaminatus ha il posto seguente nei cursus honorum municipali: D 86 – fl(amen). D 73 – flamen municipi. D 18 – flamen muni[c(ipi)]. D 58 – flamen m(unicipi). D 60 – [f]lamen m(unicipi). D 36 – flam(en) m(unicipi). D 42 – dec(urio) col(oniae), flamen mun(icipi). D 72 – dec(urio), flamen m[uni]c(ipi). D 53 – trib(unus) leg(ionis), dec(urio) munic(ipi)(1), dec(urio) munic(ipi)(2), flam(en) munic(ipi)(3) flam(en) col(oniae)(2), IIvir col(oniae)(1), dec(urio) col(oniae)(3). - [equo publico o eques Romanus], flam(en) munic(ipi)(3)
D 13 – q(uin)q(uennalis), flamen mun(icipi), sacerdos dei n(umeri) P(almyrenorum). Sette su dieci flamines municipali indicarono solo il flaminatus come carica rivestita nella loro città. Uno fu decurio in un’altra città, ma nell’insediamento del flaminatus non fu il membro dell’ordo decurionum [D 42]. Un’altro fu decurio nella sua città prima del flaminatus [D 72]. Il D 53 fu il membro dell’ordine equestre e fu decurio in varie città [D 53]. Nelle città dove lavorò come flamen, non indicò il decurionatus, ma il suo stato equestre era più alta del decurionatus, anche se questo non aveva importanza amministrativa nella data città. Probabilmente nel dato municipium fu solo flamen, ma conocorse al flaminatus come eques. Il D 13 divenne flamen dopo il IIIIviratus e l’ufficio quinquennalis. In base ai dati, la condizione fondamentale del flaminatus municipale doveva essere la cittadinanza romana, e, come dimostra l’esempio del D 58, si doveva sacrificare anche finanziaramente al bene pubblico per la carica sacerdotale. Nei cursus honorum coloniali il flaminatus ha i posti seguenti: D 50 – flamen, patr(onus) coll(egi) fabr(um). D 41 – flamen col(oniae). D 71 – flamen col(oniae). D 14 – fl(amen) col(oniae), conduc(tor) pas(cui) et salina(rum). D 53 – trib(unus) leg(ionis), dec(urio) munic(ipi)(1), dec(urio) munic(ipi)(2), flam(en) munic(ipi)(3) flam(en) col(oniae)(2), IIvir col(oniae)(1), dec(urio) col(oniae)(3). D 75 – [dec(urio)] colo[n(iae)(1)], fl(amen) coloniarum(1, 2), eq(uo) p(ublico), praef(ectus) coh(ortis), eq(uo) p(ublico) a mil(itis), flam(en) colo[n(iae)(1)], q(uin)q(uennalis) col(oniae)(1), dec(urio) [mu]nic(ipi)(1), patro[nus m]unic(ipi)(2), patro[nus colle]gior(um), patro[nus cau]sarum - 1. fl(amen) coloniae(2) – si ritirò = flaminicius - 2. [dec(urio)] colo[n(iae)(1)], flam(en) colo[n(iae)(1)]. D 38 – dec(urio), flamen col(oniae).
D 22 – [dec(urio)?] col(oniae) fl(amen)? D 66 – d[ec(urio)] col(oniae), d[ec(urio)] mun(icipi), flam(en), [I]Iv[ir], q(uin)[q(uennalis)] col(oniae), pa]t[r]onu[s] causarum col(oniae), [?e]qu{a}es [Romanus]. D 88 – [de]c(urio), flam[en], [---?]. D 89 – d]ec(urio), patro[n(us) coll(egi)? ---?], [fla]m[en col(oniae)] [---?. D 74 – d[ec(urio), ae[d(ilis)], flamen [col(oniae)], p[raef(ectus)] collegi [fab(rum). D 6 – dec(urio) col(oniae), eq(uo) p(ublico), q(uaestor?), eq(ues) R(omanus), flam(en), IIviral(is) col(oniae). D 82 – [---], [e]ques [Rom(anus], [flam]en, [IIvi]ral(is) col(oniae). D 52 – (---) flamen, q(uin)q(uennalis) prim(us) pro imp(eratore). D 4 – eq(uo) [p(ublico)], [praef(ectus) coh(ortis) I] Noric[orum], IIvir, fla[m(en)], patronus col(oniae). D 5 – decurio col(oniae), e(quo) p(ublico), q(uaestor?), a mil(itis), IIvir, flame[n] col(oniae), sac(erdos) Arae Aug(usti). D 15 – a militis, IIvir q(uin)]q(uennalis), fla[men col(oniae)(1), [sacerdos Ar]ae Aug(usti) n(ostri), [coronatus Dac(iarum) I]II, dec(urio) col(oniae)(2). D 87 – dec(urio) col(oniae), praef(ectus) coh(ortis), trib(unus) leg(ionis), decurialis tribunicius [---?], aedilic(ius) col(oniae), praef(ectus) q(uin)q(uennalis), flamen col(oniae). D 93 – dec(urio)? c]ol(oniae), [fla]men [col(oniae)], q(uin)q(uennalis) [col(oniae] [- - -?], [praef(ectus) c]o[l]l(egii) fa[b]ru[m - - -]. Sei su ventidue flamines coloniali conosciuti indicarono solo il flaminatus al dato posto come carica rivestita nella colonia. Uno [D 53] fu il membro dell’ordine equestre, così concorse alla carica non come cittadino romano medio. L’esempio del D 75 dimostra, che il decurionatus e le due cariche come flamen immediatamente prima dello stato equestre aiutavano verosimilmente l’ascesa sociale. Sei divennero flamines come decuriones, gli altri dopo la magistratura alta o bassa, oppure come equites. Sembra che anche nelle colonie daciche bastasse come condizione sociale la cittadinanza romana per la carica di flamen. Inoltre era necessario fare un contributo di carattere finanziario per il bene pubblico, come è dimostrato tramite gli esempi del D 38 e del D 58. La maggior parte dei flamines coloniali era una persona di alto livello nella vita sociale al momento dell’acquisto della carica sacerdotale. Le condizioni personali rintracciabili del flaminatus nella Dacia Dall’elenco sopra si rivela, che le condizioni fondamentali del flaminatus nelle città daciche erano la cittadinanza romana e l’ottimo stato finanziario. Ciononostante in qualche luogo, dove anche la struttura sociale era fatta così, i concorrenti al flaminatus venivano solo dai ceti alti della società. La durata del flaminatus Si può identificare un solo flamen, che si ritirò verosimilmente dal flaminatus, ma mantenne la carica di flamen occupata in un’altra città [D 75]. Il ritirarsi dal flaminatus nella prima città poteva avere motivi personali. Per quanto riguarda gli altri, non rinvia niente alla durata limitata della carica. Quindi è molto probabile, che nella Dacia la carica del flamen durasse a vita, in contrasto con certi flaminatus annuali nelle province africane.13 In base ad un dato, l’inizio della carica non era in connessione nemmeno con l’età maggiore [D 58]. Il numero dei flamines Non si può nemmeno stimare il numero totale dei flamines dacici, non solo per la mancanza delle fonti, ma anche per il suo carattere a vita. Non si può dire neanche il loro numero nelle singole città, ma sembra, che un municipium avesse solo un flamen nello stesso tempo, mentre le colonie ne avessero probabilmente due, questo però è dimostrabile con dati solo nel caso di Sarmizegetusa. Il flaminatus e le altre cariche sacerdotali I flamines non avevano altre cariche sacerdotali nello stesso luogo e nella stessa struttura giuridica e municipale, e in generale neanche in altri luoghi con l’eccezione di una parte irrelevante. Conosciamo un solo caso, dove un flamen di Porolissum indicò anche un sacerdotium [D 13], ma questo sacerdotium non appartiene alla stessa città e al mondo tradizionale della religione romana. Nella sua città fu solo flamen. Due flamines divennero sommi sacerdoti della provincia [D 5, 15], ma, da un lato, questa carica era fuori la struttura municipale, dall’altro il suo carattere è identico a quello del flaminatus per quanto riguarda il culto imperiale. Altri due furono flamines Laurentes Lavinates [D 71, 76], ma il flaminatus in un’altra città non
era in nessuna contraddizione con quello già esistente [cfr. D 53, 75], e non poteva essere incompatibile con il flaminatus in un’altra città oppure fuori la provincia.
HARUSPEX Conosciamo un solo haruspex nella Dacia, il quale occupò la sua carica ad Apulum [ D 59], nella prima metà del III secolo d. C. Venne da un ambiente latino e fu cittadino romano. Secondo il titolo usato nelle sue iscrizioni fu un haruspex col(oniae), quindi una persona sacerdotale in carica ufficiale, impiegata dalla città. Durante la sua carriera rivestì diverse cariche: D 59 - cl[?inic]us l(oci), sacerdo[s] d[ei] [?], har(uspex) col(oniae), antistes loci, [---? Benché sia conosciuto tramite varie iscrizioni, non fece erigere nessuna di esse come haruspex. Abbiamo visto, che già la lex Ursonensis disponeva sugli haruspices e il loro mantenimento, ciononostante ci sono rimaste poche memorie su di loro nelle città provinciali, e anche nell’area danubiana è conosciuto solo questo l’unico haruspex nella Dacia. Né l’impiego ricevuto dalla città [v. Addendum 1. b.], né le disposizioni di Claudius potevano fermare la diminuzione degli haruspices, perciò Severus Alexander (222-235 d. C.) dovette disporre sul mantenimento statale dei cultori della disciplina etrusca.14 Per questo è molto probabile, che neanche l’haruspex dacico ricevette la sua carica ad Apulum prima dell’epoca di Severus Alexander. Come haruspex dovette avere ruolo sicuramente ai sacrifici comunali di Apulum, più precisamente allo studio degli organi interi. Non si può affermare, in quale rapporto stesse con gli augures locali, per quanto riguarda l’attività, ma in base ai criteri professionali generali, i compiti dei due gruppi non si coincidevano. La carica di haruspex durava a vita a causa del suo carattere, il che non significava però, che il haruspex era impiegato per tutta la vita da un insiedamento. Per la mancanza dei dati non si possono definire i limiti cronologici dell’impiego municipale nella Dacia. Nella Dacia, ad Apulum l’haruspicina, in base all’unico esempio conosciuto, era compatibile con il sacerdotium, per quanto riguarda i sacerdoti, e anche con le altre attività amministrative e professionali.
PONTIFEX
Conosciamo sedici pontifices nella Dacia, durante l’esistenza di 165 anni della provincia. Tutti erano cittadini romani. In generale i pontifices rivestivano anche una magistratura, ma c’è anche uno, che indicò solo il suo pontificatus. La maggior parte venne da un ambiente latino, ma vivevano nella provincia pontifices anche dell’ambiente greco [D 57] e orientale [D 12], mentre uno ebbe una madre di origine orientale [D 23]. Abbiamo pochissime fonti per trarre larghe conseguenze di valore generale. Il titolo della carica Il titolo è in tutti i casi pontifex, non sempre in questa forma intera, ma in forma più precisa pontifex municipi (in un caso in un epitafio civitatis, rinviando al municipium) o pontifex coloniae. Il titolo non era sempre indicato in questa forma intera, ma abbreviato in forme pont(ifex) [D 10, 84] e pontif(ex) [D 12, 23, 25, 46, 54, 56, 57]. La cronologia della carica nella provincia In ogni città si presuppone l’esistenza della carica pontificale sin dalla fondazione della città. Secondo le iscrizioni la cronologia determinabile dei pontifices conosciuti dura, senza una precisazione possibile, circa dalla metà del II secolo d. C. fino alla metà del III secolo d. C. La maggior parte risale all’epoca dei Severi. La diffusione della carica nella provincia e il suo luogo Tutti rivestivano la carica in una città, legata all’insediamento. Cinque furono pontifices municipali [D 12, 23, 24, 44, 84], undici pontifices coloniali [D 2, 3, 7, 10, 11, 25, 45, 46, 54, 56, 57]. Nessuno ebbe due pontificatus contemporanei in due diversi posti, in contrasto agli augures. Conosciamo pontifices nelle seguenti città: Apulum – colonia Aurelia [D 2, 3, 7, 10, 11, 57], Drobeta – municipium [D 24], Napoca – colonia [D 54], Porolissum [D 23, 44, 84], Tibiscum [D 12], Sarmizegetusa [D 25, 45, 46, 56], quindi dalla metà delle città daciche. La sede della carica doveva essere un edificio all’interno della città, adatto a questo scopo, ma finora non è stata identificata una tale costruzione. I reperti epigrafici e i motivi delle dedicazioni Nella Dacia non si può identificare nessuna iscrizione eretta da un pontifex [per un esempio simile v. Addendum 6.]. La maggior parte è un’iscrizione votiva di carattere privato o sepolcrale, oppure la base di una statua ricevuta dai magistratus, che erano anche pontifices. Nessun’iscrizione è analizzabile dal punto di vista dell’attività sacerdotale. Sicuramente offrivano regolarmente i sacrifici alle determinate occasioni, ma su questi non nacquero iscrizioni, sarebbe proprio strano tenendo in considerazione l’usanza e i motivi generali della dedicazione.15 Il posto della carica nella carriera Nella carriera dei pontifices municipali il pontificatus ha i seguenti posti: D 12 – [pon]tif(ex). D 84 – pont(ifex) m(unicipi). D 44 – decurio, augur, pontifex civitatis. D 24 – pont[ifex], I[I -vir, -viralis] mun(icipi). D 23 – augur, [po]ntif(ex), q(uin)q(uennalis). Due indicarono solo il pontificatus [D 12, 84], e solo uno di loro segnalò il rango della città [D 84]. Uno divenne augur dopo il decurionatus, poi assunse un pontificatus [D 44]. Due divennero pontifex immediatamente prima del IIviratus oppure dell’ufficio quinquennalis [D 23, 24]. Uno di loro fu augur similmente prima del pontificatus [D 23]. In base all’elenco è evidente, che il pontificatus non aveva un posto determinato nel cursus municipale. Inoltre, bastava la cittadinanza romana come condizione fondamentale sociale per il pontificatus, ma il decurionatus oppure la magistratura potevano essere un vantaggio. A quest’ultimo rinviano il decurionatus e le magistrature di tre sui cinque pontifices municipali conosciuti. Ovviamente si dovette possedere una solida base finanziaria, ma non ci sono rimaste tracce delle donazioni fatte per il pontificatus nei municipia. Ne si conosce solo una in una delle colonie [D 56]. Il pontificatus ha i seguenti posti nella carriera dei pontifices coloniali conosciuti: D 54 – pont(i)f(ex) D 2 – pont[ifex] [col(oniae)], e[q(uo) p(ublico)]. D 3 – po[ntifex co]l(oniae), [eq(uo)] p(ublico). D 45 – pontif(ex) col(oniae), eq(ues) R(omanus), trib(unus) leg(ionis).
D 56 – dec(urio), pontif(ex) col(oniae). D 11 – eq(ues) R(omanus), pontif(ex), IIviral(is) coloniae D 46 – eq(uo) p(ublico), pontif(ex), q(uin)q(uennalis), praef(ectus) q(uin)q(uennalis) pro imp(eratore), bis q(uin)q(uennalis) col(oniae), patr(onus) coll(egi) fab(rum), eq(ues) R(omanus), sacerdos Arae Aug(usti). D 25 – dec(urio) col(oniae), e[q(uo) p(ublico)], p[o]ntif(ex) col(oniae), [?fisci a]dvoc[?atus], [---?] D 57 – II[vir(alis)] col(oniae)(1), sacerd(os) dei Aes[cul(api)], pontif(ex), q(uin)q(uennalis) IIvir col(oniae)(2). D 7 – dec(urio) col(oniae), eq(uo) p(ublico), q(uaestor?), pontifex col(oniae), patron(us) colleg(i) cent(onariorum), [I]Ivira[lis c]ol(oniae). D 10 – dec(urio), [?II]v[?iral(is)], pont(ifex), augur col(oniae)(1); decurio, augur col(oniae)(2), dec(urio) mun(icipi). Uno di loro non indicò altro solo il suo stato sacerdotale [D 54]. Tre cominciarono la loro carriera con il pontificatus, poi salirono nell’ordine equestre [D 2, 3, 45]. Uno divenne pontifex come decurio [D 56], mentre il D 25 assunse il pontificatus come decurio ed eques. Due indicarono solo la loro appartenenza all’ordine equestre prima del pontificatus, ma, dato che dopo si leggono il duumviratus e la quinquennalitas, prima dovettero occupare anche le magistrature basse. Non si può affermare, quando divennero pontifices [D 11, 46]. Anche la carriera del D 7 e del D 57 è simile dal punto di vista del pontificatus. Uno di loro divenne pontifex probabilmente dopo il IIviratus [D 10]. Nell’elenco si può vedere, che anche nelle colonie la condizione sociale del pontificatus era in generale la cittadinanza romana, ma a causa della composizione degli abitanti c’erano più persone di rango alto con il pontificatus rispetto ai muncipia. Sette su undici pontifices, quindi la maggioranza, fu il membro anche dell’ordine equestre. Questo fenomeno rinvia al prestigio più alto e all’importanza più grande dell’ufficio pontificale rispetto alle altre cariche sacerdotali. Un’iscrizione di Sarmizegetusa tramanda una donazione per il pontificatus, cioé una costruzione [D 56]. Probabilmente era necessario anche il contributo finanziario per esser eletti, ma nella maggior parte dei casi non ce ne sono rimaste tracce. Il pontificatus e altre cariche sacerdotali Quattro su sedici pontifices rivestirono anche altre cariche sacerdotali nella stessa città [D 10, 23. 44. 57], mentre uno fu sommo sacerdote, fuori il sistema municipale [D 46]. Tre delle quattro persone con altre cariche sacerdotali furono non solo pontifices, ma anche augures [D 10, 23, 44], uno augurava in due diverse città [D 10]. Oltre l’auguratus i pontifices potevano rivestire, secondo l’esempio di uno di loro, anche il sacerdotium: nel caso conosciuto il pontifex fu il sacerdos di Aesculapius prima del pontificatus [D 57]. Il pontificatus insieme all’auguratus è in armonia con la legge delle città presentata sopra [cfr. Addendum 1], che tratta insieme le due cariche sacerdotali con doveri e privilegi identici. Solo il sacerdotium di Aesculapius sembra strano, ma il culto di Aesculapius fu integrato a Roma già nell’epoca repubblicana,16 perciò una carica sacerdotale per la coordinazione della religione non sembra essere in contraddizione con un sacerdotium ufficiale, soprattutto se teniamo in considerazione, che il domare dell’epidemia di peste17 durante le guerre marcomanniche fu un compito non solo medico, ma anche amministrativo, che fu accompagnato dalla fondazione dei Asklepieiones.18 La carica sacerdotale per Aesculapius desiderava professionalità, il sacerdote fu praticamente un medico. Il carattere singolare del fenomeno dimostra però che il sacerdotium e il pontificatus contemporaneo non era molto frequente. Sono conosciuti pochissimi sacerdoti di Aesculapius, egli è un fenomeno raro anche da questo aspetto. I due sacerdoti di Aesculapius conosciuti rivestirono anche magistrature alte nella città e furono i membri dell’ordine equestre [D 57, 68]. Il numero dei pontifices e la durata dell’ufficio Una città sembra avere contemporaneamente un solo pontifex, eccezioni possono essere la colonia Aurelia Apulensium e Sarmizegetusa, ma non si conosce un’iscrizione con due pontifices contemporanei in nessuno di questi posti. Il solo pontifex non poteva formare un collegium (magari insieme al flamen), ma rappresentava il collegium dei pontifices. Naturalmente nel futuro può venire alla luce una fonte, che documenta l’esistenza di due pontifices contemporanei nella stessa città. Secondo la legge conosciuta, che è la base della comparazione, potevano essere almeno in tre, ma non è sicuro, che nelle città daciche vivessero tante persone, che si potevano permettere i debiti del pontificatus. In base alle fonti esistenti sembra che nelle altre città non ci fossero molte persone adatte a questa carica. Nei municipia esisteva probabilmente un solo ufficio pontificale. In base al numero dei flamines ed augures una colonia poteva avere eventualmente due pontifices, ma anche da questo punto di vista stanno poche fonti a disposizione, così questa teoria non è dimostrabile in contrasto per esempio ad alcune città pannoniche.19 La carica poteva essere occupata già da molto giovane, ad esempio il D 45 divenne pontifex prima della carriera militare equestre. Non conosciamo pontifices emeriti nella provincia, la carica poteva durare a vita, similmente a Roma, ed alle città di alcune province occidentali ricche di fonti epigrafiche.20
SACERDOS Conosciamo trentacinque sacerdotes nella Dacia, tre occuparono il sacerdotium in due luoghi, così il numero degli uffici occupati conosciuti è trentotto. È il gruppo sacerdotale più composto dato che è formato dai sacerdoti di diverse correnti religiose. L’unico rapporto tra i diversi sacrdotia è praticamente la definizione latino-romana del loro stato sacerdotale, tramite cui si integravano nel sistema della vita religiosa del mondo romano. Furono tutti uomini, e la maggior parte fu cittadino romano. Vennero dall’ambiente latino o greco, la maggior parte dall’ambiente greco secondo il carattere del sacerdotium. In base alle fonti rimaste non si può decidere il carattere ufficiale o inufficiale del loro sacerdotium, rivestito nel II. secolo d. C. Si può solo affermare, che quelli, che indicavano la loro appartenenza ad una città oppure ad un’entità giuridica (per esempio ad una truppa) avevano un sacerdotium senza dubbio ufficiale. Dall’altra parte, se si può localizzare il luogo del santuario, in cui praticavano la carica, e se questo santuario stava su un’area pubblica (locus publicus), il sacerdotium è considerato similmente ufficiale. Dal III secolo d. C. però tutti potevano lavorare quasi sempre ufficialmente, grazie all’emancipazione delle divinità fin a quel tempo considerate assunte e i loro culti, la quale era il risultato dello stato giuridico uguale – quindi della cittadinanza romana – di tutti gli abitanti dell’Impero Romano ottenuto tramite la Costitutio Antoniniana (212 d. C.). L’imperatore della Costitutio rese possibile ai nuovi cittadini prendere parte al culto degli dei insieme con lui. In base alle fonti si può rischiare anche l’affermazione, che i sacerdoti con un titolo diverso dal nome generale della funzione nel grembo della data religione, quindi quelli con il titolo giuridico sacerdos erano impiegati ufficialmente già nel II. sec. d. C. Chi non aveva un titolo giuridicamente interpretabile, ma era al servizio di una delle religioni come persona sacerdotale, con la sua attività stava più vicino alla religione privata oppure ci apparteneva totalmente. La persona con il titolo sacerdos poteva essere un sacerdos coloniae o municipi, eventualmente il suo sacerdotium era presso una truppa, ma solo in senso locativo. Il sacerdotium non può essere studiato entro il cursus honorum municipale, mica tanto quanto gli uffici tradizionali romani, perché era fuori questo sistema. Ciononostante molte persone con l’ufficio di sacerdos prendeva parte alla direzione delle città, che dimostra l’importanza locale dei singoli sacerdotia. Per quanto rigurada la classificazione sacerdotale del sommo sacerdote della provincia le cariche sacerdotali delle colonie potevano contare tra gli uffici di alto rango, soprattutto quelli in rapporto con la sede del consiglio provinciale [cfr. ADDENDUM 2.]. I sacerdotes delle città Oltre allo stato sacerdotale delle due persone conosciute, si legge nelle iscrizioni solo l’indicazione del rango della città, quindi non si può determinare a quale religione appartenevano i sacerdoti, ma in un caso lo si può ipotizzare. D 19 - IIvir(alis), sacerd(otalis) [co]l(oniae), eq(ues) R(omanus) D 51 - sacerd(os) col(oniae), cond(uctor) ferrar(iarum). Nel caso del D 19 non si può dire, quale carattere aveva il sacerdotium, dato che lo conosciamo tramite la sua iscrizione sepolcrale. La parola sacerdotalis rinvia ad un sacerdotium occupato nel passato, il che, nel caso di un defunto, è solo l’affermazione del fatto della morte. Ma il sacerdotium poteva significare qualsiasi carica sacerdotale entro la città, la quale il dedicatore dell’epigrafe non volle indicare precisamente. In base al suo stato sociale, l’ufficio occupato poteva essere qualsiasi carica tradizionale sacerdotale. Non si può definire neanche il sacerdotium del D 51, si può dire solo, che fu impiegato dalla colonia, perciò aveva una carica ufficiale.21 Possibilmente amministrò un culto, a cui i sacerdoti coloniali della religone ufficiale dello stato non erano adatti. Dedicò il suo altare al numen dell’imperatore insieme ad un Augustalis, per questo non è impossibile, che il suo sacerdotium fosse in un rapporto precisamente non determinabile con il culto imperiale della città. I sacerdoti di Aesculapius I due sacerdotes conosciuti di Aesculapius lavorarono ad Apulum, dove l’Asklépieion, costruito dopo le guerre marcomanniche, si estendeva in un territorio vasto.22 Ambedue i sacerdoti furono i membri del ceto dirigente della città, inoltre uno di loro fu anche pontifex. Le loro carriere si svolgevano così: D 57 - II[vir(alis)] col(oniae)(1), sacerd(os), pontif(ex), q(uin)q(uennalis) IIvir col(oniae)(2) D 68 - eques Romanus, IIviral(is) col(oniae), sacerdos. Nei loro casi non si può affermare, quanto sia cronologico questo elenco. Se tutti e due rispecchiano una vera cronologia, allora indicarono l’inizio del loro sacerdotium ufficiale nella città. Dovettero però imparare già prima la scienza medica, altrimenti non potevano diventare i sacerdoti di Aesculapius. La loro carica sacerdotale coloniale dovette essere contemporanea con la fondazione dell’Asklépieion nella colonia Aurelia di Apulum, la datazione delle loro iscrizioni è posteriore alla costruzione. I sacerdoti di Deus Yarhibol (Hierobulos)
Sono conosciuti due sacerdotes, uno di loro inidcò precisamente, a chi serviva, l’altro è ritenuto il sacerdote della divinità soltanto a causa della dedicazione. Tutti e due fecero erigere le iscrizioni ad Apulum. Uno di loro [D 17] fu di Apulum, l’altro fu il decurio della colonia di Aequum nella Dalmatia [D 28]. D 17 - sacerd(os) D 28 - dec(urio) col(oniae), sacerd(os) Quest’ultimo non conta tra i sacerdoti della Dacia, al massimo temporaneamente. Dal punto di vista della Dacia e di Apulum nessuno di loro occupò una carica, ma anche il D 17 aveva la cittadinanza romana. La dedicazione delle iscrizioni dei due sacerdotes ad Apulum si dovette svolgere nello stesso santuario. Siccome non sappiamo, dove si trovasse questo edificio, e non si può identificare neanche il collegium ufficiale dei fedeli, non si può decidere, se la loro carica sacerdotale fosse ritenuta localmente ufficiale o meno. I sacerdotes di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus Il culto e la storia dei sacerdoti di Iuppiter Dolichenus è il tema dettagliatamente studiato della storia della religione romana nell’area danubiana.23 Conosciamo ventidue persone con il titolo sacerdos nella Dacia, i quali furono in servizio di ‘Iuppiter Dolichenus’ o delle divinità appartenenti a lui. Nella maggior parte dei casi il loro sacerdotium per la divinità è stato identificato in base alla dedicazione dell’iscrizione, cioé non esclusivamente ma molto probabilmente. La maggioranza dei sacerdoti fu di origine orientale, ma un’altra parte, secondo i nomi, venne da un ambiente latino. Questi ultimi dovevano essere persone convertite localmente che poi aderirono al servizio della religione e rivestirono una carica sacerdotale. Il titolo dei sacerdoti di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus è sempre sacerdos, a volte era indicato dettagliatamente anche il nome della divinità, oppure segnalavano il loro stato sacerdotale in forma sacerdos dei o sacerdos templi rinviando alla dedicazione. Più volte appaiono in gruppo, la cui manifestazione è la costruzione comune di un santuario. In generale lavoravano in una città, ma generalmente in un insediamento vicino al campo di una truppa militare. Alcuni indicavano il loro sacerdotium presso una truppa, a volte rivestivano la loro carica contemporaneamente nella città e presso la truppa al servizio della stessa divinità. Carattersiticamente, l’ultima città dove apparirono, fu il centro civile della provinicia. La cronologia delle loro iscrizioni dura dall’ultimo decennio del II secolo d. C. circa fino alla metà del III secolo d. C. La maggior parte risale all’epoca dei Severi. Undici indicarono nelle iscrizioni solo il loro stato di sacerdos: D 1 – sacerdos. D 49 – [sace]rdos. D 61 – [sace]rdos. D 62 – sacerdos. D 63 – sace[r]dos. D 64 – [sace]rdos. D 65 – [sace]rdos. D 69 – sacerdos. D 77 – [sace]rdos. D 79 – [sace]rdos. D 35 – sacerdos. Sei [D 49, 61, 64, 65, 77, 79] fecero costruire in comune il Dolichenum a Sarmizegetusa, entro le mura della città. Il luogo del santuario rinvia al carattere ufficiale della loro carica, quindi loro, oppure almeno una parte di loro, appartenne ai sacerdoti coloniali di Sarmizegetusa. Uno indicò che il suo sacerdotium fu legato ad un dato posto. D 81 – sacerdos te[mpli]. Probabilmente al momento della dedicazione egli non appartenne più ai sacerdoti missionari di Iuppiter Dolichenus.24 Il D 37 è conosciuto tramite un’iscrizione fuori la provincia dall’epoca di Severus Alexander (222-235 d. C.), secondo di cui egli fu un sacerdos e commerciante di vino: D 37 - iereuj kai unemporoj. Il suo sacerdotium dovette essere in rapporto con il primo Dolichenum di Porolissum, il cui è conosciuto solo tramite ritrovamenti sporadici, e non con il secondo Dolichenum, costruito sotto Gordianus III (238-244 d. C.). Sembra che la distruzione generale dei santuari nel 235 d. C. al Reno e al Danubio25 non evitò nenanche il primo Dolichenum di Porolissum. Sono conosciuti altri tre sacerdotes a Porolissum, che furono i sacerdoti contemporanei di Iuppiter Optimus
Maximus Dolichenus sotto Gordianus III. Questi ultimi rivestirono anche magistrature nella città, e svolsero anche il sacerdotium di una delle cohortes a Porolissum: D 26 – vet(eranus), dec(urio) o[rnat]us ornam(entis) IIIIvir(alibus) m(unicipi), sacerdos dei, sacerdos coh(ortis). D 30 – dec(urio) m(unicipi), vegesi[m]a[r(ius)], sacerdos dei, sacerdos coh(ortis). D 31 – s(acerdos) dei, sacerdos coh(ortis), IIIIvir m(unicipi). Il secondo Dolichenum di Porolissum fu costruito da questi ultimi, sotto Gordianus III. Inoltre fecero costruire tabernae nel complesso del Dolichenum, perciò anche loro dovettero esser interessati nel commercio di vino, come anche il loro collega con l’iscrizione dedicata alcuni anni prima nella Thracia [D 37]. Oltre che rivestirono magistrature nella città, anche il Dolichenum stesso si trovava entro le mura della città.26 Ambedue i fatti rinviano a ciò che nella prima metà del III secolo d. C. i sacerdotes di Iuppiter Dolichenus appartennero ai sacerdoti ufficiali della città. Uno dei sacerdoti della divinità dolichena fece indicare che fu stato veteranus prima del sacerdotium: D 21 – vet(eranus), sacerdos. Ebbe sicuramente la cittadinanza romana, l’inizio del suo sacerdotium però non è databile. Non si può affermare, se fu sacerdote già durante il servizio militare. Presso le truppe delle armi lavoravano verosimilmente sacerdoti di stato civile, come si vede nel caso di D 48. Egli non indicò, se fosse soldato, solo che come sacerdote apparteneva alla legione:27 D 48 – s(acerdos) ad leg(ionem). Questo è uno degli esempi rilevanti nell’impero della carica sacerdotale orientale presso una legione. Il fenomeno non era frequente, nel caso delle truppe ausiliari capita più volte. Riassumendo si può dire, che i sacerdotes di Iuppiter Dolichenus nella Dacia apparivano più volte collettivamente, ma non rinvia niente a ciò, che formassero un collegio sacerdotale. Sembra che fossero pratici presso le diverse truppe militari. Secondo il luogo dei loro santuari nella città, la loro religione e la loro esistenza furono accettate nella prima metà del III secolo d. C. nel cerchio degli altri sacerdoti della città. Molti avevano interessi commerciali, erano in rapporto anche con persone che vivevano proprio dal commercio, il che era in connessione anche con la loro origine siriaca.28 Uno di loro, benché dedicò il suo altare a Dea Suria, può essere ritenuto il sacerdos di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus, dato che le due divinità appartenevano allo stesso panteon: D 32 – dec(urio) m(unicipi), sace(r)do[s] Egli fu di origine orientale e salì all’ordo decurionum. La sua carica sacerdotale, l’espansione generale del culto anche nella sfera civile, l’acquisto dei beni necessari per il decurionatus e l’attività commerciale dei sacerdotes sono fenomeni in connessione stretta. Questo fenomeno a Porolissum è illustrato dai sacerdoti sotto i numeri D 27, 30, 31. Tre di loro segnalarono sull’altare dedicato a Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus soltanto la carica sacerdotale, indicata in rapporto con una truppa militare. D 90 – sacer(dos) c(o)ho(rtis) D 91 – sacer(dos) c(o)ho(rtis) D 92 – sacer(dos) c(o)ho(rtis) La sfera civile non fu indicata come il luogo della carica, ma dato che le truppe menzionate erano di stanza vicino alle città, non è impossibile, che prendessero parte anche alla vita religiosa della città [cfr. D 26, 30, 31]. I sacerdotes delle truppe Numerose persone sacerdotali indicarono la loro carica in connessione con una truppa militare. La caratteristica comune di questi sacerdoti, che tutti avevano il titolo sacerdos ed erano in servizio del culto di una divinità orientale, nella prima metà del III secolo. La più importante è senza dubbio la carica del sacerdos presso la legione di Apulum: D 48. Il suo altare fu dedicato non solo alla sua divinità, ma anche a Dea Suria Magna Caelestis. Nel primo terzo del III secolo d. C. il numero dei soldati fedeli a Iuppiter Dolichenus nella legione dovette aumentare tanto, che oltre il personale per il culto della tradizionale religione militare si dovette impiegare anche un sacerdote di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus. Si può osservare probabilmente lo stesso fenomeno anche a Porolissum, dove i tre sacerdoti di Dolichenus della città (tra di cui c’era anche un alto magistrato) servivano anche a una delle cohortes con il titolo sacerdos cohortis: D 26, D 30, D 31. Si può osservare un fenomeno simile anche a Drobeta, dove tre sacerdotes contemporanei in carica (D 90, D 91, D 92) dedicarono insieme un altare a Iuppiter Dolichenus nella prima metà del III secolo d. C. Benché non sia descritto dettagliatamente, che cosa siginificava il sacerdotium presso una cohors, il fatto, che i porolissensi sicuramente, i drobetensi verosimilmente furono i sacerdoti di Iuppiter Dolichenus, rinvia a ciò, che anche presso le truppe indicate loro furono in servizio del culto di una divinità orientale, presumibilmente proprio di quello di Iuppiter O(ptimus)
M(aximus) Dolichenus e del pantheon dolicheno. Nell’epoca dei Severi la divinità e il suo cerchio ebbero un ruolo particolarmente importante nella vita religiosa delle armi, soprattutto lungo il Reno e il Danubio.29 Oltre ai sacerdoti della divinità dolichena fu in servizio un altro sacerdote con il titolo sacerdos presso la truppa irregolare, organizzata in base etnica, il quale non indicò il nome, e oltre alla sua carica sacerdotale egli appartenne ai alti magistrati della città vicina, anzi, fu il flamen della città: D 13. I sacerdotes dei palmiresi Conosciamo due sacerdotes nella Dacia, che sembrano aver rivestito un sacerdotium anche presso le truppe organizzate etnicamente. Ambedue i sacerdotes furono in servizio della vita religiosa dei palmiresi, sottolineando la loro carica di base etnica: D 9 – adve[n]tor huius templi, sacer(dos) creatus a Pal[myre]nis, de[c(urio) col(oniae)?]30. D 13 – q(uin)q(uennalis), flamen mun(icipi), sacerdos dei n(umeri) P(almyrenorum). Il D 9 venne dalla Macedonia al territorio di Sarmizegetusa, dove diventò sacerdos presso il numerus Palmyrenorum Orientalium di stanza nell’odierna Voislova, in un tempio, dove anche lui fu un forestiero, quindi una persona assunta nella comunità originale. Il D 13 rivestì magistrature importanti a Tibiscum, e inoltre fu anche il sacerdos del deo della truppa palmirese di stanza vicina alla città. Si conoscono varie divinità palmiresi nella Dacia, in questo caso non si può decidere, a quale di loro rinvia il sacerdote, oppure quale di loro si nasconde sotto la divinità indicata irregolarmente.31 Nel retroscena del fenomeno sta sicuramente una prescrizione severamente rispettata della religione, la quale vietò di pronunciare e di scrivere, quindi di svelare il nome della divinità. Sacerdotia indeterminabili Ci sono sei persone nella Dacia con il titolo sacerdos, il cui sacerdotium non può essere determinato precisamente, o lo si può collegare solo con riserva alla divinità menzionata nella dedicazione delle loro iscirzioni, oppure manca proprio il nome della divinità. Tutte le iscrizioni sono venute fuori nel territorio di diverse città, perciò queste persone possono essere considerate praticamente sacerdotes impiegati dalle città. La loro origine è diversa, quindi vennero nella Dacia da un ambiente latino, greco oppure orientale: D 33 – sacer(dos). D 34 – sacer(dos). L’altare dedicato da loro a I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et H(e)rquli Invicto et Liber(o) Pa[t(ri)] rispecchia la religiosità imperiale a Potaissa nell’epoca dei Severi.32 Si può affermare lo stesso sull’altare dedicato da Reginus di Apulum: D 80 – s[ac]erdos [i]n[s]titutus a consulare. Egli dedicò un altare a Hercules dopo il 178-180 d. C.33 La preferenza di Commodus (180-192 d. C.) al culto di Hercules fu conosciuto da tutti, anzi, più tardi l’imperatore si identificò con Hercules stesso.34 Il sacerdote fu investito dal luogotenente, che è un fenomeno raro, e dimostra l’importanza non solo locale dell’ufficio sacerdotale. Questo non dimostra, ma ipotizza, che il luogotenete con il diritto di dedicazione investì eventualmente non solo Reginus, ma inaugurò tutta l’area sacra del suo ufficio (Locus) investendo così non solo lui, ma anche altri sacerdoti, che sono ancora sconosciuti da questo punto di vista. Uno dei sacerdoti fu in servizio anche al culto di una divinità verosimilmente medica, ma sconosciuta per lo stato frammentario dell’iscrizione: D 59 – cl[?inic]us l(oci), sacerdo[s] d[ei], har(uspex) col(oniae), antistes loci, [---? Un sacerdote proveniente dall’area greca fu in carica in uno dei santuari (aedes) di I(uppiter) O(ptimus) M(aximus) C(onservator) dell’area sacra di Apulum. Questo santuario funzionava probabilmente anche da ostetricia. Il sacerdote si definì semplicemente sacerdos, ma con l’indicazione generale del luogo del suo servizio: D 78 – sacerdos loci.35 Riassumendo si può affermare, che i sacerdoti con il titolo sacerdos non formavano un ordine unitario sacerdotale nella provincia, ed erano in servizio di diverse correnti religiose. Una parte di loro svolse i compiti dei sacerdotes localmente, ed era impiegata sicuramente dalla città. Sul resto questo si può solo ipotizzare. Non ci forniscono più informazioni del loro sacerdotium neanche i motivi della dedicazione degli altari, li fecero erigere ex voto, come tutti nell’Impero Romano. È molto alto il numero dei sacerdotes di Iuppiter O(ptimus) M(aximus) Dolichenus, nell’epoca dei Severi loro furono i sacerdoti più attivi sia in ambiente civile che in quello militare. Grazie al gran numero dei loro fedeli, agli interessi commerciali e ai beni acquistati, molti di loro salirono nel ceto dirigente delle città. Non conosciamo nessun sacerdos emerito nella Dacia, l’unico sacerdotalis con questo titolo si conosce tramite la sua epigrafe sepolcrale. Sembra che tutti portassero il sacerdotium a vita, ciascuno nella sua comunità.
LAURENTES LAVINATES Sono conosciute tre persone daciche che rivestirono una delle cariche sacerdotali equestri dei Laurentes Lavinates sia nel II che nel III secolo d. C. In questa qualità non appartengono ai sacerdoti della provincia di Dacia, perché ricevettero la loro carica come onore dall’imperatore, dopo il servizio militare [D 76. 8]. Nel terzo caso l’iscrizione frammentaria non rende possibile la ricostruzione degli elementi precedenti della carriera [D 70]. Due di loro ebbero un flaminatus anche nella provincia [D 76, 70]. D 8 – cent(urio) frum(entarius), subprinceps peregrinorum adstatus et princeps et primipilus leg(ionis), adle[c]tus ad munera praefe[c(torum)] legg(ionum), v(ir) e(gregius), flamen lucularis Laurent(ium) Lavina[t(ium)] = sacer(dos) Lauren[t(ium) Lavi]nat(ium), patronus et decurio coloni(a)e, patronus civitat(um) D 70 – IIvir, flamen col(oniae), (---?), sacerd(os) (= flamen?) Laurentium Lavinat(ium). D 76 – dec(urio) col(oniae)(1), eq(ues) R(omanus), omnib(us) milit(is) perfunc(tus), v(ir) e(gregius)?, dec(urio) col(oniae)(2), flam(en) col(oniae)(1), flam(en) Laurentinus. Non si può dire, come potessero loro partecipare alla vita religiosa della città nell’Italia oppure alle feste latine dalla Dacia. La ricerca non si è occupata finora della questione se ci sia un rapporto tra l’apparizione della carica del flamen Laurens Lavinas nella Dacia e l’esistenza delle città daciche con il ius Italicum, dato che queste città potevano partecipare teoricamente al culto commemorativo dell’alleanza antica tra le città latine dell’Italia. Forse addirittura per questo, e non per caso, esiste questa carica sacerdotale nella provincia, in contrasto alla Pannonia, dove non rinvia niente all’esistenza né di questo titolo sacerdotale, né dell’ius Italicum.36
Note
1 Cfr. per es. Coarelli 1973, 9-21. 2 Cfr. Á. Szabó 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. 3 Cfr. Á. Szabó 2004 (Orbis Antiquus), 801. 4 Cfr. per es. Lorenz 1987. 5 V. AÉ, 1961: 2 = RSS 44 = RIU 1; cfr. inoltre Alföldy 1960, 157. 6 Per un tal posto cfr. Carandini 2000. 7 Cfr. Ardevan 1998, 619, Fig. 8 e Piso, IDR, III/5, XIX, Pl. III. 8 CIL III, 4495 = Vorbeck 1980a, 76 = Szabó 2006, P 45 – Pannonia Superior, Carnuntum. 9 Per una sintesi precedente v. Ardevan 1992, 47-53. La presupposta esistenza del flaminatus annuale nella Dacia sembra inverosimile. 10 Per una sintesi v. Saulnier 1984, 517-533; Mrozewicz 1993, 217-225. 11 Cfr. CIL III, 3362 = CIL III, 10347 = RIU 1377 = Alföldy 2004, 11-12 nr. 11 = Szabó 2006, P 2; AÉ, 1972: 363 = Szabó 2006, P 48b. 12 Cfr. anche Gabler 1966, 20-35. 13 Cfr. per es. Bassignano 1974; Marcillet – Jaubert 1987, 207-223.; Cid 1988, 157-164. 14 V. HA, Severus Alexander 44, 4 e 27, 6.; per la sintesi sugli haruspices v. per es. Thulin 1905-1909. 15 Come paragoni all’importanza della dedicazione delle epigrafi v. per es. i saggi di Alföldy – Panciera (Hg.) 2001. Sebbene qui si tratti piuttosto della pratica dedicatoria del ceto dirigente dell’impero, i nobili delle città provinciali imitavano questo ceto, e anche la motivazione e la tecnica erano le stesse, solo le apparenze erano a volte più modeste. 16 Cfr. Liv. 10, 47, 6 sg.; Ov. metam. 15, 622-744; Val. Max. de viris 22; cfr. inoltre Schmidt 1910, 31-46. 17 per una sintesi v. Kovács 2005. 18 Cfr. Kádár 1989, 1038-1061. 19 Cfr. Szabó 2006, II. 1. – Pontifex e III. 1. Aquincum. 20 Cfr. Ladage 1971, 78-80. 21 Cfr. Berger 1953, 687-688. 22 Per Aesculapius, per la sua famiglia divina e per i luoghi del suo culto v. Kerényi 1999 (K. Kerényi, Der göttliche Arzt. Studien über Asklepios und seine Kultstätten, Stuttgart 19481, 19982; per il culto di Aesculapius nell’area danubiana v. il saggio di Z. Kádár nell’edizione ungherese dello stesso volume: Asklépios-Aesculapius világa a Kárpát medencében, 67-73. Per il culto di Aesculapius nella Dacia v. anche Igna 1935; per l’Asklépieion di Apulum v. Crişan 1971, 341-347; Alicu - Crişan 2003, 89-94; Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. 23 Per quanto riguarda la Dacia v. Sanie 1989, 1165-1271; Gudea-Tamba 2001. 24 Cfr. Tóth I. 1976, 15-39. 25 Cfr. Tóth I. 1976, 69-90. 26 Cfr. Gudea–Tamba 2001. 27 Cfr. anche B. Angyal 1971, 5-26; B. Angyal 1972 (1974), 149-175. 28 Cfr. Balla 1976, 61-81. 29 Cfr. la sintesi di Speidel 1978. 30 V. anche Tóth I. 1970, 278-281. 31 Cfr. Sanie 1989. 32 Cfr. anche Bărbulescu 1984, 144-145. 33 Cfr. anche Szabó Á. 1999 (2000), 119-150. 34 V. HA, Commodus Antoninus 8; Septimius Severus nominò per Commodus un sacerdote sacrificante con il titolo Herculaneus Commodianus, v. ibidem 17. 35 Cfr. anche Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. 36 Cfr. Gostar 1969, 127-139; Ferenczy 1984, 1053-1058; Saulnier 1984, 517-533; Mrozewicz 1993, 217-225; Ardevan 1998, 235-239.
I SACERDOTI DEGLI INSEDIAMENTI
AMPELUM1 Municipium Septimium Ampelensium Il territorio popolato per lo sfruttamento delle miniere nella Dacia Superior-Apulensis giaceva nella valle dell’Ompoly. Originalmente fu il pagus di Sarmizegetusa, poi forse della colonia Aurelia apulense. Ricevette il rango municipale sotto Septimius Severus, tra il 201 e 211 d. C. Ci sono rimaste relativamente poche iscrizioni con informazioni sull’insediamento. Da Ampelum si conoscono i seguenti titoli sacerdotali e i loro rappresentanti: Sacerdotes L’unico ufficio sacerdotale, i cui rappresentanti, e l’unica religione, i cui sacerdoti sono conosciuti da Ampelum. Sei sacerdotes di Iuppiter Dolchenus agirono ad Ampelum nella pirma metà del III secolo d. C.: D 62 – Marinus Marian(i filius) Bas(sus) - sacerdos. L’iscrizione è databile alla fine del II e alla prima metà del III secolo d. C. Per questo la sua attività non è ancora in connessione con il municipium, al massimo con il predecessore del municipium, oppure con il campo militare vicino e con i suoi soldati, tra di cui egli poteva far diffondere la fede. Poteva essere uno dei dedicatori del tempio menzionato dall’iscrizione seguente: D 81 – [---]do[rus] - sacerdos te[mpli] I(ovis) O(ptimi) M(aximi) D(olicheni). L’iscrizione è databile all’inizio del III secolo d. C. Non si può affermare, se il santuario menzionato nel testo, il cui sacerdos fu proprio lui, appartenesse al municipium oppure al suo predecessore. Ma il santuario esisteva anche nel periodo municipale, come si legge anche nel testo delle seguenti iscrizioni e dei altri reperti epigrafici dei sacerdoti conosciuti:
D 1
Adde bar Semei - sacerdos
D 35
Aurel(ius) Marinus - sacerdos
D 69
Oceanus Socratis - sacerdos
I tre sacerdoti agivano contemporaneamente già nel periodo municipale, nella prima metà del III secolo d. C. La loro esistenza collettiva è forse in connessione con il campo militare vicino.2 D 63 – Fl(avius) Maximu[s] Surus - sace[r]dos. L’epigrafe sepolcrale è databile alla fine del II e all’inizio del III secolo d. C. Non si può definire il carattere del suo sacerdotium, ma il suo nome relativamente frequente in ambiente dolicheno rinvia a ciò, che anche lui, come i suoi colleghi sopramenzionati, fu in servizio del culto di Iuppiter Dolichenus. Solo i sacerdotes di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus sono conosciuti ad Ampelum, il che può essere spiegato solo con la scarsezza del materiale epigrafico. Dopo la fondazione del muncipium dovettero nascere in breve tempo le istituzioni municipali, e così anche quella sacerdotale, perciò si può con ragione aspettare, che nel futuro rinverranno altre iscrizioni sui sacerdoti di Ampelum. Anche i dedicatori cult(ores) Iovis3 dell’iscrizione di Ampelum, eretta il 25 luglio 201 d. C., potevano avere un sacerdote appartenente alla loro religione o società, se l’iscrizione non rinvia di nuovo a Iuppiter Dolichenus.
APULUM4 Apulum fu uno dei sistemi urbani più complessi della Dacia, che all’inizio del III secolo d. C. fu composto di due città – una colonia e un municipium – e di un campo legionare, inoltre fu la sede del luogotenente, la quale formava un’unità indipendente dentro il complesso urbano al conflusso dei fiumi Maros ed Ompoly. Tra le due città apulensi c’era una necropoli, che rendeva impossibile qualsiasi attributio tra le canabae legionis e il municipium Aurelium.5 Municipium Aurelium Apulensium L’insediamento romano alla riva del Maros, sul territorio dell’odierno Marosportó (Partoş o Mureş-Port) era originalmente un pagus della colonia Ulpia Traiana Sarmizagetusa. Marcus Aurelius gli diede il rango municipale con il nome municipium Aurelium Apulensium, tra il 161 e 180 d. C. Il municipium, secondo le conoscenze attuali, esisteva fino al 180 d. C.6 Era governato dai quattuorviri. Da questo insediamento non si conoscono sacerdoti, ma i sacerdoti della religione statale ci lavoravano sicuramente, e anche i sacerdotes. Durante l’esistenza di poco più di un decennio della città ci potevano agire solo uno o al massimo due impiegati (uno dopo l’altro) delle cariche sacerdotali a vita con un solo rappresentante. Colonia Aurelia Apulensium Il municipium Aurelium Apulensium acquistò il rango coloniale da Caracalla verosimilmente nel 180 d. C., sotto il luogotenente P. Helvius Pertinax, con il nome di colonia Aurelia Apulenisum. L’elevazione del rango fu accompagnato dall’allargamento del pomerium. La città ricevette il ius Italicum all’inizio del III secolo d. C. Sotto l’imperatore Trebonianus Gallus (251-253 d. C.) anche il nome Chrysopolis divenne la parte della denominazione della città.7 Si conoscono i seguenti uffici sacerdotali e i loro rappresentanti nella città fino al 271 d. C., cioé durante i novant’anni della sua esistenza, di cui almeno l’ultimo decennio è incerto: Antistes Conosciamo tre antistites ad Apulum, nella colonia Aurelia. Il loro ufficio apparteneva al Locus, quindi all’area sacra della colonia Aurelia, i cui capi amministrativi furono loro. Benché il Locus esisté già alla fine del II secolo d. C., tutti e tre antistites conosciuti come i rappresentanti dell’antistitium risalgono alla prima metà del III secolo d. C.8 Occuparono l’ufficio verosimilmente in quest’ordine, uno dopo l’altro: D 29 – M(arcus) Aur(elius) Comat(ius) Super Alla fine del II secolo d. C. – peregrinus, dopo il 212 cittadino romano, antistes, dec(urio). D 59 – C(aius) Iul(ius) Valens Nel primo terzo del III secolo d. C. – cl[?inic]us l(oci), sacerdo[s] d[ei] [?], har(uspex) col(oniae), antistes loci, [---? D 40 – Cl(audius) Marcellus Nella prima metà del III secolo d. C. fu l’an(tistes) ad Apulum, nella colonia Aurelia, secondo la sua unica carica conosciuta. Uno di loro divenne il decurio della colonia [D 29], l’altro concorse forse ad un magistratus, secondo un’iscrizione attributa ipoteticamente a lui [D 59]. Del terzo si conosce solo un rilievo con la figura di Nemesis, donato da lui [D 40]. Augures Conosciamo tre augures della colonia, tutti e tre vissero nell’epoca dei Severi. Solo l’indicazione del rango coloniale della città fornisce informazione alla datazione delle iscrizioni, e di uno si sa, che fu il sommo sacerdote della provincia tra il 212 d. C. e una data sconosciuta del regno di Severus Alexander [D 20]. Non si può affermare, se rivestissero la carica augurale contemporaneamente oppure uno dopo l’altro. Prendendo come analogia i paragrafi 66 e 67 della lex Ursonensis [Addendum 1.] presentata sopra, teoricamente potevano essere anche augures contemporanei nella stessa colonia, formando in tre un collegium augurum della città: D 20 – P(ublius) Ael(ius) P(ubli) fil(ius) P(apiria tribu) Strenuus Probabilmente dopo il 180 d. C. – equo p(ublico), augur col(oniae)(2), dec(urio) col(oniae)(3), patron(us) collegior(um) fabr(um) centonar(iorum) et nautar(um), conduc(tor) pascui salinar(um) et commercior(um), IIviralis, augur col(oniae)(1), dopo il 212 d. C. sacerd(os) Arae Aug(usti). D 47 – F[a]b(ius) Pulcher Alla fine del II secolo d. C., al più presto dal 180 d. C. – [?decuri]o, aug[ur ---?] col(oniae). D 67 – C(aius) Numm(ius) Certus Al più presto dopo il 180 d. C. – eq(ues) R(omanus), (decurio coloniae), augur col(oniae), patr(onus) coll(egi) fab(rum) et dendr(ophorum) col(oniae).
Siccome non si può precisare il periodo della loro carica dopo il 180 d. C., ma le datazioni presupposte delle loro iscrizione sono cronologicamente molto vicine, si può ipotizzare, che agivano contemporaneamente almeno due augures nella città, alla fine del II secolo d. C. Però in base ai dati a disposizione non si può determinare, in quale ordine cronologico seguisse uno l’altro nell’ufficio, quali degli augures conosciuti fossero in carica contemporanemante, oppure se lavorassero in tre nello stesso tempo. È probabile, che alla fine del II secolo d. C. non solo un augur fosse in carica nella colonia Aurelia Apulensium, ma almeno due. Flamines Conosciamo sei flamines nella colonia Aurelia Apulensium, durante la fase di teoricamente novanta anni (oppure praticamente forse di circa un decennio meno) della vita normale della città. Il numero delle persone conosciute è relativamente poco, rispetto a quello, in quanti potevano essere in carica in questo periodo determinato. Le datazioni delle loro iscrizioni stanno in relazione con il rango coloniale ricevuto della città, quindi la cronologia dei flamines conosciuti dura dal 180 d. C. fino ad una data sconosciuta del regno di Severus Alexander, in base al titolo di sommo sacerdote del D 5. In base alla cronologia delle iscrizioni e della loro carriera, rivestivano l’ufficio flaminale nei periodi seguenti, alcuni forse contemporaneamente: D 41 - Tib(erius) Cl(audius) Rufus(1) Dopo il 180 d. C. – flamen col(oniae). D 22 – Ael(ius) Valent[inus](2) Dopo il 180 d. C. – fl(amen) col(oniae). D 66 – M(arcus) Munatius M(arci) f(ilius) [---]* Dopo il 180 d. C. – d[ec(urio)] col(oniae), dopo il 193-197 d. C. – d[ec(urio)] mun(icipi), flam(en), [I]Iv[ir], q(uin)[q(uennalis)], pa]t[r]onu[s] causarum col(oniae), [?e]qu{a}es [Romanus]. D 75 – T(itus) Varen(ius) T(iti) fil(ius) Pap(iria tribu) Pudens Dall’ultimo decennio del II secolo d. C. – [dec(urio)] colo[n(iae)(1)], fl(amen) coloniarum(1, 2), eq(uo) p(ublico), praef(ectus) coh(ortis) - eq(uo) p(ublico) a mil(itis), flam(en) colo[n(iae)(1)] (ritiratosi da uno dei flaminatus – flaminicius coloniae(2)); dall’inizio del III secolo d. C. q(uin)q(uennalis) col(oniae)(1), possibilmente già durante il cursus precedente dec(urio) [mu]nic(ipi)(1), patro[nus m]unic(ipi)(2), patro[nus] [colle]gior(um), patro[nus] [cau]sarum. D 6 – P(ublius) Ael(ius) Iulianus Dalla fine del II secolo d. C. – dec(urio) col(oniae), eq(uo) p(ublico), q(uaestor?), eq(ues) R(omanus), flam(en), IIviral(is) col(oniae). D 5 – P(ublius) Ael(ius) Antipater Negli ultimi decenni del II secolo d. C., dal 180 d. C. – decurio col(oniae), e(quo) p(ublico), q(uaestor?), a mil(itis), IIvir, flame[n] col(oniae), sac(erdos) Arae Aug(usti). I cinque flamines attivi, i quali – tranne il D 75 – rivestivano il flaminatus a vita, erano in carica per circa dieci anni a testa, in questo periodo relativamente breve di circa un mezzo centenario. Secondo le iscrizioni, le cui datazioni sono cronologicamente vicine o in parte si coincidono, si può presupporre, che nella colonia di Apulum fossero in carica contemporaneamente almeno due flamines, ognuno per circa venti anni in media, prendendo in considerazione anche il flaminatus relativamente breve del D 75. Un periodo di venti anni in media come flamen può essere considerato reale nel caso di una carica occupabile già da giovani, ciononostante sia possibile, che non conosciamo tutti i flamines apulensi del dato periodo. Haruspex Conosciamo un solo haruspex ad Apulum, nella città più grande della Dacia, con circa ottocento iscrizioni dal II e III secolo d. C.9 Rispetto al gran numero delle iscrizioni, l’esistenza di un solo haruspex conosciuto sembra essere un’eccezione. Si suppone con ragione, che nella retroscena del suo impegno sta la disposizione di Severus Alexander, la quale rese il haruspicatus una carica statale pagata,10 dunque lo tolse dalle condizioni del paragrafo 62 della lex Ursonensis [Addendum 1.], cioé dalla possibilità di esser impiagati dai magistrati locali. È molto probabile che le città non spendessero all’impiego di un haruspex, dato che agivano dappertutto augures. Anche lo stato di Apulum come sede provinciale può spiegare l’impiego dell’unico haruspex. Altrimenti egli non venne nella città come haruspex, dato che prima rivestì probabilmente una funzione igienica, e anche un sacerdotium. Quindi anche durante nella sua carriera divenne l’haruspex della colonia da un dato indeterminabile, il che sottolinea di nuovo il rapporto tra la sua esistenza e la disposizione di Severus Alexander. D 59 – C(aius) Iul(ius) Valens Nel primo terzo del III secolo d. C. – cl[?inic]us l(oci), sacerdo[s] d[ei] [?], haruspex col(oniae), antistes loci, [---? Il fatto che solo lui è conosciuto come haruspex, non solo ad Apulum nella Dacia, ma anche nell’area danubiana centrale (fino al Noricum), rinvia alla particolarità del suo impiego. Verosimilmente l’haruspicatus non era una carica sacerdotale
regolare ad Apulum, neanche dopo di lui, oppure gli altri harsupices non salirono nel ceto sociale delle iscrizioni. Anche Valens fece erigere le sue iscrizioni come antistes, il suo haruspicatus è indicato solo tra gli uffici occupati. Erano dedicate iscrizioni nella Dacia e ad Apulum anche dopo l’epoca di Severus Alexander, ma in una quantità assai ridotta rispetto al periodo precedente. Così la causa della particolarità dell’unico haruspex conosciuto può essere anche la mancanza delle fonti. Pontifices Sono conosciuti cinque pontifices nella colonia di Apulum, durante la storia di quasi novanta anni della città. La datazione delle iscrizioni è in connessione con la data della fondazione della colonia, cioé con il 180 d. C. Nessuna delle iscrizioni è databile dopo l’epoca dei Severi, perciò i pontifices praticavano la loro carica a vita in un periodo di poco più di cinquant’anni dalla fondazione della colonia. D 57 – C(aius) Iul(ius) Metrobianus Prima del 180 d. C. – II[vir(alis)] col(oniae)(1), dopo il 180 d. C. – sacerd(os) dei Aes[cul(api)], pontif(ex), q(uin)q(uennalis) IIvir col(oniae)(2). D 7 – P(ublius) Ael(ius) P(ubli) fil(ius) Pap(iria tribu) Genialis Dalla fine del II secolo d. C. – dec(urio) col(oniae), eq(uo) p(ublico), q(uaestor?), pontifex col(oniae), patron(us) colleg(i) cent(onariorum), [I]Ivira[lis c]ol(oniae). D 2 – [?P(ublius) o T(itus) ? Ae]l(ius) Ael[ianu]s ? Dopo il 180 d. C. – pont[ifex] [col(oniae)], e[q(uo) p(ublico)]. D 3 – P(ublius) Ae[l(ius) ? ---]us Dopo il 180 d. C. – po[ntifex co]l(oniae), [eq(uo)] p(ublico). D 11 – T(itus) Ael(ius) Lupus Dopo il 180 d. C. – eq(ues) R(omanus), pontif(ex), IIviral(is) coloniae. Secondo la datazione delle iscrizioni dei cinque pontifices, ognuno sarebbe stato in carica per poco più di vent’anni, durante il periodo supposto di cinquant’anni. Benché si potesse diventare pontifex anche da relativamente giovani, questo tempo di carica sembra troppo lungo per una persona. Perciò si suppone, che non conosciamo tutti i pontifices neanche nell’epoca dei Severi. Però in base ai pochi dati è probabile, che, similmente agli augures, fossero in ufficio almeno due pontifices contemporaneamente. Dall’altro lato non si possono identificare indubbiamente coppie di pontifices in ufficio, ma è quasi sicuro, che i periodi di carica delle cinque persone conosciute si coincidono in più casi. Sacerdotes Conosciamo nove sacerdotes nella colonia di Apulum dal 180 d. C. fino alla prima metà del III secolo. Rivestivano diversi sacerdotia, e molti di loro occupavano anche altri uffici sacerdotali. Il D 19 fu un sacerdos coloniae e lo fu probabilmente anche il D 80. Il D 57 e il D 68 furono i sacerdotes di Aesculapius, il D 57 inoltre fu anche il pontifex della colonia. Il D 59 fu il haruspex della colonia e il dirigente dell’area sacra nominata il Locus con il titolo dell’antistes. Fece il suo servizio sacerdotale nel Locus, probabilmente nell’aedes di Iuppiter Conservator [D 78]. Non è sicuro, se il sacerdotium del D 28 fosse in connessione con Apulum, dato che egli fu il decurio probabilmente di una città dalmatica, se non di una città dacica inidentificabile. Ma il suo soggiorno ad Apulum poteva avere diverse cause. Teoricamente poté vivere ad Apulum, anche se fu il decurio in un altro luogo. Lui e il D 17 furono i sacerdotes del Deus Hierobulos, mentre il D 28 fu il sacerdos di diverse divinità (numina), tra di cui verosimilmente anche di Deus Hierobulos. Sacerdotes coloniae Sono conosciuti due sacerdotes, impiegati dalla città. Non si può definire precisamente il carattere del loro sacerdotium, avevano ruolo nell’amministrazione dei culti stranieri, oppure magari nella parte precisamente non definibile del culto imperiale, fuori la competenza dei flamines: D 80 – [---] [---] Reginus Dal 180 d. C. s[ac]erdos. D 19 – P(ublius) Ael(ius) P(ubli) f(ilius) Pap(iria tribu) Silvanus Dopo il 180 d. C. IIvir(alis), sacerd(otalis) [co]l(oniae), eq(ues) R(omanus). Conosciamo il D 19 tramite la sua epigrafe sepolcrale, per questo il suo titolo è ovviamente sacerdotalis. Non si può dire, se anche in vita avesse lo stesso titolo, ma siccome nella Dacia solo i sommi sacerdoti emeriti avevano il titolo sacerdotalis, possiamo considerare la sua carica a vita. Il D 80 fu investito nell’ufficio dal luogotenente, il che poteva essere in connessione con la fondazione della colonia, oppure l’inaugurazione dell’area sacra, ma si deve prendere in considerazione anche il suo rapporto al culto imperiale, il quale ottenne un significato importante nell’epoca con il regno di Commodus (180-192 d. C.), che coltivava specialmente Hercules.
Sacerdotes Aesculapi Sono conosciuti due sacerdotes di Aesculapius ad Apulum, i quali appartenevano al ceto nobile e dirigente della città, dopo il 180 d. C. Le datazioni determinabili delle loro iscrizioni non sono lontane cronologicamente una dall’altra, perciò i due sacerdotes potevano agire contemporaneamente ad Apulum, ma il D 68 rappresentava una generazione più giovane rispetto al D 57: D 57 – C(aius) Iul(ius) Metrobianus Prima del 180 d. C. – II[vir(alis)] col(oniae)(1), dopo il 180 - sacerd(os) dei Aes[cul(api)], pontif(ex), q(uin)q(uennalis) IIvir col(oniae)(2). D 68 – C(aius) Nummius Verus Dal 180 d. C. – eques Romanus, IIviral(is) col(oniae), sacerdos num(inis) Aesculapi. Il fatto, che non conosciamo altri sacerdotes di Aesculapius nel periodo seguente, il quale era però relativamente ricco di materiale epigrafico, rispecchia l’eventualità dell’impegno dei due sacerdotes conosciuti. I sacerdotes di Aesculapius si istruirono sicuramente non ad Apulum, ma per esempio ad Epidauros o a Pergamon, e ricevettero il sacerdotium lì. Il D 71, un flamen di Sarmizegetusa, fece erigere un altare nella seconda metà del II secolo per Aesculapius di Pergamon, perciò gli Asklépieiones dacici potevano essere in connessione in diversi modi finora non chiariti con il santuario di Aesculapius a Pergamon e con l’istruzione dei medici. I D 57 e 68 furono soprattutto magistratus, uno di loro anche pontifex [D 57]. Anche quest’ultimo rinvia a ciò, che il loro sacerdotium per Aesculapius appartenne originalmente non alla provincia e alla città, ma vennero e si stabilirono ad Apulum per un dato scopo, dove furono molto apprezzatti: divennero tutti e due IIviri della città, anzi, uno di loro anche quinquennalis [D 57]. Quest’ultimo visse prima a Sarmizegetusa, dove l’Asklépieion fu ricostruito proprio in questo tempo.11 L’apparizione dei due sacerdoti nobili di Aesculapius ad Apulum poteva essere in rapporto con un’occasione particolare, accompagnata dall’epidemia di peste scoppiata durante le guerre marcomanniche12 e dai provvedimenti successivi, dunque dalla fondazione degli Asklépieiones. I sacerdotes di Aesculapius potevano fondere l’Asklépieion di Apulum formalmente, che da questo momento funzionava con un personale locale adeguato, ma senza i sacerdotes investiti a Pergamon, per questo mancano probabilmente i testi con i sacerdotes di Aesculapius tra le iscrizioni del periodo successivo.13 Sacerdotes loci Similmente, i sacerdotia dei D 78 e D 59 sono in connessione con l’Asklépieion, con i suoi istituti, e con i santuari appartenenti, per questo possono essere considerati praticamente ufficiali e anche i sacerdotes erano impiegati dalla colonia: D 78 – Antiochu(s) Nella prima metà o alla metà del III secolo d. C. – sacerdos loci. D 59 – C(aius) Iul(ius) Valens Nel primo terzo del III secolo d. C. – cl[?inic]us l(oci), sacerdo[s] d[ei] [?], haruspex col(oniae), antistes loci, [---? Si è affermato, che il Locus apulense incorporava l’Asklépieion e anche altri santuari.14 Il D 78 poteva essere un sacerdote nel Locus, nell’aedes Iovis Optimi Maximi Conservatoris, in cui funzionava anche un’ostetricia. Il D 59 invece fu il sacerdote anche di una divinità medica del Locus, mentre cominciava la sua carriera probabilmente come medico specialista.15 Sacerdos Iovis Optimi Maximi Dolicheni È conosciuto un solo sacerdote di Iuppiter Dolichenus nella città, il quale, in base alla sua iscrizione dedicata alla salute dell’imperatore e per la storia del culto, si dovette stabilire nella colonia di Apulum dopo il 212 d. C., dove rinnovò un tempio già esistente. D 21 – Ael(ius) Valentinus(1) - vet(eranus), sacerdos Iovis Dolicheni Non dovette essere lui l’unico sacerdote del santuario rinnovato durante la storia della città, ma conosciamo solo la sua iscrizione. Rivestì la sua carica sacerdotale verosimilmente sul territorio della colonia in forma ufficiale, probabilmente a vita. Sacerdotes Dei [H]ierhiboli Sono conosciuti ad Apulum due sacerdoti di Deus Hierhibolus. Yarhibol fu uno della triade divina di Palmyra, con Bel e Aglibol.16 Nel titolo sacerdotale del D 28 i numina è al plurale, perciò la parola può rinviare agli altri due dei della triade oltre Yarhibol. L’esistenza dei due sacerdoti rinvia ad un santuario degli dei palmiresi, il quale doveva essere simile a quello di Sarmizegetusa.17 Il D 28 venne probabilmente dalla Dalmatia ad Apulum, dato che fu il decurio di una città dalmatica. Il D 17 fu un cittadino romano, e non conosciamo nessuna delle sue cariche. I due sacerdoti furono impiegati probabilmente uno dopo l’altro, verosimilmente nel territorio della colonia. Non si può affermare, ma è molto probabile, che funzionassero ufficialmente: D 17 – Ael(ius) Nisa Dal 161-180 d. C. sacerdos Dei [H]ierhiboli.
D 28 – Aur(elius) Bassinus Nella prima metà del III secolo d. C., dopo il 212 – dec(urio) col(oniae), sacerd(os) numinum. Il loro sacerdotium durò probabilmente a vita, non abbiamo nessun dato sul periodo limitato della carica. Il luogo del santuario è sconosciuto.
Canabae legionis18 XIII Geminae Non conosciamo nessun sacerdote nelle canabae fino al momento quando l’insediamento divenne una città. Ma come città militare aveva istituti di carattere civile e municipale, perciò dovette avere anche sacerdoti.19 Muncipium Septimium Apulensium Le canabae della legio XIII Gemina ricevettero il rango municipale sotto Septimius Severus, molto probabilmente nel 197 d. C. L’insediamento fu governato dai IIIIviri.20 La città si trovava tra la colonia Aurelia e il campo della legione, a Nord della colonia Aurelia. Tra le due città si trovavano un’area sacra e una necropoli. Della sua vita municipale di poco più di settant’anni (o considerando la data superiore della cronologia delle iscrizioni daciche – quindi l’epoca di Gallienus – da un periodo poco più di cinquant’anni) conosciamo le seguenti cariche e i suoi portatori nella città: Augur Conosciamo solo un augur nella città. Tramite lui possiamo affermare, che la carica sacerdotale esisteva veramente nella città, come si vede in ogni città fondata secondo la legge romana. Rivestì la sua carica nel primo quarto del III secolo d. C.: D 39 - Tib(erius) Cl(audius) Augustianus - eq(uo) p(ublico), augur m(unicipi), sacerdos (Arae Augusti o Arae Augusti nostri, coronatus Daciarum III). Sotto Severus Alexander divenne il sommo sacerdote della provincia, e poi non si può dire, quanto lungo agì nella città come augur. Rivestì la carica di augur a vita nella prima metà del secolo. Flamines Sono conosciuti tre flamines del municipium Septimium Apulensium. Le iscrizioni dei tre flamines sono databili solo rispetto alla fondazione della città, ma non si può determinare una cronologia interna. Uno di loro fu il decurio della colonia Aurelia dopo il 180 d. C. [D 42], perciò poteva essere lui il primo flamen in carica dal 197 d. C. tra le tre persone conosciute. Il praenomen e il nomen del D 36 rende possibile il suo stato come cittadino romano sin dal 212 d. C., ma questo è solo una possibilità teorica, dato che la famiglia poteva portare questi nomi già da Marcus Aurelius. Siccome non aveva altre cariche, può darsi che fosse un cittadino nuovo di buona condizione finanziaria, che conocorreva anche alla carica di flamen. Il D 72 doveva diventare il rappresentante della carica di flamen tra i due sopramenzionati: D 42 – Tib(erius) Cl(audius) Rufus(2) Dopo il 180 d. C. – dec(urio) col(oniae), dopo il 197 flamen mun(icipi). D 72 – [.] Statorius [---]ianus Dopo il 197 d. C. – dec(urio), flamen m[uni]c(ipi). D 36 – M(arcus) Aur(elius) Maximus Circa il 197 d. C., possibilmente dopo il 212 d. C.(?) – flam(en) m(unicipi). Le datazioni delle iscrizioni dei tre flamines conosciuti sono molto vicine cronologicamente, per questo si potrebbe ipotizzare, che svolgessero i loro compiti parallelamente, o almeno due di loro contemporaneamente. Ma sembra più probabile la possibilità, che furono i flamines del municipium uno dopo l’altro, come negli altri municipia con dati sufficienti per un tale osservazione. Colonia Nova Apulensium Secondo un dato incerto, il muncipium Septimium ricevette il rango coloniale con il nome colonia Nova Apulensium versosimilmente sotto Traianus Decius (249-251 d. C.).21 Non conosciamo nessun sacerdote da questo periodo. Legio XIII Gemina Il legio fu di stanza ad Apulum dalla conquista fino all’abbandono della provincia.22 Conosciamo solo un sacerdote, che fu in servizio presso la legione, alla fine del II e all’inizio del III secolo d. C. D 48 – Flavius bar Hadadi - s(acerdos) I(ovis) D(olicheni) ad leg(ionem) XIII Geminam. Conosciamo numerosi sacerdotes in servizio per i soldati fedeli a Iuppiter Dolichenus. La spiegazione del fenomeno è ciò, che la divinità trionfante divenne la parte della religione militare, ma come un culto militare indipendente, perciò non fece
parte della religione tradizionale.23 Come il sacerdote di Iuppiter Dolichenus egli poteva lavorare presso la legio al massimo fno al 235 d. C.,24 quindi non è da escludere, che lui fu l’unico sacerdote del culto di Iuppiter Dolichenus presso la legione.
DIERNA25 Muncipium Septimium Diernensium La città della Dacia Inferior, poi della Dacia Malvensis si trova al punto d’incontro dei fiumi Cserna e Danubio. Ulpianus la elenca tra le città daciche con il ius Italicum, ritenendola una città fondata da Traianus e menzionandola come colonia.26 Le fonti epigrafiche non appoggiano questi dati, Dierna apparve come città solo nel III secolo d. C. Secondo i dati conosciuti Dierna fu un muncipium Septimium, fondato al più tardi nel 197 d. C. dall’imperatore e guidato dai quattuorviri. Dal periodo tra il 197 e 271 d. C. conosciamo la seguente carica sacerdotale e il suo rappresentante nell’insediamento: Flamen Portava cariche e uffici sacerdotali in varie città, tra l’altro anche a Dierna. È l’unico rappresentante conosciuto della carica di flamen a Dierna, perciò non si possono dedurre conseguenze importanti sulla vita religiosa organizzata della città: D 53 – L(ucius) Iu[l(ius)] [B]assinus Dalla fine del II secolo d. C. – trib(unus) leg(ionis), dec(urio) munic(ipi)(1), dec(urio) munic(ipi)(2), flam(en) munic(ipi)(3) flam(en) col(oniae)(2), IIvir col(oniae)(1), dec(urio) col(oniae)(3). Il fatto che le sue cariche e i suoi uffici legavano la persona a sei città daciche, tra di cui Dierna era solo una, presuppone, che al posto di uno dei suoi flaminati erano in sevizio almeno due flamines, di cui uno era sicuramente sempre presente per svolgere le cerimonie e le feste locali. I flamines, come sacerdoti del culto imperiale, avevano ruolo in ogni città agli stessi giorni festivi. Siccome possiamo figurarci due flamines piuttosto in una città con il rango coloniale, così [B]assianus dovette essere l’unico flamen a Dierna, quindi svolse i compiti per lo più là. La vita cultica della città non si poteva svolgere neanche a Dierna senza pontifices e augures. La presenza del flamen in sé rinvia all’esistenza del collegium dei pontifices, ma non abbiamo finora nessun dato degli altri uffici sacerdotali.
DROBETA27 Municipium Aelium Hadrianum Drobetensium È forse l’insediamento più vecchio della Dacia, alla riva del Danubio, nella Dacia Inferiore oppure Malvensis. Hadrainus lo alzò al rango municipale, il suo nome ufficiale fu municipium Aelium Hadrianum Drobetensium. Fu governato dai duumviri. Dal periodo municipale, quindi dalla fase tra il 117-138 e il 193-197 d. C. conosciamo le seguenti cariche sacerdotali e i loro rappresentanti nella città: Flamen È conosciuto un solo flamen nel municipium. Tramite lui si può dimostrare la presenza dell’ufficio nel periodo municipale, il che è comunque ovvio, dato che si tratta di una città regolata dalle leggi romane. Egli divenne flamen da molto giovane, alla metà oppure nella seconda metà del II secolo. Le spese munerali per il concorso furono pagate da suo nonno: D 58 – C(aius) Iul(ius) Naesus Sabinus – flamen m(unicipi). Non si può dire, quanti flamines fossero in carica contemporaneamente nel municipium di Drobeta, ma si presuppone, che a causa della sua età almeno in un terzo del periodo municipale della città svolse lui i compiti sacerdotali del flaminatus. Pontifex Conosciamo un pontifex del municipium di Drobeta, che rivestì la carica sacerdotale durante il II secolo d. C.: D 24 – Cn(aeus) Aem[ilia]nus I[---?] Tra il 117-138 e 193 d. C. – pont[ifex], I[Ivir, –Iviralis?] mun(icipi). Secondo la sua iscrizione frammentaria poté essere anche duumvir nella città. In base all’epigrafe non si può dire il numero dei pontifices contemporaneamente in carica. Se fu da solo, rappresentò lui i pontifices del collegium pontificum, e formarono con il flamen [cfr. D 58] il collegium non molto numeroso. Colonia Septimia Drobetensium Il municipium di Hadrianus fu alzato al rango coloniale da Septimius Severus con il nome di colonia Septimia Drobetensium, in un momento indeterminabile, alla fine del II o all’inizio del III secolo d. C. Dal periodo coloniale, quindi tra il 193-211 e il 271 d. C. conosciamo le seguenti cariche sacerdotali e i loro rappresentanti nella città: Flamines
Conosciamo due flamines nel periodo coloniale di Drobeta. Secondo la datazione delle loro iscrizioni, che non può precedere la fondazione della colonia, rivestirono i loro flaminatus nei primi decenni del III secolo d. C. Tutti e due furono equites, e dopo il servizio militare fecero una carriera municipale, in cui arrivarono tra l’altro fino al duumviratus: D 53 – L(ucius) Iu[l(ius)] [B]assinus Alla fine del II e all’inizio del III secolo d. C. – trib(unus) leg(ionis), dec(urio) munic(ipi)(1), dec(urio) munic(ipi)(2), flam(en) munic(ipi)(3), flam(en) col(oniae)(2), IIvir col(oniae)(1), dec(urio) col(oniae)(3). D 4 - T(itus) Ael(ius) T(iti) Ael(i) Zeuxi fil(ius) Pa[p(iria tribu)] Aelianus Dall’inizio del III secolo d. C. – eq(uo) [p(ublico)], [praef(ectus) coh(ortis) I] Noric[orum], IIvir, fla[m(en)], patronus col(oniae). Secondo la datazione delle iscrizioni, non è da escludere, che erano in carica contemporaneamente. Perciò si suppone, che due flamines fossero in carica anche a Drobeta, similmente a Sarmizegetusa, oppure ad Aquincum nella Pannonia Inferiore.28 Uno di loro occupò l’ufficio di flamen in due città, oltre a Drobeta anche a Dierna vicina [D 53]. Questo fenomeno suppone almeno due flamines a Drobeta, visto che alle date feste contemporanee uno dei flamines conosciuti poteva flaminare a Dierna. La presenza dei due flamines a Drobeta rinvia indirettamente all’esitenza del collegium pontificum. Sacerdos In base alle iscrizioni trovate a Drobeta sono conosciuti tre sacredotes di Iuppiter Dolichenus dall’epoca dei Severi [D 90, 91, 92]. Si definirono come sacer(dotes) c(o)hortis pr(mae) Sag(ittariorum), perciò non appartengono ai sacerdoti della città, ma a quelli militari. Non è da escludere, che prendessero parte anche alla vita religiosa della città, come i colleghi a Porolissum con cariche simili [D 26, 30, 31], ma non ne abbiamo nessun dato.
NAPOCA29
Municipium Aelium Napocensium La città fu fondata da Hadrianus tra il 117 e 138 d. C. accanto al fiume Szamos nella Dacia Porolissensis con il nome municipium Aelium Napocensium. Fu governata dai IIviri. Del periodo municipale della città, della fase breve tra il 117-138 e il 161-180 d. C. sono conosciuti le seguenti cariche sacerdotali e i loro rappresentanti:
Flamen È conosciuto un solo flamen nel municipium di Napoca. Non si può dire, quando cominciò la sua carica durante la breve fase municipale: D 18 – [P(ublius) Ae]lius Probus Tra il 117/138 e il 161/180 d. C. – flamen muni[c(ipi)]. Non è da escludere, che egli flaminò da solo nel municipium. In questo caso, durante il breve periodo municipale, se contiamo con la carica a vita dei flamines, potevano avere quest’ufficio due, al massimo tre flamines. Allo stesso tempo, l’esistenza della carica rinvia anche alla presenza del collegium pontificum. Colonia Aurelia Napocensium Il municipium fondato da Hadrianus fu alzato al rango coloniale probabilmente da Marcus Aurelius, con il nome colonia Aurelia Napocensium. Rimase governata dai duumviri. Del periodo coloniale, quindi della fase tra il 161/180 e il 270 d. C. conosciamo le seguenti cariche e i loro rappresentanti nella città: Augures Conosciamo due augures della colonia. Uno di loro [D 16] fece erigere un’iscrizione probabilmente nel II secolo d. C.; l’altro poté essere augur nella colonia possibilmente già alla fine del II secolo d. C., ma il suo periodo ufficiale poté durare fino all’inizio del III secolo d. C.: D 16 – P(ublius) Ael(ius) Maximianus Tra il 161/180 e il 193/197 d. C. augu[r] col(oniae). D 10 – P(ublius) Ael(ius) P(ubli) f(ilius) Fab[ianus] Nell’ultimo terzo del II secolo e all’inizio del III secolo d. C. – dec(urio), [?II]v[?iral(is)], pont(ifex), augur col(oniae)(1). Nel frattempo decurio, augur col(oniae)(2), e dopo il 197 d. C. dec(urio) mun(icipi). La cronologia delle iscirizioni dei due augures conosciuti, e la loro carriera si possono coincidere in parte, ma non abbiamo nessun dato diretto oppure un punto di riferimento cronologico per confermare il loro auguratus contemporaneo. La loro esistenza può essere trattata praticamente come la presenza dei rappresentanti dell’ufficio di augur. Non ci poteva essere molte persone adatte all’auguratus a Napoca, dato che il D 10 venne da Sarmizegetusa, e anche là occupò uno dei posti augurali. Perciò, anche se la legge della città rendeva possibile per le colonie avere più di un augur, non è probabile, che anche in pratica ci fossero più rappresentanti dell’ufficio sacerdotale che richiedeva beni e professionalità. Una sola persona poteva rappresentare il collegium sacerdotale. Flamines Conosciamo tre flamines della colonia di Napoca, dall’ultimo terzo o quarto del II secolo fino al primo terzo del III secolo d. C.: D 86 – [---] [---] [---] Durante il II secolo d. C., dal regno di Marcus Aurelius – fl(amen). D 89 – [---][---][---] Nel primo terzo del III secolo d. C. – d]ec(urio), patro[n(us) coll(egi)?---?], [fla]m[en col(oniae)] [---?. D 15 – P(ublius) Ael(ius) Maximus Dall’inizio del III secolo d. C. – a militis, IIvir q(uin)]q(uennalis), fla[men col(oniae)(1), dopo il 222 d. C. – [sacerdos Ar]ae Aug(usti) n(ostri), [coronatus Dac(iarum) I]II, dec(urio) col(oniae)(2). Durante i circa 50 anni della loro carica e delle loro iscrizioni, tutti e tre potevano occupare un flaminatus a tempo pieno, senza la coincidenza del periodo ufficiale. Il D 15 divenne flamen relativamente tardi anche per quanto rigurada la sua propria carriera, dopo l’ufficio quinquennalis della colonia. La cronologia determinabile dei tre flamines rinvia ad un solo flamen in carica nello stesso tempo. Ovviamente per provarlo occorrono altri dati diretti o più dati indiretti. Pontifex
Conosciamo un solo pontifex nella colonia, che poteva occupare il suo ufficio già dalla fine del II secolo, ma in parte anche nel III secolo d. C.: D 54 – C(aius) Iul(ius) Con[s]tans La fine del II secolo – inizio del III secolo d. C. – pont(i)f(ex). Siccome lui è l’unico pontifex conosciuto della colonia di Napoca, non si può stimare il numero dei membri contemporanei dei pontifices locali del collegium pontificale. Oltre il pontifex anche il flamen apparteneva al collegium. Secondo la cronologia delle fonti non è sicuro, ma è molto probabile, che nella colonia di Napoca ci fosse in ufficio contemporaneamente solo un rappresentante di ogni carica sacerdotale. Non conosciamo la legge della città, ma in teoria poteva rendere possibile, che i membri dei collegia sacerdotali fossero in più, soprattutto perché si tratta di una colonia. Le fonti rimaste potrebbero appoggiare la possibilità del regolamento dell’ufficio in una persona, ma rispecchiano più probabilmente la pratica, quindi il numero basso delle persone adatte alle cariche sacerdotali.
POROLISSUM30 Municipium Septimium Porolissensium Il municipium di Porolissum fu fondato sulle basi in parte civili, da parte di Septimius Severus nel III secolo d. C., i documenti risalgono al 211 d. C. La città si trovava nella vicinanza di uno dei centri più complessi del sistema militare e della difesa delle frontiere nella Dacia, accanto al confine settentrionale della provincia, nella Dacia Porolissensis. Fu governata dai IIIIvir. Sono conosciute le seguenti cariche sacerdotali e i loro rappresentanti nella città: Augures Conosciamo tre augures del municipium di Porolissum, che rivestivano il loro ufficio continuamente dalla fondazione della città nel 211 d. C., nella prima metà del secolo. Il fatto, che due su tre augures furono anche pontifices, dimostra la ristretteza del numero delle persone adatte alle cariche sacerdotali nella città. In base agli uffici doppi, si suppone con diritto nel caso di Porolissum, che ogni ufficio sacerdotale avesse un solo posto, anzi, in due casi svolse la stessa persona la rappresentanza di due collegia. Potevano rivestire la carica di augur in seguente ordine: D 23 – Ael(ius) Vitalianus Dagli anni 210 d. C. – augur, [po]ntif(ex), q(uin)q(uennalis). D 43 – M(arcus) Co[cce]ius Alexander Nel primo terzo del III secolo d. C. – vet(eranus) ex Y(centurione), augur m(unicipi). D 44 – Cocceius Umbria[n]us Nella prima metà del III secolo d. C. – decurio, augur, pontifex civitatis (municipi) A causa della rarità del nome, si suppone parentela tra il D 43 e il D 44, che furono augures della città uno dopo l’altro. Non si può dire, fino a quando durò la vita normale coloniale di Porolissum entro la storia della città teoricamente fino al 271 d. C. Sembra però probabile, che conosciamo la maggior parte degli augures in carica nella città. Flamen Conosciamo un solo rappresentante della carica di flamen a Porolissum, il quale poté rivestire la carica nella prima metà del III secolo d. C., al più presto dal 211 d. C., ma è molto probabile, che non fu lui il primo flamen della città: D 13 – P(ublius) Ael(ius) Malachu(s) - q(uin)q(uennalis), flamen mun(icipi), sacerdos dei n(umeri) P(almyrenorum). Dato che lui è l’unico flamen conosciuto del municipium, questa fonte non ci fornisce informazioni dettagliate sull’ordine dell’istituto locale del flaminatus. È probabile, che fu in carica solo lui nel dato periodo, come si può dimostrare anche nel caso degli augures e pontifices. Nella sua iscrizione l’elenco degli uffici segue un ordine cronologico, perciò poté diventare flamen come quinquennalis, oppure successivamente, dopo la morte del suo predecessore. Per questo lui poté essere al massimo il secondo flamen della città cronologicamente. Appartiene ai flamines rari della Dacia, i quali avevano anche un sacerdotium oltre il flaminatus. Il suo sacerdotium però non era in connessione con la città, ma con un numerus organizzato in base etnica, di stanza a Porolissum. In base a suo cognomen fu anche lui di Palmyra, come anche i soldati del numerus, perciò serviva con competenza verosimilmente il culto di una divinità della loro patria, il cui nome era vietato pronunciare e scrivere. Pontifices Conosciamo tre pontifices di Porolissum, i quali potevano rivestire la loro carica nel seguente ordine, uno dopo l’altro: D 23 – Ael(ius) Vitalianus Dagli anni 210 d. C. – augur, [po]ntif(ex), q(uin)q(uennalis). D 84 – [---] [---] [---] Nel secondo quarto del III secolo d. C. – pont(ifex) m(unicipi). D 44 – Cocceius Umbria[n]us Nella prima metà del III secolo d. C. decurio, augur, pontifex civitatis (municipi). Come lo abbiamo già menzionato nel caso degli augures di Porolissum, due su tre pontifices ebbero anche la carica di augures insieme al pontificatus. La causa del fenomeno può essere ciò, che il numero dei rappresentanti della data carica sacerdotale era fissato in una persona, dall’altra parte neanche la composizione della società militare della piccola città poteva avere molte persone adatte agli uffici sacerdotali.
I sacerdoti conosciuti della religione statale di Porolissum nella prima metà del III secolo d. C.:
collegium augurum
collegium pontificum
augur pontifex flamen
D 23
Ael. Vitalianus
?
D 13
P. Ael. Malachu(s)
D 43
M. Co[cce]ius
Alexander
D 84
[---] [---] [---]
D 44
Cocceius Umbria[n]us
I dati a disposizione rinviano a ciò, che gli uffici di augur, di pontifex e di flamen nel municipium furono occupati da una sola persona. Le cariche compatibili di pontifex e di augur furono occupate in due casi dalle stesse persone, il che dovette avere una causa sociale nella città. Il D 43 e il D 84 dovevano essere sacerdoti conemporanei. In base agli altri due esempi [D 23, 44] non sarebbe sorprendente, se venisse fuori, che le due fonti trattavano della stessa persona. Sacerdotes Sacerdotes Iovis Optimi Maximi Dolicheni Conosciamo cinque sacerdotes nella città di Porolissum, di cui tre erano attivi contemporaneamente. Tre di loro indicarono, che erano i sacerdotes di Iuppiter Dolichenus [D 26, 30, 31]. Uno partecipò alla rinnovazione di un dolichenum, il che, insieme alla dedicazione, rende sicuro, che anche lui fu il sacerdos di Iuppiter Dolichenus. Il quinto sacerdos conosciuto di Porlissum dedicò l’altare alla Dea Suria, il che non dimostra in sé, che fu il sacerdos di Iuppiter Dolichenus, ma non lo esclude. Dea Suria dovette essere la sua divinità di patria. Il nome di Dea Suria capita spesso in ambiente dolicheno, perciò possiamo ritenere anche lui il sacerdos di Iuppiter Dolichenus. Rivestirono la loro carica nei seguenti tempi e periodi: D 32 – Aur(elius) Gaianus Dopo il 212 d. C. – dec(urio) m(unicipi), sace(r)do[s]. D 37 – Aur(hlioj) Sabeinoj Qeiofilou Suroj Tra il 222 e 235 d. C. – iereuj, unemporoj thj Dakiaj. Nel secondo quarto del III secolo d. C.:
D 26
M(arcus) Ant(onius) Maximu[s]
- vet(eranus),
Tra il 238 e 244 d. C. –
dec(urio) o[rnat]us ornam(entis)
IIIIvir(alibus) m(unicipi), sacerdos dei, sacerdos
coh(ortis).
D 30
Aure(lius) Fla(v)us
Tra il 238 e 244 d. C. – dec(urio) m(unicipi),
vegesi[m]a[r(ius)], sacerdos dei, sacerdos coh(ortis).
D 31
M(arcus) Aur(elius) Fla(v)us
Dopo il 212 d. C. – s(acerdos) I. [O.] M. D.
- dei, Tra il 238 e 244 d. C. sacerdos coh(ortis), IIIIvir m(unicipi).
A Porolissum i sacerdotes di Iuppiter Dolichenus furono presenti sin dall’inizio della vita della città fino alla metà del III secolo d. C. Il luogo del Dolichenum I è sconosciuto, il Dolichenum II però fu costruito entro le mura,31 il che, insieme alle magistrature dei sacerdoti, dimostra che a Porolissum questi sacerdoti rappresentavano il culto della divinità di origine dolichena, interpretata come Iuppiter Optimus Maximus, come sacerdotes ufficiali del municipium. Sacerdotes cohortis I tre sacerdoti contemporanei di Iuppiter Dolichenus a Porolissum e i magistrati della città svolgevano anche i compiti sacerdotali di una delle cohortes di stanza locale (probabilmente della cohors III Campestris dell’iscrizione).
D 26
M(arcus) Ant(onius) Maximu[s]
- vet(eranus),
Tra il 238 e 244 d. C. –
dec(urio) o[rnat]us ornam(entis) IIIIvir(alibus)
m(unicipi), sacerdos dei, sacerdos coh(ortis).
D 30
Aure(lius) Fla(v)us
Tra il 238 e 244 d. C. – dec(urio) m(unicipi), vegesi[m]a[r(ius)],
sacerdos dei, sacerdos coh(ortis).
D 31
M(arcus) Aur(elius) Fla(v)us
Dopo il 212 d. C. –
s(acerdos) I. [O.] M. D. e dei,
Tra il 238 e 244 d. C. sacerdos coh(ortis), IIIIvir
m(unicipi).
Non si può dire, di quale divinità furono i sacerdotes presso la cohors, ma molto probabilmente si tratta di Iuppiter Dolichenus. Probabilmente il Dolichenum del municipium non sopravisse alla distruzione generale dei dolichena lungo il Reno e il Danubio, all’inizio del regno di Maximinus Thrax,32 e per questo fu costruito un nuovo sotto Gordiano III (238-244 d. C.) [cfr. D 26, 30, 31]. Come sacerdotes potevano avere posto anche nei tempi cupi presso una truppa organizzata in base etnica, i cui soldati coltivavano il culto della loro divinità di patria. Per questo, ovviamente, l’inizio del loro sacerdotium presso la cohors non si intende secondo il luogo indicato nell’iscrizione. Si trova alla fine del testo, perché prima vennero elencati gli uffici municipali. Sacerdos dei n(umeri) Il D 13, oltre che fu il flamen della città, svolse anche il sacerdotium di una delle truppe organizzata in base etnica, di stanza a Porolissum, nella prima metà del III secolo d. C., probabilmente dopo il 211 d. C. Secondo il suo cognomen dovette essere anche lui di Palmyra, come anche i soldati del numerus Palmyneorum Porolissensium, perciò svolse nel campo praticamente i compiti del culto della divinità di sua patria. La persona della divinità è indeterminabile, non si può identificarla con nessuna delle divinità palmiresi conosciute nella Dacia. Il suo nome dovette essere un segreto, oppure fu vietato dirlo e scriverlo. In generale i flamines di una città non rivestivano altre cariche sacerdotali contemporanee in un altro insediamento. Neanche l’ufficio sacerdotale di Malachu(s) apparteneva alla città, ma, come scrisse anche nell’epigrafe, alla truppa. Così le due cariche sacerdotali si separano giuridicamente. Allo stesso tempo gli uffici del sacerdote nella città rinviano ad un rapporto stretto tra l’insediamento civile e quello militare, mentre l’esistenza del sacerdote per il culto della divinità del numerus riferisce sulla vita religiosa indipendente e parallela del numerus, che differiva dalla religione tradizionale militare. Il D 9 poteva avere un ruolo simile a Sarmizegetusa, presso il numerus Palmyrenorum Orientalium. Si può affermare, che conosciamo assai bene i rappresentanti della vita religiosa organizzata di Porolissum, per quanto riguarda il periodo della vita della città e l’epoca tramandata dalle fonti, e abbiamo più dati anche sulla vita religiosa organizzata delle truppe di stanza vicina.
POTAISSA33
Fu un campo di legione e un insediamento civile nella Dacia Porolissensis, a Sud-Est di Napoca, nella valle del fiume Aranyos. Il campo fu costruito durante la seconda metà del regno di Marcus Aurelius (161-180 d. C.), dopo che la legio V Macedonica venne integrato nelle armi della Dacia. Al campo della legione appartenevano anche le canabae, che poi ricevettero il rango della città. Canabae legionis34 V Macedonicae Non conosciamo nessun sacerdote dalle canabae della legio V Macedonica. Municipium Septimium Potaissensium Le canabae della legio V Macedonica di Potaissa vennero innalzate al rango di municipium da Septimius Severus attorno al 197 d. C. Il municipium esisteva al massimo per poco più di un decennio, poi ricevette il rango coloniale similmente da Septimius Severus, al più tardi nel 211 d. C. Fu governato dai duumviri. Dal periodo municipale conosciamo un solo sacerdote della città: Flamen Conosciamo un solo flamen del municipium di Potaissa, dalla sua esistenza di poco meno di uno e un mezzo decennio, tra il 197 e 211 d. C.: D 73 – Val(erius) Celsus - flamen municipii. Egli poté avere la carica di flamen del municipium per poco più di un decennio. A cause di questo breve periodo sembra molto probabile, che tramite lui conosciamo il rappresentante dell’ufficio di flamen per tutto il periodo municipale di Potaissa. Non è da escludere che dopo questa carica concorse anche al flaminatus della colonia, ma è un fatto, che con la cessazione del municipium finì anche la fonte di diritto del suo flaminatus municipale. Se non venne eletto flamen anche nella colonia (su cui non abbiamo ancora nessun dato), dopo la fondazione della colonia egli divenne flaminicius, cioé un flamen emerito. Un esempio simile è tramandato anche ad Aquincum.35 Non fece indicare la sua appartenenza all’ordo decurionum, perciò si può affermare solo la sua cittadinanza romana. Oltre a lui anche almeno un augur e un pontifex partecipavano alla direzione della vita religiosa della città. Colonia Septimia Potaissensium La colonia septimia Potaissensium con il ius Italicum esisté dal 211 d. C. fino all’abbandono della provincia, oppure fino all’evacuazione della città, che poté accadere prima. Da questo periodo di circa un mezzo secolo conosciamo i seguenti sacerdoti della città: Sacerdotes Dopo il 212 d. C. conosciamo solo due sacerdotes della colonia, i cui sacerdotia non si possono determinare precisamente:
D 33
Aur(elius) Gai(u)s
- sacer(dos).
D 34
Aur(elius) Ingenu(u)s
- sacer(dos).
A causa della dedicazione particolare della loro iscrizione – I. O. M., H(e)rquli Invicto, Liber(o) Pa[t(ri)] – che con questi nomi non armonizza affatto con il loro sacerdotium, si può ipotizzare, che ambedue furono sacerdotes coloniae, che occupavano l’ufficio contemporaneamente, e che furono possibilmente anche fratelli. La dedicazione rinvia alla religiosità privata dell’imperatore all’inizio dell’epoca dei Severi.36 Si sa anche senza dati, che nella città agivano anche augures, pontifices e flamines. Solo con loro poté compiersi l’amministrazione coloniale e poté divenire la città una colonia regolare, organizzata secondo i diritti romani.
SARMIZEGETUSA37 Colonia Ulpia Traiana Dacica Augusta Sarmizegetusa Metropolis La prima città della Dacia, fondata da Traianus tramite la deduzione tra il 106 e 108 d. C. La città venne classificata nella Papiria tribus. Fu la capitale ideologica della provincia, la sede dei procuratores e del consiglio provinciale. Fu governata dai IIviri. Dalla sua esistenza più di uno e mezzo secolo si conoscono le seguenti cariche sacerdotali e i loro rappresentanti della città: Augures Conosciamo tre augures di Sarmizegetusa, dalla vita di più di uno e mezzo secolo della città. Praticamente tutti e tre furono augures nell’epoca dei Severi. Non si può dire, se uno dopo l’altro oppure contemporaneamente. Prendendo come analogia i paragrafi 66-67 presentati della lex Ursonensis [v. Addendum 1.], teoricamente in una colonia ci potevano essere in carica anche tre augures contemporanei. D 10 – P(ublius) Ael(ius) P(ubli) f(ilius) Fab[ianus] Nell’ultimo terzo del II secolo e all’inizio del III secolo d. C. – dec(urio), [?II]v[?iral(is)], pont(ifex), augur col(oniae)(1). Nel frattempo decurio, augur col(oniae)(2), e dopo il 197 d. C. dec(urio) mun(icipi). D 55 – C(aius) Iul(ius) Diocletianus Dalla fine del II secolo d. C. – eq(uo) p(ublico), dec(urio), augur col(oniae)(1), dec(urio), patronus causarum col(oniae)(2). D 20 – P(ublius) Ael(ius) P(ubli) fil(ius) P(apiria tribu) Strenuus Dopo il 180 d. C. – equo p(ublico), augur col(oniae)(2), dec(urio) col(oniae)(3), patron(us) collegior(um) fabr(um) centonar(iorum) et nautar(um), conduc(tor) pascui salinar(um) et commercior(um), IIviralis, augur col(oniae)(1), dopo il 212 d. C. – sacerd(os) Arae Aug(usti). Sebbene in base alle fonti a disposizione non si possa decidere, la cronologia vicina degli augures di Sarmizegetusa fa pensare, che nella città ci fossero in carica almeno due augures contemporanei, similmente ai pontifices con uguali condizioni. Flamines Conosciamo in persona tredici flamines di Sarmizegetusa, dal primo terzo del II secolo fino alla prima metà del III secolo d. C. Loro formano praticamente il gruppo più numeroso dei sacerdoti con la stessa carica. Studiando l’epoca trattata, tutti avevano almeno 10 anni di carica. Contrariamente alle fonti sulle cariche sacerdotali che richiedevano qualifica (auguratus, pontificatus), abbiamo notevolmente più fonti sui flamines. Pare che per essere flamini non bisognassero altre condizioni, solo lo stato individuale fisico, sociale e finanziario, così c’erano molti che potevano occupare l’ufficio. La legge per le città rendeva possibile l’esistenza di più di un solo flamen in una colonia: potevano essere in due, anzi, anche in tre. Siccome il flaminatus era in rapporto con il culto imperiale, anche la sua rappresentanza era più grande. I flamines sembrano essere più attivi per quanto rigurada le iscrizioni sui propri meriti. Le iscrizioni si possono datare solo largamente, per questo ci sono molte coincidenze cronologiche nelle carriere delle singole persone, che dimostra proprio cariche contemporanee. Nell’anfiteatro di Sarmizegetusa è stato ritrovato un banco di pietra con l’iscrizione flamen,38 che riferisce ad un solo flamen, al più presto dal 158 d. C., cioé dalla costruzione dell’anfiteatro di pietra.39 Ma tutti dopo la magistratura avevano un posto nell’anfiteatro tra i magistrati, e se non là, allora si sedevano nella fila dell’ordo decurionum o in quella dell’ordo equester. Ma è senza dubbio, che ci fu almeno una sedia per un flamen nell’anfiteatro di Sarmizegetusa, che era proprio necessario, visto che si conoscono almeno tre flamines, che non rivestirono nessuna magistratura fino alla dedicazione della loro iscrizione, (potevano essere eventualemente decuriones) così poterono occupare solo il banco speciale del flamen [D 14, 50, 71], se non si siedevano tra i decuriones. Dall’altra parte, la carriera per es. del D 75 si formava in un modo, che divenne molto presto il flamen di due colonie, e poi rinunciò a uno dei uffici, a quello di Apulum, ma mantenne l’altro di Sarmizegetusa. Cominciò però la carriera militare equestre già come flamen. Così non capitò nella città per un periodo lungo, di più anni. Così non poteva per esempio offrire i sacrifici alle feste regolari di ogni anno a causa della sua assenza. Questo fatto rinvia indirettamente a ciò, che ci doveva essere un altro flamen nella città, che svolse i compiti del flaminatus. Si può affermare, che durante il II e III secolo d. C. possiamo contare almeno con due flamines contemporanei a Sarmizegetusa. Questo fenomeno rende possibile l’altra affermazione, che durante il periodo di poco meno di 150 anni della cronologia delle iscrizioni ogni flamen di Sarmizegetusa aveva in media più di venti anni di carica del flaminatus a vita, che non è poco, se, come possiamo vedere, alcuni di loro poterono diventare flamen da molto giovani. La datazione delle singole iscrizioni non rende possibile la determinazione precisa, chi, quando e insieme a chi era il flamen in un dato periodo. I flamines svolgevano i loro uffici a Sarmizegetusa nella cronologia seguente (i sacerdoti delle iscrizioni cronologicamente vicine o coincidenti potevano essere in carica anche contemporaneamente, considerando il carattere a vita dell’ufficio): D 52 – Q(uintus) Ianuarius Q(uinti) f(ilius) Collina (tribu) Rufus Tavius Dal primo terzo del II secolo d. C. – flamen, q(uin)q(uennalis) prim(us) pro imp(eratore).
D 38 – Q(uintus) Aurelius Q(uinti) f(ilius) Pap(iria tribu) Tertius Prima del 142 d. C. – dec(urio) col(oniae), dopo il 142 d. C. flamen col(oniae). D 14 – T(itus) Ael(ius) Marius Tra il 138 e 180 d. C. – fl(amen) col(oniae), conduc(tor) pas(cui) et salina(rum). D 70 – M(arcus) Proc(ilius) M(arci) fil(ius) Pap(iria tribu) Niceta Dopo la metà del II secolo d. C. – IIvir, flamen col(oniae), sacerd(os) Laurentium Lavinat(ium). D 50 – L(ucius) Fl(avius) Valens Dopo la metà del II secolo d. C. – flamen, patr(onus) coll(egi) fabr(um). D 74 – Sex(tus) Val(erius) Sex(ti) fi[l(ius) Pap(iria tribu)] Fronto Nella seconda metà del II secolo d. C. – d[ec(urio), ae[d(ilis)], flamen, p[raef(ectus)] collegi [fab(rum). D 87 – [---] [---] [---] Probabilmente dagli anni 140 d. C. – dec(urio) col(oniae), praef(ectus) coh(ortis), trib(unus) leg(ionis), decurialis tribunicius [---?], aedilic(ius) col(oniae), tra il 161 e 169 d. C., nel 163 o nel 168 d. C.? praef(ectus) q(uin)q(uennalis), poi flamen col(oniae), (---?). D 93 – [---] [---] [---] Nell’ultimo terzo del III secolo d. C., ma presumibilmente prima dell’epoca dei Severi – [dec(urio)? c]ol(oniae), [fla]men [col(oniae)], q(uin)q(uennalis) [col(oniae)] (- - -?), [praef(ectus) c]o[l]l(egii) fa[b]ru[m - - -]. D 71 – C(aius) Spedius Hermias Dall’ultimo terzo del II secolo d. C. – flamen col(oniae). D 75 – T(itus) Varen(ius) T(iti) fil(ius) Pap(iria tribu) Pudens Dall’ultimo decennio del II secolo d. C. – [dec(urio)] colo[n(iae)(1)], fl(amen) coloniarum(1, 2), eq(uo) p(ublico), praef(ectus) coh(ortis), eq(uo) p(ublico) a mil(itis), flam(en) colo[n(iae)(1)] (si ritirò da uno dei flaminatus – flaminicius coloniae(2)), forse già all’inizio del III secolo d. C. q(uin)q(uennalis) col(oniae)(1), possibilmente già durante il cursus precedente dec(urio) [mu]nic(ipi)(1), patro[nus m]unic(ipi)(2), patro[nus] [colle]gior(um), patro[nus] [cau]sarum. D 76 – T(itus) Varen(ius) T(iti) f(ilius) Pap(iria tribu) Sabinianus Dall’inizio del III secolo d. C. – dec(urio) col(oniae)(1), eq(ues) R(omanus), omnib(us) milit(is) perfunc(tus), v(ir) e(gregius), dec(urio) col(oniae)(2), flam(en) col(oniae)(1), flam(en) Laurentinus. D 82 – [---] [---] Pap(iria tribu) [---]o ? Nella prima metà del III secolo d. C. – [---], [e]ques [Rom(anus], [flam]en, [IIvi]ral(is) col(oniae). D 88 – [---] [---] [---] II e III secolo d. C. – [de]c(urio), flam[en], [---?. Prescindendo da alcune eccezioni, che sembrano essere cittadini più ricchi, la carica di flamen a Sarimzegetusa era rivestita dai membri del ceto dei magistrati della città. Pontifices Conosciamo quattro pontifices a Sarmizegetusa, dalla storia della città di più di 150 anni, quindi solo una piccola parte di loro. Non si può datare precisamente il periodo ufficiale di nessuno di loro: D 56 – M(arcus) Iul(ius) Pap(iria tribu) Iustus Verosimilmente durante il II secolo d. C. – dec(urio), pontif(ex) col(oniae). D 45 – (Marcus) Cominius Celerinus Nel terzo quarto del II secolo d. C. – pontif(ex) col(oniae), eq(ues) R(omanus), trib(unus) leg(ionis). D 25 – L(ucius) Ant(onius) Rufus Alla fine del II secolo d. C. – dec(urio) col(oniae), e[q(uo) p(ublico)], p[o]ntif(ex) col(oniae), [?fisci a]dvoc[?atus], [---?]. D 46 – M(arcus) Cominius M(arci) f(ilius) Pap(iria tribu) Quintus Nell’ultimo decennio del II secolo d. C. – eq(uo) p(ublico), pontif(ex), q(uin)q(uennalis), tra il 212 e 217 d. C. – praef(ectus) q(uin)q(uennalis) pro imp(eratore) rinviando alle due quinquennalitates bis q(uin)q(uennalis) col(oniae), patr(onus) coll(egi) fab(rum), eq(ues) R(omanus), circa prima del 222 d. C., ma al più tardi all’inizio del regno di Severus Alexander (222-235 d. C.) – sacerdos Arae Aug(usti).
L’uguale periodo della datazione del D 25 e 46 rinvia a ciò, che almeno per un certo tempo c’erano due pontifices contemporanei in carica nella città. A questa possibilità rifersicono anche i paragrafi analogici della lex Ursonensis [v. Addendum 1.]. Tramite loro si può affermare, che a Sarmizegetusa il posto di pontifex, similmente agli augures, poteva essere occupato da più sacerdoti. Il numero piccolo delle iscrizioni rispetto per esempio al numero dei flamines rinvia a ciò, che non ci potevano essere molti pontifices, quindi si può contare con periodi, quando non tutti i posti pontificali erano occupati, ovviamente a causa dell’incapacità. Non lo si può spiegare in altro modo, tenendo in considerazione i privilegi dei pontifices. Insieme ai flamines però formano uno dei collegia più numerosi dei pontifices nella provincia. Sacerdotes Sacerdotes I. O. M. Dolicheni Apparvero sei sacerdoti di Iuppiter Dolichenus nella città nell’epoca di Severus Alexander. Tra il 222 e 235 fecero costruire un santuario entro il pomerium, nell’angolo sud-occidentale della città.40 I sacerdotes furono persone siriache e palmiresi: Tra il 222 e 235 d. C. (totius provinciae sacerdotes?):
D 49
Fl(avius?)
M[arianus?]
- [sace]rdos
D 61
Lu[cianus?]
[---]
- [sace]rdos
D 64
Maximus bar
S[emon?]
- [sace]rdos
D 65
[Ma]ximus
Gora
- [sace]rdos
D 77
[---]i
Abraen(us?)
- [sace]rdos
D 79
Marinu[s ---]
- [sace]rdos
L’apparizione contemporanea di sei sacerdotes significa un numero un po’ più grande rispetto a quello, che abbiamo visto nel caso dei sacerdoti di Dolichenus. In generale 2-4 di loro si leggono contemporaneamente nelle singole iscrizioni.41 Il numero grande e contemporaneo dei sacerdotes dimostra non solo quello, che si riunirono a causa di un’occasione speciale nella capitale della provincia per fare costruire un santuario, ma potevano rappresentare eventualmente anche tutti i sacerdoti dolicheni all’impresa importante nella capitale. Un altare ritorvato a Tác fu dedicato da tutti i sacerdoti della provincia a Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus,42 questo fenomeno può capitare anche nella Dacia. È anche da notare, che a Sarmizegetusa solo loro ed il D 9 rappresentano nelle fonti la funzione di sacerdos a quest’occasione speciale. Sacerdos Palmyrenorum Non molto lontano da Sarmizegetusa, nel territorio di Voislova odierna era di stanza il numerus Palmyrenorum Orientalium.43 Probabilmente per la truppa, e per i parenti dei soldati si stabilì l’ufficio di sacerdos, come anche a Porolissum [D 13], di cui conosciamo un solo rappresentante: D 9 – P(ublius) [Ael(ius) Art]emidorus Nel III secolo d. C. – adve[n]tor templi, sacer(dos) creatus a Pal[myre]nis, de[c(urio) col(oniae)?]. Il santuario stava già anche prima dell’arrivo del sacerdote. Egli divenne il sacerdote della comunità e del tempio probabilmente dopo il congedo o la morte del sacerdote precedente. Unicamente nella pratica epigrafica romana si definì un forestiero nella comunità e nel tempio. L’adventor non si può interpretare come il nome di una carica. Il suo ufficio sacerdotale non era in connessione con il suo etnico, dato che venne dalla Macedonia e non da Palmyra, quindi sull’incarico nel santaurio decise piuttosto la sua abilità.
TIBISCUM44 Municipium Septimium Tibiscensium Venne alzato al rango di città verosimilmente da Septimius Severus (193-211 d. C.), nel primo decennio del III secolo d. C., al più tardi nel 211. Una parte notevole della società della città era formata dai palmiresi, cioé i soldati congedati del numerus Palmyrenorum Tibiscensium e i loro familiari. La città fu governata verosimilmente dai quattuorviri, come la maggior parte dei municipia fondati da Septimius Severus. Dalla storia analizzabile di circa cinquant’anni della città si conoscono le seguenti cariche sacerdotali e i loro rappresentanti: Flamen Conosciamo un solo flamen del municipium, che rivestì la sua carica nella prima metà del III secolo d. C. D 60 – Iulius Valentin[us] - [f]lamen m(unicipi). Non si possono dedurre conseguenze larghe dall’esistenza di una sola persona, così lui documenta solo la carica nella città. Non si può escludere, che come nel municipium di Porolissum, anche a Tibiscum ci fosse un solo flamen contemporaneamente in carica, che, insieme al pontifex [D 12], rappresentava il collegium pontificum. Pontifex Conosciamo un solo pontifex della città, che rivestì la sua carica nella prima metà del III secolo d. C.: D 12 - Ael(ius) Habibis - [pon]tif(ex). Dato che lui è l’unico rappresentante dell’ufficio nella città, non si possono dedurre conseguenze generali sulla carica pontificale della città. Insieme al rappresentante della carica del flamen formava il collegium pontificum di Tibiscum. Forse lui è l’unico pontifex di origine orientale nella provincia, che si spiega con la composizione della società della città. Come il discendente di una famiglia di vecchia cittadinanza romana naturalmente poteva essere pontifex come notabilità locale.
CITTÀ SENZA DATI Romula - municipium Aelium, colonia Septimia45 Era la città della Dacia Inferior – Malvensis, si trovava alla ripa destra del fiume Olt, nella parte meridionale della Dacia. Non si conosce nessun sacerdote dell’insediamento. Sicuramente erano presenti nella vita pubblica della città i sacerdoti della religione statale, cioé i pontifices, gli augures e i flamines. Si aspetta che i nuovi scavi archeologici porteranno alla luce iscrizioni con vari sacerdotes. ? Malva - colonia?46 Dopo la riorganizzazione della provincia sotto Marcus Aurelius la Dacia Inferior ricevette il nome Dacia Malvensis. In base al dato di un diploma militare e al nome della provincia, l’opinione scientifica pensava a lungo che avesse dovuto esistere una colonia Malva. L’insediamento non è identificato archeologicamente, forse non era una città. Si è presentata l’idea, che fosse identica a Romula. Non si conosce né magistratus, né sacerdote di Malva.
I SACERDOTI DELLE TRUPPE
I sacerdotes di Iuppiter Dolichenus Molte persone sacerdotali indicarono la loro carica presso ad una truppa dell’esercito. Una caratteristica comune di questi sacerdoti, che tutti portavano il titolo di sacerdos, e tutti erano in servizio del culto di una delle divinità orientali, nella prima metà del III secolo d. C. Apulum Il più importante sembra essere senza dubbio l’ufficio del sacerdos presso la legione di Apulum: D 48 – s(acerdos) I(ovis) D(olicheni) ad leg(ionem). Dedicò l’altare non solo alla sua divinità, ma anche a Dea Suria Magna Caelestis. Il numero dei soldati fedeli di Iuppiter Dolichenus nella legio divenne così notevole nel primo terzo del III secolo d. C., che divenne ragionevole impiegare un sacerdote della divinità dolichena, oltre il personale della religione tradizionale del campo militare. Porolissum Si può osservare verosimilmente il fenomeno sopra schizzato anche a Porolissum, dove i tre sacerdoti al servizio di Iuppiter Dolichenus della città furono in servizio anche presso una cohors come sacerdotes cohortis: D 26 – vet(eranus), dec(urio) o[rnat]us ornam(entis) IIIIvir(alibus) m(unicipi), sacerdos dei, sacerdos coh(ortis). D 30 – dec(urio) m(unicipi), vegesi[m]a[r(ius)], sacerdos dei, sacerdos coh(ortis). D 31 – s(acerdos) I(ovis) [O(ptimi)] M(aximi) D(olicheni) e dei, sacerdos coh(ortis), IIIIvir m(unicipi). Benché non sia descritto dettagliatamente il carattere del sacerdotium presso la cohors, il fatto, che loro altrimenti erano i sacerdoti di Iuppiter Dolichenus, rinvia a ciò, che anche presso la truppa erano in servizio di una divinità orientale, presumibilmente del culto di Iuppiter Dolichenus e quello del panteon dolicheno. Nell’epoca dei Severi la divinità e la sua cerchia avevano un ruolo importantissimo nella vita religiosa dell’esercito, soprattutto lungo il Reno e il Danubio.47 I sacerdoti dei palmiresi Conosciamo due sacerdotes nella Dacia, che sembravano avere un sacerdotium presso le truppe organizzate in base etnica. Ambedue i sacerdotes erano in servizio della vita religiosa dei palmiresi. ? (Voislova, jud. Hunedoara)
D 9 – adve[n]tor huius templi, sacer(dos) creatus a Pal[myre]nis, de[c(urio) col(oniae)?].48 Venne dalla Macedonia nel territorio di Sarmizegetusa, dove divenne sacerdos presso il numerus Palmyrenorum Orientalium di stanza all’odierna Vosilova, in un tempio, dove, secondo la sua definizione propria, fu forestiero. Questa definizione segnala il suo stato differente rispetto ai locali membri “originali” della comunità del culto. Tibiscum
Rivestì magistrature nella città, inoltre fu anche il sacerdos della divinità della truppa palmirese, che era di stanza vicina alla città: D 13 - q(uin)q(uennalis), flamen mun(icipi), sacerdos dei n(umeri) P(almyrenorum). Nella Dacia sono conosciute parecchie divinità palmiresi, in questo caso non si può decidere, a quale rinvia il sacerdote, oppure quale si nasconde nell’indicazione del dio.49 Gli scavi archeologici finora non hanno portato a luce nessun santuario di divinità orientali entro i campi militari. Il santuario o il tempio del sacerdotium delle truppe poteva essere nel territorium del campo, nel vicus.
Note
1 Cfr. Noeske 1977, 357-358; Wollmann 1996, 179-187; Ardevan 1998, 51-53, 145, 181-182. 2 Cfr. IDR, III/3, 297, 300, 302, 312, 325, 344, 354, 376. 1-2; Ardevan 1998, 51. 3 CIL, III, 1602 = IDR, III/3, 311. 4 Per una sintesi v. Popa 1975, 36-103; Ardevan 1998, 45-50, 81-82, 139-145; Piso 2001, XV-XXI con la letteratura precedente; cfr. anche Piso 1993, pp. 325-337. 5 V. Lex coloniae Iuliae Genetivae sive Ursonensis c. 73 [qui Addendum 1.]; Cicero, de legibus 2, 23, 58; cfr. anche Sommer 1988, 556. 6 Cfr. Diaconescu – Piso 1993, 67-70; Ardevan 1998, 48, 139-143, 208. 7 Cfr. Ardevan 1998, 48-49, 139-143, 210-216. 8 Cfr. Á. Szabó 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. 9 V. IDR, III/5, 1-724 e 1*-19*. 10 V. HA, Severus Alexander 44, 4 e 27, 6. 11 Cfr. Rusu-Pescaru – Alicu 2000, 32-42. 12 Cfr. la sintesi di Gilliam 1979, 144-175. 13 Per Aesculapius, per la sua famiglia divina, per i luoghi del suo culto v. Kerényi K. 1999 (K. Kerényi, Der göttliche Arzt. Studien über Asklepios und seine Kultstätten, Stuttgart 19481, 19982); per il culto di Aesculapius nell’area danubiana v. il saggio di Z. Kádár nell’edizione ungherese dello stesso volume: Asklépios-Aesculapius világa a Kárpát medencében, 67-73; per il culto di Aesculapius nella Dacia v. Igna 1935; per l’Asklépieion di Apulum v. Crişan 1971, 341-347; Rusu-Pescaru – Alicu 2000, 123-125; Alicu - Crişan 2003, 89-94; Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. 14 Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. 15 Sui medici nelle città cfr. anche Liebenam 1900, 100-105; in sintesi e ultimamente sul Locus e sui suoi istituti conosciuti v. Szabó Á. 2004 (Orbis Antiquus), 787-801. 16 Cfr. Sanie 1989, 1237-1238. 17 Cfr. ultimamente Alicu – Rusu-Pescaru 2000, 84-90. 18 Sul carattere dell’insediamento cfr. la sintesi di Bérard 1992, 75-105. 19 Cfr. anche Ardevan 1998, 209-210. 20 Cfr. Ardevan 1998, 49-50, 144-145, 216-217. 21 Cfr. Ardevan 1998 , 50. 22 Cfr. Moga 1985. 23 Cfr. la sintesi di Speidel 1978; v. anche B. Angyal 1971, 5-26; inoltre Tóth I. 1970), 278-281. 24 Cfr. Tóth I. 1976, 69-88. 25 Cfr. Ardevan 1998, 36-39, 72-73, 133-135. 26 V. Ulp. dig L, 15, 1, 8. 27 Cfr. Davidescu 1981, 98; Ardevan 1998, 33-36. 28 V. Szabó 2006, III. 1 – Aquincum. 29 V. Daicoviciu 1977, 919–949; Ardevan 1998, 61-65. 30 Cfr. Gudea 1986; Paki 1988 (AMP), 215-226; Ardevan 1998, 65-67. 31 Cfr. Gudea – Tamba 2001. 32 Cfr. Tóth I. 1976, 69-88. 33 V. Bărbulescu 1994; Ardevan 1998, 55-61. 34 Per il carattere dell’insediamento v. la sintesi di Bérard 1992, 75-105. 35 V. AÉ 2003, 1446 e AÉ 1972, 363 e cfr. anche Szabó 2006, P 48. 36 Cfr. Bărbulescu 1984, 144-145. 37 Cfr. C. Daicoviciu 1974, coll. 610-655; Daicoviciu – Piso 1975, 159-164; Daicoviciu – Alicu 1984; Paki 1988 (SCIVA), 355-368; Paki 1990, 149-163; Alicu – Paki 1995; Étienne – Piso – Diaconescu 1990, 273-296; Piso 1993, 325-337; Piso 1998, 134-135; Piso 2001 (TR), 17-37; cfr. anche Ardevan – Găzdac 2004, 7-13. 38 V. CIL III, 7991; EE, II, n. 440; IDR, III/2, 35. 39 Cfr. Alicu 1997, 101, 262-263, nr. VIII. 40 Cfr. Á. Szabó 2004 (HPS), 139-162. 41 Cfr. Tóth I. 1976, 15-18; CCID, 60, 61, <64>, 65, 77, 87, 112, 115, 124, 148, 221, 229, 231, 207, 371, 373, 385, 408, 409, 414; Á. Szabó 2004 (HPS), 144-146. 42 V. CIL III, 3343 = AÉ 1944: 86b = Merlat 72-73 = RIU 1528; v. anche Tóth I. 1976, 40-68 = Fitz 1992-1995, 424 = Szabó 2006, P 91. 43 V. anche IDR, III/2, 348, 366, 367, 416; cfr. Gostar 1979, 663-665; Piso 1987-1988, 163-164. 44 Cfr. Ardevan 1998, 39-42, 73-74, 135. 45 Cfr. Ardevan 1998, 29-33, 70-71, 132; sono conosciuti alcuni magistrati v. per es. AÉ, 1957: 334 – Reşca (Romula?): D(is) M(anibus) // Ael(io) Iul(io) Iuliano dec(urioni) quaestoric(io) / aedilic(io) col(oniae) Romul(ae) Valeria Ge/mellina marito b(ene) m(erenti) p(osuit) / coniugi pro meritis quondam karissimo coniunx / hanc Iuliano domum flendo fabricavi perennem / frigida qua membra possint requiescere morti / quattuor hic denos vixit sine culpa per annos / et sua perfunctus vidit cum gloria honores / ecce Gemellina pietate ducta marito / struxi dolens digno sedem cum liberis una / inter pampinea virgulta et gramina laeta / umbra super rami virides ubi densa ministrat / qui legis hos versus opta leve terra viator; AÉ, 1972: 483: [Da]rdanic(a)e / [---]us dec(urio) col(oniae) et (A)el(ius) / [---]L ex voto posuerunt.,ecc. 46 Cfr. Ardevan 1998, 98. 47 Cfr. la sintesi di Speidel 1978. 48 V. anche Tóth I. 1970, 278-281. 49 Cfr. Sanie 1989.
I CONSIGLI PROVINCIALI E I SOMMI SACERDOTI
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Traianus (98-117 d. C.) conquistò il regno dacico in due guerre (101-102 e 105-106 d. C.),1 dal quale organizzò una provincia con il nome Dacia [v. qui p. 8], e dove invitò coloni da tutte le parti del mondo romano d’allora. La nuova provincia venne divisa in tre parti dopo la fondazione2: nelle province di Dacia Superior, Dacia Inferior3 e Dacia Porolissensis.4 La sede del luogotenente, che prima aveva il rango di praetor, era ad Apulum, dove anche la legio XIII Gemina5 era di stanza. Dacia Inferior e Dacia Porolissensis furono governate dai procuratores. Sotto Marcus Aurelius (161-180 d. C.) la provincia venne riorganizzata: dal 169 d. C. Dacia Superior cominciò a portare il nome Dacia Apulensis, mentre Dacia Inferior ricevette il nome Dacia Malvensis. Dacia Porolissensis mantenne il nome vecchio.6 La seconda legione della Dacia, la legio V Macedonica venne stabilito a Potaissa.7 Da questo momento la provincia aveva due legioni, con un luogotenente di rango consularis. La difesa dei confini della provincia fu guarantita da numerose truppe ausiliari.8 La Dacia traianea rimase la provincia dell’Impero Romano fino al 271 d. C.9 L’organizzazione della provincia fu seguita dalla fondazione della prima città da parte di Traianus: la colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa, prima del 108 d.C.10 Sotto il regno di Severus Alexander (222-235 d. C.) la città ricevette anche l’attributo Metropolis, che indicava il suo rango.11 Hadrianus (117-138 d. C.) fondò tre città nella Dacia, una colonia, la colonia Aelia Romula (col. Malva?),12 e due municipia. Il municipium Publium Aelium Hadrianum Drobetensium acquistò il rango di colonia sotto Septimius Severus (193-211 d. C.) con il nome colonia Septimia Drobetensium.13 Il municipium Aelium Hadrianum Napocensium di fondazione adrianea fu alzato al rango coloniale verosimilmente da Marcus Aurelius con il nome colonia Aurelia Napocensium.14 Marcus Aurelius (161-180 d. C.) fondò il municipium Aurelium Apulensium, che venne elevato al rango coloniale e ricevette il diritto romano dal suo successore, Commodus (180-192 d. C.), con il nome colonia Aurelia Apulensium. Sotto Trebonianus Gallus (251-253 d. C.) la città ricevette anche l’attributo Chrysopolis. Septimius Severus donò il rango municipale alla città militare, che ricevette il nome municipium Septimium Apulensium tra il 193 e 197 d. C. Forse questo muncipium divenne la colonia Nova Apulensium sotto Traianus Decius (249-251 d. C.).15 Septimius Severus (193-211 d. C.) fondò nella prima metà del suo regno il muncipium Septimium Potaissensium, il quale poi fu alzato da lui al rango coloniale tra il 200 e 211 d.C. con il nome colonia Septimia Potaissensium.16 Similmente lui fondò quattro altri municipia nella Dacia: le città di Ampelum,17 Dierna,18 Tibiscum19 e Porolissum,20 le quali tutti furono municipia Septimia. Con questi divenne intera la rete urbanistica della Dacia.21 Quattro o cinque(?) città (Dierna (?), Sarmizegetusa, Napoca, Apulum e Potaissa22) ricevettero il Ius Italicum fino all’epoca o nell’epoca dei Severi, che significava, che il loro territorio godeva gli stessi diritti che la terra italica.23 I terreni con il Ius Italicum fecero la parte decisiva del territorio della provincia e divennnero veramente le proprietà delle città senza imposta fondiaria. Le città li potevano vendere, così i terreni divennero proprietà private. In realtà cessarono il diritto di proprietà e la responsabilità dello stato su questi terreni, che d’altra parte continuavano a fornire l’imposta fondiaria e altri incassi di carattere fiscale per l’erario. Con questa donazione apparente delle immunità di una grandezza senza precedente lo stato “si tolse” economicamente dalla maggior parte della provincia, quindi prima della resa (271 d. C.) cominciò a ‘sanare’ previdentemente e discretamente la provincia. L’organizzazione del consiglio provinciale della Dacia accadde con ogni probabilità direttamente dopo la fondazione della provincia.24 La sua sede fu la prima città della Dacia, la colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Il forum provinciae e l’Ara Augusti, circondati da un portico di 66 x 66 m, si trovava entro il territorio dell’Area sacra fuori le mura, accanto alla città, verso Nord, vicino all’anfiteatro.25 Del primo periodo non abbiamo nessuna fonte epigrafica. Ma l’anfiteatro, ricostruito in pietra nel 158, ha anche un periodo precedente in legno, che dimostra, che c’erano stati giochi a Sarmizegetusa anche precedentemente.26 Inoltre, anche le monete ritrovate nel territorio dell’Area sacra provano l’uso continuo del territorio sin dalla fondazione.27 Finché ci fosse una sola città nella provincia, il consiglio provinciale non poté oltrepassare i limiti di essa, e nella Dacia non c’erano civitates. Non sono conosciute civitates di origine autoctona nella Dacia, i cui abitanti potevano partecipare alle cerimonie. Nell’epoca di Hadrianus esistevano già più di una città nella provincia, che potevano formare un consiglio provinciale formale, anche se non molto numeroso. Sotto Marcus Aurelius una nuova città poté mandare i suoi legati nel consiglio provinciale, il quale si indicò come provincia nelle iscrizioni dei due altari eretti da sé stesso nell’epoca [1, 2].
1.
Provincia [Dacia Superior] a. Altare di marmo. Sarmizegetusa. Vajdahunyad (Hunedoara). CIL, III, 1412; CIL, III, 7902; ILS, 7155; Piso 1972 (AMN), 463-465; IDR, III/2, 93; Ardevan 102; Szabó Á. 1999 (2000), 128; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 108, nr. 1; [Dis] Faventibus et Co[n|c]ordia Imp(eratorum) evenit qu|od a primo adventu | suo P(ublius) F(urius) S(aturninus) leg(atus) August[or(um)] | donec provincia de|ceder(et) ita singulos un[i]|versosque benig(ni)tate sua | tractarit oneribus etiam | rel[e]vaver[it] ut felicissim(a) | et praeci[p]uis virtuti[b(us)] | eius obs[tr]icta simul [e]t | devota provincia ei | [grat]ia[s] agat [---] | [---] Germ(---) p(---) . b. Altare di marmo.
Sarmizegetusa. Al centro di Várhely (Cetăţuia) , a pochi metri dal muro della città romana. AÉ, 1972: 463; Piso 1972 (AMN), 464-465; IDR, III/2, 94; Ardevan 109; Szabó Á. 1999 (2000), 128; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 108, nr. 1; Dis Fav[ent(ibus) et Con]|cordia [Imperator(um)] | evenit q[uod a primo ad]|ventu su[o P(ublius) Furius Saturni]|nus leg(atus) A[ugustor(um) donec pro]|vincia [Dacia super(iore) decede]|ret ita s[ingulos universos]|que ben[ignitate sua tracta]|rit on[eribus etiam releva]|ver[it ut ---] | [--- . Le due iscrizioni risalgono al 161-162 d. C., in base al periodo ufficiale del luogotenente. Il nome del consiglio provinciale nel testo delle iscrizioni è provincia o provincia [Dacia Superior].28 Le denominazioni usate esprimono l’essenza del consiglio provinciale, che sotto questo nome si identificò con la provincia rappresentata da loro. Il nome in una delle iscrizioni e la provincia, a cui nome si agiva, rinviano a ciò, che l’istituto funzionava nella Dacia Superior, e una delle iscrizioni venne eretta a nome della Dacia Superior. Quindi l’altra si può riferire a tutta la provincia complessiva di tre parti amministrative. Le due iscrizioni, scolpite contemporaneamente, e probabilmente erette originalmente allo stesso posto, rende possibile l’ipotesi, che il consiglio provinciale funzionasse all’inizio solo nella Dacia Superior, che rappresentava tutta la Dacia. La sua sfera d’influenza non doveva essere identica al territorio entro i confini della provincia.29 Per questo poté far erigere due iscrizioni con lo stesso testo: una a nome della Dacia Superior, un’altra a nome di tutta la Dacia. Gli antefatti storici possono spiegare il fenomeno. Fino a Hadrianus (117-138 d. C.) c’era una sola città nella provincia, proprio nella Dacia Superior (l’unica città anche nella Dacia Superior fino alla fondazione del municipium Aurelium Apulensium), così il consiglio provinciale riguardava solo questa città e il suo territorio, quindi la parte civile della provincia. Da Hadrianus, però, anche i nuovi insediamenti fondati, che nel 161-162 d. C. si trovavano fuori i confini della Dacia Superior, mandavano i loro legati logicamente nella colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa, nel consiglio provinciale della Dacia Superior, quindi in quello della Dacia. La speciale struttura provinciale della Dacia non avrebbe spiegato i consigli in ogni singola provincia, così l’istituto funzionava probabilmente sin dalla fondazione con la competenza su tutta la Dacia. L’autoidentificazione provincia esprime proprio quello, che dice anche la leggenda Provincia Dacia [qui 3] sul rovescio delle monete provinciali, coniate circa cento anni dopo. Non sono conosciute altre fonti del II secolo d. C. sul consiglio provinciale della Dacia. Nel III secolo d. C. l’istituto si presenta con un nome diverso, esprimendo così la sua competenza in tutte e tre sottoprovince della Dacia di struttura speciale.
2.
Concilium provinciarum Daciarum III a. Tavola marmorea del piedistallo di una statua [ = D 39]. Sarmizegetusa. Várhely (Cetăţuia). AÉ, 1903: 69; Kerényi 610; Daicoviciu 1969, 388, nr. 1; Deininger 1965, 118-119; IDR, III/2, 79; Piso 1982, 26614; Ardevan 91; Szabó Á. 1999 (2000), 128; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 112, nr. 7; ---] | [--- pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) | M(arci) Aur(eli) Severi Alexan|d]ri Pii [Fel(icis) Aug(usti)] | concilium p[ro]|vinciarum Dac(iarum) I[II(trium)] | [[dedicante Iasdio | Domitiano co(n)s(ulari)?]] | sacerdot(io) Tib(eri) Cl(audi) | Augustiani eq(uo) p(ublico). 222-235 d. C. b. Base di marmo. Sarmizegetusa. Várhely (Cetăţuia). CIL, III, 1454; ILS, 7128; Deininger 1965, 118-119; Daicoviciu 1969, 388, nr. 2; IDR, III/2, 80; Fishwick 1987, 302; Ardevan 88; Szabó Á. 1999 (2000), 128-129; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 112, nr. 7; Imp(eratori) Caesari | Marco Anton(io) | Gordiano Pio | Felici Aug(usto) pont(ifici) | max(imo) trib(uniciae) pot(estatis) IIII | co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) | concilium prov(inciarum) | Daciarum III(trium) | devoti numini | maiestatique | eius. 241 d. C. c. Base marmorea di una statua. Sarmizegetusa. Várhely (Cetăţuia). Deininger 1965, 118-119; IDR, III/2, 81; Ardevan 92; Szabó Á. 1999 (2000), 129; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 112, nr. 7; Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Iulio | Philippo Pio Felici | Aug(usto) pont(ifici) m(aximo) | trib(unicia) pot(estate) V co(n)s(uli) III | p(atri) p(atriae) [proco(n)s(uli) c]on|cil[ium III(trium) pr]o|vi[nciar(um) Dac]iar(um) | de[voti n]umi|ni [maiestat]iq(ue) | [eius]. 248 d. C.
Il nome del consiglio provinciale in forma concilium provinciarum Daciarum III si legge su tre basi per statue a Sarmizegetusa, erette dal consiglio per l’imperatore. Le iscrizioni si datano tra il 222 e 235 d. C. [a.], al 241 d. C. [b.] e al 248 d. C. [c.]. Quindi il consiglio provinciale aveva il nome concilium provinciarum III Daciarum almeno dall’epoca di Severus Alexander. Il nome preciso e fedele esprimeva la pratica esistente, cioé che l’istituto con la sede a Sarmizegetusa rappresentava tutte e tre Dacie. Allo stesso tempo, con queste iscrizioni il consiglio provinciale si rappresenta nel III sec. d. C. con un nome praticamente classico, che esprime l’essenza dei consigli provinciali, similmente ai quelli delle province occidentali, sopratutto delle Tres Galliae,30 e ai consigli delle province orientali di lunga tradizione.31 Tutto sommato, questo nuovo nome segnala un consiglio provinciale verosimilmente riorganizzato.32
3.
Provincia Dacia Sesterzi e dupondi di bronzo. Dacia, Moesia Superior etc. Pick 1898, nnr. 1-195; Alföldi 1931, 146; IDR, I, 31; Fitz 1964; Winkler 1971; Fitz 1978 (GRPD), 636; Fitz 1979; Martin 1992, 84-113; Ardevan 1998, 336; Szabó Á. 1999 (2000), 129-130; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 114-115, nr. 12; Diritto: Ritratto dell’imperatore con il nome e titolo appartenente. Rovescio: Provincia Dacia | an(no) I---XI | D(acia) F(elix). 246 – 257 d. C. con tutti gli anni intermedi. La provincia di Dacia ricevette il diritto di coniazione da Philippus Arabs nel 246 d. C., e lo esercitò per 11 anni, fino al 257 d. C.33 Sui diritti delle monete si vede il ritratto e il nome dell’imperatore, dell’imperatrice o dell’erede del trono, sui rovesci invece il Genius della Dacia in elmo, tenendo in mano un vexillum con le lettere D(acia) F(elix), un ramo di palma oppure uno sceptrum. La figura femminile è circondata degli animali dell’insegna della legio XIII Gemina di Apulum, e quelli della legio V Macedonica di Potaissa: un’aquila con una corona nel becco, e un leone. La leggenda del rovescio (PROVINCIA DACIA), le lettere, lo spazio tra di loro e la loro divisione sono diversi, similmente al segno della zecca. Sotto si vede l’anno dell’emanazione della data serie, contando dall’inizio della coniazione.34 In base ai criteri stilistici A. Alföldi ha localizzato il luogo di produzione di queste monete a Viminacium di Moesia.35 Dall’altra parte, in base alla frequenza dei reperti – menzionata come argumento anche nella questione della zecca possibile di Viminacium –, I. Winkler ha presentato la teoria, che il tipo di moneta fu coniato a Sarmizegetusa dal consiglio provinciale della Dacia.36 J. Fitz ha ritenuto l’ipotesi di Winkler inverosimile.37 Comunque, indipendentemente dal luogo della zecca, il diritto della coniazione fu esercitata verosimilmente dal consiglio provinciale della Dacia, la leggenda del rovescio indica sia la provincia che il suo rappresentante, il consiglio provinciale. Questo è espresso semplicemente con le parole provincia Dacia, invece del concilium provinciarum Daciarum III, come anche nelle iscrizioni del II secolo d. C. [cfr. qui 1]. Il consiglio provinciale fu indicato con un’espressione simile sui rovesci delle monete coniate nella Moesia vicina nello stesso periodo, che sono le analogie più vicine: koinón Makedonon.38 Recentemente anche R. Ardevan ha ritenuto le serie della provincia Dacia le coniate del consiglio provinciale.39 Le monete del 257 d. C. sono allo stesso tempo le ultime memorie dell’attività del consiglio provinciale della Dacia, il quale aveva ancora solo 14 anni nel territorio della Dacia traianea fino alla resa e all’evacuazione della provincia. Quindi si può affermare, che il nome del consiglio provinciale della Dacia fu provincia nel II secolo d. C., mentre dal primo quarto del III secolo d. C. concilium provinciarum Daciarum III, e queste denominazioni corrispondevano anche al sistema amministrativo della provincia, delle province. È probabile, che la Provincia Dacia nella leggenda non segnali formalmente il nome del consiglio provinciale, il suo uso può essere spiegato anche con lo spazio piccolo per la scrittura. Si può osservare un fenomeno simile nell’uso delle parole nella Pannonia Inferior del II secolo d. C., dove nell’iscrizione di un sommo sacerdote, che fu in carica verso la metà del III secolo d. C., si legge il nome dell’ufficio in forma usata solo nel II secolo d. C., indicato quindi, con ogni probabilità, non formalmente.40
I SOMMI SACERDOTI Conosciamo otto sommi sacerdoti della provincia di Dacia, quindi circa il cinque percento delle 165 persone in caso ottimale, contando con 165 anni tra la conquista e l’evacuazione della provincia, e prendendo in considerazione anche il fatto, che erano sicuramente non in 165. I sommi sacredoti venivano per lo più dalla parte latina dell’impero. La maggior parte era il membro dell’ordine equestre. Per quanto riguarda la loro origine, vennero da Apulum [D 5, 27, 39], da Napoca [D 15], da Potaissa [D 85] e da Sarmizegetusa [D 20,40], e di uno non si sa da quale città [D 83]. Il titolo della carica Il titolo della carica dei sommi sacerdoti si legge nelle forme di sacerdos provinciae [D 83], di sacerdos Daciae di valore uguale [D 85], di sacerdos Arae Augusti [D 5, 20, 46] e di sacerdos Arae Augusti nostri coronatus Daciarum III [D 15, 27]. Il titolo di uno è sconosciuto. Secondo il periodo quando la sua iscrizione fu eretta poté essere sia sacerdos Arae Augusti che sacerdos Arae Augusti nostri, coronatus Daciarum III [D 39]. Sembra probabile, che in base alla datazione delle iscrizioni e la compilazione del titolo in forma presente oppure passata, i due titoli con diversi contenuti dei sommi sacerdoti indichino anche un ordine cronologico. Nel II secolo e all’inizio del III secolo d. C. i sommi sacerdoti portavano i titoli sacerdos provinciae e sacerdos Daciae. Dall’inizio del III secolo d. C., nel primo quarto del secolo rivestivano la loro carica con il titolo sacerdos Arae Augusti. Sotto il regno di Severus Alexander (222-235 d. C.) il titolo venne ampliato in sacerdos Arae Augusti nostri, coronatus Daciarum III.41 La cronologia dei sommi sacerdoti conosciuti Non c’è un’iscrizione eretta da un sommo sacerdote prima dell’epoca dei Severi, mentre l’ultima fu dedicata sotto il regno di Gordianus III, quindi conosciamo sommi sacerdoti da un periodo di meno di cinquant’anni, che, ovviamente, non significa, che non ce n’erano affatto. Questo numero illustra solo la situazione generale epigrafica. Il luogo della carica Indipendentemente dal posto di ritrovamento delle iscrizioni, il luogo della carica corrispondeva ovviamente alla sede del consiglio provinciale. La sede dell’ufficio del sommo sacerdote era nella colonia di Ulpia Traiana Sarmizegetusa, nel territorio della città, ma fuori le mura, verso Nord, nel territorio del forum provinciae nell’Area sacra, costruita accanto all’anfiteatro.42 Le iscrizioni e il loro posto Delle iscrizioni sui sommi sacerdoti solo alcune possono essere legate ad un sommo sacerdote proprio in carica. Ne conosciamo alcune, che vennero erette dai sommi sacerdoti, e ci sono altre che furono dedicate a loro. Non ci sono finora nessuna traccia delle statue dei sommi sacerdoti, erette dal consiglio provinciale. Si conosce una sola iscrizione nella zona del forum provinciae, la quale fu eretta da uno dei sommi sacerdoti in carica [D 5 f.] anche al Genius delle tre Dacie, il che è opportuno in questo luogo.43 Uno dei sommi sacerdoti dedicò due iscrizioni a Mars per la salute dell’imperatore verosimilmente durante la sua carica, tra il 238 e 244 d. C. [D 27 b., c.]. Le altre iscrizioni conosciute non sono in connessione con l’ufficio dei sommi sacerdoti: la loro dedicazione ha cause private di diversi caratteri, oppure sono onori della città, non per il sommo sacerdote, ma per il magistratus della città, che fu per caso un sommo sacerdote. Il posto della carica nella carriera Il posto della carica dei sommi sacerdoti nelle iscrizioni conosciute, oppure il loro posto ricostruibile insieme agli altri elementi della carriera: La fine del II – l’inizio del III secolo d. C. - D 85 – [---] [---] [---] - vet(eranus) ex b(ene)f(iciario) leg(ati), [?eq(ues) Roman]us(?), [sac]erdotalis Daciae. D 83 - [---] [---] [---] - [--- cariche, uffici ---] [municip]iorum(1,2), sacerdotal(is) provinciae. Il primo quarto del III secolo d. C. - D 5 - P(ublius) Ael(ius) Antipater - decurio col(oniae), e(quo) p(ublico), q(uaestor?), a mil(itis), IIvir, flame[n] col(oniae), sac(erdos) Arae Aug(usti). D 20 - P(ublius) Ael(ius) P(ubli) fil(ius) P(apiria tribu) Strenuus - equo p(ublico), augur col(oniae)(2), dec(urio) col(oniae)(3), patron(us) collegior(um) fabr(um) centonar(iorum) et nautar(um), conduc(tor) pascui salinar(um) et commercior(um), IIviralis, augur col(oniae)(1), sacerd(os) Arae Aug(usti). D 46 - M(arcus) Cominius M(arci) f(ilius) Pap(iria tribu) Quintus - eq(uo) p(ublico), pontif(ex), q(uin)q(uennalis), praef(ectus) q(uin)q(uennalis) pro imp(eratore) <= bis q(uin)q(uennalis) col(oniae)>, patr(onus) coll(egi) fab(rum), eq(ues) R(omanus), sacerdos Arae Aug(usti).
Dal secondo quarto del III secolo d. C., dal regno di Severus Alexander (222-235 d. C.) - D 39 - Tib(erius) Cl(audius) Augustianus - eq(uo) p(ublico), augur m(unicipi), sacerdos (Arae Augusti o Arae Augusti nostri, coronatus Daciarum III?). D 15 - P(ublius) Ael(ius) Maximus - a militis, IIvir q(uin)]q(uennalis), fla[men col(oniae)(1), [sacerdos Ar]ae Aug(usti) n(ostri), [coronatus Dac(iarum) I]II, dec(urio) col(oniae)(2). D 27 - M(arcus) Antonius Valentinus - eq(ues) R(omanus), dec(urio), [pat]ronus co[ll(egi) f]abr(um) (?) m(unicipi), dec(urio) col(oniae)?, sacerdos Arae Aug(usti) n(ostri), coronatus Dac(iarum) III. Si può affermare che nessuno di loro aveva altro ufficio dopo la carica come sommo sacerdote. Nel caso del D 15 l’indicazione del decurionatus in una seconda colonia ha solo importanza cronologica, cioé divenne il membro dell’ordo decurionum a Sarmizegetusa come sommo sacerdote. Il testo delle iscrizioni erette dai sommi sacerdoti contengono elenchi lacunosi del cursus: nel testo sono indicate soprattutto le cariche attuali. Anche dove il cursus è descritto assai dettagliatamente, sono indicate solo le magistrature continue oppure quelle più alte rivestite. Sei su otto sommi sacerdoti conosciuti erano sicuramente i membri dell’ordine equestre [D 5, 15, 20, 27, 39, 46], l’appartenenza di un altro è incerta, ma era verosimilmente eques anche lui [D 85], e dell’ultimo non si sa questo, dato che la maggior parte dell’iscrizione è andata persa [D 83]. In base alla maggioranza rilevante si può affermare, che le persone che concorrevano alla carica del sommo sacerdote della Dacia, dovevano essere con ogni probabilità i membri dell’ordine equestre, oppure quelli che non erano equites, non concorrevano, secondo i casi conosciuti. Molti di loro avevano fatto anche servizio militare oppure servizio militare equestre [D 5, 15, 83]. È un fatto generalmente affermato, provato e accettato, che i sommi sacerdoti erano in tutto l’impero omnibus honoribus functis, quindi prima dell’acquisto del summus honor occupavano tutte le stazioni del cursus honorum municipale. Nel caso dei sommi sacerdoti della Dacia le fonti epigrafiche non contengono in ogni caso un intero cursus honorum, a causa dei diversi motivi dedicatori. Si sa, che quattro su otto sacerdoti erano duumviri o duumviri quinquennales nella loro città [D 5, 15, 20, 46]. Le iscrizioni sugli altri quattro sono frammentarie oppure furono erette da loro, e per questo indicano solo il loro stato sociale e gli onori continui o a vita. Alcuni di loro rivestivano cariche in due, tre città: erano i membri dell’ordo decurionum oppure occupavano un ufficio sacerdotale [D 15, 20, 27, 83]. Tutto sommato, nel caso della metà dei sommi sacerdoti si può dimostrare l’esistenza dell’intero cursus municipale, ma lo si può presupporre con ragione anche nel caso dell’altra metà. Alcuni avevano prima della carica di sommo sacerdote diverse cariche sacerdotali municipali oltre le magistraturae: l’auguratus [D 20 – in due posti, D 39], il flaminatus [D 5, 15] e il pontificatus [D 46]. Si può affermare, che tutte le cariche sacerdotali della religione tradizionale dello stato erano compatibili con l’onore del sommo sacerdote della provincia. Molti erano anche i patroni delle organizzazioni civili, e si può dimostrare, che svolgevano anche attività industriale o commerciale [D 20, 27, 46]. La carica del sommo sacerdote sembra veramente l’apice della carriera civile, il summus honor anche nella Dacia. Le condizioni della carica del sommo sacerdote provinciale nella Dacia In base ai sopraddetti si può affermare che, per quanto riguarda il suo stato sociale, l’aspirante dell’onore del sommo sacerdote doveva essere il membro dell’ordine equestre, e veramente omnibus honoribus functus. Inoltre, poteva essere un vantaggio, se aveva avuto uffici, onori in più città, ma almeno era stato il membro dell’ordo decurionum. Tra questi ultimi avevano importanza rilevante gli ordines decurionum di Sarmizegetusa e di Apulum. Inoltre contava una buona condizione economica, che si poteva basare sull’industria o sul commercio, poi il patrocinio delle organizzazioni civili. La durata della carica del sommo sacerdote provinciale Il candidato veniva eletto al summus honor sicuramente per un anno anche nella Dacia. Niente rinvia a ciò, che si deviasse dalla pratica generale in tutto l’impero. Il consiglio provinciale della Dacia e i sommi sacerdoti Visto che ogni anno veniva eletto un sommo sacerdote provinciale, dovremmo conoscere 165 sommi sacerdoti della Dacia dal periodo tra l’organnizzazione e l’evacuazione della provincia. In pratica ne potevano essere un po’ meno, perché poteva passare un certo tempo fino all’organizzazione della provincia e fino all’elezione del primo sommo sacerdote, e anche le circostanze degli anni direttamente precedenti all’evacuazione della provincia sono sconosciute. Inoltre, una persona poteva essere più volte sommo sacerdote. Nonostante la grande quantità delle iscrizioni daciche i pochissimi sommi sacerdoti conosciuti permettono l’ipotesi, che alcune persone benestanti di grande rispetto vennero elette sommi sacerdoti più di due volte nella vita, caso mai continuamente. Si fecero rieleggere più volte, fino all’età massima [cfr. anche Addendum 3, 4], perciò ne conosciamo così pochi. Conosciamo otto sommi sacerdoti sicuri nella Dacia, e ci sono alcune persone con certi elementi nella carriera, in base a cui si può ipotizzare anche per loro questa carica. Questi ultimi però non contano tra i sommi sacerdoti. Così si possono dedurre solo alcune conseguenze molto generali in base ai sommi sacerdoti conosciuti, che sono in pochi rispetto al numero possibile. L’esistenza di un sommo sacerdote rinvia in generale alla funzione del consiglio provinciale e viceversa.44 La cronologia delle fonti sui sommi sacerdoti in testa al consiglio provinciale risale alla fine del II secolo d. C. Sembra che fino all’inizio del III secolo d. C. il titolo ufficiale dei sommi sacerdoti fosse sacerdos provinciae [D 83] o sacerdos Daciae di valore uguale45 [D 85]. Il titolo del sommo sacerdote armonizza con il nome provincia del consiglio provinciale del II secolo d. C. Dall’inizio del III secolo d. C. fino al regno del Severus Alexander i sommi sacerdoti portavano il titolo sacerdos Arae
Augusti [D 5, 20, 46]. Il nostro primo dato sul nome concilium provinciarum Daciarum III [2.a.] del consiglio provinciale risale all’epoca di Severus Alexander (222-235 d. C.) [2a]. Del titolo del sommo sacerdote nell’iscrizione [D 39] è indicata solo la parola sacerdos, così non sappiamo, quale titolo portasse lui. Poteva essere sacerdos Arae Augusti oppure già sacerdos Arae Augusti nostri, coronatus Daciarum III. Quest’ultima possibilità deriva dal fatto, che i sommi sacerdoti successivi portavano ormai un titolo più lungo, in cui veniva integrato anche il loro stato come i capi del consiglio provinciale (similmente alla pratica nelle province orientali) e anche uno dei simboli dell’onore: sacerdos Arae Augusti nostri, coronatus Daciarum III [D 15, 27]. L’ultima parte del titolo corrisponde al nome contemporaneo del consiglio provinciale, che si riferisce similmente alle tre province. La maggior parte dei sommi sacerdoti conosciuti erano di Sarmizegetusa [D 20, 46] e di Apulum [D 5, 27, 39], ma la provincia aveva anche sommi sacerdoti di Potaissa [D 85] e di Napoca [D 15]. È sorprendente che non si conosce nessun sommo sacerdote delle città della Dacia Inferior-Malvensis. Questo può essere spiegato solo con la mancanza delle fonti. Sei su otto sommi sacerdoti erano sicuramente i membri ell’ordine equestre [D 5, 15, 20, 27, 39, 46], uno verosimilmente [D 85], mentre dell’ultimo non si sa [D 83]. Con una sola eccezione, le cui cariche furono indicate intenzionalmente selezionate, tutti rivestivano le magistrature in più insediamenti oppure erano decuriones in più città.
Note
1 Cfr. pl. Cichorius 1927; Patsch 1937. 2 Cfr. Macrea 1966, 121-151. 3 Cfr. Vlădescu 1983; Vlădescu 1986. 4 Cfr. Piso 1985, 471–481. 5 Cfr. Moga 1985. 6 Cfr. Petolescu 1987 (Reorg), 123-134. 7 Cfr. la sintesi di Bărbulescu 1987; Bărbulescu 1994. 8 Cfr. la sintesi di Beneš 1978; Petolescu 2002; Gudea – Lobüscher 2006. 9 Per la storia della provincia cfr. la sintesi TIR L–34, Aquincum-Sarmizegetusa-Sirmium, Budapest 1968; TIR L–35, Romula-Durostorum-Tomis, Bucureşti 1969; TIR K–34, Naissus–Dyrrhachion-Scupi-Serdica-Thessalonike, Ljubjana 1969; Alföldi 1929, 161-188 - 1930, 1-26, 81-95, 164-170; Daicoviciu 1938 = Daicoviciu 1943; Alföldi 1940; Alföldi 1943, 1-93; Macrea – Tudor 1960, 345-476; Daiciviciu 1966, 153-171; Macrea 1969; Glodariu 1977, 950-989; Piso 1982, 225-238; Tóth E. 1986, 46-106; Opreanu 1998; Vékony 1989, 116-179; Petolescu 2000. 10 Cfr. Daicoviciu 1974, 610-655; H. Daicoviciu – Piso 1975, 159-164; H. Daicoviciu – Alicu 1984; Paki 1988 (SCIVA), 355-368; Paki 1990, 149-163; Alicu – Paki 1995; Étienne – Piso – Diaconescu 1990, 273-296; Piso 1993, 325-337; Ardevan 1998, 42-44; Piso 1998, 134-135; cfr. anche Ardevan – Găzdac 2004, 7-13. 11 V. Daicoviciu 1969, 387. 12 Cfr. Petolescu 1987 (Malva), 23-32; Ardevan 1998, 29-33. 13 Cfr. Petolescu 1993, 59-64; Ardevan 1998, 33-36. 14 Cfr. H. Daicoviciu 1977, 919-949; Ardevan 1998, 61-65. 15 Per le due città v. Popa 1975, 36-103; Ardevan 1998, 45-50, 81-82, 139-145; Piso (IDR III/5), XV-XXI con la letteratura precedente; cfr. anche Piso 1991 (1993), 325-337. 16 Cfr. Bărbulescu 1994; Ardevan 1998, 55-61. 17 V. Ardevan 1998, 51-53. 18 Cfr. Petolescu 1993, 59-64; Ardevan 1998, 36-39. 19 Cfr. Ardevan 1998, 39-42. 20 Cfr. Gudea 1986; Paki 1988 (AMP), 215-226; Ardevan 1998, 65-67. 21 Per l’urbanizzazione v. la sintesi di Tudor 1968; Macrea 1969; Branga 1980; Bogdan–Cătăniciu1993, 203-25; Ardevan 1998; per la popolazione della provincia v. A. Kerényi A. 1940, per completare Russu 1975 (1977), 1-17. 22 Ulp. dig 50, 15, 1; Ulpiani de censibus libri VI, Liber I [de iure italico], 8-10. 23 Cfr. Gostar 1969, 127-139; v. anche Ferenczy 1984, 1053-1058. 24 Cfr. Deininger 1965, 118-119; Fishwick 1987, 302; Ardevan 1998, 328-341; Szabó Á. 1999 (2000), 119-150; si tratta dei consigli provinciali di ogni singola provincia anche in Haensch 1997. 25 V. Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 83-119. 26 Per una sintesi v. Alicu 1997. 27 Cfr. Găzdac – Cociş 2004, 34-60. 28 V. Piso 1972, 464-465; Ardevan 1998, 334; Szabó Á. 1999 (2000), 128 con la letteratura precedente. 29 Cfr. Deininger 1965, 21-24, 69-82, 99-107, 120-121. 30 Per una sintesi v. anche Carette 1895; inoltre cfr. anche Fishwick 1996, 87-100. 31 Cfr. in generale Kornemann 1901; Deininger 1965; Fishwick 1987-2004. 32 Cfr. Szabó Á. 1999 (2000), 129-130; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 83-119. 33 Cfr. Deininger 1965, 170-172. 34 V. Martin 1992, 84-106, i singoli tipi e anni con le varianti conosciute. 35 V. Alföldi 1931, 146. 36 V. Winkler 1971, 145-147, 149, 156-158. 37 V. Fitz 1978, 636. 38 V. Head 1879, 22-29. 39 V. Ardevan 1998, 336. 40 V. CIL III, 3485 = Szabó 2006, P 13. 41 Cfr. Szabó Á. 1999 (2000), 119-150; Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 83-119; cfr. anche Fishwick 1987, 326-335. 42 Cfr. Szabó Á. 2004 (ArchÉrt), 83-119. 43 Cfr. Tóth E. 2001, 8. 44 Cfr. Kornemann 1900, 801. 45 Cfr. Deininger 1965, 1186.
RIASSUNTO
SACERDOTI CONOSCIUTI Conosciamo 93 persone nella Dacia dal periodo tra il 106 e 271 d. C. le quali avevano una carica sacerdotale [D 1-92] e altri tre sacerdoti che sono menzionati dalle iscrizioni di autenticità o interpretazione incerta [D a-c], i quali sono menzionati solo nel catalogo, ma nel riassunto no. Molte delle persone conosciute rivestivano diverse cariche sacerdotali, e a volte in diverse città. Così il numero degli uffici sacerdotali conosciuti e spettanti ai singoli insediamenti è più grande del numero delle persone presentate: nelle tre Dacie è più di cento. La cronologia delle fonti nella Dacia risale, ovviamente, al periodo tra il 106 e 271 d. C., ma, secondo la situazione generale dei reperti epigrafici della Dacia, le iscrizioni rimaste sono del periodo tra l’epoca di Hadrianus e quella di Gallienus (117/137-253/268 d. C.), quindi di un intervallo di poco più di cento anni. Entro questo periodo la maggior parte delle fonti si data all’epoca dei Severi. L’origine delle singole persone sacerdotali corrisponde all’immagine generale della provincia: la maggior parte fu il discendente dei cittadini immigrati dalle province occidentali e venne da un ambiente di lingua latina. In questo gruppo è rilevante il numero delle persone con contatti con la Dalmatia e l’Italia settentrionale, che potevano essere i discendenti dei primi coloni. Nell’epoca dopo le guerre marcomanniche molte persone che avevano una carica sacerdotale erano venuti dalla parte greca dell’impero oppure erano i loro discendenti. Inoltre, parecchie persone di origine siriaco-palmirese occupavano un ufficio sacerdotale, soprattutto di carattere etnico, ma anche cariche della religione statale, secondo l’immagine etnica della provincia nell’epoca dei Severi. Il numero dei sacerdoti della parte greca e dell’ambiente orientale non oltrepassa il numero dei sacerdoti delle province occidentali. Tutti i sacerdoti conosciuti erano uomini. Per quanto riguarda il loro stato sociale, la maggior parte dei sacerdoti dacici apparteneva al ceto dirigente delle città, agli ordines decurionum, soprattutto i rappresentanti degli uffici della religione statale. Inoltre, si rappresentano in numero assai grande le persone solo con la cittadinanza romana e in numero minore i sacerdoti di stato giuridico peregrinus per i singoli culti orientali, fino al 212 d. C. Dopo la Constitutio Antoniniana si possono dimostrare differenze solo di carattere puro sociale tra i rappresentanti delle diverse cariche sacerdotali. Una parte delle persone con una carica sacerdotale che rappresentavano il ceto alto della società era in connesso familiare-commerciale tra di loro. Questo fenomeno è appariscente per lo più nel caso dei sommi sacerdoti della provincia. CARICHE SACERDOTALI Nel gruppo di province daciche appaiono antistites, augures, flamines, pontifices e i sacerdotes di diverse divinità, di diversi santuari. Inoltre è conosciuto anche un haruspex. ANTISTES: Nella Dacia sono conosciuti tre antistites [D 29, 40, 59]. La loro carica capita nei contesti amministrativi della religione e nei contesti dei santuari. Tutti erano uomini, che venivano dall’ambiente latino, e tutti avevano la cittadinanza romana. Quest’ultimo doveva essere la condizione fondamentale sociale della carica. Tutti e etre avevano la carica nella stessa città, nella colonia di Apulum, nella sede del luogotenente. In due casi il nome della carica si legge nell’iscrizione semplicemente in forma antistes [D 29, 40], di cui l’ultimo fu abbreviato in forma an(tistes). In uno dei casi, oltre al titolo, fu indicato anche il luogo in forma antistes huiusque loci o antistes huiusce loci [D 59]. Tutti e tre portavano la loro carica nella prima metà del III secolo d. C. Nessuna delle iscrizioni erette dai tre antistites di Apulum è dedicata ad una sola divinità, perciò nel caso di Apulum la competenza della carica non era ristretto al territorio del santuario di una sola divinità. Si può affermare, che si tratta di un ufficio con la competenza su una data area sacra. Quest’area sacra si può chiamare il Locus, in base al nome dell’iscrizione del D 59. Benché anche il motivo personale della dedicazione capiti spesso nelle iscrizioni, gli altri motivi di tono ufficiale rafforzano la teoria, che l’antistittum avesse un carattere ufficiale. Tramite gli antistites, conosciuti esclusivamente per le manifestazioni religiose, e tramite l’antistitium di una sola persona con un’altra carica sacerdotale [D 59], l’antistitium di Apulum sembra essere una funzione religiosa coloniale. Il rappresentante della carica non doveva essere il sacerdote di una certa divinità, ma era piuttosto un superiore religioso, che poteva essere anche sacerdote. Due degli antistites dedicarono un’iscrizione anche a Nemesis [D 40, 59], che vale anche ai due di tre antistites della Pannonia [P 60,62]. Per quanto riguarda lo stato sociale delle persone con questo ufficio, l’antistitium non era la carica più alta, ma aveva una grande responsabilità. I rappresentanti avevano la possibilità di entrare nell’ordo decurionum [D 29] o di ottenere un honor [D 59]. Il mondo delle divinità menzionate è assai eterogeneo, ma si può affermare, che l’area sacra diretta dagli antistites non aveva un carattere orientale, ma era piuttosto una forma religiosa di origine occidentale, con la presenza di divinità nuove e assunte. Non conosciamo nessun antistes emerito, e non abbiamo nessun dato di ciò, se uno di loro avesse deposto la carica già in vita, quindi non c’è niente contro l’affermazione, che la carica aveva un carattere a vita. AUGUR: Nella Dacia sono conosciute dieci persone, che furono anche augures [D 10, 16, 20, 23, 39, 43, 44, 47, 55, 67]. Due [D 10, 20] lo furono in due città, perciò il numero degli augures conosciuti è praticamente dodici. Tutte le persone conosciute erano uomini, e vennero da un ambiente latino. Occupavano l’ufficio di augur solo in città, in municipia e coloniae. In tutti i casi il titolo della carica è augur, nella maggior parte dei casi il titolo rinvia anche alla città con l’indicazione del rango dell’insediamento, in forma augur municipi oppure augur coloniae. Il nome della carica sacerdotale era scritto in generale senza abbreviazione, che può essere considerato come regola, l’unica eccezione apparente è la persona dell’iscrizione D 47, il cui titolo è diviso in due righe in forma aug|[ur] nell’iscrizione composta insolitamente. La cronologia delle iscrizioni degli augures conosciuti, quindi quella dei documenti della loro esistenza, dura dall’epoca di Commodus (180-192 d. C.) fino alla metà del III secolo d. C., e la maggior parte risale all’epoca dei Severi. Quattro degli augures conosciuti rivestirono l’auguratus in municipia [D 23, 39, 43, 44], sei invece in coloniae [D 10, 16, 20, 47, 55, 67], due di cui
in due diverse coloniae [D 10, 20]. Quindi conosciamo quattro augures municipali e otto coloniali. Conosciamo augures nelle città seguenti: municipium Septimium Apulensium [D 39] e municipium Septimium Porolissensium [D 23, 43, 44]; colonia Aurelia Apulensium [D 20, 47, 67], colonia Aurelia Napocensium [D10, 16] e colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa [D 10, 20, 55]. Tutto sommato conosciamo augures meno dalla metà delle città daciche. Nella provincia si possono sbozzare le condizioni della carica sacerdotale solo in grosso modo, e solo le condizioni sociali. Per quanto riguarda la professionalità necessaria, si può solo ipotizzare, che alle condizioni appartenessero le conoscenze delle prescrizioni delle cerimonie, del diritto della religione, e anche delle forme di circa tre mila segni nel gruppo di province. Secondo le poche iscrizioni rimaste, le condizioni sociali dell’auguratus municipale nella Dacia era – oltre alla cittadinanza romana – il decurionatus, uno stato equestre che era gerarchicamente più alto, o uno stato sociale più o meno equivalente a quest’ultimo. La condizione fondamentale dell’auguratus coloniale era similmente il decurionatus. Si può dedurre inoltre, che l’auguratus, sia municipale che coloniale, non aveva una posizione fissa all’interno del sistema del cursus honorum. In generale si può definire solo il decurionatus come una condizione fondamentale sociale dell’auguratus nella Dacia, e sembra che da questo punto di vista non c’è differenza tra gli augures dei municipia e quelli delle coloniae. Verosimilmente anche il decurionatus rivestito rispecchia piuttosto la pratica e non le prescrizioni delle leggi delle città. Gli auguratus multipli rinviano alla mancanza generale degli augures nella provincia, mentre le cariche sacerdotali occupate contemporaneamente dimostrano proprio la mancanza dei sacerdoti, quindi la mancanza delle persone adatte. Dei reperti epigrafici della Dacia solo uno può essere legato ad un auguratus, in base al posto di ritrovamento [D 16], il quale fu dedicato dal sacerdote in un luogo, dove il fulmine spesso colpiva. C’è un altro pezzo dedicato da un augur dacico a Silvanus [D 10], del quale si può ipotizzare che il sacerdote lo dedicò anche come augur, dato che Silvanus era una divinità profetica. Secondo i dati conosciuti l’auguratus era compatibile con il ponificatus, ed è molto verosimile che tra le due cariche non c’era una differenza di autorità, al massimo un rapporto gerarchico strutturale [vedi D 10, 23, 44]. Oltre al pontificatus, l’auguratus era compatibile anche con la carica del sommo sacerdote della provincia, che stava fuori il sistema dei sacerdoti municipali [D 20, 39]. Non conosciamo nessun augur nella Dacia con un sacerdotium piccolo, un flaminatus o altra carica sacerdotale nella stessa o in un’altra città. Nessuno dei pochi dati rimasti rinvia direttamente a ciò, che una città dacica avesse avuto più di un augur. Il materiale epigrafico non permette conclusioni larghe. Sono conosciuti augures in numero relativamente grande solo a Porolissum. Loro rivestivano la carica nel municipium uno dopo l’altro [D 23, 43, 44], due di loro erano parenti, probabilmente padre e figlio [D 43, 44]. La datazione larga di alcune iscrizioni della stessa città si coincidono in parte, concretamente nel caso di Apulum e Sarmizegetusa, perciò, considerando anche il carattere a vita della carica, possiamo presupporre più di uno, ma al massimo due augures contemporanei nella stessa città, più precisamente nelle grandi colonie. Non conosciamo il limite inferiore d’età per l’auguratus nella Dacia. Per quanto riguarda il tempo ufficiale, non conosciamo augures emeriti nella provincia. È conosciuto il testo del monumento sepolcrale di uno di loro, il quale non fa pensare, che egli non fu augur fino alla morte [D 44]. Per questo in base ai dati a disposizione, possiamo ritenere l’auguratus come una carica sacerdotale a vita anche nella Dacia, quindi la situazione dacica corrisponde a quella descritta dalla lex Ursonensis [cfr. ADDENDUM 1.]. FLAMEN: Conosciamo trentatre flamines nella Dacia, di cui trenta erano flamines di città, e portavano la loro carica proprio nella città, mentre gli altri tre erano i flamines del culto locale di dimensione e importanza imperiale in una città italica. Due dei flamines di città rivestivano la carica in due insediamenti, perciò il numero dei flamines locali conosciuti nelle città è trentuno. La parte decisiva veniva da un ambiente latino, ma, in base ai nomi, alcuni erano sicuramente orientali. Tutti erano cittadini romani. Nelle iscrizioni si leggono due diversi tipi della carica di flamen. Uno è il flaminatus nelle città della provincia, l’altro è la carica fuori la provincia. Questi ultimi non contano tra i sacerdoti dacici, sono però menzionati, perché vivevano come persone sacerdotali nella Dacia. Nelle città della provincia solo la propria carica sacerdotale della città fu indicata a volte nella semplice forma flamen, perché era chiaro a tutti [D 22, 38, 50, 52, 58, 74], dove apparteneva il sacerdote, senza l’indicazione del luogo e del soggetto. È frequente, che l’indicazione municipi o coloniae si trova dopo più cariche elencate, la quale però riferisce a tutte le singole cariche, così anche al flaminatus [D 4, 6c, 13, 15c, 66, 72]. A volte fu abbreviata in forma fl(amen) [D 14, 75a, 86] o flam(en) [D 75b, 76]. La forma ufficiale del titolo sacerdotale era flamen municipi o flamen coloniae [D 5f, 14, 18, 36, 41, 42, 53, 60, 70, 71, 73, 93], eventualmente seguito dal nome dell’insediamento. In base a questo, anche la semplice forma flamen – soprattutto se la data persona rivestiva anche altre cariche nella città – indica sacerdoti con il titolo flamen municipi oppure flamen coloniae. L’altro flaminatus rintracciabile nella Dacia è la carica sacerdotale di una città italica, riservata agli equites. Le iscrizioni contengono il titolo sacerdotale in varie forme, forse perché nella provincia lontana non si conosceva sempre il preciso titolo ufficiale. Perciò si legge la seguente forma nelle iscrizioni: flamen lucularis Laurent(ium) Lavina[t(ium)] – prendendo in considerazione, che questa forma si trova in un’iscrizione italica di Fulginae, non lontano dal luogo del culto, la si ritiene la forma ufficiale. [D 8a]. Lo stesso ad Apulum si legge nell’iscrizione eretta dai magistrati locali come segue [D 8b]: sacer(dos) Lauren[t(ium) Lavi]nat(ium). Un eques dacico [D 70] fece scrivere il titolo sacerdotale nella stessa forma a Sarmizegetusa: sacerd(os) Laurentium Lavinat(ium). Nel suo caso è molto probabile, che fosse l’esempio apulense che influenzava la semplificazione del titolo della carica, dato che l’espressione sacerdos era adatto ad esprimere qualsiasi carica sacerdotale. La terza forma conosciuta della carica è il flam(en) Laurentinus [D 76]. L’esistenza di due persone sicuramente con il titolo di flamen e il fatto che il titolo di uno di loro venne scritto sacerdos secondo l’uso locale, dimostrano, che anche il D 70 era veramente un flamen. Per quanto riguarda la cronologia, nella Dacia conosciamo flamines quasi dalla fondazione, cioé abbiamo dati sulla carica già nel primo terzo del II secolo, i quali possono essere contemporanei con la città stessa. La cronologia delle fonti sulla carica sacerdotale dura fino alla metà del III secolo d. C., secondo la situazione generale delle iscrizioni e delle fonti nella Dacia. Oltre ai sacerdotes, abbiamo le più numerose iscrizioni sui flamines, anzi, se separiamo i singoli sacerdotia, il flaminatus è la carica più documentata della provincia. Conosciamo dieci flamines municipali e ventuno coloniali. Abbiamo fonti sui
flamines nelle seguenti città: Apulum - colonia Aurelia [D 5, 6, 8, 22, 41, 66, 75] e municipium Septimium [D 36, 42, 72], Dierna [D 53], Drobeta [D 4, 53, 58], Napoca [D 15, 18, 89], Porolissum [D 13], Potaissa [D 73], Sarmizegetusa [D 14, 38, 50, 52, 70, 71, 74, 75, 76, 82, 88], Tibiscum [D 60], quindi dalla maggior parte delle città daciche. Dobbiamo sottolineare Sarmizegetusa, dove conosciamo nove flamines nel II secolo d. C. Conosciamo uffici di flamines solo in connessione con le città, cioé il flaminatus fu una carica sacerdotale espressamente urbana. Alcuni flamines rivestivano più cariche, e c’erano tra di loro parecchie persone di alto rango. Si può affermare lo stesso anche sulle iscrizioni erette per ragioni private, qundi neanche queste sono in rapporto con l’ufficio del flamen. Anche i posti delle iscrizioni su di loro sono molto svariati. Nessuna è rinvenuta al posto originale, ma le basi erette dalla comunità stavano sicuramente in area pubblica, le iscrizioni di costruzione sugli edifici menzionati, le epigrafi sepolcrali nelle necropoli, nei cimiteri. Nessuna delle dedicazioni è collegabile ai compiti del flamen nel culto imperiale. È conosciuta una sola iscrizione, la cui dedicazione è per Iuppiter Optimus Maximus, per gli dei e le dee, e il dedicatore indicò solo il suo flaminatus, e non scrisse, se l’epigrafe fosse un voto [D 41]. Perciò verosimilmente questa è l’unica iscrizione eretta dal sacerdote come flamen, il che, però, non mostra nessun rapporto diretto con l’attività di flamen e con il culto imperiale. Dunque l’attività di flamen non è rintracciabile tramite le iscrizioni. In opposizione, si conoscono tre iscrizioni che riferiscono una donazione fatta per il flaminatus ricevuto. Il D 38 ob honorem flamonii et HS LXXX nummum ad annonam dedit; il D 50 ob honorem flamonii B(---?) p(ublico?) dedit; il D 58 ob honorem flamoni cryptam vetustate dilapsam pecunia sua reformavit et exaltiavit. Da questi tre esempi in tre diverse città si può trarre la conclusione, che alla carica del flamen conocorrevano più persone contemporaneamente, perciò lo stato sociale non bastava, se qualcuno voleva divenire flamen, era ragionevole fare qualcosa anche per il bene pubblico. Questo fenomeno dimostra senza dubbio l’importanza del flaminatus nella vita della città e della data persona, e nella sua carriera, e rinvia anche alla situazione concorrenziale in questo periodo. Inoltre sembra, che la grandezza e il carattere del dono non fossero determinati, probabilmente il luogo e la situazione influivano la somma e la donazione dedicate dalla persona per la sua elezione alla posizione sacerdotale. L’attività dei flamines svolgeva sicuramente sotto il controllo dei pontifices anche nelle province, e anche loro erano i membri del collegium pontificum, come nella città di Roma. Siccome non esiste una fonte dacica, che documentasse l’attività dei flamines, si può affermare in generale anche sulla Dacia, che l’attività dei flamines era in connessione con il santuario locale del culto imperiale nella città (di cui non sappiamo niente) e con i giorni festivi. L’attività dei flamines svolgeva sicuramente sotto il controllo dei pontifices anche nelle città daciche. Le condizioni fondamentali del flaminatus nelle città daciche erano la cittadinanza romana e l’ottimo stato finanziario. Ovviamente in qualche luogo, dove anche la struttura sociale era così, anche i concorrenti al flaminatus venivano dai ceti alti della società. Nella Dacia si può identificare un solo flamen, che si ritirò verosimilmente dal flaminatus [D 75], ma mantenne la carica di flamen occupata in un’altra città. Il ritirarsi dal flaminatus nella prima città poteva avere motivi personali, oppure eventualmente amministrativi. Per quanto riguarda gli altri, non rinvia niente alla durata limitata della carica. Quindi è molto probabile, che nella Dacia la carica del flamen durasse a vita, in contrasto con alcuni flaminatus annuali nelle province africane. In base al paragone africano non si possono dedurre nessune conseguenze essenziali sulla Dacia. Secondo un dato, l’inizio della carica non era in connessione nemmeno con l’età maggiore [D 58]. Non si può nemmeno stimare il numero totale dei flamines dacici, non solo per la mancanza delle fonti, ma anche per il suo carattere a vita. Non si può dire neanche il loro numero nelle singole città, ma sembra, che un municipium avesse solo un flamen nello stesso tempo, mentre le colonie ne avessero probabilmente due, questo però è dimostrabile con dati solo nel caso di Sarmizegetusa, e si può ipotizzare nel caso di Apulum. I flamines dacici non avevano altre cariche sacerdotali nello stesso luogo e nella stessa struttura giuridica e municipale, e in generale neanche in altri luoghi con l’eccezione di una parte irrelevante. Conosciamo un solo caso, dove un flamen di Porolissum indicò anche un sacerdotium [D 13], ma questo sacerdotium non appartiene alla stessa città e al mondo tradizionale della religione romana. Nella sua città fu solo flamen. Due flamines divennero sommi sacerdoti della provincia [D 5, 15], ma, da un lato, questa carica è fuori la struttura municipale, dall’altro il suo carattere è identico a quello del flaminatus per quanto riguarda il culto imperiale. Altri due furono flamines Laurentes Lavinates [D 71, 76], ma il flaminatus in un’altra città non era in nessuna contraddizione con quello già esistente [cfr. D 53, 75], e non poteva essere incompatibile con il flaminatus in un’altra città oppure fuori la provincia. Sono conosciute tre persone nella Dacia, con una delle cariche sacerdotali equestri di Laurentes Lavinates, sia nel II che nel III secolo d. C. In questa qualità probabilmente non contano tra i sacerdoti della Dacia, ricevettero quest’onore dall’imperatore, dopo il servizio militare [D 76. 8]. Due di loro avevano un flaminatus anche nella provincia [D 76, 70]. Nel terzo caso l’iscrizione frammentaria non rende possibile la ricostruzione degli elementi della carriera [D 70]. Non si può dire, come potevano partecipare alla vita religiosa della città italica, o alle feste latine, se abitavano nella Dacia. La ricerca non si è occupata finora della questione, se esistesse una connessione tra l’apparizione della carica del flamen Laurens Lavinas e l’esistenza delle città daciche con il ius Italicum, dato che teoricamente queste città potevano partecipare al culto della memoria dell’alleanza tra le città antiche latine nell’Italia, Così la carica esiste nella provincia con ragione e non per caso, in contrasto con la Pannonia, dove non ci sono dati né su questa carica sacerdotale, né sull’ius Italicum. HARUSPEX: Conosciamo un solo haruspex nella Dacia, il quale occupò la sua carica ad Apulum [D 59], nella prima metà del III secolo d. C. Venne da un ambiente latino e fu cittadino romano. Secondo il titolo usato nelle sue iscrizioni fu un haruspex col(oniae), quindi una persona sacerdotale in carica ufficiale, impiegata dalla città. Benché egli sia conosciuto tramite varie iscrizioni, non fece erigere nessuna di esse come haruspex. Abbiamo visto, che già la lex Ursonensis [cfr. ADDENDUM 1.] disponeva sugli haruspices e il loro mantenimento, ciononostante ci sono rimaste poche memorie su di loro nelle città provinciali, e anche nell’area media e inferiore danubiana, dal Mar Nero fino al Noricum si conosce solo questo l’unico haruspex nella Dacia. Né l’impiego ricevuto dalla città, né le disposizioni di Claudius potevano fermare la diminuzione degli haruspices, perciò Severus Alexander (222-235 d. C.) dovette disporre sul mantenimento statale dei cultori della disciplina etrusca. Per questo è molto probabile, che neanche l’haruspex dacico ricevette la sua carica ad Apulum prima dell’epoca di Severus Alexander. Come haruspex dovette avere ruolo sicuramente ai sacrifici comunali di Apulum, più
precisamente allo studio degli organi interi. L’haruspicina, in base all’unico esempio conosciuto, era compatibile con il sacerdotium, per quanto riguarda i sacerdoti, e anche con le altre attività amministrative e professionali. PONTIFEX: Conosciamo sedici pontifices nella Dacia, durante l’esistenza di 165 anni della provincia. Tutti erano cittadini romani. In generale i pontifices erano persone con magistratura, ma c’è anche uno, che indicò solo il suo pontificatus. La maggior parte venne da un ambiente latino, ma sono conosciuti pontifices nella provincia che vennero dall’ambiente greco [D 57] e orientale [D 12], mentre uno ebbe una madre di origine orientale [D 23]. Abbiamo poche fonti per trarre conseguenze larghe di valore generale. I pontifices conosciuti erano tutti cittadini romani, e occupavano il loro ufficio in una città. Tutti venivano da un ambiente latino, rivestivano anche una magistratura e facevano il servizio militare, benché alcuni ne fossero esenti per il padre sacerdotale. Abbiamo poche fonti per le conseguenze larghe, ma alcune caratteristiche possono esser accennate. Il titolo è in ogni caso pontifex, non sempre in questa forma intera, ma in forma più precisa pontifex municipi (in un caso su un epitafio civitatis, rinviando al municipium) o pontifex coloniae. Il titolo non era indicato sempre in questa forma intera, ma abbreviato nelle forme pont(ifex) [D 10, 84] e pontif(ex) [D 12, 23, 25, 46, 54, 56, 57]. In ogni città è presupposta la fondazione della carica pontificale sin dalla fondazione della città. Secondo le iscrizioni, la cronologia determinabile dei pontifices conosciuti dura, senza una precisazione possibile, circa dalla metà del II secolo fino alla metà del III secolo d. C. La maggior parte è conosciuta dall’epoca dei Severi. Tutti rivestivano la carica in una città, legata all’insediamento. Cinque furono pontifices municipali [D 12, 23, 24, 44, 84], undici pontifices coloniali [D 2, 3, 7, 10, 11, 25, 45, 46, 54, 56, 57]. Nessuno ebbe due pontificatus contemporanei in due diversi posti, in contrasto agli augures. Conosciamo pontifices nelle seguenti città: Apulum – colonia Aurelia [D 2, 3, 7, 10, 11, 57], Drobeta – municipium [D 24], Napoca – colonia [D 54], Porolissum [D 23, 44, 84], Tibiscum [D 12], Sarmizegetusa [D 25, 45, 46, 56], quindi dalla metà delle città daciche. La sede della carica doveva essere un edificio all’interno della città, adatto a questo scopo, ma finora non è stata identificata una tale costruzione. Nella Dacia non si può identificare nessuna iscrizione eretta dai rappresentanti della carica come pontifices. La maggior parte è un’iscrizione votiva di carattere privato o sepolcrale, oppure la base di una statua ricevuta dai magistratus, che erano anche pontifices. Non si può analizzare nessuna delle iscrizioni dal punto di vista dell’attività sacerdotale. Sicuramente offrivano i sacrifici regolarmente alle determinate occasioni, ma su questi non nacquero iscrizioni, sarebbe proprio strano tenendo in considerazione l’usanza e i motivi della dedicazione. Nella Dacia il pontificatus non aveva un posto fisso nel cursus municipale, il che rinvia di nuovo a ciò, che il pontifex seguente poteva cominciare a lavorare solo dopo che il posto divenne libero. Sembra che bastasse la cittadinanza romana come condizione fondamentale sociale per il pontificatus, ma il decurionatus oppure la magistratura potessero essere un vantaggio. A quest’ultimo rinviano il decurionatus e le magistrature di tre sui cinque pontifices municipali conosciuti. Ovviamente si dovette possedere una solida base finanziaria, ma non ci sono rimaste tracce delle donazioni fatte per il pontificatus nei municipia. Ne si conosce solo una, in una delle colonie [D 56]. Anche nelle colonie la condizione sociale del pontificatus era in generale la cittadinanza romana, ma a causa della composizione degli abitanti c’erano più persone di rango alto con il pontificatus rispetto ai muncipia. Sette su undici pontifices, quindi la maggioranza, fu il membro anche dell’ordine equestre. Questo fenomeno rinvia al rango più alto dell’ufficio pontificale. Un’iscrizione di Sarmizegetusa tramanda una donazione per il pontificatus, cioé una costruzione [D 56]. Probabilmente era necessario anche il contributo finanziario per esser eletti, ma nella maggior parte dei casi non ce ne sono rimaste tracce. Quattro su sedici pontifices rivestirono anche altre cariche sacerdotali nella stessa città [D 10, 23. 44. 57], mentre uno fu sommo sacerdote, fuori il sistema municipale [D 46]. Tre delle quattro persone con altre cariche sacerdotali furono non solo pontifices, ma anche augures [D 10, 23, 44], uno di loro augurava in due diverse città [D 10]. Oltre l’auguratus i pontifices potevano rivestire, secondo l’esempio di uno di loro, anche il sacerdotium: nel caso conosciuto il pontifex fu il sacerdos di Aesculapius prima del pontificatus [D 57]. Il pontificatus insieme all’auguratus è in armonia con la lex Ursonensis dell’epoca di Tiberius e Claudius [cfr. ADDENDUM 1.], il cui autore trattò insieme le due cariche sacerdotali con doveri e privilegi identici. Solo il sacerdotium di Aesculapius dopo le guerre marcomanniche sembra strano, ma il culto di Aesculapius fu integrato a Roma già nell’epoca repubblicana, perciò una carica sacerdotale per la coordinazione della religione non sembra essere in contraddizione con un sacerdotium ufficiale di interesse pubblico, soprattutto se teniamo in considerazione, che il domare dell’epidemia di peste durante le guerre marcomanniche fu un compito non solo medico, ma anche amministrativo, e fu accompagnato dalla fondazione dei Asklepieiones. La carica sacerdotale per Aesculapius desiderava professionalità, il sacerdote fu praticamente un medico. Il fenomeno unico dell’insieme del pontificatus e del sacerdotium dimostra che un caso simile non era molto frequente. Sono conosciuti pochissimi sacerdoti di Aesculapius, egli è un fenomeno raro anche da questo aspetto. Le due persone conosciute rivestirono nella città anche magistrature alte e furono i membri dell’ordine equestre [D 57, 68]. Una città sembra avere contemporaneamente un solo pontifex, eccezioni possono essere la colonia Aurelia Apulensium e Sarmizegetusa, ma non si conosce un’iscrizione con due pontifices contemporanei in nessuno di questi posti. Il solo pontifex non poteva formare un collegium (magari insieme al flamen), ma rappresentava il collegium dei pontifices. Naturalmente nel futuro gli scavi possono portare alla luce una fonte, che documenta due pontifices contemporanei nella stessa città. Secondo la lex Ursonensis [ADDENDUM 1], che è la base della comparazione, potevano essere almeno in tre, ma non è sicuro, che nelle città daciche vivessero tante persone, che si potevano permettere i debiti del pontificatus. In base alle fonti esistenti sembra che nelle altre città non ci fossero molte persone adatte a questa carica. Si suppone, che nei municipia esistesse veramente un solo ufficio pontificale. La carica poteva essere occupata già da molto giovane, ad esempio il D 45 divenne pontifex prima della carriera militare equestre. In base a questo si può affermare, che sebbene la carica sacerdotale rendesse i figli dei sacerdoti esenti dal servizio militare, molti non ne approfittavano, se la loro carriera dipendeva dal servizio imperiale-militare. Non conosciamo pontifices emeriti nella provincia, la carica poteva durare a vita, sia a Roma, che nelle città di un’altra provincia occidentale. SACERDOS: Conosciamo trentacinque sacerdotes nella Dacia, tre occuparono il sacerdotium in due luoghi, così il numero degli uffici occupati conosciuti è trentotto. È il gruppo sacerdotale più composto dal punto di vista, che erano i sacerdoti di diverse correnti religiose. L’unico rapporto tra i diversi sacerdotia è praticamente la definizione latino-romana del loro stato
sacerdotale, tramite cui si integravano nel sistema della vita religiosa del mondo romano. Erono tutti uomini, la maggior parte era cittadino romano. Vennero dall’ambiente latino o greco, la maggior parte dall’ambiente greco, secondo il carattere del sacerdotium. In base alle fonti rimaste non si può decidere il carattere ufficiale o inufficiale del sacerdotium. Oltre che la forma del titolo scritto in latino doveva avere una concreta ragione, anche se c’erano denominazioni delle cariche per uso interno nel grembio della data religione, si può solo affermare, che quelli, che indicavano la loro appartenenza ad una città oppure ad un’entità giuridica (per esempio ad una truppa) avevano un sacerdotium senza dubbio ufficiale. Dall’altra parte, se si può localizzare il luogo del santuario, in cui praticavano la carica, e se questo santuario stava su un’area pubblica, il sacerdotium è considerato similmente ufficiale; similmente se si tratta di un sacerdotium rivestito nell’ambito di una società – collegium – ufficiale. Per il numero alto dei sacerdotes che sembrano essere impiegati ufficialmente, si ipotizza, che tutti i sacerdoti con il titolo sacerdos rivestissero la carica con condizioni ufficiali, cioé non nella religione privata. Quest’ipotesi è sostenuta dal fatto, che esistevano relativamente molte espressioni per indicare le persone in servizio di una religione, con un’attività che stava più vicino alla religione privata oppure ci apparteneva totalmente. In contrasto ai sacerdotes, ci sono rimaste pochissime tracce epigrafiche del loro nome e titolo usato nel culto. La persona con il titolo sacerdos poteva essere un sacerdos coloniae o (municipi), eventualmente il suo sacerdotium era presso una truppa, ma piuttosto in senso locativo. Il sacerdotium non può essere studiato nel cursus honorum municipale, perché era fuori questo sistema. Ciononostante molte persone con l’ufficio di sacerdos prendeva parte alla direzione delle città, che dimostra l’importanza locale dei singoli sacerdotia. Il decurionatus dopo il sacerdotium nella stessa carriera rinvia a ciò, che i singoli sacerdotia nelle città aiutavano l’ascesa sociale. L’ufficio dei sacerdotes sembra una carica a vita nella Dacia, tranne quella dei sacerdotes coloniae. La lex de flamonio provinciae Narbonensis [v. ADDENDUM 2.] disponeva, che il flamen di una città poteva sostiuire il sommo sacerdote della provincia con il titolo di flamen nel caso di impedimento, o nel caso di un’assenza lunga può prendere il suo posto nel resto dell’anno. Nella Dacia il titolo sacerdotale dei sommo sacerdoti era il sacerdos, il che, alla luce della legge di Narbo, accresce notevolmente l’importanza dell’ufficio del sacerdos coloniae. Nella Dacia non sono conosciuti sacerdotes emeriti, sembra che la carica sacerdotale durasse a vita nelle città della provincia. L’unico sacerdotalis coloniae [D 19] è un’eccezione nella provincia, quindi significa un caso particolare, ma lui è conosciuto tramite la sua epigrafe sepolcrale, quindi il suo sacerdotium è finito per la morte. Nella Dacia i sacerdotes Iovis Dolicheni sembrano i sacerdoti più attivi, nelle diverse forme religiose loro sono conosciuti nel numero più grande. La presenza dei singoli sacerdotia sembra essere in rapporto strettissimo con la composizione etnica della società della provincia. Nella Dacia agivano anche sacerdotes di origine palmirese [D 9, 13] nel servizio di Deus Hierobulos (Yarhibol), o di altre divinità palmiresi. I SACERDOTI DEGLI INSEDIAMENTI Conosciamo sacerdoti in dieci città daciche, solo in una o due no. Confrontando i municipia con le coloniae è appariscente, che il numero dei sacerdoti dei muncipia è più piccolo. Questo è in parte normale, dato che si tratta di insediamenti di dimensioni piccole e con vita breve, di cui una parte divenne presto colonia, l’altra parte fu fondata troppo tardi rispetto all’abbondamento della provincia. Ma nemmeno la situazione epigrafica può spiegare il fatto, il quale sembra una regola generale, che nei municipia c’era un solo rappresentante ufficiale delle cariche sacerdotali della religione statale nello stesso tempo. Quest’affermazione però è ovviamente ipotetica, siccome si conosce un solo sacerdote nella gran parte dei muncipia, e loro sono soprattutto flamines. Il fenomeno si può dimostrare chiaramente solo a Porolissum. Tutti i rappresentanti conosciuti degli uffici di sacerdotes nei municipia erano i sacerdoti di Iuppiter Dolichenus, quindi la carica dei sacerdotes municipi manca totalmente. In contrasto ai muncipia, nelle coloniae c’erano in ufficio almeno due sacerdoti contemporanei del sistema della religione statale, degli augures, dei flamines e dei pontifices, come si può affermare nel caso di Sarmizagetusa e Apulum, ricche di materiale epigrafico. Possibilmente un sistema simile vigeva anche nelle altre colonie, ma in base alle poche fonti non lo si può affermare chiaramente. In contrasto ai municipia appaiono più sacerdotia nelle colonie: oltre ai sacerdotes delle divinità orientali e greche ci agivano anche sacerdotes coloniae, in numero piccolo. Inoltre, ad Apulum capita anche la carica dell’antistes e dell’haruspex coloniae. Nel caso della Dacia sembra caratteristico il fenomeno delle cariche sacerdotali rivestite in diverse città, che è appariscente soprattutto nel caso degli augures, ma troviamo anche flaminatus multipli, per lo più doppi. Per quanto rigurada gli augures, c’è esempio per l’auguratus di tre volte, che rinvia senza dubbio alla mancanza degli augures nella provincia. Ovviamente non c’erano molti augures qualificati con uno stato adeguato sociale. Le singole città potevano risolvere il problema della mancanza con l’elezione di una persona in carica in un’altra città. Perciò non è da escludere, che nei piccoli insediamenti, come per esempio a Tibiscum, non c’era affatto augur. Quindi le cariche multiple sacerdotali dimostrano il numero piccolo delle persone adatte agli uffici sacerdotali, e non sempre rinviano alla voglia di accumulare i titoli e i ranghi. Lo stesso fenomeno è dimostrato anche dalla carica complessa di augur-pontifex a Porolissum, che ritornava ogni tanto. Inoltre, ci rinvia anche il fatto, che non conosciamo nessun sacerdote emerito nella provincia, quindi tutte le cariche sacerdotali duravano a vita che è appariscente soprattutto nel confronto con la sitauzione nella Pannonia.1 È notevole anche il numero dei sacerdotes delle truppe militari. Erano regolari le cariche sacerdotali per le divinità orientali, senza eccezioni, soprattutto per Iuppiter Dolichenus, ma anche per le divinità palmiresi presso le truppe. La pratica deriva da un lato dall’esistenza delle truppe organizzate in base etnica, dall’altro vivevano molte persone di origine orientale nella provincia, che facevano il servizio militare non solo nelle truppe ausiliari, ma venivano reclutati anche nelle legiones, e le quali continuavano a coltivare la divinità di patria anche qui, quindi avevano bisogno dei sacerdoti. I fenomeni però non rappresentano un esempio di massa e variabilità, perciò non sono adatti a dedurre conseguenze generali. I CONSIGLI PROVINCIALI E I SOMMI SACERDOTI CONSIGLIO PROVINCIALE: L’organizzazione del consiglio provinciale della Dacia accadde con ogni probabilità direttamente dopo la fondazione della provincia. La sua sede fu la prima città della Dacia, la colonia Ulpia Traiana
Sarmizegetusa. Il forum provinciae e l’Ara Augusti, circondati da un portico di 66 x 66 m, si trovava entro il territorio dell’Area sacra fuori le mura, accanto alla città, verso Nord, vicino all’anfiteatro. Del primo periodo non abbiamo nessuna fonte epigrafica. Ma l’anfiteatro, ricostruito in pietra nel 158 d. C., aveva anche un periodo precedente in legno, che dimostra, che c’erano stati giochi a Sarmizegetusa anche precedentemente. Inoltre, anche le monete ritrovate nel territorio dell’Area sacra provano l’uso continuo del territorio sin dalla fondazione. Finché ci fosse una sola città nella provincia, il consiglio provinciale non poté oltrepassare i limiti di essa, e nella Dacia non c’erano civitates. Nell’epoca di Hadrianus esistevano già più di una città nella provincia, che potevano formare un consiglio provinciale regolare, anche se non molto numeroso. Sotto Marcus Aurelius una nuova città poté mandare i suoi legati nel consiglio provinciale, il quale si indicò come provincia nell’epoca. Nel III secolo d. C., dall’epoca di Severus Alexander (222-235 d. C.), l’istituto si presenta con un nome diverso – concilium provinciarum Daciarum III –, esprimendo così la sua competenza in tutte e tre sottoprovince della Dacia di struttura speciale. Il nome preciso e fedele esprimeva la pratica esistente, cioé che l’istituto con la sede a Sarmizegetusa rappresentava tutte e tre Dacie. Allo stesso tempo, con queste iscrizioni il consiglio provinciale usa nel III sec. d. C. un nome praticamente classico, che esprime l’essenza dei consigli provinciali, similmente ai quelli delle province occidentali – sopratutto nelle Tres Galliae – e ai consigli delle province orientali di lunga tradizione. Verosimilmente questo nuovo nome segnala un consiglio provinciale riorganizzato. Il consiglio provinciale fece coniare monete per undici anni con la leggenda Provincia Dacia dall’epoca di Philippus Arabs (244-249 d. C.) fino a Gallienus (253-268 d. C.). SOMMI SACERDOTI: La carica del sommo sacerdote significava l’apice di una carriera nella provincia. Conosciamo otto sommi sacerdoti della Dacia [D 5, 15, 20, 27, 39, 46, 83, 85], quindi circa il cinque percento delle 165 persone in caso ottimale, contando con 165 anni tra la conquista e l’evacuazione della provincia, e prendendo in considerazione anche il fatto, che erano sicuramente non in 165. In pratica ne potevano essere meno, perché poteva passare un certo tempo fino all’organizzazione della provincia e fino all’elezione del primo sommo sacerdote, e anche le circostanze degli anni direttamente precedenti all’evacuazione della provincia sono sconosciute. Inoltre, una persona poteva essere più volte sommo sacerdote. Non c’è un’iscrizione eretta da un sommo sacerdote prima dell’epoca dei Severi, mentre l’ultima fu dedicata sotto il regno di Gordianus III. Conosciamo sommi sacerdoti da un periodo di meno di cinquant’anni, che, ovviamente, non significa, che non ce n’erano affatto, questo numero illustra solo la situazione generale epigrafica. In generale venivano da un ambiente linguistico latino, la maggior parte era il membro dell’ordine equestre. Per quanto riguarda la loro origine, vennero da Apulum [D 5, 27, 39], da Napoca [D 15], da Potaissa [D 85] e da Sarmizegetusa [D 20,40], e di uno non si sa da quale città [D 83]. In base alle fonti sui pochi sommi sacerdoti conosciuti, rispetto al loro numero possibile, si possono dedurre solo alcune conseguenze molto generali su di loro. L’esistenza di un sommo sacerdote rinvia in generale alla funzione del consiglio provinciale e viceversa. La cronologia delle fonti sui sommi sacerdoti in testa al consiglio provinciale risale alla fine del II secolo d. C. Sembra che fino all’inizio del III secolo d. C. il titolo ufficiale dei sommi sacerdoti fosse sacerdos provinciae [D 83] o sacerdos Daciae di valore uguale [D 85]. Il titolo del sommo sacerdote armonizza con il nome provincia del consiglio provinciale del II secolo d. C. Dall’inizio del III secolo d. C. fino al regno del Severus Alexander (222-235 d. C.) i sommi sacerdoti portavano il titolo sacerdos Arae Augusti [D 5, 20, 46]. Il nostro primo dato sul nome concilium provinciarum Daciarum III del consiglio provinciale risale all’epoca di Severus Alexander [2a]. Del titolo del sommo sacerdote nell’iscrizione [D 39] è indicata solo la parola sacerdos, così non sappiamo, quale titolo portasse lui. Poteva essere sacerdos Arae Augusti oppure già sacerdos Arae Augusti nostri, coronatus Daciarum III. Quest’ultima possibilità deriva dal fatto, che i sommi sacerdoti successivi portavano ormai un titolo più lungo, in cui veniva integrato anche il loro stato come i capi del consiglio provinciale (similmente alla pratica nelle province orientali) e anche uno dei simboli dell’onore: sacerdos Arae Augusti nostri, coronatus Daciarum III [D 15, 27]. L’ultima parte del titolo corrisponde al nome contemporaneo del consiglio provinciale, che si riferisce similmente alle tre province. La maggior parte dei sommi sacerdoti conosciuti era di Sarmizegetusa [D 20, 46] e di Apulum [D 5, 27, 39], ma la provincia aveva sommi sacerdoti anche di Potaissa [D 85] e di Napoca [D 15]. È sorprendente che non si conosce nessun sommo sacerdote delle città della Dacia Inferior-Malvensis. Questo può essere spiegato solo con la mancanza delle fonti. Sei su otto sommi sacerdoti erano sicuramente i membri dell’ordine equestre [D 5, 15, 20, 27, 39, 46], uno verosimilmente [D 85], mentre dell’ultimo non si sa [D 83]. Con una sola eccezione, le cui cariche furono indicate intenzionalmente selezionate, tutti rivestivano le magistrature in più insediamenti oppure erano decuriones in più città. Indipendentemente dal posto di ritrovamento delle iscrizioni, il luogo della carica corrispondeva ovviamente alla sede del consiglio provinciale. Così la sede dell’ufficio del sommo sacerdote era nella colonia di Ulpia Traiana Sarmizegetusa, nel territorio della città, ma fuori le mura, verso Nord, nel territorio del forum provinciae nell’Area sacra, costruita accanto all’anfiteatro. L’aspirante dell’onore del sommo sacerdote doveva essere il membro dell’ordine equestre, e veramente omnibus honoribus functus. Inoltre, poteva essere un vantaggio, se aveva avuto uffici, onori in più città, ma almeno era stato il membro dell’ordo decurionum. Tra questi ultimi avevano importanza rilevante gli ordines decurionum di Sarmizegetusa e di Apulum. Inoltre contava una buona condizione economica, che si basava sull’industria o sul commercio, e il patrocinio delle organizzazioni civili. Il candidato veniva eletto al summus honor sicuramente per un anno anche nella Dacia, come nelle altre province dell’Impero Romano.2 Niente rinvia a ciò, che si fosse deviato dalla pratica generale in tutto l’impero. Alla fine dobbiamo affermare un’ultima caratteristica: benché nella provincia ci siano tracce del culto di diverse divinità femminili, non è menzionata nessuna sacerdotessa nelle fonti epigrafiche.
1 Cfr. Szabó 2006. 2 Cfr. Kornemann 1901; Deninger 1965; Fishwick 2004.
![Page 1: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/65.jpg)
![Page 66: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/66.jpg)
![Page 67: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/67.jpg)
![Page 68: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/68.jpg)
![Page 69: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/70.jpg)
![Page 71: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/71.jpg)
![Page 72: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/72.jpg)
![Page 73: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/73.jpg)
![Page 74: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/74.jpg)
![Page 75: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/75.jpg)
![Page 76: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/76.jpg)
![Page 77: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/77.jpg)
![Page 78: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/78.jpg)
![Page 79: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/79.jpg)
![Page 80: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/80.jpg)
![Page 81: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/81.jpg)
![Page 82: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/82.jpg)
![Page 83: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/83.jpg)
![Page 84: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/84.jpg)
![Page 85: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/85.jpg)
![Page 86: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/86.jpg)
![Page 87: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/87.jpg)
![Page 88: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/88.jpg)
![Page 89: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/89.jpg)
![Page 90: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/90.jpg)
![Page 91: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/91.jpg)
![Page 92: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/92.jpg)
![Page 93: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/93.jpg)
![Page 94: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/94.jpg)
![Page 95: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/95.jpg)
![Page 96: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/96.jpg)
![Page 97: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/97.jpg)
![Page 98: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/98.jpg)
![Page 99: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/99.jpg)
![Page 100: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/100.jpg)
![Page 101: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/101.jpg)
![Page 102: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/102.jpg)
![Page 103: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/103.jpg)
![Page 104: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/104.jpg)
![Page 105: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/105.jpg)
![Page 106: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/106.jpg)
![Page 107: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/107.jpg)
![Page 108: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/108.jpg)
![Page 109: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/109.jpg)
![Page 110: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/110.jpg)
![Page 111: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/111.jpg)
![Page 112: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/112.jpg)
![Page 113: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/113.jpg)
![Page 114: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/114.jpg)
![Page 115: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/115.jpg)
![Page 116: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/116.jpg)
![Page 117: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/117.jpg)
![Page 118: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/118.jpg)
![Page 119: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/119.jpg)
![Page 120: I sacerdoti nella Dacia. Manuscript. Published in Hungarian [Szabó Á., Daciai papság. (Budapest, 2007)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020613/63158166c32ab5e46f0d56c1/html5/thumbnails/120.jpg)