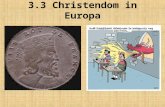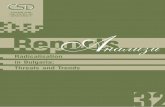ORHAN PAMUK EN LAS FRONTERAS DE EUROPA Serie Miradas a Europa
I Bulgari e la Bulgaria in Europa
Transcript of I Bulgari e la Bulgaria in Europa
DirettoreFrancesco BAlma Mater Studiorum — Università di Bologna
Comitato scientificoStefano BAccademia delle Scienze d’Ungheria — Istituto di Storia
Stephen KPrinceton University
Silvio PUniversità degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Robert SUniversity of Oxford
L’ALTRA EUROPA
COLLANA DI STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE
Inseguendo l’Occidente
La collana propone saggi scientifici e di alta informazione sulla storiacontemporanea e attuale degli Stati del continente eurasiatico, dalla lineaStettino–Trieste all’Oceano pacifico. Sono i territori dell’ex comunismo: maanche degli ex Imperi asburgico, ottomano, tedesco e russo, crollati tra il e il , sotto il peso della guerra e delle loro interne contraddizioni.Nel XX secolo essi hanno ospitato tra i più drammatici e tragici eventi dellastoria mondiale, originati dall’intervento nazionalsocialista e poi dalla “mo-dernizzazione” comunista. Oggi i nuovi Stati indipendenti ricercano unaloro via alla prosperità e alla democrazia, nelle nuove condizioni della glo-balizzazione. In forme anche assai diverse, tuttavia: dai paesi europei ormaichiamati “centroorientali”, a quelli balcanici e postsovietici, alla Federazionerussa.
Il presente volume è stato pubblicato nell’ambito delle attività del BAUCenter of Eurasian Studies.
Redazione: Roberto Sciarrone, Fabio L. Grassi.
Copyright © MMXIVARACNE editrice S.r.l.
via Raffaele Garofalo, /A–B Roma()
----
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: giugno
7
Indice
Prefazione Fabio L. Grassi
La Bulgaria dopo la prima guerra mondiale nelle carte della Commissione interalleata di controlloAntonello Biagini
I Bulgari e l’Italia. Precedenti storici e nuove migrazioni Antonio Ricci
1.1. Introduzione, 27 – 1.2. Le relazioni tra Italia e Bulgaria in epoca contemporanea, 29 – 1.3. I collegamenti tra il Risveglio nazionale bulgaro e il Risorgimento italiano, 31 – 1.4. Gli inse-diamenti d’italiani in Bulgaria tra la fine dell’800 e la prima metà del ‘900, 35 – 1.5. La penetrazione italiana tra le due guerre. L’opera dei missionari e delle istituzioni italiane, 41 – 1.6. La pe-netrazione economica finanziaria, 46 – 1.7. La Bulgaria vista at-traverso la pubblicistica italiana della prima metà del ‘900, 53 – 1.8. Gli anni del comunismo, 1.9 I rapporti tra Italia-Bulgaria dalla fine del comunismo a oggi, Conclusioni, Nota Bibliografica, 105
107 La Bulgaria post-comunista
Nota Bibliografica, 133
137 Giustizia, affari interni e immigrazione in Bulgaria nel processo d’integrazione
Giuseppe Motta
Nota Bibliografica,
9
15
27
Roberto Sciarrone
63 - 72 - 102 -
159
9
Prefazione
Fabio L. Grassi
I bulgari sono una delle piccole, grandi nazioni balcaniche.
Piccola numericamente, ma grande per la sua storia. Una storia molto varia, caratterizzata nei secoli da rapporti tutt’altro che superficiali e marginali con l’Italia, benché la Bulgaria appar-tenga allo spazio religioso ortodosso e inoltre, per cinque secoli, sia appartenuta allo spazio politico turco-ottomano.
I bulgari arrivano dall'interno dell’Eurasia. Dopo aver fonda-to un grande impero tra mar Nero e mar Caspio, nella seconda metà del VII secolo si spostano in gran parte verso ovest, a dan-no dell'Impero Bizantino. Con il trattato di pace del 681 abbia-mo la definitiva fondazione dello Stato bulgaro nei Balcani. Ad essa segue un rapido processo di cristianizzazione e slavizza-zione di una popolazione originariamente legata, se non appar-tenente, all'insieme delle genti turche. Periodi di splendore e di crisi si alternano fino al 1371, quando la Bulgaria si divide in tre piccoli regni. Questa frammentazione favorisce la conquista ottomana, che si può considerare definitiva dopo la disfatta cri-stiana di Nicopoli del 1396.
Il giudizio sul mezzo millennio di dominio ottomano in Bul-garia, come in generale nei Balcani, è controverso. Soprattutto a partire dall'inizio dell'Ottocento, in Occidente ha imperato l'idea di una lunga e uniforme epoca di oppressione, di malgoverno e di depressione culturale. Da qualche decennio è in corso una certa rivalutazione di quel dominio, soprattutto in considerazio-
I bulgari e la Bulgaria in EuropaISBN 978-88-548-7297-4DOI 10.4399/97888548729741pp. 9-13 (giugno 2014)
10 Prefazione
ne di due elementi che lo contraddistinsero: la tolleranza reli-giosa e il rispetto delle identità dei popoli soggetti. Anche in Bulgaria ci fu un afflusso non irrilevante di genti musulmane, a cui si aggiunse l’accettazione dell’islam da parte di non pochi slavi bulgarofoni, senza però che si determinasse nella popola-zione una chiara maggioranza musulmana e senza che la convi-venza si trasformasse in vera integrazione. Il risultato fu che, anche dopo secoli e secoli, la dominazione turca era sentita co-me una dominazione sostanzialmente straniera. Restava aperta la porta al risveglio nazionale bulgaro.
Esso avvenne nell’Ottocento e fu vigorosamente sostenuto dall'Impero Russo, che vedeva nella Bulgaria la sua più sicura e fedele testa di ponte nei Balcani. Fu appunto in diretto rapporto con la grande rivolta bulgara del 1876 che scoppiò, nel 1877, la guerra russo-turca che portò alla pace di Santo Stefano, con cui veniva costituita una grande Bulgaria de facto indipendente. Questo risultato, però, fu fortemente “limato” nel successivo congresso di Berlino.
Per la piena indipendenza del loro Stato i bulgari dovettero attendere il 1908. Quanto all’unità nazionale, l’acquisizione del-la Rumelia meridionale - nel 1885 - non pose fine alle loro ri-vendicazioni, che però, secondo uno schema classico nell’Europa centro-orientale, confliggevano con quelle delle na-zioni vicine. C’era poi il caso particolare dei macedoni, di cui si discuteva se fossero una nazione a sé stante, o nient’altro che bulgari parlanti un dialetto particolare (come molti bulgari ri-tengono tuttora). Con le guerre balcaniche del 1912-13 la Bul-garia ampliò i propri confini ma vide frustrate le proprie aspira-zioni in direzione della Macedonia e della Tracia. Salonicco passò alla Grecia, Adrianopoli rimase alla Turchia, gran parte della Macedonia interna fu assorbita dalla Serbia, la Dobrugia meridionale fu incorporata dalla Romania. Il tentativo di rivin-cita operato durante la prima guerra mondiale, in cui il regno bulgaro scelse di marciare a fianco degli Imperi centrali, si ri-solse con la perdita dello sbocco sul mar Egeo.
Fu dunque in un paese sconfitto, deluso, isolato, provato e turbato (si veda il primo contributo a questo libro), che si inserì
Prefazione 11
ne di due elementi che lo contraddistinsero: la tolleranza reli-giosa e il rispetto delle identità dei popoli soggetti. Anche in Bulgaria ci fu un afflusso non irrilevante di genti musulmane, a cui si aggiunse l’accettazione dell’islam da parte di non pochi slavi bulgarofoni, senza però che si determinasse nella popola-zione una chiara maggioranza musulmana e senza che la convi-venza si trasformasse in vera integrazione. Il risultato fu che, anche dopo secoli e secoli, la dominazione turca era sentita co-me una dominazione sostanzialmente straniera. Restava aperta la porta al risveglio nazionale bulgaro.
Esso avvenne nell’Ottocento e fu vigorosamente sostenuto dall'Impero Russo, che vedeva nella Bulgaria la sua più sicura e fedele testa di ponte nei Balcani. Fu appunto in diretto rapporto con la grande rivolta bulgara del 1876 che scoppiò, nel 1877, la guerra russo-turca che portò alla pace di Santo Stefano, con cui veniva costituita una grande Bulgaria de facto indipendente. Questo risultato, però, fu fortemente “limato” nel successivo congresso di Berlino.
Per la piena indipendenza del loro Stato i bulgari dovettero attendere il 1908. Quanto all’unità nazionale, l’acquisizione del-la Rumelia meridionale - nel 1885 - non pose fine alle loro ri-vendicazioni, che però, secondo uno schema classico nell’Europa centro-orientale, confliggevano con quelle delle na-zioni vicine. C’era poi il caso particolare dei macedoni, di cui si discuteva se fossero una nazione a sé stante, o nient’altro che bulgari parlanti un dialetto particolare (come molti bulgari ri-tengono tuttora). Con le guerre balcaniche del 1912-13 la Bul-garia ampliò i propri confini ma vide frustrate le proprie aspira-zioni in direzione della Macedonia e della Tracia. Salonicco passò alla Grecia, Adrianopoli rimase alla Turchia, gran parte della Macedonia interna fu assorbita dalla Serbia, la Dobrugia meridionale fu incorporata dalla Romania. Il tentativo di rivin-cita operato durante la prima guerra mondiale, in cui il regno bulgaro scelse di marciare a fianco degli Imperi centrali, si ri-solse con la perdita dello sbocco sul mar Egeo.
Fu dunque in un paese sconfitto, deluso, isolato, provato e turbato (si veda il primo contributo a questo libro), che si inserì
la breve e tragica avventura del leader contadino progressista Stambolijski. Divenuto primo ministro nel 1920, Stambolijski avviò una coraggiosa politica di riforme e di redistribuzione delle terre, ferocemente avversata dalle classi privilegiate e rea-zionarie. Nel marzo del 1923 questi firmò un accordo con il Re-gno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, riconoscendo le fron-tiere scaturite dalle guerre precedenti e impegnandosi a soppri-mere l’Organizzazione Rivoluzionaria Interna Macedone (VMRO), fortemente radicata in Bulgaria. Il colpo di stato del 9 giugno 1923 portò al barbaro assassinio di Stambolijkski e all’instaurazione di un governo reazionario. Negli anni succes-sivi, in un quadro politico-istituzionale teso e instabile, emerse progressivamente il regime personale dello zar Boris III.
Scoppiata la seconda guerra mondiale, la Bulgaria cercò di trarne vantaggio senza farsi coinvolgere direttamente. Questa politica apparve coronata dal successo con il recupero della Do-brugia meridionale. Ma nel 1941, quando le truppe tedesche, per invadere la Grecia, chiesero di passare attraverso il territorio bulgaro, Boris III si rassegnò a unirsi alle potenze dell’Asse (1º marzo). Tuttavia, egli si rifiutò di dichiarare guerra all’Unione Sovietica, visti i radicati sentimenti filorussi della popolazione, e cooperò con il governo, con il clero e con la maggior parte del popolo bulgaro alla salvezza dei cittadini ebrei: una pagina lu-minosa della storia bulgara, che andrebbe maggiormente cono-sciuta. Dopo la misteriosa morte di Boris nel 1943, ciò non sal-vò la Bulgaria dall'occupazione sovietica e dalla sua trasforma-zione in “democrazia popolare”. Questa vicenda ebbe, però, il suo peso nella sorte della Dobrugia meridionale, che restò alla Bulgaria.
Il partito comunista bulgaro aveva un reale radicamento e un leader di alto profilo internazionale, Georgi Dimitrov, che però era ormai in condizioni di salute molto precarie. Alla sua morte (1949) seguì una ferrea stalinizzazione sotto il “proconsole” Červenkov. Il suo successore, Todor Živkov, fu un dirigente di stampo brežneviano, sotto il quale la Bulgaria acquisì l’immagine di placido e fedele satellite dell’URSS, anche se, in realtà, non mancarono turbolenze, come il tentativo di colpo di
12 Prefazione
Stato “filocinese” del 1965. Sia pure con momenti di minor pressione nei periodi di distensione tra i due blocchi, la mino-ranza turca continuò a essere vista con ostilità e sospetto dal re-gime bulgaro, giacché la Turchia era il baluardo della NATO nella regione balcanica (oltre che nel Medio Oriente).
Ma fu verso la fine degli anni Ottanta che lo Stato avviò una vera e propria campagna di pulizia etnica, nella quale i turchi si trovarono nella condizione di dovere scegliere tra assimilazione ed emigrazione. Ciò portò - nel 1989 - all’emigrazione di più di 300.000 turchi di cittadinanza bulgara in Turchia (negli anni successivi, da un parte, proseguì in misura minore il flusso mi-gratorio; dall’altra, molti turchi rientrarono in Bulgaria). Con questa politica Živkov, che con l’avvento di Gorbačëv alla gui-da del PCUS aveva perso ogni sostegno esterno, cercò di di-strarre il suo popolo dall’incombente fallimento dell’economia socialista. In quello stesso 1989 il partito sostituì Živkov con Petăr Mladenov, ma nel febbraio 1990 esso rinunciò al monopo-lio del potere.
Nel successivo giugno si tennero le prime elezioni libere dal 1931. Il seguito, con la nuova Costituzione, la faticosa ripresa economica, gli sviluppi della vita politica pluripartitica, i flussi migratori verso gli altri paesi, l’ingresso nell’UE e l'adeguamen-to alle direttive comunitarie, è trattato in dettaglio nel secondo, terzo e quarto contributo di questo volume.
La Bulgaria può essere considerato un significativo case study per misurare i successi e i limiti della transizione dal so-cialismo alla democrazia e il beneficio che l'integrazione euro-pea può aver prodotto nelle società dell’ex-blocco sovietico. In questo periodo, che ormai è prossimo al quarto di secolo, la Bulgaria è raramente assurta agli onori della cronaca: la caduta del regime di stile sovietico è avvenuta in modo incruento e la “dialettica interetnica” non è sfociata in conflitti di vasta porta-ta. Certamente le pulsioni ultranazionaliste e xenofobe, in Bul-garia così come in buona parte dei paesi dell’est europeo, conti-nuano a serpeggiare in settori non sempre ristretti e non sempre marginali della popolazione. Possono essere tenute sotto con-trollo, ma è difficile che possano spegnersi del tutto.
Prefazione 13
Stato “filocinese” del 1965. Sia pure con momenti di minor pressione nei periodi di distensione tra i due blocchi, la mino-ranza turca continuò a essere vista con ostilità e sospetto dal re-gime bulgaro, giacché la Turchia era il baluardo della NATO nella regione balcanica (oltre che nel Medio Oriente).
Ma fu verso la fine degli anni Ottanta che lo Stato avviò una vera e propria campagna di pulizia etnica, nella quale i turchi si trovarono nella condizione di dovere scegliere tra assimilazione ed emigrazione. Ciò portò - nel 1989 - all’emigrazione di più di 300.000 turchi di cittadinanza bulgara in Turchia (negli anni successivi, da un parte, proseguì in misura minore il flusso mi-gratorio; dall’altra, molti turchi rientrarono in Bulgaria). Con questa politica Živkov, che con l’avvento di Gorbačëv alla gui-da del PCUS aveva perso ogni sostegno esterno, cercò di di-strarre il suo popolo dall’incombente fallimento dell’economia socialista. In quello stesso 1989 il partito sostituì Živkov con Petăr Mladenov, ma nel febbraio 1990 esso rinunciò al monopo-lio del potere.
Nel successivo giugno si tennero le prime elezioni libere dal 1931. Il seguito, con la nuova Costituzione, la faticosa ripresa economica, gli sviluppi della vita politica pluripartitica, i flussi migratori verso gli altri paesi, l’ingresso nell’UE e l'adeguamen-to alle direttive comunitarie, è trattato in dettaglio nel secondo, terzo e quarto contributo di questo volume.
La Bulgaria può essere considerato un significativo case study per misurare i successi e i limiti della transizione dal so-cialismo alla democrazia e il beneficio che l'integrazione euro-pea può aver prodotto nelle società dell’ex-blocco sovietico. In questo periodo, che ormai è prossimo al quarto di secolo, la Bulgaria è raramente assurta agli onori della cronaca: la caduta del regime di stile sovietico è avvenuta in modo incruento e la “dialettica interetnica” non è sfociata in conflitti di vasta porta-ta. Certamente le pulsioni ultranazionaliste e xenofobe, in Bul-garia così come in buona parte dei paesi dell’est europeo, conti-nuano a serpeggiare in settori non sempre ristretti e non sempre marginali della popolazione. Possono essere tenute sotto con-trollo, ma è difficile che possano spegnersi del tutto.
In ogni caso, il fatto che la Bulgaria e gli immigrati bulgari non “facciano notizia” può essere un buon segno: ma non un motivo per trascurare una vicenda storica così significativa.
Il presente volume consta di quattro contributi. Il primo, di Antonello Biagini, è una sapiente e concisa ricostruzione delle vicende politiche e belliche che portarono alla pace di Neuilly del 27 novembre 1919 e del ruolo italiano nel controllo dell'at-tuazione delle sue clausole militari. Dai rapporti dei membri ita-liani della commissione interalleata di controllo emergono le realtà complesse e difficilmente governabili del Paese osservate “sul campo” e non nelle ovattate stanze della Conferenza di pa-ce. Il secondo contributo, di Antonio Ricci, riassume la storia dei rapporti tra bulgari e italiani e ricorda l’influsso importante del Risorgimento italiano sul movimento nazionale bulgaro nell’Ottocento. Esso si diffonde, poi, sulla presenza bulgara in Europa, particolarmente in Italia, dopo la caduta del regime comunista.
Il terzo e il quarto contributo sono per molti aspetti comple-mentari. Quello di Roberto Sciarrone ripercorre il travagliato, anche se non tragico, percorso di fuoruscita della Bulgaria dal sistema monopartitico e dall’economia pianificata verso l’approdo alla piena integrazione nell’Unione Europea; quello di Giuseppe Motta analizza il non facile processo di adegua-mento del “Paese delle Rose” alle direttive comunitarie, anche nel quadro di un più ampio esame della sua politica estera.
Roma, giugno, 2014
15
La Bulgaria dopo la prima guerra mondiale nelle carte della Commissione
interalleata di controllo
Antonello Biagini
All’approccio teorico degli studiosi sui temi della prima guerra mondiale, si può aggiungere il contributo offerto dalle fonti documentarie, come quelle consultate da chi scrive negli anni, conservate presso l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito di Roma. L’archivio, oltre a conservare documenti di carattere propriamente militare (Diari Storici e Memorie Storiche delle Unità militari, piani operativi, etc.), si è rivelato prezioso per la ricostruzione di momenti non secondari della politica interna ed estera dell’Italia, grazie all’apporto del-le relazioni degli addetti militari sulle loro missioni all’estero e alle loro considerazioni politiche. Le carte di cui si tratta sono collocate nel fondo Commissioni interalleate di controllo. Per quanto concerne la Bulgaria, il materiale va individuato fra un materiale vasto ed eterogeneo (telegrammi, dispacci, note in-formative, tabelle numeriche, verbali di riunioni, richieste d’informazioni, etc.).
Il contesto è quello dagli anni immediatamente successivi al-la prima guerra mondiale, quando nasce per l’Italia l’esigenza di ricostruire sul piano diplomatico e sociale le linee di una nuova politica estera, da inserire nel più vasto contesto europeo e mondiale. Con la Conferenza di Versailles, le Potenze vincitrici
I bulgari e la Bulgaria in EuropaISBN 978-88-548-7297-4DOI 10.4399/97888548729742pp. 15-25 (giugno 2014)
16 Antonello Biagini
tentano - in maniera non concorde - di disegnare un nuovo as-setto europeo e internazionale, nell’intento di costituire un nuo-vo “sistema” di relazioni internazionali, capace di sostituire l’impiego della guerra come strumento risolutivo dei conflitti politici, al fine di dare concreta attuazione alle speranze e alle attese maturate in seno all’opinione pubblica durante i difficili anni del conflitto. La dissoluzione dei grandi Imperi plurinazio-nali e la fine sia del militarismo prussiano, che dell’obiettivo espansionistico a esso legato, avrebbero dovuto aprire una nuo-va epoca, caratterizzata dalla presenza di nazionalità che final-mente divenivano soggetti di diritto internazionale con un pro-prio Stato sovrano, libero e indipendente. Su tale sfondo genera-le, la tensione ideologica interna alle varie società produce ef-fetti contrastanti e contradditori, aprendo un periodo di crisi e d’instabilità lungo un intero ventennio. Paradossalmente, la pa-ce - e quindi la ricostruzione del sistema internazionale - è im-praticabile, proprio perché i risultati raggiunti a Versailles non sono altro che la logica conseguenza dello spirito di crociata che aveva caratterizzato le forze contrapposte durante la guerra.
Per gli Stati vinti si apre la strada della disgregazione sociale e politica, aggravata dalla questione delle riparazioni economi-che, mentre gli Stati dell’Intesa si trovano a dover amministrare una vittoria più formale che sostanziale. Essi avevano partecipa-to alla guerra con interessi e scopi diversi e conoscevano al pro-prio interno analoghi sintomi di crisi sociale ed economica. Non a caso prendono corpo soluzioni istituzionali di tipo autoritario in molti paesi d’Europa - Italia, Germania, Polonia, Ungheria, Romania, Jugoslavia - inizialmente non contrastate dalle demo-crazie parlamentari di più antica tradizione - come l’Inghilterra, gli Stati Uniti d’America, la Francia - nella speranza di contene-re e/o eliminare lo spettro della rivoluzione sociale conseguente all’affermazione della rivoluzione bolscevica in Russia.
La storiografia italiana, con studi di settore e/o opere di sin-tesi, si è dignitosamente occupata di tali avvenimenti, affron-tando i temi in questione in opere importanti, come Mussolini e la politica estera italiana. 1919-1933, di Ennio Di Nolfo; L’Italia e la pace di Versailles, di Fulvio d’Amoja; La dissolu-
La Bulgaria dirante la prima guerra mondiale 17
tentano - in maniera non concorde - di disegnare un nuovo as-setto europeo e internazionale, nell’intento di costituire un nuo-vo “sistema” di relazioni internazionali, capace di sostituire l’impiego della guerra come strumento risolutivo dei conflitti politici, al fine di dare concreta attuazione alle speranze e alle attese maturate in seno all’opinione pubblica durante i difficili anni del conflitto. La dissoluzione dei grandi Imperi plurinazio-nali e la fine sia del militarismo prussiano, che dell’obiettivo espansionistico a esso legato, avrebbero dovuto aprire una nuo-va epoca, caratterizzata dalla presenza di nazionalità che final-mente divenivano soggetti di diritto internazionale con un pro-prio Stato sovrano, libero e indipendente. Su tale sfondo genera-le, la tensione ideologica interna alle varie società produce ef-fetti contrastanti e contradditori, aprendo un periodo di crisi e d’instabilità lungo un intero ventennio. Paradossalmente, la pa-ce - e quindi la ricostruzione del sistema internazionale - è im-praticabile, proprio perché i risultati raggiunti a Versailles non sono altro che la logica conseguenza dello spirito di crociata che aveva caratterizzato le forze contrapposte durante la guerra.
Per gli Stati vinti si apre la strada della disgregazione sociale e politica, aggravata dalla questione delle riparazioni economi-che, mentre gli Stati dell’Intesa si trovano a dover amministrare una vittoria più formale che sostanziale. Essi avevano partecipa-to alla guerra con interessi e scopi diversi e conoscevano al pro-prio interno analoghi sintomi di crisi sociale ed economica. Non a caso prendono corpo soluzioni istituzionali di tipo autoritario in molti paesi d’Europa - Italia, Germania, Polonia, Ungheria, Romania, Jugoslavia - inizialmente non contrastate dalle demo-crazie parlamentari di più antica tradizione - come l’Inghilterra, gli Stati Uniti d’America, la Francia - nella speranza di contene-re e/o eliminare lo spettro della rivoluzione sociale conseguente all’affermazione della rivoluzione bolscevica in Russia.
La storiografia italiana, con studi di settore e/o opere di sin-tesi, si è dignitosamente occupata di tali avvenimenti, affron-tando i temi in questione in opere importanti, come Mussolini e la politica estera italiana. 1919-1933, di Ennio Di Nolfo; L’Italia e la pace di Versailles, di Fulvio d’Amoja; La dissolu-
zione dell’Austria-Ungheria, di Leo Valiani; Rivoluzione e rea-zione in Europa, a cura di Franco Gaeta. Nell’ambito dei più vasti rapporti di politica estera, l’Italia mostra un nuovo interes-se e una più accentuata attenzione alle proprie relazioni con la Bulgaria, alla quale era già legata - come è noto alla storiografia sia italiana, che bulgara - nel periodo risorgimentale e nel mo-mento della formazione dello Stato bulgaro. Nel contesto di un lavoro più ampio condotto nel tempo e relativo all’attività svol-ta dalle commissioni interalleate di controllo dopo la prima guerra mondiale, ho individuato una parte significativa dei ma-teriali documentari - conservati negli archivi italiani e in quegli stranieri - che riguarda proprio la situazione bulgara.
Nelle complesse trattative che si svolgono a Versailles, le Commissioni interalleate vengono costituite per dare concreta attuazione alle decisioni prese dalla Conferenza degli ambascia-tori e assumono il compito di occuparsi di una molteplicità di problemi, quali il pagamento dei danni di guerra e delle com-pensazioni, le delimitazioni dei confini e la ricostituzione degli eserciti, l’assetto politico-istituzionale e le riforme finanziarie. I lavori delle Commissioni, dunque, producono materiali e do-cumenti di grande interesse proprio per l’ampiezza delle compe-tenze e l’importanza dei temi trattati.
Una consistente parte dei documenti analizzati, conservati presso l’Archivio ricordato, copre l’arco temporale compreso tra il 1918 e il 1923 e comprende una serie di relazioni e di altri materiali relativi alla situazione politica interna della Bulgaria e alla lotta fra le varie formazioni politiche di questo Paese. Una delle prime note informative di una certa consistenza è quella del colonnello Castoldi (febbraio e luglio 1918), il quale riper-correva le tappe fondamentali della storia recente della Bulgaria e rilevava come il problema della Macedonia e l’«idea-mito» della Grande Bulgaria costituissero il centro della politica bul-gara. La ricostruzione del passato bulgaro, finalizzata a spiegare le richieste e i progetti di quel momento, si ritrova in numerose altre relazioni e rapporti redatti anche sotto forma di promemo-ria per la delegazione italiana a Versailles: materiali che avreb-bero dovuto servire per offrire le opportune informazione ai de-
18 Antonello Biagini
legati. In essi si sostiene che la sistemazione raggiunta con il Congresso di Berlino (1878) aveva mortificato le aspettative bulgare. Il territorio della progettata “Grande Bulgaria” era stato diviso in tre parti: la prima, a nord dei Balcani, con il nome di Bulgaria, era divenuta un principato autonomo, ancora sotto l’alta sovranità – nominale- della Sublime Porta; alla seconda, la Rumelia orientale, era stata concessa una parziale autonomia, sotto un governatore cristiano. La Macedonia era tornata sotto il dominio diretto ottomano. La terza parte, la Dobrugia, malgra-do fosse un territorio prevalentemente abitato da Bulgari, era stata assegnata alla Romania.
Le vicende dei paesi della penisola balcanica risultavano co-sì legate da una parte al filo sottile della contrapposizione ai grandi Imperi plurinazionali, quello ottomano e quello asburgi-co; e dall’altra, alle esigenze delle singole nazionalità, spesso in contrasto fra loro. Ecco allora le due guerre balcaniche che se-gnano - paradossalmente - un momento di significativa unità di forze e di intenti (prima guerra balcanica, contro l’Impero otto-mano), per concludersi con il prevalere della tradizionale di-sgregazione e disomogeneità (seconda guerra balcanica).
Per la Bulgaria, la partecipazione alla prima guerra mondiale trova giustificazione nell’intento di appoggiare chi possa offrir-le in compenso il possesso della Macedonia (o quanto meno, ot-tenere una promessa in merito). Per la realizzazione di tale obiettivo, la Bulgaria è disposta a sacrificare ogni suo rapporto internazionale, associandosi indifferentemente alle Potenze eu-ropee che meglio le assicurino il suo diritto.
Per tale ragione, fino a quando la lotta nei Balcani è caratte-rizzata dalla contrapposizione fra l’Austria e la Serbia, la Bulga-ria riesce a dichiararsi e mantenersi neutrale. Ma con l’entrata in guerra dell’Italia si accentua la spinta all’intervento a fianco de-gli Imperi centrali. Vale la pena di ricordare che la Bulgaria, all’epoca, riveste una determinante importanza strategica per entrambi le parti in lotta. Se, per l’Intesa, il suo territorio può rappresentare un mezzo per isolare la Turchia e offrire sicurezza alla Serbia, per gli Imperi centrali essa è essenziale per poter piegare la Serbia e per garantire sicure comunicazioni dirette
La Bulgaria dirante la prima guerra mondiale 19
legati. In essi si sostiene che la sistemazione raggiunta con il Congresso di Berlino (1878) aveva mortificato le aspettative bulgare. Il territorio della progettata “Grande Bulgaria” era stato diviso in tre parti: la prima, a nord dei Balcani, con il nome di Bulgaria, era divenuta un principato autonomo, ancora sotto l’alta sovranità – nominale- della Sublime Porta; alla seconda, la Rumelia orientale, era stata concessa una parziale autonomia, sotto un governatore cristiano. La Macedonia era tornata sotto il dominio diretto ottomano. La terza parte, la Dobrugia, malgra-do fosse un territorio prevalentemente abitato da Bulgari, era stata assegnata alla Romania.
Le vicende dei paesi della penisola balcanica risultavano co-sì legate da una parte al filo sottile della contrapposizione ai grandi Imperi plurinazionali, quello ottomano e quello asburgi-co; e dall’altra, alle esigenze delle singole nazionalità, spesso in contrasto fra loro. Ecco allora le due guerre balcaniche che se-gnano - paradossalmente - un momento di significativa unità di forze e di intenti (prima guerra balcanica, contro l’Impero otto-mano), per concludersi con il prevalere della tradizionale di-sgregazione e disomogeneità (seconda guerra balcanica).
Per la Bulgaria, la partecipazione alla prima guerra mondiale trova giustificazione nell’intento di appoggiare chi possa offrir-le in compenso il possesso della Macedonia (o quanto meno, ot-tenere una promessa in merito). Per la realizzazione di tale obiettivo, la Bulgaria è disposta a sacrificare ogni suo rapporto internazionale, associandosi indifferentemente alle Potenze eu-ropee che meglio le assicurino il suo diritto.
Per tale ragione, fino a quando la lotta nei Balcani è caratte-rizzata dalla contrapposizione fra l’Austria e la Serbia, la Bulga-ria riesce a dichiararsi e mantenersi neutrale. Ma con l’entrata in guerra dell’Italia si accentua la spinta all’intervento a fianco de-gli Imperi centrali. Vale la pena di ricordare che la Bulgaria, all’epoca, riveste una determinante importanza strategica per entrambi le parti in lotta. Se, per l’Intesa, il suo territorio può rappresentare un mezzo per isolare la Turchia e offrire sicurezza alla Serbia, per gli Imperi centrali essa è essenziale per poter piegare la Serbia e per garantire sicure comunicazioni dirette
con Costantinopoli. Entrambe le parti in lotta esercitano perciò forti pressioni per indurre - con ampie garanzie e aiuti militari - lo zar Ferdinando a schierarsi: l’Austria promette i territori che dovrebbero essere tolti alla Serbia, mentre l’Intesa offre alla Bulgaria la Tracia e lascia intravedere la possibilità di ottenere la Macedonia (oltre a un consistente aiuto finanziario), qualora essa si impegni ad attaccare direttamente la Turchia. In quel momento, le sorti della guerra sono decisamente favorevoli agli Imperi centrali e lo zar Ferdinando ritiene che a essi spetterà la vittoria finale, che sola consentirebbe il recupero dei territori perduti dopo la seconda guerra balcanica. Decide dunque di unirsi agli Imperi centrali, con la promessa di ricevere la Do-brugia, la Macedonia e la Tracia. Non tutti i bulgari, però, sono d’accordo. Stambolijski, capo del Partito agrario, segnala allo zar i rischi di quella scelta che potrebbe mettere in pericolo per-sino il trono nel caso di un esito negativo della guerra.
Nel corso del conflitto, Stambolijski è condannato alla de-tenzione perpetua proprio per essersi opposto all’alleanza con gli Imperi centrali, oltre che per aver denunciato il regime di violenza instaurato nel paese. L’intervento bulgaro segna il crollo definitivo delle pur minime possibilità di resistenza della Serbia, ma l’offensiva che l’Intesa apre a Salonicco, in breve tempo conduce i bulgari all’armistizio (29 settembre 1918), concluso con il generale Franchet d’Espérey, al fine di evitare una occupazione del territorio nazionale da parte dei serbi e dei greci.
Per superare il forte malcontento interno e per ricreare l’unità del paese e dell’esercito intorno alla dinastia, lo zar Fer-dinando decide di liberare Stambolijski e di affidargli la gestio-ne della cosa pubblica attraverso un governo di coalizione, ma questo non basta a placare la grave tensione interna e per Ferdi-nando si impone la scelta dell’esilio. Stambolijski - che intanto ha assunto i pieni poteri - chiede (come aveva fatto l’Ungheria) che i territori pretesi dagli Stati vicini siano sottoposti a plebi-scito sulla base dei quattordici punti di Wilson. Ma le potenze vincitrici non accolgono tale richiesta e con la pace di Neully (27 novembre 1919) le frontiere della Bulgaria vengono definite
20 Antonello Biagini
con prevalentemente strategici, che non tengono in alcun conto la realtà specifica delle presenze etniche: la Tracia occidentale, abitata da popolazioni bulgare e turche, fortemente mescolate, viene ceduta alla Grecia (al fine di allontanare la Bulgaria dalla zona degli Stretti e precluderle l’accesso all’Egeo); la Jugosla-via ottiene un esiguo ma importante tratto di territorio, che al-lontana la frontiera bulgara dalla linea ferroviaria Belgrado-Salonicco; alla Romania viene confermato il possesso della Do-brugia meridionale.
In tale contesto, meritano di essere segnalati i numerosi rap-porti italiani riguardanti la politica interna ed estera della Bulga-ria.
A differenza di altri paesi balcanici - scriveva il colonnello Castoldi nel luglio 1918 - il problema territoriale bulgaro è esclusivamente balcanico e finalizzato al raggiungimento dell’indipendenza nazionale. La Bulgaria avrebbe accettato di buon grado la condanna dello zar Ferdinando e del suo governo, nonché l’imposizione di sanzioni di carattere finanziario, purché non si fosse messo in discussione il suo diritto al mantenimento dell’unità nazionale. Cinque le rivendicazioni bulgare che ven-gono avanzate: restituzione della Dobrugia meridionale; rettifi-ca della frontiera con la Serbia; sistemazione della questione macedone; navigazione sul Danubio; internazionalizzazione del porto di Salonicco.
Ognuna di tali rivendicazioni trova la propria motivazione nel lungo excursus di carattere storico che il colonnello Castoldi non manca di redigere puntualmente e con diligenza, ponendo l’accento, profeticamente, sul fatto che la mancata soddisfazio-ne di queste aspettative - o comunque l’assenza di soluzioni di compromesso da parte dei delegati alla conferenza di pace - sa-rebbe stata condizione sufficiente per futuri e ben più gravi con-flitti di carattere internazionale. Deve aggiungersi a ciò la grave crisi politica della società bulgara, mortificata dalla sconfitta militare e dalla grave crisi economica, sulla quale pesa - come si segnala nelle relazioni del tenente Jacomoni - l’ingente massa di profughi provenienti da quei territori ora sottratti alla Bulgaria. Vanno, infine, considerate le speculazioni finanziarie e la diffi-