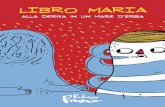Girolamo Maria Rosa, Bortolo Brasi, Giovanni Marchiori e gli intagli del refettorio con una nota sul...
Transcript of Girolamo Maria Rosa, Bortolo Brasi, Giovanni Marchiori e gli intagli del refettorio con una nota sul...
• 421 •
“non men degno da vedersi è anche altresì il so-praddetto Refettorio per la delicatezza degl’inta-gli de’quali è arricchito”.
L’arredo ligneo del refettorio, con il prezioso ornamento dei suoi celebri intagli, che per la loro “delicatezza” Giovanni Battista Rossetti incluse tra le principali cose d’arte merite-voli di lode presenti a Praglia1, fu eseguito in occasione dei lavori di rinnovamento dell’antico cenacolo promossi dall’a-bate Alberto Angeli tra il 1726 e il 17292. Esso si sviluppa lungo l’intero perimetro della grande aula quattrocentesca, cui si accede dal chiostro pensile, cuore del complesso mo-nastico: tutto intorno alla sala le pareti si presentano, infatti, rivestite da dossali, con specchiature in radica di noce, e su tre lati sono ancora disposte nove ampie mense intagliate con relative panche, quattro per ognuno dei lati lunghi e una nella parete di fondo; il tutto, verosimilmente, secondo il disegno fornito da fra Fortunato Abbiati da Venezia “comesso in Santa Giustina”3.
Il ritmo incalzante dei dossali è scandito da lesene bom-bate con capitello ionico, che delimitano ad un tempo lo stallo di ciascun monaco, come pure dalla presenza di urne poste, in asse, sul cornicione aggettante. Proprio al di sopra di tale cornicione si svolge quindi il programma decorativo e didascalico che, caratterizzando in modo alquanto singo-lare l’ambiente, è in primo luogo costituito da una varietà di immagini minutamente scolpite a tutto tondo, ciascuna delle quali – al centro, tra le urne, rispetto al sottostante dossale – poggia su intrecci di volute intagliate a motivi fitomorfi (fig. 1).
Se il repertorio adottato per ornare i dossali privi di pan-che e delle antistanti mense si limita a una variata serie di volatili e a composizioni di fiori o frutta (fig. 2-4), ben più
ampia si presenta invece la gamma delle raffigurazioni – tutte accompagnate da un motto in latino inciso in un cartiglio dorato – che contrassegnano i sessantatre stalli dei monaci.
Sette per ciascuna delle nove mense, questi emblemi nel loro susseguirsi formano una serrata sequenza che, a mo’ di pausa a giovamento dell’osservatore, viene sapientemente in-terrotta in corrispondenza degli intervalli tra le tavole nei due lati lunghi, dove il cornicione si apre a formare un arco spezzato, dall’inserimento di quattro grandi scudi con episo-di biblici riferiti alle virtù cardinali, nonché dalla coppia di putti alla base del pulpito marmoreo sulla parete di ponente e, dirimpetto, sul lato opposto, dall’immagine dell’Immacolata, tra altri due putti. Inoltre, raffigurazioni simboliche di mag-giori dimensioni segnano ritmicamente, in corrispondenza delle grandi finestre dell’aula, il centro delle mense nei due lati lunghi (fig. 1) e, analogamente, gli estremi della mensa sulla parete di fondo, al cui centro campeggia, sopra lo stallo dell’abate, lo stemma del monastero.
L’incarico di “animarne co’ gli Emblemi que’ legni” era stato affidato dall’abate Alberto Angeli al monaco professo Girolamo Maria Rosa, al quale spetta, quindi, l’articolato pro-gramma iconografico da lui stesso illustrato nello scritto Il refettorio morale, o sia spiegazione de’ simboli intagliati negli orna-menti del Refettorio maggiore del Monastero di Praglia4. Quest’o-peretta esegetica – come chiarisce il monaco – “porta ella il titolo di Refettorio Morale” poiché, in effetti, gli emblemi altro non sono “che fonti onde ne tragga l’animo gli alimenti di una morale dottrina”: sono queste raffigurazioni “disposte sur le spalliere che a ciascheduna delle Tavole corrispondono, quasi alfine che chiunque a queste si asside, impegnato ne resti all’acquisto della virtù, dal cui simbolo viene adorno il suo seggio”5.
Girolamo maria rosa, Bortolo Brasi, Giovanni marchiori e Gli intaGli
del refettorio con una nota sul San Girolamo di Giovanni Bonazza
Simone Guerriero
Girolamo maria rosa, Bortolo Brasi, Giovanni marchiori e Gli intaGli del refettorio con una nota sul san girolamo di giovanni Bonazza
• 423 •
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 424 • • 425 •
che la compongono, come altresì di precisarne le peculiarità e in cosa essa si distingua.
Facendo propria, tra le varie definizioni possibili, “quella di Monsignor Aresio”, l’impresa può dirsi dunque per Pici-nelli “un composto di figura, e di motto, che oltre al signifi-care alcuna cosa propriamente, a rappresentare per mezzo di questa figuratamente alcun nostro pensiero particolare e or-dinato”10. E, più precisamente, “dicesi l’Impresa un composto, nel quale il corpo, ò sia la figura serve come di materia, & le parole, ò sia il motto, come di forma, l’un e l’altro dei qua-li partialmente concorre alla sua formatione” non potendo sussistere vera impresa formata da sola figura o solo motto11. Sulla base di tale definizione “l’Impresa resta affatto distinta dall’altre simili compositioni, e ritrovamenti, come sono gli Emblemi, i Simboli, i Geroglifici &c.”12. Viene poi meglio chiarito che essa “è un composto, che seco porta due sensi: uno letterale, e l’altro allegorico; dovendo dal corpo e motto insieme, non solamente cavarsi il concetto, e senso, fisico, e morale: ma anco inserirsi un altro senso, che tacitamente sia rappresentativo del nostro particolare disegno, ed intento”13. Sicché – in altre parole – “la dove con la sola figura io non dichiaro i miei sensi; con le sole parole io non gli manifesto; con l’accoppiamento e di quella, e di queste, s’esprime, e si determina il senso vero, e letterale dell’Impresa, al quale per via di similitudine succeda l’illatione del senso allegorico, che con diletto insinui i sensi, ed i concetti interni dell’Autore, all’animo del contemplante”14. Alla figura e al motto, che alla “formatione dell’Impresa” concorrono “con simpatica corri-spondenza”, – ricorda Picinelli – c’è chi “à quella il nome di corpo, ed à questo d’anima volle attribuire”15.
Intorno al “corpo” come all’ “anima” varie sono, inoltre, le prescrizioni fornite e non sarà inutile riportare alcune indi-cazioni in materia, atte a comprendere a pieno la natura delle raffigurazioni intagliate nel refettorio e degli stessi motti che le accompagnano. Il corpo, innanzitutto, “può questi pigliarsi da qual si voglia oggetto, ò naturale, ò artificiale; ma quanto riuscirà di più vaga vista, e di più nobile prospettiva, tanto sarà più ragguardevole, e commendabile”16. Un corpo solo “basta alla formazione dell’Impresa”, tuttavia due figure, o più, pos-sono rendere l’Impresa “più gratiosa, e più bella, vedendosi più facilmente fra di loro l’attione, e la passione che dal motto è inferita”17. Al corpo dell’impresa “vien sopraposto il motto, accioche serva a determinare quel corpo, e quella materia, riducendola limitatamente, più ad esprimere un concetto, che un altro”18. Il motto dunque “fa si che la figura ivi delineata diviene impresa; & anco si differentia […] da qual si voglia altra impresa che col medesimo corpo fosse rappresentata”19 (si ricorderà pure che Girolamo Rosa, per un numero pur limitato di casi, riferisce di aver desunto dagli “Autori” le sole immagini, ossia i “corpi”, che, per l’appunto, “colla variazione de’ motti” volge poi, come si vedrà, ad altro significato). Le parole del motto, che “devono essere proportionate, & signi-
Ancor prima di addentrarsi nella decifrazione degli emble-mi e nell’esposizione del loro significato morale, nella lettera dedicatoria premessa allo scritto, indirizzata al suo superiore, Rosa non manca di svelare il modus operandi da lui adottato nella scelta e determinazione degli stessi, precisando altresì la loro appartenenza alla specifica categoria delle imprese. Ov-vero, come si vedrà meglio in seguito, a quel preciso genere di rappresentazioni simboliche d’un proposito, piuttosto che d’una linea di condotta, per mezzo di un motto e di una fi-gura (corpo) che vicendevolmente s’interpretano6.
Rosa osserva, pertanto, come “la preziosità del lavoro; l’e-sigenza del luogo destinato à pubblico religioso servigio; la decorosa vaghezza del medesimo, et, in fine, tanti altri sin-golari ornamenti di questo Monastero (tra quali non è la nuova opera per occupare l’ultimo posto) richiedevano che si usasse in questa ogni studio, per quanto appartiene alla idea delle Imprese; affine che degenerando queste o per la qualità del significato, o per la scelta, e disposizione de’ corpi, dalle mentovate circostanze, non apportassero loro disonore, anzi che maggior riputazione, e bellezza”.
Conscio della “gravità dell’impegno”, e pur consapevole di “non poter corrispondere alla diligenza, che nello studio de’ simboli ricercatasi”, il monaco espone così il procedimen-to seguito: “chiamai […] in soccorso alla mia insufficienza gli Autori coll’appoggio de’ quali hò formata la presente raccolta de simboli tutti Morali; buona parte di questi con le loro
spiegazioni da medesimi togliendo ad imprestito; per altri servendomi de’ soli corpi, tradotti colla variazione de’ motti ad altro significato; et altri finalmente aggiungendone; non tanto per compimento del numero, che per la corrispondenza de’ corpi stessi, quali hò proccurato disporre in tal guisa, che accoppiandone quattro della medesima spezie, con ordinata scambievolezza tra ciascheduna mensa, e quella che gli è di-rimpetto, ne risultasse tale armonia […]”7.
Un’operazione di tal sorta parrebbe presupporre da parte del Rosa la buona, se non puntuale conoscenza della tratta-tistica sulle imprese che, insieme al fiorire di veri e propri repertori, si era sviluppata a partire dal Cinquecento, e poi nel corso nel secolo successivo8, e grazie alla quale si era giunti via via ad una sempre più precisa definizione dell’impresa stessa come delle norme che ne presiedevano la creazione nel rispetto della distinzione con le altre classi di simboli.
nondimeno, va pure subito precisato, Girolamo Rosa de-sume la quasi totalità delle imprese, da lui scelte ad “animare” gli arredi del refettorio, dal Mondo Simbolico dell’abate mila-nese dell’ordine dei Canonici Regolari Lateranensi Filippo Picinelli, che, apparso in più edizioni a partire dalla metà del Seicento, presenta una rilettura in chiave religioso dottrinale del genere impresistico e può essere senz’altro indicato come il testo preso a principale riferimento dal monaco9. Dalla sua consultazione il Rosa aveva avuto modo non solo di attingere a un vasto repertorio di immagini e motti ma pure di appren-dere e far proprie le “regole” per “formare” nuove imprese. nella sua opera il Picinelli non manca, infatti, di illustrare ampiamente la natura dell’impresa, di definire le singole parti
1. Veduta dei dossali di una “tavola” del refettorio
2. Bortolo Brasi, Intaglio con volute, motivi fitomorfi e composizione di fiori3. Bortolo Brasi, Intaglio con volute, motivi fitomorfi e composizione di frutta 4. Bortolo Brasi, Intaglio con volute, motivi fitomorfi e volatile
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 426 • • 427 •
5. Giovanni Marchiori, David e l’angelo sterminatore (Prudenza) - 6. Giovanni Marchiori, Sansone che abbatte le colonne del tempio (Fortezza)7. Giovanni Marchiori, Il giudizio di re Salomone (Giustizia) - 8. Giovanni Marchiori, Giuseppe che fugge dalla moglie di Putifarre (Temperanza)
9. Giovanni Marchiori, Madonna Immacolata e angeli recanti il giglio e la rosa 10. Giovanni Marchiori, Madonna Immacolata, par-ticolare 11. Giovanni Marchiori, Angelo con libro e faretra e angelo con arco e strale
ficare le attioni della figura”, “non siano communi, ed appli-cabili a molti corpi, ma quanto più si potrà ristrette al corpo assunto all’Impresa” e vogliono “esser brevi, sucose, e frizzan-ti” per non diminuire il “brio e leggiadria dell’Impresa”20. E, ancora, “possono i motti levarsi di peso da Poeti, Istorici, ed Oratori, o col medesimo senso, e concetto, col quale da loro son riferiti; o con mutatione, e ridotione dalla similitudine, e proposito usati da loro, ad altre similitudini, e pensieri”. Ma ciò non esclude “che non possano anco formarsi dall’ingegno di chi specola, e compone l’impresa”21. Deve il motto, insie-me con la figura, afferma quindi l’abate Picinelli, “significare semplicemente, ed esprimere una proprietà fisica, e naturale, ma non dire il concetto allegorico, e morale: poiché l’appli-
catione dell’Impresa non deve esser fatta immediatamente dal motto, ma dall’intelletto così di chi la compone, come di chi la considera, e l’osserva”22.
La serie “de’ simboli intagliati negli ornamenti del Refet-torio” si apre dunque con lo stemma del monastero, posto al centro della mensa sulla parete di fondo, sopra lo stallo dell’a-bate, vero e proprio fulcro prospettico e perno del programma decorativo-didascalico che da lì si dipana lungo i lati dell’aula, segnando i sessantatre stalli dei monaci. Consapevole, però, di come la lunga, ininterrotta serie di emblemi “avrebbe potuto annojare e l’occhio, e la mente di chi alla osservazione de’ medesimi applicato si fosse”, Girolamo Rosa, come si è sopra accennato, volle introdurre “nelle quattro maggiori nicchie”,
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 428 • • 429 •
poste tra i dossali nei due lati lunghi, in corrispondenza delle interruzioni delle mense, le quattro virtù cardinali, espresse “piuttosto che con loro simboli, con quattro storie cavate dal fonte inesausto della Sagra Scrittura”23.
E così, scolpiti nel legno in medaglioni a bassorilievo, racchiusi in cornici polilobate decorate da motivi floreali, troviamo gli episodi di David e l’angelo sterminatore24, con il vecchio re David che intercede per fermare il castigo di Dio sul popolo d’Israele – “Davide alzò gli occhi e vide l’angelo del Signore fermo tra la terra e il cielo, con in mano la spada puntata contro la città di Gerusalemme” (2 Sam 24, 16) – per illustrare la Prudenza (fig. 5); Sansone abbatte le colonne del tem-pio, la Fortezza (fig. 6); Il giudizio di re Salomone, la Giustizia (fig. 7); Giuseppe fugge dalla moglie di Putifarre, la Temperanza (fig. 8).
I tralci intagliati alla base di ciascuna scena alludono anco-ra alle quattro virtù: “l’Albero, o ramo del Moro corrisponde alla Prudenza; la Palma alla Giustizia; il Salice alla Temperanza,
e la Quercia alla Fortezza”25, come, avverte il Rosa, riporta Pierio Valeriano nei suoi Ieroglifici26.
In correlazione a questi ultimi fregi, con l’intento di ot-tenere “l’intiero compimento de’ simboli”, Girolamo Rosa dispose la realizzazione di un’ultima serie di ornamenti da porre nelle ulteriori tre ‘nicchie’ che si aprono tra i dossali. Quindi, secondo quanto lo stesso monaco riferisce, sotto lo Stemma del monastero (fig. 12) troviamo intagliati “Girasoli, e Gigli, per additare la contemplazione con quelli, con questi la purità, che sono due Virtù dello stato Monastico proprie”27. Sotto l’immagine della “Vergine Augustissima” (fig. 9-10) – posta nel mezzo, sul lato sinistro dell’aula, accompagnata dall’iscrizione Te Duce e da due putti recanti la rosa e il gi-glio, simboli che pure come l’immagine della stessa Vergine devono servire da ammaestramento28 – “si vede l’Oliva, et il cedro; piante dallo Spirito Santo adattate, nell’ecclesiasti-co, a significare le prerogative della sua Sagratissima Sposa”29. Infine – dalla parte opposta – “sotto il Pulpito, per alludere
12. Bortolo Brasi, Stemma del monastero; Giovanni Marchiori, Angelo con pastorale e angelo con mitria
13. Bortolo Brasi, Sole nell’eclittica, Fictus labor - 14. Sole nell’eclittica, Fictus labor (in P. Aresi, Delle Sacre Imprese, Tortona 1630) - 15. Bortolo Brasi, Fontana, Fortior e latebris - 16. Bortolo Brasi, Pozzo, Exercita purior - 17. Bortolo Brasi, Cicogna in atto di lacerare le Serpi, Conficiam - 18. Bortolo Brasi, Luna incorniciata, Completur cursu
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 430 • • 431 •
alla Lezione Spirituale, simboleggiata dagli Angeli collaterali”, uno recante il libro e una faretra e l’altro l’arco e lo strale30 (fig. 11), si trovano “fiori, e frutta; imperocché con la mede-sima, non meno si ricrea, di quello che si pasca lo spirito di chi da terreni pensieri si innalza, quanto è d’uopo per accorre le Frutta stesse, che abbondanti dalla Sagra lezione ci si pre-sentano”31.
Il refettorio morale, o sia spiegazione de’ simboli inta-gliati negli ornamenti del Refettorio maggiore del Mo-nastero di Praglia
L’illustrazione da parte di Girolamo Rosa “de’ simboli in-tagliati negli ornamenti del Refettorio” – che seguiremo a mo’ di guida – ha inizio con la descrizione dello stemma del monastero, sopra lo stallo dell’abate (fig. 12): “una stella, che sopra tre Monti risplende” con il motto “sub sidere ver-nant, quasi che co’ benigni influssi di quella, verdi, e fioriti mantengansi”; dunque, se vogliamo attendere alla verità del significato, “si deve da tali premesse inferirne, che lo splen-dore, e mantenimento di questo Monasterio non da altra stella dipende, che da Dio, quale nella Apocalisse (22, 16) è chiamato stella splendida, et matutina”32.
Dopo aver descritto lo stemma – “posto tra due Angeli, l’uno de quali tiene in mano un Baston Pastorale, a l’altro la Mitra, che sono le Abaziali insegne”33 – il Rosa passa quindi ad analizzare, uno a uno, seguendo la disposizione delle tavole, i successivi simboli34. Per ciascuno indica l’immagine che lo contraddistingue e il sottostante motto, chiarendone prima il significato letterale e di seguito l’allusione a una norma morale, riferita in primis alla vita monastica. In quest’opera di puntuale descrizione ed esegesi il monaco di fatto – avendo mutuato dagli “Autori”, come egli stesso per primo rive-la, buona parte dei simboli “con le loro spiegazioni” - salvo
poche eccezioni riprende alla lettera, o, più di rado, parafra-sandolo, il testo dell’abate Picinelli. Dal Mondo Simbolico, per ciascuna delle imprese da lì ricavate, attinge quindi non solo la spiegazione vera e propria, e l’eventuale commento, ma pure la larga messe di citazioni usate a supporto e a sostanziare il significato morale e religioso, citazioni tratte dalle Sacre Scrit-ture come dalla Regola di san Benedetto, dai testi dei Padri e Dottori della Chiesa (tra cui ricorrono spesso sant’Ambrogio, san Giovanni Grisostomo, san Pier Damiani e san Gregorio) come dagli scrittori latini, quali Virgilio o Seneca.
nella “Tavola di Prospetto”, a partire da sinistra, la prima impresa (fig. 13) – desunta dal Mondo Simbolico ma che l’aba-te Picinelli trae a sua volta della Sacre Imprese di monsignor Aresi (fig. 14) – mostra “Il Sole nella Eclittica”, col titolo Fictus labor, “additandoci, che pel continuo suo movimento non sente fatica veruna, ne timore gli apportano i favolosi mostri del Zodiaco, e insegna che chi cammina per la via della perfezione Religiosa, giammai non si stanca; ne per le insidie del Mostro infernale apprende timore […]”35. L’im-presa a seguire, con la scritta Terrena sordent ad accompagnare l’immagine, purtroppo scomparsa, dell’aquila “che affisa gli occhi nel sole”, sovente associata anche ad altri motti e volta a diversi significati36, è invece “documento ad ogni Fedele, ma molto più a qualunque Religioso, che dovrebbe tener sem-pre fissa la mente nel Sole Divino; e, in contemplando le sue infinite bellezze, distaccare il suo cuore da gli oggetti terreni […]”37. La raffigurazione, quindi, della fontana (fig. 15), col detto Fortior e latebris, “denota che la solitudine del Religioso ritiro serve a promuovere l’Anima all’altezza di purità, e di ogni altra virtù […]”38, mentre, dall’altro lato dello stemma abbaziale, l’immagine del pozzo (fig. 16), alla quale il Rosa associa il motto Exercita purior, vuole significare che “siccome l’acqua di questo quanto più si tiene in moto tanto ella è più perfetta, e salubre, così con l’esercizio delle virtudi si perfe-ziona maggiormente lo spirito […]”39. Di seguito la figura,
21. Bortolo Brasi, Pappagallo incatenato al trespolo, Servitute nobilior - 22. Pappagallo incatenato al trespolo, Servitute clarior (in G. Ferro, Teatro d’Imprese, Venezia 1623) - 23. Bortolo Brasi, Albero mezzo tagliato con la scure al tronco, Non uno concidit ictu - 24. Albero mezzo tagliato con la scure al tronco, Non uno ictu (in G. Ferro, Teatro d’Imprese, Venezia 1623) - 25. Bue da pascolo in un prato, Meliora quaero (in G. Ferro, Teatro d’Imprese, Venezia 1623) 26. Bortolo Brasi, La serpe in mezzo al fuoco, Tollit flamma virus
19. Bortolo Brasi, Panno tessuto dalla pietra d’amianto, Illaesus ardore nitet 20. Bortolo Brasi, Pianta innestata, Non sua dat poma
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 432 • • 433 •
sfortunatamente incompleta (fig. 17), della “Cicogna in atto di lacerare le Serpi” col cartello Conficiam – a variazione del motto “Conficere est animus”40 – “esprime la nimicizia della medesima co’ Serpenti”, osservata da Virgilio nelle Georgiche; e “da questa vien poi simboleggiata la perpetua nimicizia, quale deve ognuno avere contro de vizi, impegnando tutta la diligenza a fine di distruggerli […]”41. Infine, “la Luna incor-niciata, sotto di cui si legge Completur cursu, ci persuade che la perseveranza nelle virtù è necessaria per giungere al compi-mento delle medesime, quale da essa dipende […]” (fig. 18)42.
negli stalli delle tavole che seguono, lungo i due lati lunghi della sala, le immagini intagliate, ovvero i “corpi” di ogni singola impresa sono distribuiti in modo da stabi-lire una precisa corrispondenza tra ciascuna mensa a quella che sta di fronte (“accoppiandone quattro della medesima spezie”), cosicché ne risulti – come spiega lo stesso Rosa – un’armonia “donde non solo l’intelletto, per la varietà da loro sensi misteriosi, ma l’occhio ancora, per la loro dispo-sizione restasse appagato”43.
Dunque, laddove lo stallo di una tavola è contraddistinto da un determinato corpo “naturale” (che sia corpo celeste o elementare, quadrupede, pesce, serpente, pianta, fiore ecc.) o “artificiale” (come uno strumento matematico piuttosto che uno strumento musicale), nella tavola dirimpetto, in quattro casi almeno, viene posto in esatta corrispondenza un corpo affine, appartenente alla medesima specie44.
La prima impresa che scorgiamo volgendoci quindi alla “Tavola prima a Ponente” è rappresentata dal “Panno tessuto dalla pietra Amianto, quale nelle fiamme non si consuma, ma dalle macchie si purga” (fig. 19): proprietà questa espressa nel motto Illaesus ardore nitet – composto forse dallo stesso Rosa – a significare che “col superare gli ardori delle tentazioni, e preservandosi incontaminata anco fralle occasioni del male diventa più pura l’Anima, e và sempre maggior pregio acqui-stando”45. Accompagnata dal cartiglio Quoquo dirigar, seguiva poi l’immagine, ora scomparsa, del “Cavallo, che, tendendo il freno in bocca si mostra pronto à cenni di chiunque lo regga” a esprimere “la puntuale religiosa ubbidienza”46. Più oltre è posta “la Pianta innestata” (fig. 20), accompagnata dall’iscri-zione Non sua dat poma – suggerita al Rosa dal verso di Vir-gilio (Georgiche, 2, 80), “Miraturque novas frondes, et non sua poma”, in sostituzione del motto “non sua germina profert”, riportato dal Mondo simbolico – per esprimere l’insegnamento secondo cui “non dobbiamo gloriarci delle nostre virtuose, e meritorie operazioni, quali in vero non tanto sono nostre, quanto d’Iddio, in virtù del quale, e con l’aiuto della cui grazia le mandiamo ad effetto […]”47. Quindi, in posizione centrale, e di maggiori dimensioni, la rappresentazione del pappagallo incatenato al trespolo (fig. 21) con il titolo Servitu-te nobilior (“clarior” in Picinelli, per il resto ripreso alla lettera, e in Ferro, fig. 22), a dire che “la prigionia, e la tenacità de’ legami, entro a’ quali il Pappagallo è tenuto, anziché apporta-
gli danno veruno, il rendono più qualificato cogli ammaestra-menti, facendolo più nobile, che in se nol sarebbe” e quindi che “maggiore però si è la nobiltà, che acquistano i Religiosi, vivendo coi legami de’ voti annodati, e frà le strettezze de’ chiostri riservati a Cristo”48.
Completano questo gruppo di imprese “un albero mezzo tagliato con la scure al tronco” (fig. 23-24) con il motto Non uno concidit ictu, “che sono parole tolte da S. Gio: Grisosto-mo […], dove Egli ci persuade a replicare nelle Orazioni le nostre istanze, per impetrare da Dio l’adempimento […]”49. Poi l’immagine, perduta, del “bue che pascola in un prato” con scritto Meliora lego (“quaero” in Picinelli, come in Ferro, che il Rosa può aver in questo caso pure consultato, fig. 25) “per significare, che, siccome questo animale, quasi per così dire, scordatosi delle erbe da esso dianzi gustate, va facendo scelta delle migliori per cibarsene; così chi aspira a maggiore acquisto di spirituali profitti, non dee contentarsi del possesso di alcune virtù; ma colla ricerca, et esercizio delle altre mi-gliori promovere i suoi avanzamenti […]”50. Infine, “la Serpe in mezzo al fuoco” (fig. 26) con l’iscrizione Tollit flamma virus, la quale “inferisce che col fervore della Carità si dileguano i veleni degli odj, e col fuoco dello Spirito Santo si consuma il tosco della umana malizia […]”51.
Di fronte, nella “Tavola prima à Levante”, nell’ordine, la prima impresa vede raffigurata un’ara con un sacrificio (fig. 27) a cui è associato il motto Sine labe, essendo “superstiziosa diligenza del Gentilesimo il far scelta delle vittime che voleva sacrificare, perché fossero pure non meno da ogni macchia esteriore, che nette da qualunque infezione di viscere […]; da ciò” – spiega Rosa, che in questo caso amplia e arricchi-sce il testo del Mondo Simbolico – “i religiosi sono tenuti ad apprendere “con quale integrità custodire si debbano, pre-servandosi esenti da qualunque contaminazione ed umano difetto; mentre sono essi elevati non solo alla Figliolanza del vero Dio, per mezzo del Battesimo; ma sono in oltre vittime consegrate particolarmente al servigio dello stesso per via della loro Professione […]”52. A seguire l’immagine, perduta, del “Cervo, che fugge, con la freccia nel fianco”, accompa-gnata dal motto Comes individua – in Picinelli “E più duolsi” o “Haeret ubique”, come in Bargagli o in Ferro, dove tuttavia serve a esprimere altro concetto53 (fig. 28) – “per denotare che ovunque se n’vada, seco sempre porta la sua ferita, da cui vien agitato; tale si è il peccatore, che non può giammai fug-gire da rimorsi della propria coscienza […]”54. Quindi “l’Uva pendente dalla vite, ma appoggiata alla terra” (fig. 29) con il cartiglio Inhaerendo putrescam, simboleggia “l’Anima, quale coll’applicarsi alle cose terrene, non ne ricava che pregiudizi spirituali […]”55; accanto, la figura, ora mutila, del pavone, con il motto Vanum posthabet orbem, costituiva “l’immagine del vero servo di Dio che, postasi dietro le spalle ogni mon-dana vanità […]56; mentre la raffigurazione della vite la quale “se non vi si levino i tralcj infrottuosi, e superflui, rimane
27. Bortolo Brasi, Ara con un sacrificio, Sine labe - 28. Cervo che fugge con la freccia nel fianco, Et più duolsi (in S. Bargagli, Dell’Imprese, Venetia 1594) 29. Bortolo Brasi, Uva pendente dalla vite e appoggiata alla terra, Inhaerendo putrescam - 30. Bortolo Brasi, Vite, E vulnere ubertas 31. Bortolo Brasi, L’Alicorno, infilzato col corno in un albero, Praeproperum poenitet - 32. Bortolo Brasi, Fenice, Ardore foecunda
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 434 • • 435 •
sterile”57 (fig. 30), come accenna il detto sottostante E vulnere ubertas, serve ad indicare che “anco noi stessi […] dobbiamo staccare dal nostro cuore i tralcj de viziosi affetti, e desiderj men regolati, acciocché non perda l’anima la fertilità virtuosa, e non traligni in vane superfluità, e smoderatezze, essendo da noi purgata col mezzo della mortificazione […]”58. Proceden-do oltre, “l’Alicorno, infilzato col corno in un albero (il che gli suole succedere per colpa della sua precipitosa velocità)” (fig. 31), è segnato con il motto Praeproperum poenitet, - com-mutazione di “Consiliis inimica celeritas” del Mondo Simbolico – “per dimostrare quanto a chiunque riesca dannoso l’ope-rare con una inconsiderata prestezza, anzi che con maturo, e considerato consiglio […]”59; e, infine (fig. 32), “la scrizione Ardore foecunda, sotto la Fenice, che sta tra le fiamme, c’insegna che ove è acceso il fuoco della carità, ivi compare la copia, & la fecondità delle virtù, e delle buone operazioni […]”60.
Apre il gruppo delle imprese poste sugli stalli della “Ta-vola seconda a Ponente” l’immagine intagliata del Salterio (fig. 33). “Egli è mai sempre mutolo da se stesso […]; ma se avviene che ei sia battuto, rende un delicato concerto, ri-saltandone quel Sonus ex ictibus che gli è affisso per Lemma; non altrimenti noi pure, alorché siamo dalla Divina mano percossi, eccitiamo nel nostro cuore l’armonia di quelle virtù ch’egli per se non darebbe, se non fosse da quella destato […]”61. Segue “il Serpente che afferra con la bocca la propria coda, ed ha per motto Ad me redeo” (fig. 34, 36), impresa, che Picinelli desume dal trattato di Scipione Bargagli, che vuol significare “il tipo di chi attende alla cognizione di se mede-simo, della quale leggiamo presso S. Agostino […]”62. Di poi (fig. 35), “la Spongia in atto di scancellare le note musicali da una carta, col titolo: Meliora sequentur, addita che, levando dal nostro cuore i caratteri del vizio, e purgandolo colle lagri-me, iscopriremo noi nel medesimo le armoniose note della virtù […]”63. In posizione centrale, e dunque di dimensioni maggiori, è raffigurato un cammello (fig. 37, 39) che, quando “si sente abbastanza carico, da se medesimo si alza da terra, nel qual atto è introdotto a dire: Ne supra vires” – variante del più comune motto “no Puedo mas” (o “non posso più”) registrato da Picinelli e Ferro (fig. 40) – “simboleggiando la cautela, che deve usarsi da ognuno nel ricevere cariche, o nell’intraprendere che che sia, per non addossarsi peso supe-riore alle proprie forze […]”64.
Quindi si scorgono “la Calamita sopra una carta da navi-gare” (fig. 38), con il detto Monstrat iter, “vero simbolo della nostra Santa Regola, che fra le procellose burasche di questo mondo, sicuri ci guida al porto dell’eterna Beatitudine […]”65; “la Vipera, che prima di accostarsi alla Fonte per bere, depo-ne il veleno, proprietà contrassegnata nel cartello Jam virus evomuit” (fig. 41): da questa ne ricava Sant’Agostino motivo di ammaestramento “con l’inferirne quale disposizione ri-cerchisi all’Orazione, scrivendo a Giuliano: ‘Quemadmodum serpentis quoddam genus, cum it ad bibendum, priusquam ad
fontem veniat, omne venenum evomit ita Christianus, cum ad orandum accedit, omnem iracundiam, et odium proximi deponet’ […]”66; ed infine, qui appesa a una palma e posta al centro di un tripudio di trofei d’armi, la Tromba (fig. 42), a cui, “perché avvalora gli animi de’ combattenti”, è associato quale motto il verso di Virgilio (Eneide, V, 764) Vires animum- que ministrat, così da esprimere “la forza del buon esemplo, che dà coraggio per imitarlo […]”67.
Di fronte, nella “Tavola seconda a Levante”, la scelta e la disposizione delle imprese è nuovamente dettata dall’esigen-ze di porre in relazione visiva immagini di analoga natura. Dunque al salterio, dalla parte opposta dell’aula, risponde qui l’immagine intagliata dell’organo (fig. 43), con il sottostante motto Non ad choreas, che ricorda “a’ Religiosi, ch’essi non devono applicarsi a studj vani, a passatempi giocosi, ma con serietà operando, ed impiegandosi in esercizi di pietà, di van-taggio a se medesimi, e di edificazione al prossimo, hanno a dimostrare in ogni loro operazione, che sono tali, quali da Dio furono eletti per servire al di Lui onore […]”68. Segue la raffigurazione del Serpente “che lascia la spoglia in passando fralle spaccature di un sasso” con la scritta Novus exorior per indicare la “mutazione de costumi prescritta da S. Paolo”69 (fig. 44). Con il motto Rite, si saepe revisar (revisor), “l’Orolog-gio da ruote” (fig. 45) addita “la grande utilità del frequente esame della propria Coscienza, conosciuta non solo da Santi Padri, ma ancora, con il puro lume di natura dagli stessi an-tichi Filosofi […]”70.
In posizione centrale e dominante è l’impresa contraddi-stinta dal motto Sic ardua peto “che da alcuni Autori fu sopra-scritto all’Elefante, quale nelle acque si lava” (fig. 49) - si veda ad esempio, prima del Mondo simbolico, anche i Ragionamenti di Luca Contile71 (fig. 50) – nel nostro caso a dimostrare “che la purità dell’interno e la mondezza del cuore si è un mezzo efficace, per accingersi, e condurre a felice riuscita qualunque cosa noi siamo per intraprendere […]”72.
Una meridiana priva dello gnomone (fig. 46) significa che “non basta il Sole, che illumini l’Orologgio, per mostrar le Ore, se non vi sia lo stilo, quale con la propria ombra le segni” e a ragione dunque vi è il titolo Non lumine tantum, “quale esprime che poco rileva che il raggio della Divina grazia risplenda sul nostro capo quando manchi dal nostro canto il cooperarvi […]”73. Segue “un fascio di Erbe e fiori medi-cinali, intorno al quale vi è un serpente, porta il motto Ex utroque pharmacum, ed è il simbolo della sana prudenza, che sa cavare utilità da qualunque oggetto, buono e cattivo, santo o vizioso che ei sia […]” (fig. 47-48)74. Infine (fig. 51), “la Cetra, quale figurasi bene accordata, il che viene accennato dalla sua Iscrizione Nec una discors” – al posto del motto “Dissona, si discrepet una”, presente nel Mondo Simbolico – “si è l’idea dell’Uomo perfetto, che tale è costituito […] da una regolata unione di tutte le Virtudi […]: laddove per l’opposto, nella guisa appunto, che nella cetra una sol corda mal concertata
33. Bortolo Brasi, Salterio, Sonus ex ictibus 34. Bortolo Brasi, Serpente che afferra con la bocca la propria coda, Ad me redeo 35. Bortolo Brasi, Spugna in atto di cancellare le note musicali da una carta, Meliora sequentur 36. Serpente che afferra con la bocca la propria coda, Ad me redeo (in S. Bargagli, Dell’Imprese, Venetia 1594) 37. Bortolo Brasi, Cammello, Ne supra vires 38. Bortolo Brasi, La Calamita sopra una carta da navigare, Monstrat iter
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 436 • • 437 •
rende dissonante, ed ingrata l’armonia di tutte le altre, non altrimenti la trasgressione di un solo precetto sconcerta di tutte le altre Virtù l’armonia […]”75.
La serie delle imprese della “Tavola terza a Ponente” si apre quindi con l’immagine di un “Mazzo de Fiori” (fig. 52), a cui bene si adatta il motto Cito decident (nel Mondo Simbolico “In iuventute senescimus”), “poiché in esso vien figurata la brevità della vita umana, da cui cantò il Tasso nella Gerusa-lemme liberata: Così trapassa al trapassar d’un giorno / De la vita mortale il fiore, e il verde […]”76.
A seguire, un’orsa raffigurata nell’atto di passare la lingua sul suo piccolo (fig. 53), con il motto Lambendo reformat, poi-ché “non con la durezza, e la mordacità offensiva del dente, ma con la morbidezza, e soavità della lingua l’Orsa madre conduce i mostruosi suoi Parti alla perfezione”, dimostra “che la soave correzione ha più forza del soverchio rigore […]”77, mentre, accanto, “i due Globi, Celeste, e Terracqueo”, prima della scomparsa segnati col cartello Non nisi alterutrum, “ci ammaestrano che non si può essere insieme e corporale, e spirituale, e che non può godersi e della terra, e del Cielo, ma o l’uno o l’altro ci conviene scegliere […]”78. In posi-zione preminente, l’immagine quindi del Vitello Marino (fig. 54), che “quando il mare è più agitato dalle Tempeste, suole appoggiarsi ad un scoglio, ove prende saporiti, e quietissimi i sonni” – accompagnato perciò dal motto Tuto quiescit (“Sic quiesco” in Picinelli) – ci dice invece che “chi non aderisce a Dio, non potrà giammai ritrovare la vera quiete tra le procelle di questo mondo […]”79. Più oltre il Rosa pone “due corone assieme intrecciate, ma l’una di Spine, l’altra di Rose, con il titolo Non sine altera” (fig. 55): significano che “non si ottiene
la felicità senza il patimento, ciò che scriveva S. Paolo […]”80. Accanto, un leone che dorme con gli occhi aperti (fig. 56), per cui il motto sottostante Nec in somno quies, “è simbolo del Contemplativo, quale ne’ suoi riposi alza l’Anima a Dio e si solleva a i secreti del Cielo”81; ed infine (fig. 57) “la pianta di rose fiorite con il Lemma Ver integer annus, vuol dire che, siccome una specie di rose produce in ciaschedun mese i suoi fiori, quali conservano nel giro di tutto l’anno una ridente primavera, così coll’esemplo di queste, deve il vero Religioso fiorire nell’esercizio delle Virtù, non in un solo tempo deter-minato, ma in tutti i giorni della sua vita […]”82.
nella “Tavola terza a Levante”, secondo l’abituale schema di corrispondenze visive, Rosa pone quindi l’impresa formata da “alcune piante di fiori sotto le quali vi si nasconde il serpente” (fig. 58), unite al motto Subsident noxia, il quale allude “al pen-siere di Virgilio”, per argomentare “che sotto i mondani piaceri si nascondono i veleni, le amarezze, le morti […]”83. Ricalcata invece, come di consueto, da Picinelli, che a sua volta trae lo spunto da Giovanni Ferro, l’impresa accanto, mostrandoci “la Scimia, che, scorzando la noce, porti il titolo Intima, non exti-ma” (fig. 59), ci indica come, secondo l’insegnamento di San Girolamo, “lo studioso della sagre Scritture non deve appagarsi del loro senso esterno, che è la prima lettera, ma insinuandosi ad intendere gl’interni Misterj, ne caverà spirituale alimento di dol-cissima sostanza”84. Più oltre l’immagine di una bilancia a bracci uguali con il cartiglio Levatur altera (fig. 60), a illustrare che “se la bilancia da un capo si abbassa, in conseguenza si solleva dall’al-tro” lo stesso egualmente in noi succede, “imperocche quanto più con le mortificazioni e penitenze da noi viene il corpo depresso, viè più agile e pronto s’innalza a Dio lo spirito […]”85.
41. Bortolo Brasi, Vipera, Jam virus evomuit - 42. Bortolo Brasi, Tromba, Vires animumque ministrat
39. Bortolo Brasi, Cammello, Ne supra vires 40. Cammello, No puedo mas (in G. Ferro, Teatro d’Imprese, Venezia 1623)
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 438 • • 439 •
Al centro della serie campeggia quindi la figura di una sirena con il motto Dulcedine perdit (fig. 62), impresa il cui significato il Rosa, discostandosi dal dettato del Mondo Sim-bolico, così chiarisce: “Favoleggiarono i poeti che le Sirene con la soavità del loro canto addormentassero i passaggeri quali di poi nel mare affogati se li divoravano86, Ovidio così ne canta: Monstra maris sirenes erant, quae voce canora / Quamlibet admissas detinuere rates [Ars Amatoria, III, 311-312]”, per poi spiegare che “con uno di questi mostri si figurano le lusinghe non egualmente favolose che suole usare il mondo co’ suoi ade-renti, quali allora egli uccide, quando mostra di accarezzarli […]”87. Più oltre l’immagine incompleta del cannocchiale, il cui uso avvicina alla nostra vista “anco le cose più lontane”, accompagnata dal motto Propinquat dissita, serve ad ammae-strarci che “non v’ha forse cosa più lontana dalla mente de gli uomini, quanto la memoria, o la considerazione de’ Novissimi o seppure Ella è a taluno presente, la giudica di gran lungo rimota” ma “dovrebbersi per l’opposto, averla sempre sotto gli occhi in qualità d’imminente […]”88. Anch’essa imperfetta, la raffigurazione che costituisce il corpo dell’impresa succes-siva mostrava il cane che, “qualor tenti di sfogar i suoi sdegni contro de riccio spinoso, più gravi ei riceve le ferite da spini del medesimo, di quello, che co’ suoi denti ei imprime nello stesso”; ragione per cui ha per motto Sibi poena malum “vo-lendo significare che la malizia ridonda sempre in danno, e maggiore discapito del suo proprio autore […]”89. Infine (fig. 61), “una pianta di Rose con i fiori tutti racchiusi, ma vicini ad aprirsi, e che perciò è segnata con il motto Sub Sole pate-bunt, forma un simbolo che tutto quadra alle nostre segrete operazioni, o buone, o cattive, che sieno; mentre che queste, abbenche da noi fatte di nascosto, pure finalmente sotto il sole di Cristo Giudice nell’ultimo, e formidabile giorno compari-ranno isvelate, ed aperte in faccia di un Mondo intero […]”90.
Inaugura il gruppo delle imprese che segnano gli stalli della “Tavola quarta a Ponente” l’immagine del pesce (fig. 63), per la quale il monaco compone il motto In sicco moritur91, ché, “siccome vivono i pesci stando nell’abbondanza delle Acque, così all’opposto, ridotti in asciutto muoiono”: da cui se ne ri-cava che “i vizi, quali si fomentano tra le delicatezze e piaceri, tra le aridità del digiuno, e delle penitenze vengono meno […]”92. Segue la raffigurazione di un ramo di castagno con i suoi frutti racchiusi nel riccio (fig. 64): tal frutto “è spinoso, ed orrido se l’esterna sua corteccia si osserva, ma al didentro si fa conoscere ch’egli è quale il motto lo rappresenta” cioè Sub cortice mitis, e serve quindi a spiegare che “non altrimenti la regolare osservanza che a prima vista sembra rigida, et austera, riesce piena di dolcezza e di gioconda soavità […]”93. Sullo stallo successivo si poteva osservare l’immagine di un’allo-dola, caratteristica della quale è che “stando a terra, non mai articola il canto, ma allora solo forma le sue voci armoniose, quando per l’Aria verso il Cielo s’innalza”: da Rosa unita dunque all’iscrizione Elevata canit “servirà per dinotare che
l’Anima rattenuta dalle affezioni terrene è male atta al con-certo delle Divine lodi, ma che solamente allora può dare il canto di una fruttuosa Orazione quando sia sollevata in Dio […]”94. A seguire, in posizione centrale, sovrasta l’immagine dell’albero ricolmo di frutti (fig. 65), “quale più carico ch’egli è di frutta, tanto più abbassa i suoi rami”, con il motto Hu-milior quo onustior a voler dire che, similmente, “chi abbonda di vera virtù, tanto più è adorno di una eroica Umiltà”95. L’impresa costituita dall’immagine dello “Sparviere con uc-cello tra gli artigli” – ora perduta – e dal motto Non sibi, sed Domino, esprime a sua volta «l’idea del buon servo d’Iddio, che cerca sempre con ogni suo operazione, non il suo proprio vantaggio, ma quello del suo Signore, della maggior gloria di questo, e del profitto delle Anime […]”96; mentre “dalle pere corrose, e votate dalle vespe, con il cartello A parvo exitium si ricava di quanto nocumento sia il non temere i piccioli difetti mentre da questi ne provengono danni considerevoli […]”97 (fig. 66). Infine l’immagine scomparsa del coccodrillo, di cui “dicono gli Autori”, che, “quanto più vive, sempre più cresce”, accompagnata dunque dal cartello Jugiter crescit, per il Rosa “può significare il profitto spirituale, che non ha limita-zione veruna nella sua grandezza, ma si può sempre a maggior grado avvanzare […]”98.
Da ultima, la “Tavola quarta a Levante”, mostra per comin-ciare l’immagine del delfino (fig. 67), che “quando il Mare dal suo fondo commosso dà principio a procellosa tempesta […], spiccando su la superficie delle acque giulivi salti, non solamente scuopre eroica fortezza, ma dimostra inoltre effetti di giubilo”, da cui il motto In adversis exultat, così da offri-re l’idea “dell’Uomo Giusto che incontra con intrepidezza le sconvolte del Mondo […]”99. Accompagnata dal cartiglio Expressa probantur, è l’immagine delle melarance, di cui “si conosce […] il sapore in comprimendole” e “non in diversa maniera si fa conoscere la vera virtù tra le oppressioni e le miserie, il che pur bene insegnò Seneca […]”100 (fig. 68). Alla figura del drago, sfortunatamente perduta, il Rosa pone il motto Haud inficit astra, poiché “per quanto vomiti il Dragone quel suo pestifero alito, non può mai arrivare ad infettare i corpi celesti”, ad alludere che “tenti pure l’infernale mostro a suo talento le Anime giuste, che non mai ne riporterà la vittoria […]”101.
Al centro, l’immagine in scala maggiore di una palma con il motto Dulce cacumen (fig. 69) corrisponde alla figura dell’al-bero intagliata nello stallo di fronte. “Il tronco della Palma egli è di ruvida asprezza attorniato: ‘Aspera radix videtur in terra’, ne scrive S. Agostino; ma poi nella sua sommità, insegna Plinio, che è dolce, ‘Dulcis medulla in cacumine’. Di qui ne è preso il motto per questo arbore, quale non altro significa” – prosegue il monaco, sviluppando il concetto già presente nel Mondo Simbolico – “se non che non mai può arrivare al dolce delle Virtù di chi atterrito dalle prime difficoltà che vi si incontrano ne rittrae il piede […]”102. L’immagine dell’Idra
43. Bortolo Brasi, Organo, Non ad choreas44. Bortolo Brasi, Serpente, Novus exorior 45. Bortolo Brasi, Orologio, Rite, si saepe revisar46. Bortolo Brasi, Meridiana priva dello gnomone, Non lumine tantum 47. Bortolo Brasi, Fascio di erbe e fiori medicinali, intorno al quale vi è un serpente, Ex utroque pharmacum 48. Fascio di erbe e fiori medicinali, intorno al quale vi è un serpente, Pharmacum ex utrisque (in F. Picinelli, Mondo simbolico, Milano 1680)
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 440 • • 441 •
con accanto una torcia (fig. 70) ci suggerisce invece che “non averebbe bastato ad Ercole il troncare col ferro i capi dell’Idra se con il fuoco non avesse loro impedito il rinascere”, e alla fiaccola dunque, “che appiè di questo mostro si scorge, appar-tiene il detto: Renasci vetuit” e “moralmente significa la virtù di chi, volendo veramente assicurarsi dal velenoso mostro del peccato, ne distrugge con ogni studio le occasioni […]”103. Accanto, un paio di frutti in mezzo a dei fiori (fig. 71), con il motto Aspectus decipit, indicano che “sotto la vaga, e ben colorita corteccia si nasconde un frutto di acerbo sapore, o di corrotta sostanza”, impresa questa “quale serve di avverti-mento agli incauti, che dalle vane, ed esteriori apparenze delle cose ingannare si lasciano […]”104. Per finire, a ornare l’ultimo stallo si scorge l’immagine di un delfino tra i flutti attornia-to dai suoi piccoli (fig. 72), poiché “si legge che i piccioli Delfinetti spaventati dai tumulti delle tempeste rientrano in seno alla loro Madre” ed “effigiati pertanto in tale atto sono essi introdotti a dire: Spes una in reditu” – al posto di “Iterato introeunt” del Mondo Simbolico – “con che sono l’idea di que’ Peccatori, che agitati dalle tempeste de’ mali esterni, o da’
rimorsi della loro rea coscienza, ritornano in seno alla Divina Misericordia […]”, quale unica speranza di salvezza105.
“giugno 20//1726: si diede principio al lavoro delli schienali e tavole del refettorio del venerando mona-stero di Praglia”106
Dalle carte d’archivio emerge come, per il “lavoro delli schienali e tavole del refettorio”, nel corso di tre anni circa, a partire dal giugno del 1726, fosse all’opera a Praglia un piccolo drappello di intagliatori, ciascuno dei quali pagato a scadenze regolari per le proprie prestazioni. Si trattava in al-cuni casi di maestri certamente veneziani e tutti, eccetto uno, di cui ora si dirà, impegnati solo nell’esecuzione delle parti secondarie delle decorazioni107. Per la realizzazione degli inta-gli principali, come già ci rende noto Girolamo Rosa, furono infatti appositamente ingaggiati due distinti e rinomati artisti. È lo stesso monaco a svelarci, con un certo orgoglio, il nome del primo dei due, anch’egli nel novero dei maestri stabilitisi per l’occasione a Praglia, vale a dire quel “Bartolomeo Brasi Intagliatore Veneto” (come pure indicato nei documenti, e non Biasi, secondo quanto in seguito riportato anche da Glo-
ria108), dal cui “eccellente scalpello, in breve spazio di trè anni, a meravigliosa perfezione espresse furono le fin’ora dichiarate zifare” - ovvero le imprese –, “e le cime tutte, che sopra il cornicione son poste”109.
Dunque un artista veneziano, del quale non si conoscono altre opere al di fuori dei lavori di Praglia, ma comunque noto in virtù del fatto che il suo nome ricorre più volte tra le carte d’archivio relative all’arte degli intagliatori. In-fatti, oltre a comparire tra i membri della corporazione ne-gli elenchi dell’arte che vanno dal 1706 al 1733110, Bortolo Brasi è documentato già dal 1704 in relazione a una causa contro un collega111 e, ancora, nell’anno successivo per aver assunto, in qualità di capo mastro, un garzone presso la pro-pria bottega112; risulta presente, inoltre, verso la metà degli anni venti ai capitoli generali dell’arte nei quali concorre alle cariche, tra l’altro, di ‘sindaco’ e ‘tansador’113. Informazioni, benché parziali e sommarie, che ci restituiscono l’immagine di un maestro verosimilmente abbastanza affermato, a capo di un’avviata bottega – nella quale, oltre ad alcuni giovani garzoni, lavorava anche il figlio114 –, sicuramente attiva dall’i-nizio del Settecento e almeno fino alla prima metà del quarto decennio del secolo.
I documenti del monastero relativi ai lavori per il refet-torio registrano il nome dell’artista a partire dal 21 dicembre 1726, giorno in cui “Bortolo Brasi intagliator” riscuote l’ac-conto del suo salario, corrispondente, secondo gli accordi, a dieci ducati al mese115. La scelta da parte dei monaci di Praglia del maestro cui affidare la parte più impegnativa, certo quanto a mole di lavoro, della decorazione dei dossali doveva essere avvenuta poco più di un mese innanzi, ovvero quando verso la metà di novembre “mistro Mattias” marangon viene man-
dato a Venezia “per proveder un’intagliatore” in aggiunta al gruppetto già all’opera nel refettorio116. I pagamenti al Brasi si susseguono quindi anno dopo anno, intensificandosi tra il dicembre del 1729 e il gennaio dell’anno successivo, vale a dire in prossimità del compimento dell’intera serie delle imprese, che può ritenersi finalmente conclusa nel marzo del 1730 quando vengono registrate le spese relative all’acquisto di “oro per compire le cartelle” e alle prestazioni “dell’indora-tore per dar la vernice” alle stesse, nonché l’ultimo pagamento a “mistro Bortolo Brasi”117.
Impegnato fin da subito nella realizzazione degli intagli delle ‘cime’ dei dossali, e degli emblemi in particolare, dob-biamo immaginare il maestro all’opera sotto la sorveglianza attenta e costante di Girolamo Rosa, che, in quanto autore del programma decorativo didascalico, avrà senz’altro fornito precise indicazioni circa l’iconografia di ciascuno dei soggetti dei ‘corpi’ delle imprese; nondimeno, Brasi, oltre ad avvalersi di un proprio repertorio di motivi decorativi, avrà forse re-cepito qualche suggerimento per il disegno dei racemi, delle cornici e delle volute che contornano ogni singola immagine anche da fra Fortunato Abbiati autore, come si è detto, del progetto complessivo degli stalli118.
Poco più che cinquantenne, al tempo dei lavori per il re-fettorio119 Bortolo Brasi doveva essere ormai artista maturo ed esperto, come peraltro confermano la concezione e la qualità d’esecuzione degli intagli, che subito tanta ammirazione su-scitarono in Girolamo Rosa.
nell’osservare il succedersi delle singole imprese così come le serie di vasi di fiori, cesti di frutta o uccelli, che le precedono o accompagnano, immagini, le une come le altre, parimenti incastonate in racemi intessuti di inflorescenze o in volute che
49. Bortolo Brasi, Elefante, Sic ardua peto
50. Elefante quale nelle acque si lava, Sic ardua peto (in L. Contile, Ragio-namenti, Pavia 1574)
51. Bortolo Brasi, Cetra, Nec una discors
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 442 • • 443 •
52. Bortolo Brasi, Mazzo di fiori, Cito decident 53. Bortolo Brasi, Orsa, Lambendo reformat54. Bortolo Brasi, Vitello marino, Tuto quiescit 55. Bortolo Brasi, Due corone assieme intrecciate, l’una di spine, l’altra di rose, Non sine altera 56. Bortolo Brasi, Un leone che dorme con gli occhi aperti, Nec in somno quies 57. Bortolo Brasi, Pianta di rose fiorite, Ver integer annus
58. Bortolo Brasi, Piante di fiori sotto le quali si nasconde il serpente, Subsident noxia - 59. Bortolo Brasi, Scimmia in atto di aprire una noce, Intima, non extima - 60. Bortolo Brasi, Bilancia, Levatur altera - 61. Bortolo Brasi, Pianta di rose, Sub Sole patebunt
si arricciano sinuose, colpisce, da un lato, la ricchezza della de-corazione, esaltata dalla minutezza stessa degli intagli (ovvero la “delicatezza”, secondo le parole del Rossetti) che risponde alla minutezza del pensiero che vi è sotteso, dall’altro, la sublime armonia dell’insieme. Il movimento di queste composizioni, è stato infatti giustamente affermato, “tende a cadere in un ritmo regolare, simmetrico, bloccato anche se sottilmente valorizza-to”120. Le qualità e la perizia tecnica dimostrate dal Brasi negli intagli del refettorio, che superano “una capacità strettamente artigianale”, sono indicative, giusta l’analisi della Spiazzi, “di un gusto non più attardato su schemi barocchi turgidamente pesanti, bensì di un gusto aggiornato, e molto puntualmente, sull’evolversi della cultura figurativa dal barocco al rococò, ario-samente leggero e brioso”121.
Girolamo Rosa riferisce che alla competenza nell’ar-te dell’intaglio Bortolo Brasi “accoppiò altre singolari dotti morali, tra esse una modestia rarissima in occultare la propria perizia”; fu dunque a causa di ciò “che sul principio del di
Lui lavoro, per non esserne anco nota la sua abilità, si ordinò ad altro Artefice, che effigiasse l’Immagine della Vergine Sa-crosanta, con li sei Angeli, e li scudi delle quattro accennate Medaglie”; ma come Brasi “superò di gran lunga l’aspettazio-ne, che uscì intorno alle sue opere concepita, così l’arte del secondo fù egualmente inferiore alle larghe promesse, ed alle corrispondenti speranze quali sopra questo fondate si erano”. E, conclude il monaco, “Dio volesse, che non altra mano, che quella dell’accennato signor Biasi [sic] impiegata si fosse nel compimento degli ornamenti di questo Refettorio, quali all’ora senza verun difetto comparirebbero”122.
L’“altro Artefice” coinvolto nell’esecuzione dei princi-pali intagli, ovvero l’artista di cui il Rosa tace volutamen-te il nome, viene menzionato a chiare lettere in una nota di pagamento, inspiegabilmente sfuggita a coloro che fino a oggi, occupandosi dell’argomento, hanno visionato le carte d’archivio relative ai lavori del refettorio, nella quale si legge che in data 9 maggio 1728 viene corrisposto l’ammontare di
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 444 • • 445 •
374 lire “al signor Marchioris scultore” – ovvero Giovanni Marchiori – “per n. 6 Angeli, l’imagine della Beata Vergine, e quatro medaglie”.
Tale dato d’archivio doveva un tempo essere comunque ben noto quantomeno all’interno della comunità di Praglia, se Camillo Semenzato, indicando nello scultore agordino l’autore della decorazione a intaglio del refettorio – nella sua interezza tuttavia, non essendogli noto il testo di Girolamo Rosa che testimonia l’intervento del Brasi –, scrive infatti che “una vecchia tradizione accenna al Marchiori”. Sulle orme del Semenzato e verosimilmente ricollegandosi a questa stessa ‘tradizione’, il nome dello scultore, questa volta correttamente riferito ai soli intagli di sua spettanza, è stato quindi senza indugi avanzato anche da Anna Maria Spiazzi e più tardi ri-badito da Giovanna Galasso123. Diversamente, a poca distan-za di tempo, Massimo De Grassi – incautamente seguito da Andrea Bacchi124 – ha invece creduto di dover espungere dal
catalogo del Marchiori i lavori pragliesi (e verrebbe a questo punto quasi da pensare che la damnatio memoriae sentenziata dal monaco abbia trovato nella critica più recente dei no-velli e inconsapevoli fautori), sia in ragione della presunta assenza di precise indicazioni documentarie sia “per il dato più propriamente stilistico”125, anche se in verità le figure e i rilievi realizzati da Marchiori per Praglia palesano una totale sintonia con il linguaggio formale che contraddistingue le opere appartenenti alla prima produzione nota dell’artista, antecedente gli anni quaranta del Settecento.
Al tempo già affermato intagliatore in legno e scultore in pietra, Marchiori, nel corso del 1727, non molti mesi prima dal suo intervento per il refettorio, stava realizzando per con-to dei monaci di S. Giorgio Maggiore a Venezia “l’Angelo di legno” da porre alla sommità del nuovo campanile126 - al cui progetto di ricostruzione pare avesse collaborato anche fra Fortunato Abbiati –, circostanza che può probabilmente aver offerto l’occasione per il successivo incarico da parte dei benedettini di Praglia.
In quegli stessi anni l’attività nel campo dell’intaglio li-
gneo di Marchiori, che proprio nel 1728 sarà eletto gastaldo dell’Arte127, è testimoniata anche dalla sua presenza – attestata da una nota del 9 giugno 1727 – nel novero dei “capi mistri” intagliatori impegnati, sotto la direzione di Antonio Corra-dini, a condurre a termine la decorazione ad intaglio della prua, della poppa e de “l’intiero soffito” del nuovo bucinto-ro128; delle decorazioni che ornavano l’imbarcazione distrutta a fine secolo dai francesi, all’artista potrebbe tra l’altro spetta-re, secondo quanto indicano i caratteri stilistici, la cosiddetta ‘valva’ dorata con la figura a rilievo di San Marco Evangeli-sta, conservata al Museo Correr129. Quanto ai lavori in legno compiuti da Marchiori negli anni immediatamente successivi, completamente perduti sono gli intagli dei due “peatoni” do-gali, eseguiti dall’artista per incarico del Senato veneziano nel 1733130, così come le decorazioni eseguite dopo il 1736 per gli armadi della stanza attigua alla sala della Libreria Pubblica, il cui soffitto venne decorato con stucchi di Abbondio Stazio e Carpoforo Mazzetti Tencalla131.
Distrutto, con il crollo del 1774, l’Angelo posto sul campa-nile di S. Giorgio, le opere realizzate da Marchiori per Praglia andranno pertanto meglio avvicinate ai primi lavori noti in marmo, risalenti però tutti agli anni trenta del Settecento132, sebbene l’artista fosse attivo come scultore in pietra sicura-mente già dagli inizi del decennio precedente, tenuto conto che nel 1723 risulta già iscritto al neonato collegio degli scultori.
La statua dell’Immacolata costituisce indubbiamente, in relazione al contributo di Marchiori per la decorazione del refettorio, l’opera di gran lunga più significativa e meglio riuscita; alla nobile ed elegante figura, che si staglia contro la parete, al centro dell’aula, lo scultore imprime un moto di avvitamento spiraliforme, quasi uno scatto improvviso e vigoroso. Per la complessione della figura e per la medesima sensibilità con cui è trattato il panneggio, l’immagine della Vergine può essere facilmente accostata alla Santa Giuliana Falconieri scolpita nel 1738 per la chiesa dei Servi a Venezia,
63. Bortolo Brasi, Pesce, In sicco moritur - 64. Bortolo Brasi, Ramo di castagno, Sub cortice mitis 65. Bortolo Brasi, Albero ricolmo di frutti, Humilior quo onustior - 66. Bortolo Brasi, Pere corrose, A parvo exitium
62. Bortolo Brasi, Sirena, Dulcedine perdit
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 446 • • 447 •
ora nella parrocchiale di Fratta Polesine; ancor più puntuali appaiono i rapporti, in ragione di un analogo disporre le pieghe delle vesti, del profilo e della resa minuta del volto come della stessa definizione della capigliatura, tra la figura di Praglia e la statua con la Fede nella chiesa di S. Maria Maddalena di Treviso, da datarsi, per motivi stilistici, agli stessi anni trenta del Settecento. Stesse consonanze sussisto-no, inoltre, tra l’Immacolata e i due angeli adoranti dell’al-tare del Santissimo Sacramento della chiesa di S. Eufemia a Rovigno, scolpiti entro il 1739 e giustamente assegnati allo scultore agordino da Klemencic133, e per i quali la scultura di Praglia costituisce ora un nuovo e significativo termine di confronto.
Se gli angioletti paffuti scolpiti da Marchiori per il refetto-rio – a loro volta strettamente imparentati con la coppia di putti posta sotto la mensa del medesimo altare di Rovigno e con il Putto con libro, firmato, già sul monumento a Pietro e Lorenzo Morosini a San Clemente in isola e ora al Museo diocesano di Venezia134 – mostrano, al pari dell’Immacolata, il fare sicuro e disinvolto dell’artista, i rilievi intagliati sugli scudi, come pure è stato osservato, appaiono invece assai deboli, soprattutto se raf-frontati ai più tardi bassorilievi con Storie della vita e dei miracoli di san Rocco dell’omonima Scuola Grande, realizzati tra il 1741 e il 1743135. In questi lavori per San Rocco l’artista agordino, sfoggiando ormai un’acquisita dimestichezza con la tecnica del rilievo, articola le scene con misura ed equilibrio e rivela altresì una cura particolare nella definizione delle figure, finemente intagliate, e nella descrizione degli stessi sfondi paesistici. Per contro, nei rilievi di Praglia tutto è trattato in modo più som-mario e corsivo, a partire dall’ambientazione, pressoché assente, fino alle figure, rese in modo alquanto schematico, tanto da po-ter comprendere, in parte almeno, la delusione e l’atteggiamen-to critico di Girolamo Rosa. A prima vista questi potrebbero apparire lavori acerbi di Marchiori, ma è più probabile invece che lo scultore, al tempo sicuramente già esperto anche nella tecnica a rilievo, abbia affidato l’esecuzione delle quattro scene allusive alle virtù cardinali a collaboratori di bottega, tanto che le figure che le animano sono meglio avvicinabili proprio alle parti secondarie della decorazione plastica dell’altare di Rovi-gno, indubbiamente spettanti alla bottega, ovvero ai due angeli posti sul timpano (e, in tal senso, si veda, ad esempio, come coincida il disegno più schematico e secco dei panneggi o la definizione compendiata dei lineamenti nei volti). È pur vero che non mancano, nei rilievi intagliati per i ‘medaglioni’ del refettorio, anche elementi tipici del linguaggio formale dello scultore, alla stregua di cifre stilistiche distintive, quali il disten-dersi e il ripiegarsi quasi geometrico delle lunghe stoffe che, infatti, ritroviamo anche in talune scene intagliate a S. Rocco.
L’intervento di Marchiori a Praglia rappresenta di fatto un ulteriore tassello per ricomporre la fisionomia dell’atti-vità dell’artista e comprenderne il linguaggio antecedenti gli anni quaranta del Settecento, quando la sensibilità classici-
stica dello scultore andrà ancor più affinandosi, in un clima di rinnovato interesse per l’antico, sotto l’impulso – come è stato più volte osservato – della pubblicazione dei due vo-lumi Delle Antiche Statue Greche e Romane dei cugini Zanetti e delle teorie di Francesco Algarotti, amico e committente dello scultore.
Il San Girolamo di Giovanni Bonazza
Circa tre lustri prima dell’avvio dei lavori di rinnovo del refettorio, era stato inaugurato il monumentale scalone in pietra d’Istria che, su modello di quello longheniano del mo-nastero veneziano di San Giorgio Maggiore, dal chiostro bo-tanico sale all’appartamento dell’abate136.
Qui, in posizione privilegiata, all’interno di una nicchia po-sta nel punto in cui, ascesa la prima rampa, lo scalone si biforca, campeggia una statua in pietra d’Istria raffigurante, secondo un’iconografia consolidata, San Girolamo in veste di eremita penitente (fig. 73). Il santo – che prima di intraprendere il viag-gio in Oriente, dedicandosi a un’esistenza ascetica nel deserto vicino ad Antiochia, aveva scelto la vita monastica – è, infatti, rappresentato come un vegliardo seminudo e con una lunga barba, coperto solo da un manto che scende dal capo, accom-pagnato da alcuni degli attributi precipui legati alla sua figura di anacoreta: il teschio, simbolo della vanitas e della meditazione sulla morte, posato sul libro che allude ai numerosi suoi scritti esegetici e all’impresa della Vulgata; la clessidra – distesa ai piedi della figura – che, come strumento di misurazione del tempo, pure richiama al tema della meditazione sulla caducità delle cose terrene; il serpente, il quale fa capolino proprio sopra la clessidra, simbolo del demonio insidioso, pronto a tentare l’e-remita nel deserto, e perciò sovente associato, come in questo caso, a Girolamo137.
È ipotizzabile che in origine l’eremita ostentasse tra le dita della mano destra – le quali sono state palesemente, e mala-mente, rifatte, forse in occasione di un vecchio restauro della statua (ora la mano sembra trattenere, tra indice e pollice, una sorta di bulbo oculare) – o la pietra con cui soleva percuotersi il petto in segno di penitenza o, molto più probabilmente, la penna utilizzata per l’opera di trascrizione della Bibbia.
Camillo Semenzato138 ha giustamente riconosciuto in quest’opera la mano di Giovanni Bonazza, uno dei maggiori rappresentanti della scultura veneta barocca, pur erronea-mente indicando quale soggetto della statua la personifi-cazione del Tempo, probabilmente tratto in inganno dalla presenza della clessidra e dando così seguito a una singolare e fortunata tradizione locale139 (e nello stesso equivoco è curiosamente incorsa la critica in relazione a un’altra ope-ra dello stesso scultore, posta nel Monumento Valier nel-la basilica veneziana dei SS. Giovanni e Paolo, raffigurante in verità l’allegoria dello Zelo (fig. 74) opera, nondimeno,
67. Bortolo Brasi, Delfino, In adversis exultat 68. Bortolo Brasi, Melarance, Expressa probantur 69. Bortolo Brasi, Palma, Dulce cacumen 70. Bortolo Brasi, Idra con la torcia, Renasci vetuit71. Bortolo Brasi, Frutti, Aspectus decipit72. Bortolo Brasi, Delfino tra i flutti con i suoi piccoli, Spes una in reditu
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 448 • • 449 •
73. Giovanni Bonazza, San Girolamo. Abbazia di Praglia, scalone monumentale
74. Giovanni Bonazza, Zelo. Venezia, basili-ca dei Santi Giovanni e Paolo, Monumento Valier
75. Giovanni Bonazza, San Girolamo. Rovigno, convento francescano
stilisticamente e cronologicamente prossima alla statua di Praglia140). Semenzato ha ritenuto, altresì, di poter datare l’opera al secondo decennio del Settecento141, anche se una datazione circoscritta ai primissimi anni di tale decennio appare tuttavia ancor più opportuna, tenuto conto che lo scalone risulta terminato nel 1712142.
Lo scultore veneziano aveva affrontato più volte nel corso della propria carriera il medesimo tema del san Girolamo ri-tratto in veste di penitente nel deserto e, come nella statua di Praglia (che pare anche memore dell’omonima figura di Ales-sandro Vittoria nella basilica veneziana dei Frari), il soggetto viene sempre trattato da Bonazza con analoghi esiti stilistici, accomunati da un’eguale resa tormentata del corpo emaciato e pur possente dell’eremita, e secondo un’iconografia che pre-vede la presenza dei medesimi tradizionali attributi associati alla figura del santo, anche se di volta in volta scelti e tra loro associati sulla base del variare delle composizioni. Varrà dunque la pena, a titolo d’esempio, accostare la statua dello scalone al San Girolamo penitente del convento dei francescani di Rovigno (fig. 75) ove il santo eremita è raffigurato disteso sulle rocce, poggiato al leone (altro suo attributo), ripreso, come a Praglia, in meditazione sul teschio posato sul libro, mentre ai piedi della figura è deposto il calamaio; oppure, all’analogo San Girolamo, pure disteso, della Biblioteca universitaria di Padova, ritratto mentre è intento alla lettura della Scritture143.
Alla mano di Giovanni Bonazza sono state recentemente
ricondotte alcune sculture realizzate per il giardino della villa di proprietà della famiglia Rosa a Tramonte di Teolo, nei pres-si di Praglia, ovvero due figure virili poste sui pilastri di un cancello d’ingresso e i due busti raffiguranti Francesco Petrarca e Laura, ora collocati nel retro dell’edificio144. non so se sia lecito, ma è fin troppo ovvio immaginare che a proporre l’ar-tista per l’incarico di scolpire la statua di San Girolamo per il nuovo scalone del monastero sia stato proprio un membro di quella famiglia, quel Girolamo Maria Rosa appunto che tanta parte avrà negli anni a venire nell’invenzione degli intagli del refettorio di Praglia145.
note
1 G.B. Rossetti, Descrizione delle pitture, sculture, ed architetture di Padova, con alcune osservazioni intorno ad esse, ed altre curiose notizie, di Giovambattista Rossetti, Padova 1780, p. 362. L’assoluta rilevanza della decorazione ad intaglio del refet-torio è ancora testimoniata verso la metà del secolo successivo dalle parole di Pietro Selvatico il quale, discorrendo su Praglia, non può sottrarsi dal ricordare ampiamente tali lavori pur additandoli quale massimo esempio del presunto cattivo gusto dell’età barocca: “Anche il cenobio di Praglia ebbe a tollerare la mortifera peste; ed il miasma letale che non potea impodestarsi colà né della architettura, né della pittura, perché l’una e l’altra, conservatissime mostrandosi non permettevano d’essere insozzate dai novelli ornamenti dell’età malata penetrò nel refettorio, ghermì le panche che doveansi rinnovare (era l’anno 1728) e per opera di certo Biasi intagliatore di Venezia, menò orrendo strazio del povero legno di noce destinato ad ornarle. E quasi non bastassero i barbari fogliami ed i ricci che erano in moda allora, venne un Padre del monastero a farvi aggiungere un subbisso d’emblemi morali, oscuri, puerili, degni dell’età che ancora bagnava co’ soli ed asciugava co’ fiumi. Di codesta stramba simbolica se ne compiaque il buon Padre come d’opera insigne e ne publicò un opuscolo a fine di illustrarla: fece forse bene, giacché senza tale aiuto non sarebbe age-vole decifrare que’ logogrifi” (P. Selvatico, Il monastero di Praglia, in Ricordi sui
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 450 • • 451 •
colli Euganei. Illustrazioni storico-artistiche. Strenna del Giornale euganeo, [Padova] 1846, p. 45).
2 I documenti conservati presso l’Archivio dell’abbazia di Praglia (AAPr) attestano che i lavori presero avvio nel giugno 1726 (millesimo che corri-sponde alla data incisa sotto lo stemma del monastero posto sopra lo stallo dell’abate), preceduti, a partire dal febbraio dello stesso anno, dall’acquisto dei legnami e dalla realizzazione dei disegni cui pure si è fatto cenno, e si concluse-ro tra il dicembre 1729 e il 15 gennaio 1730, data alla quale risalgono gli ultimi pagamenti (AAPr, caps. 13, Documenti relativi alle fabbriche, ornamenti, pitture ec. Della chiesa, e monastero di Santa Maria di Praglia. Dall’anno 1470 all’anno 1790 circa, c. 62-69); per un più dettagliato resoconto dei lavori effettuati e delle diverse maestranze impegnate, basato sul medesimo materiale documentario, cfr. A.M. Spiazzi, Il refettorio grande, in Praglia 1985, p. 160. Va ancora ricordato che il rinnovo del refettorio fu reso possibile anche grazie alle donazioni dei singoli monaci: alla munificenza dell’abate stesso si aggiunsero le donazioni di vari monaci dimoranti nell’abbazia di Praglia o in altre sedi (cfr. ancora Spiazzi, Il refettorio grande, p. 160).
3 Dai documenti risulta infatti che, il 22 marzo 1726, 63 lire vennero “contate per mancia a F. Fortunato da Venezia comesso in Santa Giustina per aver fatto il disegno delli schenali e tavole” (AAPr, caps. 13, Documenti, c. 62 r.; cfr. anche Spiazzi, Il refettorio grande, p. 160). Come già segnalava la studiosa (ivi, p. 163 nota 7), a fra Fortunato Abbiati (1698-1774), incisore e architetto, spettano, tra l’altro, anche alcuni disegni per la costruzione dei nuovi armadi della sacrestia, mai realizzati, e gli è stato riferito il progetto di parte dei lavori di rinnovo, avviati tra 1726 e 1728, del campanile di S. Giorgio Maggiore a Venezia, crollato nel 1774 (ma al riguardo vedi anche P. Rossi, Per gli inizi di Giovanni Marchiori scultore in legno: note d’archivio, in Per l’arte da Venezia all’eu-ropa. Studi in onore di Giuseppe Maria Pilo, a cura di M. Piantoni, L. De Rossi, Monfalcone 2001, II, p. 489). Per quanto ora ricordato e, più in generale, su Fortunato Abbiati cfr. inoltre F.L. Maschietto, Fra Fortunato Abbiati benedettino (1698-1774 ): ingegno versatile e benemerito di Corbezzola, Padova 1993.
4 G.M. Rosa, Il refettorio morale, o sia spiegazione de’ simboli intagliati negli ornamenti del Refettorio maggiore del Monastero di Praglia rinnovato dal Reverendis-simo P.D. Alberto Angeli nel suo secondo Reggimento; ritrovati, disposti, e dichiarati da D. Girolamo Maria Rosa padovano Monaco Professo del Monastero suddetto l’an-no MDCCXXVII, manoscritto (c. 228-248) inserito all’interno del fascicolo intestato Documenti… (AAPr, caps. 13). A lungo rimasto inedito il testo sarà pubblicato a cura di C. Buzzoni, preceduto da cenni biografici sull’autore, in Per le felicissime nozze Leva-Rosa, Padova 1864.
Vedova annota che “Rosa (Girolamo), di nobile famiglia, abbracciò lo stato monastico dell’Ordine di san Benedetto nel convento di Praglia”; aggiunge, infine, che “questa onorata famiglia, che oggidì ancora fiorisce, è fregiata del titolo di Conte” (G. Vedova, Biografia degli scrittori padovani, Padova 1832, II, p. 172-173). Sulla famiglia Rosa vedasi ora F. Benucci, Charles Patin: la casa, gli ultimi anni di vita a Padova, la famiglia, “Quaderni per la storia dell’Università di Padova”, 41, 2008, p. 55-67. Su Girolamo Maria Rosa vedasi ancora, per ulteriori notizie, Spiazzi, Il refettorio grande, p. 163 nota 9.
5 Rosa, Il refettorio morale, c. 230v.6 Per un’illustrazione sintetica ma efficace relativa alla storia, alle caratte-
ristiche e all’uso dell’impresa si veda L. Squillaro, Dalle imprese rinascimentali al logo commerciale. Le imprese rinascimentali: un sistema polisemico, in L’originale assente. Introduzione allo studio della tradizione classica, a cura di M. Centanni, Milano 2005, p. 277-306. Per approfondimenti si rinvia, oltre alla trattatistica dei secoli XVI e XVII che si troverà di seguito citata, a R. Klein, La théo-rie de l’expression figurée dans les traités italiens sur les “Imprese” (1555-1612), “Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance”, XXVI, 1957, p. 320-341; M. Praz, Studies in Seventeenth Century Imagery, London 1964; G. Innocenti, L’immagine significante, Padova 1981; A. Maggi, Identità e Impresa Rinascimen-tale, Ravenna 1998; G. Arbizzoni, Un nodo di parole e di cose: storia e fortuna delle imprese, Roma 2002.
7 “[…] donde non solo l’intelletto, per la varietà da loro sensi misteriosi, ma l’occhio ancora, per la loro disposizione restasse appagato” (Rosa, Il refettorio morale, c. 229v).
8 Si pensi, solo per citare alcuni dei principali, a testi quali: P. Giovio, Dia-logo dell’imprese militari et amorose, di monsignor Giovio vescovo di Nocera. Con un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, Vinegia 1556; G. Ruscelli, Le imprese illustri con espositioni, et discorsi del Sor. Ieronimo Ruscelli, Venetia 1566; L. Contile, Ragionamento di Luca Contile sopra la proprietà delle im-prese, con le particolari de gli Academici Affidati, et con le interpretationi et croniche [...],
Pavia 1574; B. Pittoni, Imprese nobili et ingeniose di diversi prencipi, et d’altri personaggi illustri nell’arme et nelle lettere: le quali, col disegno loro estrinseco, dimo-strano l’animo, et la buona ò mala fortuna de gli Autori loro / con le dichiarationi in versi di M. Lodovico Dolce & d’altri, Venetia 1583; C. Camilli, Imprese illustri di diversi coi discorsi di Camillo Camilli, et con le figure intagliate in Rame di Gi-rolamo Porro Padovano, Venetia 1586; G.C. Capaccio, Delle imprese. Trattato di Giulio Cesare Capaccio. In tre libri diviso. Nel primo, del modo di far l’impresa da qualsivoglia oggetto, o naturale, o artificioso con nuove maniere si ragiona. Nel secondo, tutti ieroglifici, simboli, e cose mistiche in lettere sacre, o profane si scuoprono; e come da quegli cavar si ponno l’imprese. Nel terzo, nel figurar degli emblemi di molte cose naturali per l’imprese si tratta, napoli 1592; S. Bargagli, Dell’imprese di Scipion Bargagli gentil’huomo sanese. Alla prima Parte, la Seconda, e la Terza nuovamente aggiunte: dove; doppo tutte l’opere così scritte a penna, come stampate, ch’egli potuto ha leggendo vedere di coloro, che della materia dell’Imprese hanno parlato; della vera natura di quelle si ragiona, Venetia 1594; G. Ferro, Teatro d’Imprese di Giovanni Ferro all’Ill:mo e R.mo S.r Cardinal Barberino Parte Prima, In Venetia 1623; P. Aresi, Delle Sacre Imprese di Monsig.r Paolo Aresi vescovo di Tortona. Libro quarto, Tortona 1630; sino a F. Picinelli, Mondo simbolico o sia università d’imprese scelte, spiegate, ed illustrate con sentenze, ed eruditioni sacre, e profane. Studiosi diporti dell’abbate D. Filippo Picinelli milanese ne i Canonici Regolari Lateranensi Teologo, Lettore di Sacra Scrittura, e Predicatore Privilegiato. Che somministrano àgli Oratori, Predicatori, Accademici, Poeti &c. infinito numero di concetti. Con indici copiosissimi, Milano 1653.
9 Il testo del Picinelli, che – come è stato osservato (Squillaro, Dalle im-prese, p. 282) – costituisce la summa delle teorizzazioni sul genere tra XVI e XVII secolo, muove da una volontà ben precisa, che lo stesso autore dichiara nel proemio, ovvero predisporre un’opera utile a “oratori, predicatori, acca-demici e poeti”, i quali avessero necessità, per esprimere i propri concetti, “di metafore o di immagini alla cui formulazione le imprese potevano utilmente servire” (ibidem); la presenza, in coda al volume, di un articolato sistema di in-dici, rendeva il testo dell’abate milanese di facile consultazione per chi volesse servirsene, come nel nostro caso, per attingere a specifiche imprese ed elabo-rare un proprio programma didascalico. L’edizione da noi consultata, a cui di seguito si farà riferimento, è F. Picinelli, Mondo simbolico formato d’imprese scelte spiegate et illustrate conferenze, ed eruditioni Sacre e Profane; in questa nuova impres-sione dall’autore accresciute sopra al numero di Cinquecento alle quali s’è aggionto il suo proprio Indice, studiosi diporti dell’abate Filippo Picinelli milanese nei Canonici Regolari Lateranensi Teologo, Lettore di Sacra Scrittura, e Predicatore Privilegiato. Che somministrano á gli Oratori, Predicatori, Accademici, Poeti &c. infinito numero di concetti. Con indici copiosissimi. All’Illustriss. e Reverendiss. Sig. Sig.e Patron Col. il Sig. Abbate D. Gio. Battista Meazza governatore per N. S. Innocenzo XI. Della Città della Pieve &c., Milano 1680.
10 Picinelli, Mondo simbolico, cfr. l’introduzione “Compendioso trattato della natura dell’imprese”, al capitolo “Ciò che sia impresa, e come si deffi-nisca”.
11 Ibidem.12 “Da gli Emblemi, poiché se questi ammettono ogni sorte di figure, intie-
re e spezzate, reali, e immaginarie, favolose ed istoriche, perfette e mostruose […], perfettamente significando, ò con le figure sole, ò con le parole, le quali precisa, ed espressamente dicono il concetto morale, che nelle figure si rap-presenta: l’Impresa e sceglie più ristrettamente i suoi corpi […] e significa parzialmente, deducendo i sensi, dalla corrispondenza, che il corpo, ed anco il motto scambievolmente tengono frà loro. Da i simboli, che la dove questi […] altro non sono, che un detto sententioso, il quale in sembianza d’un enimma è significativo di qualche documento, o mistero […]; l’impresa oltre le parole, vuole il corpo; e le parole sue le richiede non di sentenza perfetta, ma dimez-zata. Da i Geroglifici in somma, non essendo questi che schiette figure, le quali senza aggiuntione veruna di parole significano […] la dove l’impresa vuole esser formata di figura, ma non sola; di parole ma non sole; ma composta, e di figure, e di parole ancora, ciascune delle quali partialmente concorrono ad un senso perfetto” (Picinelli, Mondo simbolico, cfr. l’introduzione “Compendioso trattato della natura dell’imprese”, al capitolo “Ciò che sia impresa, e come si deffinisca”).
Analogamente per Emanuele Tesauro (E. Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, o sia, idea dell’arguta et ingeniosa elocutione, che serue a tutta l’arte oratoria, lapida-ria, et simbolica. Esaminata co’ principii del diuino Aristotele, dal conte D. Emanuele Tesauro ... Accresciuta dall’autore di due nuoui trattati, cioe, De’ concetti predicabili, et Degli emblemi, Venezia 1678, p. 36), l’impresa, che definisce più astrusa rispetto agli altri simboli, si caratterizza per la presenza di un “motto più arguto e bre-
ve”, mentre, ad esempio, l’emblema, più intelleggibile, “dichiara diffusamente la figura per palesarne il morale Documento”. Precisa quindi che “il motto dell’Impresa serve la figura non serba l’essenza dell’Impresa, mancandovi l’ar-gomento di somiglianza: al contrario l’Emblema può conservarsi la sostanza dell’Emblema nel solo epigramma senza la immagine dipinta: perché nello stesso epigramma si esprime il soggetto dell’immagine e applicazione”. Ma l’una e l’altra fra loro discordano innanzitutto circa l’oggetto: “in quanto la impresa risguarda un proposito heroico particolare, et l’Emblema risguarda (come si è detto) un general Documento in ordine di vivere humano”. Tant’è che Tesauro definisce l’impresa “metafora di Proportione: impressa nello scudo, o nel cimiero, o nelle insegne; significante un concetto particolare, et heroi-co: per mezzo di figura, et proprietà pellegrina; aiutata da un motto Arguto” e, viceversa, l’emblema quale “metafora ad ornamento di Fregi delle Sale, ò degli Apparati: significante alcun Documento morale ò insegnamento dottri-nale, per mezzo di Figure iconologiche, o Fabulose: o di altre ingegnose, et erudite rappresentazioni assai più libere che le Imprese, aiutate da un motto chiaro, o da più Versi” (Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, p. 488). non meno interessante è l’affermazione dell’autore del Cannocchiale aristotelico circa quel “genere dogmatico” di rappresentazioni – a cui forse potrebbero appartenere anche gli intagli del refettorio – “che per mezzo di simboli à modo d’Impresa, insegna cose filosofiche, o Morali” ma le quali in realtà “non sono Imprese, ma Emblemi” (ivi, p. 450).
13 Picinelli, Mondo simbolico, cfr. l’introduzione “Compendioso trattato della natura dell’imprese”, al capitolo “Ciò che sia impresa, e come si deffi-nisca”.
14 Ibidem.15 Ibidem.16 Picinelli, Mondo simbolico, cfr. l’introduzione “Compendioso trattato
della natura dell’imprese”, al capitolo “Del corpo dell’impresa”.17 Ibidem.18 Picinelli, Mondo simbolico, cfr. l’introduzione “Compendioso trattato
della natura dell’imprese”, al capitolo “Del motto dell’impresa”.19 “E perché il motto, come di sopra si disse, non deve significare il tutto
da sé, ma concorrere parzialmente insieme col corpo, ed insinuare un con-cetto formato, e compito: perciò dai motti si escludono gli adagij, e i detti sententiosi, i quali da lor medesimi formano senso indipendente, intiero, e non bisognevole che loro s’aggiunga alcun corpo” (ibidem).
20 “Una sola parola, verbo, o avverbio può bastare per animar l’impresa, con due parole il motto riesce più sonoro e più vago; che vi si possono mettere anco tre, ma che non passino il numero di quattro” (ibidem).
21 Ibidem.22 Ibidem. 23 Rosa, Il refettorio morale, c. 246v.24 La scena è stata precedentemente letta come rappresentazione de Il
pentimento di Saul, in Spiazzi, Il refettorio grande, p. 160; G. Galasso, Giovanni Marchiori e Valentino Panciera Besarel, in Scultura lignea barocca nel Veneto, a cura di A.M. Spiazzi, Verona 1997, p. 334.
25 Rosa, Il refettorio morale, c. 246v.26 Scrive infatti Pierio Valeriano: “Del Moro. In alcuni trattati di varij alberi,
scritti à requisitione d’alcuni amici, habbiamo dimostrato, che per la quercia la fortezza, per la palma la giustizia, e hora per il salice si significa la temperanza. Et hora (ò Grana) ci aggiungeremo la quarta virtù eroica, ch’è la prudenza” e prosegue spiegando come questa virtù sia “significata per il moro tra tutti gli alberi”, “peroché, secondo il detto di tutti questo è tenuto di tutti più pruden-te”; analogamente, illustra in dettaglio anche la relazione tra la Fortezza e la quercia (“È stato costume usato da molti per la Quercia significare la fortezza, e le gagliarde forze, ò sia perché co il nome da Robur derivato è detta rovere: perché gl’huomini forti, e gagliardi, come dice Festo, si chiamano robusti dalla robusta rovere”), come pure tra la Giustizia e la palma (“La palma fa il frutto di eguale peso con le foglie, e di qui vollero, che significasse la giustitia. Di più la materia della palma è incorrotta”, “si come ai amministratori della giustizia si conviene”, ecc.) (P. Valeriano, Ieroglifici overo commentarii (…), Venetia 1625, p. 668-669, 679-680, 694).
27 Rosa, Il refettorio morale, c. 247r.28 Girolamo Rosa spiega che “l’immagine della Beatissima Vergine, qua-
le siccome raccolse in se tutte le perfezioni, e le virtudi, che sono in parte rappresentate da precedenti simboli, così a noi col suo esempio può servire di Maestra, perché ne otteniamo l’acquisto; non meno che, con la sua santa Protezione, ci può essere sicura guida, per condurci tra il pelago di questa vita
al porto dell’eterna salvezza. A questa pertanto io soscrissi: Te Duce; parole tolte da Batista Mantoano […]” (Rosa, Il refettorio morale, c. 245v). Inoltre il monaco, circa i due angeli a lato dell’immagine della Vergine, precisa che l’u-no, reggente la rosa, si presenta con “il cartello Innoxia floret; denotando con questo la Immacolata Concezione della gran Regina de Cieli; perché, siccome la Rosa, che vien prodotta dalla radice, tronco, e rami, quali tutti sono spinosi, essa si è pure esente dalle spine; così la Vergine sagratissima nasce da radice spinosa, e peccatrice; ma è però da qualunque peccato libera, e preservata […]” (ivi, c. 245v-246r). L’altro angelo “ha un Giglio con il lemma: Argento copulat aurum. È questo fiore simbolo della Madre d’Iddio, la quale al merito della sua purissima virginità accoppiò il fervore della Carità […]” (ivi, c. 246). E dunque “possono in oltre per nostro documento servire i due simboli pre-cedenti; insegnando a noi pure la rosa, che quantunque sia tra le spine, cioè tra vizi di questo mondo, fiorisca la nostra vita nelle virtudi, e da quelli si astenga; dal giglio poi egualmente impariamo ad unire con l’innocenza de’ costumi un’intenso amore di Dio, che ne nostri cuori fiammeggi; con che immitando la in qualche parte le prerogative della Vergine Augustissima, non ci rendiamo indegni della sua protezione, tanto a noi necessaria pel conseguimento della gloria celeste, che è la meta delle virtù, quali sono adombrate ne’ simboli col di cui mezzo possiamo finalmente passare dalla cognizione che ora abbiamo d’Id-dio per speculum et in enigmate, come dice S. Paolo [Prima Lettera ai Corinzi, 13.12] alla di Lui visione beata, per la quale: “Videbimus eum sicuti est” [San Tommaso d’Aquino, Expositio et lectura super epistolas Pauli Apostoli]” (ibidem).
29 Rosa, Il refettorio morale, c. 247r.30 “Per dimostrare le utilità, quali si ricavano dalla lezione delle Sagre Scrit-
ture, uno degli angeli sotto il pulpito con il libro in mano, e colla destra in atto di cavare dal carcasso una freccia, avrà il motto: Hinc tela perché la Sagra Scrittura per appunto, quasi ben provveduta faretra amministra acuti strali per trafiggere il tentatore, e rintuzzare quanti tentativi possano dal medesimo con-tro di noi avventarsi […]. Avvegna che molte volte la freccia scagliata dall’arco non faccia colpo, è però vero, che al dire del Bembo [P. Bembo, Rime, Bergamo 1753, p. 7, sonetto VIII)]: ‘In van sempre non scocca’; detto, che corrisponde al Non semper frustra dell’angelo che coll’arco tiene in mano uno strale per vibrarlo. Tale si è la spirituale lezione, che una volta o l’altra compunge final-mente anco i cuori più ostinati, et i più neghiettosi colpisce […]” (Rosa, Il refettorio morale, c. 245).
31 Rosa, Il refettorio morale, c. 247r.32 Quindi prosegue: “Dunque dalla benefica influenza della Divina Mise-
ricordia e l’universale di questo sagro Ritiro, e ciascheduno de’ Religiosi in particolare riconosca ogni suo bene; e, coll’applicarsi quello indefessamente nell’osservanza della Santa Regola; e col mantenere questo illibata la candi-dezza de’ proprii costumi, non si renda indegno delle celesti beneficenze” (ivi, c. 231r).
33 Ivi, c. 31r. I due putti sono accompagnati rispettivamente dai motti ‘Et regit, et stimulat’ e ‘Centeno fulgore dives’ incisi su cartigli dorati.
34 Elenco e descrizione degli emblemi sono stati in passato riportati in La Badia di Praglia: guida storico-artistica, Padova 1962.
35 Rosa, Il refettorio morale, c. 231v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 23 (160); P. Aresi, Delle Sacre Imprese di Monsig.r Paolo Aresi vescovo di Tortona. Libro quarto, Tortona 1630, p. 701.
36 Si vede quindi, anche per un riferimento iconografico, P. Picinelli, Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et tam sacris, quam profanis eruditionibus ac sententiis illustratus: subministrans oratoribus, praedica-toribus, academicis, poetis &c. innumera conceptuum argumenta, Colonia 1687, p. 276. La medesima immagine con l’aquila che affissa gli occhi al sole la ritroviamo anche, ad esempio, a formare il corpo dell’impresa del nobile genovese Pier Francesco Moneglia, completata dal motto in francese ‘C’est a moy seul’, in C. Camilli, Imprese illustri di diversi coi discorsi di Camillo Camilli, et con le figure intagliate in Rame di Girolamo Porro Padovano, Venetia 1586, come pure, molto più tardi, nell’impresa associata a San Giovanni Evangelista in C. Labia, Simboli festivi, Venezia 1698, p. 443.
37 Rosa, Il refettorio morale, c. 232r; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 155 (132). 38 Rosa, Il refettorio morale, c. 232r; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 105 (427).39 Rosa, Il refettorio morale, c. 232r; il Rosa si ispira comunque per quest’im-
presa a quella di analogo significato, contraddistinta nel corpo dalla medesima raffigurazione del pozzo ma con il motto “Fit purior haustu”, presente nel Mondo simbolico nonché nelle Imprese illustri di Camillo Camilli; cfr. Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 108 (439) e C. Camilli, Imprese illustri, Venetia 1586, p. 30, pp. 153-155 (Orsina Cavalletti),
Arte GirolAmo mAriA rosA, Bortolo BrAsi, GiovAnni mArchiori e Gli intAGli del refettorio con unA notA sul san girolamo di giovAnni BonAzzA
• 452 • • 453 •
40 Che distingue la stessa impresa in Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 164 (194); vedasi in tal senso anche Ferro, Teatro d’Imprese, II, p. 216, ove è pure riprodotta l’immagine che contraddistingue il corpo dell’impresa in questione associata però ad altro motto e significato.
41 Rosa, Il refettorio morale, c. 232r-v.42 Ivi, c. 232v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 34 (235).43 Rosa, Il refettorio morale, c. 229v.44 È qui utile riportare la classificazione dei corpi presente nelle pagine intro-
duttive del Mondo Simbolico dell’abate Picinelli (ed. Milano 1680). Corpi naturali: Corpi celesti; corpi elementari (riferiti ai 4 elementi); dei, et uomini; ucelli; quadrupedi; pesci; serpenti, et animali velenosi; animali imperfetti; piante, e frutti; erbe; fiori; gemme, e pietre; metalli. Corpi artificiali: strumenti di Chiesa; strumen-ti domestici; Edificii, e loro attenenti; strumenti febbrili; strumenti da giuoco; lettere alfabetali, ed altri attenenti; strumenti marinareschi; strumenti matematici; strumenti militari; strumenti musicali; strumenti rurali; misti.
45 Rosa, Il refettorio morale, c. 233; in questo caso il Rosa non sembra attin-gere, anche per le stesse citazioni a corredo della sua illustrazione dell’impresa in esame, come di consueto, al testo del Picinelli, all’interno del quale è tuttavia presente una rappresentazione simbolica di analogo significato (che alla pietra di amianto nel fuoco accompagna il motto “Purgor, non uror”, cfr. Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 536 [18]); ma si veda anche Ferro, Teatro d’Imprese, p. 450 e Camilli, p. 39-40, che alla stessa immagine associano il motto “Tergit, non ardet”.
46 Rosa, Il refettorio morale, c. 233; quest’impresa trova corrispondenza di concetto con quella presente nel Mondo Simbolico, contraddistinta dalla mede-sima immagine ma con il motto “Qua dirigit gradior”, cfr. Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 248 (217); da un’altra impresa del Mondo simbolico, contraddistinta dal motto “Omnia nutu” e che Picinelli mette in relazione con il concetto di ubbidienza, il Rosa trae a suo uso un passo di san Bonaventura (cfr. Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 247 [207]). Per un riferimento iconografico inerente il corpo dell’impresa in questione si veda Ferro, Teatro d’Imprese, II, p. 340, ill.
47 Rosa, Il refettorio morale, c. 233v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 470 (481).48 Rosa, Il refettorio morale, c. 233v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 195 (425).
Vedi anche Ferro, Teatro d’Imprese, II, p. 351, ill. Rosa (ibidem), poi prosegue: “Così S. Paolo, che potea vantarsi di essere Cittadino Romano, non si pregiò giammai, che chiamandosi servo di Cristo. Rom 1. 3. “Paulus Servus Jesu Christi”, riconoscendosi più nobilitato, et illustrato da tale servitù, che dalla Romana cittadinanza, che pure in que’ tempi in grande stima teneasi […]”.
49 Rosa, Il refettorio morale, c. 233v; cfr. Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 459 (396) (con il motto “non uno decidit ictu”). Per un riferimento iconografico inerente il corpo dell’impresa in questione si veda Ferro, Teatro d’Imprese, II, p. 17, ill.
50 Rosa, Il refettorio morale, c. 234r; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 226 (66); vedi quindi anche Ferro, Teatro d’Imprese, p. 145, e p. 143, ill., per un riferi-mento iconografico inerente il corpo dell’impresa in questione.
51 Rosa, Il refettorio morale, c. 234r; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 362 (72).52 Rosa, Il refettorio morale, c. 234v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 55 (13).53 Bargagli, p. 284; Ferro, Teatro d’Imprese, II, p. 205, e, inoltre, p. 207, ill.,
per un riferimento iconografico inerente il corpo dell’impresa in questione.54 Rosa, Il refettorio morale, c. 234v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 252 (241).55 Rosa, Il refettorio morale, c. 234v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 454 (354).56 Rosa, Il refettorio morale, c. 235r; Picinelli, I, p. 199 (452).57 Precisa Rosa, Il refettorio morale, c. 235r, “somministrandone il sentimento
la Verità Evangelica, Jo: 15.2. Omnem palmitem qui fert fructum purgabit eum, ut fructum plus afferat” (“Omnem palmitem in me non ferentem fructum tollet eum, et omnem qui fert fructum purgabit eum, ut fructum plus afferat”, Gv 15, 2).
58 Rosa, Il refettorio morale, c. 235r.59 Ibidem; da Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 221 (28), che, mutuando l’im-
presa da Emanuele Tesauro, riporta appunto il motto “Consiliis inimica cele-ritas”.
60 Rosa, Il refettorio morale, c. 235r-v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 179 (304).
61 Rosa, Il refettorio morale, c. 236r.62 Ibidem; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 359 (58); S. Bargagli, Dell’Im-
prese…, p. 252.63 Rosa, Il refettorio morale, c. 236r; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 340 (199).64 Rosa, Il refettorio morale, c. 236v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 229 (80).
Ferro (Ferro, Teatro d’Imprese, II, pp. 154-155, ill.), oltre a “no puedo mas” e
“Più non posso”, al cammello, “che quando si sente caricato tanto che basta, si leva, e si parte”, associa anche il motto ‘nil ultra vires’.
65 Rosa, Il refettorio morale, c. 236v; per analogia, cfr. Picinelli, Mondo sim-bolico, II, p. 539 (38) e, soprattutto, anche per la presenza del medesimo motto, p. 726-727 (32).
66 Rosa, Il refettorio morale, c. 236v; cfr. Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 366-367 (103-104), da cui anche la citazione di sant’Agostino.
67 Rosa, Il refettorio morale, c. 237r; Picinelli, Mondo simbolico, II, p. 802 (154), che a sua volta si ispira a un’impresa presente in Ferro, Teatro d’Imprese, I, p. 198, 199; II, p. 700.
68 Rosa, Il refettorio morale, c. 237v; Picinelli, II, p. 809 (29); vedi anche Ferro, Teatro d’Imprese, II, p. 527.
69 Rosa, Il refettorio morale, c. 237v, riporta infatti il passo della lettera ai Co-lossesi (3, 9), mutuandolo sempre dal Mondo Simbolico, “expoliantes vos veterem hominem cum actibus suis et induentes novum» […]”; cfr. Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 357 (45): alla medesima impresa pone però il motto “Lascio la vecchia, e la nova spoglia prendo” (che appare già in Bargagli, associato al ser-pente in muta che striscia tra i sassi, per esprimere tuttavia diverso concetto; cfr. Bargagli, p. 454, ill.); il motto “novus exorior” è presente comunque nel Mondo Simbolico – da dove quindi lo trae Girolamo Rosa –, parimenti collegato all’immagine del serpente che cambia spoglia, ma per esprimere il concetto del passaggio a nuova e miglior vita con la mortificazione della carne attraverso la penitenza (cfr. Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 358). Per lo stesso motto associato all’immagine del serpente in muta, ma con altro significato – e per un ulteriore riferimento iconografico per il corpo dell’impresa in questione – vedi anche Ferro, Teatro d’Imprese, II, p. 629, ill.
70 Rosa, Il refettorio morale, c. 237v; Picinelli, Mondo simbolico, II, p. 769 (128), che riporta correttamente “Rite si saepe revisor”.
71 L. Contile, Ragionamento di Luca Contile sopra la proprietà delle imprese, con le particolari de gli Academici Affidati, et con le interpretationi et croniche ..., Pavia 1574, p. 262, ill.
72 Rosa, Il refettorio morale, c. 238r; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 262 (317).73 Rosa, Il refettorio morale, c. 238r; Picinelli, Mondo simbolico, II, p. 761 (85).74 Rosa, Il refettorio morale, c. 238r-v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 361,
con il motto “Pharmacum ex utrisque” (si tratta di una delle poche imprese illustrate nel volume).
75 Rosa, Il refettorio morale, c. 238v; Picinelli, Mondo simbolico, II, p. 805 (7), anche qui, come in altri casi, tranne che per il motto, ripreso quasi alla lettera da Rosa.
76 Rosa, Il refettorio morale, c. 239r; cfr. Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 501 (2): Rosa in questo caso rielabora il testo meglio adattandolo al diverso motto; nel contempo fa propria la citazione dal Tasso.
77 Rosa, Il refettorio morale, c. 239r; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 288-289 (504). Vedi anche Ferro, Teatro d’Imprese, p. 532-533, chiamato in causa dallo stesso Picinelli.
78 Rosa, Il refettorio morale, c. 239r-v; Picinelli, Mondo simbolico, II, p. 757 (63), ma con il motto ‘Ha’ da ser uno de dos’.
79 Rosa, Il refettorio morale, c. 239v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 348 (247); si veda anche Ferro, Teatro d’Imprese, II, p. 563, per il motto ‘Sic quiesco’ legato alla stessa immagine.
80 Rosa, Il refettorio morale, c. 239v; Picinelli, Mondo simbolico, II, p. 834 (40); ma si veda anche Ferro, Teatro d’Imprese, II, p. 252: “Due Corone una di Spine, l’altra di Rose col motto non sine altera ha dell’Emblema, è di Monsign. Ta-gliapietra Piovano di Burano, il quale fece molte Imprese graziose poste da me à suoi luoghi, & in questa volse forse alludere à quello, che scrisse San Paolo Non coronabitur, nisi qui legitime certaverit, non andandosi alla vittoria, se non col mezo di guerre, e travagli”.
81 Rosa, Il refettorio morale, c. 239v: prosegue, sempre sulla falsariga del Mon-do Simbolico, “Leo apertis oculis dormit, dice S. Pier Damiano Epist. 39. Et tu sic quiesce sepositus a mundo, ut pervigiles semper oculos habere perseveres in Domino, sic dicitur: Ego dormio, et cor meum vigilat”; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 275 (412): specifica che il motto è preso da Lucarini (cfr. quindi A. Lucarini, Imprese dell’Offitioso Accademico Intronato raccolte da lo Sconosciuto Accad. Unito, Siena 1641).
82 Rosa, Il refettorio morale, c. 239v-240r; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 527 (189).
83 Rosa, Il refettorio morale, c. 240v; per un possibile riferimento si veda l’impresa, di analogo concetto, con la medesima raffigurazione e il motto ‘Latet’ in Camilli, p. 78-79, ill.
84 Rosa, Il refettorio morale, c. 240v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 301 (588), con l’immagine della castagna anziché della noce, così come in Ferro, Teatro d’Imprese, p. 639.
85 Rosa, Il refettorio morale, c. 240v; Picinelli, Mondo simbolico, II, p. 748 (7). Vedi anche Ferro, Teatro d’Imprese, p. 134.
86 Cfr. Ferro, Teatro d’Imprese, II, p. 640.87 Rosa, Il refettorio morale, c. 241r; per significati analoghi cfr. Picinelli,
Mondo simbolico, I, p. 132-133, in particolare l’impresa (71) col motto “Son le lusinghe sue sempre mortali”; per il motto “Dulcedine capio”, presente in Picinelli (ivi, p. 133) e commutato da Rosa in “Dulcedine perdit”, vedi anche Ferro, Teatro d’Imprese, II, 641.
88 Rosa, Il refettorio morale, c. 241r.89 Ivi, c. 241r-v.90 Rosa, Il refettorio morale, c. 241v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 529 (198),
con il motto ‘Sub Sole patebit’.91 Rosa, Il refettorio morale, c. 242r, cita Isaia, 50. 2, “Computrescent pisces
sine aqua, et morientur in sicco”, da cui dichiara di aver tratto “il Lemma per il simbolo del pesce”.
92 Rosa, Il refettorio morale, c. 242r; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 310 (8), ma con il motto “In arido moriar”.
93 Rosa, Il refettorio morale, c. 242r; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 415 (74).94 Rosa, Il refettorio morale, c. 242r-v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 145
(42), ma con diverso motto: “che però di lei dissi: Modulatur Elata, e per bocca dell’allodola istessa: Concino dum elevor”.
95 Rosa, Il refettorio morale, c. 242v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 460 (412).96 Rosa, Il refettorio morale, c. 242v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 209 (525).97 Rosa, Il refettorio morale, c. 242v-243r.98 Ivi, c. 243r; pur mancando in questo caso una precisa corrispondenza
con il Mondo Simbolico, cfr. comunque Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 315-316 (43) per l’impresa con il motto “Cum tempore crescit”, ma riferita, all’opposto, ai vizi e, ancora, ivi, I, 316 (44) la successiva con il motto ‘Magnitudinis eius non est finis’.
99 Rosa, Il refettorio morale, c. 243v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 322 (80).100 Rosa, Il refettorio morale, c. 243v; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 412-413
(52), che in premessa indica come “l’Abbate Giovanni Ferro, al frutto dell’aran-cio soprapose: Expressa probatur, e Gio. Francesco Bonomo: Comprime nos- ces”; cfr. quindi anche Ferro, Teatro d’Imprese, II, p. 95, ill.
101 Rosa, Il refettorio morale, c. 243v, 244r, variante dell’impresa descritta da Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 354 (28), con il motto “Haud inficit alta”.
102 Rosa, Il refettorio morale, c. 244r; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 436 (212) con il motto “In cacumine dulcis”.
103 Rosa, Il refettorio morale, c. 244r; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 355 (33), con il motto “Vetuitque renasci”.
104 Rosa, Il refettorio morale, c. 244v.105 Ibidem, dove si legge ancora “Tali furono Pietro, dopo la negazione;
Tommaso dopo l’infedeltà, et il Prodigo dell’Evangelo che dalla fame agitato, ritornò finalmente tra le braccia, e nella casa del Padre, quale tutto amoroso lo accolse”; Picinelli, Mondo simbolico, I, p. 323 (86).
106 AAPr, caps. 13, Documenti, c. 60.107 nei documenti, oltre a Bortolo Brasi e Giovanni Marchiori, di cui si
parlerà oltre, sono registrati i nomi dei seguenti intagliatori: Guglielmo Talbon, attivo da luglio a novembre 1726; “Massimo Patriarca con due giovani intaglia-tori”, il cui nome compare solo una volta in relazione a un pagamento del 15 ottobre 1726; così per Francesco Renier e Antonio Serrafin assieme a Mattio Bigon, pagati rispettivamente in marzo e settembre 1728; Tomaso Fornella, Bernardo Dolce, Francesco Dandoli, risultano invece pagati a scadenze regolari per la loro opera dalla fine del 1726 sino al dicembre del 1729 (AAPr, caps. 13, Documenti, c. 62r-68r). Antonio Serrafin e Mattio Bigon compaiono come lavoranti tra gli intagliatori veneziani impegnati nelle decorazioni del nuovo bucintoro in una nota datata 27 maggio 1727, dunque l’anno precedente il loro impiego a Praglia (ASVe, Senato Arsenal, filza 23, 21 giugno 1727; docu-mento reperito da Alberto Secco in occasione della realizzazione di un Regesto di fonti relative all’ultimo bucintoro, 1704-1760).
108 Andrea Gloria (A. Gloria, Il territorio padovano illustrato, Padova 1862, II, p. 59) oltre a ricordare che “gli emblemi degl’intagli e i motti latini a ogni emblema spiegò il padre Girolamo Maria Rosa nel suo Refettorio mora-le, dedicato (1727) all’Abate Angeli”, segnala come “gli intagli del refettorio maggiore furono eseguiti nel secolo andato da quel Biasi che lavorò gli scaffali della Biblioteca di S. Giustina in Padova”, informazione quest’ultima inesatta,
dovuta probabilmente a una confusione con Michele Bartems, pure attivo per Praglia, avendo realizzato un Crocifisso ligneo conservato in chiesa, e autore dei lavori di S. Giustina.
109 Rosa, Il refettorio morale, c. 247. Al Brasi, come ancora riferisce il mo-naco, spetta pure l’esecuzione dei fregi simbolici, prima descritti, posti sotto l’immagine dell’Immacolata, il pulpito e lo stemma del monastero (Rosa, Il refettorio morale, c. 247).
110 ASVe, Milizia da Mar, b. 544, Arte degli intagliatori, 1706, 1712; ivi, b. 626, Arte degli intagliatori, 1711; ivi, b. 672, Arte degli intagliatori, 1723; ivi, b. 673, Arte degli intagliatori, 1724, 1725; ivi, b. 679, Arte degli intagliatori, 1733; cfr. anche B. Cogo, Antonio Corradini scultore veneziano 1688-1752, Este 1996, p. 140 nota 116; H. Seražin, M. Klemencic, I contratti di garzonato degli scultori, lapicidi e intagliatori veneziani (I), “Acta historiae artis Slovenica”, 7, 2002, p. 177; H. Seražin, M. Klemencic, I contratti di garzonato degli scultori, lapicidi e intagliatori veneziani (II), “Acta historiae artis Slovenica”, 8, 2003, p. 202. Talvolta l’intagliatore è registrato nei documenti come “Bortolo Brazi”.
111 Bortolo Brasi compare infatti per la prima volta nei documenti d’archi-vio in relazione a una causa contro l’intagliatore Zuanne Rossello, riguardante sei cornici, in occasione della quale furono nominati come periti Giusep-pe Torretti, nadalino Treto e Antonio Tarsia (M. De Vincenti, Antonio Tarsia (1662-1739), “Venezia Arti”, 10, 1996, p. 49; ASVe, Giustizia Vecchia, b. 106, reg. 128, alla data 7 giugno 1704.
112 Seražin, Klemencic, I contratti… (I), p. 172. Altri garzoni risultano as-sunti dal Brasi nel 1725 e nel 1731, cfr. Seražin, Klemencic, I contratti… (II), p. 195, 196.
113 Come risulta, in particolare, dai verbali delle riunioni tenutesi nel 1723 (cfr. ASVe, Milizia da Mar, Capitoli dell’Arti per il Taglion 1713-1723, b. 671; ivi, b. 672). Il suo nome è registrato altresì nei verbali dei due anni successivi (cfr. ivi, b. 673; vedi anche Cogo, Antonio Corradini, p. 92).
114 negli elenchi dell’Arte nel 1711 e nel 1723 è presente infatti anche Bastian Brasi, figlio di Bortolo (ASVe, Milizia da Mar, b. 626, Arte degli intaglia-tori 1711, nota dei “figli de Capi maestri”: “Bastian Brasi ani 10” (cfr. anche P. Peron, voce Brasi (o Brassi o Brazi) Bastian, in E. Colle, Il mobile Barocco in Italia. Arredi e decorazioni d’interni dal 1600 al 1738, Milano 2000, p. 443).
115 AAPr, caps. 13, Documenti, c. 64r.116 Ivi, c. 64r.117 Ivi, c. 65r-69r.118 Totalmente priva di qualsiasi fondamento appare l’ipotesi formulata dalla
Galasso che il Brasi si sia servito di disegni di Giovanni Marchiori così come non sussiste alcun rapporto tra gli emblemi intagliati da Brasi e i finalini che compaiono nell’edizione delle Raccolta di lettere sopra la pittura e architettura di Francesco Algarotti data alle stampe a Livorno nel 1784, come invece sostiene la stessa studiosa (cfr. Galasso, Giovanni Marchiori, p. 336).
119 nella “notta de Capi maestri de Intagliatori” del 1711 accanto al nome del Brasi è infatti indicata l’età “ani 38” (ASVe, Milizia da Mar, b. 626, Arte degli intagliatori, 1711).
120 C. Semenzato, La scultura veneta del Sei e Settecento, Venezia 1966, p. 60.121 Il credito acquisito da Brasi con questi lavori indusse i monaci a com-
missionare al maestro nel corso del 1729, oltre a “otto candellieri grandi di cirmolo intagliati” e successivamente indorati, la realizzazione di un “apparato nuovo in chiesa per l’espositione del Santissimo Sacramento”, anch’esso in legno dorato (AAPr, caps. 13, Documenti, c. 71r). Fiandrini, autore nei primi anni dell’Ottocento di alcune memorie manoscritte sul monastero, ricorda che l’apparato dovette essere ben presto smontato e modificato poiché minacciava di rovinare a terra (B. Fiandrini, Memorie storico-cronologiche del monastero di S. Maria di Praglia, in AAPr, caps. 13, Documenti).
122 Rosa, Il refettorio morale, c. 247.123 Spiazzi, Il refettorio grande, p. 162; Galasso, Giovanni Marchiori, p. 334.124 A. Bacchi, Marchiori, Giovanni, in La scultura a Venezia da Sansovino a
Canova, a cura di Id., Milano 2000, p. 745-747.125 M. De Grassi, Giovanni Marchiori, appunti per una lettura critica, “Saggi e
Memorie di storia dell’arte”, 21, 1997, p. 130-131. Si veda anche Id., Giovanni Marchiori tra intaglio e scultura: appunti sugli esordi, “Arte Veneta”, 59, 2002, p. 161.
126 Il campanile era stato ricostruito tra il 1726 e il 1728 per volontà dell’a-bate del monastero benedettino di S. Giorgio Maggiore, Leopoldo Cappello, su modello del proto Giovanni Scalfurotto che aveva anche diretto i lavori; Mar-chiori era stato pagato per la statua in legno, poi ricoperta da una lastra di rame, il 29 settembre 1727; il 27 febbraio 1774 il campanile crollò causando la perdita della statua (Rossi, Per gli inizi di Giovanni Marchiori, p. 489-490).
Arte
• 454 •
127 ASVe, Milizia da Mar, b. 676, reg. 41. Per l’attività di Giovanni Marchiori nel campo dell’intaglio ligneo si veda ora M. De Vincenti, S. Guerriero, Inta-gliatori e scultura lignea a Venezia nel Settecento, in Con il legno e con l’oro. La Venezia artigiana degli intagliatori, battiloro e doratori, a cura di G. Caniato, Verona 2009, p. 147-150, ove è già presente un riferimento ai lavori pragliesi dello scultore.
128 ASVe, Senato Arsenal, filza 23, 9 giugno 1727, Allegato n. 6: stima di Corradini e degli intagliatori; documento reperito da Alberto Secco in occasione della realizzazione di un Regesto di fonti relative all’ultimo bucintoro, 1704-1760.
129 Per l’attribuzione a Marchiori di quest’opera – in precedenza tradi-zionalmente riferita a Corradini - cfr. De Vincenti, Guerriero, Intagliatori e scultura lignea a Venezia nel Settecento, p. 150.
130 Rossi, Per gli inizi di Giovanni Marchiori, p. 489-490.131 Era stato il custode Anton Maria Zanetti ‘il giovane’ a occuparsi dell’in-
venzione degli ‘armari’ con l’ausilio del ‘marangon’ Battista Gafforello, i disegni erano stati forniti dal pittore “di architettura e di ornati” Giambattista Moretti, mentre gli intagli erano stati per l’appunto eseguiti da Marchiori “celebre scultore bellunese” (M. Zorzi, La Libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia dei Dogi, Milano 1987, p. 263, 493 nota 149).
132 Per le opere in marmo risalenti a questo periodo si veda: M. Klemencic, Giovanni Marchiori v Rovinju, “Acta historiae artis Slovenica”, 2, 1997, p. 97-108; Id., Goriški i beneški delež pri Schoyevem velikem oltarju v graški stolnici: Pasquale Lazzarini in Giovanni Marchiori, in Barok na Goriskem / Il Barocco nel goriziano, a cura di F. Serbelj, nova Gorica 2006, p. 293-303; De Grassi, Giovanni Marchiori, p. 161-167 (va, a mio avviso, sospeso il giudizio, in attesa di più convincenti riscontri, su un busto ligneo di collezione privata, raffigurante forse Adone, che reca sul retro il nome dello scultore agordino e che De Grassi assegna senza in-dugi a Marchiori, ritenendolo il primo lavoro d’intaglio noto dell’artista, la cui esecuzione risalirebbe agli inizi degli anni venti del Settecento).
133 Klemencic, Giovanni Marchiori v Rovinju.134 Bacchi, Marchiori, Giovanni, p. 746.135 Per tali lavori si rinvia al recente intervento di P. Rossi, Le sculture del
Seicento e del Settecento in La Scuola Grande di San Rocco a Venezia, a cura di F. Posocco, S. Settis, Modena 2008, p. 161-173.
136 L’avvio dei lavori per lo scalone, conclusisi in un paio d’anni, va col-locato verso il finire del 1710, stante l’accordo stipulato il 12 settembre 1710 tra il monastero e “Benetto Canella tagliapietre” (AAPr, caps. 13, Documenti, c. 40). La conclusione avverrà due anni più tardi, sotto l’abate Giovanni Barpo, come riferisce uno scritto sugli abati di Praglia, conservato presso la Biblioteca civica di Padova (ms. BP. 804/III), nel quale si legge “Fece questo abate la scala grande del monastero che fu terminata nel 1712” (F.L. Maschietto, Biblioteca e bibliotecari di S. Giustina di Padova (1697-1827), Padova 1981, p. 41). Andrea Gloria (Gloria, Il territorio padovano, II, p. 59) ricorda genericamente che “La scala maggiore di pietra istriana fu eseguita entrante il secolo XVIII”.
137 Per una descrizione dell’iconografia di san Girolamo, accompagnata da una chiara ed esaustiva rassegna dei simboli associati al santo, si veda, ad esempio, R. Giorgi, Santi, Milano 2002, p. 150-155.
138 Semenzato, La scultura veneta, p. 121.
139 Tale indicazione circa il soggetto raffigurato nella statua, certamente assai suggestiva – tanto da aver riscosso una sorta di unanime consenso –, ma del tutto fuorviante, non risulta trovare alcun appoggio, se si fa eccezione come si è detto per l’attributo della clessidra, nella tradizionale iconografia della personificazio-ne del Tempo, per la quale vedasi ad esempio C. Ripa, Iconologia, ed. a cura di P. Buscaroli, Milano 1992, pp. 438-439. Come allegoria del Tempo la statua è trattata anche da S. Faccini, La scultura, in Praglia 1985, p. 114.
140 Tra le diverse sculture che nel monumento al doge Silvestro Valier, eretto tra 1705 e 1708 circa, spettano a Giovanni Bonazza vi è infatti un rilievo, firmato, posto alla base della struttura architettonica, il cui sogget-to, a partire dalla Guida dell’abate Giannantonio Moschini del 1815 (G.A. Moschini, Guida per la città di Venezia, Venezia 1815, I, p. 137; seguito poi da G.B. Soravia, Le chiese di Venezia, Venezia 1822, I, p. 43), è stato fino ad oggi sempre identificato come l’allegoria del Tempo in ragione della sola presen-za della clessidra. In realtà il personaggio scolpito nel rilievo, un vecchio ammantato, che con una mano alza uno scudiscio e con l’altra sostiene una lucerna accesa, rappresenta appunto l’allegoria dello Zelo descritto da Cesare Ripa nella sua Iconologia quale “Uomo in abito di Sacerdote. Che nella destra mano tenga una sferza e nella sinistra una lucerna accesa” (Ripa, Iconologia, 1992, p. 487- 488). La figura dello Zelo, che, come precisa il perugino “è un certo amore della Religione col quale si desidera che le cose appartenenti al Culto Divino sieno eseguite con ogni sincerità e prontezza, e diligenza” (ibidem), è rappresentata mentre con un piede calpesta un serpente (evidente allusione al male e all’infedele sconfitti attraverso l’esercizio di tale virtù) ed è ancora accompagnata, più in basso, da un putto che ha quali attributi le ali, un cuore e, infine, la clessidra, rispettivamente simboli, sempre secondo Ripa, della stessa Prontezza, Sincerità e Diligenza (Ripa, Iconologia, 1992, p. 365, 407-408; per la personificazione della Diligenza, C. Ripa, Iconologia overo Descrittione di diverse Imagini cavate dall’antichità et di propria invenzione, Roma 1603, p. 104).
141 Semenzato, La scultura veneta, p. 121.142 Cfr. supra.143 Per le opere citate si rinvia a S. Guerriero, in Orazio Marinali e la scultura
veneta fra Sei e Settecento, catalogo della mostra (Vicenza, Palazzo Thiene), a cura di M. De Vincenti, S. Guerriero, F. Rigon, Cittadella 2002, p. 92-93, ill. a p. 94.
144 M. De Vincenti, in Per un Atlante della statuaria veneta da giardino. II, a cura di M. De Vincenti, S. Guerriero, “Arte Veneta”, 64, 2007, p. 286-291, fig. 21-22.
145 Un ipotetico ruolo del giovane monaco nella commissione della statua dello scalone non apparirebbe peraltro affatto strano anche alla luce del fatto che, come ricorda il Fiandrini, “Girolamo Maria Rosa da Padova decano fece fare la statua, e nicchia di prospetto alla porta del Monastero nel campo dell’ara nel muro verso Tramonte” (Fiandrini, Memorie storico-cronologiche); la scultura in questione è stata identificata con la statua di Ercole – in precario stato di conservazione, e dunque difficilmente giudicabile – all’interno della nicchia situata in un angolo dell’attuale parco antistante il ‘capannone’ del monastero (Spiazzi, Il refettorio grande, p. 163 nota 9).