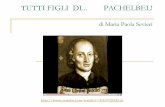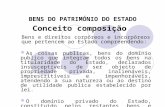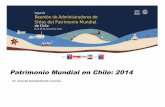F.I.C.O. o come essere generosi con il patrimonio di tutti*, lazzarettoautogestito.org
-
Upload
goldsmiths -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of F.I.C.O. o come essere generosi con il patrimonio di tutti*, lazzarettoautogestito.org
FICO o come essere generosi col patrimonio di tutt* Pubblicato su lazzarettoautogestito.org, 2014 Agricoltura di lusso al sapore di dismissione
“Quello che sta succedendo a Milano con Expo è simile a quello che succede in Val di Susa, a Niscemi, nella Roma dei festival o nella Bologna di FICO. Robby Maggioni, autore insieme a Offtopic di Expopolis Eataly World. Che vuol dire Mangitalia Mondo, cioè niente. Ma un niente con il brand Eataly intorno.” Wu Ming Dall’Expo a FICO, passando per Farinetti Il progetto FICO, Fabbrica Italiana Contadina, viene annunciato l’estate del 2013 e recepito con grande entusiasmo da stampa e Comune. L’idea è quella di riqualificare l’area del Mercato Ortofrutticolo CAAB, per lo sviluppo di un immenso parco tematico agroalimentare con 40 ristoranti, «stalle, acquari, campi, orti, officine di produzione, laboratori, banchi serviti, grocery”, (come descritto sul sito CAAB), organizzati secondo percorsi didattici, con cartelloni, audio guide e accompagnatori. Frontmen del progetto, per lo meno in un primo momento, sono Andrea Segré (Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agroalimentari dell'Università di Bologna, presidente del CAAB, nonché fondatore di Last Minute Market) e Oscar Farinetti, effervescente imprenditore renziano, fondatore della catena alimentare di lusso Eataly (detenuta per il 40% dalla Coop), presente anche a Bologna nella Coop Ambasciatori (libreria, supermercato e ristorante).
La parabola ascendente di Farinetti inizia nel 2004, quando vende la catena di distribuzione di famiglia, Unieuro. Con i soldi fonda una nuova catena di distribuzione, questa volta di prodotti alimentari di lusso, in parte provenienti dalle sue stesse aziende. Nel 2007 apre il primo supermercato alimentare di lusso, ristorazione inclusa, a Torino, in uno spazio concesso gratuitamente dall’allora sindaco Sergio Chiamparino (nonché direttore dell’Expo 2015). Infatti, il progetto di FICO non è motivato solo dalla dichiarata familiarità di Farinetti che ‘da comunista’, ama lavorare a Bologna, bensì dal più ampio contesto dell’Expo 2015 a Milano, tanto da far veicolare la formula ‘EXBO’, riferita all’apertura di FICO (il 1 maggio 2015, tanto per festeggiare l’imprenditoria ‘comunista’), come sorta di after dell’Expo. Un evento, quello milanese, che lascerà un debito di 10 miliardi, un investimento in cementificazioni da 8 miliardi, aprendo, nel frattempo, nuovi orizzonti di precarietà per i contratti di lavoro (il premier Letta ne vuole fare un esempio) e, grazie a poteri speciali di commissariamento, distribuendo generosamente appalti all’intero range dei poteri italiani, attraversando democraticamente Pd, Pdl, Lega e mafie. Giusto per la par condicio.
Sono almeno tre le ragioni per cui FICO, nella forma attuale, avrebbe la capacità di danneggiare la città inesorabilmente. Perciò, tuffiamoci nella mistificazione del marketing FICO, nel tentativo di comprendere le intenzioni del progetto e, dove possibile, immaginiamo alternative! MODELLO DI PRODUZIONE: ‘agricoltura da palcoscenico’ o eccellenza emiliana? Una Disneyland del cibo come FICO intenderebbe concentrare produzione, raccolto, vendita, ristorazione ed educazione, con afferenti percorsi ‘museali’, all’interno della struttura del CAAB. Pretesa molto ambiziosa, ma poco rispettosa della natura, come alcuni agricoltori hanno notato. Del resto, Noè a parte, chi riuscirebbe a raccogliere la totalità del gamma alimentare (come da presentazione), da frutteti a vigneti, da cereali a piantagioni, acquari e allevamenti (immaginiamo, dunque, mattatoi inclusi), sempre in bella mostra per il cliente? La vita della terra, l’evoluzione delle piante e degli animali non si presta alla spettacolarizzazione, se non in un’ottica da zoo. Volendo rispettare la biodiversità e la specificità degli esseri della terra e dell'acqua, ognuno di essi dovrebbe svilupparsi nel proprio luogo e tempo, e non può essere schiaffato in una vetrina dove esibirsi per la totalità dell’anno. E questo, qualcuno come Oscar Farinetti, il cui marketing è spalmato di agricoltura, lo dovrebbe sapere.
Perché, invece del solito centro commerciale in strutture pubbliche e dell’agricoltura da palcoscenico, non si investe nella vera eccellenza agricola emiliana? Quella dei piccoli produttori locali, di realtà come Campi Aperti e Genuino Clandestino, che, combattendo il monopolio dell’etichetta ‘biologica’, si sono auto-certificati, raggiungendo i consumatori grazie ai mercatini Km 0 negli spazi sociali, diffondendo un modo genuino di fare agricoltura (basato sul rispetto della biodiversità, della sovranità alimentare e del lavoro con la terra), ma anche di fare commercio (basato sulla filiera corta e la socialità tra consumatori e produttori)? Chiunque dei potenziali destinatari di FICO – dai consumatori locali, ad alunni e studenti o turisti - potrebbero raggiungere e conoscere i miracoli della terra nei momenti e nei luoghi specifici, scoprendo le piccole aziende e fattorie (anche didattiche), ma anche agriturismi che costellano l’Emilia, anzi che rinchiudersi nella ‘fabbrica’ di FICO. Perché non sostenere questo tipo di agricoltura, che esiste già e arricchisce il nostro territorio? CONDIZIONE DEI LAVORATORI: precarietà e sorveglianza oltre l’articolo 18 Da parte di uno che marketizza perfino le sue discendenze comuniste, Farinetti non poteva evitare la retorica dell’imprenditore ‘procacciatore di lavoro’. Troppo spesso, e FICO non ne fa eccezione, operazioni economiche ambigue vengono legittimate dalla creazione di posti di lavoro, caratterizzati poi da precarietà e sfruttamento, sempre che non siano le leggi stesse a prevederle (infatti Farinetti e Renzi hanno i loro piani per l’articolo 18).
Ma che tipo di lavoro promuove Eataly, cosa dobbiamo aspettarci? L’azienda non è riconosciuta come particolarmente rispettosa dei diritti dei suoi lavoratori: a Bari 160 su 180 dipendenti sono subordinati con contratti interinali e i sindacati insorgono, inceppando l’immagine idilliaca del brand. Inoltre, si scopre recentemente che i lavoratori a tempo pieno sono costretti a gareggiare per gli straordinari se vogliono raggiungere 800 Euro/mese. E siccome, si sa, “chi ha un reddito basso e non ha coscienza civica è spinto a rubare” (mica come politici e imprenditori), le commesse di Roma e Bari, che staccano a mezzanotte, vengono perquisite prima di lasciare il negozio. Questo è il sistema di sfruttamento che ci aspettiamo per il nuovo centro commerciale FICO. Sempre che non si ceda al ricatto di abolire l’articolo 18 ed eliminare tasse sul lavoro, cosa che, a detta di Farinetti, aumenterebbe notevolmente assunzioni e ammontare dei salari. E su questo dovrete crederlo sulla parola. Ma c’è un ulteriore aspetto legato al lavoro, che FICO potrebbe mettere in crisi, e riguarda altri settori piccoli e medi legati all’agricoltura, al turismo, alla ristorazione e perché no, alla didattica. Se, come annunciato, FICO vorrà erigersi come colosso del turismo agroalimentare, molte altre realtà potrebbero essere schiacciate dalla competizione, portando anche a possibili perdite di luoghi di lavoro e andando a incrementare l’‘esercito di riserva’ dei disoccupati ricattabili. Sono le attività diversificate e specifiche del territorio, che si evolvono in base alle esigenze dei piccoli consumatori, che sembrano proliferare in un momento di così selvaggia smaterializzazione e finanziarizzazione dei mercati all’insegna della speculazione. Accentrare patrimoni pubblici, capitali e risorse umane in un unico progetto mammut come FICO rappresenta un rischio maggiore per il patrimonio di tutti (che non tornerà ad essere pubblico) e per la
forza lavoro (in balia della precarietà, senza tutele), di quanto non lo sia per gli investitori privati, il cui possibile fallimento sarà – ancora una volta – attutito e pagato dai contribuenti. Ecco perché le esperienze agricole del territorio andrebbero sostenute e, possibilmente, replicate, anzi che concentrarsi sull’accentramento delle risorse e la privatizzazione del pubblico. MODELLO DI INVESTIMENTO: il pubblico investe, il privato incassa E questo ci porta alla vera posta in gioco di FICO. Non un parco tematico con 6 milioni di visitatori l’anno (“ipotesi conservativa” a detta della presentazione e di un business plan che nessuno ha visto), bensì una mastodontica operazione di privatizzazione immobiliare, a spese e col sostegno del pubblico. Infatti FICO non potrebbe esistere senza il Fondo immobiliare Parco Agroalimentare. Un fondo immobiliare è un insieme di beni immobili e mobili, dunque patrimoni e denaro, messi nelle mani di un amministratore (una Società di Gestione del Risparmio, SGR), che ne dovrebbe aumentare il valore, da qui il titolo di ‘fondo comune di investimento’. Nel nostro caso, il fondo parte con una somma iniziale di 100 milioni di euro, che potrà quadruplicarsi nel corso dei 40 anni di durata del fondo. Il maggior investitore nel progetto finora è il Comune di Bologna, che, cambiando la convenzione in atto col CAAB (pubblico per l’80%), permette la cessione delle strutture, stimate a 55 milioni di Euro, senza contropartita economica. Gli altri investitori sommano insieme una cinquantina di milioni, tra Coop Adriatica, Farinetti, Unindustria, Granarolo e una miriade di banche. Non è ancora chiara la spartizione delle quote, o meglio, con quanto gli altri investitori abbiano partecipato al fondo. Certo è invece il fatto che patrimonio e capitale passano nelle mani di una SGR (Società di Gestione del Risparmio), nel nostro caso la Prelios SGR, ex-Pirelli Real Estate, dal 2012 detenuta da Massimo Caputi (immobiliarista famoso nelle cerchie romane; ex-compagno di merende di Caltagirone; spesso nel mirino delle Procure) e della famiglia Haggiag (famiglia di immobiliaristi vicina a Pirelli e al suo maggior azionista Marco Tronchetti Provera). E come recita l’articolo 36, comma 6, del Testo Unico della Finanza/1998 che regola i fondi immobiliari: “ciascun fondo comune di investimento costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascuna partecipante”, quindi, vada come vada, quel che è certo è che l’immenso patrimonio immobiliare del CAAB non sarà più in possesso del Comune ma passato nel patrimonio del fondo, senza contropartita economica. Dunque, se l’agro-Disneyland dovesse prosperare, il Comune ne godrà platonicamente (in fondo il CAAB l’ha generosamente messo a disposizione senza volere niente in cambio). Se invece, FICO dovesse essere un flop, il CAAB resterebbe in chissà quali mani private. Perché il patrimonio è del fondo, cioè di tutti e di nessuno, e andrebbe liquidato dall’amministratore per restituire le quote ai vari investitori, mentre il valore delle quote sarebbe pur sempre influenzato dall’andamento del prezzo sul mercato, dunque in balia
della speculazione.
In conclusione, per il Comune, l’unica certezza nell’affare FICO è l’aver perso il CAAB. Contrariamente alla retorica che voleva FICO ‘senza costi per il pubblico e ulteriore consumo di suolo’, FICO assorbirà 55 milioni di patrimonio pubblico (incluso un impianto fotovoltaico da 100.000 mq finanziato con soldi pubblici). Mentre il fatturato del CAAB conta attualmente 400 milioni di euro annui. In altre parole, si cede un’attività e una proprietà che portano utili al Comune, in cambio di…niente?! E per quanto riguarda il consumo di suolo, perché, se il centro commerciale dovesse fallire, non dovremmo temere una cementificazione massiccia nell’area del CAAB? In fondo, i nuovi proprietari ne potranno disporre a piacere e sappiamo che le autorità locali sono sempre avvezze di smussare i vincoli allo sviluppo urbanistico. Al proposito urge specificare che l’area è già nel mirino della riqualificazione urbanistica, individuata come facente parte del “Polo funzionale CAAB” in base a un accordo tra Provincia e tre comuni (Bologna, Castenaso, Granarolo) firmato nel lontano 2008 dall’allora Assessore all’urbanistica Virginio Merola. Il “Polo funzionale del CAAB” è “una partita urbanistica da 2,5 milioni mq” che punta, tra le altre cose, al “miglioramento del mix sociale del Pilastro”, con una “riqualificazione fisica e sociale” (leggasi gentrificazione). L’accordo, in sostanza, “dà il via libera al residenziale” e alla dismissione delle case popolari, mettendole in vendita. Di grandi opere in programma ce n’è per tutti i gusti: non solo residenziale privato, ma anche un nuovo centro commerciale, la metrò, la Lungosavena e, naturalmente, l’immancabile parcheggio. In altre parole, il tavolo è apparecchiato.
Ecco perché la vera posta in gioco di FICO è il Fondo immobiliare Parco Alimentare (Fipa). Infatti FICO, come l’Expo o il sottobosco delle SGR, sono solo alcune delle espressioni del proliferante ‘capitalismo di stato’, che sta prosperando indisturbato in Italia. Quel capitalismo, cioè, basato non tanto sulla lodata meritocrazia e competitività degli imprenditori, quanto sul parassitismo rispetto all’avere pubblico, sotto forma di privatizzazioni, appalti e sottrazione di patrimonio. Grazie all’accaparrare di risorse e patrimoni pubblici, questo tipo di economia prospererà sempre, perché azzera i rischi e massimizza i profitti. Di conseguenza, qualsiasi perdita viene riversata sulla collettività, meccanismo che la ‘crisi’ sta perfezionando a livello globale. Ma questa forma di profitto parassitario non potrebbe sopravvivere senza l’intermediazione complice dell’élite politica, locale quanto nazionale. Infatti, il progetto FICO è espressione del superpotere della Coop, a livello locale, e fa riferimento all’ala renziana del Pd, da Merola ai piani più alti, come lo dimostra il coinvolgimento della SGR Prelios, società il cui detentore vanta documentati rapporti col Pdl e i palazzinari Romani che, si sa, sono politicamente trasversali. Del resto, la rapidità con cui la giunta Merola ha propulso il progetto FICO ci fa immaginare che i vertici politici siano stati oleati a dovere e che, dunque, possano immaginare la massiccia posta in gioco.
In sostanza, come nel caso dell’Expo, il modello ‘EXBO’ (dall’Expo di Milano a Bologna) è molto semplice: interessi privati, investimenti pubblici, guadagni privati (fonte). Per qualche strana ragione, il pubblico, che è il maggior investitore in questi fantasmagorici progetti, non avanza mai nessuna clausola. E’ possibile procedere diversamente? Come sostenere l’impegno dei politici, che sembrano ‘disarmati’ nel negoziare col privato? Ecco alcuni suggerimenti.
1. Privatizzare il rischio (una volta tanto)
Se questi progetti sono così irresistibili come vengono presentati, perché i privati non ci investono in prima persona? Con una bella asta pubblica e rispettando il valore del CAAB, evitando, cioè di regalarlo, Coop e Farinetti si potrebbero aggiudicare il terreno pubblico e procedere allo sviluppo, magari contraendo un credito che siano in grado di ripagare, senza metterlo sulla schiena dei cittadini. Fare profitti lasciando il compito di investire al pubblico (cioè a tutt* noi) è molto accomodante, perché non si corrono rischi alcuni. Lo spazio viene ceduto gratuitamente, si ha la possibilità di avviare un gigantesco ipermercato di lusso e, se questo non dovesse funzionare, si può sempre ripiegare sulla ‘riqualificazione urbana’ (leggasi cementificazione), visto che il terreno e gli edifici non torneranno mai in mano pubblica. In sostanza, FICO potrebbe essere una bella operazione di spoliazione del patrimonio pubblico mascherata dall’avvio di un centro commerciale di lusso.
2. Vincolare la cessione del CAAB e il suo ritorno in mani pubbliche
Teoricamente, sempre in base al misterioso business plan di Ernst & Young, FICO travolgerà il panorama alimentare internazionale. Le proiezioni, a cui tutti credono con religiosa riverenza e gratitudine, sono di un minimo di 5 milioni di visitatori l’anno. Per ripagare l’originalità di un progetto talmente ambizioso, il Comune non può evidentemente evitare la concessione gratuita del CAAB. Ma perché non potrebbe pure vincolarla, questa cessione? Limitarla, per esempio, a un paio d’anni. Secondo la presentazione del progetto in Comune, fino al 2019 FICO accoglierà almeno 26 milioni di visitatori. La clausola potrebbe essere: se i cinque milioni di turisti l’anno non dovessero arrivare, stabile e terreno rientrino nel patrimonio pubblico. In questo modo l’investitore pubblico, per una volta, potrebbe tutelarsi, anzi che subire e ammortizzare perdite solamente.
3. Reclamare utili proporzionali agli investimenti e potere di veto sulla gestione
Ma se l’affare dovesse funzionare, il CAAB, quindi il Comune, avendo messo a disposizione metà delle risorse per il fondo immobiliare Parco Agroalimentare, dovrebbe reclamare il diritto ad altrettanti utili che ritornino al Comune, e la cui destinazione venga tassativamente decisa in maniera democratica e trasparente, in conformità con i bisogni della città. Non rischiando dunque di riempire le tasche di palazzinari e speculatori sotto forma di cementificazioni e devastazioni urbanistiche, sotto le mentite spoglie di ‘riqualificazioni urbane’. Allora risulterebbe piuttosto evidente che la città non ha bisogno di un altro People Mover o Civis, ma di case popolari e sostegno per la sanità e l’educazione pubblica. Allo stesso tempo, il Comune dovrebbe reclamare il diritto di controllare l’operato della SGR, cioè dell’amministrazione del fondo, per appurare se e come provveda alla tutela del patrimonio ceduto, con il diritto, in quanto maggior investitore, di sanzionare l’amministratore. Ma lo sapete perché questo è impossibile? Primo, perché il Comune – nella sua infinita generosità – non vuole una controparte in cambio della cessione del CAAB (Farinetti, da comunista, avrà insistito, ma Merola non ne ha voluto sapere). In secondo luogo, perché la SGR che gestirà il fondo immobiliare che ha assorbito la proprietà del CAAB non dovrà rendere conto al Comune delle sue decisioni. Cosa possiamo fare? Siamo forse impotenti di fronte a questa spoliazione a colpi di marketing farinetto-renziano (che, sappiamo, non annunciare mai, niente di buono)? Nient’affatto. La prima arma è quella dell’informazione. Informarsi, facendosi strada nella giungla dell’aziendalese, bisogna rivelare i meccanismi e gli effetti di queste
operazioni economiche. Nel contesto della crisi, poiché basata sulla speculazione e l’indebitamento, il senso di inferiorità intellettuale è centrale e indispensabile al potere. Si tende a prostrarsi di fronte all’expertise dei 'professionisti dell’investimento', come se fossero gli unici in grado di cavalcare l’imprevedibile andamento del ‘mercato’, mentre quello che si nasconde dietro la volatilità del ‘mercato’ è un'inevitabile un’erosione, per non dire il costante esproprio, dell’avere pubblico. In secondo luogo bisogna fare pressione sugli intermediatori di questa spoliazione. I grandi gruppi di interessi privati hanno bisogno dei loro ‘facilitatori’ politici, per dare una parvenza di legittimità all’esproprio. Perciò, i politici devono essere direttamente responsabili di fronte alla cittadinanza delle conseguenze delle loro concessioni e il loro operato va monitorato e sanzionato, non solo elettoralmente, ma anche con ulteriori responsabilità giuridiche rispetto all’esito di simili operazioni. E la giunta bolognese ha già ampiamente spianato la strada al progetto con una rapidità senza precedenti, il che fa immaginare che il progetto sia oggettivamente inattaccabile. Chi si assumerà le responsabilità se si dovesse verificare il contrario? Perché accettare placidamente che i politici giochino d’azzardo con i beni pubblici, senza assumersi la responsabilità delle firme che facilitano massicci passaggi di proprietà? In ultima istanza, se la collettività dovesse realizzare la portata dell’esproprio del CAAB, è giusto fare pressione perché l’intero progetto si trasformi o si fermi addirittura, tutelando collettivamente gli spazi pubblici e riempendoli di contenuti e attività che possano arricchire e abbellire la vita della cittadinanza, anzi che sottoporla alla mercificazione e precarizzazione made in Eataly.