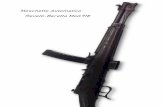Demitizzare il Novecento, note critiche al libro di Marco Revelli
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Demitizzare il Novecento, note critiche al libro di Marco Revelli
:e redistributiva. volontario, così resta' sulla cari-esplicita inten
rsonali e azione :itro il rischio di
se ciò sia poss1-nni di controritradizionali pra-epidemiologica
tazione o i blocYli comunali o le ~
ova modalità di Jon truppe, non dinate, ma indi~ente, insomma, one tra sé e gli ~rse delle grandi ~rsone capaci di agone logiche di wo 'militanti', il tari'. A me pare
OLTRE IL NOVF.CF.~TO
Demitizzare il Novecento Note critiche al libro di Marco Revelli
di Simone Lanza
Il libro di Marco Revelli parla della fine di un'epoca rivoluzionaria e prelude a nuove forme cli azione poli tica diverse da quelle de l Novecento. È un libro che parla delle prassi politiche del comunismo storico novecentesco. È un libro che è stato attaccato dalle colonne del quotidiano comunista Il Manifesto, in cui da Pintor è stato definito «il libro più organicamente anticomunista»1 che avesse letto. Eppure le tesi di Marco Revelli vanno prese sul serio, come alcuni critici hanno fatto, a partire da un uomo d'azione quale Bertinotti.
Cercherò di articolare quelli che mi sembrano dei punti di forza delle tesi di Revelli, intorno ad alcune parole chiave del suo discorso: organizzazione scientifica del lavoro, sviluppo, senso, violenza, comunità. Contemporaneamente svilupperò alcuni spunti e richiamerò liberamente alcuni saggi critici.
Organizzazione scientifica del lavoro L'organizzazione scientifica del lavoro come è stata teorizzata da Taylor costi
tuisce il punto di partenza dell'analisi di Revelli. In questa fine analisi si mostra come questo modello di organizzazione fosse condiviso da Lenin, Gramsci e da tutti i comunisti. Questo mito produttivista costituì la base non esplicitata non solo della Russia rivoluzionaria ma di tutto il comunismo storico novecentesco. Qui una prima origine dell'eterogenesi dei fini, per cui - credendo di costruire il socialismo - stavano costruendo una megamacchina. Secondo Revelli il modello taylorista non fu un mero modello di organizzazione di fabbrica, ma un «organico e inedito modello sociale, un sistema integrato di nuove tecniche, nuove relazioni sociali e nuove forme istituzionali focalizzate intorno alla centralità della produzione» (p.469) Insomma il lavoratore di fabbrica fu il nuovo soggetto egemone, o come scrisse Gramsci: «il fordismo è il maggior sforzo collettivo verificatosi finora per creare, con rapidità inaudita e con una coscienza del fine mai vista nella storia, un tipo nuovo di lavoratore e di uomo»2. L'Operaio è il modello di uomo per il reazionario Ji.inger come per il rivoluzionario Gramsci: è il soggetto egemone nel secolo della razionalizzazione in cui la logica produttivista della fabbrica è fondamento relazionale e in cui produzione e riproduzione non sono più separati, in cui cioè non sono separati l'ambito del lavoro e l'ambito della vita. Revelli osserva come nei 011aderni Gramsci notasse che lo stesso capitalismo avesse creato le condizioni in cui il «lavoratore collettivo operasse come una macchina entro un sistema di macchine» (p.47) e si compiacesse quasi che questa organizzazione così efficiente non facesse sprecare energie sessuali all'operaio, esigendo da lui la monogamia.
A essere decostruito è quel Gramsci che scriveva: «Il potere concreto immediato del Partito socialista è quindi il problema del potere, è il problema dei modi e delle forme per cui sia possibile organizzare tutta la massa dei lavoratori italiani
113
Alternative/i, n.2, giugno2011
SIMONE LANZJ\
in una gerarchia che organicamente culmini nel Partito»3. Massa organizzata in partito, come nella fabbrica.
Rimanendo nello spirito di decostruzione di Revelli credo che sarebbe interessante mettere in relazione come i tratti del mito taylorista della fabbrica (efficiente, razionale, gerarchico - tutti attributi che le donne ci rinfacciano quotidianamente) siano esplicitamente riconosciuti ed esaltati in uomini d'azione del Novecento tanto diversi tra loro come Hitler, Lenin, Ohno, accomunati dall'ammirazione per Taylor. Dal libro di G. Alvi,4 si possono estrapolare molte citazioni di comunisti che hanno creduto nel mito del collettivismo macchinale. Per esempio Gastev e Lenin, elogiando il nuovo spirito collettivista della rivoluzione: «La psicologia rivela un nuovo collettivismo nella classe operaia, che si manifesta non soltanto nelle relazioni tra le persone, ma nelle relazioni di interi gruppi di persone con interi gruppi di meccanismi. Questo collettivismo può dirsi collettivismo meccanizzato. Le manifestazioni di questo collettivismo meccanizzato sono così estranee alla personalità, così anonime, che il movimento di questi complessi collettivi è simile a quello delle cose». Credo che questa citazione ci riporti al problema centrale: ciò che occorre fare per andare oltre il Novecento, non è - come diversi critici di Revelli pretendono - separare definitivamente il comunismo dallo stalinismo,s ma separare ogni nuova prassi di liberazione dal mito del taylorismo. La frase riportata ci deve infatti condurre a una spietata riflessione sul nodo posto da Revelli: il mito taylorista fu fatto proprio senza critiche dal comunismo storico novecentesco, e questo, sia detto en passant, 111algré Marx, e le scoperte (in ambito teoretico) dei Grmzdr:sse e del VI libro inedito del Kapital Revelli ci propone di lasciare alle spalle tutte quelle teorie che definisce !iberazio11iste, secondo cui le trasformazioni in atto nel capitalismo, nelle sue componenti tecnologiche, e le trasformazioni da esse indotte nelle mentalità collettive, ampliano i margini di possibile autonomia e moltiplicano le possibilità concrete di liberazione (p.191).
Benché il comunismo si sia presentato (storicamente) con il progetto utopico di liberazione dal lavoro, tale progetto si è molto radicato nel mito produttivista -occidentale, direbbe Latouche - secondo cui lo sviluppo tecnologico avrebbero lasciato alle macchine le peggiori fatiche. Mito questo però tutto novecentesco che il comunismo condivise con il suo nemico capitalista, mito che oggi si moltra per la sua totale infondatezza. Tecnocratico e sviluppista questo sogno di liberazione dal lavoro faceva affidamento allo sviluppo delle forze produttive più che al rovesciamento dei rapporti di produzione in al!ra produzione, altro rapporto tra genere umano, natura e strumentor'.
Proprio Keynes - teorico del capitalismo del Novecento - profetizzava infatti un futuro che, grazie allo sviluppo tecnologico, nel 2000 avrebbe permesso all'umanità di lavorare solo tre ore al giorno! Una umanità che avrebbe «disprezzato il denaro», diceva Keynes, assicurando che «rivaluteremo di nuovo i fini sui mezzi e preferiremo il bene all'utile». Keynes che concludeva: «Ma attenzione! Il momento non è ancora giunto!»7. Come il capitalismo negava nella pratica ciò che i suoi profeti promettevano, così il socialismo negò nella pratica ciò che prometteva per il sol dell'avvenire.
114
Alternative/i, n.2, giugno2011
nizzata in par-
: sarebbe intefabbrica (effi
no quotidiana-d' azione del
:iati dal!' ammi.lte citazioni di ::. Per esempio Jne: «La psicoifesta non soldi persone con :ivismo meccao così estranee ::ssi collettivi è problema cen)me diversi cri-11!0 stalinismo,5
La frase riporto da Revelli: il ) novecentesco, ) teoretico) dei .ciare alle spalle mazioni in atto 1azioni da esse tonomia e mol-
rogetto utopico , produttivista -gico avrebbero wecentesco che gi si mostra per 8 di liberazione più che al roveiporto tra gene-
1fetizzava infatti permesso all'u
:: «disprezzato il fini sui mezzi e
.ne! Il momento ) che i suoi pro:ietteva per il sol
0URE IL NOVECENTO
Sviluppo Secondo Paolo Ferrero, uno dei più attenti critici, la tesi di Revelli, secondo cui
il welfare ha prodotto una de-socializzazione della sfera produttiva e una rottura di vincoli di reciprocità, mutua assistenza e vincoli sociali, è «eccessivamente organicista». Si chiede infatti Ferrero: come non vedere che il 1velfare state ha allungato le vite medie? come si fa a non vedere che la scolarizzazione di massa è un fenomeno positivo? E continua: «il non vedere il miglioramento delle condizioni di vita del complesso della popolazione, il non vedere gli elementi di nascita di una nuova qualità della socializzazione che sono insiti in quella dissoluzione della tradizionale economia domestica che Revelli descrive come una disgrazia, il non vedere l'elemento liberatorio - contraddittorio ma liberatorio - che è stato per milioni di donne il poter uscire di casa per andare a lavorare - magari per fare un lavoro di merda -mi sembra un errore clamoroso» s.
Mi pare la critica più azzeccata e più esplicita a Revelli, al cui confronto molte altre tesi risultano superficiali. A Ferrero dunque il merito di aver evidenziato delle perplessità che molti condividono e che sono alla radice della disapprovazione, benché solo parziale, del libro di Revelli. A Revelli il demerito di non averle spiegate sufficientemente bene. Eppure il libro di Revelli riguarda la prassi storica del comunismo, non Ja discussione delle categorie di filosofia della storia: Ferrero infatti esplicita che il suo dissenso verte sulle categorie di filosofia delJa storia di cui il libro di RevelJi è portatore. 9 L'errore di Ferrero e di altri consiste tuttavia proprio nel fossilizzarsi, nel rifiutare le categorie poco dialettiche adoperate da Revelli, nel rifiutarne la visione del 111ondo e di evitare gli interrogativi che tale visione pone al 1J1ondo. Revelli non vuole analizzare la dialettica del comunismo - il bene e il male insiti ne] movimento storico reale - ma mettere a nudo i miti che nel Novecento il comunismo ha fallimentarmente condiviso con il suo avversario, per prenderne definitivamente ]e distanze. Reve]li su questo non è andato fuori tema, i suoi critici spesso sì1 11 •
Il secondo grande mito che il comunismo mutuò dal suo secolo fu quello dello sviluppo 11 . Revelli racconta come il piano Marshall fu l'inizio del donare per accumulare (p.62), che sarà poi Ja caratteristica delle politiche di sviluppo del Nord nel Sud del mondo per i successivi 50 anni. Un dono avvelenato, con cui il capitalismo del Nord ha chiamato sviluppo il neocolonialismo. Secondo Sullo: «Revelli costeggia, senza assumerle fino in fondo, le tesi ad esempio degli antiutilitaristi (e cita Latouch'è-e Caillé), i quali svolgono una critica radicale della ragione strumentale, dei suoi deliri produttivistici e della conseguente occidentalizzazione del mondo»12.
Revelli segnala come la forza del capitalismo novecentesco fu ]a virtù keynesiana di trasformare l'antagonismo operaio in motore di sviluppo: «l'aumento de] potere d'acquisto delle masse lavoratrici, il loro consumo crescente e il loro accesso codificato in forma di diritto sociale a un ventaglio amplio di servizi gratuiti sarebbero diventati condizioni permanenti dello sviluppo e dell'accumulazione capitalistica». (p.62) Oggi noi sappiamo che quei diritti sociali furono possibili grazie a una globalizzazione crescente, una sussunzione delle economie domestiche del Sud del mondo a quella capitalistica. Se da un lato infatti il 1velfare state si è presentato come una conquista della classe operaia, e certamente la redistribuzione fu
115
Alternative/i, n.2, giugno2011
SIMONE L/\NZ/\
conquistata con grandi lotte, dall'altro lato si dimentica che gli stati sociali sorsero
sfruttando il Sud del mondo. Mi sembra una questione cruciale: <<la lunga, tormentata, per nulla lineare
vicenda nel corso della quale si è comumato lo spostamento del terreno fondamentale dello scontro sociale dalla questione dell'autonomia dei produttori a quella della distribuzione del surplus. Il passaggio cioè, dalla residua resistenza operaia, lascito della precedente fase artigiaua., a cedere il controllo sul proprio corpo e sul proprio prodotto - che aveva ancora dominato lo scenario ottocentesco e che fu definitivamente sconfitto a ridosso della seconda rivoluzione industriale ... » (p.69, corsivo mio).
Penso al Capitale, che descrive l'origine del processo di sussunzione del lavoro al capitale con lo sradicamento dall'economia domestica, dove manifattura e agricoltura erano saldamente legate (e in sapienti mani femminili, direbbe V Shiva): «Così l'espropriazione dei contadini che prima coltivavano in proprio e il loro distacco dai mezzi di produzione procedono di pari passo con la distruzione dell'industria sussidiaria rurale, con il processo di separazione di manifattura e agricoltura. E solo la distruzione dell'industria domestica rurale può dare al mercato interno di un paese l'estensione e la salda consistenza delle quali abbisogna il modo di produzione capitalistico»13. Credo che questo processo non sia solo da vedere nel passato ma abbia molte analogie con quello in atto oggi. E penso che questo processo abbia molte analogie con ciò che stanno subendo le comunità indigene in lotta in Chiapas come in Ecuador, in India come in Brasile.
Allora non solo Revelli parla di una lunga, tormentata, per 1111lla lineare vicenda, ma questa vicenda ha tratti strutturali che ancora ritroviamo in quell'allargamento geografico del capitalismo nella sua fase attuale di sussunzione dell'economia domestica del Sud del mondo: per i prossimi 20 anni, con questo modello di sviluppo, avremo una riduzione dagli attuali due terzi della popolazione agricola mondiale a un solo terzo: baraccopoli, periferie, violenza, polizia, ecc. .. Una della cause delle emigrazioni è il processo di pauperizzazione delle campagne del Sud del mondo, quella che Marx definiva appunto la distruzione dell'industtia smsidiaria rurale, con il processo di separazione di manifattura e agricoltura. L'industrializzazione delle campagne del Sud del mondo (oggi in primo luogo dovuta alle biotecnologie) rappresenta un passaggio simile al processo descritto da Revelli; eppure oggi abbiamo la possibilità di evitare quel passaggio, nonostante chi come Ferrero ritiene che oggi ancora (come già per Hegel e Marx) lo sviluppo economico e sociale novecentesco abbia permesso un «superamento dei precedenti legami sociali»14. Oggi gli zapatisti pretendono !111 mondo che contenga molti mondi (e molte visioni del mondo, molte filosofie della storia). Oggi è possibile evitare che la storia si ripeta come farsa, evitare che tutte le comunità esistenti nel mondo passino dallo sviluppo novecentesco. Evitare il destino delle megalopoli significa evitare a un terzo dell'umanità alcune sciagure del Novecento oltre alle altri ben peggiori che si stanno profilando, significa andare alle radici di alcune cause dello sfruttamento planetario, significa iniziare a praticare nuove forme di sviluppo locale, significa studiare diverse tecnologie (appro
priate). Riportandoci alla iniziale resistenza operaia al processo di controllo e indivi
duando come perniciosa la fase di distribuzione del benessere prodotto industriai-
116
Alternative/i, n.2, giugno2011
lti sociali sorsero
per nulla lineare •fondamentale dello istribuzione del suri precedente fase ::lotto - che aveva iente sconfitto a io). J.zione del lavoro .anifattura e agrijrebbe V. Shiva): prio e il loro dis!struzione dell'induicoltura. E solo la :erno di un paese produzione capipassato ma abbia esso abbia molte in Chiapas come
·neare vicenda, ma llargamento geoeconomia dome::lello di sviluppo, ricola mondiale a della cause delle Sud del mondo,
z·a rurale, con il pro:lle campagne del )presenta un paso la possibilità di 5gi ancora (come itesco abbia per-zapatisti preten
J, molte filosofie farsa, evitare che centesco. Evitare à alcune sciagure o, significa anda:a iniziare a praticnologie (appro-
::rntrollo e indivi)dotto industriai-
0URE IL NOVECENTO
mente, la prospettiva di Revelli, proprio perché vede in Taylor il male del secolo, ci apre a prospettive antisviluppiste, che devono sapere inventare un'altra tecnologia, ecologica, democratica, sostenibile. Ci porta a riflettere sul luogo in cui il movimento reale che si oppose allo stato di cose esistente iniziò a far proprio il mito alla base della civiltà dello sfruttamento capitalistico che invece voleva sovvertire.
Così Revelli esce veramente non solo dal Novecento ma anche dall'eurocentrismo. Benché citi appena Latouche, esce dalla logica marxista e operaista secondo cui il capitalismo nel punto più alto del suo sviluppo produce le contraddizioni da cui scaturirebbe il suo superamento; contraddizioni da ricercare nel modo di produzione della società. Prospettiva quindi opposta a quella di Toni Negri,1s che sposta lo sguardo dalla produzione di fabbrica alla produzione immateriale, alla perenne ricerca del soggetto storico della trasformazione, finendo con l'individuare nel solo Nord il luogo del superamento dell'oppressione. Ma si sbaglia Negri (e con lui tutti i marxisti che persistono nel ricercare nei punti alti dello sviluppo le contraddizioni del superamento capitalistico), e noi oggi infatti - attivisti antineoliberisti - ringraziamo gli zapatisti, i Sem Terra, i contadini indiani che, come ha recentemente commentato Chomsky, possono cambiare il corso della storia del mondo.
Dal militante al Volontario, volontà vs razionalità Nonostante alcuni critici del Manifesto facciano apparire le cose diversamente,
nel libro di Revelli esiste una breccia, una finestra che già nel Novecento ha posto le basi per l'uscita dal Novecento stesso. «Così fu nei giorni di Maggio in cui la gréve gènérale paralizzò la Francia, e nel silenzio delle macchine utensili, dei treni, degli uffici e del traffico, gli uomini tornarono a far sentire le proprie voci, a parlarsi tra loro, a incontrarsi» (p.82).
Veramente poco scientifica e molto letteraria, questa descrizione del Maggio francese. Molto letterario e quindi molto vicino alla verità questo accostamento di sciopero e incontro, silenzio delle macchine e parola della politica. L'utilizzo di romanzi e lo stile talvolta esso stesso letterario e poco scientifico hanno fatto irritare div~rse persone tra cui un esaltato critico di Revelli: «A Revelli non interessa mostrare catene fattuali e nessi causali, ma affermare un convincimento: l'idea che la storia dell'ultimo secolo si sia svolta sotto il peso della maledizione della volontà di potenza della Ragione moderna: di qui il trionfo della violenza nichilista del Lavoro e della Tecnica, violenza di cui il comunismo pare a Revelli costitutivamente impregnato»16. Revelli non getta via il bambino con l'acqua sporca, riconosce brecce all'interno del Novecento anche se non le narra tutte: scopo di questo libro non è di descrivere tutte le brecce che già nel Novecento hanno annunciato l'uscita possibile dal capitalismo, ma di suggerirne i tratti, che grazie al suo stile preciso e documentato quanto pieno di passione letteraria, ha saputo egregiamente evocare. Del resto, il più grande politico di oggi (Marcos) non parla per nessi fattuali e causali, ma per metafore e fiabe, e Revelli scrive - lo ripeto - per attivisti politici non per accademici da salotto.
Ha fatto poi molto discutere la tesi di Revelli secondo cui il 1Jlilitante deve lasciare spazio al Volontario. Intendiamoci però sui termini. Per militante Revelli
117
Alternative/i, n.2, giugno2011
SI~IONE L\Ni'.r\
intende colui che trova il senso del suo agire in qualcosa a lui esterno. Revelli descrive così come tragici alcuni militanti russi, eliminati dallo stesso partito, che non sapevano più trovare alcun senso al loro esistere. Paradigma negativo 17 è il modello estremo staliniano in cui il partito sussume ogni fine e l'intera gamma delle relazioni umane (amici, famigliari, ecc ... ) perdendo però poi assolutamente ogni senso. Il volontario di Revelli ha qualcosa a che vedere con il desiderio situazionista quale unico contrasto del sistema logico delle merci (Debord e Vaneigem, cit. p. 80). È quindi l'opposto del compagno staliniano.
Effettivamente Revelli non trova una espressione adatta, 18 e mi sembra proprio infelice questo termine Vo/011/ario; eppure decostruendo il mito del compagno comunista descrive con compiutezza i tratti essenziale di questa nuova figura rivoluzionaria alborale: una diffusa «trama di atomi positivi è da tempo in azione» che resiste alla furia del movimento economico. Trama che annoda fili di legame sociale, che fa della debolezza la sua risorsa. Fili con cui i lillipuzianiI9 potranno fermare il gigante mostro economia che tutto inghiotte. Privo di sapere organico e predittivo, non scinde ragione e passione. La sua logica è <<la disseminazione, la multiattività, la messa in rete dell'eterogeneità». Un fare gratuito, sociale, cooperativo, non segnato dal segno negativo del lavoro, che vive in forma confusa, mai lineare, sincretica e reticolare: una pratica dal basso capace di identificare momenti globali (Seattle) in cui rappresentare la propria vocazione globale (p.282-286).
Sullo ha portato la discussione sui giusti binari: «Perciò Negri scrive che non sarà 'la compassione' a spostare il mondo. Non saranno i 'cristiano-sociali', dice Luigi Pintor. Scorciatoia che intanto rifiuta di prendere atto come non si spieghi se non con la con-passione, con la con-divisione, il fatto che il figlio di un piccolo borghese maestro di scuola divenne il capo della rivoluzione mondiale: un certo lllianov, che poi ci fabbricò sopra la teoria dell'avanguardia»20.
Il compagno comunista è una figura antropologica che deve scomparire con tutte le virtù e i vizi che gli erano connaturati. Tale figura è stata decostruita a suo tempo, e probabilmente con maggiore profondità, da Costanzo Preve,21 che ne aveva messo in luce l'origine antropologica tutta novecentesca nella invenzione leninista del Partito. Preve aveva sostenuto che Lenin si rese conto dell'ambiguità di Marx il quale, da un lato, descriveva il comunismo come movimento che abbatte lo stato di cose esistente, dall'altro confuse un soggetto sociale (operai) con un soggetto filosofico 0a classe rivoluzionaria dei proletari). Il comunismo ottocentesco oscillò quindi tra una posizione crollista, secondo cui il capitalismo si sarebbe esaurito da solo, e una spontaneista, secondo cui la classe operaia sarebbe di per sé portatrice dell'universalismo comunista. Affinché il proletariato diventasse soggetto di instaurazione di un universalismo autentico era necessario - per Lenin - introdurre il concetto di Partito: nasce così il comunismo storico22 novecentesco che univa gli intellettuali borghesi illuminati con la classe operaia, ponendo questi de facto alla guida del proletariato. Militanza e rappresentanza sono due aspetti conti-nui - secondo Preve - del partito novecentesco leninista: il compagno nacque così con la virtù della appartenenza al Partito, la virtù del sacrificio per la Causa, lo Spirito di sacrificio, e alla sua religione ateista, con la sua citologia secondo cui neppure gli eterodossi mettevano in discussione la Scrittura di Marx, e via dicendo.
118
Alternative/i, n.2, giugno2011
rno. Revelli descri:::i partito, che non rativol7 è il model-' gamma delle rela-.mente ogni senso. situazionista quale gem, cit. p. 80). È
e mi sembra pro-1ito del compagno nuova figura rivo-1po in azione» che ili di legame socia-9 potranno fermare organico e preninazione, la mulciale, cooperativo, nfusa, mai lineare, e momenti globali -286). gri scrive che non tiano-sociali', dice e non si spieghi se di un piccolo borondiale: un certo
'e scomparire con decostruita a suo
o Preve,21 che ne . nella invenzione nto dell'ambiguità mento che abbatte (operai) con un 1nismo ottocentetalismo si sarebbe . sarebbe di per sé :liventasse soggetper Lenin - intronovecentesco che ionendo questi de due aspetti conti•agno nacque così . per la Causa, lo secondo cui nepe via dicendo.
Or;rnE IL NOVECENTO
Revelli critica questo Partito sullo stesso terreno. Una volta creato, il partito diventò libero di non dire la verità al popolo, di occultarla. Partito che, secondo Revelli, compirà il peggior peccato «nella guerra alle autonomie del sociale» (p. 245). Con la perdita di legame tra popolo e verità si perse anche il senso dell'agire politico. Rubasciov, protagonista di Darkness, romanzo di Koestler, si chiede al termine dei suoi giorni: «Per che cosa muoio? Mi trovo di fronte al nulla assoluto. Non c'è nulla per cui si possa morire, se si muore senza essersi pentiti, senza essersi conciliati con il Partito e il Movimentm>23. L'invito di Revelli è a lasciare alle spalle questa idea di dedizione alla causa del Partito dove «l'autonomia individuale è messa a tacere con la forza delle cose grandi e di tutti di contro alla piccolezza delle questioni personali (dei singoli) » (p.257).
Ripensare oggi una nuova figura di attivista significa ripensare anche il ruolo degli intellettuali, vertice della piramide nel partito gramsciano-leninista; intellettuali che devono uscire dalla concezione metafisica di verità come adeguamento di realtà e pensiero per rivestire il ruolo più umile di tessitori ·di reti nei movimenti, di traduttori di linguaggi e gerghi, di facilitatori della comunicazione; nei movimenti, non alla testa dei movimenti. In questo l'intellettualità femminile, letteraria e non filosofica, radicata nel personale e nella pratica dell'ascolto, potrebbe costituire un punto di ripartenza per noi maschi attivisti perché ci chiama alla costruzione di quel comune sapere non organico né predittivo, che lega ragione e passione, sapere a cui Revelli ci invita.
Così come la concezione di verità - parola che in Revelli ricorre molto - deve essere ripensata dalle categorie di Arendt sul giudizio estetico kantiano: la verità è quella che appare e si disvela nel discorso comune, quella che si riconosce nell'altro/ a, quella che emerge nel discorso, nel confronto, quella che nasce nell'influenzamento reciproco sui gusti, quella dello spazio pubblico dell'apparenza umana. La verità non è dei partiti né dei suoi leader ma nella prassi di condivisione; la verità sola anima il coraggio e la ribellione, cioè l'azione.
Violenza Ricorre nel libro di Revelli un totale rifiuto della violenza. Revelli avvicina tre
episodi di violenza così diversi, come furono l'esperienza del campo di concentramento tedesco, la bomba atomica, e i comunismi storici del Novecento, facendosi dare del revisionista da chi del suo discorso non ha capito nulla. Ho associato questa mai dichiarata presa di posizione nonviolenta di Revelli - benché dubito che Revelli si definisca nonviolento - con l'inizio del discorso di Zanotelli all'incontro della rete Lilliput: «Se me lo permettete volevo partire con un volto: il volto di Renato Curcio. L'ho incontrato quando era in carcere a Re bibbia. Credo fosse il '91. È stato un incontro che mi ha sconvolto. Sono stato portato lì perché ha chiesto di vedermi. Sono entrato e sono stati tre quarti d'ora stupendi, intensi e bellissimi. Alla fine lui mi ha detto una cosa che mi ricorderò sempre: 'Alex, lo sbaglio di noi brigatisti è stato solo uno: aver creduto a Machiavelli, che il fine giustifica i mezzi.' Io gli ho risposto: 'Guarda Curcio che non sei stato il solo ad aver creduto a ciò; anche i tuoi nemici politici lo credevano fermamente ed hanno usato lo stesso sistema'. 'Alex', mi risponde lui, 'sono arrivato ad un punto della mia vita in cui sento
119
Alternative/i, n.2, giugno2011
che non posso più usare nessuno per qualsiasi progetto di chissà quale tipo: ogni uomo è fine a se stesso'»24.
Più che machiavellica questa posizione storica per la violenza buona fu posizione masdule. Una violenza che il comunismo fece propria quando iniziò a essere a capo dello Stato in Russia. Violenza mutuata quindi dallo Stato. Una violenza che non si è introdotta nella storia per il comunismo, perché non furono i comunisti i responsabili della trasformazione della rivoluzione in guerra, ma una violenza che si impossessò del comunismo al punto da agirlo da dentro, modellandone habitm e a11ÙJJus (pp. 225-227). Una violenza in primo luogo verbale che ho poi ritrovato in tante riunioni politiche degli anni Novanta negli ambienti da me frequentati, ormai lontani dalle purghe e dagli assassini politici. Per questo il libro di Revelli è importante anche se fa male a molti leader di partitini e partitoni.
Dal deserto della fabbrica agli approdi domestici Il libro di Revelli ci apre a due prospettive nuove, tesorizzando l'esperienza
negativa del Novecento e sfatando definitivamente i suoi due miti (taylorismo e sviluppo): una via nonviolenta alla politica e un ripensare la politica sotto il segno della non centralità del lavoro. Oserei dire: un ripensamento della politica a partire dalla centralità dell'economia domestica, luogo d.i incontro/ scontro del senso della riproduzione sociale, di uomo e donna. Ma qui risiede anche il primo limite del libro che vorrei sottolineare: la visione di ge11der manca. Certo è ingeneroso rimproverare quello che è mancato a tutto il secolo; dobbiamo inventarla, crearla, in luoghi prima solo maschili e poi misti, non possiamo lasciare ancora sole le donne a discutere sulle differenze di genere: il patriarcato è dominio che deve essere messo in discussione da entrambi i sessi. Se la rivoluzione meglio riuscita del Novecento è quella delle donne, dobbiamo ripartire dalla possibilità di mettere in gioco un essere maschile non sessista, possibilità ancora aperta perché questo maschio nuovo non esiste affatto, o esiste poco. E forse lo spazio di ripensamento potrebbe essere quella dimensione domestica, quella Oikia che il Novecento, offrendo l'illusione di liberazione delle donne nello spazio sociale della fabbrica, ha in realtà modellato secondo i ritmi e i movimenti, il nonsenso della fabbrica (p.135).
Un secondo limite di Revelli è comunque l'avere assolutizzato l'Operaio. Nel mondo fino ad oggi - in Cina, India, Africa, America Latina - la realtà è maggiormente rurale. Revelli ammette chiaramente nel dialogo con Bertinotti su Carfa25 che il suo libro vuole fare i conti con il deserto identitaria prodotto dalla fabbrica, anche se, nel libro, mai esplicita il suo scenario: una triste Torino, geometrica e silenziosa, dove la classe operaia è andata davvero in paradiso. Su questo Revelli aveva gi~ scritto partendo da un dato psichiatrico: una grande massa di cassintegrati dal 1981 passò per i centri di salute mentale torinesi o per depressione, o per tentativi di suicidio; la maggioranza veniva dal Sud, aveva tra i 30 i 50 anni, erano i compagni del ciclo di lotte che si era chiuso26. E giustamente si chiede: ma che grande identità era quella che questi migranti si erano costruiti se poi con la scomparsa della fabbrica non aveva lasciato nulla. Assenza totale di senso. Eppure oggi il senso viene da voci oppresse ma numerose, quelle indigene e campesinas, zoccolo duro del popolo di Seattle. Il novecento non è stato - a livello mondiale - proleta-
120
Alternative/i, n.2, giugno2011
uale tipo: ogni
mana fu posi) iniziò a esseU na violenza
1rono J comua violenza che 1done habitus e oi ritrovato in _uentati, ormai ~velli è impor-
o l'esperienza 1lorismo e svi) il segno della a partire dalla
:1 senso della mo limite del ~eneroso nmrla, crearla, in sole le donne
e deve essere o riuscita del di mettere in
'erché questo ripensamento J Novecento, .a fabbrica, ha Jbrica (p.135). 'Operaio. Nel tà è maggiorsu Cartazs che lalla fabbrica, geometrica e iuesto Revelli i cassintegrati :i.e, o per ten-
. . anni, erano J
jede: ma che con la scomEppure oggi
sinas, zoccolo :aie - proleta-
0ITRE H. NOVECENTO
rio. In queste pagine mi sono sforzato di evitare di dire - come molti critici hanno invece fatto - ciò di cui Revelli non ha parlato. Devo dire però che non posso trattenermi dall'esplicitare un mio rammarico per non aver letto spunti su quel filo rosso del comunismo comunitario nel Novecento, quella storia delle associazioni di mutuo appoggio e di soccorso operaio, quando le comunità sostenevano gli scioperi a oltranza, quando l'autonomia dcl movimento era maggiore, storia a Revelli molto cara27. Forse nel prossimo libro? In questa mancanza vedo il terzo limite, quello che altri hanno definito in termini di deficienza dialettica. In realtà, come si è detto, Revelli è fine: il percorso di sussunzione del movimento comunista sotto la protezione dello Stato non è lineare. Ma - nel dialogo citato - Bertinotti incalza, e nonostante l'uso di una categoria molto superficiale, quale quella forse un po' vecchia di lotta di classe, pone un problema serio a Revelli: questo libro è poco dialettico, e così - nel dialogo - l'intellettuale (Revelli) che profetizza neri scenari lascia al politico (Bertinotti) l'incarico di trovare le soluzioni, le aperture in avanti. Giustamente quindi Bertinotti gli rinfaccia che non è mai stata possibile, e oggi meno che ieri, una divisone tra politici e intellettuali. La guerra contro il lavoro c'è, gli intellettuali non possono limitarsi a una disincantata lettura del passato.
Per finire Vorrei chiudere con questa ultima riflessione, goffamente maschile: l'essere
comunitario che non sa dare senso alla sua dimensione riproduttiva non ha futuro. La crisi del compagno novecentesco è squilibrio nel rapporto tra politica e affetti familiari28. Questi/ e nuovi/ e attivisti/ e o si interrogheranno sulle loro comunità di riproduzione, sulle loro economie domestiche o periranno, perché il potere della società postmoderna sull'educazione della prole è sempre più forte e pervasivo. E il senso non viene dal privato ma dal personale che si mette in gioco pubblicamente, sulle sue modalità di essere padre, single, omosessuale (a cui questa società nega il diritto alla paternità). Allora un libro che ci parla, seppur in modo asessuato, della violenza, della gerarchizzazione, della efficienza della peiformance, del lavoro produttivo, ha qualcosa da dire a chi vuole ripensare la politica partendo dalla relazione donna-uomo ed è cresciuto nella tradizione rivoluzionaria del Novecento, volendone però oggi uscire. Pur mancando, nella prospettiva di Revelli, l'attributo relazionale della nuova politica sessuata che ci attende, il suo libro rimane un passaggio se non obbligato sicuramente consigliato specialmente a chi nella cultura dell'attivismo novecentesco è, nel bene o nel male, cresciuto/ a. Difendere la dignità del lavoro dalle forze che lo vorrebbero schiavizzare, e difendere la dignità umana dalla guerra scatenata nel mondo dal neoliberismo significa oggi anche sforzarsi di creare fin d'ora pratiche comunitarie di liberazione che non separino ciò che il nostro nemico continua (dal Novecento) a separare dentro di noi: il mondo della produzione (morte) da quello della riproduzione (vita) .
Alternative/i, n.2, giugno2011
Note
1 L. Pintor, Dentro il Novecento, Il Manifesto, 20.2.01. 2 A. Gramsci, A111erica11is1110 e fordismo; cit. in M. Revelli, Oltre il Novecento. La poli
tica, le ideologie e e insidie del lavoro, Torino, Einaudi, 2001, p.47 (tutte le pagine citate nel testo si riferiscono a questo libro, come anche le citazioni di Gramsci e Koestler).
3 A. Gramsci, Ordine Nuovo, Autunno 1919; cit. p.266. 4 G. Alvi, Il secolo aJJ1ericano, Milano, Adelphi, 1996, p.123; libro che Revelli mai
cita né usa. 5 Mi riferisco soprattutto a P. Ferrero, Superare il Novecento, Alternative/i,
marzo 2001, n.1. 6 Togliatti riteneva che il capitalismo monopolistico di Stato dell'Italia del
dopoguerra, con il suo sviluppo tecnologico, preannunciava delle riforme socialiste: tesi che i maoisti contrastarono (cf. Ancora sulle divergenze tra il co!Jlpagno Togliatti e noi, Milano, Edizione Oriente, 1965).
7 J. M. Keynes, Prospettive economiche per i nostri nipoti, in id. La fine del Laissezjàire e altri scritti, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.
8 P. Ferrero, op. cit., pp. 20-21. 9 lbid., p.122. 10 Riguardo quindi alle critiche mosse da Ferrero, penso si possa andare avan
ti molto filosofeggiando sulle categorie di filosofia della storia che l'interlocutore adopera, ma l'arte dialettica - quella insta nella virtù umana dell'ascolto e del sapere dialogare - dovrebbe condurci a discutere sul piano delle prassi. Ritengo che i grandi progressi del Novecento siano da attribuire alla posizione di dominio del Nord del mondo piuttosto che a un avanzamento tecnologico, come Illich ha mostrato nel campo della medicina.
11 Revelli non cita ne usa la letteratura ormai ampia su queJla che è stata definita archeologia dello sviluppo, i cui nomi più importanti sono S. Latouche, A. Caillé, G. Rist, V Shiva, W Sachs.
12 P. Sullo, Le scomode domande sul presente, Il Manifesto, 4.3.01. 13 K. Marx, Il Capitale, I.I, cap.XXIV, §6, Roma, Editori Riuniti, 1989. 14 P. Ferrero, op. cit., p.121. 15 T. Negri, Dalla parte del Mi11ota11ro, Il Manifesto, 27.2.01; articolo nel quale,
discutendo le tesi di Revelli, l'autore conclude designando l'Europa quale unico laboratorio di pensiero altro a quello unico neoliberista, e implicitamente quale unico luogo di uscita dalla società delle merci.
16 A. Burgio, I peccati mortali della 111odernità, Il Manifesto, 1.3.01; accusando Revelli di revisionismo tale critico non merita grande attenzione; Burgio è ritornato aJla carica con: Reazione di fine secolo, Il Manifesto, 3.3.01.
17 Ha ragione quindi Ferrero nel vedere nel compagno descritto da Revelli una figura idealtipica e non il compagno storico del comunismo novecentesco; si sbaglia però a rimproverare l'uso dei romanzi "quale strumento di inchiesta" (P. Ferrero, op. cit., p.120) perché fraintende lo scopo di Revelli che non è descrivere la realtà novecentesca nelle sue ricche sfaccettature sociologiche, ma decostruire il
122
Alternative/i, n.2, giugno2011
Jovecento. La po/ile pagine citate di Gramsci e
che Revelli mai
" Alternative/i,
o dell'Italia del riforme socialimnpagno Togliatti
e del Laissezjaire
sa andare avan~ l'interlocutore olto e del sapei. Ritengo che i di dominio del come Illich ha
:he è stata defiuche, A. Caillé,
ti, 1989.
icolo nel quale, pa quale unico :itamente quale
•.01; accusando urgio è ritorna-
::> da Revelli una entesco; si sbai inchiesta" (P. i è descrivere la a decostruire il
OLTRE IL NOVECENTO
mito de] compagno come si è progressivamente andato costruendo assimilando inconsapevolmente e involontariamente i presupposti delJ'avversario capitalista.
18 Chi scrive propone i] termine attivista: esso superando le ambiguità del termine coJJ1pagno e scansando le perniciose accezioni negative del termine Volontario, riprende un termine ancora novecentesco, che richiamandosi al significato più autentico delJa politica quale attività propria delJ'essere umano (secondo Arendt) potrebbe tenere insieme dal militante de] centro sociale a] difensore dei diritti umani di Amnesty, dal sindacalista a] cooperante internazionale.
19 Purtroppo dobbiamo registrare che anche il termine lillipllziano è connotato dall'appartenenza a un nuovo schieramento politico, che, per quanto si richiami alJa rete come struttura organizzativa, imita molti tratti delle forme politiche novecentesche.
20 P. Sullo, op. cit. 2 i La critica al comunismo storico novecentesco venne portata avanti dai
primi anni novanta da diversi intellettuali torinesi che nel decennio precedente avevano elaborato una pratica teorica comune: tra questi C. Preve, M. Porcaro, R. Bellofiore e M. Revelli, a cui sono grato per avermi trasmesso la passione e gli strumenti della critica dell'economia politica. La decostruzione dell'ideologia marxista è svolta da Preve in numerosissimi e articolati saggi, di cui i più importanti mi sembrano: Il convitato di pietra. Saggio su nichilisJJ10 e 111arxisJJ10, 1991; Il pianeta rosso. Saggio su JJ1arxisJJJo e universalisJ110, 1992,· L'uguale libertà. Saggio st1lla natura llJJJana, 1994, tutti editi da Vangelista, Milano.
22 A differenza di Revelli giova sottolineare che Preve distingue tra co!l1tt11is1110 storico novecentesco (quello esistito realmente) e comunismo novecentesco (che include anche le posizioni intellettuali critiche).
23 A. Koestler, Darkness, pp.273-274, cit. p.209; questa frase, a dispetto di chi vede la letteratura come genere poco realista, riproduce quasi letteralmente il testamento di Bucharin tenuto davanti al tribunale che stava per condannarlo alla pena capitale dopo una vita dedita alla causa comunista.
24 A. Zanotelli, Intervento al priJJJo ùtcontro nazionale della &te Lilliput, Massa Carrara, Dicembre 2000.
25 Dialogo tra Marco Reve/li e Fausto Bertinotti suigrandi di/evm1i del Novecento: la politica e il lavoro cioè il coJJJunisJJJo e la fabbrica, Carta, Marzo 2001, n.17, pp. 28-32.
26 M. Revelli, L'identità operaia nel deserto della fabbrica, in AAVV, Radici e naziom; Roma, Manifestolibri, 1992.
27 M. Revelli, Uscire dal Novecento, in Alt n.O, 1992; Disaccordo universale e Il !Ve/fare alle ortiche, Manifesto 12 e 17 .11.1992; o con M. Porcaro, !Ve/fare e lavoro, Riff-Raff (forino), Marzo, n.2, 1993, pp.6-12.
28 In questo senso condivido solo parzialmente le riserve di Dominijanni, che sembra accodare le donne al coro delle mancanze di Revelli, non cogliendo nella demitizzazione dell'economico del Novecento l'apertura verso quella Oikia, arcaica e postmoderna, che Revelli invece tratteggia, pur rimuovendone il carattere sessuato e desiderante: «Il fatto è che per vedere l'aspetto desiderante della politica, bisognerebbe preliminarmente riconoscerle una qualche autonomia dall'economico, mentre nel ragionamento di Revelli la politica nell'economia si radi-
123
Alternative/i, n.2, giugno2011
SIMONE LAN/.i\
ca e dell'economia resta prigioniera: puro derivato della logica dello sviluppo fordista (e postfordista), ne mutua le forme e vi si conforma ... Di questa coincidenza fra economia e politica, nel libro fanno le spese - mi preme questo punto fin qui assente dal dibattito - anche le donne, che pure sembrano occuparvi un posto d'onore». I. Dominijanni, L'homo postfaber e i suoi rimossi~ Il Manifesto, 6.3.01.
124
Alternative/i, n.2, giugno2011