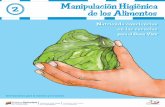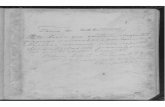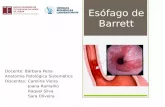De Rossi 2
Transcript of De Rossi 2
Luigi MonteLLa è professore di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi del Mo-lise. Ha pubblicato saggi sulla lirica del Cin-quecento e del Seicento con un’attenzione, oltre alla ricerca d’archivio, all’analisi filologica dei testi (L. Terracina, A. Muscettola, G. Acciano, B. Pisani). Tra i lavori sull’Otto e il Novecento si ricordano: l’edizione critica Studi di leggende popolari in Sicilia di Giuseppe Pitrè, le pagine dedicate a Leopardi, a Giuseppe Ricciardi, alla produzione letteraria di Isabella Teotochi Albriz-zi, le monografie su Giuseppe Raimondi e Italo Calvino.
e 18,00
antonio
de’ rossi
sonetti
XLVIII
“Civiltà letteraria italiana”, dopo oltre un ventennio di attività editoriale e circa cinquanta pubblicazioni, as-sume la denominazione di “Le civiltà letterarie” e si apre ai contributi delle lingue e delle letterature straniere, conservando sempre l’originaria e rigorosa attenzione alla centralità del testo nel procedimento esegetico e nell’interpretazione saggistica.
***
Volumi pubblicati:
1. a. granese, L’aquila e il poeta. Ricerche e studi di letteratura italiana.
2. g. PaPareLLi, Storia della “lirica” foscoliana.3. a. granese, La cultura italiana del Settecento. I. La “cornice” nel
sistema tragico di Vittorio Alfieri.4. L. MonteLLa, Una poetessa del Rinascimento: Laura Terracina.
Con le None rime inedite. (seconda ediz.)5. g. PaPareLLi, Feritas, Humanitas, Divinitas. L’essenza umanistica
del Rinascimento.7. g. PaPareLLi, Da Ariosto a Quasimodo.9. L. MonteLLa, Italo Calvino. Il percorso dei linguaggi.12. n. M. saLerno, Rime, a cura di Rosa Giulio.13. B. Pisani, I sonetti, a cura di Luigi Montella.14* a. granese, Divina Libertà. La rivoluzione della Tragedia, la
tragedia della Rivoluzione: Pagano Galdi Salfi.14** F. M. Pagano - M. a. gaLdi - F. s. saLFi, Teatrali contese, a cura
di Alberto Granese (due volumi indivisibili in cofanetto).15. L. MonteLLa, Seguendo d’Amor le tracce.Studi di letteratura italiana dal Cinquecento all’Ottocento.16. a. granese, Lettere dal deserto.Sulla letteratura del secondo Novecento.17. L. MonteLLa, Intersezioni novecentesche.Studi e ricerche di letteratura italiana.18. d. BartoLo, Lo calascione scordato, a cura di Rosa Troiano19. r. giuLio, Di Fedra il cieco furor. Passione e potere nella tragedia
del Settecento: Il Crispo di Annibale Marchese (con l’edizione del testo)
20. e. ajeLLo, Carlo Goldoni. L’esattezza e lo sguardo.22. R. giuLio, Gli eroi d’invitta pazienza. Epos storico e tragico
cristiano nell’età della «ragione spiegata» con l’edizione della tragedia L’Ermenegildo.
25. a. granese, Ugo Foscolo. Tra le folgori e la notte27. r. giuLio, Tempo dell’inquisizione tempo dell’ascesi.28. L. reina, Romanticismo e dintorni.30. a. granese, Le stelle erranti. Manieristi e moderni nella letteratura
italiana.31. r. troiano, Dialetti scritti e descritti. Studi di dialettologia e di
lettreratura.32. r. giuLio, Tasso: inchiesta sulla bellezza. Il Minturno tra «memorie
innamorate» e «giovamento degli uomini civili».34. Vincenzo MartineLLi, Lettere familiari e critiche. A cura di Carmen
di Donna Prencipe.36. a. granese, I campanili di Martinville. Debenedetti tra progetto
e destino.39. r. giuLio, Sotto il segno di Athena. L’Ellade eroica tra mito e
storia nella letteratura italiana.40. r. giuLio, Il dio ignoto. Dalla crisi del Rinascimento alla mo-
dernità letteraria.41. a. granese, Le tracce nel testo. Esperienze letterarie tra due
millenni.42. r. deLLi PriscoLi, Di Gessner felice alunno. Aurelio De’ Giorgio
Bertola e la letteratura di lingua tedesca in Italia.43. L. castori, I troni in polvere. Salfi tra Alfieri e Monti: La tragedica
allegoria della storia.45. a. granese, Menzogne simili al vero. Epifanie del moderno: il
mito, il sacro, il tragico.46. M. MontaniLe, Tra Otto e Novecento. Itinerari di lettura.47. R. Giulio, Gli infiniti disordini delle cose. Sullo Zibaldone di
Leopardi.
Le ciViLtà
Letterarie
edisud
saLerno
EDISUD SALERNOvia leopoldo cassese, 26 - tel. 089.22.08.12
salerno
Le ciViLtà Letterarie
SONETTI
A CURA E CON INTRODUZIONE DI
LUIGI MONTELLA
XLVIII
antonIo de’ rossI
edisud
saLerno
le Civiltà letterarieProfili - Saggi - Testi
Comitato scientifico
Joseph Farrell - Claudio Griggio - Pasquale GuaragnellaMariarosa Masoero - Aldo Maria Morace
Giorgio Patrizi - Marie-José Tramuta
Xlviii
I volumi della Collana sono sottopostial preliminare vaglio scientifico
di un comitato di referees anonimi
© Edisud Salerno 2012Via Leopoldo Cassese, 26Tel. 089/22089984100 Salerno
www.edisud.it - [email protected]
Il sistema di qualità della casa editrice
è certificato ISO 9001:2008
ISBN: 978-88-95154-00-8
Ad Anna, Nicola e Andrea
Non dobbiamo cercare di vivere a lungo, ma di vivere bene: giacché il vivere a lungo dipende dal destino, il vivere bene dall’animo [L. A. seneca, Lettere a Lucilio, XV, 93].
Prefazione
I
Oltre a molte altre virtù critiche e filologiche, Luigi Montella è un raffinato e attentissimo studioso del ba-rocco, e, più specificamente, della rimeria più o meno partecipe della ricchissima costellazione della luce poetica del Marino. La stampa delle raccolte poetiche dei rimatori barocchi, spesso copiose, nella varietà dei sottogeneri e delle molteplici sperimentazioni di metri e forme e strutture, è indispensabile per comprendere un po’ più a fondo quella che è stata una delle supre-me invenzioni della letteratura europea fra la fine del cinquecento e la fine del seicento; e qualcosa negli ultimi trent’anni, si è fatto, meritoriamente, anche se molto altro ancora resta da fare. Adesso Montella offre l’edizione ampiamente commentata, con una sontuosa introduzione, dei sonetti di un rimatore napoletano, Antonio de’ Rossi, al quale sia il Croce sia il Getto han-no dedicato qualche attenzione, introducendo qualche sonetto (a dire la verità, ben pochi) nelle loro antologie, ma al quale poca indagine critica finora è stata data in confronto con rimatori di supremo fulgore, come il Lubrano, il Fontanella, il Preti, il Sempronio (e tanti altri ancora).
Il fatto che Montella abbia scelto il de’ Rossi per l’edizione e l’interpretazione ha una ragione fonda-mentale: i Sonetti del de’ Rossi furono pubblicati nel
Prefazione
II
1661, quando la grande sperimentazione poetica che ha il Marino come emblema sta, per un verso, bru-ciando i più veementi fuochi, mentre per l’altro già si avvertono i mutamenti del gusto, i tentativi di diverse e contraddette sperimentazioni. Il Dotti è un esempio fondamentale: prima il rimatore alacremente e inventi-vamente teso fino all’esasperazione della metaforicata; poi il celebratore morale, fino a scegliere la satira etica e politica. Montella coglie e illustra molto efficace-mente e suasivamente quell’inquieta trasformazione della ventura poetica e concettuale che ha inizio con la metà del secolo barocco; e la scelta dell’opera poetica del de’ Rossi gli vale a rilevare un aspetto della lette-ratura barocca che è fondamentale: quella dedita al sacro, all’esperienza religiosa, che non è conformismo e inerte ossequio ai dettami della riforma cattolica, ma un’interpretazione spesso fastosa e spesso audace e avventurosa del cristianesimo. Bastino due esempi: le rime del Campanella e le Dicerie sacre del Marino; e, nei rimatori, ci sono, sia in Italia, sia in Spagna, sia in Inghilterra, sia in Germania, sia anche in Francia, presso che sempre la visione e la rappresentazione del tragico cristiano nell’esasperazione delle violenze di guerre, pesti, massacri, miserie, fami, rivoluzioni. Montella dà giusto rilievo ai sonetti del de’ Rossi che parlano della rivolta di Masaniello e delle eruzioni del Vesuvio, a confronto con la sua costante religiosità, che per lo più trova la sua foce nella fiducia in Dio, nella speranza, nell’accettazione della volontà e della giusti-zia divina. All’opposto di tanta altra poesia barocca, la tragicità della storia e della natura è raffrontata dal de’ Rossi con il punto di vista di Dio per un verso, delle colpe umane dall’altro.
Prefazione
III
Un pregio ulteriore del lavoro di Montella è il fatto di essersi rivolto, in rapporto con l’opera letteraria del de’ Rossi (i poemetti di argomento cristiano, le prose concettuali e meditative), allo studio, amplissimo e poco indagato finora, delle teorie, delle teologie, delle interpretazioni del cristianesimo come sviluppo e anche alternative del corpus non più unitario della riforma cattolica post-tridentina, e di verificare in questo modo, per il tramite della sensibile esperienza poetica del de’ Rossi, l’eco in Italia e più specificamente a Napoli e nel Sud di tali nuove inquietudini e indagini teologiche. È davvero moltissimo. Montella mostra che la koiné barocca è infinitamente variegata nelle sperimentazioni liriche e in quelle teologiche. Basta avere qualche espe-rienza delle letture degli infiniti predicatori cattolici, nel corso del seicento, tutt’altro che uniformi sia come linguaggio, sia come interpretazione e rinnovamento della costruzione teologica del cristianesimo, anche in rapporto con le teologie riformate, e cito almeno i molti predicatori che indagano il nulla in relazione con la tragicità della storia.
Naturalmente i sonetti del de’ Rossi hanno un nucleo fondamentale, su cui Montella insiste giustamente: il confronto fra la fallibilità e gli errori degli uomini per un verso; la giustizia e la misericordia di Dio anche di fronte alle colpe più gravi per l’altro. Di qui derivano due temi insistenti e strenui: la riflessione e il pentimen-to dei colpevoli, soprattutto di vanità mondane, di cui la letteratura amorosa è esempio efficace, l’invocazione del perdono, la preghiera a Dio, con l’intreccio degli echi petrarcheschi, più specificamente del Petrarca che medita sul vano amore; e dell’invocazione di fede. Ma l’aspetto più rilevato e significativo della rimeria del
Prefazione
IV
de’ Rossi, come giustamente rileva Montella, è il cavare moralità da avvenimenti della storia e della cronaca o da tecnologie moderne o dalle attività materiali. Penso, in particolare, al sonetto Che l’umiltà paziente sia la vera pietra de’ filosofi, nella contrapposizione fra le vir-tù delle anime e la vanità delle ricerche della scienza e delle tecnologie. Si rinnovano le opposizioni, spesso mol-to tese in concordanza con tanta rimeria barocca, fra corpo e anima, filosofia cristiana e fantasie supponenti e superbe, mode ed eventi terribili e angosciosi, che hanno come radici la vanità umana, termine davvero centrale dei sonetti del de’ Rossi. Montella minuziosamente e acutissimamente introduce ogni sonetto, sia dal punto di vista metrico, sia da quello storico, sia per quel che riguarda gli avvenimenti a cui il rimatore si rivolge, sia per i dedicatari molto indicativi per fissare meglio le ragioni e i modi della scrittura, sia per l’esplicazione dei concetti e delle metafore, secondo la tradizione barocca (marinista) sempre molto ardue e allusive nelle trasfor-mazioni, per l’uso attuale e i messaggi, di nomi dei miti antichi e di costumi e di attività e di luoghi concreti, capaci tuttavia di rivelare e di rilevare il concetto pre-dicato dal rimatore. L’edizione dei Sonetti del de’ Rossi, è sì, l’ulteriore e utilissimo documento della cultura e della letteratura barocca, ma è anche la dimostrazione esemplare della ricchezza e della varietà di un tempo letterario e concettuale mosso, avventuroso, variegato, alterno: Montella di tutto questo è l’eccellente interprete.
GiorGio BárBeri squarotti
introduzione
9
La poesia degli uomini che vissero nella frantuma-zione storica e politica dell’Italia del Seicento e nella sofferenza generata dalla povertà economica del se-colo - decimati dalle pestilenze e dalle lotte interne, su uno sfondo piú generale di contrasti internazionali - è caratterizzata, spesso, da una spiccata tensione verso il consolidamento della fede in Dio. Fondata su uno sguardo indagatore, che dall’intimo del poeta si allarga sul mondo, è capace di originare un’emozione schietta, riservata, con il rischio di passare inosser-vata, se non si colgono i riflessi delle problematiche nascoste e del paesaggio umano celati al suo interno. L’osservazione in filigrana restituisce, infatti, insie-me a un folla di personaggi, una moltitudine di que-stioni e idee sottese allo stretto rapporto che, in parti-colare nel XVII secolo, cosí come avviene di solito nei secoli di crisi, lega la letteratura, ma anche l’arte e la musica, all’esperienza religiosa. Il risolvimento della difficoltà a dialogare con Dio, originata in determinati contesti storici e umani, è affidato proprio alla poesia. Il Medioevo e parte dell’umanesimo hanno fornito ampie testimonianze in tal senso, certificate dal re-cupero delle fonti classiche e della patristica, riutiliz-zate con nuovi e piú articolati significati; similmente, nel pieno Seicento, all’interno delle sperimentazioni
introduzione
10
citatorie delle liriche spirituali, è possibile rinvenire l’esigenza di affermare i nuovi dettami precettistici.
L’assenza di ogni possibile equivoco semantico, nelle stratificazioni linguistiche del registro lirico re-ligioso, costituisce lo steccato divisorio dall’uso ludico e paradigmatico della replicazione metaforica tipica della lirica barocca. La moltiplicazione dei temi, vera novità della poesia secentesca, rivive nella proiezio-ne continua di sequenze bibliche o evangeliche, ma anche nei richiami continui alle tematiche espresse dai filosofi della Chiesa, dando vita a un virtuosismo artificioso teso verso la ricostituzione di una nobiltà d’intenti che il poeta reputa sempre piú evanescen-te nelle azioni dell’uomo. Sostenuta dall’imponente saggistica morale e dalle opere di precettistica catto-lica, la poesia che aspira al parlare mistico finisce per assumere un carattere esortativo, implicando da un lato l’esigenza del ‘convertire’ e dall’altro il manifesto tentativo di educare, con un chiaro intento moraliz-zatore, i costumi. tale esperienza artistica, in verità, rinvigorisce anche in buona parte dell’Europa; basti pensare alla Germania, ridotta come l’Italia in una serie di staterelli, a causa dell’indebolimento dell’au-torità imperiale e del conflitto politico-religioso aper-to con la riforma. La lotta tra cattolici e protestanti (1618-1648) aveva segnato in maniera negativa un’e-conomia fondata sul latifondo agrario, tanto che per tutto il Seicento non riuscí a dare palpabili segni di ripresa. Motivi diversi, sebbene in parte legati ai pro-blemi interni, caratterizzarono il fiorire della lirica religiosa anche nella vicina Francia e nell’Inghilterra.
Nel quadro, pur variegato, di una frantumata
introduzione
11
elaborazione culturale e di un complesso panorama storico-sociale s’inserisce l’opera di Antonio de’ rossi, grazie alla quale è possibile in parte ricostruire il com-plesso sistema di pensiero dominante a Napoli tra gli anni Quaranta e Sessanta del Seicento. La capitale partenopea, infatti, insieme ad altre importanti città italiane, era al centro di un articolato dibattito teorico su come utilizzare la letteratura per ricomporre il filo, in parte lacerato e in parte solo assottigliatosi, che unisce l’uomo a Dio. La poesia e l’applicazione della grammatica a essa attinente non vengono piú pensa-te e praticate per conquistare unicamente fama e glo-ria, ma anche per indicare il cammino della fede, per illuminare la strada da percorrere ai credenti e ten-tare di avvicinare alla Chiesa chi da essa è distante, mediante una sorta di predicazione in versi. Già Boe-zio, d’altronde, aveva sostenuto: «Ita fit ut quamlibet prolixi temporis fama, si cum inexhausta aeternitate cogitetur, non parva sed plane nulla esse videatur»1, tutto nello spirito della considerazione cristiana che ritiene la fede luce di Dio nell’uomo.
La poesia di Antonio de’ rossi si mantiene, sul pia-no formale, all’interno di una costruzione ideata se-condo alcuni ammaestramenti del Marino, ma, nello stesso tempo, distante da quell’ispirazione, perché le riconsegna quell’utilità pedagogica dallo stesso Mari-no sottrattale. Siamo negli anni in cui le nuove ten-denze poetiche della lirica morale spingono verso una
1 S. Boezio, De consolatione Philosophiae, a cura di Maria Bet-tetini, traduzione di Barbara Chitussi, Note di Giovanni Catapano, Torino, Einaudi, 2010, lib. II, 18, p. 77: «Accade cosí che la fama, di qualsivoglia durata, se paragonata all’eternità illimitata, sembri essere non solo piccola ma addirittura inesistente»
introduzione
12
concretezza dello stile, lontano da opere fastose pen-sate per essere adulate. Si va verso una spoliazione significativa di alcune mollezze espressive - ruotanti, per lo piú, intorno alle varie Filli o Clori - o di spiccati artifici; i poeti sono attratti da piú attuali esigenze di chiarezza formale, mediante la ricerca di un ver-so maggiormente equilibrato. Non viene, però, meno l’arguzia, né la componente erudita, né scompaiono metafore e similitudini ancora proprie del tempo. L’o-biettivo è quello di ridurre l’ingegnosità, a favore di formule scrittorie piú adatte a contenuti teologici, sa-cri, fideistici.
In tale casistica rientra Il peccator pentito2, un po-emetto strutturato in cinquantatrè ottave, nel quale de’ rossi racconta dei propri errori e della ritrovata fede. Nei versi, pieni di riecheggiamenti di salmi, ri-sulta palese l’esercizio retorico operato sul significato. Il tema è semplice e ripetuto: dolore per lo smarri-mento, richiesta di perdono per le proprie colpe, pre-ghiera del poeta al Signore di renderlo degno cantore del suo amore.
perdon, Signor, ti chieggo. errai, men dolgotardi, egli è ver, ma che piú fa’ poss’io?A l’infinita tua pietà mi volgo:oprai qual uom, tu devi oprar qual Dio.Sciorre io vorrei, ma quanto a me non sciolgoquel ghiaccio adamantin ch’è nel cor mio.Opra sol fia del tuo supremo amore,che io sciolga in pianto liquefatto il core!
Signor, ben sai che da primier parente
2 Pubblicato a Napoli, Giov. Francesco Paci, 1668, con dedica al padre Superiore e agli Assistenti della Congregazione di Fede napo-letana.
introduzione
13
trassi il fallo e col fallo ogn’altro male.Fin da l’alvo materno ebbi io la mentea te rubella e ’l senso infermo e frale;nacqui di terra e a la terra intentele voglie ho tutte del terren mortale.
(…)
Sogni, ah, furo i miei giorni e i miei diletti,sogni d’uom che vaneggia ed è pur desto,io, trasognando entro a’ mortali affetti,esca divenni d’empio ardor funesto!o sogni forsennati e maledetti,onde a me stesso doppia morte appresto,per voi pensai goder, ma non godeiche momenti di gioia, acerbi e rei3!
Si noti come all’interno di un codificato utilizzo di topoi lessicali (ghiaccio adamantin), in un artificio tutto barocco, si colleghino il riferimento e il signifi-cato di un lessico appartenuti a uno stereotipato ince-dere poetico con l’allora diffusa Vulgata Clementina4. Si consideri, infatti, la citazione biblica: «Et cor suum posuerunt ut adamantem, ne audirent legem, et ver-ba quæ misit Dominus exercituum in spiritu suo per manum prophetarum priorum: et facta est indignatio magna a Domino exercituum»5, ben distante, quindi,
3 Ivi, II, ott. 2-4.4 Il nome Vulgata deriva dalla dicitura latina vulgata editio
(edizione per il popolo) è una traduzione della Bibbia in latino, realizzata all’inizio del V secolo da San Girolamo, il quale lavorò sulle precedenti traduzioni latine (Vetus latina), ma anche sui testi originali in ebraico, aramaico, e sull’allora autorevolissima Settanta, versione greca dell’Antico testamento. Dalla sua realizzazione fino al Concilio Vaticano II (1962-1965) ha rappresentato la traduzione ufficiale della Bibbia per la Chiesa cattolica.
5 Nella Vulgata, Zacharias, Vetus Testamentum, 7:12 «Indurirono il cuore come un diamante per non udire la legge e le parole che il Signore degli eserciti rivolgeva loro mediante il suo spirito, per mezzo dei profeti del passato. Cosí si accese un grande sdegno da parte del Signore degli eserciti».
introduzione
14
dalle intenzioni della piú immediata tradizione pe-trarchesca.
La testura fonica è invece organizzata, cosí come per gli altri componimenti, su una serie di suoni rei-terati, articolati in un lessico ripetitivo, dominato, nell’andamento dell’endecasillabo piano, da omofonie (sciorre - sciolgo, goder - godei ecc.), forme anadiploti-che (trassi il fallo e col fallo ogni altro male; Nacqui di terra e alla terra intente, e cosí via) o riprese anafo-riche (Sogni… / sogni), spesso riproposte nel verso con formule derivative (trasognando), a sostegno di un ri-tuale patetico e specifico di alcuni aspetti del barocco. Cosí che procedimenti simmetrici e accoppiamenti op-positivi, insieme con allitterazioni e ripetizioni, anche con anafore plurime, risultano tesi a creare un giusto ritmo, senza allontanarsi dalla diffusa sensibilità me-lodica del linguaggio poetico e dall’esibizione del raffi-nato repertorio linguistico secentesco.
In de’ Rossi, però, pur nel riflesso di una costru-zione rivolta alla creazione musicale interna all’ende-casillabo, in uso nella prassi poetica nel XVII secolo, non è estranea la visione teologica espressa dal mon-do gesuitico, secondo la quale l’universo trova la sua estrinsecazione attraverso la razionalità musicale, che nell’armonia dei suoni vede il rispecchiamento di Dio6. Il discorso poetico tende, quindi, a integrare ne-
6 trovo opportuno ricordare anche il successo ottenuto dalla Mu-surgia Universalis, opera in 10 volumi (1152 pagine in folio), romae, Ex Typographia Haeredum Francisci Corbelleti, Anno Iubilaei, 1650 del gesuita Athanasius Kircher (1602-1680). Nella sistematica espo-sizione delle basi teoriche e pratiche della musica, non viene tra-scurato l’approfondimento del fenomeno sonoro sotto tutti i punti di vista, con interessanti collegamenti interdisciplinari, partendo dalla visione della struttura armonica dell’universo. Un simbolo dell’ar-monia divina è costituito anche dalla rappresentazione kircheriana
introduzione
15
gli spazi chiusi delle raffigurazioni fisiche, concrete, anche l’universale, la dimensione intemporale. Quasi sempre ben riuscita risulta l’armonizzazione dei livel-li sintattici ed espressivi, con un buon amalgama tra il piano lessematico e il piano della versificazione, tanto da valutare la curva armonica in maniera sintonica con l’incedere escussivo dei concetti, pur nella sem-plicità che talvolta le combinazioni rimiche lasciano intravedere. La meditazione sul destino dell’uomo, la constatazione della sua finitezza e della sua poca resistenza al peccato si distendono nel verso in corpi sintagmatici pausati e circolari, sia sul piano ritmico che negli addensati richiami biblici. Meno evidenti, rispetto alle Rime, vicinanze significative tra le strut-ture dei significanti e gli elementi semantici.
I solleciti di de’ rossi a non lasciarsi ingannare da-gli inutili lussi e sfarzi, né ad abbandonarsi a lascivie, testimonianza dell’ingratitudine umana verso Dio, si muovono in opposizione alle teorie luterane che vole-vano il destino dell’uomo già preordinato, pertanto, vano sarebbe risultato ogni tentativo di modificarlo. Cosí come l’ammonimento contro i falsi profeti, spesso presente nei suoi versi, è da considerarsi rivolto an-che all’attacco, che da piú parti veniva, ai sostenitori delle teorie gesuitiche. Queste ultime, infatti, nell’in-tento di promuovere l’ascetismo come opportunità per liberare l’anima dal corpo, lasciavano adito a credere che la corruzione della carne con i piaceri terreni non
dell’organo del mondo suonato dal Dio creatore. Anche la musica sa-cra era ritenuta uno strumento di missione apostolica, testimonando, attraverso di essa, l’onnipotenza divina. Sull’opera cfr. t. PanGrazi, La «Musurgia universalis» di Athanasius Kircher. Contenuti, fonti, terminologia, Firenze, olschki 2009.
introduzione
16
avrebbero influito sulla sua salvezza. Lo spavento e il dolore provocati dall’umanità scettica e insensibile verso i dettami della Chiesa spingevano gli scrittori ad argomentare con continue analogie, nell’intento di scuotere le coscienze intorpidite, omettendo di segna-lare che il fenomeno dell’allontanamento dalla comu-nità ecclesiale era per lo piú generato dalla sfiducia nei confronti della confraternita cristiana, a causa dei molteplici errori compiuti dai cattolici (ma anche dai protestanti) nell’intraprendere le troppe guerre det-tate dal fanatismo religioso e giustamente avversate dai fautori illuminati della pace. Va considerato, inol-tre, che dalla vicina Francia si andavano espanden-do, riscuotendo sempre maggiore consenso, le teorie antiaristoteliche del Gassendi7, congiuntamente alla sfiducia nelle verità scientifiche - dal filosofo ritenu-te semplici constatazioni naturali, non avendo còlto, nonostante la grande attenzione mostrata per le sco-perte galileane, il sostrato matematico presente nel-le nuove scoperte - e nella fede, incapaci di svelare i misteri dell’universo. Non ritenendo possibile, per-tanto, il raggiungimento di verità assolute, mediante processi razionali, Gassendi affermava che solo chi crede a priori può sentirsi appagato nel bisogno di co-noscenze.
Il materialismo diffuso spingeva, poi, verso il recu-pero del pensiero epicureo, diventando portavoce di un affermato ateismo che trovò la summa nella cir-
7 Pierre Gassend, detto Gassendi, abate (1592-1655), contestava la Metafisica di Aristotele, centrando la sua idea sull’impossibilità dell’uomo ad arrivare a verità assolute, in considerazione della rela-tività della sua conoscenza.
introduzione
17
colazione clandestina del Theophrastus redivivus8, il quale proprio nella critica alla religione individuava uno dei punti centrali della sua esegesi. Né va esclusa da questo sintetico quadro di contorno alla predica-zione di de’ Rossi, la manipolazione popolare del dub-bio cartesiano, spesso utilizzato per contestare l’esi-stenza di Dio. Nel momento, quindi, in cui si acuiva in maniera sempre piú netta la frattura tra scienza, argomentazioni razionali e dogma religioso, de’ ros-si cerca di utilizzare le stesse armi del razionalismo, unite a quelle dell’erudizione e della poesia, per difen-dere i princípi fondamentali della teologia e in parti-colar modo della fede. La partecipazione del nostro autore alla Congregazione de propaganda Fide di Na-poli è fondamentale per la definizione delle linee della sua poetica, in quanto pone in primo piano la difesa della funzione evangelica del credo cattolico. Nell’i-deale fideistico, infatti, si celano le motivazioni della pubblicazione, a un decennio circa dalla sua entrata nelle Missioni Apostoliche, del sopracitato poemetto e delle Risposte accademiche.
La tradizione gesuitica a Napoli risale al 15529,
8 L’opera, di autore anonimo, datata intorno al 1659, si presenta come una sorta di centone in cui si racchiudono autori e testi del mon-do classico e moderno, prendendo in considerazione la nozione di Dio, le aporie della concezione creazionistica dell’universo e, tra le altre cose, la tesi della mortalità e materialità dell’anima; oggi è consul-tabile in edizione critica a cura di G. Canziani - G. Paganini, 2 voll., Milano, Franco Angeli, 1985. Sulla questione, cfr. anche J. S. SPink, La diffusion des idées matérialistes et anti-religieuses au début du XVIIIe siècle: le «Theophrastus redivivus», in «revue d’Histoire Lit-téraire de la France», XLIV, 1937, 248-255; T. GreGory, Theophrastus Redivivus. Erudizione e ateismo nel Seicento, Napoli, Morano 1979.
9 F. c. Grimaldi, in Memorie storiche della città di Napoli, Napoli, M. Lombardi, 1857, n. XLI, pp. 332-33, scrive: «Il giorno dell’Assunta del 1534, S. Ignazio [Lojola], Pietro Fabro, Francesco Saverio, Giaco-mo Lainez, Alfonso Salmerone, Nicola Alfonso (Bobadilla) e Simone
introduzione
18
anno della fondazione del “Collegio Napoletano” che inizialmente ospitava scuole di grammatica e umani-tà; a partire dal 1565 anche corsi superiori di filoso-fia e teologia. L’homo universalis dei gesuiti era stato fortemente minacciato10 dalla pubblicazione delle Let-tres Provinciales (1656) di Blaise pascal11, in partico-lare con l’attacco alla strategia di adottare qualunque sapere per soddisfare ogni necessità. La relatività delle matrici etiche, mutevoli di luogo in luogo, dimo-strava, secondo pascal, come l’uomo vivesse nell’er-rore continuo, ingannato dai suoi stessi princípi mo-rali; pertanto, risultava irrealizzabile il progetto di riabilitazione della natura umana attuato dai gesuiti. L’attacco del filosofo francese muoveva anche dall’in-
Rodriguez, nella chiesa dell’abadia di Montemartire, fecero voto d’in-traprendere il viaggio in Gerusalemme e dedicarsi alla conversione degli infedeli e quando ciò gli venisse impedito, offrirsi al Papa per farsi spedire ove egli v[o]leva: qui si unirono ad essi altri tre, cioè Claudio Lajo, Giovanni Lodoario e pascasio Broet, e questi furono i fondatori della compagnia di Gesú». Con la bolla Regimini militantis (27 settembre 1540), Paolo III approvava ufficialmente l’ordine gesu-ita. Il 16 agosto 1773 fu soppresso con il breve Dominus ac Redemptor di papa Clemente XIV. L’ordine fu poi ricostituito, 41 anni dopo, da pio VII nel 1814.
10 Sulla questione, cfr. G. imBruGlia, Le strategie della civilizzazio-ne. L’ideologia missionaria della Compagnia di Gesú nell’America del Sud alla fine del Cinquecento, in r. Zorzi (a cura di), L’epopea delle scoperte, Firenze, Olscki, 1994; Un impero dell’età moderna: la Com-pagnia di Gesú. Le problème de l’”altéritè” dans la culture européenne aux XVIIIe et XIXe siècles: anthropologie, politique et religion, «Chro-mos», 10 (2005), pp. 1-9, urL: http://www.cromohs.unifi.it/10 2005/imbruglia gesuiti.html. Cfr. anche S. Pavone, I gesuiti, Bari, Laterza, 2004.
11 Cfr. B. Pascal, Le provinciali, a cura di r. Vitiello, pordenone, Studio-tesi, 1991. A partire dal 1656, pascal volge il suo interesse verso gli studi teologici; nel 1658, espone a Port Royal il progetto di un’”Apologia del Cristianesimo” che, partendo dall’attestazione della miseria e della limitatezza dell’uomo, giunge ad affermare la neces-sità del cristianesimo e la sua veridicità, comprovata dalla storia. L’Apologia non verrà mai completata, anche se molti frammenti di quest’opera è possibile ritrovarli nei Pensieri.
introduzione
19
sofferenza avvertita verso la condanna dell’Augustinus di Giansenio, pare suggerita proprio dai gesuiti12. In tale opera, composta di tre libri, l’autore, nel primo li-bro, appellandosi all’autorità di Sant’Agostino, presen-ta e contraddice l’eresia pelagiana, la quale negava la trasmissione del peccato originale e l’importanza della grazia, sostenendo la forza dell’uomo a guadagnare da solo la salvezza13. Nel secondo affronta la questione del-lo status naturae lapsae e dello status naturae purae, mentre nel terzo dichiara la teoria della dottrina gian-senistica sulla grazia e sulla predestinazione. L’uomo riceve la grazia, secondo Giansenio, solo per la bontà divina, nulla può fare per meritarsela; essa previene il libero arbitrio che può, di conseguenza, solo obbedirle. Dio, inoltre, decide chi predestinare alla salvezza e chi alla dannazione; il numero degli eletti è fissato nella mente di Dio e il mondo esisterà fin quando non sarà raggiunto il numero stabilito.
12 Il 10 agosto 1641 la Congregazione dell’Indice e dell’Inquisizio-ne condannò 18 opere, tra le quali l’Augustinus, seu doctrina sancti Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina ad-versus Pelagianos et Massilienses (Lovanio 1640; ristampato a Pari-gi nel 1641), di Cornelio Giansenio (nome italianizzato di Cornelius Otto Janssen). Nel trattato è possibile rinvenire la teorizzazione del giansenismo. A questa condanna fecero seguito: la bolla In eminenti di Urbano VIII nel 1642, la bolla Cum occasione di Innocenzo X nel 1653, le bolle Ad sanctam beati Petri sedem (1656) e Regiminis Apo-stolici (1664) di Alessandro VII.
13 Il famoso monaco bretone, Pelagio (IV-V sec. d. C.), non riteneva gli uomini predestinati, ma, grazie al loro libero arbitrio, alle preghie-re e alle opere buone, potevano salvarsi senza l’intervento della gra-zia divina. La teoria era ripresa dal teologo origene (vissuto tra Ales-sandria e Cesarea in palestina nel II-III sec. d. C.), condannato nel 401 da Teofilo, vescovo di Alessandria d’Egitto. Negava la trasmissio-ne del peccato originale, per cui il battesimo era ritenuto un semplice rito di accoglienza nella Chiesa. Secondo tale pensiero, un bambino che moriva senza battesimo, poteva essere ugualmente accolto in pa-radiso. Quest’ultimo punto fu fortemente avversato da Sant’Agostino, convinto assertore che il peccato originale fosse ereditario e collegato all’atto sessuale, in base al quale siamo tutti peccatori.
introduzione
20
Giansenio contrapponeva le sue tesi alla confusio-ne generata dalla morale ecclesiastica, con particola-re riferimento a quella gesuitica, secondo la quale la salvezza è sempre a portata dell’uomo, conquistabi-le con la buona volontà, accompagnata dalla grazia che è già in lui. La Compagnia di Gesú, infatti, aveva inserito i postulati della possibile salvezza alla base delle sue conversioni; con tali argomentazioni, i suoi adepti riuscivano a portare nella Chiesa un numero alto di anime, senza soffermarsi molto sui comporta-menti e sulla effettiva religiosità sentita. Il gianseni-smo contro questo lassismo ecclesiale proponeva un rigorismo morale e religioso senza compromessi.
Le dissertazioni filosofiche di Pascal portarono i gesuiti ad abbandonare nel secolo successivo la teoria dell’adattamento14, sulla quale si era eretto l’intero sistema di evangelizzazione del XVII secolo, pubbli-cando, anch’essi in francese (come quelle di pascal), le Lettres édifiantes et curieuses, nelle quali si cele-bravano con enfasi le attività missionarie della Com-pagnia. Superata la teoria dell’adattamento, i gesuiti puntarono sulla teoria del miracolo, che vedeva nella storia la connessione tra i miracoli e lo svolgersi delle vicende naturali15; secondo quest’ottica, il santo di-ventava exemplum in terra di un prodigio divino.
14 Il gesuita - avendo appreso, durante il suo percorso formativo, di dover mantenere in vita solo la sua fede cristiana, dimenticando le sue origini geografiche - si adattava al mondo con il quale entra-va in contatto, sentendosi uomo universale. Su alcuni aspetti della questione, cfr. J. p. ruBiès, The concept of cultura dialogue and the Jesuit method of accomodation: between idolatry and civilization, «Archivium Historicum Societatis Jesu», LXXIV 2005, pp. 237 sgg.; G. imBruGlia, Un impero d’età moderna: la Compagnia di Gesú, cit.
15 Cfr. G. imBruGlia, Dalle storie di santi alla storia naturale della religione. L’idea moderna di superstizione, «rivista storica italiana», CI (1989), pp. 36-84.
introduzione
21
L’asse si sposta, quindi, dal discorso dottrinale verso l’accertamento storico di una realtà ‘meraviglio-sa’, meglio rispondente all’applicazione della retorica dimostrativa (inventio e dispositio, piú che elocutio), cui prima si faceva riferimento. La testimonianza piú fedele di tale teorizzazione può essere rintracciata ne-gli Acta sanctorum, in cui il Bolland aveva dato vita a un rigoroso metodo critico16, ricostruendo la storia sacra attraverso le testimonianze degli uomini, dan-do concretezza ai nuovi tratti delle teorie gesuitiche che intravedevano una continuità tra la storia sacra e quella profana17. Sulla base di queste considerazioni, assume un particolare rilievo l’attenzione ai contenu-ti che, nella poesia teologico-morale, spiega il motivo di moderazione alla base di una scelta stilistica per molti aspetti in controtendenza con le adesioni pro-prie del secolo.
L’intervento di de’ rossi si pone già in linea con la presa di coscienza dei limiti teorici della Compagnia, impostata sul convincimento che i missionari fosse-
16 Cfr. J. Bolland, Introductio, in Acta sanctorum, Antverpiae 1643, t. I, pp. XXXIV-XXXIX. Jean Bolland (1596-1665) era membro di un collegio di dotti gesuiti belgi, costituitosi nella metà del secolo XVII per pubblicare le vite dei santi, ordinati per giorno secondo il martirologio; si dedica a trattare scientificamente i problemi storici fondamentali della complessa disciplina. L’acta Sanctorum di gen-naio è comparso nel 1643. Il testo completo è di 68 volumi a stampa, pubblicati fra il 1643 e il 1940, a cura della Société des Bollandistes, e raccoglie le vite dei santi, dall’inizio dell’era cristiana fino alla Ri-forma.
17 La teoria gesuitica che affidava alla predicazione dei missiona-ri l’utilizzo del miracolo come prova e documento venne fortemente avversata nella seconda metà del Seicento, in particolare da pierre Bayle e da Antoine Arnauld. Quest’ultimo, in La logique ou l’art de penser, paris, Guillaume Desprez, 1683, sosteneva che solo nella sto-ria sacra l’eventualità teorica di un fatto coincideva con la sua neces-sità, nella storia profana, infatti, l’argomento sarebbe risultato falso. Di qui la netta separazione tra le due storie. Cfr. anche G. imBruGlia, Un impero dell’età moderna: la Compagnia di Gesú, cit., p. 10.
introduzione
22
ro la testimonianza di un miracolo continuo, ma non ancora in sintonia con il rinnovo della strategia gesu-itica, vòlta non piú verso la teoria dell’adattamento, intesa come confronto con l’altro (si pensi alle opere missionarie in Sud-America), ma dell’identità, indivi-duando nella storia sacra europea il modello di riferi-mento. Certo è che la spiritualità gesuitica, all’interno della quale s’intravedono le linee teoriche elaborate dal Concilio di Trento - in cui, tra le altre norme, si stabi-liva che l’arte dovesse contribuire a rinforzare la fede nei credenti, mediante la capacità di generare emo-zioni che li avvicinassero a Dio -, è presente nell’opera di de’ Rossi. Sulla base di queste coordinate si muove l’interessante tentativo d’indottrinamento compiuto dall’autore, in un periodo in cui un tormentato dibat-tito coinvolge i campi dell’arte, della letteratura, della musica, dell’architettura, della filosofia, della religio-ne, implicate nel rinnovamento epocale generato dal-la nuova scienza.
La dichiarazione stilata nella lettera dedicatoria del Peccator pentito: «Era ben dovere, che questa mia operetta del Peccator pentito si lasciasse vedere alla publica luce sotto il nome e gli auspici delle Vostre reverendissime, essendo ella primizia di quello spi-rito, che mi venne somministrato da’ loro salutevoli insegnamenti fin dal punto che, […], elle, senz’alcun mio merito, si compiacquero d’accogliermi nella loro religiosissima adunanza» rende manifesta la visione morale originata dallo studio degli orientamenti teo-logici che contraddistinguono anche le altre opere. La descrizione della corrotta natura umana, pervasa dalle vane glorie che la vita terrena propone e dalle quali il poeta è spinto in percorsi di vita stolti e ingan-
introduzione
23
nevoli, è il motivo centrale del suo lavoro poetico, cui si contrappone l’immagine del Cristo sofferente sulla croce, coronato di spine, eppure in grado di dispensa-re perdono.
***Il tema della fede e i fondamentali dettami della
dottrina cristiana sono invece i punti nodali del Te-stamento cristiano - Napoli, Francesco paci, 1669, de-dicato al Conte Don Andrea Massarengo, Canonico e penitenziere Maggiore della Cattedrale di Napoli18 -, opera che s’inquadra anch’essa, in ripresa di alcuni temi Dell’immagine della vita umana19, all’interno di un’idea evangelizzatrice che parte dalla letteratura per raggiungere e rinforzare la fede nei credenti.
Il poemetto, costruito in novantanove ottave e due sonetti, racconta di quanto sia vano il mondo e quanta pazzia sia presente nell’uomo da spingerlo a donarsi alle cose terrene, piuttosto che rivolgersi a quelle ce-lesti. Boezio, timoteo, Agostino sono solo alcuni degli autori richiamati nei versi a sostegno delle sue tesi. Il compendio delle varie argomentazioni si esplica nella parte finale dell’opera, con un riecheggiamento degli ammonimenti di San Bernardo: «Chi brama in quel Regno essere traslato, / serbi il ben dato e fugga il mal vietato»20.
18 Massarengo (anche Massarenghi), nacque a Napoli nel 1629, figlio di Marco Aurelio, che si trovava nella capitale del Regno in qualità di commissario straordinario del duca di parma, per svolgere una missione affidatagli. Era stato nominato canonico della Cattedrale di Napoli e penitenziere maggiore dall’Arcivescovo di Napoli; il 28 marzo 1678 divenne Vescovo della Diocesi di Massalubrense (NA), carica che ricoprí fino alla morte, sopraggiunta il 29 settembre 1684. Fu molto amato per la sua sapienza e le sue grandi virtú.
19 Dell’opera si parlerà piú avanti.20 LXXXXIX, vv. 7-8.
introduzione
24
I princípi delle verità rivelate - raccontati median-te una continua sollecitazione di elementi interiori, giuocando sulle emozioni suscitate dal raffronto tra le illusorie chimere inseguite dall’uomo e gli eterni insegnamenti di Cristo, vòlti alla salvaguardia del-lo spirito - si pongono all’interno di una consolidata strategia ecclesiale, impegnata nel recupero non solo delle massi popolari, ma, nel nostro caso, degli intel-lettuali e dei letterati in genere:
Saggio sia l’uom, sí ch’esser tal s’impegnae i mezzi in ciò non sprezza e non trascura, tosto in lui cessa ogni saviezza degnach’egli stima esser tal, né piú procura;ove incostanza, ove alterigia regna,ivi alberga ignoranza e notte oscura,né illuminar potrà nostr’intellettolume verun, s’egli è d’orgoglio infetto21.
una sorta d’illuminata predicazione tesa, nella fu-sione di elementi dotti e immagini suggestivamente crude, a coinvolgere il popolo e le classi dominanti. La frammentata rappresentazione delle figurazioni va ascritta alla tipica tendenza barocca di costruire relazioni tra concetti, richiamati per una piú funzio-nale comunicazione. D’altronde, lo stesso Galilei usa le metafore come vettore per correlare e connotare i fenomeni fisici, anche se nella poesia il sistema di-venta centrale, non solo come elemento per arrivare all’estrinsecazione delle teorie. In poesia la ricerca emozionale vive, infatti, di variazioni multiple, nella visionaria figurazione di ogni singola rappresenta-zione, non unicamente di aspetti simbolici conclusi-
21 LIII.
introduzione
25
vi. Nel nostro caso piú specifico, il valore autonomo dei componimenti è da riferirsi, poi, alla complessa illustrazione dell’iconografia religiosa, tesa a creare suggestioni intime, funzionali allo sviluppo del senso morale e al risveglio delle coscienze. L’opera si con-clude con il sonetto Considerando quanto il mondo sia vano, si consiglia a fuggirlo, rendendo manifesto l’intento sotteso alla composizione:
Ond’io, mentre da lui fuggo e m’ascondo,perdendo il suo favor me stesso acquisto22.
***In tale ambito, assumono un valore particolare an-
che le Risposte accademiche, in quanto si alimentano della fusione tra elementi sacri e profani. Nello stesso tempo, si utilizzano i procedimenti logici e razionali propri della scienza, per testimoniare convincimenti di ordine morale, ritenuti indispensabili allo sviluppo della civiltà umana. Sulla scorta degli insegnamenti aristotelici, le Risposte23 articolano quattro ragiona-menti - strutturati secondo procedimenti analogici e formule sillogistiche -, nel tentativo di dare una solu-zione ai vari quesiti posti dal principe dell’accademia. Sul problema: «Qual grazia sia piú sicura: se quella
22 vv. 13.14.23 Pubblicate a Napoli, per Don Antonio Ferro, 1669, dedicate
a Monsignor Bonaventura Cavalli, Vescovo di Caserta. L’edizione dell’opera testimonia indirettamente il nuovo ruolo assunto nel dibat-tito intellettuale dall’Accademia degli oziosi, in particolare dopo la riorganizzazione operata da Giuseppe Battista - in seguito alla morte del Manso avvenuta il 28 dicembre del 1645 - il quale nell’Avviso, premesso alla parte terza delle sue Giornate accademiche (Venezia, Combi & La Noú, 1673), prescrisse la regola che in ogni tornata, oltre ai componimenti poetici, si dovesse ragionare intorno a qualche pro-blema. Compito dell’Arciaccademico era quello di proporre il proble-ma e di rispondere agli accademici.
introduzione
26
delle genti o quella dei principi», il nostro autore non ha dubbi a individuare nell’adulazione della corte il mezzo peggiore per conseguire onori e glorie24. richia-mando le esperienze storiche degli Spartani e degli Ateniesi, gli uni affezionati a Licurgo gli altri a So-lone, sottolinea come il popolo si legò ai loro capi per le leggi favorevoli che essi promulgarono25, cosí come accadde ai romani con Quirino e ai persiani con Ciro, catturati dal singolare valore che nei due riconobbero e non certo per le sterili lodi che i cortigiani interes-sati tessevano ai loro principi.
Che però mi fo a credere che di gran lunga sia piú sicura la grazia che s’ottiene presso le genti, cioè a dire presso la moltitudine, di quella che s’ottiene presso de’ principi e appoggio il mio pa-rere a tre principali fondamenti: il primo, si è il motivo onde regolarmente l’una e l’altra grazia procede; il secondo, la qualità del grado, in cui per amendue queste grazie si perviene; il terzo, il luogo dove l’uno e l’altro favorito esercita le sue funzioni. Quanto al primo, l’insinuarsi nella gra-zia della moltitudine non suole avvenire, che o per qualche eroica virtú, che in alcun suggetto
24 Il ragionamento affonda le radici nell’Antico testamento, in cui i falsi profeti erano considerati, di solito, profeti di corte, perché, que-sti ultimi, ricavavano generose ricompense, dicendo al re e ai suoi ufficiali quello che desideravano sentire, sotto forma di profezie favo-revoli. Questo genere di profetismo al popolo d’Israele era giunto dal vicino oriente. Le scritture, e in particolare l’Apocalisse di Giovanni, affrontano in maniera chiara la questione.
25 licurGo, leggendario legislatore di Sparta del quale non si sa nulla di certo. Si dice che fosse il fondatore della Costituzione e del sistema sociale e militare spartano. solone, uomo di stato e poeta. Fu considerato dagli antichi uno dei Sette Savi: 1) contribuí ad abolire la schiavitú per debiti; 2) al criterio di nobiltà di nascita, come segno distintivo tra le classi, sostituí quello del reddito, concedendo, almeno sul piano teorico, la possibilità a chiunque di compiere la scalata so-ciale, garantendosi la pienezza del diritto; 3) applicò il sistema degli Eubei, rierito ai pesi e alle misure.
introduzione
27
risplenda o per qualche segnalato beneficio che siasi da lui derivato. Cosí i Lacedemoni a Licur-go, gli Ateniesi a Solone sommamente s’affezio-narono, mercé delle salutevoli leggi che meritas-sero. Cosí i romani a Quirino, i persiani a Ciro i primi onori affettuosamente dedicarono, mossi dall’eccellente virtú e dal singolar valor che in essi conobbero26.
Il fine del docere è evidente nel procedere retori-co e allusivamente morale. Nelle Risposte, infatti, si evidenziano i caratteri della vuota vita di corte e la provvisorietà dei comportamenti dettati dall’umana volontà, rispetto alla giustezza delle azioni virtuose che assumono l’indirizzo codificato della legge morale.
La seconda questione è incentrata su «Qual danno sarebbe maggiore: se non vi fosse la scienza delle leg-gi o quello che avviene essendo esercitata da persona ignorante dell’altra scienza». proseguendo in una serie di dotte argomentazioni morali, si afferma che maggior danno sarebbe per l’umanità se non vi fosse la scien-za delle leggi, rispetto a una cattiva amministrazione della stessa. Il ragionamento parte dalla seguente ri-flessione: «Questa mia openione sulla necessità precisa che tutte le civili adunanze hanno delle leggi, per mez-zo delle quali, come ben disse Isidoro, ponendosi il fre-no all’insolenza dei piú potenti, viene a serbarsi illesa tra i malvagi l’innocenza e sicura dalle oppressioni la bontà. Il che da questa moral filosofia ben può ridursi ad atto senza la compagnia dell’altre scienze»27.
26 Cfr., A. de’ rossi, Risposte accademiche, cit., pp. 3-4. 27 Ibidem, p. 15. La citazione di de’ Rossi è tratta dal libro II delle
Etymologiae, una grande opera enciclopedica ordinata da Isidoro di Siviglia (560 circa - 636) secondo i vocaboli di cui si dà l’etimologia, per trarre da questa la spiegazione delle cose espresse.
introduzione
28
Il terzo problema - «Qual sia piú ammirabile: che il fortunato tema il tutto o che il miserabile non di-speri di cosa veruna» - viene affrontato muovendo da una premessa: «Quanto è vero Signor principe che fra il timore e la speranza, quasi fra due poli, si raggiri perpetuamente l’umana vita; tanto pare che l’una e l’altro, con mendicati artefici, contendono nei nostri petti la maggioranza. Lusinga, questa, con le promes-se, sgomenta, quegli, con le minacce»28. Il concetto s’i-spira al De remediis utriusque fortune di Francesco petrarca, con particolare riferimento ai primi due li-bri (composti rispettivamente da 122 e 131 dialoghi), in cui viene affrontato il tema della ragione che si confronta con la Gioia, la Speranza (I libro), il Dolore e il Timore (II libro). Dalla dottrina stoica petrarca ricavava l’idea che la ratio può dominare tutti gli af-fetti, in quanto il dolore e il timore non sono altro che falsa immagine di un male già attuale o ancora da venire, mentre la gioia e la speranza rappresentano l’errata sensazione di un bene presente o solo imma-ginato. Il discorso di de’ rossi utilizza questi presup-posti per concludere, attraverso una serie di citazioni, da Cicerone a Virgilio, e una sequenza considerevole di esempi, basati sulle esperienze degli antichi, che tra gli squallori di uno stato miserabile non si dispera di alcunché, quando invece s’incontra la fortuna co-minciano i «timori del tutto».
Quando che siccome lascia ogni tratto lusin-garsi il fortunato dai vezzi d’una ingannevole speranza, cosí non può non temere l’incostanza di quella ruota, che ha per natura l’esser volu-bile. E se l’orridezza de’ propri infortuni sparge
28 Ibidem, p. 21.
introduzione
29
il misero di scontentezza, e sparge di timore, il racconsola, al parer di tullio, la speranza con im-maginarie dolcezze di future felicità29.
Ma quantunque abbia molto di che temere il fortunato, e molto anche di sperare il miserabi-le, ad ogni modo mi fo a credere che di maggior maraviglia si renda degno in temendo il prospero d’ogni cosa che in non disperando il miserabile di cosa veruna.
Imperciò che nascendo la maraviglia in noi giusta l’insegnamento del gran Nisseno30, dalle cose eccedenti l’ordinario confine o della natura o del costume quando siffatto eccesso sarà mag-giore, altrettanto sarà maggiore la maraviglia. Come dunque sia proprio della prosperità di ren-der gonfi gli animi nostri e di produrre in essi, come scrisse Grisostamo, molti e vivaci spiriti, piú che molto sarà degno di maraviglia il veder-gli poi temere d’ogni cosa31.
L’ultimo quesito cosí si articola: «In che cosa siasi renduto piú ragguardevole il reverendissimo padre Nicolò Ridolfi, Maestro Generale dell’Ordine de’ Predi-catori32, se nell’essere stato ugualmente piacevole con
29 Cfr., M. tullio cicerone, Oratio in Catilinam quarta, 8, a cura di Giovanni Bellardi, Torino, Utet, 1999, p. 788: «[…]; eripit etiam spem, quae sola homines in miseriis consolari solet (perfino la spe-ranza toglie loro, l’unico conforto che nella sventura resti all’uomo).»
30 Gregorio di Nissa, detto Nisseno, nacque intorno al 335 a Ce-sarea di Cappadocia da Emmelia e da Basilio il vecchio. Ebbe la su prima istruzione, prevalentemente religiosa, ad Annesi dalla sorella Macrina; il maggiore artefice della sua formazione fu, però, suo fra-tello maggiore Basilio (San Basilio Magno). Si sposò e divenne mae-stro di retorica, solo piú tardi entrò nel monastero fondato dal fratello Basilio sull’Iris nel Ponto. Nell’autunno del 371 fu consacrato vescovo di Nissa; probabilmente morí nel 394. Sul pensiero di Nisseno, cfr. W. volker, Gregorio di Nissa filosofo e mistico, a cura di Claudio Mo-reschini, Milano, Vita e pensiero, 1993 (prima traduzione italiana).
31 Cfr. A. de’ rossi, Risposte accademiche, cit., pp. 22-23.32 Fu il 55° Maestro Generale dei Domenicani, dal 1629 al 1644;
cfr. la nota al son. 33. Sulla sua figura, cfr. P. D. Pennone, I Dome-nicani nei secoli. Panorama storico dell’Ordine dei Frati Predicatori, Bologna, Studi Domenicani, 1998, pp. 340-351.
introduzione
30
tutti i sudditi o nell’aversi fatto conoscere da’ sudditi rigoroso solamente con sé stesso». Il procedimento reto-rico tende a evidenziare come il padre sia stato apprez-zato dai contemporanei per la severità con sé stesso, pur non disdegnando la magnanimità verso gli altri. Le argomentazioni addotte tentano un disvelamento del-le maschere che spesso si utilizzano per ingannare gli amici piú sinceri. L’affabilità delle parole, dei modi o la piacevolezza del verso possono, infatti, derivare da un addottrinamento e non da un animo virtuoso, men-tre il rigore morale non può che scaturire da puri inse-gnamenti. San Bernardo, Seneca, Milziade, Achille, il grande Alessandro, Cesare sono alcuni esempi richia-mati come modelli che spinsero gli animi alla virtú e, secondo de’ rossi, solamente per stupire si narra che i sudditi non imitarono i loro principi nei costumi.
La scrittura in prosa del nostro autore si alimenta di una costruzione del periodo moderatamente ampio, con varie subordinate, tipico dei costrutti barocchi. Scompaiono le eccessive lungaggini del modello tre-centesco (Boccaccio), mentre vivono concatenazioni lo-giche tenute insieme dalle congiunzioni (che), con varie sfumature e funzioni. Viva è anche la tendenza alla linearità oratoria, all’interno della quale, cosí come in uso nei poeti barocchi, suscitano meraviglia le conti-nue analogie create con i numerosi personaggi storici e mitici, costruite con fine razionalismo e finalizzate alla dissertazione retorica. Quella realizzata da Antonio de’ Rossi è, in effetti, una rappresentazione del conflit-to tra il bene e il male già presente nei componimenti esaminati, propria anche delle argomentazioni gesuiti-che discusse; alcune volte, contraddistinta da un anda-mento brioso, altre, invece, da un tono solenne.
introduzione
31
elementi religiosi e politici si fondono in una co-dificazione di comportamenti connotati da caratteri epici, coraggiosi, gloriosi. esempi rivolti a moralizza-re la vita nobiliare e del sovrano, in modo che anche il popolo riesca a trarne giovamenti utili per la pro-pria condotta. Metafora di vita, quindi, in grado di suggerire percorsi etici da seguire, cosí da modificare in positivo il destino degli uomini. In quest’ottica, la letteratura svolge una funzione centrale nell’invito ad applicare alla vita l’azione raccontata; cosí come nei versi, scambievolmente, al ciceroniano sistema del docere viene subordinato il delectare e viceversa. È una prassi connotativa della produzione religiosa quella che - in ultima analisi - segna i versi di de’ Rossi, o le sequenze filosofiche argomentate nelle Ri-sposte, organizzate vicino alle considerazioni del Bar-toli33, propositore di un pacato moralismo della pa-rola34. Le eccessive fioriture stilistiche sono, infatti, quasi abbandonate, per una pratica artistica capace di rappresentare in maniera degna e mediata l’altez-za dei contenuti. D’altronde, già erano vive a Napoli testimonianze autorevoli che si orientavano verso un barocco moderato: Muscettola, Battista, Pisani, Gau-diosi applicavano nelle loro poesie le linee poetiche indicate dal Meninni, cui si aggiungevano gli speci-fici inviti, provenienti dall’ambiente romano, contro alcune intemperanze barocche e, in quegli anni, dai
33 Cfr. D. Bartoli, Dell’uomo di lettere difeso et emendato, par-ti due del padre Daniello Bartoli della Compagnia di Gesú, Milano, Malatesta, 1646.
34 Per la definizione, cfr. A. Battistini-E. Raimondi, Le forme del testo, Teoria e poesia, I, in Letteratura italiana, a cura di A. A. rosa, torino, einaudi, 1984, p. 123.
introduzione
32
Panegirici sacri del ligure Segneri35, con particolare riguardo alle pubblicazioni di Pietro Sforza Pallavi-cino36.
Il contrasto irrisolvibile tra scienza e fede diventa invisibile, nascosto nelle pieghe delle argomentazio-ni retoriche e annullato a favore delle dissertazioni morali. Siamo nell’altra faccia del barocco: apparen-temente lontani dall’enigma e dalle ricercate com-binazioni verbali. Il probabilismo, l’incertezza, l’in-quietudine si esprimono, infatti, nel complicato gioco delle analogie e dei velati sillogismi, con l’obiettivo di tenere insieme, legata a un comune senso del pecca-to, un’intera classe dirigente - sempre piú sfuggente e mal disposta a subire le imposizioni del corrotto po-tere ecclesiastico -, cosí da dominare indirettamente pure le masse popolari, anch’esse ormai restíe ad ac-cettare silenziose soprusi e vessazioni di ogni genere.
L’intero processo dello sviluppo scientifico soffre, negli anni in cui nascono le opere di de’ rossi, ancora di censure irragionevoli, penalizzato fortemente nella diffusione dei nuovi contenuti aritmetici, geometrici, fisici, che filosofi e scienziati, sempre piú uniforme-mente, tentano di affermare nelle singole ricerche. ostacolate da argomentazioni fallaci e ritenute anti-
35 Sull’autore, cfr. r. Paternostro, L’artificiosa parola. Studi sulle poetiche manieristico-barocche, roma, Aracne, 2006, pp. 125-143. Contestualmente non va dimenticato: L. alBrizio, Panegirici sacri, roma, Ignatio de’ Lazzeri, 1655, raccolta curata da Gerolamo Vanni, in cui si pubblicano i componimenti del Padre della Compagnia di Gesú (documentato altrove anche come Albrizzi o AlBitrio) di piacenza.
36 Si ricorda che il famoso gesuita parmense, poi cardinale (1659), scrisse una Storia del Concilio di Trento, in risposta all’anticuriale Storia di Sarpi, che ebbe larga diffusione in ambiente protestante. L’opera fu pubblicata nel 1656-57, e presenta un’articolata giustifica-zione alla politica temporale della chiesa cattolica.
introduzione
33
quate le nuove prospettive e le diverse angolazioni da cui si discutono temi male affrontati dal fondamenta-lismo religioso e morale, ecco spuntare l’esigenza di riportare ogni cosa sotto l’egida del Dio buono, offeso dai comportamenti umani, riducendo gli spazi aperti dalla scienza, nel tentativo di riconquistarli allo spi-rito, all’interno di un complesso e delegittimante si-stema normativo.
Il nostro poeta, in ultima analisi, tenta di rende-re attuabile il collegamento tra il Dio della ragione e il Dio della fede auspicato nella trattatistica morale di San tommaso, dove si considera la ragione natu-rale il punto centrale intorno al quale si sviluppa la specificità dell’essere umano. Pur nello stato d’imper-fezione - generato dalla forza della volontà che può indurre l’uomo nell’errore - essa eccelle sulla terra, ma resta inferiore rispetto ai valori della scala delle intel-ligenze37. In altre parole, le dissertazioni di de’ rossi e, piú in generale, i molti temi religiosi cantati nelle ope-re barocche si caratterizzano per la visione dell’uomo naturalmente proteso verso il Bene, mortificato, però, in questo progetto dal peccato originale che, nel tem-po, finisce per spingerlo, attraverso la cattiva volontà, nell’errore, dal quale solo la Grazia può salvarlo.
***La Vergine Madre assunta in cielo, dedicata a Don
Innico Cardinal Caracciolo Arcivescovo di Napoli (Na-poli, Giov. Francesco paci, 1668), è un’opera, struttu-rata in tre libri, per un numero complessivo di 240 ottave cosí suddivise: 73 (1° libro), 88 (2° libro), 79 (3°
37 Nella distinzione di S. tommaso: l’Intellectus mostra il Bene, mentre la Ratio dà l’assenso ed è legata alla volontà.
introduzione
34
libro), con un’impostazione talvolta dialogante, nella quale l’autore rivolge un’invocazione alla regina dei Cieli, chiedendole di ridurre i suoi affanni e di aiutar-lo a seguirla nel regno celeste38. La Vergine rispon-de di dolersi molto dell’umano dolore, ma il Signore vuole che «di sudor miei riposo io prenda / e ognun di voi l’altrui salvezza intenda» ( I, 37). L’opera continua ricordando le vittorie conseguite da Maria sul male fino al tripudio finale, concludendo:
(…)Ma qual lingua mortal spiegar presumequei celesti portenti e quei stupori?Chi lo splendor dirà di quelle faci?Musa, deh, frena il vol, contempla e taci39!
***
Il giudizio universale, dedicato a Don Luigi San-severino, principe di Bisignano e Grande di Spagna, Napoli (Giov. Francesco paci, 1668), è un poemetto, invece, suddiviso in due libri, rispettivamente di ot-tantuno ottave il primo e di centoundici ottave il se-condo. In esso, il poeta affronta il tema del giorno del giudizio, definito «… orrido e grande, / giorno d’ira e vendetta angoscia e duolo»40, utilizzando la visione profetica presente nell’ultimo libro della Bibbia per richiamare gli uomini alla rettitudine, che non può esistere fuori dalla comunità cristiana:
Quando a tenzon verrà la terra e il polo,anzi a gloria di lui che regge il tutto,
38 «oh, di vera umiltà specchio e sostegno! / … / tu te n’andrai su ne l’empireo regno, / ove mille alme a corteggiar sian pronte / le tue glorie, i tuoi merti e i pregi tuoi; I, 7, vv. 1-7.
39 III - 79, v. 8.40 I - 1, vv. 1-2.
introduzione
35
vedrassi il mondo e il tempo arso e distrutto»41.
Le citazioni bibliche dai libri di Ezechiele, di Isaia e in particolare dall’Apocalisse di San Giovanni rispondo-no alla precisa esigenza di affrontare la crisi che attra-versa il XVII secolo, confidando nella speranza di una rivincita, cosí come fu per il popolo d’Israele che riuscí nella fede a trovare il conforto e la forza per sopportare i soprusi di cui era oggetto. Bisognerà, quindi, valutare il significato che la visione dell’apocalisse rivestiva nel Seicento, nel rinnovato spirito riformistico che la rilet-tura evangelica offriva. Il termine, infatti, manteneva nella predicazione di quegli anni il senso dotto di rive-lazione42; il genere apocalittico, pertanto, segna un par-ticolare modo di esprimersi, fatto di immagini grandio-se e talvolta irreali, di simboli, di messaggi cifrati che nel linguaggio contemporaneo corrispondono a eventi catastrofici. Nell’antico come nel nuovo testamento l’in-tenzione era tutt’altro che intimidatoria o spettacolare; le sacre scritture indicano i fenomeni che procureranno dolore all’umanità come un breve periodo, cui seguirà il tempo del bene preparato da Dio43.
Il sol, ch’è d’aurea luna albergo e fonte,
41 Ib., 6-8. Cfr., Apocalisse 8, 7, «Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra. un ter-zo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde si seccò».
42 Dal verbo greco apokaljpto = svelare, da cui deriva il sostantivo apokàljpsis = rivelazione, manifestazione.
43 A cominciare da S. Giustino verso il 150, si è identificato l’au-tore dell’Apocalisse con l’Apostolo Giovanni (autore del IV Vangelo). oggi, considerata l’approssimazione della lingua, gli studiosi ritengo-no che l’autore del libro sia da ricercare fra i discepoli di Giovanni l’A-postolo (si parla di una scuola catechistica “giovannea” sorta a efeso). Si suppone, infatti, che i discepoli avrebbero prodotto la redazione finale di tutti gli scritti giovannei.
introduzione
36
fia di tenebre e d’ombre orrido imago,verrà che de la luna allor tramonte,chiuso il candor, quasi in sanguigno lago,fosche le stelle a giú cader sian prontedal firmamento, or sí lucente e vago,né parte avrà di questo sí vasta moleche ’l suo fin non prevegga onde si duole44.
In definitiva, è, quello del nostro autore, un mes-saggio di buon auspicio che richiama tutti gli obblighi del cristiano, nel dovere di una fedeltà incrollabile alla causa di Cristo e della Chiesa. A questo risvolto positivo, che accompagna i molti versi dell’opera, in perfetta sintonia con lo spirito evangelico dell’epoca, si rifarà la costituzione dogmatica del Concilio Vati-cano II, nella quale, a proposito delle verità rivela-te nelle Sacre scritture, sancisce: «sono utili per in-segnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia, affinché l’uomo di Dio sia perfetto, ad-destrato a ogni opera buona»45.
Né, però, manca in de’ Rossi il vigore biblico del Dio che punisce, alla cui giustizia niente potrà sottrarsi:
L’alta giustizia, tante fiate e tante,irritate da noi co i falli nostri,a punir l’uomo perverso e ’l mondo erranteaprirà del furor gl’intimi chiostri46.
La decadenza delle cose terrene, la loro distruzio-
44 ott. XV.45 Dei Verbum (Parola di Dio) promulgata il 18 novembre 1965.
In questo documento si tracciano le linee guida per la lettura cristia-na dell’Antico e del Nuovo testamento, partendo dall’affermazione che le cose rivelate, contenute nei libri della Sacra Scrittura, furono consegnate sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, si ritiene che Dio è l’autore dei libri nei quali sarà possibile trovare gli orientamenti per la nostra salvezza.
46 I - 6, 1-4.
introduzione
37
ne sarà visibile nel fatidico giorno in cui appariranno chiare a tutti la potenza di Dio e la vacuità terrena. Gloria invece sarà data a chi
Senza curar del fral corporeo velo,non piú a tesor caduco o vano onore,ma deste in preda a’ beni eterni il core47.
e conclude:
Cristian, per tanto ben che in ciel n’aspetta,ogni nostro sudor ben troppo è leve,patria a goder, sí dolce e sí diletta,convien per calle alpestre e breve,s’altri cader non vuol per via sí strettad’ogni pondo mortal sgravar si deve,chi ascender brama in morte al ciel superno discenda in vita a riveder l’inferno48.
A causa dell’affermazione assolutistica del potere e dell’integralismo religioso, alla moralizzazione dei costumi concorrono, nel corso del Seicento, quasi in esclusiva, chierici e poeti. Nel nostro caso, de’ ros-si, anche in ripresa dell’idea cartesiana sulla morale, figlia delle regole che il potere determina, sposta il concetto nella direzione della piú indefinita debolezza umana e del libero arbitrio operante nella condizione di fragilità in cui versa l’uomo di fronte alle tenta-zioni. L’intera problematica morale del nostro autore si lega, inoltre, a un progetto piú generale che cerca di riportare all’interno dei moderni postulati della scienza la rivalutazione dello spiritualismo cristiano,
47 Ivi, 25, 6-8. Cfr. Matt. VI, 20: «Thesaurizate vobis thesauros in coelo».
48 II - 111, 1-8. Sui primi tre vv., cfr. Matt. 7-19: «Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione»; ma anche Luca, 13.
introduzione
38
nel tentativo di salvaguardare e identificare nuove certezze nella trascendenza di Dio, nell’immortalità dell’anima, nell’istituto della provvidenza e nell’in-contestabilità dei miracoli. Né va dimenticato il già citato sforzo di recuperare quella fascia di intellettua-li che oggi amiamo catalogare come libertini eruditi, i quali, seppur aperti ad accogliere le novità del sapere, restavano ancorati all’accettazione del potere politi-co, pur nel rifiuto dell’ignoranza, dei pregiudizi e nel disprezzo delle masse rozze. Nel corso del Seicento venivano identificati come coloro i quali allontanati-si dalla vera fede erano rimasti preda del vizio. La nuova prospettiva ribaltava le teorie rinascimentali, fortemente avversate da Calvino, protese a esaltare la naturalità dell’uomo, considerando nella resurre-zione di Cristo anche il riscatto della carne. Secondo questo punto di vista, il desiderio non doveva essere oggetto di repressione, ma, proprio nel volere del ri-sorto, andava soddisfatto. L’attacco verso gli uomini che avevano perduto il sentiero del bene si sviluppa, in de’ rossi, nella triplice concatenazione che il ter-mine libertino presentava nel nuovo secolo: dissoluto, ateo, filosofo scettico49.
La visuale compositiva del poeta partenopeo si muove in parte anche nell’arguto riflesso della crea-zione di immagini, cui non è estraneo il rapporto tra parola e rappresentazione, proprio del teatro gesuiti-co. L’idea di fondo, infatti, parte dallo sguardo sulla realtà, mediante uno spazio concepito nella memoria dalla reinvenzione fantastica. A tal fine, sembra ispi-
49 Sulla storia del libertinaggio, cfr., F. didier, Storia del liber-tinaggio e dei libertini, trad. di Marianna Matullo, Salerno, roma, 2009.
introduzione
39
rarsi il procedimento retorico del poeta, vòlto a legit-timare una lezione morale attraverso gli espedienti tecnici della composizione, cosí da evidenziare i nes-si generati dalle similitudini visionarie da lui stesso ideate. In questo contesto, per cogliere appieno l’im-pegno retorico concepito, corre l’obbligo di richiamare alla mente il De arte retorica libri tres ex Aristotele, Cicerone et Quinctiliano precipue deprompti, di Ci-priano Soarez50, testo esemplare della retorica gesui-tica, con oltre duecento ristampe fino al Settecento, per aver recuperato il patrimonio classico, rendendolo funzionale al progetto cristiano. Fondamentale, poi, per comprendere lo sforzo prodotto nel salvaguardare il valore dell’eloquenza, la centralità data nella predi-
50 Dell’opera esce una prima edizione a Coimbra, sede privilegia-ta, nella seconda metà del XVI secolo, dei maestri della Compagnia di Gesú, presso Ioannem Barrerium, nel 1562, e una seconda, per ope-ra del tipografo Michiel Tramezzino, che ne ebbe l’esclusiva per un ventennio, a Venezia nel 1565, revisionata dal famoso gesuita pedro Juan Perpinyà, insegnante di retorica presso i collegi di Coimbra e di roma. Cipriano Soarez fu padre gesuita, spagnolo di nascita, anche se visse a lungo in portogallo (di qui l’alternanza morfologica del co-gnome Suarez/Soarez). Dedicò la sua vita all’insegnamento della re-torica classica e fu rettore del Collegio d’educazione della Compagnia di Gesú di Coimbra, uno dei piú antichi e prestigiosi collegi dell’e-poca. Morí, quasi settantenne, nel 1593. Per la bibliografia sull’au-tore, cfr., L. coci, La retorica della retorica: Ferrante Pallavicino e Cipriano Soarez, in Gino rizzo (a cura di) Sul romanzo secentesco. Atti dell’incontro di studio di Lecce (29 nov. 1985), Galatina 1987, pp. 153-165. Della studiosa riportiamo l’efficace sintesi data all’opera di Soarez: «Il De arte rhetorica consta di un proemio, di carattere rias-suntivo, e di tre libri come esplicitato dal frontespizio: il primo tratta dell’inventio, soffermandosi a lungo sull’amplificatio e analizzando i sedici loci comunes desunti dalla topica ciceroniana; il secondo del-la dispositio, illustrando i caratteri dell’orazione mediante frequenti esempi classici; il terzo della elocutio, o piú specificatamente di tropi e figurae dell’ornatus, infine della memoria e della pronunciatio. Cfr., inoltre, A. Battistini, I manuali di retorica dei Gesuiti, in La «ratio studiorum». Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Ita-lia tra Cinque e Seicento, a cura di Gian paolo Brizzi, roma, Bulzoni, 1981, pp. 77-120.
introduzione
40
cazione al genere epidittico e l’attenzione alla misura dell’elocutio, cosí da costruire su regole sperimentate i nuovi sermoni.
Lo stile epidittico trova, per Soarez, il principale riferimento in Quintiliano che intravede nella dire-zione dimostrativa uno dei tre generi della retorica classica, piuttosto che nel senso dell’atto di indicare. Il procedimento vive, quindi, nell’ostentazione dell’ec-cellenza espressiva, nell’ardore della rappresentazio-ne, per cui, a seconda dell’intenzione discorsiva, gli ar-gomenti affrontati diventano oggetto di lode o di bia-simo. Si attua, pertanto, una colorazione del linguag-gio che rischiara e aiuta il processo conoscitivo, con una forza nuova assegnata alla parola che travalica il semplice confine ornamentale. Nel pieno significato aristotelico si elimina, quindi, ogni scorporazione tra ragione e parola: quest’ultima, infatti, è da intendersi come mezzo per rendere visibile il verbum mentis. Di qui l’importanza assunta dall’espressione nell’ideolo-gia gesuitica: grazie a essa è possibile il disvelamento della verità, ma può anche diventare il veicolo di una falsa verità, come abbiamo visto nelle Risposte del de’ rossi. La soluzione va ritrovata allora, e ancora una volta, nell’insegnamento di S. tommaso, il quale rite-neva la profezia non come un habitus, ma come una mozione transeunte; in base a ciò, la stessa persona può profetare sia il vero sia il falso, a seconda che sia stata toccata o meno dallo Spirito di Dio51.
51 Al tempo dei profeti la distinzione tra vera e falsa profezia non era sempre chiara. Il possesso di uno “spirito” profetico estatico non era un criterio sicuro: i profeti potevano essere toccati dallo spirito e anche profetare il falso; inoltre, la maggior parte dei profeti non danno segni certi di essere stati estatici.
introduzione
41
L’utilizzo di un discorso orientato verso la rap-presentazione dell’intelletto conoscitivo non può che accettare la diversità dei punti di vista; partendo dal presupposto che la verità umana contempera un adeguamento dell’intelletto al mondo sensibile, da cui si genera ogni conoscenza umana, non può non considerare la diversità delle argomentazioni che in essa coesistono. Quando la parola restituisce visibili-tà al concetto, si ammanta di una profondità etica e morale, in quanto, nuovamente secondo la visione di San Tommaso, nella sensibilità vive una spiritualità autonoma; pertanto, attraverso l’unione tra l’intellet-to e il sensibile è possibile giungere alla conoscenza. L’arte della retorica, grazie alla cura dell’espressione, al tono, agli usi corretti dei suoni della voce e alla capacità figurativa, può raggiungere e toccare le sfere intime dell’affettività, riuscendo a persuadere - solle-citando la volontà a dominare le passioni, orientando-le verso il bene o almeno nella ricerca di un equilibrio tra l’intelletto e la sensibilità -, cosí da correggere gli eccessi ed educare alla moderazione.
L’importanza del trattato di Soarez va identificata, inoltre, nel tentativo di spostare alcune difficili que-stioni del dibattito dottrinale nella direzione morale ed emotiva. Il testo di Soarez, infatti, ribalta la tesi di erasmo, il quale, nell’Ecclesiastes52, aveva orien-tato il predicatore alla funzione dell’insegnamento, assoggettando la tripartizione classica dei generi e la varietà delle funzioni retoriche all’evangelizzazio-
52 Sul trattato teorico di erasmo sulla predicazione, cfr. L. de Gra-nada, Ecclesiastes sive de ratione concionandi libri sex, Venice, F. Zi-lettus, 57; J. W. O’ malley, Erasmus and the history of sacred rhetoric, in «Erasmus of Rotterdam Society Yearbook», V (1985), pp. 1-29.
introduzione
42
ne53. La scelta sempre piú diffusa del volgare nella predicazione andava di pari passo, in particolare nel Cinquecento, con un ricercato gusto estetico, special-mente nell’uso delle coordinate linguistico-letterarie. Si avvertiva, pertanto, il bisogno di trovare un punto d’incontro tra l’esigenza di una predicazione popolare e una struttura retorica efficace. Sempre piú diffusa-mente si tenta, allora, di riunificare i modelli di reto-rica sacra con quella profana, nel senso che la retorica umanistica dettava le sue regole sulla predicazione volgare e sulla precettistica, con la conseguente appli-cazione degli strumenti retorici, piú o meno tradizio-nali, ai pronunciamenti dei discorsi sacri. In questo modo, le prediche cominciarono ad assumere, sempre piú saldamente, dei veri e propri caratteri letterari.
Di qui, come si può notare, le tesi di Soarez rive-stono un carattere rilevante per l’elaborazione della retorica gesuitica. La diffusione capillare nei molti collegi gesuitici sparsi in Italia consentí al trattato di diventare un punto di riferimento di quella cultu-ra; per cui, non poteva che essere apprezzato anche nel collegio napoletano frequentato da de’ rossi e seguíto nelle tecniche oratorie e letterarie proposte. L’insegnamento dell’eloquenza, sulla base del trat-tato, partiva dall’equilibrata imitazione dei modelli - corrispettivo poetico del concetto di emulazione che accompagnò il dibattito cinquecentesco e la diffusio-ne del petrarchismo -, in particolare di Cicerone, ri-chiamato espressamente nel manuale come punto di
53 A tal proposito, cfr. l’interessante l’analisi di S. GiomBi, in Pro-cessi di disciplinamento linguistico nella prima età moderna: teorie sulla retorica sacra fra XVI e XVII secolo, in Modernità: Definizioni ed esercizi, a cura di Albano Biondi, Bologna, Cooperativa Libraria Universitaria 1998, pp. 167-168.
introduzione
43
riferimento dell’eredità greco-romana. L’idea di base, infatti, considera la lingua come forma che si traman-da di secolo in secolo, in cui si sintetizza l’esperienza delle civiltà precedenti, ritenute frutto esclusivo della ragione.
I classici, quindi, ripuliti dalle scorie pagane, ve-nivano a sostenere la nuova cultura cattolica che, in tal modo, si nutriva anche della tradizione. tali co-noscenze, ampiamente diffuse nel secolo decimosesto, furono travasate nel successivo: non erano estranee, quindi, a de’ rossi, come non lo erano ai giovani che si formavano nelle scuole gesuitiche dell’epoca. Basti pensare, d’altronde, alle idee dei vari trattatisti di re-torica, anche sacra; l’ammonimento a «imitar con giu-dicio» del già citato Daniello Bartoli54, oppure i riferi-menti alla moderazione dell’imitazione presenti nel Cannocchiale di emanuele tesauro. È noto, inoltre, come l’azione pedagogica della Compagnia di Gesú travalicasse ben presto le mura dei collegi, estenden-
54 Cfr. D. Bartoli, Dell’uomo di lettere difeso et emendato, cit., in Trattatisti e narratori del Seicento, a cura di e. raimondi, Milano-Napoli, ricciardi, 1960, pp. 329-330, in ripresa dell’edizione Milano, Malatesta, 1646 (la prima edizione di quest’opera uscí a roma, eredi del Corbelletti, 1645, poi in una piú aggiornata riedizione, Venezia, N. Pezzana, 1672): «Ma degli scritti altrui approfittarsi con sola l’imitazione, a giudicio di Quintiliano, che lungamente ne parla è troppo poco guadagno. Sia dunque la seconda maniera di furto, non che di lecito, ma lodevolissimo, torre da altrui ciò che si vuole, ma del suo migliore sí che non sia piú desso. Nella maniera che i diamanti, ricevendo un semplice raggio di luce che loro penetra al fondo, sí l’abbelliscono e la dipingono di tanti e cosí be’ colori che il sole non è sí bello e le stelle ne perdono». Nella rappresentazione della luce del Bartoli non mi sembra estranea la concezione espressa da Soarez nel terzo libro del già citato trattato, nel quale s’intendeva l’elocutio come l’elemento che attribuisce colore al linguaggio, come un abito simile alla luce. Negli anni vicini alla produzione di de’ rossi, ricordiamo sempre del Bartoli: Il torto e ’l diritto del non si può dato in giudicio sopra molte regole della lingua italiana, Venetia, presso paolo Baglioni, 1658.
introduzione
44
dosi nell’intera società civile attraverso le Congre-gazioni Mariane. Esse affiancarono gli ex studenti impegnati nelle cariche civili e religiose, le famiglie nobili, i gruppi mercantili, le borghesie urbane, etc., diffondendo la cultura gesuitica in tutta europa, an-che attraverso una serie di pubblicazioni che, insieme a preghiere e canti religiosi, tracciavano le linee per una vita regolata sia nel comportamento pubblico sia in quello privato55. Né mi pare impropria, in questo contesto, la citazione dell’utilizzo linguistico dell’apo-logeta tertulliano56, il quale, nella ripresa di alcune caratteristiche del parlato degli avvocati, strutturava i periodi in modo segmentato, con continue formu-le interrogative, esclamative, con metafore, cosí da rendere il discorso piú convincente e di effetto. egli evidenziava, infine, la possibilità di somiglianze tra la verità rivelata e l’etica di alcune dottrine filosofi-che pagane, tanto da considerare Seneca come un sa-piente sostenitore di teorie affini al pensiero cristia-no. Sulla base di ciò, e per l’esaltazione che egli fece delle Sacre scritture, Quinto Settimio può ritenersi
55 Sulla questione, cfr. D. zardin, Congregazioni, libri di regole e manuali per la formazione dei laici: un modello di fortuna internazio-nale, The Jesuits and the Educationof the Western World (16th – 17th Centuries), Georgetown university at Villa Le Balze - 21-22 June, 2002. S. GiomBi, Sacra eloquenza: percorsi di studio e pratica di let-ture, in Libri, biblioteche e cultura nell’Italia del Cinque e Seicento, a cura di E. Barbieri e D. Zardin., Milano, V&P Università 2002, pp. 137-217.
56 Quinto Settimio Fiorente tertulliano fu retore, avvocato e te-ologo (Cartagine 155 circa - 230 circa), convertitosi al cristianesimo, scrisse, tra le altre opere, l’Apologeticum, in difesa dei cristiani e contro le usanze pagane; pose le basi per la teologia trinitaria della Chiesa latina. Fu uno degli autori lungamente rivisitato in tutto il periodo umanistico, in particolare per le sue sentenze icastiche; dalle sue tragedie sono state estrapolate spesso sintagmi, trapiantati per intero nelle opere tardo-cristiane, fino al Boiardo e in buona parte del Cinquecento.
introduzione
45
un ulteriore e consolidato punto di riferimento per il discorso, fin qui svolto, sui modelli seguiti nel secolo diciasettesimo.
L’esperienza mariniana della parola nuova, slega-ta dai meccanismi della retorica cinquecentesca, non stride con l’intenzione di de’ rossi di arricchire il gio-co verbale di significati etici. Le citazioni degli autori antichi vengono utilizzate, infatti, in una dimensio-ne sovrastorica, rapportando i valori dell’humanitas alla sollecitazione dell’intelletto, il quale, una volta acquisiti i dati della conoscenza, tocca i luoghi inte-riori dell’anima, disciplinando e orientando gli appe-titi sensitivi. Nello stesso modo, l’idea dell’ut pictura poesis, che accompagna tanta produzione secentesca, sostiene - nel nostro autore - le numerose raffigura-zioni cristologiche, rispondenti in buona parte all’i-deale dell’indottrinamento. Al tempo stesso, però, in filigrana è possibile intravedere quella proprietà della filosofia religiosa che considera il corpo umano come imago del corpo di Cristo in cui si racchiude il mistero dell’incarnazione divina, valutando la stessa come arricchimento dell’umanità piuttosto che una mortificazione dell’interezza di Dio, cosí come risul-ta ampiamente dimostrato nella costruzione scenica del teatro gesuitico57. Si potrebbe ipotizzare, inoltre, che la mutazione unica della natura divina nell’uomo abbia sostituito nell’immaginario popolare le molte-plici e variegate metamorfosi che accompagnavano
57 Sulla questione, cfr. G. zanlonGhi, Teatri di formazione. Actio, parola e immagine nella scena gesuitica del Sei-Settecento a Milano, Milano, Vita e pensiero, 2002, pp. 222-223. Della stessa autrice, a proposito del rapporto tra parola e rappresentazione, cfr., La psicolo-gia e il teatro nella riflessione gesuitica europea del Cinque-Seicento, in «Memorandum», 4, 2003, pp. 61-85.
introduzione
46
l’operato degli dèi pagani. Alla luce delle riflessioni fin qui articolate, si possono rileggere quelle opere soste-nute dall’ottimismo etico - riconosciuto alle strategie gesuitiche - e pedagogico, che, in altro modo, risulte-rebbero incomprensibili se non si osserva la comples-sa architettura versificatoria, nella quale, anche nelle strutture esterne del verso, si condensa una sintesi di filosofia morale, con travasi di retorica sacra, in par-te lontana, però, dalla poesia pienamente religiosa, quando risulta contaminata dagli elementi mitologici.
La continua citazione interna fra testi ‘sacri e profani’ si sposa con l’esigenza tipica di evidenziare l’elemento dotto, espressione della teorizzata tecnica a intarsio, cui segue l’allegoria che spinge verso la riflessione e la comprensione del messaggio morale. Nel procedimento poetico di de’ rossi, incontriamo, a tal proposito, una serie di personaggi che si ergono nei componimenti come simboli, peculiare esempio assurto a emblema nel componimento barocco. Il si-stema ermeneutico, infine, si muove sempre nell’ac-quisizione dei dati conoscitivi e allena a decifrare il senso delle cose attraverso la costruzione retorica, che diventa, in ultima analisi, espressione dell’origi-nalità del poeta.
***Non si discosta dai temi discussi il poema Dell’im-
magine della vita umana58, diviso in dodici libri, dove 58 Dell’immagine della vita umana, poema morale del Signor A.
de’ Rossi, parte prima, con gli argomenti fatti da incerto autore, Napo-li, Eredi di Roberto Mollo 1669 (libri I-VI), è dedicato All’Ill.mo ed Ec-cell.mo Sign. D. Gasparo De Bragamonte e Gusman, Conte di peñe-randa, Viceré e Capitan Generale del regno di Napoli. La seconda parte (libri VII-XII) fu stampata sempre in Napoli, Giov. Francesco Paci 1670, e dedicata al Vescovo di Bitonto, Alessandro Crescenzio. Il numero di ottave che compongono i diversi libri varia da un numero
introduzione
47
l’autore offre uno sguardo sulla vita dell’uomo, illu-strandone vizi e virtú. L’opera si apre con una lettera dedicatoria di Alberto de’ Rossi, fratello del poeta, a Don Gaspare di Bragamonte y Gusman59 ed è caratte-rizzata da una serie di allegorie; in essa luci e ombre si alternano nello sviluppo di una costruzione poetica sapientemente organizzata tra erudizione e fervida immaginazione.
Il I libro si apre con una serie di visioni in cui l’au-tore si propone di narrare gli errori commessi dall’uo-mo e lo sforzo compiuto dalla virtú per mostrare a lui i beati chiostri. L’uomo avvolto in un duro laccio chiede aiuto al Signore; a un tratto gli si presenta un messaggero celeste per svelargli i misteri umani. Dio è colui che vive nell’uomo e permette agli uomini di esercitare le funzioni vitali:
Questo spirto vital che ’l corpo avviva,ove ingombra l’arterie e si trasfonde,l’innalza ed è dover che ciò s’ascriva60.
Davanti al cuore si aprono due finestre: una per ammirare il Signore, l’altra per distinguere gli errori umani. L’uomo sa che deve amare Dio piú di ogni al-
che si aggira intorno a 70 fino a ben oltre 100; ogni inizio di libro è preceduto da un’ottava di proemio.
59 «eccll.mo principe, la Vita umana anche nello stato dell’innocen-za ebbe bisogno della custodia e della protezione di un angiolo istra-darsi al glorioso acquisto della sperata beatitudine… Oltre che essendo l’intento dell’autore indirizzato alla riforma dei costumi, co’ che da lui si desidera negli altri, vedendosi nobilmente delineato nella rettezza impareggiabile ben regolata azione… 10 agosto 1662. Frate Alberto de’ rossi de’ predicatori», pp. 3-4. Don Gaspare Gusman, Viceré di Napoli dal 1659 al 1664, fu al comando della delegazione spagnola alla pace di Westfalia nel 1648 per conto del re di Spagna, Filippo IV; dopo la morte del re, nel 1665, divenne uno dei reggenti del regno di Spagna.
60 XVIII, 1-3.
introduzione
48
tra cosa, solo cosí potrà raggiungere la pace infinita, se invece non lo ama perviene all’errore; l’angelo gli fa notare che l’uomo è l’opra maggior uscita dalla mano del gran fabro. L’ingratitudine dell’uomo verso Dio ha generato la distruzione di Gomorra. Segue la visione dell’uomo che rincorre inutili lussi e sfarzi, generando nel poeta dolore e spavento. Arrivato alle pendici di un monte, sulla cui sommità alberga la virtú, incon-tra una donna che esorta gli uomini a non lasciarsi ingannare dalle lusinghe.
La vicinanza alle immagini dantesche della Co-medía, nei versi sopra riportati, farebbe pensare su-bito alla “teoria degli spiriti vitali” che Dante ricava dalla elaborazione di Alberto Magno della fisica aristo-telica, secondo la quale il nostro corpo sarebbe percorso da spiriti (o «funzioni dell’anima») invisibili e preposti al funzionamento dei diversi organi del corpo. In parti-colare nella Vita nova (II), Dante descrive i movimenti degli «spiriti» alla presenza della donna amata: ogni stato psico-fisico, come esultanza, dispiacere o perdita di coscienza, viene spiegato come diretta conseguenza del loro disporsi all’interno del corpo o anche dell’ab-bandono temporaneo della loro sede. Lago del cor (la parte piú interna del cuore) definisce Dante il luogo dove albergano gli spiriti, in cui si raccoglie il sangue e da cui, diramandosi, porta gli spiriti vitali per tutto il corpo. Il Boccaccio, nel suo commento ai primi dicias-sette canti dell’Inferno, riferisce l’opinione dei suoi con-temporanei, secondo cui in questa cavità abiterebbero gli ‘spiriti vitali’, dove risiedono tutte le passioni.
La discussione è ampiamente documentata nella trattatistica scientifica dei secoli XI-XVII; pertanto, conviene spostare l’attenzione su alcuni indispensa-
introduzione
49
bili riferimenti, per meglio inquadrare certi aspetti del pensiero di de’ Rossi nell’ambito delle conoscenze del XVII sec., cosí da attestare appieno il gusto che muove il poeta nelle opzioni lessicali interne ai testi. Causa brevitatis, quindi, si segnala solamente qual-che importante punto che animò il dibattito secente-sco. Nello specifico contesto delle opzioni linguistiche del nostro autore, va ricordato che la scoperta della circolazione sanguigna deve ritenersi una vera e pro-pria rivoluzione scientifica, in quanto, nel Seicento, apportò un cambiamento radicale nei metodi e nel ri-pensamento delle funzioni vitali61. Alla stessa stregua del rapporto Galileo-Copernico, deve essere conside-rato il famoso volume di William Harvey, Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, pubblicato a Francoforte nel 1628, nei confronti delle teorie di Galeno ancora in auge negli anni Sessanta del ’600. Harvey sosteneva, infatti, che la circolazione sanguigna avveniva in un sistema chiuso: il sangue, una volta spinto dal cuore agli organi, ritornava nuo-vamente al cuore. La teoria si sviluppava, quindi, in opposizione alla tesi galenica, secondo cui il sangue contenuto nel ventricolo destro veniva inviato ai pol-moni allo scopo di nutrirli. Il sangue era considerato, inoltre, veicolo di calore che si propagava dal centro dell’organismo verso le estremità, senza alcuna pos-sibilità di essere ritenuto, quindi, come fluido inerte, poiché presentava connotazioni di tipo vitalistico62.
61 Si rimanda, per un’ampia e documentata panoramica sulla que-stione, a thomas s. kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, torino, einaudi 1999.
62 Harvey dimostrò che nelle vene il sangue non aveva decorso centrifugo, come invece sosteneva Galeno, secondo cui il sangue an-dava dal fegato alla periferia. Galeno, inoltre, differenziava il sangue
introduzione
50
Simboleggiava, inoltre, la sede dell’anima ed era in-dissolubilmente legato a quegli “spiriti vitali”, capaci di rinnovarlo e rigenerarlo continuamente63.
Di spiriti vitali nel Seicento parlano anche Hobbes - che nella teoria della conoscenza considera alcuni contenuti concettuali distaccati dal pensiero, soste-nendo che gli elementi esterni esercitano sui sensi uno stimolo meccanico, il quale permette alla mente di sviluppare il concetto corrispondente, mediante la reazione degli spiriti vitali inferiori. In tale ambito, le essenze non costituiscono l’oggetto diretto della conoscenza, bensí i concetti64 -, Cartesio, pascal, per
venoso da quello arterioso, di un colore piú vivo, originato alla pre-senza di pneuma e di spiriti vitali. Il sangue arterioso, localizzato nel ventricolo sinistro del cuore, si generava dalla commistione di pneu-ma e sangue e veniva distribuito, muovendosi anch’esso unicamente in direzione centrifuga, per giungere a vivificare tutte le parti dell’or-ganismo. Questi due diversi tipi di sangue svolgevano due distinte funzioni: il sangue venoso era considerato essenzialmente un liquido nutritivo, mentre il sangue arterioso trasportava gli spiriti vitali. Harvey capí invece il reale meccanismo della circolazione venosa e la funzione di pompa svolta dal cuore per mettere in circolo il sangue; non riuscí, però, a vedere i capillari, in seguito scoperti da Malpighi negli animali a sangue freddo (tra il 1659 e il 1662) e da Spallanzani in quelli a sangue caldo (nel 1768 pubblica Dell’azione del cuore nei vasi sanguigni). Val la pena ricordare, inoltre, che nella metafisica campanelliana il sangue diventa sinonimo di calore, di potenza, di sa-pere e di amore. Sulla questione cfr. A. cerBo, Theologiza et laetare. Saggi sulla poesia di Tommaso Campanella, Napoli, Istituto univer-sitario Orientale, 1997, pp. 155-180.
63 Harvey, si laureò dottore in Medicina, presso l’Università di Padova, il 25 aprile 1602; per un riscontro sulle questioni poste, cfr. W. harvey, Opere, a cura di F. Alessio, Torino, Boringhieri 1963; W. PaGel, Le idee biologiche di Harvey, Milano, Feltrinelli 1979; F. ro-Bert, Harvey e i fisiologi di Oxford, Bologna, Il Mulino 1983.
64 All’interno di tale visione, la razionalità viene concepita come una sorta di calcolo, in quanto i contenuti concettuali sono raggruppati in proposizioni: la mente, analogamente a una macchina, opera sulle parole tramite operazioni aritmetiche. Anche sul piano etico, Hobbes ritiene che le emozioni e gli atti della volontà siano prodotti dagli stimoli che provengono dall’oggetto e determinati meccanicamente. Il piacere nasce con l’aumentare del movimento degli spiriti vitali e l’oggetto che lo produce viene recepito come bene. Da tale teoria
introduzione
51
citare solo alcuni nomi che promuovono opere e dibat-titi contestualmente alla produzione del nostro poeta. Affermare con un tono profetico il naturale protendi-mento dell’uomo verso il cielo (a opera di una parte della letteratura spirituale), voleva dire, in definiti-va, opporsi alla visione materialistica e deterministi-ca del pensiero inglese, che conquistava sempre piú spazio nella discussione tra gli intellettuali di tutta europa. Allo stesso modo, seguendo il percorso razio-nale di Cartesio, pascal criticava il metodo con cui il filosofo giungeva, mediante il cogito, alla dimostra-zione dell’esistenza di Dio. Quando, infatti, pascal nega il mero “Dio dei filosofi”, si riferisce soprattutto al Dio accettato da Cartesio come motore dell’univer-so e approvato per dimostrare altre cose. Dio non può essere considerato una macchina che dà movimento a un’altra macchina, sostiene pascal, ignorando l’in-finito amore e la misericordia che lo caratterizzano65. Alla luce di queste considerazioni, le immagini impie-gate nei versi prima citati testimoniano la vivacità della produzione letteraria di de’ rossi e, in linea piú generale, il collegamento che le parole operano con le istanze scientifiche e filosofiche presenti nel dibattito
deriva l’autoconservazione: ogni organismo mira a perpetuare il suo movimento vitale e a evitare la morte, poiché la propria sopravvivenza costituisce il valore supremo, ogni individuo agisce egoisticamente. Non esiste, quindi, alcun principio superiore a cui è necessario fare riferimento: ognuno decide da sé la cosa migliore per lui.
65 B. pascal, Pensieri, traduzione e cura di Chiara Vozza, rimini, Guaraldi, 1995. 77: «Non posso perdonare a Descartes; il quale in tutta la sua filosofia avrebbe voluto fare a meno di Dio, ma non ha potuto evitare di fargli dare una spintarella, per mettere in movimento il mondo; dopo di che non sa piú che farne di Dio». pascal nega sia il conatus recedendi (la forza centrifuga che animerebbe tutti i corpi) che la considerazione cartesiana sugli spiriti vitali (cause delle passioni). La realtà, secondo il filosofo francese, è infinitamente piú ricca di quanto l’immaginazione umana riesca a concepire e per affrontarla adeguatamente, occorre mol-tiplicare i metodi, seguendo le indicazioni che essa, di volta in volta, offre.
introduzione
52
teorico dell’epoca. La presenza di una cosí viva con-cettualità nel linguaggio cólto del tempo, attesta, infi-ne, la popolarità di tali discussioni e di come i sistemi poetici contribuiscano a rendere visibile l’universo composito della società che li partorisce, mediante l’adozione di specifiche formule comunicative66.
Nel II libro, il poeta, adottando un fuggevole richia-mo virgiliano, racconta di scorgere, presso un fiume, una sirena graziosa e vaga, impegnata nel tentativo di deviare il pellegrino dal sentiero che porta al monte per orientarlo verso il fiume, dove si trova la dimora delle sirene. La valle, in cui la sirena dal dolce canto i sensi ammaga, è metafora della condizione in cui vive l’uomo privo di senno ed è il luogo dove si annidano diversi mostri. Nell III libro narra, invece, l’entrata del poeta nel tempio di pallade, con la successiva descri-zione dei vari personaggi mitici raffigurati all’interno. Nel IV e V libro constata che spesso il men degno al trono ascende e spiega i difetti dei letterati ingegni:
Ben converrà che ’l dolce e chiuso inganno,che i vani ingegni lusingando preme,ti additi e spieghi il lagrimevol danno;per cui rado l’uom dotto è mesto e geme,spesso di colpe indegno autore tiranno,fassi tra voi di vostre scienze il seme,ei, dal sentiero in cui virtú soggiorna, con fitte larve i cori altrui inganna67.
Il messaggero sottolinea, poi, come la vita umana non si preoccupi di giungere alla meta stabilita da Dio. Nell’ammirare tra i filosofi Cratilo e Socrate, il poeta chiede:
66 A riprova di ciò, si ricordino le diffuse rappresentazioni della circolazione sanguigna nell’Adone del Marino.
67 IV, 4.
introduzione
53
perché gli altri piú degni, e in sé perfetti,spesso giaccion fra noi bassi e negletti68?
L’angelo spiega che il regolatore di ogni cosa è Dio, e tutto ciò che in genere si attribuisce alla sorte o al fato è frutto della sua mente; dona, inoltre, lo scet-tro ai buoni e diffonde gli alti onori, mentre all’uomo crudele conserva gli eterni mali. proseguendo poi il cammino, s’intravede un nuovo monte; uno stuolo di creature mostruose ne rende però difficile l’accesso. Continua l’invettiva contro l’invidia, l’inganno, la guerra, l’orgoglio, affermando che solo nella fede l’uo-mo può trovare godimento. Nel libro VI, l’autore spie-ga come i tiranni, attraverso l’inganno, raggiungano i loro scopi, ma la frode donerà solo piaceri brevi; s’in-vita, pertanto, l’uomo a evitarne i consigli. Nel VII libro, Astrea, dea della giustizia, viene percossa da un mostro, simbolo della frode, che tenta di usurparne il trono, successivamente sconfitto insieme ai seguaci:
Quegli, orrendo di forma, a forze estremeavea congionto temerario ardire,l’ali di pipistrel dibatte e fremecrucioso, par che fiamme essali e spire;squamoso il dorso e ’l sen non sente o temedi forte il braccio le percosse e l’ire,ove gli artigli impetuoso ei volveogni duro metal frange e dissolve69.
Il libro VIII illustra la fragilità dell’uomo di fronte al lusso e agli inutili piaceri.
Nel IX libro si racconta dello scontro tra la verità e la calunnia, spalleggiata quest’ultima dall’ambizione.
68 IV, proemio, vv. 7-8.69 VII, 6.
introduzione
54
Nel X e XI libro sono argomentati i consigli della veri-tà, con citazioni agostiniane, e l’intento del poeta a di-rigersi verso il monte, sulla cui cima alberga la virtú. Il percorso si presenta quanto mai pericoloso; fortu-natamente, però, egli incontra la fede, la speranza e la carità, sotto le spoglie di tre donne illustri (ott. 28) che aiutano coloro i quali decidono di ascendere alla vetta. La fortezza e la sapienza sostengono e guidano i sensi umani, unitamente alla pietà e alla vigilanza, adornate, nella visione del poeta, di bianche spoglie, e all’umiltà, avvolta in un corporeo velo.
La visione descritta potrebbe, come primo impat-to, richiamare alla mente la canzone delle Tre donne dantesche70, definita da Carducci, se non la piú bella di Dante, quella “piú fortemente e immaginosamente sentita, la piú largamente e altamente intonata, la piú solidamente e leggiadramente costrutta”. Di tre donne, però, Dante parla, com’è noto, piú dettaglia-tamente nella Comedía, a cominciare da quando Vir-gilio, parafrasato - nel caso di de’ rossi - dal messag-gero, rivolgendosi a Dante, recita: «poscia che tai tre donne benedette / curan di te ne la corte del cielo»71. Le donne, in questo caso, sono la Vergine, S. Lucia e Beatrice, ma nel XXIX canto del purgatorio, Dante accenna a Tre donne in giro da la destra rota / venían danzando… (vv. 121-22), riferite piú espressamente alle tre virtú teologali. Il richiamo di de’ rossi alla simbologia dantesca della fede, della carità e della speranza è da considerarsi letterariamente piú ade-guato. riconsiderando, poi, alcuni aspetti della teolo-
70 dante, Rime, Le tre donne erano la Giustizia umana, la Giusti-zia Divina e la Legge, esuli anch’esse dal mondo degli uomini.
71 Inf., II, 124-25.
introduzione
55
gia cristiana - secondo i quali, le virtú teologali72 sono quelle virtú che riguardano Dio e consentono all’uomo di vivere in relazione con la trinità, orientando l’agi-re morale cristiano - si spiegano anche alcuni ragio-namenti avviati dal nostro autore.
Nella dottrina della Chiesa cattolica, le virtú teo-logali, a differenza delle cardinali, non possono esse-re ottenute con il solo sforzo umano, ma sono infuse nell’uomo dalla grazia divina. L’adesione di de’ rossi è piena, quindi, alle direttive ecclesiali: nella ripresa, però, anche del concetto di virtú già vivo nell’antica Grecia, quello etike arete, nell’accezione di essere “abi-tualmente eccellente”. La nozione di virtú era, infatti, ben salda nella cultura antica e, grazie all’uso che ne fece Cicerone, fu accolta dai filosofi cristiani fino a di-ventare un fondamento degli studi teologici cattolici. Nella visione di de’ Rossi è, però, possibile recupera-re la traccia del significato specifico che nella cultura seicentesca rivestiva il termine. Risulta visibile, in-fatti, la fusione operata nella tradizione occidentale sia dei dettami dei padri della Chiesa sia di quelli ari-stotelici. La scelta del poeta di accompagnare la fede, la speranza e la carità con la fortezza, la sapienza e la vigilanza mi pare che esprima una giusta mistura tra una moderna visione religiosa e quella del filosofo di Stagira, il quale menzionava quattro virtú: coraggio, temperanza, saggezza e giustizia73, distanziandosi, in
72 L’ordine di successione è ricavato dalla prima lettera di paolo ai tessalonicesi: «rivestiti della corazza della fede e della carità avendo come elmo la speranza» (1ts 5,8).
73 Aristotele, nel II libro dell’Etica Nicomachea, considera le virtú etiche come “giusto mezzo”: 1) il coraggio come giusto mezzo tra la viltà e la temerarietà; 2) la temperanza come giusto mezzo tra intemperan-za e insensibilità; 3) la liberalità come giusto mezzo tra avarizia e pro-digalità; 4) la magnanimità come giusto mezzo tra la vanità e l’umiltà;
introduzione
56
tal modo, dalla canonica rappresentazione dantesca. Siamo nella parte centrale del libro XI (ott. 34) e
verso la fine dell’opera, per cui piú sostanza acquista-no gli elementi simbolici. Nella ripresa ancora una volta del genere apocalittico, è possibile associare il bianco delle vesti o il velo al mondo della gloria, che nella tradizione sacra raffigura la gioia della vittoria.
Il XII libro racconta del gioioso raggiungimento della vetta. Qui si scoprono gli inganni del sapere terreno e i pellegrini giunti alla sommità incontrano la Fama, la Gloria, la Vittoria, unitamente alle virtú teologali e cardinali. L’opera si conclude con l’arrivo dei viandanti al tempio della beatitudine, dove viene consegnato loro il premio di una pace beata e stabil gloria, per aver seguito un cosí duro cammino.
***Di Antonio de’ Rossi si pubblicano a Napoli, per gli
Eredi di Roberto Mollo, nel 1661, i Sonetti, dedicati al fratello Alberto, Priore del Real Convento di San Do-menico Maggiore di Napoli. Nella lettera dedicatoria, preposta alla raccolta dei Sonetti, Giuseppe Dome-nichi74 informa che la responsabilità della pubblica-zione è sua, essendosi l’autore allontanato da Napoli per ritirarsi a vita religiosa, quindi, ignaro dell’inizia-tiva. La struttura della raccolta risulta organizzata mediante un accorpamento tematico che non segue
5) la mansuetudine come giusto mezzo tra l’irascibilità e l’indolenza. La virtú principale resta la giustizia a cui sarà dedicato l’intero quinto libro. Le virtú dianoetiche sono proprie dell’anima razionale. Esse sono la scienza, l’arte, la saggezza, l’intelligenza, la sapienza. Sull’opera, cfr. aristotele, Ethica Nichomachea, trad. it. Etica Nicomachea, a cura di Claudio Mazzarelli, testo greco a fronte, Bompiani, Milano,1998.
74 Giuseppe Domenichi era segretario dell’Accademia dei Confusi, con lo pseudonimo l’Offuscato.
introduzione
57
un criterio cronologico. Il tono, gli eventi raccontati e la datazione interna di molti componimenti ci con-sentono d’inquadrarli in un arco temporale che si al-lunga fino a un decennio, e oltre, prima dell’anno di pubblicazione, in un periodo in cui Napoli vive una significativa rinascita dopo i profondi disagi sociali e la miseria che avevano portato alla rivolta del ’4875.
Siamo in un tempo in cui la diffusione delle teorie cartesiane favorisce il dibattito teorico, con un rinno-vamento culturale che cerca di allontanarsi dalle or-mai consunte, pur se ancora in parte vive nel nostro autore, visioni dell’aristotelismo e del tomismo. Né il nuovo dibattito fu impedito dal viceregno spagnolo. Nonostante i sovrani di Spagna si dichiarassero re cat-tolici, erano, infatti, in velato contrasto col potere ec-clesiastico, a causa di questioni giurisdizionali. Nella seconda metà del Seicento, rinascono a Napoli le arti; la musica, a esempio, smette con le imitazioni venezia-ne e fiorentine, tanto che il teatro di San Bartolomeo, costruito nel 1620, diviene, a partire dal 1651, sotto il governo del viceré d’oñate, il tempio del dramma mu-sicale napoletano. I conservatori della città diventano particolarmente attivi nella formazione di musici e di cantanti e, insieme con essi, rinasce l’attività teatrale, con la formazione di ottimi ballerini, mimi, scenografi, la cui bravura si va affermando nel resto dell’Italia e in Europa, nonostante la peste che flagellò di nuovo Napoli nella metà degli anni Cinquanta.
In questo nuovo clima di rinascita artistica e socia-75 Sull’importanza della rinascita culturale a Napoli nel corso del
Seicento e sui precorrimenti verso una nuova idea di modernità che, per alcuni aspetti, anticipano finanche le manifestazioni dello spirito illuministico e romantico, cfr., V. Giannantonio, L’ombra di Narciso, Lecce, Argo, 2006.
introduzione
58
le si collocano le liriche di de’ rossi. L’orientamento della raccolta rispetta in pieno le moderne organiz-zazioni dei canzonieri, lontani dalle tappe di crescita e di giudizio del poeta sulle proprie esperienze esi-stenziali, cosí come aveva insegnato a lungo petrarca, puntando, invece, sull’aggregazione di frammenti e, nel nostro caso, di riflessioni su temi e motivi per lo piú morali e religiosi.
Il componimento di apertura delle Rime, Illustrato dalla divina grazia, si ritrae dagli amori profani, rende manifesti i contenuti di base ai quali s’ispira la raccolta:
Se tra lacci funesti il piede avvoltotrassi i verdi anni in libertà captivo, e fiso a i lampi d’un volubil vólto[…]doglioso umor, quel primo incendio impuro,[…]
Alla riadozione di termini petrarcheschi, o larga-mente usati dalla tradizione letteraria, Antonio de’ Rossi ne affianca altri tendenti a rompere lo stereotipa-to argomentare amoroso, per trasferire il discorso nelle pieghe dello spirito, dove maggiormente si avverte la tensione al trascendente. Avviene cosí che i consueti lacci d’oro diventano funesti (nell’Adone di G. B. Mari-no: «Conobbi… / che s’io l’ardor versava in calde stille / ed avea l’alma in duro laccio avvolta», XIV, ott. 253)76, segnando in negativo gli anni della giovinezza; la tra-dizionale rota diventa un volubil vólto e il doglioso cor si trasforma in doglioso umor, anticipando l’atmosfera triste e sofferta di un pentito pianto liberatorio.
76 In Fiori gittati al fuoco, di Bartolomeo tortoletti, leggiamo: «Ahi, che pur troppo il mio destre insano / mi fe’ soggetto; or tempo è ben che fia / sciolto il laccio crudel da la mia mano», vv. 9-11, da Rime, Roma, Lodovico Grignani, 1645; anche Marinisti, cit., pp. 494-95.
introduzione
59
Sullo stesso tema argomenta il secondo sonetto della breve silloge, piú brioso, anche se il tono mora-le resta l’elemento caratterizzante della lirica. In essa la forma dell’ossimoro petrarchesco et ardo et sono un ghiaccio (R.V.F. CXXXIV) muta in è in ghiaccio arden-te, anzi in gelato ardore3 accompagnando i dubbi pen-sier. Ciò che colpisce nelle rime dell’autore napoletano è la tendenza a ridurre gli slarghi metaforici in aper-tura e chiusura del sonetto, elemento peculiare delle composizioni barocche, per mantenere invece la chiusa etica. Esempio emblematico di come, nella ripresa del-la sintesi retorica e morale sin qui illustrata, si formuli una conclusione logica ben legata alle analogie crea-te all’inizio del componimento. L’elemento concettoso, infatti, si addensa nella poesia, ma invece di stupire, com’era solito nel Marino - creando dinanzi allo sbalor-dimento della metafora iniziale un successivo dubbio nella metafora conclusiva -, tende a trovare un suo na-turale epilogo nell’evento ammonitore, a sostegno del discorso sviluppato nel corso della lirica. un rinnovato utilizzo di una struttura metrica che proprio a Napoli aveva conosciuto, mediante il Marino e prima ancora nel tansillo77, una rottura al codificato sistema della ripetizione, che trova nella sostituzione degli scambi incrociati e delle ambigue correlazioni metaforiche, con una presa diretta sulla realtà, mediante le forti e illuminate analogie, l’attuazione piú riuscita dell’in-tento pedagogico sotteso al rigoroso incedere dedutti-
77 Sulla raccolta antologica dei documenti teorici e dei poeti d’am-biente napoletano, cfr. G. Ferroni-a. quondam, La «locuzione artifi-ciosa». Teoria ed esperienza della lirica a Napoli del manierismo», Roma, Bulzoni, 1973; cfr., inoltre, le ancora stimolanti e fondamenta-li riflessioni di G. Parenti, Vicende napoletane del sonetto tra manie-rismo e marinismo, in «Metrica», n. 1, 1978, pp. 225-239.
introduzione
60
vo, nonostante il complicato sistema allitterante che alle figurazioni mariniane pure s’ispira.
Sicuramente arguta è l’articolazione del sonetto Nella nascita della Beatissima Vergine Madre di Dio:
Sovra il Carro di stelle, il puro senosolcava di Giunon la notte oscura,né de’ lumi dorati il bel serenoombra tingea di fosca larva impura;
Teti (a’ fieri Aquilon’ già posto il freno)ridea, vie piú che mai tranquilla e pura,e ’l ciel, nuov’ Argo al parto di natura,parea d’occhiute pompe ornato e pieno.
Si osservi la fusione tra le immagini mitiche e l’ar-gomento religioso e la popolosa comparsa di personag-gi che svaniscono non appena citati. I rappresentanti del mito, inoltre, risultano sopraffatti da una creatura terrena, offuscatrice di ogni espressione pagana, che si libra verso il cielo ridimensionando e schiacciando ogni possibile altezza dell’Olimpo. Da notare la deli-cata immagine d’apertura che trasforma le sette piú brillanti stelle della costellazione dell’orsa Maggiore in un carro di stelle, senza creare però alcun contra-sto con il buio della notte78; l’opposizione vive, infat-ti, nella purezza della divina Giunone che si staglia nell’oscurità della notte. Cosí come almeno singolare, se non unica nella tradizione letteraria, riesce la pen-sata associazione delle occhiute pompe. Diversi sono poi i componimenti rievocatori di personaggi biblici ed eventi miracolosi che circondano leggendariamente le
78 In ripresa del mito secondo il quale le sette stelle, con il loro lento ruotare intorno alla stella polare, assumevano agli occhi dei latini un carro trainato da sette buoi da lavoro (septem triones, da cui il termine settentrione).
introduzione
61
vite dei santi. I motivi delle varie liriche si estrinse-cano attraverso le regole della composizione che, nel corso del XVII secolo, si rivelano testimonianza dell’e-satta attuazione di norme stilistiche, all’interno delle quali si distende il sentimento.
Antonio de’ rossi si presenta, tra i rimatori del Seicento, allineato - come già accennato - ad alcune tendenze della scuola napoletana che, pur sulla scia innovatrice del Marino mantiene viva la linea della tradizione letteraria, in una misura niente affatto ri-voluzionaria, tendente però a rispecchiare una pro-pria autenticità e originalità. particolarmente fer-vida è, infatti, la produzione lirica che, tra gli anni Cinquanta-ottanta, segna l’evento letterario a Napo-li, caratterizzata da una forte mediazione tra le istan-ze innovatrici, ancora solidamente vive nel dibattito teorico, e le tendenze classicistiche. La lente d’in-grandimento applicata sul lavoro formale dell’artista permette di definire l’elemento fondante di un’idea della letteratura e, nello stesso tempo, di discernere e individuare l’adesione agli orientamenti piú significa-tivi scaturiti dalla discussione tra gli intellettuali. Il discorso sullo stile diventa, inoltre, materia indispen-sabile per l’approfondimento degli schemi conoscitivi, in quanto l’utilizzo di specifici moduli letterari non si collega solo a un momento estetico della composizio-ne poetica, ma, insieme agli elementi contenutistici, fornisce dati essenziali per la corretta interpretazione dell’opera d’arte. Altresí, come nel nostro caso, offre la possibilità di decifrare, attraverso l’indagine gene-rale sull’autore, l’organigramma dell’intricato mondo ideologico sotteso alla complessa e variegata società seicentesca. È indubbio che - nel corso del secolo -
introduzione
62
l’architettura metrica e le particolari intelaiature rit-miche, costruite anche su una serie innumerevole di correlazioni foniche, si presentino come il corrispetti-vo delle piú generali tendenze artistiche. È pur vero, però, che le stesse rappresentano lo svecchiamento di una socialità vigente in particolare nelle classi nobi-liari, che il poeta, nella minuziosa calibratura del me-tro, finisce per rappresentare in una sorta di rispec-chiamento della nuova formazione sociale.
La crisi delle strutture versificatorie del mondo ri-nascimentale, identificabile anche nella nuova speri-mentazione dell’endecasillabo, rifletterà - a esempio - il punto piú alto di una crisi già in atto nella società79. Si considerino, a tal proposito, le verifiche dei tardi pe-trarchisti (Della Casa e tansillo), la propensione alla polimetria del tasso - evidente nell’alternanza di en-decasillabi e settenari esibiti nell’azione scenica dell’A-minta e nell’utilizzo di varie forme liriche nei cori, con la presenza della canzone petrarchesca -, cosí come av-viene nel Pastor fido del Guarini. Si pensi pure a tutta la trattatistica e alla pratica metrica proposta dal tris-sino, dal Minturno, al rifiuto delle formule canonizzate e al tentativo barocco di disciplinare gli elementi irra-zionali. L’oggetto poetico diventa, quindi, nel tempo, l’ideale corrispettivo dell’assetto pubblico, in particola-re quando tale ordine non sussiste nella comunità. La comunicazione che l’oggetto in sé propone vige, dun-que, nel sistema di leggi che ne determinano la poetici-tà, diventando il riflesso di un contesto storico-sociale ben definito dal quale l’autore trae l’ispirazione.
79 Sui rapposti tra poesia e società, cfr. G. Bárberi Squarotti, in Problemi di metrica, in Il sogno della letteratura, Milano, Franco An-geli, 1988, pp. 33-54.
introduzione
63
In pratica, è ciò che accade con la nuova poesia se-centesca, dove le rotture non si esplicano in frantuma-ti gruppi sillabici, come accadrà in maniera evidente nella poesia del Novecento, ma nel ripensato rappor-to tra significante e significato, nel rinnovamento del corroso concetto di ordine cinquecentesco, nella nuova funzionalità del metro, nel riuso dello stesso, proiettato verso la ricerca di una musicalità che medi il rivolgimento interno delle strutture versificatorie con il mantenimento di un apparato esterno rivolto a convalidarne l’esperienza artistica. I connotati poeti-ci propongono, pertanto, pur nell’impiego di tecniche poetiche tradizionali, rinnovate relazioni tra strutture linguistiche e ritmiche. uno stile che solo apparente-mente risulta - nelle formule diffuse delle riadozioni formali e nelle continue variazioni tematiche - privo di contenuti, speculare di una semplice pratica estetica. Nella catena verbale è identificabile, infatti, la natura individuale e sociale dell’autore, da cui emerge il carat-tere distintivo, nella quale si riflette la multidireziona-lità della società o almeno di una parte di essa.
Se la tradizione letteraria si presenta poi come un organismo in continuo movimento - bisognoso di risi-stemarsi dopo l’apparizione di opere nuove, per docu-mentare l’avvenuta rigenerazione80 -, sarà possibile cogliere, all’interno degli impulsi innovatori, le nuove tendenze, essenziali per codificare con la loro esisten-za le esperienze precedenti. Si resta continuamente
80 Cfr., t. S. eliot, Tradizione e talento individuale (1919), trad. it. in Opere, Milano, Bompiani 1992, vol. I, p. 394: «L’ordine esistente è in sé concluso prima che arrivi l’opera nuova; ma dopo che l’opera nuova è comparsa, se l’ordine deve continuare a sussistere, tutto deve essere modificato, magari di pochissimo».
introduzione
64
nell’attesa di moderni eventi letterari, per riconosce-re gli elementi di novità, in modo da classificare quelli pregressi nella giusta posizione di un indefinito puz-zle. Accade ciò - in definitiva - nella poesia barocca: un catalizzatore intorno al quale si fissano sempre nuove monadi. La visione d’insieme può essere generata, per-tanto, solo da una falsa prospettiva, perché non appe-na si adopera la lente d’ingrandimento per mettere a fuoco la conformazione della massa, ci si accorge dei numerosissimi microcosmi di cui essa è composta. Non è in alcun modo possibile, quindi, prescindere da un’os-servazione precisa e capillare per delineare la struttu-ra portante della vasta quantità poetica.
La rottura con le tendenze dell’epoca e, al tem-po stesso, l’adesione a specifiche correnti di pensiero s’identificano in de’ Rossi nell’intento di far rivivere all’interno di un verso tradizionalmente armonizzato, con il suo incedere grave, lentamente cadenzato, a so-stegno di contenuti altrettanto seri e compassati, una serie di figurazioni lontane tra loro, aventi quasi un carattere neutro, demistificante e demitizzante della materia trattata. Al lettore è affidata la decontestua-lizzazione delle scene rappresentate e il dipanamento delle formule enigmistiche sostenute dalla rete delle analogie, cosí come prevedeva la componente di base della lirica secentesca. In contemporanea, però, le tecniche poetiche si rivestono di una rinnovata ideo-logia, rispetto ai criteri che le avevano generate. Il linguaggio assume, in tale contesto, pur all’interno di una scuola, valenze e progettualità diverse, in un completo processo di attuazione storica.
Va assottigliandosi la gratuità e l’apparenza del puro esercizio letterario, per sostenere il racconto e
introduzione
65
potenziare la suggestione e l’esemplarità del signifi-cato. Il collegamento tra l’imprevedibilità degli acco-stamenti e gli obiettivi che li hanno generati è reso in maniera piú evidente, di conseguenza piú chiaro diventa il rapporto tra le parole. Il testo si va cosí formando attraverso una serie di concatenazioni ver-bali che non procurano eccessive vertigini e oscurità, anzi, rendono visibile il punto di approdo, cosí da ren-dere palese anche la posizione di partenza. piú che uno straniamento, nel lettore si verifica uno sposta-mento nella dimensione incorporea, dove s’incontra-no l’intelletto, l’anima, l’alter ego, con cui è possibile dialogare, correggere, convenire. È un nuovo metodo investigante che concilia le tendenze galileiane con lo spirito antiaristotelico, pur nell’aggancio formale di una retorica classicheggiante mantenuta piú nel-la forma che nella sostanza. Lo spazio dell’indagine trova, pertanto, un cammino che sposta l’analisi al di là del convenevole ludico, per addentrarsi nell’artico-lazione di una ricerca che utilizza i campi ideati dalla mente come chiave di lettura per entrare in contatto con il mondo spirituale dell’individuo, nell’accogli-mento del magistero di Campanella, tracciando linee e percorsi etici in stretto rapporto con i dettami della dottrina cristiana.
Dalla lettura del sonetto dedicato alla rivoluzione operata da Masaniello, non si nota una benché minima partecipazione al dramma esistenziale delle plebi, come invece sembra trasparire da qualche verso del Muscet-tola81, ma solo una sentita adesione al lutto che l’evento rivoluzionario genera (In sé stessa sconvolta è in sé divi-
81 Cfr. A muscettola, Rime, a mia cura, Alessandria, ed. Dell’or-so 20022, p. 29.
introduzione
66
sa,/ Partenope, non piú festosa e vaga,/ or tutta è duol, nel proprio sangue intrisa, vv. 9-11). Semmai una re-sponsabilità traspare, si assegna allo stesso Masaniello:
Marin guerriero anzi a i squamosi armentiguerra eccitò co i canapi ritorti,or di Marte costui rende i men forti,in riva al bel Tirren, seguaci ardenti;82.
Ancora piú chiaramente viene espressa la posizio-ne del poeta nei due sonetti successivi: All’istessa cit-tà di Napoli agitata dalle rivoluzioni. Paragone tra Venere, dea del gentilismo a Masaniello d’Amalfi83; S’invitano i poeti napoletani alle lodi del Signor Con-te d’Oñate per le cose da lui operate a favor della Co-rona di Spagna nelle rivoluzioni del Regno nel 1647 e 1648. Interessante nel primo componimento è l’acco-stamento tra Venere e Masaniello: proprio della poe-tica della meraviglia risulta l’avvicinamento di perso-naggi e situazioni lontane, per esprimere attraverso la rete analogica il giudizio sugli eventi accaduti.
Da le spume del mar Vener già nata in te pompe fastose un tempo ottenne; da le spume del mar colui sen vennech’ or muove in te sedizïon malnata.Quella, al popol di Gnido in pregio e grata,di culto indegno a i primi onor pervenne,questi, a gli applausi d’una plebe ingrata,da i tempi violar non si contenne.
82 Cfr. Masaniello d’Amalfi, il pescatore fatto capo della plebe se-diziosa nelle rivoluzioni di Napoli; sotto di 7 luglio 1647, son. IX. Il sonetto è riportato nell’antologia dei Marinisti, a cura di Giovanni Getto, torino, utet, 19622, p. 350. Per un profilo biografico sul capo-popolo napoletano, cfr. S. D’Alessio, Masaniello, con presentazione di Aurelio Musi, Salerno, Roma, 2007.
83 Il componimento è stato ripubblicato nell’antologia Marinisti, cit., p. 351.
introduzione
67
A franger legni, ad eccitar tempeste,dal mar crudele e l’una e l’altro apprese,a far le gioie altrui naufraghe e meste.
Gli erari e gli ori a divorar intese,nei palaggi e ne i cor fiamme funestel’una d’amor, l’altro di sdegno accese.
Si noti che l’esposizione del tema si gioca anche su una vicinanza lessicale, simile è l’emistichio dei vv. 1-3, replicato in chiave anaforica (Dalle spume del mar)84, e l’espressione in te (2° e 4° verso). Le ri-petizioni, unite alle variate alternanze rimiche delle quartine, originano una rete omofona edificata con cura sulla duplicazione di vari segmenti. L’effetto paronomasico genera, inoltre, un richiamo interno al testo, teso al citato accostamento degli elementi lon-tani, decontestualizzando l’evento storico con la tra-sposizione o quantomeno l’avvicinamento al mito. Il ricordo dell’ingannevole culto pagano (Di culto inde-gno ai primi onor pervenne) consente al poeta, infine, di definire ingrata la plebe e Masaniello colui che ap-prese a far le gioie altrui naufraghe e meste.
Centrato su una dominanza di endecasillabi a ma-iore, il testo presenta una simmetrica disposizione di varietà accentuativa, caratteristica che attraver-sa l’intera produzione poetica di de’ rossi. risultano, infatti, largamente adottate formule corrispondenti, disposte intorno all’asse centrale, mediante un’equa distribuzione laterale di vocali forti e deboli. L’impor-
84 L’intero verso riprende il mitico racconto della nascita di Ve-nere, riaffermato in G. B. marino, Adone, vii Allegoria, in Tutte le opere, a cura di G. Pozzi, Milano, Mondatori 1976, «Il nascimento di Venere, prodotta dalle spume del mare, vuol dire che la materia della genitura, come dice il filosofo, è spumosa e l’umore del coito è salso».
introduzione
68
tanza del metro evidenzia implicitamente pure le scel-te lessematiche adottate dall’autore, con uno stretto rapporto di significative corrispondenze. In questo di-scorso rientra anche la funzione ritmica che, pur non combaciando interamente con l’uso della parola, a essa si correla per la funzione intonazionale che assolve. Né va sottovalutato, in questo ambito, lo stretto rapporto esistente tra metro e ritmo, già diffusamente dibattuto nella Poetica di Aristotele e non estraneo alla discus-sione secentesca sui procedimenti retorici: «essendo dunque l’imitare conforme a natura e cosí pure l’armo-nia e il ritmo (è infatti manifesto che i metri sono parte dei ritmi), fin da principio quelli che erano a ciò nativa-mente piú disposti, progredendo a poco a poco, diedero origine alla poesia partendo da improvvisazioni»85.
Il sonetto successivo si mantiene distante dal rac-conto storico, pur nell’incontro di una serie di perso-naggi che scompaiono improvvisamente, lasciando sorpreso il lettore. Ne sono esempi i richiami a Gue-vara (Del gran Guevara a eternar gli onori)86, Virgilio (Cigno di Manto), enea e cosí via, disposti nel testo all’interno di un coordinamento incentrato sullo sci-volamento delle figure ritmiche poste a sostegno del-la verbalità. Il sistema delle variazioni tonali risulta estremamente organico anche quando ci s’imbatte in una mobile variante dell’ictus, l’armonia tassonomi-ca si mantiene, infatti, sempre all’interno di una ben distribuita economia del verso. Il discorso musicale vive, inoltre, nella partitura di un sistema costruito mediante la ripetizione di fonemi, correlati da una
85 aristotile, Dell’arte poetica, a cura di Carlo Gallavotti, Milano, Mondadori-Valla 1974, p 11.
86 Indico Ve’lez de Guevara, conte d’oñate.
introduzione
69
sonorità che rende compatta la versificazione. I temi risultano solo apparentemente agganciati alla realtà storica figurata dal poeta, i riferimenti a eventi e per-sone trovano, infatti, una propria collocazione nell’ar-ticolata metaforizzazione del linguaggio. Le strutture morfo-sintattiche si offrono, in ultima analisi, come mediazione tra i princípi conoscitivo-ideologici di ordine generale e la raffigurazione della particolare visionarietà dell’autore, che di per sé mantiene sem-pre il carattere dell’unicità. Diventa cosí visibile l’o-rientamento del pensiero, la singolarità dell’autore, la particolare sensibilità, la personale decifrazione di una realtà piú latamente complessa.All’interno di una diffusa pratica allegorica, diretta a sle-gare l’azione morale dai semplici dettami dell’esperienza per concatenarla in maniera diretta a princípi univer-sali, Antonio de’ rossi non si sottrae alla trattazione di temi largamente sfruttati dai lirici barocchi; lo testimo-nia il grido levato contro l’invidia che diventa il titolo di un sonetto. riuscite immagini accompagnano il testo:
Mostro inuman che, d’Acheronte uscito,col torvo sguardo infetti e avvelenie, d’odio sparso e da livor feritoper l’altrui ben, te stesso impiaghi e sveni,[…],anzi, a Cocito omai ritorna e fuggi,qui batti a vòto il formidabil dente,e te stesso mordendo, ivi ti struggi87.
La mariniana voce distemprar (Adone, XIX, 409, 1-4, «S’invido fato, avaro ciel mi toglie / distemprar gli oc-chi in lacrimoso mare, / di questa tomba le funeste soglie / non mi torrà con gemiti baciare») viene qui
87 Son. VIII.
introduzione
70
riutilizzata in maniera esemplare per sovvertire il falso scorrere sereno della vita (fra le mie gioie), ren-dendo visibile il furor che permette azioni temerarie. Il finale non apre, come si affermava poc’anzi, a nuovi dubbi e incertezze, ma si presenta come la chiusura di un cerchio in cui viene a trovarsi il naturale epilogo del tema affrontato. Alla caratterizzazione del tono risentito, l’autore contribuisce, con la disposizione nel verso di suoni stridenti e duri, a sottolineare l’asprez-za dell’argomento e al tempo stesso a raffigurare il suo stato d’animo.
È possibile notare, infatti, nella prima quartina, una massiccia disposizione di occlusive dentali sorde (t), raramente alternate con le sonore (d), sostenute da suoni sempre occlusivi della bilabiale sorda (p), sporadica la sonora (b), della costrittiva labiodentale sorda (f), della alveolare sorda (s) e sonora (r). L’ince-dere del verso trova, pertanto, nel sistema fonema-tico un corrispettivo al procedimento metronomico, cosí da offrire al verso un andamento rallentato che origina, nella ripetizione di fonemi duri o vibrati, un ritmo pausato, sintonico con le cadenze dell’endeca-sillabo piano. Da registrare, inoltre, l’agglutinamento di alcune parole intorno alle labiodentali sonore (v) e la diffusa presenza delle velari posteriori (o), ten-denti a dilatare e allungare il verso, favorendo il tono grave e sentenzioso. Che non ci sia dissimilazione tra la prima e l’ultima strofa viene poi confermato dalla strutturazione del sonetto. In essa notiamo, infatti, in attacco della terzina, la rima ito, posta alla fine del primo endecasillabo (uscito1 - Cocito2)
88, con cadenze
88 Ancora una volta l’immagine proposta si avvicina all’Adone del
introduzione
71
successive rallentate dalla diffusione di fonemi già vi-sti nella prima quartina.
L’equilibrio armonico della versificazione assume un carattere distintivo nell’associazione dei signi-ficanti, dei quali si è cercato di dare un esempio. I fonemi, posti in una correlazione ritmica, segnalano l’originale movimento impresso al verso, nato dall’i-spirazione e realizzata nell’opzione della parola. Cosí come le costituenti lessicali trisillabiche, che alterano talvolta l’andamento tassonomico, sono risolte nelle irrelazioni bisillabiche e nelle corrispondenze piane delle rime a esse speculari. La distribuzione delle immagini, infine, della parola e della melodia spin-gono l’autore verso la creazione di una poesia che si alimenta di motivazioni allegoriche, ampiamente dif-fuse nei testi, seguendo un percorso argomentativo, talvolta, interrotto da una serie di frasi intermedie, le quali, però, non segmentano l’unità testuale, almeno per ciò che concerne i piani del contenuto. Già Petrar-ca aveva orientato verso una compattezza della tra-ma, che in alcuni punti presentava un incedere qua-si prosastico, almeno se ci si riferisce alla dispositio delle figurazioni, correlate alle piú intime confessioni sentimentali.
Le strette attinenze tra forma e contenuto sem-brano avere in alcuni testi di de’ Rossi una propria visibilità, pur nel riutilizzo delle strutture versifica-torie tradizionali, con un saldo rapporto di senso tra il significato e l’impianto dei significanti, siano essi
Marino, cfr. Canto XII, ott. 5: «Qual ria megera o scelerato mostro / ti manda a noi da’ regni oscuri e tristi? / Vattene vanne a quell’orribil chiostro / onde rigore a’ tuoi veleni acquisti. / Non piú contaminar lo stato nostro, torna, torna, a Cocito onde partisti; / ch’aver dove ben s’ama in nobil petto / non può basso timor lungo ricetto».
introduzione
72
ritmici o fonici. Mi pare che tale fenomeno sia mag-giormente riprodotto negli anni in cui piú vivo e ac-ceso diventò il dibattito tra i restauratori della tradi-zione e gli innovatori legati al Marino, originando un particolare filone lirico che trova una sua peculiarità poetica nei caratteri di un’espansione del significato agli eventi ritmici e, piú in generale, stilistici. Anto-nio de’ rossi opera in questa direzione, utilizzando la catena verbale e i rapporti fonematici in maniera speculare alla simmetria modulare e al valore seman-tico, o almeno non mi pare occasionale il legame tra le componenti formali con alcune specificità tematiche. un gruppo di quattro sonetti è dedicato a eventi di tipo cronachistico89, tesi a documentare la peste del 1656, l’eruzione del Vesuvio del luglio del 166090, l’eclissi del due novembre e l’inondazione del Tevere, sempre nel novembre dello stesso anno, con presagi di inon-dazioni di fiumi e scarsi raccolti. Tutto all’interno di un esercizio letterario impegnato a documentare fatti che consentano al lettore di ricavare atteggiamenti e consolidare le credenze tipiche dell’epoca.
Sul drammatico evento della peste ricordiamo la testimonianza di Giannone nell’Istoria, in cui si ritie-
89 Sonetti XII-XIV. Il son. XIII reca il titolo Descrive l’inondazione del Tevere occorsa a’ 4 di novembre1661; da alcuni riscontri d’archi-vio, si è trovato segnalazione dell’accadimento, anche se una vera e propria inondazione si segnala nel 1660.
90 L’unico documento dell’epoca che testimonia l’avvenuta eruzione, oggi catalogato, fu redatto in due opuscoli dal gesuita p. suPo, Giornale dell’incendio del Vesuvio dell’anno MDCLX con le osservazioni mate-matiche. Al molto illustre e molto eccellente signor mio Padrone osser-vandissimo, il signor Don Giuseppe Carpano, dottore dell’una e l’altra legge e nella Sapienza di Roma primario professore, roma, Ignazio De Lazzari 1660. Continuazione dei successi del prossimo incendio del Ve-suvio, con gli effetti della cenere e pietre da quello vomitate, e con la dichiarazione ed espressione delle croci meravigliose, apparse in vari luoghi, dopo l’incendio, Napoli, G. Francesco paci, 1661.
introduzione
73
ne che l’epidemia sarebbe stata portata a Napoli da un vascello proveniente dalla Sardegna91. A Napoli, il 23 maggio, la Deputazione della Sanità, organismo crea-to per l’occasione, ordinò che i viandanti non potesse-ro entrare e uscire dalla città senza il bollettino di sa-lute della terra di partenza. La diffusione del morbo raggiunse velocemente anche la Basilicata - mentre risparmiò la Calabria e le terre d’Otranto - che vide assottigliare la sua popolazione da 200.000 abitanti a 150.000, con una particolare drammaticità nei mesi di settembre e ottobre, testimoniata dai libri parroc-chiali dei morti. Del tragico evento epidemico trovia-mo un’ampia cronaca dello storico ed economista di Moliterno Giacomo racioppi, il quale, riprendendo l’ipotesi di Giannone, specifica che il morbo ebbe la sua massima propagazione tra la primavera e l’esta-te, passando da una media di 150 decessi al giorno
91 Sull’evento, cfr., p. Giannone, Istoria civile del Regno di Napoli, Napoli, Niccolò Naso, 1723, t. IV, cap. XXXVII, cap. VII, pp. 395-400; sull’ipotesi d’importazione del virus, Giannone cosí scrive: «Da mol-to tempo che l’isola di Sardegna era travagliata di pestilenza e per ciò, non meno del Conte di Castrillo, che dagli altri Viceré suoi pre-decessori, s’eran pubblicati severi bandi, proibendo ogni commercio; ma capitato nel nostro porto un vascello proveniente da quell’isola carico di soldatesche o sia per trascuraggine de’ Guardiani del porto o perché invece delle patenti di Sardegna si fossero esibite quelle di Genova, ovvero, che per non trattener le soldatesche fosse cosí stato eseguito con particolar ordine del Vicerè, gli si diede pratica. Non tardò guari che ammalatosi uno de’ sbarcati, condotto nello spedale dell’Annunziata, in tre giorni se ne morí, apparendo nel suo corpo minute macchie livide; poco da poi un che serviva lo spedale, assalito da un capogiro, in ventiquattr’ore spirò e poco appresso spirò anche la madre. Attaccatosi il malore nelle vicine case, si vide in brevissi-mo tempo sparsa la contagione ne’ quartieri inferiori della città, e particolarmente nel Lavinaro, Mercato, porta Calce ed Armieri» (pp. 395-396). Tale ipotesi è stata giudicata attendibile da G. Galasso, in Napoli spagnola dopo Masaniello, Sansoni, Firenze 1982, vol. I, pp. 41-50, pur con qualche dubbio espresso sull’ipotesi di incubazione di quattro mesi del virus, essendo la peste cominciata a diffondersi nel mese di gennaio.
introduzione
74
nel mese di maggio a quella di 1000-1500 nel mese di giugno. Fu tale l’intensità che raggiunse nel periodo successivo da essere paragonata alla “peste nera” del XIV secolo. Né mancarono le voci, con le conseguenti cacce all’uomo, sui presunti “untori” che propagavano il morbo cospargendo di polveri venefiche i muri delle strade e le porte delle case92.
Le autorità potentine tardarono a prendere provve-dimenti utili per arrestare il diffondersi dell’epidemia. Solo quando la popolazione, impaurita e sconfortata, cominciò ad affidarsi sempre piú a riti religiosi, orga-nizzando processioni, novene e numerosissime messe, favorendo la diffusione del virus con l’aggregazione nello stesso luogo di centinaia di persone, fu emanato un “Bollettino di Sanità”. Si soppressero cani e gatti, furono apposti i sigilli ai fondachi di merciaria e tessu-ti, considerati ricettacolo di zecche, pulci e insetti rite-nuti responsabili di diffondere il contagio, furono isti-tuiti lazzaretti maschili e femminili, la situazione co-minciò a normalizzarsi nel febbraio del 1657. Due mesi prima, l’otto dicembre, a Napoli, era stata celebrata, con solenni feste in Santa Maria di Costantinopoli, la fine dell’epidemia, con una stima di quasi duecentoset-tantamila morti causati dal tragico evento93.
92 Cfr., G. racioPPi, Storia dei popoli della Lucania e della Basi-licata Ermanno Loescher & C., Roma 1889, vol. II, oggi in ristampa anastatica, Matera, Grafica BMG, 2 voll., 1970.
93 una tela del pittore Mattia preti - detto il Cavaliere calabrese, per la sua nascita a Taverna, un piccolo centro della Calabria, pro-mosso al rango di Cavaliere da Papa Urbano VIII – esposta a Napoli, presso il Museo di Capodimonte, racconta il drammatico avvenimen-to partenopeo. Il preti si trasferí a Napoli nel 1653 e, tra il 1657 e il 1659 affrescò le porte della città durante la peste (cfr., p. Giannone, Dell’Istoria civile…, t. IV, cap. XXXVII, p. 401). Al Museo di San Mar-tino, invece, troviamo un’altra famosa tela del pittore Carlo Coppola, Scena della peste del 1656, in cui si raffigurano cadaveri abbandonati,
introduzione
75
All’umiltà, come possibile grado di ascesa alla gloria del cielo, sono dedicati due sonetti (18-19), il cui inte-statario è Padre Ambrogio di Sorrento dell’Ordine dei Francescani94. ritorna il tono morale laddove si canta la virtú (son. n. 20) o ci si schiera contro i poeti lascivi (son. n. 21). Tipicamente barocco, nel riuso delle forme d’en-comio tradizionali, è invece il componimento dedicato al Duca d’Atri della famiglia Acquaviva (Con bell’ACQUA si diè, purgata e VIVA), con riferimenti alle Imprese dell’aquila, simbolo dell’Accademia degli Oziosi, di cui il Duca era principe, e al leone, simbolo della famiglia:
L’aquila, che di stelle a sé fa velo,se di pregio e di lume altrui non cede,quando sorge il leon, tramonta in cielo;
questa, ch’ al sol si specchia e qui presiede,del tuo regio leon tra i lampi e ’l zelopiú chiara splende e in te se stessa eccede95.
L’originalità di Antonio de’ rossi è da ascrivere nella testimonianza di una poesia che concilia con-cetti e parole per riuscire ad ammaestrare. Senza tra-lasciare l’esperienza poetica in sé, va sottolineato il contributo dell’autore allo sviluppo del nuovo ideale poetico e di quella che Getto lucidamente ha defini-
ammucchiati, preti, cavalieri: la scena di una disperazione assoluta.94 Si ordinano i restanti dedicatari delle rime. religiosi: Don Luca
Tartaglione, teologo; Don Michele Maielli, dottore in legge; Padre Se-rafino de’ Rossi, suo fratello; Don Nicolò Ridolfi, Generale dei Padri Predicatori; Don Vincenzo Caraffa, Generale dei Padri Predicatori della Compagnia di Gesú; Monsignor Ventriglia, vescovo di Caserta. Nobili e studiosi: Don Giovanni de Vargas, figlio del Duca di Cagna-no; Girolamo Follieri, famoso matematico; Paolo di Cordova, medico; don Diego de Vargas, primogenito del Duca di Cagnano; Diana Carac-ciolo, marchesa di Brienza; Don Vincenzo Boenzi.
95 Son. XXIII, vv. 9-14.
introduzione
76
to «storia della poesia»96. La maestosità del progetto non sempre si realizza nell’austerità della versifica-zione, anche se si esprimono in maniera compiuta sia il livello verbale e sia quello melodico, ma nell’inge-gnosità degli accostamenti, nella severità degli inse-gnamenti, nello spostamento delle immagini che, pur colpendo l’intelletto, riempiono di forti passioni l’ani-mo. I colori restano cosí in secondo piano, un po’ sbia-diti rispetto alle forti tonalità interiori, alle intense connotazioni dell’eloquenza, direttamente impegnate nella formazione delle coscienze. tutto si giuoca sul coinvolgimento della ragione: ridotte si presentano le stravaganze barocche. La poesia e la tecnica della meraviglia sono utilizzate come elementi di supporto al metodo razionalistico, per arrivare al lettore attra-verso il ragionamento, gli esempi, cosí da educarlo97. Siamo di fronte a un equilibrio già sperimentato, ma che presenta un rinnovato utilizzo dell’arte poetica, rivolto all’impegno morale e civile, indugiando talvol-ta sull’erudizione storica, con sprazzi che anticipano talune tendenze settecentesche. L’impostazione, il piú delle volte, si articola su formule apodittiche, con premesse inequivocabili, fondate su princípi inamovi-
96 G. Getto, Barocco in prosa e in poesia, rizzoli, Milano 1969, p. 22.
97 Nel contesto del discorso non va trascurata l’opera del gesuita B. Gracián, Agudeza y arte del ingenio, Huesca, Nognes, 1648, trad. it. di G. PoGGi, L’acutezza e l’arte dell’ingegno, palermo, Aesthetica, 1986, nella quale si teorizza una poesia caratterizzata dalla velocità e dalla profondità semantica delle parole. Nella prima edizione, pubblicata nel 1642 (Arte de ingenio - Tratato de la agudeza), sottolinea la differenza tra dialettica e retorica, affermando che la prima mira alla connessione dei termini, per formare un sillogismo, mentre la retorica compone le proprie figure con l’ornato delle parole. Cfr. r. Assunto, La città di Anfione e la città di Prometeo, Milano, Jaca Book, 1997, p. 140. Vd., inoltre, P. GuaraGnella, Gli occhi della mente: stili nel Seicento italiano, Bari, Palomar, 1997.
introduzione
77
bili; il conseguente assenso razionale non trascende dall’intento di creare un consenso emotivo nel lettore, con spinte deliberative, cosí come intendeva Aristote-le. Sulla scorta degli insegnamenti del filosofo di Sta-gira, il poeta utilizza l’inventio per sostenere le argo-mentazioni, mediante riferimenti recuperati da con-testi extra-retorici, tanto che potrebbe definirsi una scoperta, piuttosto che un’invenzione98. Il discorso si basa, quindi, su un ragionamento solido e convincen-te, di qui la capacità dei collegamenti arguti, talvolta dei salti pindarici, dei riferimenti mitici o storici. L’in-tersecazione con il metodo induttivo giustifica la reto-rica degli esempi, siano essi documentabili o inventa-ti, con la relativa corrispondenza dell’entimema99. La dispositio dei temi, infine, segue spesso una sorta di ordine nestoriano, secondo il quale gli argomenti che piú colpiscono il lettore vengono disposti all’inizio e alla fine del compimento, con una digressio centrale; né viene trascurato il semplice ordine crescente degli argomenti, cosí da porre nella conclusione la sezione del messaggio che l’autore intende lasciare nel let-tore. Nella brevità del verso si consolidano, quindi, le tendenze a condensare in una sola enunciazione l’inventio e la dispositio, cosí com’era già in uso nelle predicazioni del Cinquecento, talvolta espresse nella titolazione o in apertura del componimento, in modo
98 Sull’argomento, cfr., r. Barthes, 1972, La retorica antica, Bom-piani, Milano (tit. orig. L’ancienne rhétorique, 1970), traduzione dal francese a cura di Paolo Fabbri, Milano, Bompiani, 1993.
99 La differenza fra sillogismo ed entimema nel procedimento ari-stotelico consiste, sostanzialmente, nel fatto che il sillogismo dialet-tico è uno strumento della dialettica e ha come fine la dimostrazione. L’entimema, invece, è uno strumento retorico che tende a persuadere anche chi non possiede un bagaglio culturale tale da consentirgli la comprensione di dissertazioni difficili.
introduzione
78
da far ruotare intorno a una lapidaria espressione, successivamente amplificata, ‘l’unità dell’azione’, con il risultato di rendere unito il testo.
Il particolare riguardo che il poeta infonde nella fusio-ne dei suoni con le immagini, attraverso la distillazione delle parole, concorre alla genesi di una poesia protesa a dialogare con istanze superiori, siano esse identificabili con i valori dell’humanitas che con il Dio padre che ac-coglie anche i propri figli piú sventurati. Una sacralità diffusa si scioglie, quindi, nel resoconto della perdita di quei valori che hanno accompagnato in positivo la storia dell’umanità, unita all’intimazione di non recedere dal-la naturale propensione verso il divino. In questo anda-mento verticale, de’ rossi trasla la visionaria esempla-rità dell’esistenza dell’unicum poetico alla piú generale meditazione offerta ai lettori-ascoltatori.
testimonianza sicuramente minore quella di An-tonio de’ Rossi, nella cui opera, però, sono presenti al-cuni aspetti importanti della produzione meridionale, che - nel secondo Seicento - vedono Napoli, all’interno di una codificazione poetica piú generale, conciliare le innovazioni del Marino con la tradizione rinascimen-tale e, nel nostro caso piú specifico, con la teorizza-zione spirituale. Il tentativo sarà quello di misurarsi - mediante anche alcuni precorrimenti arcadici - con una funzione del poeta che cerca, attraverso la rifles-sione sulla condizione umana, di trovare risposte eti-che e di vaticinio alle spinose problematiche esisten-ziali, basandosi su un ampliamento autonomo e coeso degli sviluppi poetici.
79
A tutt’oggi, le mie ricerche d’archivio sulla vita e sulle vicende intellettuali di Antonio de’ rossi hanno avuto risultati piuttosto scarsi. Il ritratto delineato si presenta, pertanto, lacunoso e le poche notizie otte-nute sono ricavabili per lo piú dalla lettura delle sue opere. Si è cercato di porre rimedio a tali lacune ten-tando di ricostruire un quadro d’insieme che potesse dar conto del dibattito intellettuale che direttamente o indirettamente influenzò la sua opera. Ebbe la sua formazione a Napoli; fu sicuro membro dell’Accade-mia degli oziosi e, tra gli anni Cinquanta-Sessanta, entrò a far parte delle Missioni Apostoliche della Con-gregazione di propaganda della Fede di Napoli.
nota BioGraFica
80
nota al testo
1. Il volumetto Sonetti del Signor Don Antonio de’ Rossi, in Napoli, per gli Eredi di Roberto Mollo, 1661, è conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napo-li, coll. 113. A. 241; la legatura in carta pergamenata è posteriore. Il libro è composto di quarantotto fogli (mm. 145x95) a cui vanno aggiunti due fogli di guar-dia; non c’è alcuna numerazione, ma su ogni foglio è presente la parola di richiamo. Sulla prima pagina, che contiene la dedica ad Alberto de’ Rossi, troviamo impresso un festone di foglie e fiori di mm. 85, nel quale si riprendono alcuni motivi già presenti nel fe-stoncino del frontespizio (mm. 20) e riutilizzati come elemento separatore tra il titolo di ogni singolo com-ponimento, i versi e le diverse strofe (mm. 10). La let-tera capitale è racchiusa in un quadrato all’interno del quale, insieme ai fiori, è visibile la figura di un angelo. Alla fine della stampa, sul recto dell’ultimo foglio, si legge la seguente dedica del prefatore:
Ad autorem.Surripui, Antoni, flores, tua Thespis amoenos
legerat aonijs quos operosa IugisSurripui, et praelo exposui; quo succus ab istis
1 un altro esemplare identico nella stampa si trova all’interno di una raccolta miscellanea dell’opera di de’ Rossi, sempre presso la Biblio-teca Nazionale di Napoli (coll. 113. B 36. 7). Il volume risulta mancante della dedica finale del prefatore all’autore e presenta delle correzioni, con penna a inchiostro (probabilmente del secolo scorso, generata da un’errata interpretazione dei versi), su alcune parole dei testi che tal-volta ne compromettono il senso e la leggibilità. Dalle ricerche effettua-te, non sono stati trovati esemplari in altre biblioteche italiane.
81
Melleus expressa conditione fluat.Ambrosiam reddo Fratri; floresque probabunt,
quam liquor ex ipsis fructibus almus erit.Devotionis ergo. Don Ioseph Domenichi.
Finis2
2. Criteri di edizione. Nella trascrizione dei testi ho limitato gl’interventi alle seguenti modifiche:a) distinzione secondo l’uso moderno di u e v;b) sostituzione di et e della nota tironiana & con e;
con ed davanti a parola iniziante per e-;c) abolizione di tutte le h etimologiche e paretimo-
logiche; normalizzazione di all’hor in allor;d) uniformazione di -ij in ii;e) normalizzazione della grafia latineggiante del
gruppo ti+vocale in zi+vocale; f) ammodernamento degli sporadici digrammi eti-
mologici ph e th rispettivamente in f e t;g) assimilazione del prefisso latino ab + consonan-
te (absorti);h) normalizzazione di se’n (se ne) in sen.i) adeguamento all’uso moderno del plurale in -gia
(piagge);l) conservazione della maiuscola secondo il moder-
no uso grafico e nelle personificazioni;m) scioglimento del segno tachigrafico;n) mantenimento della i in gielo, messagier, per la
2 Ho sottratto, Antonio, i fiori, dopo che Tespi quelli amabili / ave-va còlto, i quali con dedizione alle vette aonie / ho sottratto, e ho posto sotto il torchio; / affinché il succo da questi /scorra mielato in una cre-azione ben delineata. / Offro ambrosia al Fratello e i fiori mostreran-no / quanto sarà nutriente il liquido da questi frutti. per devozione. Don Giuseppe Domenichi. Fine.
Sonetti
82
rispondenza fonica che essa origina; o) uniformazione dell’unica presenza del nome
Giesú, in Gesú (titolo son. XXXIV);p) conservazione delle forme analitiche nelle pre-
posizioni articolate (a i, co’ il) e negli avverbi (in vano, in tanto qua giú);
q) scioglimento delle abbreviazioni: M. = Molto, P. = Padre, R. = Reverendo, S. = Signore, G. B. = Giovan Battista, Div.mo = Divotissimo, Serv. = Servitore, Osser. = Osservante, D. = Donna, seg.= seguente, etc.
- Nel registro delle doppie e delle scempie sono sta-te conservate le oscillazioni tra scempie e geminate imputabili alla concorrenza di forme diverse, anche piú o meno culte, o a incertezza nell’adozione del raf-forzamento nell’univerbazione o ancora a oscillazioni comuni nell’uso del tempo.- Nella punteggiatura si è cercato, con opportuni in-terventi aggiuntivi, soppressivi e di modifica relativi all’uso di oggi, di raggiungere una soluzione di equi-librio fra il doveroso rispetto dell’interpunzione origi-nale e le esigenze di una lettura moderna. - Si è usato il segno dell’apocope e l’accento per distin-guere omografi e indicare i seguenti fenomeni:1) con il primo si è indicato l’aferesi (’ve, ’state), il troncamento di aggettivi, verbi, preposizioni articola-te, sostantivi e della preposizione ver’;2) con il secondo si è distinto: vòto (vuoto) da vóto (voto), vòlto (verbo) da vólto (sost.), se (cong.) da sé (pron.), ne (pron.) da né (cong.) etc.; si è utilizzato inoltre nelle forme verbali tòr, invídi, etc. Altresí, si è disaccentato qualche monosillabo per il quale il mo-
antonio de’ roSSi
83
derno uso grafico non richiede l’accento (su), etc.- Le parentesi aguzze indicano rarissime integrazio-ni, mentre le parentesi tonde sono state usate dall’au-tore. - Ogni singolo componimento è preceduto da una bre-ve nota metrico-stilistica e da una sintesi contenu-tistica. Si riportano, inoltre, cenni sulla vita e sulle opere del personaggio cui è dedicato il componimento e approfondimenti sugli eventi citati, quando le ricer-che effettuate ne hanno consentito il reperimento.
Le correzioni sono state documentate nell’appara-to negativo a piè del testo.Le cifre arabe che segnano i componimenti nella stampa seicentesca sono state sostituite dai numeri romani.
85
Molto Reverendo Padre e mio Signore Osservante,L’osservanza ch’io professo al Signor Don Antonio de’ rossi, dignissimo fratello di Vostro padre Molto reverendo, mi ha persuaso a mandare alle stampe questi pochi suoi sonetti, che in vari tempi e occasio-ni mi son pervenuti in mano. So che l’autore, essen-dosi dato a vita religiosa e ritirata, si risentirà meco gravemente, perché io gli abbia publicati senza sua saputa e ritrovandosi egli assente da questa città. Ma resto anche persuaso che, appreso la modestia di lui, verrò scusato da’ virtuosi amatori delle belle lettere, perciò che io, in grazia loro, abbia commesso questo fallo, quantunque non lo stimi tale, mentre in ciò non ebbi altro fine se non ch’egli non lasci peri-re le sue fatiche e non resti defraudato di quelle lodi che sono all’istesse meritamente dovute. e di qui egli risolva di dare alle stampe il suo moral poema, in-titulato: l’Imagine della vita umana, opera, s’io non mi inganno, degnissima della luce del mondo. Spero anche di venirne discolpato appresso l’istesso da Vo-stro padre Molto reverendo, al cui nome e protezione sono stati da me ragionevolmente dedicati, affinché ne’ parti d’un suo fratello ella si riconosca, a parte di quel merito che, in età giovanile, l’ha sollevata a reggere cotesto convento cosí nobile e cosí numeroso.
86
Carica veramente di somma onorevolezza, ma corri-spondente al talento riguardevole che la divina bontà ha riposto in lei. Stimo parimente di avere in ciò fatto cosa grata a’ Signori Academici oziosi, mentre ravvi-saranno in questi pochi, sí, ma eruditi, componimenti i lumi di quell’ingegno, ch’è nobil membro dell’istesso loro illustrissimo corpo. Ho poi disposti questi sonetti secondo la materia che trattano: e quelli che furono dall’autore indirizzati a diversi suoi amici sono stati posti da me per ordine di alfabeto, secondo le prime lettere de’ loro nomi, e ciò a fine di sfuggire lo scoglio delle precedenze. priego, intanto, dal Cielo a Vostro padre Molto reverendo, ogni maggior esaltazione e le bacio riverentemente le mani.
Napoli, primo settembre 1661.
Di Vostro padre Molto reverendo,Divotissimo Servitore
don GiosePPo domenichi
antonio de’ roSSi
87
i
Sonetto di schema variato nella fronte: aBaBBaaB cdcdcd, con una sola attestazione in petrarca (RVF, ccX; con variatio a rime alternate nella 1a quartina e incrociate, ma invertite, nella 2a quartina anche il son. ccXcv). Rime ricche ai vv. 1:3:6; derivativa ai vv. 9:11. Le complesse componenti fonico-vocaliche, ordite con riprese interne (in -or7, anche in 1a versale ai vv. 5:7:10:11:13), declinano il metro, rimarcando l’unicum melodico, dominato dalle scelte nominali bisillabiche so-prattutto in sede centrale. Alla calibratura ritmica con-tribuiscono anche le diffuse distribuzioni dittologiche o congiuntive poste alla fine del verso e sostenute da cel-lule trisillabiche.
La speranza (o promessa) di una nuova vita, segna-ta dal pentimento per la cecità del passato, caratterizza il tema del componimento. Le scelte lessematiche, pur nella ripresa di fonti e formule tradizionali, determina-no nuovi accostamenti nella variazione dei significati. L’invocazione verbale, posta in attacco delle terzine, genera uno stacco deciso dal rimpianto espresso nella prima quartina e dalla constatazione del rinnovamento spirituale già in atto nella seconda. Il carattere mistico della narrazione si attua visivamente nella scelta di ter-mini che si spostano sempre di piú verso una dimensio-ne incorporea. Lo scenario biblico rappresentato dall’in-tromissione del fuoco divino, ad esempio, viene richia-mato dal sostantivo ardor, dalla voce verbale infiammi, anticipati dal plurale raggi e dagli aggettivi: celeste e puro, fido e santo, in antitesi all’incendio impuro e al cor algente e duro.
Sonetti
88
Illustrato dalla divina grazia,si ritira dagli amori profani
Se tra lacci funesti il piede avvoltotrassi i verdi anni in libertà captivo, e fiso a i lampi d’un volubil vóltovissi al tuo nume e a me stesso a schivo,
or che in me volgi il guardo eterno e divo,anch’io, padre del ciel, ver’ te rivolto,il cor, pur dianzi in cieco error sepolto,sottraggo a morte e nel tuo spirto avvivo. piova da’ raggi tuoi celeste e puroardor, ché il sen m’infiammi e spegna, in tanto doglioso umor, quel primo incendio impuro,
e dritto è ben, ché s’al tuo fido e santo lume il cor fu gran tempo algente e duro, si stempri omai per i tristi occhi in pianto!
2. trassi: trascorsi; captivo: prigioniero (latinismo).3. lampi: occhi; volubil vólto: fortuna.4. a me stesso a schivo: cfr. L. Alamanni, Rime, [Parte], VII, vv. 4-5:
Si noti come il carattere soggettivo del componimento sia rimarcato dalla forma pronominale ripetuta anche nel verso successivo.
6. ver’: verso.9-10. per similitudine, cfr. F. Petrarca, RVF, CLIV, vv. 8-9: «par
ch’ Amore et dolcezza et gratia piova. / L’aere percosso da’ lor dolci rai / s’infiamma d’onestate»; ché: affinché.
13: algente e duro: ghiacciato e indurito.14. Cfr. D. aliGhieri, Vita nova, 23, v. 11: «le lagrime dogliose agli
occhi tristi».
antonio de’ roSSi
89
ii
Sonetto di schema invertito nella fronte aBaBBaBa cdcdcd, attestato solo due volte in petrarca (RVF, cclXXiX e cclX). L’inversione rimica nelle prime due strofe genera una sorta di chiave nella rima baciata tra prima e seconda quartina. Allitterazioni sparse antici-pano la parola-rima di A (vv. 1:3), consuona e assuona la prima versale di B (v. 2), con forte omofonia della parola in rima di B con D (v. 10) e in radice di A (v. 3) con C. Il suono consonantico ripetuto, in chiave anaforica, ai vv. 7-8, anticipato in 6a nel v. 6, chiude le quartine domina-te dall’alternanza della e, sia in posizione palatale che velare, ampiamente riproposta anche in sede postonica nel verso finale. Va aggiunto, inoltre, che la sibilante è già introdotta all’inizio del componimento (S’apre), la cui sonorità sorda viene prolungata nei foni successi-vi, accompagnata dalla presenza della semivocalica i e replicata nei dittonghi consecutivi. Il suono della pala-tale (i) dominerà anche l’endecasillabo seguente (v. 2), scandendone il ritmo, unitamente alle occlusive dentali sorde (t) e sonore (d) convergenti nel riflesso del doppio ossimoro (v. 3). I lessemi mono (sé) e bisillabici - ben distribuiti nelle formule accentuative e nelle cesure di emistichio (pensier4, immortal7) - determinano una coin-cidenza tra l’equilibrio melodico del verso e i contenuti racchiusi nei segmenti frasali, utili alla resa dell’unità metrica e del messaggio in essa nascosto.
Il componimento registra la sofferenza generata dal-la passione insana, testimoniata dalla rima -ore in A, chiusa semanticamente dal sostantivo orrore. Ben sal-da si presenta la struttura bilaterale del prosodema, le cui implicazioni soprasegmentali rendono armonica la scansione ritmica. La coesione sintagmatica è resa da
Sonetti
90
una serie di agglutinazioni binarie (sost.+agg.), distri-buite talvolta in costrutti anche chiastici (v. 3), pur nel sostanziale andamento narrativo del testo. La chiusa (menzogne insane), anticipata da una serie di aggettiva-zioni sinonimiche (empio, ingannatrici, vane, bugiardo), concretizza, infine, il connubio già esplicitato nella tito-lazione.
antonio de’ roSSi
91
Effetti dell’amor lascivo
S’apre ne’ petti altrui per man d’Amoredi duol, di pianto inessiccabil venae in ghiaccio ardente, anzi in gelato ardore,stringe i dubbi pensier’ ferrea catena;
mentre fugge empio tosco, e s’avvelena,vere dolcezze a sé promette il core,se la mente immortal nacque serena,sé stessa involve entro a penoso orrore.
Fatto de’ proprii scempi avido il guardo,a larve intende ingannatrici e vane,’l vago ammira d’un color bugiardo.
Fra gli incendii il desío cieco rimane,reso a i lumi celesti ottuso e tardo,d’ombre ei si pasce e di menzogne insane.
1. L’incipit, per similitudine, può ricondursi all’immagine di G. B. marino, Adone, XI, 53, v. 7: «e so che col pugnal non s’apre il petto», che a sua volta rimanda al piú vicino incipit di t. tasso, Gerusalem-me conquistata, XIV, 102, v. 1: «S’apre lo scudo al frassino pungente».
2-3. di duol… ardente: cfr. G. Preti, Poesie, Nuovo amore. Rispo-sta al Sig. Dottor Francesco Ellio, v. 4, «per far un cor, ch’era di ghiac-cio, ardente»; vd. anche lo sviluppo oppositivo in G. B. marino, Adone XIX, 414, v. 4: «secca la vena de’ miei pianti amari?». per gelato ardo-re, inoltre, cfr. B. rota, Rime, XXXVI, 5, «d’ardente tema e di gelato ardore», pur nello stereotipato petrarchismo rimico amore-ardore.
4. Interessante l’inversione prospettica rispetto a G. B. marino, Adone, XVI, 266, vv. 5-6: «bastò ch’avesse al piè ferrea catena / s’aver non valse aurea corona in testa».
5. L’attacco è vicino, nella costruzione dell’immagine, a quello di t. tasso, Rime d’amore, 55, v. 6: «mentre fugge costei per vie di-storte!», cosí già nel padre Bernardo, Inni et ode, VI, A Pan, 6, v. 2: «Mentre fugge, s’affanna». Cfr., inoltre, G. B. Marino, Adone, Xii, Argomento, vv. 3-4: «e, mentre col suo tosco infuria Marte, / Adon sen fugge e trova alta ventura»; tosco: tormento, veleno.
7. mente immortal: anima.9-10. Interessante la similitudine, anche se ancora in chiave ri-
baltata, con G. B. marino, Adone, VII, 167, vv. 7-8: «e con guardo a nutrir cupido e fiso / men la bocca che gli occhi avido intende»; a
Sonetti
92
larve intende: ai falsi ideali volge l’attenzione, cfr. Petrarca, RVF, LXXXIX, vv. 7-8: «quel traditor in sí mentite larve / che piú saggio di me ingannato avrebbe.
13. tardo: stolto. L’occhio «ottuso e tardo», in l. de’ medici, Canz., cXXiii, v. 6, esprime la condizione negativa dell’esistenza. Né va escluso il riferimento a sé stesso di petrarca, A Francesco Bruni, in Epistole senili, I, 6: «Da ultimo quantunque io mi sia tardo d’ingegno, di giudizio ottuso, rozzo di eloquio ed in ogni dottrina incerto e dub-bioso».
14. di menzogne insane: per la collocazione del sintagma in sede finale del verso, cfr. G. B. Marino, Adone, IV, 132, v. 1: «Deh! che ti par de le menzogne insane».
antonio de’ roSSi
93
iii
Sonetto di schema variato nella fronte aBaBaBBa cdcdcd. Rima ricca ai vv. 3:5, derivativa ai vv. 4:6; A assona con D. L’evento rimico del v. 10 è ampiamente anticipato da molteplici foníe interne; cosí come nel v. 8 la parola in rima viene preparata da una serie di allitte-razioni che scandiscono, in una gradazione ascendente, l’incedere ritmico. pur distanziate nello spazio dell’uni-tà fraseologica, si rincorrono una serie di sequenze col-locabili in ambito rimico (Giunon2 - Aquilon5; al7 - vital29; Amor12- or13), talvolta poste anche in attacco del verso (ridea6 - parea8, anticipate da tingea4). Le connotazioni acustiche sostengono gli accenti dell’endecasillabo, cosí da rendere la cadenza accresciuta o diminuita a seconda del rilievo cui il poeta destina alcuni termini. La combi-nazione semantica è frammentata da inclusioni paren-tetiche, in modo da mantenere il verso incentrato sulle battute frastiche, tipico artificio barocco, lasciando che il pensiero si agglutini intorno a sintagmi lontani, in una sorta di puzzle accuratamente definito.
L’intero universo si prepara alla festa della nascita di Maria, la cui castità è sottolineata da formule con-trastive (impura-pura); la rivelazione della duplice sua natura vive invece nell’opposizione terra-cielo. Il proce-dimento binario sostiene l’intero componimento, in par-ticolare nelle coppie aggettivali, insieme anche alle com-binazioni sost.+agg. L’elemento contemplativo emerge nella 2a terzina, ponendo in particolare rilievo espres-sivo la componente divina (primo Amor), già sottesa nei versi precedenti e preparatoria alla climax finale.
Sonetti
94
Nella nascita della Beatissima Vergine Madre di Dio
Sovra il Carro di stelle, il puro senosolcava di Giunon la notte oscura,né de’ lumi dorati il bel serenoombra tingea di fosca larva impura;
Teti (a’ fieri Aquilon’ già posto il freno)ridea, vie piú che mai tranquilla e pura,e ’l ciel, nuov’Argo al parto di natura,parea d’occhiute pompe ornato e pieno.
Quando a l’aura vital diva novellasorse e, racchiusa entro a corporeo velo,(eletta in madre) offriasi al verbo ancella,
qui, sparso il primo Amor d’eterno zelo,disse: «Or, che splende in lei luce sí bella,non ha la terra onde piú invídii il cielo».
1. Carro di stelle: il Grande Carro, la costellazione dell’orsa Mag-giore; puro seno: si ricorda che il mito attribuisce alla caduta di una goccia di latte dal seno di Giunone la genesi della nascita del giglio, divenuto nella cristianità il simbolo della purezza verginale di Maria. Per l’occorrenza alla fine del verso del sintagma il puro seno, cfr. B. tasso, Rime, LVII, A l’aure, v. 5; LXX, v. 12; CVI, Egloga quarta. Galatea, v. 88.
3. lumi dorati: stelle.2. per la posizione in rima del sintagma la notte oscura e per si-
militudine di alcune immagini, cfr. F. Petrarca, RVF, cclXv, v. 6.5-7. Teti…: avendo la moglie di oceano fermati i venti del nord
(Aquilon’), contribuisce a preparare la natura ad accogliere degna-mente il lieto evento; vie: ancora, particella avverbiale con valore raf-forzativo davanti a comparativo; Argo: costellazione australe.
8. occhiute pompe: scintillanti stelle.9. a l’aura vital: alla vita.10. corporeo velo: corpo umano. per l’occorrenza corporeo velo,
riferito alla Vergine, cfr. B. Gareth, La Pascha di Chariteo, V, vv. 73-74: «Et sovra i chori angelichi exaltata. / Conforme al figlio, nel corporeo velo»; cfr. anche L. ariosto, Orl. Fur., LXII, 14, vv. 6-8: «L’al-ma… / disciolta dal corporeo velo/ fra dolce melodia salí nel cielo», con riferimento a petrarca, rime, CCLXIV, 114.
antonio de’ roSSi
95
iv
Sonetto di schema aBBaaBBa cdcdcd, assona C con D. Rima, ricca ai vv. 2:3:7, 5:8, 12:14, anche deriva-tiva ai vv. 3:7, 1:4. Si duplica in C la rima in A del sonet-to precedente (freno), nella renovatio di una complessa contiguità tematica. Le combinazioni di rime interne in 2a versale - apprestar1-ristorar8, consuonate al v. 13 (Imperator), con vicinanze omofone nei gruppi al (ripe-tute nei vv. 10-12), -el (vv. 13-14), con ripresa nei prono-mi questi5, quegli9 - contribuiscono a rendere compatto il procedimento retorico, segnato dalla voce verbale al passato dell’incipit, replicata nella medesima accenta-zione ai vv. 7:10. Si apprezzino i perfetti bilanciamenti degli emistichi, con congiunzioni centrali alternate nei tipi aggettivali e nominali; gli elementi verbali invece, privilegiati in sede accentuativa, distanziano talvolta le due fasce laterali dalle battute mediane.
Il tema del sonetto si sviluppa intorno al paragone tra Giuseppe, figlio di Rachele e Giacobbe, e San Giu-seppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesú. Artico-lato sul rimando dei pronomi questi-quegli, il confronto richiama gli eventi della vita dei due protagonisti che li hanno portati alla gloria eterna.
Sonetti
96
San Giuseppe, sposo della Beata Vergine, rassomigliato all’antico Patriarca Giuseppe
Stupí l’egitto, ove apprestar si videcontro a l’orrida fame esca vitaledi cibo eletto: in quel digiun mortalele turbe afflitte il saggio ebreo provide.
E questi, a cui fan pompa illustri e fidevirtú, che pari ha ’l nome e ’l merto eguale,co ’l pan ch’ei custodí, sacro, immortale,vien, che mille alme ristorar confide.
Quegli da carcer tetro assunto al regno,non superbí questi s’alzò, non meno per umiltà, d’eccelse glorie al segno,
ma l’un sostenne al fin scettro terreno,l’altro a quel Grande d’imperar fu degno che del mondo e del ciel contempra il freno.
1-14. Giuseppe, secondo la Bibbia, è il figlio prediletto di suo pa-dre Giacobbe. La preferenza del padre alimenta la gelosia dei suoi fratellastri, i quali decidono di venderlo come schiavo a una carovana di mercanti israeliti per venti monete d’argento. Condotto in egitto, è rivenduto come schiavo a potifar, un ufficiale del faraone. per aver rifiutato il corteggiamento della moglie dell’ufficiale, viene accusato ingiustamente dalla donna e rinchiuso in prigione (cfr. Genesi 39,1-20). uscito di prigione interpreta i sogni premonitori del faraone: il primo delle sette vacche grasse e delle sette vacche magre e il secondo delle sette spighe piene e delle sette spighe vuote. Giuseppe predice un tempo di abbondanti raccolti (sette vacche grasse e sette spighe piene) e sette anni di carestia. propone di fare delle scorte negli anni di abbondanza, da utilizzare in quelli di carestia (vv. 1-4). Il faraone convinto dalla proposta di Giuseppe lo mette a capo del paese (cfr. Genesi 41,1-40). Allo stesso modo, Giuseppe, sposo di Maria, seppe conquistarsi, con il suo comportamento e la sua fede, la gloria divina.
2. esca vitale: nutrimento dell’uomo. per la posizione in rima, cfr. G. Fontanella, Ode, I, Alla luce, v. 21, «Allegrezza de l’alme, esca vi-tale»; L. lePoreo, Leporeambi, C, v. 5, «Dispenso al mondo immenso esca vitale».
antonio de’ roSSi
97
v
Sonetto di raro schema invertito nella fronte aBaB-BaBa cdcdcd1. Rime ricche ai vv. 4:7, 9:13. Come già in precedenza, le rime alternate nella II quartina generano una sorta di verso chiave tra la prima e la se-conda quartina. Si riprende in B la rima C del sonetto precedente; rimandi rimici interni in -er e in -ar sono visibili ai vv. 1:4, 2:7, replicati in prima versale ai vv. 10:13 e sostenuti dalle forme apocopate ai vv. 6:8 (in -on). Diffuse consonanze scandiscono, infine, il ritmo dei diversi emistichi. La scansione binaria del verso domina il piano retorico-formale del sonetto, si veda la coppia agg.+sost. a partire dal v. 1, esaltata nel v. 8 con la sola intromisssione dell’articolo. Nel v. 9 notiamo l’interes-sante dispositio a raggiera invertita in 2a versale, con l’aggettivo centrale e i due sostantivi laterali, riproposta nel verso successivo, questa volta a raggiera piena, con i due aggettivi intorno a un unico sostantivo.
Il componimento è dedicato alla figura di Domenico di Guzmán (Caleruega, 1170 ca. - Bologna, 6 agosto 1221), fondatore dell’ordine dei Frati predicatori. Domenico fin dalla giovinezza si caratterizzò per la vicinanza alla sofferenza altrui; durante una carestia, probabilmente intorno al 1191, si racconta che vendette quanto in suo possesso, incluse le sue pergamene, per dare da man-giare ai poveri. Basò la sua opera sulla predicazione e sull’esempio, cercando di convertire gli eretici con pub-blici dibattiti, con la preghiera e la penitenza.
L’iconografia che riporta una stella sulla fronte di San Domenico, richiamata nel titolo, si riferisce all’e-vento miracoloso testimoniato dalla nutrice che, duran-te il rito battesimale, vide formarsi una stella sulla fron-te del neonato. Su tale evento l’autore distribuisce nel testo una serie di argute immagini.
1 per l’attestazione in petrarca, cfr. l’introduzione al sonetto II.
Sonetti
98
al Patriarca san domenico. Si allude alla stella che fu veduta nel fronte di lui quando
era fanciullo e alle eresie che in quel tempo infestavano Santa Chiesa, ripresse poi con la dottrina del Santo.
Già del celeste uscier da nembo oscuroscorgeasi in alto mar sorpreso il legno,ed Eolo e Dori, in vólto acerbo e duro,contro al sacro nocchier fremer di sdegno;
voragin’ vaste, entro ’l ceruleo regno,apre in lega Aquilon con Austro impuro;foschi nembi eccitar d’orgoglio indegnoil piovoso orion, l’infausto Arturo.
Qual comparisse in ciel propizia luce,sembra anelar, tra ’l chiuso orror profondo,del navigio fedel piangente il Duce,
quando il tuo raggio di virtú fecondorecar si vide, o nuovo, alto polluce,calma insperata al naufragante mondo.
1-14. Il beato Alano della rupe (Alain De La roche, 1428-1475) racconta che San Domenico, durante la sua permanenza a tolosa, ottenne dalla Vergine Maria di combattere l’eresia albigese senza vio-lenza. Nella notte dell’Annunciazione del 1214, una nave pirata, sulla quale si trovava il santo prigioniero da più di tre mesi, fu scossa da una violentissima tempesta; alle sue preghiere rispose la Madonna, promettendo la salvezza dei naviganti se si fossero rifugiati nel rosa-rio. I pirati cominciarono allora a pregare e il mare improvvisamente si calmò; da quel momento il rosario divenne la preghiera piú diffusa per combattere le eresie.
1-2. celeste uscier: per similitudine, cfr. G. marino, La galeria, I, papa Paolo V, v. 6: «Onde celeste Uscier , con aurea chiave»; nembo oscuro… legno: per l’immagine della nave in nembo oscuro, cfr, B. tasso, Rime, LXXIV, vv. 2-4: «[…] ti parti, sí che nembo oscuro e gra-ve / questa mia frale e disarmata nave / non spinga a forza in qualche duro scoglio».
3. Eolo-Dori: Dio dei venti - Figlia di oceano e di teti, madre delle Nereidi, per antonomasia il mare.
4. fremer di sdegno: per la posizione in rima, cfr. G. Preti, L’oriuo-
antonio de’ roSSi
99
lo, in Rime, v. 38: «E sembrano in girar fremer di sdegno». 6. Aquilon: vento settentrionale; Austro: vento che spira dal Sud,
caldissimo e apportatore di pioggia.7. foschi nembi: temporali minacciosi.8. piovoso Orion: La costellazione di orione tramonta nel periodo
invernale, portatrice di tempeste e maltempo. Cfr. VirGilio, Aen., I, 535. Arturo: stella luminosissima. presso gli antichi Greci e romani, Arturo era considerato un astro latore di avvenimenti nefasti. Se-condo omero annunciava tempeste ai navigatori, mentre Virgilio lo riteneva portatore di disgrazie per i contadini.
11. navigio… duce: il comandante della nave.13. Polluce: stella gigante di colore arancione. Per la combinazio-
ne con l’aggettivo, cfr. t. tasso, Rime, III, 2, v. 14: «Castore vostro e ‘l vostro alto polluce».
Sonetti
100
vi
Sonetto di schema variato nella fronte aBaBaBBa cdcdcd. Rime ricche ai vv. 1:3, 2:7, 9:13. I due trisil-labi in rima provocano uno sbilanciamento in B, in par-te recuperato dalla identità fonica di A (vv. 1:3) e dalla continuità trisillabica in C. La struttura del componi-mento si distende in un procedimento narrativo, trovan-do nell’esuberanza della repetitio del termine sol, ai vv. 10:12, anche come metafora di Cristo, l’esplicazione del significato. Ondulato si potrebbe definire lo schema ge-nerale della poesia, retoricamente costruito sull’alterna fissità delle rime nelle quartine, in una sorta di asservi-mento al pensiero poetante, lontano, però, dal carattere puramente esornativo.
Il sonetto riprende un episodio del Vangelo di Luca (1,39-48), in cui si racconta della nascita di Giovanni Battista.
antonio de’ roSSi
101
San Giovanni Battista riconosce il Verbo umanato dentro a l’utero materno.
Di colpe infauste entro gli orrori e ’l gielogiaceasi il mondo orribilmente involto,ancor tra i cerchi d’un virgineo cielode l’umana salute il sole accolto, quando, da’ chiusi lumi il fosco velonel sen materno al precursor disciolto,egli, al Verbo fatt’uom fiso e rivolto,tutto avvampò d’incomparabil zelo.
Ben la madre di lui gli influssi alteriscerse del Sol che ’l sol vince d’assai,e al nuovo prodigio erse i pensieri:
scovrir del sol, non ancor nato, i rai,svelar, chiuso ne l’alvo, alti misteri,meraviglie maggior chi vide mai?
1-14. La nascita di Giovanni Battista parte da un evento miraco-loso, in quanto suo padre Zaccaria e la madre Elisabetta non avevano avuto figli, perché Elisabetta era sterile e ormai anziana. Un giorno, mentre Zaccaria offriva l’incenso nel tempio, gli comparve l’arcan-gelo Gabriele che gli disse: «Non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché sarà grande davanti al Signore». L’arcangelo Gabriele fu mandato, poi, da Dio a Nazareth ad annunciare a Maria la mater-nità del Cristo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi anche Elisabetta, tua parente, nella vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile; nulla è impossibile a Dio». Maria allora si recò a salutare Elisabetta. Entrata nella casa di Zaccaria, Elisabetta appena ebbe udito il saluto di Maria, sentí il bambino sussultarle nel grembo (v. 13). Giovanni Battista, per aver esultato di gioia (Luca 1:44), fu riempito di Spirito Santo quando era ancora nel seno della madre (Luca 1:15).
3. virgineo: luminoso.4 salute: salvezza.10. scerse: scorse.
Sonetti
102
vii
Sonetto di schema aBBaaBBa cdcdcd; assonanti le rime A e D. Rime ricche ai vv. 6:7; richiami rimici interni si notano in 1a versale (-or, -ol) ai vv. 1:7, 2:8. L’incipit disegna la componente ritmica delle quartine, costruita con la ripresa del verbo al passato (vv. 4-5-6-8-14), generando, quando è posto fuori dalla sede centrale, degli evidenti sbilanciamenti laterali, compensati a loro volta dai vocaboli ossitoni in 6a, unitamente alle forme avverbiali forti (sí), poste come punti culminanti delle aree laterali nelle terzine. Seguono costrutti dittologici sparsi, segmenti bini avverbio+aggettivo (v. 12), omo-fonie diffuse, anche con anticipazione della parola in rima (v. 1), repetitio (ciel2-6-13), pure in radice (fulmin-4), e significative allitterazioni (vv. 4:5:6) che anticipano e riprendono il suono iniziale della parola in rima. La con-catenazione fonologica rende il componimento compatto anche nella giusta ripartizione sillabica e periodica.
I richiami ai personaggi della mitologia uniscono l’elemento sacro del tema con quello profano, tipica in-tromissione barocca, sintonici con la rappresentazione anticipata nella titolazione.
Sant’Ivone Hèlori, detto Elorí, avvocato bretone nato a Lohanec nel 1253 e morto nel 1303. Fu giudice eccle-siastico a rennes e istituí per primo il patrocinio gratui-to per i poveri. patrono dei giudici, notai, magistrati, avvocati, giuristi, procuratori, orfani, portieri e uscieri (per le altre notizie sulla vita, cfr. son. n. XXXiX).
antonio de’ roSSi
103
San Ivone, cui santità fu espressa in sogno alla madre sot-to l’imagine d’un gigante, mentre celebrava i sacri misteri
dell’altare un globo di fuoco gli circondò la testa.
Stimò tal or, con monte imposto a monte,l’empio stuol de’ giganti al ciel ribellede l’aurea luce impoverir le stellee fulminar chi fulminò Fetonte;
ma in van di folle orgoglio armò la fronte,che irato il ciel vibrò strali e facellee, tra ’l fragor di torbide procelle,scuotendo il suol, puní i superbi e l’onte.
ove d’alta umiltà fatto sostegno,per sublime virtú gigante Ivoneaspira a i seggi de l’empireo regno,
vince in sí degna e sí gentil tenzone,e ’l Cielo istesso, di vittoria in segno, gli ordí con le sue fiamme auree corone.
1-2. monte… ribelle: il riferimento è alla rivolta dei giganti con-tro gli dei, i quali, per raggiungere la vetta dell’olimpo, dovettero sovrapporre tre monti uno sull’altro. per la diffusa attestazione del sintagma in rima, cfr. la singolare riflessione di Torquato Tasso: «Ho veduto il sonetto di Vostra Signoria, e m’è piaciuta molto l’invenzio-ne; ma due parole in due versi volentieri vedrei mutate, parendomi errori d’inosservanza: perchè dove Vostra Signoria ha scritto “quelli”, non seguendo vocale in quel verso; Quelli per cui fu monte imposto a monte; non mi piace: ma si può agevolmente conciare in questo modo: Color, per cui fu monte imposto a monte», in t. tasso, Le Lettere di Torquato Tasso. Ad Antonio Costantini, 1416. Cfr. anche Varianti della Gerusalemme liberata, in Gerusalemme liberata, V, 38, v. 3, «allor che, sendo monte imposto a monte». Interessante si presenta la posizione in 2a versale del sintagma in G. B. marino, La galeria, I, Giuliano Apostata, v. 1, «Non per alzar con monte imposto a monte», Adone, XIX, 166, v. 1, «Quasi animato monte imposto a monte».
3. Per l’immagine dei giganti ribelli, con la successiva perdita di luce delle stelle, cfr. t. tasso, Rime d’occasione e d’encomio, III, 5, vv. 6-7, «superba torre e d’alme al ciel ribelle, non di gigante che ferir le
Sonetti
104
stelle»; per similitudine, si veda anche B. tasso, Rime, III, A donna Giulia Gonzaga, vv. 6-7, «né meno né si curò d’impoverir le stelle, / per far le vostre sol simili a quelle».
4. Il riferimento è a Zeus che scagliò un fulmine su Fetonte, figlio del Sole, il quale, avendo ottenuto di guidare per un giorno il carro del padre, lasciò che i cavalli balzassero fuori dal loro corso, rischiando di bruciare la terra. L’intervento di Giove evitò il pericolo.
7. Sull’immagine della pioggia rumorosa, cfr. T. tasso, Il mondo creato, VI: «e le procelle torbide e sonanti».
14. fiamme: stelle.
antonio de’ roSSi
105
viii
Sonetto di schema aBaBaBaB cdcdcd. rima ricca ai vv. 11:13. La coordinazione polisindetica nella prima quartina collega le figurazioni all’interno di un incedere narrativo, segnato dai costrutti interrogativi ai vv. 6:8. La presenza ripetuta dell’indice connettivo consente, inoltre, di creare uno schema logico sintattico impernia-to sul 2+2, rendendo piú unitario e fluido l’andamento del verso, spezzando la durezza fonica delle parole e ve-locizzando il ritmo dell’endecasillabo. Diffuse iterazioni intrastrofiche compattano invece la restante parte del sonetto, pur all’interno di una progressione dimostrati-va, sostenuta da una minima varietà nell’articolazione sia fonica che strutturale del verso.
Il testo racconta, mediante la solita rete analogica, il logorio procurato dall’invidia, al quale il poeta si sot-trae, lasciando che il sentimento si autodistrugga.
Sonetti
106
Contro dell’invidia
Mostro inuman che, d’Acheronte uscito,col torvo sguardo infetti e avvelenie, d’odio sparso e da livor feritoper l’altrui ben, te stesso impiaghi e sveni,
qual cerbereo furor ti rende arditofra le mie gioie a distemprar veneni?Qual ti lusinga barbaro appetito,perché sien foschi i giorni miei sereni?
Lungi, sgombra empia erinni, angue nocente,vanne a gli ermi piú fieri e quivi aduggigli orsi e le tigri col tuo fiato ardente,
anzi, a Cocito omai ritorna e fuggi,qui batti a vòto il formidabil dente,e te stesso mordendo, ivi ti struggi.
1. Acheronte: mitico fiume infernale, qui come sineddoche per in-tendere l’Inferno nella sua interezza.
5. cerbereo furor: furore infernale. Cerbero: guardiano del tartaro, che divorava chiunque tentasse di fuggire dal reame dell’Ade. Cfr., anche per similitudine, p. M. virGilio, Aen., I, 294-6; L. ariosto, Orl. fur., XXXVII, 44.
9. erinni: simbolo dell’inferno, vendetta; angue nocente: serpente velenoso.
10. vanne … fieri: vattene in luoghi deserti e aspri; aduggi: ina-ridisci, bruci.
12. Cocito: uno dei cinque fiumi degli Inferi. In Virgilio il fiume del pianto, Aen., vv. 131-32: «[…]. tenent media omnia silvae / Cocyto-sque sinu labens circumvenit atro».
antonio de’ roSSi
107
iX
Sonetto di raro schema invertito nella fronte aBBa-BaaB cdcdcd. L’unità fonematica dal v. 1 s’irradia anche nei versi successivi, in particolare nei raggrup-pamenti -er, -or, quest’ultimo anche in costrutto di ana-fora (ai vv. 3:11), palindromicamente richiamato al v. 1 (guerriero); con presenza anche al v. 2 (ritorti), distri-buito in rimandi rimici interni (vv. 3:5:7) e variato nelle corrispondenze -ar (vv. 6:8). Il suono della palatale (i) presente nell’elemento nominale dell’incipit scandisce l’intero primo verso, riproposto nelle rime A, B e C. Nel-lo stesso modo, l’allitterazione e le adozioni in chiave anadiplotica dominano il v. 9, segnando la rima C. Si scandiscono, infatti, i foni della sestina, evidenziando il campo semantico della sofferenza sopportata dalla città di Napoli. L’intenzione è quella di circoscrivere le flessi-bilità armoniche all’interno di un ristretto piano eurit-mico, cosí da generare una convergenza tra le dinami-che delle modulazioni, con attenzione alle dislocazioni accentative, e le connotazioni concettuali.
Il 7 luglio 1647 scoppia a Napoli una rivolta antifi-scale, causata dall’introduzione di una nuova gabella su tutti i prodotti di origine vegetale che danneggiava i consumi piú diffusi; alle proteste seguí un tumulto dei popolani, che nei giorni successivi coinvolse anche gli al-tri ceti cittadini e si trasformò in una insurrezione aper-ta, con a capo Masaniello, contro il re. Il martedí del 16 luglio, Masaniello veniva ammazzato a tradimento, du-rante la festa della Madonna del Carmine. La sua testa recisa fu mostrata in pubblico proprio da un popolano, che prima, come tanti altri, l’aveva seguito e osannato. Non si conosce il luogo dove giacciono le sue spoglie. In Santa Maria del Carmine resta una lapide sulla quale si afferma che la salma, un tempo custodita in quel luogo, fu rimossa perché indegna di tanto riguardo.
Sonetti
108
Masaniello d’Amalfi, vil pescatore, fatto capo della plebe sediziosa nelle rivoluzioni di Napoli,
sotto li 7 di luglio 1647.
Marin guerriero anzi a i squamosi armentiguerra eccitò co i canapi ritorti,or di Marte costui rende i men forti,in riva al bel Tirren, seguaci ardenti;
corron costor, quasi in ebbrezza assorti,di faci armati a divorar gli argenti,resi d’alto furor sciolti torrenti,fan per tutto inondar ruïne e morti.
In sé stessa sconvolta e in sé divisa,partenope, non piú festosa e vaga,or tutta è duol nel proprio sangue intrisa. E di piú fieri scempi omai presaga,su meste arene, in bruna spoglia assisa,il suo grembo gentil di pianto allaga.
9. stessa] stesso
Si ricorda la rivolta di Masaniello che, da umile pescatore del tir-reno (mare che bagna Napoli), divenne il capo della ribellione che portò gli insorti a invadere la reggia, a devastare gli uffici daziari, a bruciare registri e a liberare i prigionieri.
1. anzi: prima; squamosi armenti: pesci.2. canapi ritorti = le funi, tipici arnesi del pescatore.6. faci: fiaccole.
antonio de’ roSSi
109
X
Sonetto di schema variato nella fronte aBBaaBaB cdcdcd. Rima derivativa ai vv. 1:4, 3:6, 5:7; ricca ai vv. 2:8. Assuonano B, C e D. La specularità dei lesse-mi composti nelle quartine tendono verso una soluzione omofona nella successione di parole in rima quasi iden-tiche. La compattezza del prosodema è sostenuta anche dalla repetitio in prima versale del primo emistichio (vv. 1:3) e dall’elemento dimostrativo (vv. 5:7), con sbilancia-mento del verso a sinistra, riequilibrato successivamen-te nella replicazione in chiave trisillabica dei termini composti sopra indicati. Le relazioni tra parole apocopa-te in -ar (ai vv. 1:3:8:9:10:11), in -or (ai vv. 4:6:13:14), ma anche i richiami ai vv. 6:14 (sdegno-indegno), e le forme pronominali ripetute (v. 10) contribuiscono ad addensa-re unitariamente la versificazione.La lirica si struttura sull’elemento contrastivo determi-nato dal paragone tra Venere e Masaniello, con simili origini marine, ma con sviluppi di vita opposti, conside-rato che la dea mosse i cuori all’amore, mentre Masa-niello alla violenza.
Sonetti
110
All’istessa città di Napoli agitata dalle rivoluzioni.Paragone tra Venere, dea del gentilissimo,
e Masaniello d’Amalfi.
Da le spume del mar Vener già nata in te pompe fastose un tempo ottenne; da le spume del mar colui sen vennech’ or muove in te sedizïon malnata.
Quella, al popol di Gnido in pregio e grata,di culto indegno a i primi onor pervenne,questi, a gli applausi d’una plebe ingrata,da i tempi violar non si contenne.
A franger legni, ad eccitar tempeste,dal mar crudele e l’una e l’altro apprese,a far le gioie altrui naufraghe e meste.
Gli erari e gli ori a divorar intese,nei palaggi e ne i cor fiamme funestel’una d’amor, l’altro di sdegno accese.
3. colui: Masaniello.4. sedizion: ribellione5. Quella…: Venere. Cnido era una antica città greca dell’Anato-
lia, situata nella regione della Caria di fronte ad Alicarnasso, devota a Venere.
8. tempi: templi. 12. erari: tesoro pubblico.
antonio de’ roSSi
111
Xi
Sonetto di schema aBBaaBBa cdcdcd, assuona con inversione A con B. rima ricca ai vv. 1:5. un pacato tono festoso, sostenuto dal continuo progredire analogi-co, pervade il testo. La catena lessicale è segnata nella proiezione metremica da omofonie diffuse e richiami ri-mici, in particolare ai vv. 2:5 (trar-eternar), ai vv. 5:7 in 1° versale (Guevara-rara), con spostamento a sinistra al v. 11 (recar), dai suoni ripetuti delle occlusive dentali (t) e delle alveolari sonore (r - l) al v. 2, con significati-va ripresa al v. 8. Si noti, inoltre, un attraversamen-to trasversale ai vv. 6:9 della rima B, variata al v. 12, col risultato di un addensamento sillabico che mantie-ne simmetricamente stabile la contiguità accentativa dell’endecasillabo.
Nell’aprile del 1648 fallita la rivoluzione - sia per l’in-vio massiccio di truppe dalla Spagna, sia per l’incapaci-tà di unificare il moto urbano con i moti rurali, sia per la repressione nelle campagne della nobiltà baronale -, Napoli, logorata dai disordini, messa in ginocchio dalle rovine causate dalla sommossa, accolse come liberatori il Conte d’oñate e don Giovanni d’Austria. L’inconclu-dente duca d’Arcos lasciò la città nel gennaio del 1648; nei primi giorni di marzo, dopo una breve luogotenenza di Don Giovanni d’Austria figlio illegittimo di Filippo IV, fu nominato nuovo viceré Indico Ve’lez de Guevara, conte d’Oñate, carica che lasciò al Conte di Peñaranda nel gennaio del 1653. L’ottavo conte d’oñate e di Villa-mediana (Madrid, 1597 - 1658) fu un diplomatico spa-gnolo raffinato, cinico ed esperto, consigliere di Filippo IV e ambasciatore spagnolo a Roma presso il Papa. Il primo marzo 1648 sbarcò a Napoli, assumendo la carica di Viceré di Napoli (2 marzo 1648 - 10 novembre 1653). Don Inigo-Velez de Guevara y taxis, conte di oñate, fu nominato viceré di Napoli da Filippo IV di Spagna in un
Sonetti
112
periodo non facile, da poco era terminata la rivoluzio-ne di Masaniello, le truppe francesi avevano occupato Ischia, mentre in Calabria infuriava la sommossa dei Pignatelli di Monteleone. Il viceré, abile stratega, in poco tempo riuscí a scacciare i soldati d’oltralpe, con-quistò Nisida e Ischia e domò la rivolta dei Pignatelli. Nel giugno del 1648 respinse un tentativo della flotta francese di sbarcare a Posillipo; nel 1649 fece arrestare e condannare Andrea d’Avalos, principe di Montesar-chio, colpevole di essersi schierato dalla parte di don Juan d’Austria che mirava alla conquista di Napoli. Guidò le truppe alla conquista di Piombino e Portolon-gone; diede impulso alla cultura, favorendo l’Accademia degli oziosi, e all’arte, promuovendo il dramma musi-cale nei teatri. Fece restaurare, infine, il Palazzo degli Studi, oggi Museo Archeologico Nazionale, gravemente danneggiato durante la rivoluzione di Masaniello. L’a-zione del Conte Oñate era, però, pur sempre ispirata a una sorta di restaurazione pre-rivoluzionaria, costruita su una base di ortodossia cattolica e di fedeltà alla mo-narchia spagnola, per questa opera si serví dei gesuiti, favorendoli nelle loro richieste, e del cardinale Ascanio Filomarino che guardava con benevolenza e simpatia alle rivendicazioni dei rivoltosi. La sua attività si ba-sava sull’incontro delle ali moderate del popolo e della nobiltà intorno alla corona. Con il passare del tempo, però, la sua presenza a Napoli non fu piú gradita dalla nobiltà napoletana, il cardinale Ascanio Filomarino di-venne suo acerrimo nemico e don Inigo Velez nel 1653 fu richiamato in Spagna da re Filippo IV. Al suo ritorno in Spagna fu nominato Consigliere di Stato e insignito del titolo di Marchese de Guevara. Nel 1658 fu nominato governatore di Milano, ma nello stesso anno morí.
antonio de’ roSSi
113
S’invitano i poeti napoletani alle lodi del Signor Conte d’Oñate, per le cose da lui operate, a favor della Corona di
Spagna, nelle rivoluzioni del Regno nel 1647 e 1648.
Voi, del vago tirren cigni canori,cui l’alme a trar dal ruginoso oblioinfiamma i bei pensier nobil desio,gli eroi fregiando d’immortal allori,
del gran Guevara a eternar gli onorifuror v’accenda del castalio dio,gloria piú rara il dolce stil natiotrarrà di lui tra i bellici fulgori.
Che s’al Cigno di Manto il pio troianoe di Smirna al cantor valse peliderecar ne’ pregi suoi vanto sovrano,
che fia per questi, a cui maggior non videla prisca età? Questi ch’al cielo ispanosorse novel, ma piú sagace, Alcide?
1. cigni canori: i poeti.5. gran Guevara: Indico Ve’lez de Guevara, conte d’oñate.6. castalio dio: Apollo. L’aggettivo si riferisce alla celebre sorgente
Castalia, presso il santuario di Delfi, ritenuta ispiratrice di poesia.9. Cigno di Manto: Virgilio; pio troiano: ettore.10. di Smirna cantor: omero.
Sonetti
114
Xii
Sonetto di schema aBBaaBBa cdcdcd, assonan-za tra A, C e D. Rima derivativa, ai vv. 3:7, ricca ai vv. 9:11. Le quartine sono dominate da forme bine in 2a ver-sale e da relazioni rimiche e foniche di sicuro effetto. Al v. 3, ad esempio, la parola in rima viene anticipata in attacco dello stesso verso; al v. 7, si genera invece una corrispondenza omofona nel primo emistichio. Altresí, le forme apocopate ai vv. 8:9 (Vien-velen) fungono da cerniera fonica con le terzine, governate dalla ripetuta anafora e da cellule vòlte a creare simmetrie ritmiche nelle rispondenze e negli echeggiamenti speculari. re-toricamente lineare, la lirica si sviluppa in due ampi periodi, tesi a raccordare semanticamente l’ottava con la sestina.
Sul piano dei contenuti, il componimento testimonia una tremenda sciagura che si abbatté su Napoli otto anni dopo i fatti richiamati nei sonetti precedenti, sotto il Viceregno del conte di Castrillo, quando una pestilen-za dimezzò la popolazione, che allora superava i quat-trocentomila abitanti (vd. Introd. pp. 72-73).
antonio de’ roSSi
115
Descrive la peste di contagio che, nel 1656, afflisse ilRegno di Napoli e gran parte dell’Italia
Tolta di grembo a Pluto, orrida pesteper l’italico suol move e s’aggira,spira stigii aneliti e, mentre spira,vibra ne’ petti altrui fiamme funeste.
Da’ chiusi alberghi, sbigottite e meste,le turbe a i campi ella sospinge e tira,ma ’l contagio mortal, che in lor conspira,se fugge il piè, vien che la vita arreste.
Come ignoto velen dentro s’apprendedal tatto solo, anzi, da un fiato lieve:vede il vulgo e ammira e non comprende;
come serpa e’ s’avvanzi in spazio breve,e come il cor sí atrocemente offende,ch’ei si dilegui, come al sol di neve.
1. Pluto: Signore dell’oltretomba, anche Ade, dio dei morti. Il nome Ade era considerato poco augurale, pertanto, si usavano titoli eufemistici tra cui Plouton, il ricco.
3. spira: emana, soffia.5. Da’ chiusi alberghi: dalle case; per la ripresa del sintagma, cfr.
G. B. Marino, Adone, VIII, 72, v. 1: «Può da que’ chiusi alberghi a l’ampia corte». Quanto al riuso degli aggettivi sbigotite e meste, cfr. G. Cavalcanti, Rime, p. 101, vv. 1-2: «Noi siàn le triste penne isbigotite, … dolente».
7. contagio mortal: cfr. ancora, G. B. Marino, Adone, XIX, 315, v. 4: «di contagio mortal gli Argivi oppresse».
9. s’apprende: si aggruma, contagia.10. tatto: contatto; fiato lieve: respiro; si noti l’inversione dell’ag-
gettivo con il sostantivo rispetto al verso mariniano, Adone, VI, 101, v. 7: «che con volo lascivo e lieve fiato».
Sonetti
116
Xiii
Sonetto di schema aBBaaBBa cdcdee. rime ricche ai vv. 4:5-6:7, 9:11, rima inclusiva ai vv. 13:14.La struttura presenta una rara rima baciata nel distico finale, in ripresa del diffuso uso di questa tecnica nel Trecento, evitata però da Petrarca, e caduta quasi defi-nitivamente in disuso nel XIV e XV secolo (cfr. santaGa-ta, 1984). Lo schema si rivela rinforzato dalle contigue e dalle diffuse omofonie dei gruppi: -al, -ar, -or, ai vv. 2:3, 4:8:9, 11:12. La descrizione dell’inondazione del tevere regge l’inte-ra composizione, esplicitata dal termine fiume, posto in attacco del v. 3 e ripetuto nell’ultimo verso del sonetto, anticipato con formula allitterante in fame e nella paro-la che precede la rima del v. 11 (furie).Da numerose ricerche effettuate non si è trovata notizia di un’inondazione riferita alla data citata dal poeta, è probabile che ci sia stato un refuso, con riferimento in-vece alla piena del 5 novembre del 16601.
1 Prima ancora degli idrometri del 1798 e del 1821, il livello delle inondazioni a roma veniva registrato sulle famose colonne di tra-vertino del porto settecentesco di Ripetta, inaugurato nel 1704. Su tali colonne sono stati riportati, riprendendoli probabilmente da iscri-zioni su palazzi nelle immediate vicinanze, anche i livelli raggiun-ti dall’acqua in alcune delle maggiori esondazioni precedenti, come quella del 1660 che raggiunse i 17,11 Hidrom (m) Ripetta.
antonio de’ roSSi
117
Descrive l’inondazione del Tevere,occorsa a’ 4 di novembre 1661.
Gonfio da gli austri e da alterigia pieno,già ’l Tebro innalza il crin dal letto algoso,e, da fiume real torrente ondosofatto, ei niega il tributo al mar Tirreno.
Al popol di Quirin minaccia il frenod’impor superbo, e co ’l suo piè fastoso,egli ratto, non men che strepitoso,tenta occupar del Campidoglio il seno.
Corrono a depredar l’onde vittrici da i ricchi alberghi i prezïosi arredie ’l tutto empion d’orror, qual furie ultrici;
co i venti in lega le procelle or vedi:mesto il vulgo sospira, asceso in alto,de la fame e del fiume il doppio assalto.
1. da gli austri: dai venti umidi e carichi di pioggia.2. Tebro: tevere.3. fiume real: anticamente era ritenuto fiume reale dai poeti quel-
lo che fa capo in mare (come l’Arno); cfr. D. aliGhieri, Purg., V, 122: «ver’ lo fiume real tanto veloce».
5. popolo di Quirin: uno dei rari miti riferiti a Quirino lo associa a Romolo, di qui l’identificazione con i Romani.
7. ratto: veloce.9. onde vittrici: onde vittoriose, con gravi conseguenze per i rac-
colti.11. ultrici: vendicatrici.
Sonetti
118
Xiv
Sonetto di schema aBaBaBaB cdcdcd. rima ric-ca ai vv. 3:7, 10:12. Il gruppo -er dell’aggettivo fier2 è ri-chiamato in formule iterative ai vv. 10, 12, 14; cosí come nel v. 5 troviamo la ripetizione del gruppo -or e nei vv. 9-10 quella del sostantivo ciel. tali elementi si presen-tano come microcellule metremiche - poste all’interno di formule descrittive, con effetti paronomasici diffusi - tese al ricompattamento, nella linearità accentativa, delle armonie interne al testo.
Il componimento si lega alle precedenti testimonian-ze di cronaca; riferite questa volta all’eruzione del Vesu-vio, del 3 luglio 1660 di tipo esplosivo, con ceneri e danni fino in Irpinia.
antonio de’ roSSi
119
Descrive l’incendio del Vesuvioseguito sotto li 3 luglio 1660.
Sotto gelida rupe oppresso e chiuso,di sdegno ardendo il fier Vesevo e d’irascuote l’aspra cervice e, in suon confuso,globi al ciel di faville avventa e spira.
L’empio ardor che lo strugge, e fuor d’ogn’uso,sulfurei nembi d’ogni intorno aggira,fra le viscere sue sparso e diffuso,vasti macigni incenerir si mira.
Sotto pallide nubi il ciel s’asconde;del ciel, c’ha per pietade umidi i lumi,sono i venti sospir, lagrime l’onde;
ov’ei di cener densa atri volumispiega del bel Tirren su l’ampie sponde,qui di pianto e di duol fa nascer fiumi.
1-2. oppresso e chiuso: per similitudine, cfr. G. B. marino, Rime amorose, V, vv. 4-5: «quasi novo tifeo, chiuso et oppresso / sotto il gran sasso del silenzio ascondo», ma anche in Adone, XVIII, 142.
2-3. di sdegno ardendo…, e d’ira: si noti la vicinanza del verso, pur nel rinnovato contesto, con quello di M. M. Boiardo, Orlando in-namorato, III, 11, v. 8: «Di sdegno ardendo tutto e de dispetto»; aspra cervice: impervia cima.
4. strugge: voce di chiara ascendenza petrarchesca, ampiamente adottata nell’Adone del Marino; fuor d’ogn’uso: lontano da ogni nor-male consuetudine.
10. c’ha… lumi: metafora del cielo commosso, che piange.11. venti… l’onde: cfr. G. B. marino, Rime marittime, XXI, v. 11:
«e per venti sospir, per onde ha lutto».
Sonetti
120
Xv
Sonetto di schema invertito nella fronte aBBaBaBa cdcdcd. Rima ricca ai vv. 3:7, 4:6:8; consuona A con C. La struttura del componimento poggia sugli effetti originati dagli elementi deittici (questi, quegli), sulle correlazioni oppositive degli indefiniti (un, altro) e degli avverbi (quinci, quindi). Il valore correlativo dei prono-mi indefiniti è riproposto anche in speculare chiave ana-forica ai vv. 3:10, 4:11; figura ripetuta ai vv. 9:12 (ambo-ambi). Il ritmo è definito, pertanto, dalle diffuse rispon-denze e dai riecheggiamenti che determinano l’ordine armonico, costruito su una lieve contrastività necessa-ria a segmentare le dimensioni melodiche del singolo verso. Si notino, infine, i rimandi interni (ardor3-umor4, assordan12-frenan14), la repetitio (ardor3-10, ambo9-12, cie-chi9-10), le continue paronomasie e i procedimenti binari.
I contenuti si collegano alle vicende testimoniate nei sonetti precedenti.
antonio de’ roSSi
121
Allude all’incendio del Vesuvio e all’inondazione del Tevere, occorsi ambedue nell’istesso anno 1660.
D’ira accesi e di sdegno, ecco a tenzonequinci il Vesevo e quindi il Tebro altero,l’un di fumanti ardor campo guerriero,l’altro umor procellosi a terra espone.
Questi, premendo la città di piero,a lei che ’l pose al mondo il giogo impone;su Partenope vaga, acerbo e fieroquegli nembi voraci alza e compone.
Ambo son ciechi e pur su l’aer vano,l’un disserra mille occhi a’ ciechi ardori,l’altro al vulgo altrettanti apre su ’l piano;
d’ambi assordano il ciel gli alti fragori,e pur ad ambi il vasto orgoglio insanofrenan due sacri e singolar pastori.
2. Tebro: Tevere. Il nome del fiume, accompagnato dall’aggettivo altero, trova una larga adozione nella tradizione; a mo’ di esempio, cfr. G. B. Marino, Adone, XX, 372, vv. 3-4: «per cui col Tebro altero in nobil gara / fia che ’l Reno minor contenda e giostra».
5. Questi: il Tevere; la città di Piero: roma. per il sintagma in rima, cfr. L. lePoreo, Leporeambi, 45, v. 2: «Di qua, di là, nella città di piero».
6. pose: impose.7-8. Partenope: Napoli; quegli: il Vesuvio.9. aer vano: spazio infinito, vuoto, senza consistenza materiale;
per il sintagma in rima, cfr. G. B. Marino, Adone, I, 48, v. 7: «lubrico è il lembo e quasi un aer vano».
14. sacri e singolar pastori: allude probabilmente al papa Ales-sandro VII e al cardinale Ascanio Filomarino, arcivescovo di Napoli dal 1641 al 1666. Non è da escludere, però, il riferimento a San Pietro e a San Gennaro, patroni delle due città.
Sonetti
122
Xvi
Sonetto di schema aBBaaBBa cdcdcd. rima ricca ai vv. 12:14. Si notino i rimandi rimici interni in prima sede ai vv. 4:5, con ripresa al v. 9 (messagier) e combinazione in 6a ai vv. 7:11 (avventar-inondar), già in allitterazione al v. 1 (immortal). La connotazione pro-sodica rimane all’interno di una dinamica relazione tra la distribuzione sillabica e i luoghi della versificazione, cosí da non creare opposizioni ritmiche al calibrato ince-dere dell’endecasillabo.
Dell’eclissi citata non si è trovata traccia nei testi che riportano i principali fenomeni astrologici dei seco-li scorsi. L’Istituto Nazionale di Astrofisica Italiano da me interpellato1, attraverso il database della NASA, è riuscito, però, a risalire a un’eclissi avvenuta tra il 2 e il 3 novembre 1660, precisamente alle ore 00,50. La cu-riosità sta nel fatto che, essendo il sole sotto la linea dell’orizzonte, il fenomeno non poteva essere visibile né da Napoli, dove presumibilmente si trovava il nostro au-tore, né da altre parti d’Italia. Con molta probabilità, pertanto, la notizia dell’accadimento fu ricavata dal po-eta dalla circolazione delle notizie astronomiche che in quel tempo erano seguite con particolare interesse.
1 Nella persona del dott. Marco Galliani, che ringrazio per la disponibilità dimostrata ad aiutarmi nella ricerca.
antonio de’ roSSi
123
al molto reverendo Padre Fra’ alBerto de’ rossi, suo Fratello.
Dall’ecclisse del sole, sotto il segno di scorpione, occorsa a’ 2 di novembre 1660 e della congiunzione dell’istesso piane-ta e di Saturno, seguita a’ 6 di questo mese, sotto il segno medesimo e quivi Marte e Mercurio presagisce gran piogge, inondazioni di fiumi e sterile raccolto.
L’angue immortal, che co ’l perpetuo girole vicende del mondo in sé racchiude,su queste rupi inorridite e nudedivora il giel che gli aquiloni ordiro.
Gli usci del ciel Febo e Saturno apriro,onde umor tempestoso in giú trasude,e lo scorpio avventar l’oblique e crudebranche su questi, ebro di sdegno, io miro.
Al messagier de’ favolosi numiscuote i torbidi vanni il segno istesso,perché i campi a inondar s’alzino i fiumi.
Veggo il fervido Marte anch’ei depresso,fia ch’atri nembi, indi, avvenir presumi,e vaste piogge e steril messe appresso.
10. torbidi] torbiti
1. angue immortal: costellazione del Serpente. 4. aquilon: i venti freddi del nord.5. Febo e Saturno: i due pianeti citati nel titolo (Sole e Saturno);
nell’astrologia rinascimentale il pianeta Saturno era considerato fon-te di positività, ma anche di influenze negative e funeste.
6. umor tempestoso: temporale. 7. lo scorpio…: la costellazione dello Scorpione.9. messagier… numi: Mercurio.10. vanni: ali.
Sonetti
124
Xvii
Sonetto di schema aBBaaBBa cdcdcd. rima ric-ca ai vv. 1:4. Il giro strofico trova anche in questa lirica alcune rispondenze rimiche interne nelle quartine (vv. 1:4, rigor-terror), con una serie di suoni ripetuti (anche in chiave anaforica, con variante, ai vv. 8:10:14), cosí da rendere lo schema generale unito in un rinvio di effetti fonici corrispondenti.
Il componimento ruota, sul piano dei contenuti, intor-no al famoso proverbio, citato da Cicerone nel I libro del De Officiis, I, 33, «somma giustizia, somma ingiustizia».
Alessandro, fu giudice di Vicaría e avvocato fiscale, figlio del piú famoso Giovan Battista Gonfalone, emi-nente giureconsulto, eletto nel 1615 giudice della gran Corte della Vicaría e nel 1621 giudice criminale; fu Pre-sidente della Camera della Sommaria nel 1647. Strenuo difensore dei diritti dello stato amalfitano, scrisse, nel 1644, il Summarium defensae sive pro tuitione Status Amalphiae. Alessandro fu invece uno dei dodici giudici preposti alla sorveglianza delle cosiddette Capitolazio-ni, durante la Rivoluzione di Masaniello del 1647.
antonio de’ roSSi
125
al siGnor alessandro GonFalone, Giudice criminale della vicaria di naPoli*.
Allude a quell’assioma legale:Summum ius, summa iniustitia.
Fier padrigno è il rigor, la madre Astreatratta e vibra ben sí vindice spada,ma pur con vóto ch’ella a pien non cada,rechi terror, non stragge acerba e rea.
Co ’l sangue già solo un Dracon scriveasue leggi altrui nell’Attica contrada,ei con dragoni a soggiornar sen vada,ché l’uman dal ferin non distinguea.
Se ministro è di Lui che regge il cielo,chi giudice è fra noi de’ nostri errori?Perché di Lui non sembra il nobil zelo?
Quanti s’odono in ciel vasti fragori,pria che si scocchi un sol fulmineo >t<elo,che fere i monti, se spaventa i cori?
tit. quell’assioma] Quelli assioma
* La Vicaría criminale giudicava in primo grado i delitti commessi a Napoli e nei suoi Casali e in appello le cause già decise nei tribunali delle province del regno (dette udienze).1. Astrea: dea della giustizia.2. vindice: vendicatrice di diritti negati. 5. Dracon… contrada: Draco, arconte di Atene autore, secondo la tra-dizione, di una costituzione scritta nel 621 a. C., ricordata per la sua particolare severità: la pena di morte era la punizione anche per pic-cole infrazioni. Ogni debitore il cui stato sociale fosse inferiore al suo creditore ne diventava automaticamente schiavo, mentre la punizio-ne era piú lieve per chi avesse debiti nei confronti di una persona di classe inferiore. Il codice di Dracone fu sostituito da quello di Solone nella prima parte del VI secolo a.C.7. dragoni: mostri infernali 11. sembra: appare. 13. telo: saetta.14. fere: ferisce.
Sonetti
126
Xviii
Sonetto di schema variato nella fronte aBaBBaaB cdcdcd1. Rima ricca ai vv. 3:7, 9:11, 10:12. La strut-tura delle quartine poggia su un procedimento binario - basato anche sulla comparazione tra la stasi dell’ar-tigiano (chiude, chiuso, fissar, fisso) e il movimento dell’oggetto da forgiare (fuggitivo, fugge) - sostenuto da suoni replicati, volti a generare calibrati equilibri orga-nici, all’interno dell’articolata catena fonematica. Nella lirica tutto si concentra dentro un procedimento omo-geneo, anche di tipo intonazionale, senza divaricazioni evidenti. Nelle terzine la rima interna in 6a, ai vv. 9-11, ricompatta l’incedere ritmico, con allitterazione sempre in 6a al v. 10.
La massima riportata nel titolo riprende, in buona parte la citazione evangelica: «Qui se humiliat, exalta-bitur»2; pur non tralasciando la concezione agostinia-na, secondo la quale l’umiltà è il fondamento di tutte le virtú.
1 per l’attestazione in petrarca, cfr., son. I.2 Cfr., Luca XVII, 14:11, «chi si umilia sarà esaltato».
antonio de’ roSSi
127
al molto reverendo Padre Fra’ amBroGio
da sorrento, Francescano. Che l’umiltà paziente sia la vera pietra de’ filosofi.
Chiude al calor d’ermetico fornelloin cavo vetro un fuggitivo argento,e chiuso il fabro entro a solingo ostello, a’ folli magisteri irrita il vento.
Versa fumo e sudor, cupido e intentoquel metallo a fissar troppo rubello:ma l’un fugge dal foco e dal martello,l’altro fisso riman nel suo tormento.
Artefice miglior, vera umiltade,mentre insegna a soffrir men giusti ardori,porta a i lucidi onor d’aurea bontade,
ella forma da i scherni alti splendori:tra le piaghe e gli oltraggi unqua non cadevinta e le povertà cangia in tesori.
2. fuggitivo argento: per il sintagma in sede finale cfr. G. B. mari-no, Rime boscherecce, III, v. 11: «l’imagin sua nel fuggitivo argento».
5. cupido: bramoso.13. unqua: giammai.
Sonetti
128
XiX
Sonetto di schema variato nella fronte aBaBaBBa cdcdcd. Rima ricca ai vv. 2:6, 5:8; assona B con D. La componente binaria, in particolare nella formula con-trastiva delle quartine (splendido-tetri, candor-notte), determina il contrappunto melodico, caratterizzato da uno sconfinamento nella tortuosità ritmica ai vv. 9-11, riequilibrati dal richiamo interno in -il (2a versale) e dal-le formule rafforzative del v. 12, modulando il giro fra-stico degli endecasillabi precedenti e lo sbilanciamento unilaterale di alcuni versi delle quartine.
Il componimento riprende l’elogio della virtú già espresso nel sonetto precedente, con particolare riferi-mento all’ardore per l’umiltà e la carità, compagne nel cammino terreno di San Francesco d’Assisi.
antonio de’ roSSi
129
al molto reverendo Padre Fra’ amBroGio da Praiano, Franciscano.
Il serafico San Francesco, in virtú della sua profonda umiltà, ottiene grado eminente di gloria nel cielo.
Splendido astro di luce, angel sublime,tra’ primi e tra’ maggiori in ciel splendea,ma ’l trasse giú da quelle eccelse cime,ne’ tetri abissi, empia alterigia e rea.
O qual divien da le sembianze primediverso? E ’n quai tormenti il fier cadea?pria nel candor l’istesso sol vincea,orrida notte or nel suo vólto esprime.
Pietade apprende dall’orribil caso Francesco e a seguir l’umil bassezza del puro angel di Dio vien persuaso;
in un gli ori e gli onori ei fugge e sprezza,sí che, d’elezion già fatto vaso,poggia del ciel sovra eminente altezza.
1. Splendido … angel sublime: Lucifero. tra le occorrenze della composizione sost.+agg. alla fine del verso, cfr. G. B. marino, La ga-leria, Chiede il ritratto a Don Angelo Grillo, vv. 1-2: «Sospendi il volo omai, ferma quell’ali / onde il Tempo e la Fama, angel sublime».
Per le altre combinazioni alla fine dei vv. 3, 12, si segnalano a mo’ di esempio: ariosto, Orl. Fur. XVII, eccelse cime; Rime, XX, fugge e sprezza.
13. fatto vaso: per similitudine, cfr. D. aliGhieri, Paradiso, I, v. 14: «fammi del tuo valor sí fatto vaso».
Sonetti
130
XX
Sonetto di schema variato nella fronte aBBaaBaB adcdcd. rima derivativa ai vv. 2:8, ricca ai vv. 12:14. L’intera lirica si mantiene compatta nella distribuzio-ne piú o meno calibrata dei valori accentativi e delle rispondenze foniche, all’interno di una diffusa congiun-zione degli elementi lessicali che segnano la linea me-lodica. L’equivoca repetitio di sol, ai vv. 1:12, l’identico attacco sonoro del verbo e del sostantivo ai vv. 1:9 e la disseminazione nelle terzine della a tonica concorrono a generare una circolarità di fondo, rendendo il discorso lirico raccolto, senza brusche rotture, anche nella rifles-sione esplicata in modo continuativo nell’intero arco del componimento.
Il piano semantico si collega ai due sonetti precedenti con l’esaltazione della virtú, intesa come valore eterno, rispetto alla caducità delle umane cose.
antonio de’ roSSi
131
al siGnore aniello lottieri.Essendo tutte le cose umane caduche e transitorie, la virtú
sola può condurci ad eterne felicità*.
Fugge, qual nebbia al sol, qual onda in fiume,de gli anni il corso e i nostri giorni involve,e ’l tempo predator disperge in polveciò che per fasto insuperbir presume.
Morte ha strali di foco e, per costume,scettri, mitre e diademi in cener solve;a i flutti de l’oblio mal regge il lume,ch’entro a spazi vitali in noi si volve.
Fumo e fiamma in un punto e larva e scena,anzi, inganno e menzogna è il viver frale ch’ allettando il pensier deluso il mena,
sol può d’alta virtú raggio vitaledonar, Lottieri, ov’ella i sensi affrena,beata eternità, soglio immortale.
* Nei Discorsi di Sant’Agostino vescovo, Serm. 255/A, 1-2, si legge: «Figli dilettissimi, conducete una vita buona, di modo che dal grande sacramento che avete ricevuto possiate ricavare incentivi per il bene. Siano corretti i vizi, sia dato un buon ordine ai costumi, siano acqui-state le virtú! Costituiscano l’ornamento di ciascuno di voi la pietà, la santità, la castità, l’umiltà, la sobrietà, sicché, potendo offrire a Dio di tali frutti, egli trovi in voi il suo beneplacito e voi in lui la gioia».
6. scettri,… diademi: per similitudine, cfr. t. tasso, Rime d’oc-casione e d’encomio, I, 570, v. 60: «Ma sovra mitre e scettri alti e diademi».
9. larva: vana apparenza; scena: finzione.
Sonetti
132
XXi
Sonetto di schema variato nella fronte aBBaBaBa cdcdcd. rima contraffatta ai vv. 1:6, ricca ai vv. 2:5 e 11:13, derivativa ai vv. 4:8; assona A con C. L’arco me-lodico del componimento si presenta in linea generale ampio, metricamente unitario, basato, in sede rimica, per lo piú su lessemi bisillabici e trisillabici (fatta ec-cezione del v. 9), riproposti in una diffusa alternanza, spesso contrapposta alla parola in rima.
Il piano semantico trova un collegamento con il sen-so morale espresso nei sonetti precedenti, in particolare nell’attestazione dell’inutilità della poesia lasciva e nel-la denuncia della corruzione da essa generata.
Il destinatario del componimento, molto probabil-mente, è il Marchese della Guardia Antonio Solimele, valoroso capitano e comandante delle forze di Salerno contro i Francesi nel 1653.
antonio de’ roSSi
133
al siGnor marchese antonio solimele.La lira d’Orfeo introduceva sensi d’umanità ne’ bruti e
quella de’ nostri poeti lascivi introduce sensi di bruto ne gli uomini.
Temprò tal or l’armonïosa lirae ’l moto ai boschi il Tracio Orfeo già diedea l’aspre sere; entro a selvaggia sedelo stil canoro umani sensi inspira.
traendo ai carmi ossequïoso il piede,l’orso e il leon lascia>n< l’orgoglio e l’ira,non piú le vite altrui vien che depredel’angue, né tosco avventa e morte spira.
Mossa per man fedel, cetra impudicaor sensi in noi d’irsuta belva innestae, tra lascivi error, gl’animi intrica;
cieca fiamma ne i cor per lei si desta, onde incendio mortal s’erge e nutricae rogo indegno a le virtú s’appresta.
1-4. Il riferimento è al famoso poeta greco, il quale, con la sua musica, convinse la dea persefone a lasciare andare dal regno dell’ol-tretomba sua moglie Euridice. L’autore, sul piano metaforico, tende a evidenziare come la buona poesia conforti l’anima, lontana dai veleni e da ogni decadenza.
6. l’orgoglio e l’ira: per similitudine, cfr. G. B. Marino, Adone, VII, 233, v. 3: «toglie al cieco Furor l’orgoglio e l’ira».
8. l’angue: il serpente; tosco: veleno.9-14. Quando la poesia è ispirata da desideri insani abbrutisce
l’uomo, spingendolo verso la distruzione di ogni virtú. 13. nutrica: nutre.
Sonetti
134
XXii
Sonetto di schema variato nella fronte aBBaaBaB cdcdcd. rima derivativa ai vv. 2:8, ricca ai vv. 4:5, 11:13, rima interna in 6a ai vv. 1:13; richiamo anaforico ai vv. 5:6, con ripresa al v. 10 in prima versale.
La costruzione delle diverse analogie testimonia l’in-capacità dell’uomo di sottrarsi all’errore; sicché l’intero mondo giace incatenato alla colpa. Il poeta auspica che gli amministratori della giustizia imparino ad avere piú comprensione per i reati meno gravi.
antonio de’ roSSi
135
al siGnor Francesco sanGiorGio vicario Generale casertano.
Che da’ giudici si devono compatire i delicti non molto gravi.
opra umana è il fallir de’ sensi al pondo:giú spinto, uom cade in varie colpe indegne,e ’l fallo, omai sotto l’infauste insegne,intiero accoglie incatenato il mondo.
Chi mai vide ingemmarsi il fango immondo?Chi l’etiope imbiancar fia che s’ingegne?Anzi, chi vedrà su l’Erebo profondosplender d’un chiaro di luci ben degne?
Anco nel sol, che d’aurea luce è fonte,rivien chi fiso il guarda o macchia od ombra,né quinci egli usa di celar la fronte.
Se, dunque, altrui men grave eccesso adombra,le voglie al compatir non sia men prontedi lui che ’l tron de la giustizia ingombra.
7. chi] ci. 9. è] e 1. fallir: lasciarsi andare; pondo: peso, errore.6. etiope … s’ingegne: il colore scuro della pelle rende impossibile
ogni tentativo di sbiancarlo. L’Etiopia anticamente era ritenuto il pae-se degli uomini dal volto bruciato, perché s’immaginava che vivessero vicino al luogo del sorgere e del ridiscendere in mare del sole. Cfr. anche virGilio, Eneide, IV, 481.
7. Erebo: Signore delle ombre infernali, piú genericamente l’infer-no. Nella Teogonia di esiodo, Erebo è descritto come la personificazio-ne dell’oscurità degli inferi.
10. rivien: ritrova.12-14. Se, dunque, le colpe commesse non sono gravi, siano i giu-
dici capaci di essere magnanimi; adombra: sospetta.
Sonetti
136
XXiii
Sonetto di schema aBBaaBBa cdcdcd. rima ric-ca ai vv. 4:5, 10:14. Rime trisillabiche in A, con domi-nanza anche in D, e bisillabiche in B e C (eccede il v. 7). rime interne caratterizzano l’andamento delle quartine ai vv. 1:3 (fecondar-versar); in 1a versale in -er ai vv. 4:5:8. Nelle terzine, ancora in 1a versale, troviamo la re-petitio in cesura ai vv. 11:13.
Il componimento è dedicato a Giosia Acquaviva d’A-ragona (1631-1679), 14° Duca d’Atri, figlio di Francesco Acquaviva d’Aragona, 13º duca d’Atri, e di Anna Con-clubet. Sposò, nel 1646, Francesca Caracciolo, figlia di Giuseppe Caracciolo, 1° principe di torella, e di Costan-za di Capua. Fu un valorosissimo capitano, ma anche un raffinato letterato; compose versi molto apprezzati sia in greco che in latino. A Giulianova (te), dove pro-babilmente ebbe i natali, lo ricordano, tra le altre cose, per aver abbellito gli stucchi all’interno della facciata del Santuario della Madonna dello Splendore, per aver finanziato la costruzione di un portico, per aver ordina-ta la decorazione del Coro dietro l’altare maggiore con alcune importanti tele, opere di Giacomo Farelli (roma, 1626 - Napoli, 1706). Un pittore che nel 1664 fu presente ad Atri per decorare le volte del palazzo ducale degli Ac-quaviva, pertanto, fu sicuramente il duca di allora (Gio-sia III) a commissionare le quattro tele che risalgono al 1665 circa.
antonio de’ roSSi
137
al siGnor don Giosia acquaviva, duca d’atri, eletto in PrinciPe da Gli academici oziosi di naPoli.
Si allude all’aquila, impresa dell’Academia*, e al leone, armi della famiglia del Principe.
Sublime eroe, cui fecondar gli alloricon bell’Acqua si diè purgata e viva,e versar d’Ippocrene in su la rivad’eloquente saper fiumi canori,
per te sorger vedrassi a’ primi onorilei che in Atene e su gli ingegni è diva,per te vedrem l’aurea sapienza argivamille sparger fra noi vivi fulgori.
L’aquila, che di stelle a sé fa velo,se di pregio e di lume altrui non cede,quando sorge il leon, tramonta in cielo;
questa, ch’ al sol si specchia e qui presiede,del tuo regio leon tra i lampi e ’l zelopiú chiara splende e in te se stessa eccede.
6. è] e
* L’Accademia fu fondata a Napoli, da Giovanni Battista Manso, marchese di Villa, nel 1611. Il termine «oziosi» fu scelto da Francesco De pietri, che nel Proemio dei suoi Problemi Accademici chiarí: «non già dell’otio scioperato, o neghittoso, ma del letterario e virtuoso».
3. Ippocrene: sorgente sacra alle Muse, sul monte elicona in Be-ozia, che si credeva avesse il potere di donare l’ispirazione poetica.
6. lei… diva: Atena, dea della sapienza, della saggezza, della tes-situra, delle arti e degli aspetti piú nobili della guerra, figlia di Zeus e della sua prima moglie Metide.
7. argiva: greca.9-11. l’aquila … velo: la costellazione dell’Aquila; sorge il leon: la
costellazione del Leone. Entrambe le costellazioni sono visibili dai due emisferi, l’Aquila preannuncia l’arrivo dell’estate nell’emisfero del nord, mentre il Leone preannuncia la primavera. Nell’emisfero del sud, l’Aquila annuncia l’inverno e il Leone l’autunno.
L’aquila, assisa sopra un colle che fissa il sole, simbolo della con-tinua ricerca delle scienze era il simbolo dell’Accademia degli Oziosi e il leone simbolo dell’impresa della famiglia degli Acquaviva.
Sonetti
138
XXiv
Sonetto di schema variato aBaBaBBa cdcdcd. rima ricca ai vv. 1:5, 2:4. richiamo rimico in 6a ai vv. 8:10, con ripresa della parola in rima del v. 1, inclusio-ne dei gruppi -or ai vv. 3:5, -on ai vv. 5:9, riproposto quest’ultimo in repetitio ai vv. 9:12 (non). Forte antici-pazione omofona della parola in rima al v. 6 - dove piú evidente è la corrispondenza sonora bilaterale, ma an-che centrale - e al v. 11, fonicamente anticipata in attac-co del verso, a testimonianza della sistematica compat-tezza melodica.
Tipicamente barocca si rivela l’entrata di un perso-naggio mitico all’interno della lirica, citato per analogia e poi subito abbandonato, da cui però si parte per un richiamo a morali comportamenti.
Il destinatario del componimento è Giovanni Vargas, figlio del Duca di Cagnano (cfr. son. n. 31). Fu sua l’oratio funebris recitata, alla presenza dei membri dell’Accade-mia degli oziosi nella Chiesa Maggiore di San Domeni-co in Napoli, in occasione della morte del padre Maestro dell’ordine domenicano Fra’ Niccolò Ridolfi, nel 16501.
1 per il riferimento, cfr. Biblioteca volante continuata dal dott. Dionigi Andrea Scancassani, 2a ed., IV, Venezia, Gianbattista Albrizzi, 1747, pp. 339. L’anno 1651, segnato nella Biblioteca come data della morte di Niccolò Ridolfi, è da ritenersi errato, considerato che i documenti da me consultati riportano tutti come anno della morte di Ridolfi il 1650 (per le altre notizie su Niccolò Ridolfi, cfr. introduzione al son. n. 33).
antonio de’ roSSi
139
al siGnor don Giovanni de varGas.Perché piaccia all’autore trattenersi in villa di ’state
Lungi da’ tetti aurati, ove il pensierotra pompe allettatrici erra e vaneggia,e dal regno de i cor, bandito il vero,menzogna e fraude i sensi tiranneggia;
or che ’l Nemeo leon, sdegnoso e fiero,per le piagge del ciel rugge e lampeggia,’ve presso a l’onde chiare un pin frondeggiade’ miei stanchi pensier seggo a l’impero,
qui lieto al suon di non fallaci argenti,senz’oltraggio temer di rea lusinga,d’innocente usignuol godo a i concenti,
e qui non vien ch’ambizion dipinga,Giovanni, al mio desio vani portenti,né ch’infida beltà m’allaccia e stringa.
7. ’ve] vè
5. Nemeo leon: la costellazione del Leone. Il leone Nemeo era un mostro di natura divina, fu sconfitto da Ercole nella prima delle sue dodici fatiche.
8. a l’impero: sotto il comando.9. fallaci argenti: ingannevoli bellezze.11. concenti: melodie, soavi canti.12. vien: conviene.13. portenti: esempi, eventi meravigliosi.
Sonetti
140
XXv
Sonetto di schema aBBaaBBa cdcdcd. rima ric-ca ai vv. 2:6, 5:8, equivoca ai vv. 3:7; assona A con D. L’incedere prosastico del componimento si avvale di un meccanismo basato sul principio delle costanti, proprio delle costruzioni metaforiche, per esprimere una medi-tata riflessione, collegando campi allotropi. Nella secon-da parte del componimento (vv. 7-11), l’autore presenta in maniera alternata un procedimento binario, con spo-stamento a destra di forme congiunte, talvolta dittologi-che, anticipate nella parte finale del v. 1.
A esplicazione del titolo e dei vv. 5-11 si riporta un passo di Santa Maria Maddalena de’ pazzi, in conside-razione della larga diffusione che le sue opere ebbero nel corso del Seicento, per lo piú antologizzate all’interno delle molte biografie, sempre rapidamente esaurite dopo la loro edizione. La citazione si rende utile per la conco-mitanza del fervido dibattito - sviluppatosi tra le comu-nità religiose, che spingevano per il processo di santità di Maria Maddalena, negli anni immediatamente pre-cedenti alla pubblicazione delle liriche di de’ Rossi - che portò, il 16 settembre del 1662, all’inizio del processo di canonizzazione della già beata monaca carmelitana.
«Vedeva che le Monache si riposavono ancor loro sotto detta vite, sí come Jesu sotto quell’albore; et cosí ancora di molte altre creature, et si stavono sotto la sua om-bra con gran consolatione e quiete. Et questo intendeva essere quella quiete che ritrova l’anima in Dio, quando è venuta a quel grado che Dio in lei si riposa con gran quiete, et essa si riposa in lui e lo possiede veramente in quel modo che quaggiú ne può esser capace» (Terzo colloquio, da I colloqui).
antonio de’ roSSi
141
al siGnor Girolamo Follieri, matematico insiGne.Dall’esser Dio benedetto l’unico centro di tutte l’essenze create, avviene che in lui solo l’anima nostra si quieti.
Quel buon, quel grande, immenso e infinitoche ’l ciel creò di nulla e ’l tutto regge,il cui centro è destin, la voglia è legge,onde il gonfio ocean si frange al lito,
il centro è ben, da le cui linee orditoun vital lume i sensi in noi corregge;lume in virtú di cui l’uom vede e leggequel bello in sé ch’ei vi stampò co ’l dito.
Dunque, è ragion che in Lui quiete e pacetrovi, e fuora di Lui l’uman desios’aggiri per camin torto e fallace;
se da quell’un, Follieri, ogn’alma usciodel mondo ad onta e di pluton mendace,convien che rieda e sol riposi in Dio.
1-2. Quel… regge: Dio, colui che creò dal nulla e tutto governa.11. torto: tortuoso.13. Pluton: signore dell’Ade.
Sonetti
142
XXvi
Sonetto di schema aBaBaBaB cdcdcd. rima ric-ca ai vv. 1:3:7, 2:4:6, 9:13.
Domina nel sonetto il termine luce situato in attacco della lirica e riproposto nella rima B, anche nei signifi-cati affini e nelle etimologie derivative, giuocato sulla ripresa del nome Luca. Rinvii rimici interni sono visibili ai vv. 5:6 (sol-fievol), 7:12 (nel gruppo -or), con diffuse allitterazioni e qualche repetitio (qual5-8-9), donano all’in-cedere prosodico una significativa armonia che si riflette nella scansione ritmica.
Nella ripresa della visione agostiniana, il poeta stig-matizza l’impossibilità della mente, una volta legata al corpo mortale, di cogliere la vera essenza delle cose.
antonio de’ roSSi
143
al molto reverendo don luca tartaGlione, teoloGo.La mente immortale dell’esser congiunta al corpo mortale
viene impedita a conoscer la verità de gli oggetti.
Luce sparsa di rai puri, immortali,creando, in noi spirò l’eterna luce, e viva imago in lei de’ suoi vitali sembianti impresse, ond’ella arde e riluce;
ma, qual per nubi il sol, da’ sensi fraliquesta involta qua giú fievol traluce,da ’l vapor de gli affetti egri e mortalio qual tetro squalore in lei s’induce;
indi, qual fiamma al fumo immista, avvienech’ella abbia e fosco il lume e lento il motoe prenda impure impression terrene.
Luca, or non fia stupor s’è il calle ignoto,onde al vero si giunge e si pervienee ’l saper nostro di sapienza è vòto.
12. calle: cammino.
Sonetti
144
XXvii
Sonetto di schema invertito nella fronte aBaBBaBa cdcdcd1. Come in precedenza, la variatio operata nel-la fronte genera una sorta di chiave tra prima e seconda quartina.
rima derivativa ai vv. 2:4, 9:11, 12:14. rinvii rimici ai vv. 1:9:10 (rettor-rigor-furor) - con repetitio ai vv. 8:9 -, 5:14 (fabril-ostil), 7:13 (turbar-domar), unitamente alle omofonie diffuse, caratterizzano la distribuzione de-gli elementi soprasegmentali e l’aggregazione lessemi-ca, cosí da creare un armonico grado di commisurazioni ritmiche.
Si racconta degli stati febbrili attraverso una serie di argute analogie.
1 per l’attestazione in petrarca, cfr. l’introduzione al sonetto II.
antonio de’ roSSi
145
al molto reverendo don michele macelli, dottor di leGGe.
Perché gli accessi della febbre siano preceduti da rigori di freddo e poi segua grand’accension* di calore.
Spirto rettor de gli organi e de’ sensientro l’uom, mentr’ei vive, accolto giace,a cui di varii spirti in vita accensiossequïoso un vario stuol soggiace.
Se materia fabril, dura e tenace,vien, che in noi s’introduca o si condensiin lei, ch’osa turbar l’interna pace,arma ei di freddo alti rigori intensi;
usa dianzi i rigor’ per cui si scuote l’umana mole, indi in furor s’accende e i membri infiamma e il cuore ange e percuote,
poi cessa, e lena in quel riposo ei prende,sorge di nuovo e, se domar non puotel’ostil veneno, al fin, vinto si rende.
tit. accension] accesion
5. materia fabril: ferro.9. dianzi. prima.10. furor s’accende: per similitudine, cfr. G. B. marino, Adone,
XVIII, 3, v. 7: «or di desire, or di furor s’accende».11. ange: opprime. Per i due verbi posti alla fine del verso, cfr. G.
cinzio, Ercole, VII, 13, v. 4: «come chi fier dolore ange e percuote».12. lena: vigore.
Sonetti
146
XXviii
Sonetto di schema aBBaaBBa cdcdcd. rime ric-che ai vv. 2:7, 5:8, 9:13; assona con inversione B con C.
I rinvii rimici interni in -ar ai vv. 4:9:14, con asso-nanza al v. 10 (uman), in -il ai vv. 1:7, le identità dei segmenti sonori in 2a versale ai vv. 9:10 (onnipotente-instrumenti) e la repetitio con variante al plurale ai vv. 1:6 (spirto/i), 2:10 (piú) testimoniano lo stretto rapporto esistente tra l’asserzione decisa della tesi e la fissità del correlato retorico.
Il sonetto riprende una polemica del tempo sull’utili-tà della diffusa pratica di cavar sangue tramite sanguet-te e altri rimedi, tanto è vero che Giacinto Gimma, in Sylva I, asserisce che: «Gassendo nel male di apoplesia morí per l’aperture fatteli della vena».
Il poeta si schiera a favore dei medici che mettevano in discussione tale pratica, presentandola quasi come una trasgressione al disegno divino.
antonio de’ roSSi
147
al siGnor don Paulo di cordova.Che il cavar sangue a gli infermi sia mera sciocchezza.
Fiamma gentil, ch’ è spirto insieme e vita,il gran padre de’ lumi accese in noidi vivo sangue; Ei si compiacque poisí pura alimentar luce gradita;
quel chiuse in vene, a cui l’arteria unitaministra alta virtú co’ i spirti suoie, perché oltraggio ostil qui non l’annoi,veste gli fabricò forte e munita.
Questo a’ formar vari instrumenti ordionel corpo uman l’omnipotente mano,e ’l passo a lui per tutti i membri aprio;
ma per l’altrui sciocchezza oprossi in vano:quel tesor che di vita a l’uom fe’ Dioardisce di versar medico insano.
1. fiamma gentil: la stereotipata immagine viene usata per indi-care il colore rosso del sangue.
5. unita: congiunta, collegata.
Sonetti
148
XXiX
Sonetto di schema aBaBaBaB cdcdcd. rima ric-ca ai vv. 4:6; si riprende in D la rima C del sonetto pre-cedente, anticipata in attacco del v. 14. rima interna di 6a ai vv. 4:12. Le particelle copulative determinano un armonico sviluppo melodico. Le coordinate distributive e le soluzioni enunciative, rispondenti agli elementi for-mali del testo, obbediscono alla piú generale strategia dell’autore volta a determinare un nucleo centrale (la seconda quartina) intorno al quale far ruotare le parti-colari corrispondenze ritmico-foniche e quelle semanti-che.
Si parte da una citazione di San tommaso per ri-prendere la concezione etica espressa dal filosofo nella Summa teologica; in essa il filosofo sostiene che il fine ultimo dell’uomo è la realizzazione della sua natura tesa alla divinità. La natura umana, pur tendendo alla perfe-zione naturale, ha un unico fine ultimo reale: l’avvicina-mento al soprannaturale, in virtú della Grazia che Dio elargisce gratuitamente; soltanto in Gesú Cristo l’uomo, infatti, trova il suo compimento. L’accostamento tra i li-bri sacri e il desiderio del Cristo è, inoltre, da associare all’idea di tommaso di onorare, sino in fondo e senza riserva alcuna, la ragione umana e, allo stesso modo, la fede nella parola di Gesú di Nazareth.
antonio de’ roSSi
149
al molto reverendo Padre Fra’ seraFino de’ rossi,suo Fratello.
San Tomaso d’Aquino richiesto dal Crocifisso qual mercede egli volesse per li suoi scritti sacri rispose non volere altra che l’istesso Cristo.
Qualor tentò su l’Aquilon stellantel’angel piú luminoso erger la sede,cadde fra i cupi abbissi, ove a l’errantepensier d’eterni orror seggio si diede;
fermò Tomaso, in sua virtú costante,su ’l centro d’umiltà l’animo e ’l piedee, a nume immortal fatto sembiante,gli empirei cerchi sorvolar si vede.
Mosse de l’un co ’l re di gloria in cielotemeraria tenzon l’empio desio, e di scherno il trafisse orribil telo;
l’altro i dovuti onor chiuse in oblioe mentre, acceso d’ammirabil zelo,un Dio sol chiede in premio, ottenne un Dio.
1. Aquilon stellante: costellazione dell’Aquilone.2. angel piú luminoso: Lucifero. 9. co ’l…cielo: Dio.
Sonetti
150
XXX
Sonetto di schema aBBaaBBa cdcdcd. La strut-tura retorica non presenta solo le correlazioni collocate nelle rime finali, ma poggia le basi anche sulle solite rispondenze rimiche - in particolare ai vv. 2:3:10 (cam-pion-tenzon-ragion, assonate in 1a versale ai vv. 4-8) -,sulla ripresa del sostantivo posto in attacco del v. 1 con la parola in rima al v. 11 e sul rinvio rimico inter-no al v. 2 (avea, empirea), circolarmente riproposto con suono quasi omofono al v. 13 (ferreo). Significativa la repetitio del termine morte3-11-14, sul quale si struttura l’intero componimento, contrapposto a vita, posizionato quest’ultimo in rima nel verso finale, costruito sul dop-pio quinario che solo l’introduzione della dialefe norma-lizza.
Il poeta ripropone la cruda iconografia della crocifis-sione, con le consuete intromissioni figurative tipiche della poesia barocca. Richiama, infine, nel componi-mento - scritto probabilmente in prossimità della cele-brazione del rito pasquale - l’affermazione del profeta osea, Vulg. Cl., 13,14: «De manu mortis liberabo eos; / de morte redimam eos. / Ero mors tua, o mors! / morsus tuus ero, inferne! / consolatio abscondita est ab oculis meis» (Sarò la tua morte, o morte!. Osea esercitò il suo ministero profetico nella seconda metà del secolo VIII a. C, nel regno scismatico d’Israele a nord della palestina).
antonio de’ roSSi
151
in morte di cristo nostro siGnore.Allude a quello della scrittura: «O mors, ero mors tua».
Le braccia e i piedi a duro tronco affissiavea il Campion de l’alta empirea corte,quando a fera tenzon sfidò la mortee ’l rettor minacciò de’ scuri abissi. pelia e olimpo al gran duello aprissi,de la stigia città tremar le porte,e per le vie del cielo, oblique e torte,s’ascose il sol con portentosa ecclissi.
Sciolti i spirti in sospir, le membra in ghiaccio,perché ella resti in sua region schernita,Egli cader lasciossi a morte in braccio;
vincer stimò ma, follemente ardita,questa avvinta trovossi in ferreo laccio,cosí di morte trïonfò la vita.
1. Cfr. e. SciPione, Per Cristo in croce, vv. 5-6: «Ecco il bel corpo e sangue, / che sopra un duro tronco, ahi doglia, langue».
2. Campion: Gesú.4. rettor … scuri abissi: Lucifero. Per la combinazione agg+sost.
alla fine del verso, cfr. F. Petrarca, Triumphus temporis, v. 100: «di cieca oblivion che scuri abissi!».
5. Pelia e Olimpo: Nel mito i Giganti poggiarono sul monte pelio il monte ossa con lo scopo di raggiungere gli dei sull’olimpo.
6. stigia città: l’inferno. 10. schernita: beffata.
Sonetti
152
XXXi
Sonetto di raro schema invertito aBaBBaaB cdcdcd; l’inversione dello schema genera una sorta di verso chiave tra la prima e la seconda quartina. rima ricca ai vv. 5:8; assonanza tra B, C e D. Rima interna di 6a ai vv. 11:12:13, anticipata in 4a al v. 4. Repetitio ai vv. 1:4 (fur), 1:10 (allor), 8:13 (Diego), con consonanza ai vv. 6:7 (Permesso-chiudessi).
La terra di Cagnano aveva acquisito titolo di Ducato nel 1628 con Giulia d’Aiello, suocera di Alonzo de Var-gas (dal quale l’aveva comprata due anni prima con la somma di 10.000 ducati). Il nipote, cui si riferisce l’inte-stazione della lirica, è Don Francesco Vargas principe di Carpino (Sulla famiglia Vargas, cfr. anche il son. 24).
antonio de’ roSSi
153
in morte del siGnor don dieGo de varGas, PrimoGenito del siGnor duca di caGnano.
Allude all’onde della famiglia Vargas e a quella del Casta-lio e alla scienza poetica di quel Cavaliere e del Signor Don Giovanni, suo fratello, e Signor Principe di Carpino, nipote.
Allor che furo entro a i castali umoril’onde cerulee tue sparse e commiste,nuova armonia tra quei ben culti alloridi Pindo ordir le vergini fur viste;
ma venner poscia lacrimose e triste, e di permesso inaridirsi i fiori,che i tuoi lumi chiudesti a i nostri orrori e’, immortal cigno, in ciel, Diego, gl’apriste.
Del sacro monte le delizie estintepiansero allor quelle famose dive, e quindi a dipartir vedeansi accinte,
quando d’alto s’udir voci festive:Diego nel suo morir le parche ha vinte,in Giovanni e in Alfonso eterno ei vive.
2. onde cerulee: fonte Castalia, ispiratrice di poesia.4. Pindo: monte sacro ad Apollo e alle Muse, simbolo della poesia;
vergini: Muse.6. Permesso: fiume sacro alle Muse che ha origine dal monte Eli-
cona; con metonimia: la morte stessa.13. Parche: divinità che presiedono al destino umano.8. l’immortal cigno: la costellazione del Cigno.
Sonetti
154
XXXii
Sonetto di schema invertito nella fronte aBaBBaBa cdcdcd. Rima ricca ai vv. 1:3:6:8, 2:4:7 (pure derivati-va); come nel sonetto precedente la variatio operata nel-la fronte genera una sorta di chiave tra prima e seconda quartina. Il componimento si caratterizza per una serie di dominanze funeree costruite sugli aggettivi estinto, esangue, pallide, associati ai sostantivi urne, mausoli, ombre e sui riferimenti di Menfi e Caria.
Donna Diana Caracciolo, figlia di Don Domizio 1° Duca d’Atripalda e Lucrezia Arcella, morí a Napoli il 12 novembre 1649.
antonio de’ roSSi
155
In morte della Signora Diana Caracciolo,Marchesa di Brienza.
Erga moli superbe e i vanti egregiCaria d’estinto eroe tra marmi accolga,e in urne eccelse i suoi famosi regi,vaga d’eterni onor, Menfi raccolga;
onde al vorace oblio spegner si tolgad’un vólto esangue e reverito i pregi,il Ponto arabe stille aduni e colgae le pallide membra altrui ne fregi.
Che in piú degni Mausoli e in piú lodateguise involar di tua virtú gli onoriconvien, Diana, a la fugace etate;
a te, fra l’ombre de’ piú culti allori,cantin le glorie in Pindo aure beate,sien tempio i cieli e viva tomba i cori.
2. Caria… accolga: regione dell’Anatolia (odierna turchia) situa-ta a sud della Ionia e a ovest della Frigia e della Licia. Ad Alicar-nasso, città della Caria, si trovava il famoso Mausoleo di Mausolo, una delle Sette meraviglie del mondo, da cui i romani denominarono mausoleo ogni grande tomba.
4. Menfi: città dell’antico egitto, famosa, tra le altre cose, per la sua necropoli con piramidi e figurazioni plastiche.
7. il Ponto: il mar Nero.
Sonetti
156
XXXiii
Sonetto di schema aBaBaBaB cdcdcd. rima ric-ca ai vv. 3:7, 12:14.
Il Maestro Generale dell’ordine dei predicatori era la maggiore autorità dell’ordine religioso fondato da San Domenico di Guzmán (vd. son n. 5). I frati dell’ordine dovevano rispettare la regola che li voleva intenti nel-lo studio per essere piú idonei a “parlare con Dio nella preghiera e a parlare di Dio nella predicazione”, ispi-randosi alla prima Comunità di Gerusalemme, con una vita dedita alla lode di Dio e allo studio. un’esistenza, quindi, finalizzata alla conversione e alla predicazione del Vangelo per la salvezza delle anime.
Niccolò Ridolfi, nato a Firenze nel 1578, fu eletto nel 1629 Maestro Generale dell’ordine Domenicano, anche grazie al favore a lui dimostrato da Urbano VIII. Suc-cessivamente cadde in disgrazia presso i Barberini1 e fu sospeso dal generalato nel 1642, per essere deposto nel 16442. Con la morte di Urbano VIII e l’elezione al papa-to di Innocenzo X, la posizione dell’ex-Maestro generale migliorò rapidamente; il processo, mai giunto a soluzio-ne definitiva, venne ripreso e concluso il 15 giugno del 1645, con una sentenza di riabilitazione. Il 1 dicembre del 1649 morí tommaso turco, Maestro generale dal
1 Secondo Mortier, i motivi della caduta di Ridolfi vanno rintrac-ciati in alcune questioni di politica internazionale, in particolare rela-tive al rapporto con la Francia. Una figura chiave per comprendere le vicende della deposizione è il domenicano Michele Mazzarino, fratello del primo ministro del re di Francia, assiso a provinciale romano nel 1638 e aspirante al generalato. Cfr. A. Mortier, Histoire des Maîtres Généraux de l’Ordre des Frères Prêcheurs, A. picard et Fils, paris 1903-14, VI, pp. 407-408.
2 Secondo lo storico domenicano, le tensioni tra Ridolfi e i Barberini nascevano dal risentimento di questi ultimi per la mediazione svolta dal Maestro generale nel negoziato matrimoniale della principessa Olimpia Aldobrandini con il figlio del principe Borghese (il matrimonio fu celebrato nel 1638), vanificando alcuni progetti dei Barberini (Ivi, pp. 447, 512).
antonio de’ roSSi
157
1644. Il 9 dicembre dello stesso anno il papa nominò Ri-dolfi Presidente Generale dell’Ordine. Nell’intenzione di Innocenzo X, il titolo di presidente era piú alto di quello di Vicario generale, con il chiaro proponimento di orien-tare gli elettori verso la rielezione unanime del Ridolfi. purtroppo, il domenicano morí il 1 maggio 1650, a dieci giorni dall’apertura del Capitolo generale3.
3 Nel Capitolo Generale del 1642 i capitolari si dividono in due partiti: il primo, contrario a Ridolfi, si riunisce a Genova per deporlo ed eleggere al suo posto Michele Mazzarino; il secondo, favorevole all’ex Maestro generale, si riunisce a Cornegliano (Lodi) per eleggere il padre tommaso de rocamora. L’ordine si ritrova cosí ad avere tre Maestri Generali; risolve la situazione una commissione papale che dichiara nulli i due Capitoli (Ivi, pp. 405-92. Cfr. anche s. de anGelis, Patronage e potere in monastero: le sorelle Maidalchini a San Domenico di Viterbo, roma, Carocci, 2009, pp. 163-164)
Sonetti
158
In morte del Reverendissimo Nicolò Ridolfi, Maestro Gene-rale de’ Predicatori.
Su la gelida tomba in cui racchiusoco ’l pio Ridolfi ogni suo pregio avea,il crin su ’l tergo lacero e confuso,le voci al duol sí la Virtú sciogliea.
Pur tramontò quel sol che i raggi e l’usodal gran Sol de l’empiro altrui porgea?Fra cerchi angusti altro splendor diffusos’involse pur da ecclissi infausta e rea?
Ma, ah, non dovea fra questi bassi girilume eccelso annidar celeste fede,doveasi a chi dal ciel trasse i desiri!
Lui che ’l fasto mortal presse co ’l piedequa giú, premendo i lucidi zaffiri,or fra gli eterni divi eterno siede.
6. gran Sol: Dio; empiro: il paradiso.
antonio de’ roSSi
159
XXXiv
Sonetto di schema aBBaaBBa cdcdcd. rima de-rivativa ai vv. 5:8.
Vincenzo Carafa nacque ad Andria, in puglia, il 9 maggio 1585; apparteneva alla famiglia dei duchi di Montorio, la stessa di papa Paolo IV, figlio di Fabrizio Carafa e Maria Maddalena Carafa. Fu alunno del Col-legio dei Gesuiti di Napoli e a 19 anni, il 4 ottobre 1604, entrò nella Compagnia di Gesú. Una volta compiuti gli studi fu ordinato sacerdote nel 1613; dal 1622 al 1627 fu maestro dei novizi, poi dal 1627 al 1630 Padre Provin-ciale di Napoli, rettore del Collegio napoletano dal 1633 al 1636 e infine, a partire dal 7 gennaio 1646, succedet-te a Muzio Vitelleschi come settimo preposito Generale dell’ordine della Compagnia, mantenendo la carica sino alla morte. I quattro anni del suo generalato furono se-gnati dalle aspre controversie con i teologi giansenisti - forti oppositori della dottrina molinista sulla Grazia, difesa dai gesuiti - e dalle accuse di lassismo morale; ma il suo fu anche il periodo delle missioni nelle Americhe, segnate dal martirio di un gruppo di gesuiti ad opera degli indiani. Si distinse per la cura degli ammalati e l’amore per i poveri; scrupoloso osservante delle regole, fu predicatore efficace sia tra il popolo, sia tra le classi elevate. Per questi scopi rifondò a Napoli la Congrega-zione dei Nobili, spingendola verso un’ampia opera di carità e beneficenza. Con l’esempio di una vita santa e segnata dal dono della profezia e dei miracoli, richia-mò i confratelli al fervore primitivo dell’Ordine. Quan-do roma, dove risiedeva, fu colpita dalla peste e dalla carestia, padre Vincenzo Carafa organizzò varie opere di carità, dando cibo a migliaia di persone; si mise al servizio degli appestati senza riserve, fino a contrarre il morbo che lo portò alla morte (8 giugno 1649). Vincenzo Carafa fu scrittore di vari opuscoli ascetici (Fascetto di
Sonetti
160
Mirra, Cammino del Cielo, Cittadino del Cielo, Il Pere-grino della terra, Idea Christiani hominis, Il Serafino) di notevole importanza, che firmava sotto lo pseudonimo di Luigi Sidereo; ebbero larga diffusione e tradotti in varie lingue.
antonio de’ roSSi
161
In morte del Reverendissimo Don Vincenzo Caraffa, Gene-rale de’ Padri Predicatori della Compagnia di Gesú.
A l’alta pugna, ove tra campi inermiriede la mente or vincitrice, or vinta,e’ in dubbie imprese la ragion sospinta,or vacilla a gli assalti e ora a i schermi;
mosse Vincenzo e di robusti e fermiarnesi d’umiltà l’alma ricinta,ogni larva atterrò bugiarda e finta, che insorse al vaneggiar de’ sensi infermi.
Vinse il mondo e sé stesso e’, in doppio vanto,l’orecchie intese ad armonie migliori,di sirena mortal rachiuse al canto,
ma se in terra ei sdegnò terreni onori,or cinto il fregia di stellato ammanto,corona in ciel di sempiterni allori.
2. riede: ritorna.5-6. Vincenzo Carafa, come segno della sua servitú, si adornava
di un cerchio di ferro ai piedi, soffrendo per non poter trascinare pub-blicamente la propria catena.
11. rachiuse: si chiuse, impedí.
Sonetti
162
XXXv
Sonetto di schema variato aBaBBaaB cdcdcd. Rima ricca ai vv. 2:4, 3:7, 9:11. Assona, con inversione, A con C. Le quartine si caratterizzano per alcuni riman-di rimici in -or ai vv. 2:4.6, con dominanza in 2a versale, richiamati nelle terzine ai vv. 10:12; una fitta rete di omofonie rendono solidamente compatta la lirica.
Nel componimento si ricordano i misteri che hanno accompagnato la vita di Gesú.
antonio de’ roSSi
163
Si spiegano i quindici misteri del Santissimo Rosario.
Uom fassi il divin Verbo e, chiuso in senodi Vergin Madre, al precursor si svela;nasce in umil presepe e in grembo al fienonuncio alato a i pastor tosto il rivela.
Vien circonciso e, mentre a’ suoi si cela,scuopre a i Rabbini il suo splendor sereno,per l’uom ribelle in sodisfare a pieno,a l’eterna giustizïa arde e anela.
ora al gran padre, e per l’affanno atroce,versa il sangue in sudor flagelli e spine,soffre e porta al Calvario, indi, la croce.
Pria muor, poscia risorge; a le divinesedi sen poggia, e qui, per la sua voce,la Madre assunta ottien corona al crine.
Si descrivono i misteri del rosario. partendo dai gaudiosi (vv. 2-4), si racconta dell’esultazione di Giovanni Battista (precursor) che, an-cora nel grembo della madre Elisabetta, riconosce Gesú (cfr. son VI), dell’annunciazione dell’Angelo ai pastori (Luca 2,8-20), della circonci-sione di Gesú (Luca 2,21) dopo otto giorni dalla nascita e del ritrova-mento di Gesú fra i dottori della legge del tempio (vv. 5-8). Seguono i misteri dolorosi, in cui il poeta rievoca la flagellazione di Gesú alla co-lonna, l’incoronazione di spine, la sofferenza del carico della croce (vv. 9-11) e la crocifissione (v. 12). Dei misteri gloriosi si citano gli eventi della resurrezione e dell’ascensione di Gesú al cielo, dell’assunzione di Maria Vergine al cielo e della sua incoronazione (vv. 12-14).
Sonetti
164
XXXvi
Sonetto di schema variato aBBaaBaB cdcdcd. rima ricca ai vv. 6:8 (inclusiva con il v. 1), 9:13. Il tono giocoso del componimento ripropone una serie di artico-late armonie nelle rispondenze rimiche apocopate (-on) in 4a e in 6a ai vv. 1:12, con repetitio in radice ai vv. 12:14 (scherzan-scherzi), e nelle allitterazioni variamente dif-fuse nel testo.
La prima Accademia dei Confusi fu fondata da Giu-lio Cesare Colonna di Palestrina a Bologna, nel 1570, e aveva come obiettivo quello di «esercitarsi nella virtú con tutte le proprie forze, affine di giovare e dilettare in-sieme …» in una «honesta ricreazione»1; la seconda durò circa un ventennio (1620-1640 circa).
1 M. manFredi (il «Vinto Accademico Confuso»), Lezione, Bologna, Benacci, 1575; la citazione è presente nella dedica a Isabella Medici orsini, cfr. Storia letteraria d’Italia, Nuova edizione a cura di A. Balduino, Il Cinquecento, a cura di G. da pozzo, piccin Nuova Libraria, Padova, 2006, I, p. 1794.
antonio de’ roSSi
165
Primavera
Al Signor Don Giuseppe Domeniche, Segretario dell’Acca-demia de’ Confusi, detto l’Offuscato.
Sotto il monton, che piú di Frisso e d’elleper l’ondoso sentier mal resse il pondo,dispiega a noi ringiovenito il mondodi vaghi fior pompe odorate e belle;
non ha cotante il ciel tremule stelle,quante liete ghirlande ha il suol fecondo;per non turbar le sue beltà novelle,lega i fiati nevosi Eolo giocondo.
Già tarpate le piume a i nembi fieri,al dolce mormorio d’onde sonore,tempra arguto usignol concenti alteri;
scherzan Flora e Giunon, gli augelli e l’ore,ma trasfonde per gli occhi entro a’ pensieri,co i scherzi suoi fiamme voraci Amore.
1-2: Frisso ed Elle erano figli di Atamante (figlio di Eolo e re di Tebe) e Nefele. La seconda moglie di Atamante, Ino, prese in odio i figliastri, i quali riuscirono a scampare alla morte fuggendo su un ariete alato dal vello d’oro che li portò oltre il mare. Elle, a causa delle vertigini, cadde nel tratto di mare che fu poi chiamato ellesponto, Frisso giunse invece salvo nella Colchide, presso la corte di eete. L’a-riete fu offerto in sacrificio a Zeus e il suo vello d’oro fu appeso nella Colchide sotto la sorveglianza di un drago.
8. Eolo: dio dei venti.11. tempra: modula.12. Flora e Giunon: Flora, dea dei fiori e della primavera; Giuno-
ne, moglie di Zeus. Il mito ovidiano le vuole unite, in quanto Giunone, contrariata dalla nascita di Atena senza madre (la dea era stata par-torita direttamente dalla testa di Zeus), decise di generare un figlio senza padre; sfiorando un’erba prodotta per lei da Flora, diventò gra-vida e generò Marte, il dio della guerra.
Sonetti
166
XXXvii
Sonetto di raro schema invertito nella fronte aBBa-BaaB cdcdcd. Rima ricca ai vv. 1:6, 4:7, derivativa ai vv. 2:3, identica ai vv. 12:14; richiami rimici interni in -or sono presenti ai vv. 1:2:4:11. Le agglutinazioni bina-rie, sostantivali, aggettivali o verbali connotano il ritmo dell’endecasillabo, ben articolato nelle forme accentati-ve, in particolare nelle quartine.
Il componimento richiama l’antico detto secondo il quale gli stolti sono dominati dalla presunzione, mentre gli uomini saggi, padroneggiando l’orgoglio, sono gover-nati dalla vera modestia.
antonio de’ roSSi
167
al molto reverendo don Giovanni vincenzo Boenzi.
L’ignorante superbo e il savio modesto.
Pien di fasto e fragor, gonfio torrentepiú non cape in sé stesso e fuor si spinge,del natio letto i sassi urta e respinge,e gli armenti e i pastor vien che spavente;
ma pur se i mari ad emular s’accinge,alto fondo non ha l’onda corrente;quant’ei frema orgoglioso, anco sovente,rozza man l’imprigiona e ’l frena e stringe.
Corre un fiume real, profondo e vasto,placido sí ch’altrui rassembra immoto,quanto ricco d’umor, pover di fasto:
per l’un s’esprime chi di scienza vòto,sovra i dotti presume e fa contrasto,per l’altro uom saggio che d’orgoglio è vòto.
1. Per la combinazione agg.+sost. alla fine del verso, cfr. G. Fon-tanella, Ode, III, All’illustriss. sig. Don Carlo Della Gatta, Mastro di campo per la Maestà Catolica nelle turbulenze d’Italia, v. 85: «Scen-dea, qual torvo in mar gonfio torrente».
2. cape: latinismo, entra; è contenuto.7. quant’ei: per quanto egli.9. fiume real: anticamente era ritenuto fiume reale dai poeti quel-
lo che fa capo in mare, cfr. nota 3, son. XIII.
Sonetti
168
XXXviii
Sonetto di schema variato aBBaaBaB cdcdcd. Rima derivativa ai vv. 1:4; ricca ai vv. 2:8, 3:6. La do-minanza nelle quartine della rima interna in -ar, ai vv. 1:3:6:7, insieme alle omofonie diffuse semplificano il rapporto della scansione, indipendentemente dalla fun-zione distintiva tra i singoli lessemi.
Il componimento si gioca sulla metafora del pasto-re (il vescovo) che recupera il suo gregge - avvolto, me-diante una metafora dantesca, nella morte dello spirito (mortal sonno) - e della sua vittoria sulla minaccia ope-rata dal dio del male (vv. 7-8).
Giovan Battista Ventriglia fu apprezzato per le sue doti umane e per la sua cultura, fu vescovo di Caserta dal 1660 fino al 1662, anno della sua morte (23 dicem-bre).
antonio de’ roSSi
169
All’illustrissimo monsiGnor ventriGlia,vescovo di caserta.
Saggio pastor, ch’a invigilar sei vòlto,su questo errante e piú negletto ovileche, dianzi al vaneggiar d’aura gentile,crebbe e si giacque in mortal sonno avvolto,
o qual vegg’io stuol rilucente e foltoteco rinovellar l’antico stile?e per te rintuzzar l’orgoglio stoltodel gran lupo di Stige ingordo e vile?
Al sacro suon de le tue voci io scernoarder di zelo i piú gelati corie, in un confuso inoridir l’inferno,
destansi a’ detti tuoi celesti ardori,per cui vien che, racceso il lume interno,in alta guisa il divin regno onori.
9. scerno] soerno
1. invigilar: vigilare, vegliare.4. mortal sonno: stato d’incoscienza. Cfr. d. aliGhieri, Inf., vv.
11-12: «tant’era pieno di sonno a quel punto / che la verace via ab-bandonai».
7-8: lupo di Stige: il diavolo; ma anche simbolo della brama di ric-chezza, la maggior nemica della felicità umana e dell’ordine sociale, cfr. d. aliGhieri, Inf., VII, vv. 6-8: «e disse: «Taci maladetto lupo; / consuma dentro te con la tua rabbia».
9. scerno: vedo.10. per similitudine, cfr, t. tasso, Rime, II, A la serenissima ma-
dama Leonora d’Este, v. 11: «accenderebbe i piú gelati cori».
Sonetti
170
XXXiX
Sonetto di raro schema invertito nella fronte aB-BaaBBa cdcdcd. rima ricca ai vv. 9:11.
Ivone o Ivo (Yves in francese) Helory de Kermartin, patrono degli uomini di legge, dei giudici e dei docenti di discipline giuridiche, studiò, prima ad Orlèans, poi a Parigi alla Sorbona e fu discepolo di San Buonaventu-ra. Giovanissimo ottenne il delicato incarico di giudice ecclesiastico, che svolse con grande impegno, ma soprat-tutto con profonda umiltà; chiamava sé stesso: «il piú meschino dei servi di Cristo». Quando era a parigi, si venne a sapere un giorno che aveva lasciato il proprio letto a due giovani orfani da lui raccolti e ospitati. Lo stimato giudice ecclesiastico dormiva sul pavimento, so-pra un mucchietto di strame, con un cilicio attorno alla vita. Il Vescovo di trèguier volle con sé lo straordinario giurista, convincendolo ad accettare l’ordine sacerdota-le, e come prete Sant’Ivone continuò con maggiore zelo e piú profonda carità la sua attività di avvocato. Avvocato soprattutto dei poveri, che difendeva gratuitamente e anche brillantemente, sfoggiando tutta la versatilità del suo ingegno vivace. Nobile di nascita, fece del castello di famiglia un ospizio, ospedale, orfanotrofio, asilo, refetto-rio e perfino bagno pubblico di tutti i poveri, i disgrazia-ti, i malati, gli orfani della regione. Il Santo dormiva in mezzo a loro, ma steso per terra, con la testa appoggiata sopra un grosso volume di diritto. Si ridusse a vestire di cenci, avendo donato ogni cosa. Sempre oberato di in-carichi, riusciva a predicare in diverse parrocchie, che raggiungeva a piedi. La sua vita operosa e combattu-ta e soprattutto le aspre penitenze, consumarono pre-sto la fibra di Sant’Ivone. Dovette rinunciare alla pro-fessione e si dedicò solo ai poveri. Presto si ammalò e non potendo piú aiutarli materialmente, li soccorse con i continui miracoli che si sprigionavano dal suo corpo
antonio de’ roSSi
171
piagato. Quando morí, il 19 maggio del 1303, non an-cora cinquantenne, i poveri furono i primi a piangerlo, non come sapiente giurista, non come loro avvocato, ma come loro padre; divenne in breve tempo uno dei Santi piú popolari della Francia del nord e patrono degli uo-mini di legge. Scrisse molto sulle leggi, e il suo Decretum ebbe una notevole influenza sul diritto canonico. Dalle sue parti ancora aleggia il detto: Sanctus Yvi erat Brito / Advocatus et non latro / Res miranda populo (Sant’Ivo era Bretone / avvocato e non ladro / una meraviglia agli occhi del popolo). Cfr. anche il son n. 7.
Sonetti
172
S. Ivone, patrocinando le cause de’ poveri fa restar vinta la calunnia.
premea, di ree menzogne armata il seno,il gran soglio d’Astrea la fraude e, i vanniporgendo audace a i mal concetti inganni,tenea del dritto i giusti imperi a freno.
Qui, mentre sparsa di mortal veneno,traea su ’l men potente iniqui affanni,sotto ’l gioco de gli empi e de’ tiranniil tradito dover cade e vien meno.
Quando, a pro de’ mendici e de gli oppressi,vibrò pietoso Ivon spada eloquente e i sofismi atterrò da l’empia espressi;
allor ch’ei strinse in doppio zelo ardentela calunnia de i fori, i fori istessidiér lieti applausi a l’orator vincente.
tit. patrocinando] patrocinado. 6. potente] pontente
2. Astrea: dea della giustizia; vanni: ali4. dritto: diritto; imperi: 9. mendici: poveri.
antonio de’ roSSi
173
Xl
Sonetto di schema variato nella fronte aBaBaBBa cdcdcd. Rima ricca ai vv. 1:8, 3:5; derivativa ai vv. 9:11. Diffusi richiami nella forma apocopata -or caratte-rizzano le quartine ai vv. 1:5:6:7, assonanzati con i rin-vii in -on delle terzine (vv. 10:12), accompagnati dalla repetitio della preposizione per ai vv. 9:11, unitamen-te a quella dell’aggettivo dimostrativo ai vv. 10:13. La distribuzione delle omofonie evita segmentazioni nella cadenza, originando una compattezza fonica che rende l’endecasillabo, in particolare nelle zone centrali, forte-mente coeso nelle geometrie ritmiche che le unità lessi-cali contigue generano.
Il componimento s’ispira a un evento citato da erodo-to (Storie, V, cap. 25).
Sonetti
174
Cambise decollò Sisanne, giudice iniquo, e della pelle di lui coprí il tribunale e in quello pose a giudicar il figlio
Ottone*.
Usò costui di tòr la pelle a i vivi,giudice no, ma ladro empio e rapace;dunque è dover che di sua pelle il privie spaventi i malvagi Astrea sagace;
la sentenza a sé stesso or detti e scrivi egli co ’l sangue del suo cor vorace;quinci, a terror di reo ministro audace,la propria fama immortalmente avvivi.
Di lui la pelle per trofeo del giustovesta e orni quel tron, s’ei di decorol’osò spogliar per ingordigia ingiusto;
qui segga il figlio e raggion porga e il foroapprenda omai ch’è ben quel seggio augfonte del dritto e non d’argento e d’oro.
* Nella trascrizione si è lasciato Ottone per otane.Il padre di otane (tra i persiani piú illustri per nascita e condizio-
ne), Sisamne, uno dei giudici reali, era stato condannato a morte dal re Cambise, per aver emesso in cambio di denaro una sentenza ingiu-sta (vv.1-2). Cambise lo aveva fatto scorticare e la sua pelle, tagliata a strisce, fatta distendere sul trono sopra cui ci si sedeva per ammi-nistrare la giustizia (vv. 2-11). Nominò giudice, in vece di Sisamne, il figlio, con l’invito a ricordarsi su quale trono sedeva, in qualità di amministratore della giustizia (vv. 12-14).
175
rimario
Si riportano i versi interi, elencati in ordine alfabetico a se-conda della desinenza (iniziando naturalmente dall’ultima vocale tonica).
ace Dunque, è ragion che in lui quiete e pace (XXV 9) s’aggiri per camin torto e fallace (XXV 11) del mondo ad onta e di pluton mendace (XXV 13) entro l’uom, mentr’ei vive, accolto giace (XXVII 2) ossequïoso un vario stuol soggiace (XXVII 4) se materia fabril, dura e tenace (XXVII 5) in lei, ch’ osa turbar l’interna pace (XXVII 7) giudice no, ma ladro empio e rapace (XL 2) e spaventi i malvagi Astrea sagace (XL 4) egli co ’l sangue del suo cor vorace (XL 6) quinci, a terror di reo ministro audace (XL 7)
accio Sciolti i spirti in sospir, le membra in ghiaccio (XXX 9) egli cader lasciossi a morte in braccio (XXX 11) questa avvinta trovossi in ferreo laccio (XXX 13)
ada tratta e vibra ben sí vindice spada (XVII 2) ma pur con vóto, ch’ella a pien non cada (XVII 3) sue leggi altrui nell’Attica contrada (XVII 6) ei co’ dragoni a soggiornar sen vada (XVII 7)
ade Artefice miglior, vera umiltade (XVIII 10) porta a i lucidi onor d’aurea bontade (XVIII 12) tra le piaghe e gli oltraggi unqua non cade (XVIII 14)
aGa partenope, non piú festosa e vaga (IX 10) E di piú fieri scempi omai presaga (IX 12) il suo grembo gentil di pianto allaga (IX 14)
ai scerse del sol, che ’l sol vince d’assai (VI 10) scovrir del sol, non ancor nato, i rai (VI 12)
176
meraviglie maggior chi vide mai (VI 14)
ale contro a l’orrida fame, esca vitale (IV 2) di cibo eletto, in quel digiun mortale (IV 3) virtú, che pari ha ’l nome e ’l merto eguale (IV 6) co ’l pan, ch’ei custodí, sacro, immortale (IV 7) anzi, inganno e menzogna e il viver frale (XX 10) Sol può d’alta virtú raggio vitale (XX 12) beata eternità, soglio immortale (XX 14)
ali Luce sparsa di rai puri, immortali (XXVI 1) e viva imago in lei, de’ suoi vitali (XXVI 3) ma, qual per nubi il sol da’ sensi frali (XXVI 5) da ’l vapor de gli affetti egri e mortali (XXVI 7)
alto mesto il vulgo sospira, asceso in alto (XIII 13) de la fame e del fiume il doppio assalto (XIII 14)
ane a larve intende ingannatrici e vane (II 10) Fra gli incendi il desío cieco rimane (II 12) d’ombre ei si pasce e di menzogne insane (II 14)
anni il gran soglio d’Astrea la fraude e i vanni (XXXIX 2) porgendo audace a i mal concetti inganni (XXXIX 3) traea su ’l men potente iniqui affanni (XXXIX 6) sotto ’l gioco de gli empi e de’ tiranni (XXXIX 7)
ano Che s’al Cigno di Manto, il pio troiano (XI 9) recar ne’ pregi suoi vanto sovrano (XI 11) la prisca età? Questi, ch’al cielo ispano (XI 13) Ambo son ciechi e pur su l’aer vano (XV 9) l’altro, al vulgo, altrettanti apre su ’l piano (XV 11) e pur ad ambi il vasto orgoglio insano (XV 13) nel corpo uman l’onnipotente mano (XXVIII 10) ma per l’altrui sciocchezza, oprossi in vano (XXVIII 12) ardisce di versar medico insano (XXVIII 14)
ante Qual or tentò su l’Aquilon stellante (XXIX 1)
riMario
177
cadde fra i cupi abbissi, ove, a l’errante (XXIX 3) fermò Tomaso, in sua virtú costante (XXIX 5) e a nume immortal fatto sembiante (XXIX 7)
anto ardor, ché il sen m’infiammi e spegna, in tanto (I 10) e dritto è ben, ché s’al tuo fido e santo (I 12) si stempri omai per i tristi occhi in pianto (I 14) Vinse il mondo e sé stesso e, in doppio vanto (XXXIV 9) di sirena mortal racchiuse al canto (XXXIV 11) or cinto il fregia, di stellato ammanto (XXXIV 13)
ardo Fatto de’ propri scempi avido il guardo (II 9) ’l vago ammira d’un color bugiardo (II 11) reso a i lumi celesti ottuso e tardo (II 13)
aso Pietade apprende dall’orribil caso (XIX 9) del puro angel di Dio vien persuaso (XIX 11) sí che, d’elezion già fatto vaso (XIX 13)
asto Corre un fiume real, profondo e vasto (XXXVII 9) quanto ricco d’umor, pover di fasto (XXXVII 11) sovra i dotti presume e fa contrasto (XXXVII 13)
ata da le spume del mar Vener già nata (X 1) ch’ or muove in te sedizïon malnata (X 4) Quella, al popol di Gnido in pregio e grata (X 5) questi, a gli applausi d’una plebe ingrata (X 7)
ate Che in piú degni Mausoli e in piú lodate (XXXII 9) convien, Diana, a la fugace etate (XXXII 11) cantin le glorie in Pindo aure beate (XXXII 13)
ea Fier padrigno e’ il rigor, la madre Astrea (XVII 1) rechi terror, non stragge acerba e rea (XVII 4) Co ’l sangue già solo un Dracon scrivea (XVII 5) che l’uman dal ferin non distinguea (XVII 8) tra’ primi e tra’ maggiori in ciel splendea (XIX 2) ne’ tetri abissi, empia alterigia e rea (XIX 4)
riMario
178
diverso? E ’n quai tormenti il fier cadea (XIX 6) pria nel candor l’istesso sol vincea (XIX 7) co ’l pio Ridolfi ogni suo pregio avea (XXXIII 2) le voci al duol sí la virtú sciogliea (XXXIII 4) dal gran sol de l’empiro altrui porgea (XXXIII 6) s’involse pur da ecclissi infausta e rea (XXXIII 8)
ede e ’l moto ai boschi il Tracio Orfeo già diede (XXI 1) a l’aspre sere, entro a selvaggia sede (XXI 3) traendo ai carmi ossequïoso il piede (XXI 5) non piú le vite altrui, vien, che deprede (XXI 7) se di pregio e di lume altrui non cede (XXIII 10) questa, ch’ al sol si specchia e qui presiede (XXIII 12) piú chiara splende e in te se stessa eccede (XXIII 14) lume eccelso annidar celeste fede (XXXIII 10) Lui che ’l fasto mortal presse co ’l piede (XXXIII 12) or fra gli eterni divi eterno siede (XXXIII 14)
edi da i ricchi alberghi i prezïosi arredi (XIII 10) co i venti in lega le procelle or vedi (XIII 12)
eGGe che ’l ciel creò di nulla e ’l tutto regge (XXV 2) il cui centro è destin, la voglia è legge (XXV 4) un vital lume i sensi in noi corregge (XXV 6) lume in virtú di cui l’uom vede e legge (XXV 8)
eGGia tra pompe allettatrici, erra e vaneggia (XXIV 2) menzogna e fraude i sensi tiranneggia (XXIV 4) per le piagge del ciel rugge e lampeggia (XXIV 6) v’è presso a l’onde chiare un pin frondeggia (XXIV 7)
eGi erga moli superbe e i vanti egregi (XXXII 1) e in urne eccelse i suoi famosi regi (XXXII 3) d’un volto esangue e reverito i pregi (XXXII 6) e le pallide membra altrui ne fregi (XXXII 8)
eGne giú spinto, uom cade in varie colpe indegne (XXII 2) e ’l fallo, omai sotto l’infauste insegne (XXII 3)
riMario
179
Chi l’etiope imbiancar fia che s’ingegne (XXII 6) splender d’un chiaro di luci ben degne (XXII 8)
eGno Quegli da carcer tetro assunto al regno (IV 9) per umiltà, d’eccelse glorie al segno (IV 11) l’altro a quel Grande d’Imperator fu degno (IV 13) scorgeasi in alto mar sorpreso il legno (V 2) contro al sacro nocchier fremer di sdegno (V 4) voragin vaste, entro ’l ceruleo regno (V 5) foschi nembi eccitar d’orgoglio indegno (V 7) ove d’alta umiltà fatto sostegno (VII 9) aspira a i seggi de l’empireo regno (VII 11) e ’l Cielo istesso, di vittoria in segno (VII 13)
ela di Vergin Madre, al precursor si svela (XXXV 2) nuncio alato a i pastor tosto il rivela (XXXV 4) Vien circonciso e, mentre a’ suoi si cela (XXXV 6) a l’eterna giustizïa arde e anela (XXXV 8)
ella quando a l’aura vital diva novella (III 9) (eletta in madre) offriasi al verbo ancella (III 11) disse: «or, che splende in lei luce sí bella (III 13)
elle l’empio stuol de’ giganti al ciel ribelle (VII 2) de l’aurea luce impoverir le stelle (VII 3) che irato il ciel vibrò strali e facelle (VII 6) e, tra ’l fragor di torbide procelle (VII 7) Sotto il monton, che già di Frisso e d’elle (XXXVI 1) di vaghi fior pompe odorate e belle (XXXVI 4) non ha con tante il ciel tremule stelle (XXXVI 5) per non turbar le sue beltà novelle (XXXVI 7)
ello Chiude al calor d’ermetico fornello (XVIII 1) e chiuso il fabro, entro a solingo ostello (XVIII 3) quel metallo a fissar troppo rubello (XVIII 6) ma l’un fugge dal foco e dal martello (XVIII 7)
riMario
180
elo sorse e, racchiusa entro a corporeo velo (III 10) qui, sparso il primo Amor d’eterno zelo (III 12) non ha la terra onde piú invidi il cielo (III 14) Di colpe infauste entro gli orrori e ’l gielo (VI 1) ancor tra i cerchi d’un virgineo cielo (VI 3) Quando, da chiusi lumi, il fosco velo (VI 5) tutto avvampò d’incomparabil zelo (VI 8) Se ministro è di Lui che regge il cielo (XVII 9) perché di lui non sembra il nobil zelo? (XVII 11) pria che si scocchi un sol fulmineo velo (XVII 13) L’aquila, che di stelle a sé fa velo (XXIII 9) quando sorge il leon, tramonta in cielo (XXIII 11) del tuo regio leon tra i lampi e ’l zelo (XXIII 13) Mosse de l’un, co ’l re di gloria in cielo (XXIX 9) pria che si scocchi un sol fulmineo >t<elo (XXIX 11) e, mentre acceso d’ammirabil zelo (XXIX 13)
ena di duol di pianto inessicabil vena (II 2) stringe i dubbi pensier ferrea catena (II 4) mentre fugge empio tosco, e s’avvelena (II 5) se la mente immortal nacque serena (II 7) Fumo e fiamma in un punto e larva e scena (XX 9) ch’ allettando il pensier deluso il mena (XX 11) donar, Lottieri, ov’ella i sensi affrena (XX 13)
ende Come ignoto velen dentro s’apprende (XII 9) vede il vulgo e ammira e non comprende (XII 11) e, come il cor si atrocemente offende (XII 13) l’umana mole, indi in furor s’accende (XXVII 10) poi cessa e lena in quel riposo ei prende (XXVII 12) l’ostil veneno, al fin, vinto si rende (XXVII 14)
ene indi, qual fiamma al fumo immista, avviene (XXVI 9) e prenda impure impression terrene (XXVI 11) onde al vero si giunge e si perviene (XXVI 13)
eni col torvo sguardo infetti e avveleni (VIII 2) per l’altrui ben, te stesso impiaghi e sveni (VIII 4)
riMario
181
fra le mie gioie a distemprar veneni (VIII 6) perché sien foschi i giorni miei sereni (VIII 8)
enne in te pompe fastose un tempo ottenne (X 2) da le spume del mar colui sen venne (X 3) di culto indegno a i primi onor pervenne (X 6) da i tempi violar non si contenne (X 8)
eno Sovra il Carro di stelle, il puro seno (III 1) né de’ lumi dorati il bel sereno (III 3) Teti (a’ fieri Aquilon’ già posto il freno) (III 5) parea d’occhiute pompe ornato e pieno (III 8) non superbí questi s’alzò, non meno (IV 10) ma l’un sostenne al fin scettro terreno (IV 12) che del mondo e del ciel contempra il freno (IV 14) Gonfio da gli austri e da alterigia pieno (XIII 1) atto, ei niega il tributo al mar Tirreno (XIII 4) Al popol di Quirin minaccia il freno (XIII 5) tenta occupar del Campidoglio il seno (XIII 8) Uom fassi il divin Verbo e, chiuso in seno (XXXV 1) nasce in umil presepe e in grembo al fieno (XXXV 3) scuopre a i Rabbini il suo splendor sereno (XXXV 6) per l’uom ribelle in sodisfare a pieno (XXXV 7) premea, di ree menzogne armata il seno (XXXIX 1) tenea del dritto i giusti imperi a freno (XXXIX 4) Qui, mentre sparsa di mortal veneno (XXXIX 5) il tradito dover cade e vien meno (XXXIX 8)
ensi Spirto rettor de gli organi e de’ sensi (XXVII 1) a cui di vari spirti in vita accensi (XXVII 3) vien, che in noi s’introduca o si condensi (XXVII 6) arma ei di freddo alti rigori intensi (XXVII 8)
ente lungi, sgombra empia erinni, angue nocente (VIII 9) gli orsi e le tigri col tuo fiato ardente (VIII 11) qui batti a voto il formidabil dente (VIII 13) Pien di fasto e fragor, gonfio torrente (XXXVII 1) e gli armenti e i pastor vien che spavente (XXXVII 4)
riMario
182
alto fondo non ha l’onda corrente (XXXVII 6) quant’ei frema orgoglioso, anco sovente (XXXVII 7) vibrò pietoso, Ivon, spada eloquente (XXXIX 10) all’ or ch’ei strinse, in doppio zelo ardente (XXXIX 12) dier lieti applausi a l’orator vincente (XXXIX 14)
enti Marin guerriero anzi a i squamosi armenti (IX 1) in riva al bel Tirren, seguaci ardenti (IX 4) di faci armati a divorar gli argenti (IX 6) resi d’alto furor sciolti torrenti (IX 7) qui lieto al suon di non fallaci argenti (XXIV 9) d’innocente usignuol godo a i concenti (XXIV 11) Giovanni, al mio desio vani portenti (XXIV 13)
ento in cavo vetro, un fuggitivo argento (XVIII 2) a’ folli magisteri irrita il vento (XVIII 4) Versa fumo e sudor, cupido e intento (XVIII 5) l’altro fisso riman nel suo tormento (XVIII 8)
eri Ben la madre di lui gli influssi alteri (VI 9) e al nuovo prodigio erse i pensieri (VI 11) svelar, chiuso ne l’alvo, alti misteri (VI 13) Già tarpate le piume a i nembi fieri (XXXVI 9) tempra arguto usignol concenti alteri (XXXVI 11) ma trasfonde per gli occhi entro a pensieri (XXXVI 13)
ermi L’alta pugna, ove tra campi inermi (XXXIV 1) or vacilla a gli assalti ed ora a i schermi (XXXIV 4) mosse Vincenzo di robusti e fermi (XXXIV 5) che insorse al vaneggiar de’ sensi infermi (XXXIV 8)
erno Al sacro suon de le tue voci io scerno (XXXVIII 9) e, in un confuso inoridir l’inferno (XXXVIII 11) per cui, vien, che racceso il lume interno (XXXVIII 13)
ero quinci il Vesevo e quindi il Tebro altero (XV 2) l’un di fumanti ardor campo guerriero (XV 3) Questi, premendo la città di piero (XV 5)
riMario
183
su Partenope vaga, acerbo e fiero (XV 7) Lungi da tetti aurati ove il pensiero (XXIV 1) e dal regno de i cor, bandito il vero (XXIV 3) or che ’l Nemeo leon, sdegnoso e fiero (XXIV 5) de’ miei stanchi pensier seggo a l’impero (XXIV 8)
ese dal mar crudele e l’una e l’altro apprese (X 10) Gli erari e gli ori a divorar intese (X 12) l’una d’amor, l’altro di sdegno accese (XII 14)
essi Quando, a pro de’ mendici e de gli oppressi (XXXIX 9) e i sofismi atterrò da l’empia espressi (XXXIX 11) la calunnia de i fori, i fori istessi (XXXIX 13)
esso scuote i torbidi vanni il segno istesso (XVI 10) Veggo il fervido Marte anch’ei depresso (XVI 12) e vaste piogge e steril messe appresso (XVI 14)
esta or sensi in noi d’irsuta belva innesta (XXI 10) cieca fiamma ne i cor per lei si desta (XXI 12) e rogo indegno a le virtú s’appresta (XXI 14)
este A franger legni, ad eccitar tempeste (X 9) a far le gioie altrui naufraghe e meste (X 11) nei palaggi e ne i cor fiamme funeste (X 13) Tolta di grembo a Pluto, orrida peste (XII 1) vibra ne’ petti altrui fiamme funeste (XII 4) Da chiusi alberghi, sbigottite e meste (XII 5) se fugge il piè, vien che la vita arreste (XII 8)
eve dal tatto solo, anzi, da un fiato lieve (XII 10) come serpa e s’avvanzi in spazio breve (XII 12) ch’ei si dilegui, come al sol di neve (XII 14)
ezza Francesco e a seguir l’umil bassezza (XIX 10) in un gli ori e gli onori ei fugge e sprezza (XIX 12) poggia del ciel sovra eminente altezza (XIX 14)
riMario
184
ica Mossa per man fedel cetra impudica (XXI 9) e, tra lascivi error, gl’animi intrica (XXI 11) onde incendio mortal s’erge e nutrica (XXI 13)
ici Corrono a depredar l’onde vittrici (XIII 9) e ’l tutto empion d’orror, qual furie ultrici (XIII 11)
ide Stupí l’egitto, ove apprestar si vide (IV 1) le turbe afflitte, il saggio ebreo provide (IV 4) E questi, a cui fan pompa illustri e fide (IV 5) vien, che mille alme ristorar confide (IV 8) e di Smirna al cantor, valle pelide (XI 10) che fia per questi, a cui maggior non vide (XI 12) sorse novel, ma piú sagace, Alcide (XI 14)
ile su questo errante e già negletto ovile (XXXVIII 2) che, dianzi al vaneggiar d’aura gentile (XXXVIII 3) teco rinovellar l’antico stile (XXXVIII 6) del gran lupo di Stige ingordo e vile (XXXVIII 8)
ime splendido astro di luce, angel sublime (XIX 1) ma ’l trasse giú da quelle eccelse cime (XIX 3) O qual divien da le sembianze prime (XIX 5) orrida notte or nel suo volto esprime. (XIX 8)
inGa senz’oltraggio temer di rea lusinga (XXIV 10) e qui non vien ch’ambizion dipinga (XXIV 12) né ch’infida beltà m’allaccia e stringa (XXIV 14)
inGe piú non cape in sé stesso e fuor si spinge (XXXVII 2) del natio letto i sassi urta e respinge (XXXVII 3) ma pur se i mari ad emular s’accinge (XXXVII 5) rozza man l’imprigiona e ’l frena e stringe (XXXVII 8)
inta rieve la mente or vincitrice, or vinta (XXXIV 2) è in dubbie imprese la ragion sospinta (XXXIV 3) arnesi d’umiltà, l’alma ricinta (XXXIV 6) ogni larva atterrò bugiarda e finta (XXXIV 7)
riMario
185
inte Del sacro monte le delizie estinte (XXXI 9) e quindi a dipartir vedeansi accinte (XXXI 11) Diego nel suo morir le parche ha vinte (XXXI 13)
io cui l’alme a trar dal ruginoso oblio (XI 2) infiamma i bei pensier nobil desio (XI 3) furor v’accenda del castalio dio (XI 6) gloria piú rara, il dolce stil natio (XI 7) temeraria tenzon, l’empio desio (XXIX 10) l’altro, i dovuti onor chiuse in oblio (XXIX 12) un dio sol chiede in premio, ottenne un dio (XXIX 14) trovi, e, fuora di lui, l’uman desio (XXV 10) se da quell’un, Follieri, ogn’ alma uscio (XXV 12) convien che rieda e sol riposi in Dio (XXV 14) Questo a’ formar vari instrumenti ordio (XXVIII 9) e ’l passo a lui per tutti i membri aprio (XXVIII 11) quel tesor che di vita a l’uom fe’ Dio (XXVIII 13)
ira per l’italico suol move e s’aggira (XII 2) spira stigi aneliti e, mentre spira (XII 3) le turbe a i campi ella sospinge e tira (XII 5) ma ’l contagio mortal, che in lor conspira (XII 6) di sdegno ardendo, il fier Vesevo, e d’ira (XIV 2) globi al ciel di faville avventa e spira (XIV 4) sulfurei nembi d’ogni intorno aggira (XIV 6) vasti macigni incenerir si mira (XIV 8) Temprò tal or l’armonïosa lira (XXI 1) lo stil canoro, umani sensi inspira (XXI 4) l’orso e il leon lascia>n< l’orgoglio e l’ira (XXI 6) l’angue, né tosco avventa e morte spira (XXI 8)
iri Ma, ah, non dovea fra questi bassi giri (XXXIII 9) doveasi a chi dal ciel trasse i desiri (XXXIII 11) qua giú, premendo i lucidi zaffiri (XXXIII 13)
iro L’angue immortal che, co ’l perpetuo giro (XVI 1) divora il giel che gli aquiloni ordiro (XVI 4) Gli usci del ciel Febo e Saturno apriro (XVI 5)
riMario
186
branche su questi, ebro di sdegno io miro (XVI 8)
isa in sé stessa sconvolta e in sé divisa (IX 9) or tutta è duol nel proprio sangue intrisa (IX 11) su meste arene, in bruna spoglia assisa (IX 13)
issi Le braccia e i piedi a duro tronco affissi (XXX 1) e ’l rettor minacciò de’ scuri abissi (XXX 4) pelia e olimpo al gran duello aprissi (XXX 5) s’ascose il sol con portentosa ecclissi (XXX 8)
iste l’onde cerulee tue sparse e commiste (XXXI 2) di pindo ordir le vergini fur viste (XXXI 4) ma venner poscia lacrimose e triste (XXXI 5) È, immortal cigno, in ciel, Diego, gl’apriste (XXXI 8)
ita Fiamma gentil ch’ è spirto insieme e vita (XXVIII 1) sí pura alimentar luce gradita (XXVIII 4) quel chiuse in vene, a cui l’arteria unita (XXVIII 5) veste gli fabricò, forte e munita (XXVIII 8) perché ella resti in sua region schernita (XXX 10) vincer stimò, ma follemente ardita (XXX 12) cosí di morte trïonfò la vita (XXX 14)
ito Mostro inuman, che d’Acheronte uscito (VIII 1) e, d’odio sparso e da livor ferito (VIII 3) qual cerbereo furor ti rende ardito (VIII 5) Qual ti lusinga barbaro appetito (VIII 6) Quel buon, quel grande, immenso e infinito (XXV 1) onde il gonfio ocean si frange al lito (XXV 4) il centro è ben, da le cui linee ordito (XXV 5) quel bello in sé ch’ei vi stampò co ’l dito (XXV 8)
iva con bell’acqua si diè, purgata e viva (XXiii 2) e versar d’Ippocrene, in su la riva (XXiii 3) lei che in Atene e su gli ingegni e diva (XXiii 6) per te vedrem l’aurea sapienza argiva (XXiii 7)
riMario
187
ive piansero allor quelle famose dive (XXXI 10) quando d’alto s’udir voci festive (XXXI 12) in Giovanni e in Alfonso eterno ei vive (XXXI 14)
ivi Usò costui di tòr la pelle a i vivi (XL 1) dunque è dover che di sua pelle il privi (XL 3) la sentenza a sé stesso or detti e scrivi (XL 5) la propria fama immortalmente avvivi (XL 8)
ivo trassi i verdi anni in libertà captivo (I 2) vissi al tuo nume e a me stesso a schivo (I 4) or che in me volgi il guardo eterno e divo (I 5) sottraggo a morte e nel tuo spirto avvivo (I 8)
oce ora al gran padre, e per l’affanno atroce (XXXV 9) soffre e porta al Calvario, indi, la croce (XXXV 11) sedi sen poggia, e qui, per la sua voce (XXXV 13)
oi il gran padre de’ lumi accese in noi (XXVIII 2) di vivo sangue, ei si compiacque poi (XXVIII 3) ministra alta virtú co’ i spirti suoi (XXVIII 6) e, perché oltraggio ostil qui non l’annoi (XXVIII 7)
olGa aria d’estinto eroe tra marmi accolga (XXXII 2) vaga d’eterni onor, Menfi raccolga (XXXII 4) onde al vorace oblio spegner si tolga (XXXII 5) il Ponto arabe stille aduni e colga (XXXII 7)
olto Se tra lacci funesti il piede avvolto (I 1) e fiso a i lampi d’un volubil volto (I 3) anch’io, padre del ciel, ver te rivolto (I 6) il cor, pur dianzi in cieco error sepolto (I 7) giaceasi il mondo orribilmente involto (VI 2) de l’umana salute il sole accolto (VI 4) nel sen materno, al precursor disciolto (VI 6) egli al verbo fatt’uom siso e rivolto (VI 7) Saggio pastor ch’a in vigilar sei volto (XXXVIII 1) crebbe e si giacque in mortal sonno avvolto (XXXVIII 4)
riMario
188
o qual vegg’ io stuol rilucente e folto (XXXVIII 5) e per te rintuzzar l’orgoglio stolto (XXXVIII 7)
olve de gli anni il corso e i nostri giorni involve (XX 2) e ’l tempo predator disperge in polve (XX 3) scettri, mitre e diademi in cener solve (XX 5) ch’entro a spazi vitali in noi si volve (XX 8)
omBra riviè chi fiso il guarda o macchia od ombra (XXII 10) se, dunque, altrui men grave eccesso adombra (XXII 12) di lui che ’l tron de la giustizia ingombra (XXII 14)
onde Sotto pallide nubi il ciel s’asconde (XIV 9) sono i venti sospir, lagrime l’onde (XIV 11) spiega del bel Tirren su l’ampie sponde (XIV 13)
ondo sembra anelar, tra ’l chiuso orror profondo (V 10) quando il tuo raggio di virtú fecondo (V 12) calma insperata al naufragante mondo (V 14) opra umana è il fallir de’ sensi al pondo (XXII 1) intiero accoglie, incatenato il mondo (XXII 4) Chi mai vide ingemmarsi il fango immondo (XXII 5) Anzi, chi vedrà su l’Erebo profondo (XXII 7) per l’ondoso sentier mal resse il pondo (XXXVI 2) dispiega a noi ringiovanito il mondo (XXXVI 3) quante liete ghirlande ha il suol fecondo (XXXVI 6) lega i fiati nevosi polo giocondo (XXXVI 8)
one per sublime virtú gigante Ivone (VII 10) vince in sí degna e sí gentil tenzone (VII 12) gli ordí con le sue fiamme auree corone (VII 14) D’ira accesi e di sdegno, ecco a tenzone (XV 1) l’altro umor procellosi a terra espone (XV 4) a lei che ’l pose al mondo il giogo impone (XV 6) quegli nembi voraci alza e compone (XV 8)
onte Stimò tal or, con monte imposto a monte (VII 1) e fulminar chi fulminò Fetonte (VII 4)
riMario
189
ma in van di folle orgoglio armò la fronte (VII 5) scuotendo il suol, puní i superbi e l’onte (VII 8) Anco nel sol, che d’aurea luce è fonte (XXII 9) né quinci egli usa di celar la fronte (XXII 11) le voglie al compatir non sia men pronte (XXII 13)
ore s’apre ne’ petti altrui, per man d’Amore (II 1) e, in ghiaccio ardente, anzi, in gelato ardore (II 3) vere dolcezze a sé promette il core (II 6) sé stessa involve entro a penoso orrore (II 8) al dolce mormorio d’onde sonore (XXXVI 10) scherzan Flora e Giunon, gli augelli e l’ore (XXXVI 12) co i scherzi suoi fiamme voraci, Amore (XXXVI 14)
ori Voi, del vago tirren cigni canori (XI 1) gli eroi fregiando d’immortal allori (XI 4) del gran Guevara ad eternar gli onori (XI 5) trarrà di lui tra i bellici fulgori (XI 8) l’un disserra mille occhi a’ ciechi ardori (XV 10) d’ambi assordano il ciel gli alti fragori (XV 12) frenan due sacri e singolar pastori (XV 14) chi giudice è fra noi de’ nostri errori (XVII 10) Quanti s’odono in ciel vasti fragori (XVII 12) che fere i monti, se spaventa i cori (XVII 14) Sublime eroe, cui fecondar gli allori (XXIII 1) d’eloquente saper fiumi canori (XXIII 4) per te sorger vedrassi a’ primi onori (XXIII 5) mille sparger fra noi vivi fulgori (XXIII 8) guise involar di tua virtú gli onori (XXIII 10) a te, fra l’ombre de’ piú culti allori (XXIII 12) sien tempio i cieli e viva tomba i cori (XXIII 14) Allor che furo entro a i castali umori (XXXI 1) nuova armonia tra quei ben culti allori (XXXI 3) e di permesso inaridirsi i fiori (XXXI 6) che i tuoi lumi chiudesti a i nostri orrori (XXXI 8) l’orecchie intese ad armonie migliori (XXXIV 10) ma se in terra ei sdegnò terreni onori (XXXIV 12) corona in ciel di sempiterni allori (XXXIV 14)
riMario
190
arder di zelo i piú gelati cori (XXXVIII 10) destansi a’ detti tuoi celesti ardori (XXXVIII 12) in alta guisa il divin regno onori (XXXVIII 14)
oro vesta e orni quel tron, s’ei di decoro (XL 10) qui segga il figlio e raggion porga e il foro (XL 12) fonte del dritto e non d’argento e d’oro (XL 14)
orte avea il campion de l’alta empirea Corte (XXX 2) quando a fera tenzon sfidò la morte (XXX 3) de la stigia città tremar le porte (XXX 6) e per le vie del cielo, oblique e torte (XXX 7)
orti guerra eccitò co i canapi ritorti (IX 2) or di Marte costui rende i men forti (IX 3) corron costor, quasi in ebbrezza assorti (IX 5) fan per tutto inondar ruïne e morti (IX 8)
oso già ’l Tebro innalza il crin dal letto algoso (XIII 2) e, da fiume real, torrente ondoso (XIII 3) d’impor superbo, e co ’l suo piè fastoso (XIII 6) egli ratto, non men che strepitoso (XIII 7)
ote usa dianzi i rigor’ per cui si scuote (XXVII 9) e i membri infiamma e il cuore ange e percuote (XXVII 11) sorge di nuovo e, se domar non puote (XXVII 13)
oto ch’ella abbia e fosco il lume e lento il moto (XXVI 10) Luca, or non fia stupor s’è il calle ignoto (XXVI 12) e ’l saper nostro di sapienza è vòto (XXVI 14) placido sí ch’altrui rassembra immoto (XXXVII 10) per l’un s’esprime chi di scienza vòto (XXXVII 12) per l’altro uom saggio che d’orgoglio è vòto (XXXVII 14)
uce Qual comparisse in ciel propizia luce (V 9) del navigio fedel, piangente il Duce (V 11) recar si vide, o nuovo, alto polluce (V 12) creando in noi spirò l’eterna luce (XXVI 2)
riMario
191
sembianti impresse, ond’ella arde e riluce (XXVI 4) questa involta qua giú fievol traluce (XXVI 6) o qual tetro squallore in lei s’induce (XXVI 8)
ude le vicende del mondo in sé racchiude (XVI 2) su queste rupi inorridite e nude (XVI 3) onde umor tempestoso in giú trasude (XVI 7) e lo scorpio avventar l’oblique e crude (XVI 8)
uGGi vanne a gli ermi piú fieri e quivi aduggi (VIII 10) anzi, a Cocito omai ritorna e fuggi (VIII 12) e te stesso mordendo, ivi ti struggi (VIII 14)
ume Fugge, qual nebbia al sol, qual onda in fiume (XX 1) ciò che per fasto insuperbir presume (XX 4) Morte ha strali di foco e per costume (XX 5) a i flutti de l’oblio mal regge il lume (XX 7)
umi del ciel, c’ha per pietade umidi i lumi (XIV 10) ov’ei di cener densa atri volumi (XIV 12) qui di pianto e di duol fa nascer fiumi (XIV 14) Al messagier de’ favolosi numi (XVI 9) perché i campi a inondar s’alzino i fiumi (XVI 11) fia ch’ atri nembi, indi, avvenir presumi (XVI 13)
ura solcava, di Giunon, la notte oscura (III 2) ombra tingea di fosca larva impura (III 4) ridea, vie piú che mai tranquilla e pura (III 6) e ’l ciel, nuov’Argo al parto di natura (III 7)
uro piova, da’ raggi tuoi, celeste e puro (I 9) doglioso umor, quel primo incendio impuro (I 11) lume il cor fu gran tempo algente e duro (I 13) Già del celeste uscier da nembo oscuro (V 1) et Eolo e Dori, in volto acerbo e duro (V 3) apre in lega Aquilon, con Austro impuro (V 6) il piovoso orion, l’infausto Arturo (V 8)
riMario
192
uso Sotto gelida rupe oppresso e chiuso (XIV 1) scuote l’aspra cervice, e’, in suon confuso (XIV 3) L’empio ardor che lo strugge, e fuor d’ogn’uso (XIV 5) fra le viscere sue sparso e diffuso (XIV 7) Su la gelida tomba in cui racchiuso (XXXIII 1) il crin su ’l tergo, lacero e confuso (XXXIII 3) Pur tramontò quel sol, che i raggi e l’uso (XXXIII 5) Fra cerchi angusti altro splendor diffuso (XXXIII 7)
usto Di lui la pelle per trofeo del giusto (XL 9) l’osò spogliar per ingordigia ingiusto (XL 11) apprenda omai ch’è ben quel seggio augusto (XL 13)
193
tavola metrica
aBaB.BaaB.cdcdcd. (4) i, Xviii, XXXi, XXXv.aBaB.BaBa.cdcdcd. (4) ii, v, XXvii, XXXii.aBaB.aBBa.cdc.dcd. (5) iii, vi, XiX, XXiv, Xl.aBBa.aBBa.cdc.dcd. (11) IV, VII, XI, XII, XVI, XVII, XXIII, XXV, XXVIII, XXX, XXXIV.aBaB.aBaB.cdc.dcd. (5) VIII, XIV, XXVI, XXIX, XXXIII.aBBa.BaaB.cdc.dcd. (3) IX, XXXvii, XXiX.aBBa.aBaB.cdc.dcd. (5) X, XX, XXII, XXXVI, XXXVIII.aBBa.aBBa.cdc.dee. (1) XIII.aBBa.BaBa.cdc.dcd. (2) XV, XXI.
195
indice dei sonetti
i Illustrato dalla divina grazia, si ritira dagli amori profani.
II Effetti dell’amor lascivo.III Nella nascita della Beatissima Vergine
Madre di Dio.IV San Giuseppe, sposo della Beata Vergine,
rassomigliato all’antico Patriarca Giu-seppe.
V al Patriarca san domenico. Si allude alla stella che fu veduta nel
fronte di lui quando era fanciullo e alle eresie che in quel tempo infestavano San-ta Chiesa, ripresse poi con la dottrina del Santo.
VI San Giovanni Battista riconosce il Verbo umanato dentro a l’utero materno.
VII San Ivone, cui santità fu espressa in so-gno alla madre sotto l’imagine d’un gi-gante, mentre celebrava i sacri misteri dell’altare un globo di fuoco gli circondò la testa.
VIII Contro dell’invidia.IX Masaniello d’Amalfi, vil pescatore, fatto
capo della plebe sediziosa nelle rivoluzio-ni di Napoli, sotto li 7 di luglio 1647.
X All’istessa città di Napoli agitata dalle rivoluzioni. Paragone tra Venere, dea del gentilissimo, e Masaniello d’Amalfi.
XI. S’invitano i poeti napoletani alle lodi del Signor Conte d’Oñate, per le cose da lui operate, a favor della Corona di Spagna, nelle rivoluzioni del Regno nel 1647 e 1648.
XII Descrive la peste di contagio che, nel 1656, afflisse il Regno di Napoli e gran parte dell’Italia.
pag. 88» 91
» 94
» 96
» 98
» 101
» 103» 106
» 108
» 110
» 113
» 115
introduzione
196
XIII Descrive l’inondazione del Tevere, occorsa a’ 4 di novembre 1661.
XIV Descrive l’incendio del Vesuvio seguito sotto li 3 luglio 1660.
Xv Allude all’incendio del Vesuvio e all’i-nondazione del Tevere, occorsi ambedue nell’istesso anno 1660.
Xvi al molto reverendo Padre Fra’ alBerto de’ rossi, suo Fratello.
Dall’ecclisse del sole, sotto il segno di scorpione, occorsa a’ 2 di novembre 1660 e della congiunzione dell’istesso pianeta e di Saturno, seguita a’ 6 di questo mese, sotto il segno medesimo e quivi Marte e Mercurio presagisce gran piogge, inonda-zioni di fiumi e sterile raccolto.
Xvii al siGnor alessandro GonFalone, Giudi-ce criminale della vicaria di naPoli.
Allude a quell’assioma legale: Summum ius, summa iniustitia.
XVIII al molto reverendo Padre Fra’ amBro-Gio da sorrento, Francescano.
Che l’umiltà paziente sia la vera pietra de’ filosofi.
XIX al molto reverendo Padre Fra’ amBro-Gio da Praiano, Franciscano.
Il serafico San Francesco, in virtú della sua profonda umiltà, ottiene grado eminente di gloria nel cielo.
XX al siGnore aniello lottieri. Essendo tute le cose umane caduche e
transitorie, la virtú sola può condurci ad eterne felicità.
XXi al siGnor marchese antonio solimele. La lira d’Orfeo introduceva sensi d’uma-
nità ne’ bruti e quella de’ nostri poeti lasci-vi introduce sensi di bruto ne gli uomini.
XXii al siGnor Francesco sanGiorGio vicario Generale casertano.
Che da’ giudici si devono compatire i de-licti non molto gravi.
» 117
» 119
» 121
» 123
» 125
» 127
» 129
» 131
» 133
» 135
indice dei Sonetti
197
XXiii al siGnor don Giosia acquaviva, duca d’atri, eletto in PrinciPe da Gli accademi-ci oziosi di naPoli.
Si allude all’aquila, impresa dell’Acade-mia, e al leone, armi della famiglia del Principe.
XXiv al siGnor don Giovanni de varGas. Perché piaccia all’autore trattenersi in
villa di ’state.XXV al siGnor Girolamo Follieri, matematico
insiGne. Dall’esser Dio benedetto l’unico centro di
tutte l’essenze create, avviene che in lui solo l’anima nostra si quieti.
XXvi al molto reverendo don luca tarta-Glione, teoloGo.
La mente immortale dell’esser congiun-ta al corpo mortale viene impedita a co-noscer la verità de gli oggetti.
XXvii al molto reverendo don michele ma-celli, dottor di leGGe.
Perché gli accessi della febbre siano pre-ceduti da rigori di freddo e poi segua grand’accension di calore.
XXviii al siGnor don Paulo di cordova. Che il cavar sangue a gli infermi, sia
mera sciocchezza.XXiX al molto reverendo Padre Fra’ seraFino
de’ rossi, suo Fratello. San Tomaso d’Aquino richiesto dal croci-
fisso qual mercede egli volesse per li suoi scritti sacri rispose non volere altra che l’istesso Cristo.
XXX in morte di cristo nostro siGnore. Allude a quello della scrittura: «O mors,
ero mors tua».XXXI in morte del siGnor don dieGo de var-
Gas, PrimoGenito del siGnor duca di ca-Gnano.
Allude all’onde della famiglia Vargas e a quella del Castalio e alla scienza poetica
» 137
» 139
» 141
» 143
» 145
» 147
» 149
» 151
indice dei Sonetti
198
di quel Cavaliere e del Signor Don Gio-vanni, suo fratello, e Signor Principe di Carpino, nipote.
XXXII In morte della Signora Diana Caracciolo, Marchesa di Brienza.
XXXIII In morte del Reverendissimo Nicolò Ri-dolfi, Maestro Generale de’ Predicatori.
XXXIV In morte del Reverendissimo Don Vincen-zo Caraffa, Generale de’ Padri Predicatori della Compagnia di Gesú.
XXXV Si spiegano i quindici misteri del Santissi-mo Rosario.
XXXVI Primavera
Al Signor Don Giuseppe Domeniche, Se-gretario dell’Accademia de’ Confusi, detto l’Offuscato.
XXXVII al molto reverendo don Giovanni vin-cenzo Boenzi.
L’ignorante superbo e il savio modesto.XXXVIII All’illustrissimo monsiGnor ventriGlia,
vescovo di caserta.XXXIX S. Ivone, patrocinando le cause de’ poveri
fa restar vinta la calunnia.XL Cambise decollò Sisanne, giudice iniquo,
e della pelle di lui coprí il tribunale e in quello pose a giudicar il figlio Ottone.
» 153
» 155
» 158
» 161
» 163
» 165
» 167
» 169
» 172
» 174
199
BiBlioGraFia
delle oPere citate nelle note ai testi
alamanni, luiGi, Versi e prose: a cura di pietro raffaelli, Firen-ze, Le Monnier, 1859.
aliGhieri dante, La divina Commedia, a cura di N. Sapegno, La Nuova Italia, Firenze, 1985; Vita nova, a cura di Gu-glielmo Gorni, torino, G. einaudi, 1996.
ariosto ludovico, Rime, in Opere minori, a cura di Cesare Se-gre, Milano, Riccardo Ricciardi, 1954; Orlando furioso, a cura di Lanfranco Caretti, torino, einaudi, 1992.
Boiardo matteo maria, Orlando innamorato, a cura di Aldo Scaglione, torino, utet, 1963.
cavalcanti Guido, Rime, a cura di Maria Corti, Milano, riz-zoli, 1978.
cicerone marco tullio, Opere politiche e filosofiche, vol. I, a cura di Leonardo Ferrero e Nevio Zorzetti, torino, utet, 1997.
colonna vittoria Rime a cura di Alan Bullock, roma-Bari, Laterza, 1982.
da Pozzo Giovanni, Il Cinquecento, a cura di, in Storia lettera-ria d’Italia, Nuova edizione a cura di Armando Balduino, Piccin Nuova Libraria, Padova, 2006, I.
De anGelis silvia, Patronage e potere in monastero: le sorelle Maidalchini a San Domenico di Viterbo, roma, Carocci, 2009.
de’ medici lorenzo, Tutte le opere, a cura di paolo orvieto, 2 voll., roma Salerno, 1992.
de’ Pazzi maria maddalena, Tutte le opere di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi dai manoscritti originali, a cura di. Fulvio Nardoni, II-III voll., Firenze, Centro Internazionale del Libro, 1960-1966.
erodoto, Le Storie - Libro 5: La rivolta della Ionia; a cura di Giuseppe Nenci, roma, Fondazione Lorenzo Valla, Mi-lano, Arnoldo Mondadori editore, 1994.
esiodo, Teogonia, Introduzione, traduzione e note di G. Arri-ghetti, Milano, rizzoli, 1996. Inno alle Muse (esiodo, Teo-gonia, 1-115), testo, introduzione, traduzione e commento a cura di Pietro Pucci, Pisa-Roma, Serra, 2007.
BiBliografia
200
Fontanella Girolamo, Ode, a cura di rosario Contarino, San Mauro torinese, reS, 1994.
Gareth Benedetto, detto il chariteo Le rime, a cura di era-smo percopo, Napoli, tipogr. dell’Accademia delle Scienze, 1892.
Gimma Giacinto, Sylva rerum notabilium ab autorum operibus tum Latinis, tum Italicis excerpatarum, a cura di Maria Occhinegro e Fabio Angelo Sulpizio, Lecce, Milella, 2000.
Giraldi Giovanni Battista, Dell’Hercole di M. Giovanbattista Giraldi Cinthio nobile ferrarese, secretario dell’illustris-simo et eccellentissimo signore il signore Hercole Secondo da Este, duca quarto di Ferrara, Modena, Stamperia de Gadaldini, 1557.
Guarini, Battista, Il pastor fido, a cura di Luigi Banfi-Ettore Bonora, Milano, Mursia, 1977.
lePoreo ludovico, Leporeambi, a cura di Valter Boggione, San Mauro torinese, res, 1993.
manteGna, Giovanni alFonso, Le rime, a cura di Bifolco Maria rosaria, Salerno, edisud, 2001.
marino GiovamBattista, Tutte le opere di Giovan Battista Ma-rino, a cura di Giovanni Pozzi, Milano, Mondadori, 1976; La galeria a cura di Marzio Pieri, Padova, Liviana, 1979; Rime amorose a cura di ottavio Besomi-Alessandro Mar-tini, Modena, Panini, 1987; Rime marittime, a cura di ottavio Besomi, Costanzo Marchi, Alessandro Martini, Modena, Panini, 1988; Rime boscherecce, a cura di Janina Hauser, Modena, panini, 1991.
Morra IsaBella, Rime, a cura di Maria Antonietta Grignani, roma, Salerno, 2000.
muscettola antonio, Rime, a cura di Luigi Montella, Alessan-dria, ed. dell’orso, 20012.
Petrarca Francesco, Rerum Vulgarium Fragmenta, Introd. Di Roberto Antonelli, Saggio di Gianfranco Contini, Nota al testo di Daniele ponchiroli, torino, einaudi, 19922; Le senili. Libro Primo, testo a cura di elvira Nota. Intr., trad. e note di ugo Dotti. roma, Archivio Guido Izzi, 1993.
Pietri Francesco, I problemi accademici del signor Francesco De’ Pietri, l’Impedito Accademico Otioso ove le piú famo-se quistioni proposte nell’illustrissima Accademia de gli Otiosi di Napoli si spiegano. Opera di somma e universal eruditione, Napoli, Francesco Savio stampator della corte
BiBliografia
201
arcivescovale, a istanza di Giovanni Dominico Montana-ro, 1642.
Preti Girolamo Poesie, a cura di Domenico Chiodo, San Mauro torinese, res, 1991.
rota Berardino, Rime, a cura di Luca Milite, parma, Guanda, 2000.
sant’aGostino, Discorsi [230-272/B]. Sui Tempi liturgici, traduz. e note a cura di pietro Bellini, Federico Crucia-ni e Vincenzo tarulli, roma, Città Nuova editrice, 1984, pp. XLIV-544.
santaGata marco, La lirica feltresco-romagnola del Quattro-cento, «rivista di letteratura italiana» II, pp. 53-106.
sciPione errico, Sonetti e madrigali e altre rime dalle raccolte giovanili, a cura di Francesco Spera-Luisa Mirone, reS, San Mauro torinese, 1993.
tasso Bernardo, Rime, a cura di Domenico Chiodo-Valeria Martignone, torino, reS, 1995.
tasso torquato, Opere, a cura di Luigi Bonfigli, Bari, Later-za, 1934. Opere, a cura di Bruno Maier, Milano, rizzoli, 1963-1964. Le Lettere di Torquato Tasso, a cura di Cesa-re Guasti, Firenze, Le Monnier, 1853-1855; Varianti della Gerusalemme liberata, in Gerusalemme liberata, a cura di L. Caretti, Milano, Mondatori, 1988.
vasari GiorGio, Opere, Firenze, presso Stefano Audin e C. Li-braj in Mercato Nuovo di Faccia Vacchereccia, V, 1823.
virGilio PuBlio marone, Eneide, a cura di rosa Calzecchi one-sti, torino, einaudi, 1989.
introduzione
203
indice dei nomi
presenti nell’Introduzione*
achille, 30 acquaviva, Giosia, 75adamanzio, oriGène, 19n,aGostino d’iPPona (santo), 19 e
n, 23alBerto, maGno, 48alBrizio o Albrizzi o AlBitrio,
Luigi, 32n.alessandro VII, 19 n,alessandro, maGno, 30 alessio, Franco, 50n, aliGhieri, dante, 28, 54 e n.amBroGio di sorrento (francesca-
no), 75aristotele, 16n, 39, 55 e n, 68 e
n, 77arnauld, antoine, 21nasor rosa, alBerto, 31nastrea (dea), 53
BárBeri squarotti, GiorGio, 62nBarBieri, edoardo, 44nBarrerium, ioannem (tipografo),
39n Barthes, roland, 77nBartoli, daniello, 31 e n, 43 e n Bartolomeo (santo), 57, 58nBasilio il vecchio, 29nBasilio, maGno (santo), 29nBattista GiusePPe, 25n, 31, Battistini, andrea, 31n, 39nBayle, Pierre, 21nBellardi Giovanni, 29nBernardo di chiaravalle (santo),
23, 30 Bettetini, maria, 11nBiondi, alBano, 42nBoBadilla, nicola alFonso, 17n
Boccaccio, Giovanni, 30, 48 Boenzi, vincenzo, 75nBoezio, severino, 11 e n, 21 e n, 23Boiardo, mattia maria, 44nBolland, Jean, 21e nBraGamonte y Gusman, GasParo de
(conte), 46n, 47 e n Broet, Pascasio, 18nBrizzi, Gian Paolo, 39n
calvino, Giovanni, 38camPanella, tommaso, 50n, 65 canziani, Guido, 17ncaracciolo, diana (marchesa), 75ncaracciolo, innico (cardinale), 33caraFFa,vincenzo 75n carducci, Giosuè, 54 carlo v (re)carPano, GiusePPe, 72ncartesio, renato, 50, 51 e ncataPano, Giovanni, 11cavalli, Bonaventura (Vescovo),
25ncavallotti, carlo, 68ncerBo, anna, 50ncesare, caio Giulio, 30chitussi, BarBara, 11ncicerone, marco tullio, 28, 29 e
n, 39, 42, 55ciro il Grande (imPeratore), 26, 27clori, 12coci, laura, 39ncoPernico, niccolò, 49 coPPola, carlo, 75nclemente XIV (papa), 18ncorBelleti, Francisci (tipografo),
14ncratilo (filosofo), 53
* Non trovano posto i nomi di Dio, di Gesú, della Vergine e degli editori moderni.
indice dei noMi
204
crescenzio, alessandro (vescovo), 47n
d’alessio, silvana, 66nde anGelis, silvia, della casa, Giovanni, 62desPrez, Guillaume (stampatore),
21ndidier, Foucault, 38ndioniso (dio), domenichi, GiusePPe, 56 e n,
eliot, thomas stearns, 63nemmelia (madre di Gregorio di
Nissa), 29nerasmo da rotterdam, 41 e nezechiele (profeta), 35
FaBBri, Paolo, 77n FaBro, Pietro, 17nFerro, antonio (stampatore), 25nFerroni, Giulio, 59nFiliPPo IV (re), 47nFilli, 12Follieri, Girolamo, 75nFrancesco saverio (santo), 75nFrank, roBert, 50n
Galasso, GiusePPe, 73nGaleno di PerGamo, 49 e n, 50n Galilei, Galileo, 24, 49Gallavotti, carlo, 68nGassend, Pierre, 16 e n Gaudiosi, tommaso, 31Getto, Giovanni, 66n, 76 e n Giannantonio, valeria, 57nGiannone, Pietro, 73 e n, 61n, 73n,
74, 75nGiansenio, cornelio, 19 e n, 20GiomBi, samuele, 42n, 44nGiovanni Battista (apostolo), 26n,
35 e nGirolamo (santo), 13Giunone (dea), 60,Giustino di naBlus (santo), 30n
Gracián, Baltasar, 76nGranada luis de’, 41nGreGorio di nissa (detto Niseno),
29nGreGory, tullio, 17nGriGnani, lodovico (stamPatore),
58nGrimaldi, Francesco ceva, 17nGuarini, Giovanni Battista,62Guevara Fray, antonio de, 68 e n
harvey, William, 49 e n, 50, hoBBes thomas, 50 e n
imBruGlia, Girolamo, 18n, 20n, 21ninnocenzo X (papa), 19n, isaia (profeta), 35isidoro di siviGlia (Santo), 27 e n
Jeanmaire, henri n
kircher, athanasius, 14n, 15nkuhn, thomas samuel, 49n
laJo, claudio, 18nlainez, Giacomo, 17nlazzeri, iGnatio de’ (stampatore),
32n, 72licurGo (legislatore), 26 e n, 27lodoario, Giovanni, 18nloJola, iGnazio (santo), 17nlomBardi, mariano (stampatore),
17n. lucia da siracusa (santa), 54
macrina, la Giovane (santa), 29nmaielli, michele, 75nmalatesta, Giovan Battista, 31n,
manso, Giovanni Battista, 25nmarco aurelio, 23n marino, Giovan Battista, 11, 52n,
58, 59, 61, 67n, 71n, 72marone, PuBlio virGilio, massarenGo, andrea (anche Mas-
sarenghi, conte), 23 e n
indice dei noMi
205
marte (dio), 66matteo (evangelista),matullo, marianna, 38n mazzarelli, claudio, 56nmeninni, Federico, 31milziade, il Giovane, 30minturno, antonio, 62mollo, roBerto (stampatore), 46n,
56, 58, 81moreschini, claudio, 29nMortier, Antonino muscettola, antonio, 31, 66 e nmusi, aurelio, 66n
naso, niccolò (stampatore), 73n
o’ malley, John, 41n
Paci, Giovan Francesco (stampa-tore), 12n, 23, 33, 34, 47, 72
PaGanini, Gianni, 17nPaGel, Walter, 50nPallade (dea), 52Pallavicino sForza, Pietro, 32, 39n PanGrazi, tiziana, 15nPaolo iii (papa), 18nPaolo di cordova, 75nPaolo di tarso (santo), 55Parenti, Giovanni, 59nPascal, Blaise, 18 e n, 20, 50, 51 e nPaternostro, rocco, 32nPavone, saBina, 18nPelaGio, Britannico, 19nPennone, Daniele, 29nPerPinyà Pedro Juan, 39nPetrarca, Francesco, 28, 58, 71Pezzana, niccolò, 43nPio VII (papa), 18nPisani, Baldassarre, 31PoGGi, Giulia, 76nPortinari, Beatrice, 54Pozzi, Giovanni, 67nPreti, mattia, 74n, 75n
quintiliano, marco FaBio, 40, 43n
quondam, amedeo, 59nquirino (romolo), 26, 27
racioPPi, Giacomo, 74 e nraimondi, ezio, 31n, 43nridolFi, nicolò, 29, 75nrizzo, Gino, 39nrodriGuez, simone, 18nrossi, alBerto de’, 47 e nrossi, antonio de’, 11, 13, 15, 17,
21, 27, 28, 29n, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 42, 43 e n, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 64, 72, 75, 78
rossi, seraFino de’, 93ruBiés, Joan Pau, 20n
salmerone, alFonso, 17n sanseverino, luiGi (principe), 34sarPi, Paolo, 32nseGneri, Paolo, 32seneca, lucio anneo, 5, 30, 44 e nsoarez, ciPriano, 39 e n, 40, 41,
42, 43n socrate (filosofo), 53soFronio euseBio Girolamo (santo)solone, 26 e n, 27, stePhenson sPink, John nsuPo (gesuita), 72n
tansillo, luiGi, 59, 62tartaGlione, luca, 75n tasso, torquato, 62teoFilo di alessandria (vescovo),
19ntertulliano, quinto settimio Flo-
rente, 44 e n, 45tesauro, emanuele, 43 teti (dea), 60 timoteo, 23tommaso aniello d’amalFi (Masa-
niello), 65, 66 e n, 73ntommaso d’aquino (santo), 33 e
n, 40, 41tortoletti, Bartolomeo, 58ntramezzino, michiel (tipografo), 39n
indice dei noMi
206
trissino, Gian GiorGio, 62
urBano VIII (papa), 19n, 74nvarGas dieGo de (duca), 75nvarGas, Giovanni de (duca), 75nvanni, Gerolamo, 32nvenere (dea), 66, 67nventriGlia, GioBan Battista (ve-
scovo), 75n
vitiello, raFFaele, 18nvolker, Walther, 29nvozza, chiara, 51n
zaccaria (profeta), 13nzanlonGhi, Giovanna, 45nzardin, Danilo, 44nzilettus Franciscus,41nzorzi, renzo, 18n
indice dei noMi
207
indice
Prefazione, di Giorgio Barbèri Squarotti ...............
L’arte della persuasione .........................................
Nota biografica ........................................................
Nota al testo ............................................................
Sonetti......................................................................
rimario ....................................................................
tavola metrica.........................................................
Indice dei sonetti .....................................................
Bibliografia ..............................................................
Indice dei nomi ........................................................
p. I-IV
« 9
« 79
« 80
« 85
« 175
« 193
« 195
« 199
« 203
Finito di stamPare
Presso la tiPoGraFia Buonaiuto sas
E-mail [email protected]
tel. 081/942663 in sarno (salerno)
Per conto della edisud salerno
nel mese di maGGio 2012