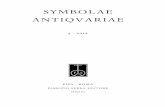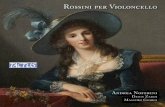Carlo Conti Rossini in Eritrea tra ricerca scientifica e prassi coloniale (1899-1903), in A. Bausi,...
Transcript of Carlo Conti Rossini in Eritrea tra ricerca scientifica e prassi coloniale (1899-1903), in A. Bausi,...
Carlo Conti Rossini in Eritrea tra ricerca scientifica e prassi coloniale (1899-1903) Draft Published in A. Bausi, A. Gori, G. Lusini. Linguistic, Oriental and Ethiopian Studies in Memory of Paolo Marrassini, Wiesbaden, Harrassowitz 2014, pp. 321-342 Il filo conduttore di questo saggio è la documentazione di una difficile conciliazione tra la passione per la ricerca scientifica e i doveri di ufficio, che costituirono le ragioni della permanenza di Carlo Conti Rossini in Eritrea nel periodo fondativo della amministrazione civile coloniale tra la fine del 1898 e il marzo del 1903. Sarebbe legittimo considerarla anche come un frammento di una storia della prassi coloniale, politica e amministrativa, attraverso la documentazione di uno dei primi funzionari civili in una posizione privilegiata nel Governatorato Martini. È anche pensabile come un segmento iniziale di una possibile biografia intellettuale del Conti Rossini etiopista. La costruzione di una biografia dello studioso sarebbe in sé storiograficamente giustificata o, potrebbe anche essere, se si vuole, una sezione importante di una “biografia di gruppo” di un ristretto numero di semitisti e etiopisti italiani, da Ignazio Guidi a Conti Rossini fino ai più giovani Enrico Cerulli e Mario Moreno, che dovrebbe andare oltre i profili biografici e bibliografici individuali, comparsi finora nelle Enciclopedie, dizionari, repertori e rari interventi in convegni. Sarebbe lavoro utile sia sul piano di una storiografia dell’etiopistica moderna, attenta ai contesti storici e politici, ai milieu e filiazioni intellettuali non solo interni alla semitistica, sia sul piano di una storiografia delle discipline dell’esotico au sens large (storiche, linguistiche, etnologiche) tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento italiano.1 Considerati i suoi precoci esordi scientifici, Conti Rossini può bene essere definito come “studioso-funzionario” già in questa prima fase. Fu certamente una figura singolare nel primo funzionariato civile, dinanzi agli stessi
1 Si veda per un bilancio della prima fase lo stesso C. Conti Rossini 1913a: 15-19.
militari sperimentati del primo gruppo arrivato in colonia, 2 da cui si distacca positivamente per le sue competenze linguistiche e storiche professionali. In contatto con tutti per dovere di ufficio, dal centro amministrativo di Asmara, apprezzava soprattutto coloro che avevano mostrato anche passione conoscitiva nel loro territorio.3 Nei limiti di questo saggio, che non può essere dunque una ricostruzione completa del quinquennio né per quanto riguarda l’attività politico-amministrativa né per quanto riguarda l’attività scientifica, seguirò temi e problemi soprattutto attraverso la corrispondenza inviata all’avvocato Peleo Bacci, al tempo in cui questi era commissario a Kärän 4 , passaggi del Diario eritreo di Ferdinando Martini e qualche lettera inviatagli dal magistrato William Caffarel, anch’egli di servizio nello stesso luogo.5 Il Bacci e il Caffarel sembrano essere anche le 2 Per un profilo di gruppo degli ufficiali e funzionari nella prima fase della colonia Eritrea e un tentativo di organizzazione tipologica (con un importante contributo documentario sul Commissariato più antico) vd. M. Zaccaria 2009 (cui rimando anche per le note biografiche dei funzionari citati nel presente saggio); un ragionato e critico affresco dei funzionari e magistrati, che include i decenni successivi e le altre colonie, inserito in una storia istituzionale, è C. Giorgi 2012; per una prima riflessione sulla etnografia pratica, prassi politica, studi scientifici e cenni al ruolo di maestro del Nostro vd. G. Dore 1993 e 2000: 3-25. 3 Nei Principi di diritto consuetudinario dell’Eritrea del 1916, summa del suo lavoro di etnologia giuridica, in cui trovano sistemazione ricerche e rapporti degli altri funzionari, ad es., definisce “pregevole” il lavoro di Odorizzi sugli Habab e “accurate” le relazioni dei residenti Mulazzani e Sapelli. Aveva recensito con severità per ricostruzioni o generalizzazione avventate e deficit linguistico, ma anche con interesse, lavori come Di qua dal Mareb di Ruffillo Perini (tempestivamente recensito nel «Bollettino della Reale Società geografica d’Italia« (BSGI), 1905, pp. 399-400); ma in generale riconosceva come “il peso dei doveri amministrativi e delle urgenze di governo” fosse freno che condizionava la sistematicità e accuratezza delle osservazioni. 4 Federica Guazzini (1999: 144-147) ha per prima segnalato presso la Biblioteca Forteguerrana di Pistoia l’esistenza dei materiali dell’Archivio Bacci e anche la circolazione tra gli ufficiali di un questionario etnografico internazionale, proposto da Hermann Post, da Berlino (2000: 310-349). Le 16 lettere spedite al Bacci dal Conti Rossini (d’ora in poi siglo nelle note CR) vanno dal 23.12.1900 al 09.02.1902 (dunque c'è circa un ulteriore anno in colonia in cui si può dubitare non si siano scambiate altre lettere), “Gruppo eritreo” faldone 3- 8 c /1, cartella Rossini C. 5 Su W. Caffarel vd. L. Martone 2013: 371 e Eliana Augusti 2013: 87-102.
due persone con cui più si sente solidale in Colonia. Nel 1899 Conti Rossini ha 27 anni, Bacci 30 e Caffarel 31: tutti e tre sono laureati in Giurisprudenza. Anche se non abbiamo a disposizione un’autobiografia, nella corrispondenza privata disponibile è in qualche modo incapsulata una rappresentazione di sé, e anche il registro emozionale coevo alla scrittura; può utilmente essere accordata con l’uso della prima persona negli incipit e nelle note dei suoi lavori, in cui rievoca o riflette sul metodo e sui modi di produzione dei documenti sul campo e su figure e relazioni. Gli uni e gli altri sono in qualche modo dei frammenti autobiografici, che possiamo utilizzare, se ne verifichiamo la coerenza e li organizziamo insieme in un racconto biografico lineare.6 Il fatto che nelle lettere coesistano richieste scientifiche, ragionamenti sulla carriera e valutazioni politiche illustra in modo esemplare l’intreccio, difficile ma costante, tra le due sfere. Malgrado la dialogia mancata,7 troviamo nelle lettere considerate molti spunti su un periodo importante per la storia della regione. Compaiono le critiche e preoccupazioni per la situazione politica eritrea e quella delle confinanti regioni del Təәgray, giudizi sferzanti sulla preponderanza dei militari e autosufficienza e arroganza dell’Arma dei Carabinieri, lamenti sulle debolezze amministrative e sulle difficoltà dell’ambiente professionale, l’insofferenza per la ristrettezza di Asmara fino al rammarico per aver scelto di andare in colonia. In nessuna lettera a questi dubbi opporrà come contraltare, almeno esplicitamente, le eccezionali possibilità per lo studio specialistico che la presenza sul territorio, di cui ha già studiato la lingua e la storia a tavolino, gli consente, per di più nella posizione cruciale prima di addetto al
6 Ho già pubblicato la piccola corrispondenza tra il giovane funzionario di governo Giovanni Battista Ellero e CR (7 unità dal 05.03.1940 al 10.11.1940), reperita rispettivamente nel Fondo CR/Corrispondenti alla Biblioteca Corsiniana dell’Accademia dei Lincei a Roma (d’ora in poi BALC/CR) e nel Fondo Ellero Pezzoli, Biblioteca della Specola, Dipartimento di Storia culture civiltà, Università Alma Mater di Bologna (in G. Dore-J. Mantel Nečko-I. Taddia 2005: 174-183). 7 In fase successiva andrà verificata la busta dedicata a Peleo Bacci, che contiene 10 pezzi, in BALC/CR/Corrispondenti. Per primo ordinamento e resoconto del Fondo vd. A. Gori 2002: 161-74.
gabinetto del governatore e poi di Direttore degli Affari politici e civili.8 Riferimenti a come si formò la decisione di andare in Eritrea non compaiono nelle lettere, per cui bisogna riferirsi all’incipit dello stesso autore in Ricerche e studi sull’Etiopia (1900: 3), dove ricorda le sollecitazioni di Giacomo Agnesa, direttore dell’Ufficio coloniale a Roma,9 in seguito alle quali salpò da Napoli a ricercare «nel tempo lasciatomi libero dalle cure ufficiali (…) le varie tracce ancor esistenti di quel periodo storico (…) che dovrebbero invece chiamarsi sabeo aksumita»).10 1. L’ambiente asmarino Chi è Peleo Bacci, il suo corrispondente privilegiato? Il Martini nel suo Diario ha anche su di lui giudizi severi, che vanno filtrati con attenzione data l’asperità dell’autore; anche questo genere di scrittura autobiografica coeva è una intenzionale autorappresentazione e probabilmente pensata per una successiva pubblicazione. Il 6 febbraio 1900, rientrando in Colonia dopo 7 mesi in Italia, “occasione di impulso e molte chiacchere”, egli scrive di aver soppresso l’ufficio di segretario particolare e dunque rimosso B. [Bacci]: Il B. è imprudente e pettegolo. Ho pur troppo dovuto convincermene. Per darsi l’aria di uomo importante scrive lettere ai suoi e ad altri descrivendo l’amministrazione coloniale in piena anarchia e commesso a lui l’ufficio alto e grave di rimetter le cose in ordine. Più vano che ambizioso: lo sento egoista e lo prevedo ingrato: l’ho sollevato dal carico di farmi da segretario particolare (sono stanco di fare l’ufficiale d’ordinanza, diceva) e l’ho
8 La carica di segretario del Governatore, assegnatagli dopo il dirottamento di Peleo Bacci a commissario di Kärän, verrà intesa dal Martini come puramente nominale. Nel mese di agosto 1899 Conti Rossini aveva retto lo stesso Commissariato. 9 Vi sono 15 lettere inviate da CR a Giacomo Agnesa in parte da Tripoli, come segretario generale del governo di Tripolitania, presso ASMAI, Persone operanti in Africa, Pos. 35, Pacco C 10, Cart. Conti Rossini (1911-1916, ma da 04.04.1912 a 01.01.1917). 10 Lo ricordava Lanfranco Ricci in un excursus che delineava la situazione degli studi italiani nel secondo dopoguerra, riconoscendovi le tracce e eredità della fase precedente (Ricci 1986: 159-166).
mandato a reggere il Commissariato di Cheren. Se si rassegna bene, se no a Massaua di piroscafi ce n’è uno per settimana” (DE, II, 06.02.1900, p. 63) Più avanti però ne loda il comportamento tenuto rispetto alle liti di confine e di terreni, mentre altri commissari non avevano provveduto a stilare una mappa catastale: «Ordino al Bacci di provvedere: e quel che è giusto è giusto, debbo dire che dal Bacci qui molti opportuni provvedimenti furono presi, molte cose buone furono già fatte» (DE, II, 08.05.1900, p. 171). Più tardi il Martini li richiama insieme, sia pure con giudizio differenziato: «Il Conti Rossini nel carattere rivaleggia col Mercatelli e col Bacci: più ombroso del primo, men maligno del secondo» (DE, III, 17.06.1902, p. 489). Asmara al tempo è un piccolo abitato, con le prime costruzioni militari e civili e percorsi impervi e oscuri; non è certo la cittadina popolata e frenetica della piena espansione coloniale.11 Il Conti Rossini, che ha seguito la prima regolamentazione urbanistica del 1902, ne lamenta le ristrettezze non solo urbanistiche, ma soprattutto morali. Il Martini, al ritorno da Aden, registrava le conseguenze di complicate relazioni private: «Il Corsi, il Conti Rossini mi raccontano la cronaca scandalosa di Asmara e le gesta della signora X veramente incredibili addirittura messalinesche. Un ufficiale, il tenente B. fu a cagion sua fatto rimpatriare; il G. rimpatrierà. Sta bene: ma bisognerà pensare a far rientrare anche lei» [DE, III, 07.03.1902, p. 533]. Ma la distanza il Conti Rossini la stabiliva soprattutto rispetto alle debolezze dell’ambiente professionale pubblico e privato (le «guerriciole casermesche»): «Circa l’ultima frase della Sua lettera, che dire? Ho girato il mondo parecchio, ma un insieme così maligno come questo eritreo non lo ho mai trovato. Bisogna scrollar le spalle e tirar via» (a B., Asmara 08.01.1901). Si affaccia, in un’aggressione subita due mesi dopo, una pur minima “criminalità” urbana, che ha come precedente e coeva esperienza il porto di Massawa, e che rimanda al malessere sociale indotto da una mobilità e scambi economici nuovi, che pongono il problema della 11 Cfr. S. Zagnoni 1993: 145-193.
sicurezza e di quello che si comincia a classificare come “ordine pubblico coloniale”.12 Mi avvenne lunedì sera un fatto grave. Uscito dal Circolo, avevo incominciato ad attraversare il mercato con passo carico dirigendomi verso il fondo di esso. Ma non avevo ancora oltrepassato le prime file quando un indigeno, che stava in agguato, nascosto nelle tenebre dietro un tucul - io credo assolutamente a scopo di furto - mi si avventò proditoriamente alle spalle, mi afferrò pel collo e fece per buttarmi a terra. Mi liberai dalla stretta e a mia volta mi avventai sull’aggressore: dopo una lotta furibonda potei acchiapparlo e trascinarlo sul vicino stradone, d’onde coll’aiuto di gente accorsa, mi fu possibile portarlo alla caserma dei carabinieri. E il colpo di scena. Mantini guarda in faccia l’aggressore, il quale – dato l’agguato, il mo[do?] d’assalto, il mio contegno – non poteva, lo ripeto, essersi proposto di non derubarmi, e mi annuncia che è … uno zaptiè! ... Ho denunziato il fatto al tribunale Militare. Ma la Benemerita in tutti i modi cerca di salvare il ladrone:13 per ora si limita a farlo passare per ubriaco, il che tanto io, rimasto per quasi mezz’ora a contatto immediato con lui, quanto i miei aiutatori escludiamo (...) Sono fuori addirittura della grazia di Dio! Ho telegrafato a S. E. e, se non ottengo piena soddisfazione, me ne tornerò a Roma, magari a mie spese. Che diavolo! Un commissario mi scrive che che gli zaptiè della sua zona amano la bella professione di contenenza e di
12 Si registrano nelle cronache e rapporti del periodo rapine, furti, aggressioni, spesso imputati a zaptiè, ascari in servizio o smobilitati, vd. M. Scardigli 1999: 175-177. 13 In altra occasione di conflitti tra il Commissariato di Kärän e i “brigadelli” scrive: «Ella sa come io la pensi circa l’Arma, la quale è senza dubbio benemerita per molti riguardi, ma che, rivolgendo su altre cose o su altro terreno il suo zelo e la sua attività, farebbe certamente un atto dal quale ben maggiori onori potrebbe operare. Ma oggi essa è quello che è e - ciò senza dubbio ha valore – trovasi in auge presso il Governatore. Ella, senza discussione, ha già capito il consiglio che da amico mi vorrei permettere di darle. Creda, ora è pericoloso aver certi con quegli egregi signori. Il povero De Rossi si informi! » (a B., 25.05.1901). Queste critiche erano parte della sua convinzione del primato da conferirsi ai funzionari civili: «Ah, perché Martini non vuole persuadersi di aprire in Italia un concorso per gli impieghi coloniali ed eliminare tutti questi ufficiali residenti ecc. ecc.! » (a B., 25.01.1901).
ladruncoli, nel Cedrer mi si dice che che gli zaptiè sotto pretesto di furto arrestano le ragazze per deflorarle, qui uno zaptiè può divenir autore di rapine a danno dei bianchi ed è poi difesa…Ma in che mondo viviamo? Qui nihil novi. Come invidio Lei che è fuori di questo centro, il peggiore di tutta l’Eritrea per le sue discordie, i suoi pettegolezzi, le sue rabbiose calunnie ecc.. ecc.. , tutte cose alle quali la non breve assenza simultanea di S. E. il Governatore e il Comandante delle rr. Truppe dà piena stura!14 Meglio Amba Debra, almeno non vi sono zaptiè che attentino alla vita. (a B., Asmara 20.03.1901) Martini, avvisato dal suo telegramma mentre è nell’attendamento di Gulza, gli riserva un commento tranchant: «Brutto affare. Il Conti Rossini ne coglie occasione per inveire contro il modo e le persone onde è fatto il servizio di polizia. Certo le lagnanze sono molte e frequenti. Ma che diavolo andava egli a fare solo e di sera tra i tucul del mercato?» (DE, II, 20.03.1901, pp. 387-8). In effetti il Conti Rossini già un paio di mesi prima aveva manifestato insofferenza per la situazione politica e non solo personale e voglia di ritornare in patria: Piuttosto, mi permetterò di manifestarle il mio rincrescimento per le notizie datemi dal mio carissimo Caffarel circa i loro fastidi, dirò d’origine militare. Le notizie peraltro non sono giunte affatto inattese a me, che conosco alquanto l’ambiente; anzi, se debbo confessarle il vero, mi stupiva che tanto esse tardassero. Ella e Caffarel hanno pienamente, pienissimamente ragione: son cose che non dovrebbero verificarsi e che, verificatesi, non anderebbero in niun modo tollerate. Ma ci vorrebbe, per esprimerle, a capo di tutto un carattere ferreo, rigidissimo, affatto incurante di molte cose, che qui invece preoccupano. Io non so se resterò in Eritrea: di troppe cose oramai sono stanco, e, se al ritorno di S. E. un radicale mutamento non mi tratterrà, anderò a far carnevale a Roma, donde non avrei mai dovuto dipartirmi per l’Eritrea. Ma, se dovesse avvenire l’improbabile caso d’una mia maggiore sosta in Colonia presso il Governatore, gl’inconvenienti in questione
14 In effetti il Martini veniva criticato per le sue lunghe assenze dalla colonia ripetute ogni anno.
sarebbero tra le cose, per le quali maggiormente insisterei: sono affari d’altri tempi!... (a B., Asmara 08.01.1901) La sua prima richiesta era poi rientrata e il Martini aveva annotato: anche la questione che pareva insolubile si è accomodata. Il Conti Rossini rimane: terrà la Direzione degli Affari civili e l’interim della segreteria, che veramente è da sopprimersi (…) Il Conti Rossini è un impiegato di prim’ordine, ma ha carattere puntiglioso. (DE, II, 31.01.1901, pp. 339-340) Ma il 4 luglio del 1902 gli tocca un altro guaio: mentre era a pranzo al Circolo, sfondano il muro del suo tucul, vi appiccano il fuoco al tavolino dove aveva molte carte e libri, e studi fatti durante gli anni passati in Colonia intorno alla storia etiopica, «gli rubano la croce di San Maurizio da me [Martini] donatagli giorni or sono». Venne danneggiato parzialmente, forse per vendetta, forse per sfregio, il codice, un Gädl, a lui prestato dal Däbrä Dəәmah Märqorewos, uno dei più importanti conventi storici del paese, non lontano da 'Addi Ugri e Arräza, creando con i suoi monaci un incidente diplomatico che dovette comporre il residente del Däqqi Täsfa Paolo Teodorani: «Si propende per credere che non si tratti di furto; ma che invece colui che entrò nel tucul, vi entrasse a fine di portar via carte: ma quali? Il Conti Rossini non ne aveva alcuna importante o d'altri o di ufficio; però è un fatto che le carte furono poste tutte sossopra e poi volontariamente incendiate» (DE, III, 05.07.1902, pp. 42-3). A parere del Nostro – aveva annotato il Martini durante la visita al monastero – era il testo «più voluminoso della letteratura originale abissina che egli conosca. Ve n’hanno de’ più voluminosi ma sono traduzioni. Questo si compone di oltre 350 fogli (di due pagine ciascuno) ed ha notizie importantissime» (DE, III, 03.05.1902, p. 591). Nulla potrà però Martini all’inizio del 1903 dinanzi alla nuova determinazione del Conti Rossini che chiede il rimpatrio: Il Conti Rossini mi chiede di rimpatriare. Lo prego di attendere ch’io stesso lasci la colonia: egli insiste per partire col piroscafo
di marzo; gli domando di rimanere fino ad aprile per non impedire il mio viaggio nell’Assaorta. Fiato sprecato. Dice di trovarsi male nell’Eritrea dopo i casi avvenuti, di non aver più passione per l’ufficio, di compiere, se pur lo compie, svogliatamente il proprio dovere. Si lagna (e qui ha ragione) di non aver avuto dalla sua venuta in Colonia alcun beneficio nella carriera. Ma se que’ signori del Tesoro odiano la Colonia e ascrivono al torto il servirla, che ci si fa? Breve, consento ch’egli parta, rinuncio al viaggio nell’Assaorta e telegrafo che pensino a mandar qui qualcuno che possa sostituire il Conti Rossini. (DE, III, 15. 02.1903, p. 114) Malgrado Schupfer15 gli offrisse i servigi per dissuaderlo dall’andarsene: «Il Conti Rossini fu da me trattato sempre piuttosto da amico che da subordinato; e non debbo né voglio credere che ciò ch’egli negò alle istanze mie concede alle istanze altrui. Se lo Schupfer parla per conto proprio, la sua intromissione non la voglio: se parla per conto del Conti Rossini, questi venga a dirsi pentito della risoluzione annunciata» (DE, III, 16.02.1903, p. 116). E così il Martini poteva solo commentarne il definitivo congedo, riconoscendone al contempo i meriti: Parte da Asmara il Conti Rossini. Mi separo da lui dopo quasi 4 anni senza rammarico. Il funzionario è prezioso per acume, per operosità, per dottrina; ma l’uomo è ombroso e suscettibile. Così s’era acquistato antipatie nella Colonia, che conosce nella sua storia, nei suoi costumi e linguaggi come non uno forse degli Europei che vi dimorano. Mi sarà difficile sostituirlo con altro impiegato così retto, così operoso, così colto: ma a sua permanenza mi avrebbe cagionato qui altre e gravi difficoltà.” (DE, III, 15.03.1903, pp. 134-15) 2. Tra doveri d’ufficio e ricerca scientifica Quando arriva ad Asmara Conti Rossini può già considerarsi uno storico filologo, che ha esordito giovanissimo, da tempo in contatto
15 Federico Schupfer, ingegnere, dirigeva l’Ufficio speciale costruzioni ferroviarie, istituito nel 1900.
con il maestro Ignazio Guidi,16 il fondatore e direttore della Scuola Orientale di Roma con il Nocentini e lo Schiapparelli, e iniziatore della moderna scuola etiopistica, e con il linguista Emilio Teza, che da orientalista aveva fatto qualche incursione nell’amarico.17 Entrambi avevano presentato due sue memorie alla Accademia dei Lincei, la prima, a tavolino, nel 1894 e la seconda, maturata sul terreno, sul Gädlä Filpos, pubblicata alla fine del suo soggiorno eritreo.18 Prima di iniziare la sua carriera ad Asmara, aveva già pubblicato 17 lavori, tra cui nel 1894 il Catalogo dei nomi propri di luogo dell’Etiopia e nel 1897 Sulla dinastia Zaguē. 19 Durante la sua permanenza ne pubblica altri 15. A testimonianza di una relazione mai interrotta, nel 1910, quando Conti Rossini è rappresentante del Tesoro a Parigi, il Guidi chiederà al Teza una sua presentazione per la nomina del vecchio allievo come socio di un’accademia italiana: Amico carissimo
16 Allo stesso CR (1935: 471-481) toccherà di commemorarlo (avendo iniziato come “autodidatta” lo giudicava, pur non avendo lavorato sul campo, ma con parlanti la lingua a Roma, “dopo l’Amari, il solo orientalista di fama schiettamente internazionale sullo scorcio del secolo scorso”); e concordò Giorgio Levi Della Vida, (1935: 471-481), i cui incroci con il Conti Rossini furono frequenti a partire dal comune insegnamento alla Sapienza a Roma. 17 Nella Biblioteca Marciana di Venezia compaiono 77 corrispondenze di Ignazio Guidi al linguista Emilio Teza dal 10.06.1865 al 9.03.1912 (Carte Teza Cod. It. XXX). Sul Teza, che morì nel 1912, vd. Carlo Frati 1913; Vincenzo Crescini 1914; Rita Peca Conti 1976. Teza recensì La Grammatica elementare amarinã del Guidi in BSGI, a. XXIV, 1890, vol. XXVII, pp. 879-886. Il legame con il decano degli studi linguistici Ascoli ci sembra così fondamentale per i rapporti con la nascente semitistica moderna italiana, sia per il rigore filologico sia per la teoria del sostrato etnico, che pure non esplicitamente richiamata – ci pare – sarebbe stata di utilità per muoversi tra le stratificazioni linguistiche ed etniche nell’altopiano etiopico (su Ascoli e l’etiopico vd. Israel 2012). A ‘900 avanzato il CR avrebbe sottolineato l’utilità della teoria delle aree laterali del Bartoli per lo studio dell’altopiano etiopico. 18 La due relazioni sulle memorie del CR furono presentate da Guidi (relatore) e Teza (socio) alla Acc. dei Linc.: la prima intitolata Il Gadla Takla Haymanot" secondo la redazione waldebbana (RRAL, ser. 5° (Sc. Mor.) vol II, 1896 parte 1°, Memorie (Roma 1896) p. 97); la seconda memoria, nella seduta del 18 giugno 1899, intitolata Il Gadla Filpos e il Gadla Yohannes, RRAL, ser. 5° (Sc. Mor.), vol. VIII, parte I, Memorie (Roma 1903), p. 61. 19 Rinvio per la completezza dei dati a A. C. Nallino (1949: 103-112) e allo stesso CR in RSO 1927: 58-63.
(...) E ora mi permetto di parlarti di una cosa che mi starebbe a cuore. Tu conosci quanto valore abbia negli studi abissini, quante belle pubblicazioni abbia fatto e prepari il nostro Conti Rossini. Egli è, senza dubbi, uno dei più grandi conoscitori di lingue e storia d'Abissinia in Europa e in America. Il Conti Rossini che è commendatore e capo divisione al Ministero del Tesoro ha [..?] una posizione ufficiale molto alta, ma gli farebbe grande piacere esser nominato in qualche accademia come è già socio di accademie estere, o corrrispondente, per es., della stessa R. Accademia di Gottinga. Ai Lincei, come sai, manca assolutamente il posto, essendo tanto pochi i posti dati alla filologia tutta quanta classica, orientale, romana etc etc (… ) Per tua norma, il Conti Rossini ignora completamente quanto io ti scrivo.20 Dall’inizio della sua attività professionale in colonia, con una stupefacente tenacia e capacità di lavoro, accumula sistematicamente materiali sulle genti e sui luoghi ed eventi, esercitando raccolta documentaria e riflessione storica e linguistica su tutte le regioni e genti della colonia. Si tratta di una messe di appunti, traduzioni e copie di scritti originali, che, pur scontando delle perdite, porterà con sé in Italia e cui attingerà a più riprese nei decenni, lavorandoci nei pori della sua attività impegnativa di civil servant. 21 Pubblica sistematicamente anche durante il servizio coloniale, con edizioni e traduzione di testi reperiti nei conventi e con i primi lavori di ricostruzione storica delle migrazioni e conseguenti trasformazioni di gruppi, come nel 1900 Ricerche e studi sull’Etiopia e nel 1901 Tradizioni storiche dei Mensa. Le riviste in cui pubblica testimoniano di un’ampia rete di relazioni anche pluri-disciplinare: dal «Giornale della Società asiatica italiana» al «Bollettino della Società geografica italiana», dalla «Rivista geografica italiana», all’«Archivio di Tradizioni popolari», all’ «Oriente», alla «Rivista degli studi orientali». Una relazione scientifica importante in colonia fu quella intessuta con gli evangelici svedesi che, al suo arrivo, dispongono di una 20 Carte Teza, Cod. IT XXX, n. 66, 30.08.1910; Guidi rinnova la richiesta per una nomina all’Istituto Veneto anche successivamente (20.10.1910/ 22.11.1910/ 28.12.1911), fino a prendere atto di un primo esito negativo a Venezia. 21 Vd. Guido Melis 2007: 1398-99.
avviata tipografia e sono già impegnati nella raccolta documentaria e nella traduzione di testi cristiani in più lingue della regione, non solo semitiche, come Karl Winqvist e soprattutto Karl Gustav Rodén, di cui in seguito sosterrà la pubblicazione del lavoro sui Mensa e la traduzione italiana, e con cui manterrà nel tempo una consuetudine di scambi.22 Anche altri studiosi africanisti di fama internazionale sono in contatto con lui nel periodo, come Leo Reinisch.23
22 In BALC/CR/Corrispondenti compaiono una lettera da Rodén (Gheleb, 28.05.1899) e due da A[nders] Svensson (08.11.1893 e 27.01.1894). Nella Universitet Bibliotek/Manuscripts di Uppsala c’è la Rodén Collection, e ivi nella sezione Correspondents ci sono corrispondenze in italiano di epoca molto successiva che testimoniano la relazione di lunga durata: due cartoline postali 26.01.1942, in cui CR annuncia la stampa della rivista «Rassegna di Studi etiopici» (RSE), e 20.09.1942 e due lettere del 1942 quando, ormai raggiunto il grado di presidente di sezione del Consiglio di Stato, ha lasciato il servizio attivo per mettere “a disposizione della scienza il resto della mia vita” (Roma 13.08. 1942, in cui si felicita anche della fine del lavoro in tigré dell’Antico Testamento, e 30.12. 1942 in cui chiede dei racconti e canzoni in tigré inediti per completare le pubblicazioni di racconti già avute in amarico, tigrino e oromo, garantendo la traduzione dallo svedese per la RSE, il principale e progettuale lavoro fino alla sua morte nel 1949, impegno di disponibilità e generosità di maestro per nuove generazioni. Scrive a Rodén: “Io da molti anni ho lasciato la carica di capo gabinetto del ministro. Raggiunsi il grado di presidente di sezione del Consiglio di Stato; ma ora ho abbandonato il servizio attivo, e metto a disposizione della scienza il resto della mia vita. Ho avuto la soddisfazione d’esser chiamato a far parte della Reale Accademia d’Italia; il che è il massimo che uno studioso possa ottenere in Italia. Certo l’onore è stato maggiore dei miei meriti”. Vd. sulla Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS), la missione per l’estero dei luterani svedesi, il recente K. J. Lundström- Ezra Gebremedhin 2011 e G. Dore 2013: 133-150. 23 In BALC/CR/Corrispondenti compaiono 21 lettere del Reinisch (in tedesco) da 04.03.1894 a 14.04.1914, una delle quali nel periodo qui considerato, il 25.01.1900. In una di queste (15.08.1913) il linguista austriaco si lamenta che il missionario August Andersson non gli abbia spedito il suo lavoro del 1903 (Ett och ennat om Kunamaerna, EFS, Stochkolm) mancando al dovere di reciprocità: “[apprendo] che Andersson ha fatto più pubblicazioni sui Kunama. Mi meraviglia che egli non mi abbia mandato alcuni esemplari, dato che io su desiderio della missione svedese ho dato il mio scritto sulla lingua kunama”. Il missionario svedese Per Lager (1837-1876) aveva aiutato il Reinisch al suo arrivo sul campo per i Nara (Barea), come testimonia il mercante G.A. Haggenmacher, assistente del Munzinger a Kassala (an L. Reinisch, Senhit 29.8.1875, Autograph 747/18-1/ 2 Bl 4 S, nel Fondo Reinisch e nella siglatura Summerauer di cui sotto). Non compaiono invece lettere del CR nelle carte solo
Queste sollecitazioni dunque viaggiano su un doppio binario, sia attraverso la richiesta privata a colleghi, con cui costruisce scambi amicali, sia attraverso la committenza di rapporti areali, che costituiranno gran parte del materiale della voluminosa relazione sulla colonia presentata dal Martini nel 1907 a conclusione del suo mandato. Sempre però saranno inserite in un suo programma scientifico in fieri, sia che muovano dall’interno della produzione di sapere amministrativo, come progettualità istituzionale esitante e discontinua nella sua fase iniziale e fondativa, sia che nascano come iniziativa dei singoli, spesso su sua sollecitazione e valorizzazione. L’area di Kärän, via di accesso al bassopiano occidentale, e le genti di lingua tigrè possono burocratiche sulla carriera accademica della Universität Wien e neppure nel deludente fondo del Reinisch presso l’Archivio della Osterreiche National Bibliotek Wien (Handschrift autograph Sammelung e anche Handschrift/Hanna), dove di notevole per l’area compaiono solo 4 lettere di pugno di Werner Munzinger (ma non le carte che gli diede!). Mancando, oltre diverse corrispondenze, anche quasi tutti i manoscritti dei suoi noti lavori (tranne 28 pagine di appunti Saho e tigrino), l’ipotesi (anche del vecchio bibliotecario in pensione, consultato tramite Gerhard Böhm, presso l’Institutet Afrikanische Geschichte, a Vienna 18.06.2009) è che il suo materiale, essendo lui morto nel 1919, senza figli, e la seconda moglie l’anno prima, sia andato disperso nella drammatica fine dell’Impero e della sconfitta (E. R. Summerauer 1988, con la sezione Briefe, nei cui excerpta compare solo un biglietto di condoglianze di Ignazio Guidi per la perdita della prima moglie, Roma 04.11.1890). Lo stesso CR nel necrologio al maestro austriaco (1920: 681-2) ricordava “il vecchio maestro degli studi cuscitici etiopici” (cui aveva “poche settimane innanzi mandato il primo memore saluto dopo questi anni di guerra”). Lanfranco Ricci nel Symposion sul Reinisch, che si tenne nel 1982 (ma Mukarovski 1987), scrisse sul rapporto tra i due con una paziente collezione di excerpta dai lavori linguistici, in cui – in un lungo arco di tempo – il CR riconosceva il suo debito scientifico anche quando vi era ragione di divergere anche notevolmente, soprattutto sulle lingue non semitiche, e lo avrebbe fatto ad es. nel 1926-27 a proposito della collocazione del Kunama (1987: 279-288). Allora Ricci non aveva avuto modo di consultare le lettere del Reinisch al Nostro (e avrebbe avuto poi parte attiva nella acquisizione dell’attuale fondo presso BALC); e alla sua ulteriore domanda, se cioè esistessero lettere del CR a Vienna, posso ora rispondere negativamente (vd. sopra in questa stessa nota).
essere documentate sia attraverso Bacci e Caffarel, ma soprattutto con i rapporti degli ufficiali di stanza a Aqordät. 24 Mi permetto di venirla a tediare per una mia cosuccia privata. Nel passato anno, essendo costì, avevo accertata la genealogia degli Ad Taclès, i quali, come ella mi insegna, collegansi con gli Habab, gli Ad Temariam e gli Zanadegle. Ora ne avrei bisogno per un lavoruccio che vo preparando sui Bet Adghedè; ma non mi viene fatto di rintracciare il foglio su cui la avevo scritta, e temo forte di averlo lasciato, con molte altre carte, a Roma. Avrebbe Ella la bontà di vedere se Le sia possibile di raccormi nuovamente tale genealogia? Di ciò naturalmente La prego soltanto nel caso in cui, lungi dall’averne disturbo, Le riuscisse comodo e agevole di soddisfare queste mie istanze. Se le sarà possibile di favorirmi tali elementi, gliene sarò sommamente grato (a B., Asmara, 23.12. 1900) Della raccolta di testi tigrè, per cui chiede collaborazione per la documentazione, vi sono più tracce nella corrispondenza e a questo impegno afferiscono i testi in etiopico in Ricordi di un soggiorno in Eritrea, i Documenti per lo studio della lingua tigré del 1903, i canti popolari tigré pubblicati nel 1903-1906 sulla «Zeitschrift für Asyriologie». La ringrazio fin d’ora dei canti tigrè, che mi riusciranno graditissimi. Con l’ultima posta ho spedito in Italia per la stampa un lunghissimo testo, pure in tigrè, contenente le vecchie tradizioni de’ Mensa; credo di aver potuto ricostruire, a grandi tratti s’intende, la storia di quel popolo dal secolo XV in poi. Vuol ridere? Le lotte con gli Ad Temariam per lo Sceb incominciano verso la fine del secolo XVII! Sarebbe, a mio avviso, davvero interessante il poter raccorre, nella lingua locale, le tradizioni storiche di almeno qualcuna delle principali tribù dell’Anseba, ma è sì difficile! (a B., Asmara, 25.02.01)
24 Peleo Bacci riportò in Italia una collezione etnografica oggettuale dalla sua area di amministrazione che donò al Museo di Antropologia di Firenze (1909), dove figura in esposizione in una delle due sale “abissine”.
E ancora sollecita a più riprese: «Guardi che delle promesse ho buona memoria. Ella mi ha promesso tradizioni storiche delle genti a Lei soggette» (a B., 25.04.01). «Mi raccomando di mandarmi – secondo l’intesa – se può i nebtàb tradizionisti e voglia mantenersi equanime degli Ad Sciaraf» (a B., 19.07. [1901]).J Anche Caffarel, che nell’attività giudicante ha interesse a studiare le tradizioni giuridiche in un luogo di confluenza tra altopiano e bassopiano sudanese, dove sono attivi e interattivi diritto islamico e diritti consuetudinari di vari gruppi, anche se non conosce le lingue, concorre all’accumulo di documenti: «Kubssai à scritto i canti tigrigna ed amarici che ti unisco alla presente: mi spiace però che tu ti sia disturbato a dargli un compenso superiore troppo ai suoi meriti».25 Ancor più che in magistrati come Caffarel o Mariano D’Amelio o Ranieri Falcone, il passaggio dell’etnologia giuridica italiana (o giurisprudenza comparata) dalle ricostruzioni e generalizzazioni evoluzionistiche, spesso aprioristiche e astoriche, alla prova del campo ha in Conti Rossini forse il primo interprete, capace anche di mediare e spesso indirizzare i funzionari, come nel caso della raccolta sul diritto consuetudinario dei Loggo Sarda, da lui editato basandosi sui commenti dei Residenti Alessandro Sapelli e Benedetto Mulazzani, ma segnalato per la prima volta dal residente dello Šəәmezäna Giuseppe De Rossi.26 Le tradizioni dei Beni ‘Aməәr e di Sabderat sono privilegiate anche per l’interesse politico per i loro movimenti pastorali, difficilmente controllabili (e tassabili), intorno all’area di confine, che richiedevano contatti e transazioni con i loro capi, e documentazione genealogica. I commenti, che intrecciano situazione politica e studio, sono frequenti: Il Diglal, secondo il solito, non combinò
25 BALC/CR/Corrispondenti: Cheren 25.11.1898. Esito scritto della sua esperienza giudicante, riflessione giurisprudenziale e sintesi dei tentativi di codificazione fu Caffarel 1909. 26 A quest’ultimo tra l’altro il CR dovette la mediazione per consultare l’Evangelo d’oro presso il prestigioso convento di Däbrä Libanos dello Šəәmezäna (Conti Rossini 1901: 177-219) e la commissione della trascrizione del Gädlä del santo Buruk ‘Amlak, che editò molto più avanti. Ma su questo vd. P. Marrassini 2002: 187-210.
nulla. Ma questo affare dei Beni Amer anderebbe proprio studiato a fondo. Qui da Asmara come si fa? Chi può dire se i sospetti abbiano fondamento? Chi far accertare il vero stato interno delle tribù? Bisognerebbe essere sul posto, e senza innamoramenti (a B., 19.07.1901) Per le mie questioni, S. E. ha deciso, e non resta che far eseguire le prescrizioni avute per mezzo del Residente del Barca, appositamente da S. E. indicate. Però privatamente mi permetto di scrivere al Crispi accennandogli l’opportunità di procedere cautissimamente. Io da questa storia di conflitti tra capo dei Beni Amer e capo dei Ad Ocud non mi attendo nulla di buono. Non me lo attendo specialmente ora che, per la recente migrazione di grosse frazioni Beni Amer e per le nostre trattative con gli Hadendoa, son da prevedersi le più attive mene da parte degli Anglo-Egiziani per portarci via gente, se non altro a titolo di rappresaglia. E mancherebbe ancora di vedere Mahmud Scerif passare il confine in seguito al prevalere del partito del Diglal. Questa quistione de’ Begia mi par finora troppo male e leggermente studiata da parte dei funzionari, me compreso (e fatta una lieta eccezione per Lei), che non ho ancora quel concetto chiaro che mi occorrerebbe (a B., 07.09.1901) Le sarei personalmente grato se Ella si compiacesse d’inviare le notizie sui capi e sui notabili della zona, richiestele da S. E. nel maggio passato. Esse mi sono necessarie per poter fare litografare un numero ristrettissimo di esemplari d’un libro di note che S. E. desidera trovare pel suo ritorno. Ora, Cheren è quasi l’unica che mi manchi…Mi perdoni se, in vista dei desideri di S. E., mi permetto di disturbarla. (a B. 16.11.1901) L’interesse si spinge fino ai Kunama appena inglobati con i trattati anche nelle frazioni centro meridionali, anche se si rammaricava di non essersi recato personalmente tra di loro, non avendo partecipato al noto itinerario Martini del 190227: 27 I capi dei Kunama “alti” (cioè kunama koyta e kunama marda) erano stati invitati ad Asmara in visita ufficiale nel
Sebbene a me non sia stato permesso di visitare, ne’ miei quattro anni e mezzo d’Eritrea, le tribù Cunama, con i cui rappresentanti ebbi rapporti soltanto in Tucùl, sede di un feudatario abissino che tende a sottoporne talune al suo dominio, e sebbene quindi non abbia avuto mezzo di far dirette indagini, tuttavia credo esattissima l’accentuazione Cunàma, perché la trovo anche in appunti filologici d’un missionario cattolico defunto, appunti da’ quali trassi alcuni dati e alcuni saggi di lingua cunama, di cui restituii (ma, per carità, non mi dia del linguaiolo!) alla Società Asiatica di Firenze le bozze definitive di stampa sin dal passato settembre” (a Teza, Roma, 5.12.1903).28 In questo caso mediatori sono da una parte ufficiali come Teobaldo Folchi e Ludovico e Alberto Pollera, 29 ma anche i missionari comboniani: il saggio Per la conoscenza della lingua cunama del 1903 si basa infatti sul manoscritto del Padre Leon Henriot, prestatogli proprio dal Padre Bonomi.30 Ma dal punto di vista linguistico i mediatori 1894 (vd. ASMAI, Pacco 23.1885-1913 e anche Pollera 1913: 67). 28 Traggo queste righe dall’unica lettera del Conti Rossini al Teza, dove gli conferma, anche appellandosi alla autorità del Reinisch, acquisita sul terreno, la corretta accentazione dell’etnonimo Cunàma rispetto alla erronea “cunamà”, chiaramente dovuta a un interprete tigrino (Carte Teza, Cod. IT XXIII). Il Teza aveva appena letto, sul «Bollettino della Società geografica Italiana» (BSGI) la relazione del cap. Ademollo sull’itinerario Martini nel 1902 nel bassopiano occidentale eritreo; cfr. E. Teza 1903: 5). Teza compare tra i corrispondenti in BALC/CR. 29 Con Alberto Pollera presso BALC/CR /Corrispondenti, per il periodo qui considerato, c’è una corrispondenza di ufficio che riguarda il lavoro politico amministrativo nel bassopiano occidentale (11 unità dal 14.01.1902 al 18.02.1903). In un’ultima isolata, da Asmara il 12 giugno 1938, chiede un sostegno per la pubblicazione presso il Ministero dell’Africa italiana della grammatica cunama di Padre Giuseppe da Cremona [da Castelnuovo], che rielaborava e completava il vecchio lavoro del 1918 di Padre Anselmo da Ponzone: ”sarebbe questo il primo completo contributo italiano alla conoscenza di una lingua della quale esistono solo i testi compilati dai missionari svedesi”. La prima relazione di Alberto Pollera sui Kunama (maggio 1902) si trova in BALC/CR nella sezione Docc. geografici militari antropologici. Su questa corrispondenza vd. G. Dore, Amministrare l’esotico. La etnografia pratica dei funzionari e missionari in Eritrea colonia, Pàtron, Bologna in preparazione. 30 Una copia che contiene un lessico di c. 2000 lemmi si trova presso BALC/CR e un’altra presso la Biblioteca Pavoniana di Asmara, retta da Ezio Tonini.
fondamentali rimanevano gli interpreti indigeni. Ne è testimonianza questa richiesta al Bacci: Ed ora vorrei pregarla d’un favore. Ho dovuto mandar via, per ubriachezza costante, il mio piantone-interprete. Se alla missione cattolica o altrove costì si trovasse qualche giovanotto che sapesse l’italiano e il tigrè, e scrivesse l’amarico, sarei lieto di prenderlo in servizio. Le dorrebbe di assumere in proposito notizie, e, in caso, di telegrafarmene? (21.12.1901) Nella sua posizione si trovava alla confluenza nevralgica degli affari più vari, dalle disparità di tributi, alla dislocazione dei battaglioni, al riordino delle residenze, carceri, ordini di cattura e repressione di rapine e abigeato, contratti di lavoro e appalti, fino ai provvedimenti per l’istituzione del sifilocomio e contro truffe affaristiche e l’usura perpetrati da mercanti greci a danno dei Nara e dei Kunama. Anche se non sempre Asmara consentiva distacco e una visione complessiva dei fatti politici della Colonia: Per le notizie chiestemi non so che fare se non confermare quanto ebbi a telegrafarle. Stando in Italia, sono più al corrente delle cose eritree di quel che lo sia in Asmara il capo di quell’ufficio di governo al quale un decreto governatoriale affida le relazioni col comando truppe, le residenze ecc. Quel che so è solo per sentito dire in Asmara o per private informazioni di amici. (a B., 25.02.1901) Forse la regione che attirò ancor più delle altre l’interesse governativo, per le sue ribellioni e banditismo sociale dalla rivolta di Batha Ḥagos in poi e per i contraccolpi dei movimenti nelle confinanti regioni etiopiche dell' ʽAgamä e dell'Ǝndärta, è l’Akkäla Guzay, «sede che, sotto questo punto di vista, ritengo la più delicata dell’Eritrea» (a B., 25.04.1901). Nelle lettere i riferimenti sono i più consistenti e sono leggibili in parallelo con le pagine del diario Martini, oltre che, come per le altre, con i file degli archivi coloniali. Conti Rossini viene ad es. mandato di verificare il conflitto tra i Gacaso Casa Yofish (Gaysha) e Rhasamo (Dhasamo) per contese di terreni col mandato di disarmare, e eventualmente multare e confiscare bestiame, compiere arresti e destituire capi (DE, II,
16.04.1900, p. 259), provvedimenti che effettivamente prende e comunica al governatore il 21 da Sänʽafä (ivi l’intero telegramma, p. 270). Nei suoi viaggi di servizio verso la regione e fino allo Šəәmezäna, Conti Rossini raccolse dati linguistici, storici e archeologici. Al Ragali rimane un testo importante anche dal punto di vista metodologico, per la capacità stupefacente di incorporare un dettagliatissimo resoconto del viaggio, lungo una storica via carovaniera e di transumanza tra altopiano e Mar Rosso, in una visione dinamica della posizione dei gruppi Sāho nell’area. Malgrado egli dichiarasse di lasciare ai funzionari sul posto come Rinaldo Bruna31 “la cura di questa gente” saho, i suoi rilievi o la riorganizzazione dei dati raccolti da altri furono illuminanti. Per la lingua saho si servì di ascari Sāho Casa Lesan in forza al terzo battaglione ascari, esprimendo il rammarico di non aversi potuto recare direttamente sul campo per avere «almeno un certo controllo dell’opera de’ nostri interpreti durante il viaggio» e senza il sussidio del precedente lavoro del Reinisch durante la rilevazione.32 Più tardi, nel 1913, utilizzerà gli appunti raccolti per scrivere sugli Irob dell’ʽAgamä, tracciandone la possibile traiettoria storica nel processo di formazione e espansione delle frazioni parlanti Sāho. In questo saggio, come nel coevo Schizzo etnico e storico delle popolazioni eritree (1913), matura anche la sua riflessione sulla tradizione orale e sui materiali folklorici, verso cui non ha un atteggiamento liquidatorio, ritenendo che i dati orali incorporati nei vari generi possano diventare fonte storica se - dinanzi ai particolari che le esigenze mutevoli e storiche della collettività o le manipolazioni genealogiche di famiglie, individui e gruppi rendono inattendibili - si riesce a cogliere “l’essenziale”. L’attendibilità storica per Conti Rossini può essere accertata sia istituendo un rapporto con testi epigrafici, cronache scritte e i testi ecclesiastici (marginalia compresi) sia con risultanze archeologiche e con gli elementi fisico
31R. Bruna 1907: 1657-1732; cfr. M. Zaccaria 2009. 32 Schizzo del dialetto Saho dell’Alto Assaorta in Eritrea venne pubblicato solo nel 1913, rivedendo e criticando il precedente lavoro pre-linguistico di Ilario Capomazza.
geografici che rendono plausibili o improbabili ipotesi di etnogenesi, comunque mai intesa come cominciamento assoluto, ma piuttosto come stratificazione dinamica di provenienze, spostamenti, rapporti gerarchici tra gruppi, come tassello di una storia di circoscrizioni regionali, i cui confini si sono formati nelle vicende storiche e nei mutevoli rapporti di potere. Distillare questa “essenza storica”, è possibile con l’esercizio di una “filologia coloniale”, per la quale uno dei suoi riferimenti espliciti è il classicista Salomon Reinach, evoluzionista, propugnatore di una “antropologia sociale” da applicare alle società classiche, traendo lumi dalle società etnologiche contemporanee, e sostenitore di una filologia dei testi classici e biblici. 33 Conosciuto per i suoi voluminosi saggi in francese, in cui intrecciava archeologia, storia e filologia, del Reinach uscì nel 1910 in italiano una Storia generale delle religioni. L’incipit del testo Irob non era forse già una operazione, compiuta da un intellettuale interno, di costruzione di un racconto storico lineare, con il passaggio dall’orale allo scritto e con una comparazione e scelta tra più versioni orali, che ora il Nostro si incaricava di costruire come nuovo documento per la storia dell’etiopistica non semitica? Appare di interesse che questa riflessione, in cui si valorizza ciò che i gruppi pensano di se stessi e della propria storia, si misuri anche con studi antropologici europei sensibili agli aspetti simbolici e sociologici, come la Formation des légendes del Van Gennep, uscito nel 1910, forse già conosciuto nel suo soggiorno parigino, al cui eccesso di prudenza oppone che il valore storico di questi generi orali può essere sondato nel suo variare secondo il popolo e l’area culturale di volta in volta considerati. 34 Nella introduzione al
33 Il Reinach, primo presidente nel 1911 dell’Institut français d’Anthropologie, fu di una certa importanza per l’impianto della storia delle religioni in Italia, per la filologia storica e archeologica sui testi biblici. Di una storia comparata delle religioni iniziava ad essere protagonista Raffaele Pettazzoni e in essa potevano iscriversi anche i lavori degli etiopisti sulla storia della Chiesa e del cristianesimo etiopico, programmaticamente considerati parte di un grande Oriente cristiano e bizantino (cfr. P. Marrassini 1986: 170 et passim). 34 In una recente storia delle discipline demo-etno-antropologiche italiane Enzo Alliegro, che ha comunque il merito di includervi gli “orientalisti” del Corno d’Africa, nota che il CR non avrebbe mai compiuto un lavoro intensivo su un territorio circoscritto e steso una monografia, intendendo
lavoro su Tradizioni proverbi e canti tigrini (1942) chiariva retrospettivamente il suo metodo: «Per richiesta mia, durante i miei lontani anni di vita eritrea, mi furono stesi da Eritrei i testi che qui pubblico: una collezione di proverbi, un centone di tradizioni e leggende su genti della nostra vecchia colonia, una raccolta di canzoni, delle quali a fianco di quelle composte nello Hamasèn e nell'Acchelè-Guzài, ve ne sono numerose altre dei paesi d'oltre Mareb, segnatamente d'Agamè e di Enderta» (scritta il 20 dicembre 1938). I rapporti del Conti Rossini con settori come il folklore e le tradizioni popolari erano mediati dal comune interesse per generi come i canti, leggende, miti, usi nuziali e funebri, e proverbi (questi anche oggetto di interesse per la giurisprudenza comparata) e condiviso con gli altri orientalisti. 35 Il Conti Rossini non si è peraltro mai considerato o definito etnologo o folklorista, anche se con questi versanti ha sempre stabilito un colloquio e anche se molto tardi, nel 1947, con la fondazione da parte del Pettazzoni dell’Istituto di civiltà primitive, ebbe all'Università di Roma un incarico di Etnologia africana. La sua auto-collocazione è sempre stata nella storia e nella linguistica e filologia storica, arealmente definita da un grande Oriente cristiano che si spingeva fino al Mar Rosso, e la via privilegiata di accesso alla storia e alla cultura di una regione era la padronanza della lingua, costante di lunga durata di questo settore specialistico. 36
evidentemente esclusivamente la monografia etnologica secondo il modello prescrittivo di organizzazione testuale inaugurato dal Malinowski e poi stabilizzato da Evans Pritchard. A parte l’errore di prospettiva sulla collocazione disciplinare e un certo anacronismo e un assolutismo sulla retorica del testo, l’intera opera di Conti Rossini può considerarsi – certo non sostenuta da un approccio funzionalista e sincronico - una gigantesca monografia sull’altopiano eritreo e le sue relazioni con le terre e genti confinanti! (E. V. Alliegro, Antropologia italiana. Storia e storiografia (1869-1975), SEID, Firenze 2011, pp. 215-216). 35 La condivisione di questi generi con folklore e etnologia non è in sé identità di campo disciplinare; per questo utilizzo la nozione di “discipline dell’esotico”, che permette inclusioni senza perdere i mutevoli confini specialistici. CR su questa condivisione, mediata però dalla linguistica, ebbe rapporti con altri intellettuali tardo ottocenteschi come Angelo De Gubernatis, attivissimo fondatore della Rivista di tradizioni popolari (1893-95), che compare tra i corrispondenti in BAL/CR. 36 Lo rimarcava il Ricci per il periodo e anche per la fase più vicina in cui l’etnologia gli appariva configurarsi come un settore anche più fortemente distinto (Ricci 1986), mentre il Marrassini, nel ribadire come la linguistica comparativa o
Semmai nel tempo la relazione più interessante fu quella istituita con Raffaele Pettazzoni, che, soprattutto dalla seconda decade del ‘900, condusse una tenace battaglia per affermare la legittimità scientifica e accademica di una storia delle religioni in Italia, e con cui poteva utilmente interagire sia come africanista, afferenza fortificata dall’essere entrambi aderenti all’ Institute of African Languages and Cultures,37 sia come storico del cristianesimo e anche, in chiave comparata, delle religioni sud-arabiche. Si deve ad entrambi se gli studi italiani poterono mantenere negli anni ’20 e ’30 una apertura con i corrispondenti settori specialistici internazionali.38 philology potesse esercitarsi su una koinè culturale e storica, rimarcava il deficit che derivava dal non partire nella semitistica comparata dallo studio delle “grandi lingue letterarie (incluso quindi il ge’ez)” e insieme notava come studi etiopici fosse definizione areale che doveva ormai ammettere l’azione unitaria ma distinta di diversi specialismi (Marrassini 1986). 37 Il Nostro era anche rappresentante per l’Italia nel Consiglio dell’Istituto (nel 1936 vi figuravano anche Francesco Beguinot e C. Alfonso Nallino). 38 In BALC/CR/Corrispondenti interessa per i periodi successivi una lettera di Pettazzoni sulla confessione sud-arabica dei peccati e sulla collaborazione per la sua rivista «Studi e materiali di storia delle religioni» (SMSR) (03.09.1934). La prima ragione del riconoscersi tra orientalisti come CR e Pettazzoni era il comune orientamento storicista (vd. R. Pettazzoni 1935-37). Nel Fondo Pettazzoni, Biblioteca G.B. Croce a S. Giovanni Persiceto (BO), ci sono 6 lettere speditegli da CR (da 12.03.1927 a 21.03.1939) tra le quali: un ringraziamento per l’invito a un articolo per SMSR “sulla storia religiosa delle contrade africane di cui mi interesso”, proprio mentre è impegnato nella stampa della Storia d’Etiopia antica [1928], e propone un contributo su “i vari stadi delle credenza religiose non cristiane in Abissinia e sovra residui di paganesimo presso i cristiani” (6.07.1927); un riferimento alle ”nostre conversazioni sulla confessione nell’Antica Arabia meridionale” (12.03.1930). Rilevante la lettera 26.01. [1939] perché si giustifica, appellandosi alla sua naturale ritrosia a apparire in pubblico, e al riserbo per l’essere sotto candidatura all’Accademia d’Italia, dinanzi a una critica, implicitamente politica, rivoltagli per la sua assenza al noto Convegno Volta del 1938, in cui Pettazzoni fu chiamato a pronunciare la prolusione di apertura, dove tra l’altro aprì alla etnologia funzionalista e applicata, lì rappresentata da due relazioni di B. Malinowski in absentia. Considerata la scarsa autonomia disciplinare dell’etnologia in Italia, al tempo fu Pettazzoni a garantire un collegamento: non a caso, nella Enciclopedia italiana, Folklore fu sottosezione di Storia delle Religioni, sotto la sua direzione, mentre la sezione Etnologia venne posta, defunto Aldobrandino Mochi nel 1929, sotto la
L’interesse per la storia etiopica valorizza i resti archeologici e si espande, con notevole intuito, dall’altopiano anche nelle rimanenze nel bassopiano occidentale. 39 Negli spostamenti di ufficio, Martini segnala come il Conti Rossini, che lo accompagnava, andasse a ricercare tracce, come nel caso dell’antica Dəәbarwa, individuandone le rovine («conversazione istruttiva col Conti Rossini circa la storia etiopica», DE, III, 04.06.1900) e esaminasse, verso il colle Amba Täriqa, usciti da Sänʽafä, un «grande monolite con iscrizione della quale CCR prende copia che reputa incompiuta» (DE, II, 18.06.1900). Ma i resti più prestigiosi, anche valorizzabili, erano sul Qoḥayto: «io sarei pronto a spendere qualche migliaio di lire, ma chi è capace di dirigere intelligentemente gli scavi? Si può fidarsi della scienza del Conti Rossini? Videbimus infra» (DE, II, 20.06.1900). Verso la fine del Governatorato avrebbe rivendicato per sé sensibilità e lungimiranza verso le ricerche per rispondere a una intervista del senatore Pippo Vigoni, che ne denunciava invece la negligenza verso i siti archeologici in Eritrea e nel Təәgray, vantando a sostegno, un colloquio con lo stesso Conti Rossini, ormai in Italia, in cui si contrapponevano come esempio positivo le missioni Rosen a Axum e dello stesso August Littmann,40 che Conti Rossini aveva incontrato quando era giunto in Eritrea per studi sulle popolazioni di lingua tigrè.41 Martini rivendicava di avere proposto al Conti Rossini la pubblicazione di Archivi eritrei, di avergli promesso un sostegno finanziario per la Storia d’Etiopia (che sarà però pubblicata solo nel 1928) e per scavi nel Samaraccion, di aver sostenuto la
direzione di Renato Biasutti, che diresse anche la sezione Geografia (e la sua organizzazione delle voci relative garantì questo stabile rapporto con gli studiosi del Corno d’Africa, base fondamentale della successiva collaborazione all’opera enciclopedica Razze e Popoli della Terra). Su questo Dore 1987. 39 Vd. Documenti per l’archeologia eritrea nella bassa valle del Barca, Acc. Dei Lincei, Roma, 1904. 40 In BALC/CR/Corrispondenti compare una busta Enno Littman e compaiono anche nomi di altri importanti semitisti d’area germanica come Theodor Nöldeke. 41 L’intervista comparve nella Cronaca Coloniale dell’ «Esploratore commerciale», fasc. 3, 1906, dove si citava il lamento del Conti Rossini che “a stranieri sarebbe toccato onorare la Roma abissina” (BSGI, gennaio 1906).
missione Loria Mochi, a conclusione del convegno di Asmara del 1906, il libro del Perini sul Märäb Mällaš e di Rodèn sulle leggende e canti popolari Mänsa (DE, IV, 27.02.1906, p. 234). Bibliografia Alliegro, E.V. 2011, Antropologia italiana. Storia e storiografia (1869-1975), SEID, Augusti, E. 2013, “Da Asmara a Tripoli (1899-1922). William Caffarel e l’amministrazione della giustizia d’Oltremare”, in G. Dore - C. Giorgi - A. Morone - M. Zaccaria (a cura), Governare l’Oltremare. Istituzioni, funzionari e società nel colonialismo italiano, Torino, Carocci,pp. 87-102. Bruna, R. 1907, “Monografia sulle popolazioni dell’Acchele Guzai”, in Governo dell’Eritrea, Relazione sulla Colonia Eritrea, 32, Camera dei Deputati, Roma, pp. 1657-1732 Caffarel, W. 1909, La codificazione del diritto eritreo, Roma, Unione Coop. Editrice Conti Rossini, C. 1900, “Ricerche e studi sull’Etiopia”, BSGI, ser. IV, vol. I, pp. 104-120 Conti Rossini, C. 1901, “L’Evangelo d’oro di Dabra Libānos”, RRAL, ser. V, 10, pp. 177-219 Conti Rossini, C. 1913 “Schizzo storico delle popolazioni eritree”, in L’Eritrea economica, Roma, vol. I, Novara, pp. 61-90 Conti Rossini, C. 1913a, “Gli studi etiopici in Italia nel primo cinquantennio di vita nazionale”, Rivista di studi orientali (RSO) 5, fasc. I, pp. 15-19 Conti Rossini, C. 1913b, “Schizzo del dialetto Saho dell’Alto Assaorta in Eritrea”, in Rendiconti dell’Accademia dei Lincei 22, fasc. 5, pp. 151-246 Conti Rossini, C. 1916, Principi di diritto consuetudinario dell’Eritrea, Roma, Tip. Unione Editrice Conti Rossini, C. 1920, “Leo Reinisch (Necrologia)”, Rivista di studi orientali 8, pp. 681-2, Conti Rossini, C. 1935, “Commemorazione di Ignazio Guidi”, Rendiconti R. Accademia d’Italia (RRAL), Ser. 6, II, pp. 471-481 Conti Rossini, C. 1942, Proverbi, tradizioni e canzoni tigrine, Collezione scientifica e
documentaria dell’Africa italiana, vol. V, Verbania, Aitoldi. Crescini, V. 1914, Emilio Teza, Venezia, Off. Grafiche Dore, G. 1987, “La sezione Etnologia della Enciclopedia Italiana nel carteggio dell’Archivio storico Treccani”, in Centro culturale francese (a cura), L’etnologia francese e italiana degli anni Trenta, Milano, Franco Angeli, pp. 225-238 Dore, G. 1993 “I documenti inediti di Giovanni Ellero sull’Etiopia”, Africa, XLVIII, 1, 21-46 Dore, G. 2000, “Giovanni Ellero: un funzionario nell’Impero d’AOI. Amministrare e conoscere nell’Eritrea e nell’Etiopia d’età coloniale”, in Uoldelul Chelati Dirar-G. Dore (a cura), Carte coloniali. I documenti italiani del Fondo Ellero, Torino, L’Harmattan Italia, pp. 3-25 Dore, G. - J. Mantel Nečko - I. Taddia 2005, I quaderni del Wälqayt. Documenti per la storia sociale dell’Etiopia, Torino, L’Harmattan Italia Dore, G. 2013, “Catechisti e evangelisti come mediatori culturali nella Colonia Eritrea”, in G. Dore et alii, Governare l’Oltremare. Istituzioni, funzionari e società nel colonialismo italiano, Torino, Carocci, pp. 133-150 Frati, C. 1913, Bibliografia di Emilio Teza: indice cronologico de’ suoi scritti e di quelli che lo riguardano 1855-1913, Venezia, Ed. Ferrari Giorgi, C. 2012, L’Africa come carriera. Funzioni e funzionari del colonialismo italiano, Torino, Carocci Guazzini, F. 1999, “Fonti per la storia del colonialismo italiano in Eritrea”, Le Carte della storia 5, I, pp. 144-7 Guazzini, F. 2000, Un documento inedito di etnografia giuridica. Esperimenti di catalogazione degli usi nella colonia Eritrea, Facoltà di Giurisprudenza/Facoltà di Scienze politiche (estr.) Gori, A. 2002, “Nuove acquisizioni al Fondo Conti Rossini dell’Accademia nazionale dei Lincei”, Rassegna di Studi Etiopici (RSE) v. I, 1, pp. 161-74 Israel, F. 2012, “Studi su Graziadio Ascoli semitista: conoscenze dell’etiopico”, in A. Bausi et alii, Aethiopica et Orientalia. Scritti in onore di Yaqob Beyene, vol. I, collana dipartimentale di Studi Africanistici - Serie
Etiopica, Dipartimento di Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi-Università L’Orientale di Napoli, Napoli, pp. 341-366 Levi Della Vida, G. 1935, “L’opera orientalistica di Ignazio Guidi”, Oriente moderno 15, pp. 236-248 Lundström, K. J. - Ezra Gebremedhin 2011, Kenisha. The Roots and Development of the Evangelical Church of Eritrea, Trenton N.J., Red Sea Press Marrassini, P. 1986, “Studi di etiopistica”, in Atti del Convegno «Gli studi africanistici in Italia dagli anni ’60 ad oggi» (25-27 giugno 1985), Roma, Istituto Italo Africano, pp.167-173 Marrassini, P. 2002, Gli studi di filologia e storia e i militari italiani in Eritrea, Società italiana di storia militare, Quaderno 2001-2002, pp. 187-210. Martone, L. 2013, “Caffarel William”, in I. Birocchi- E. Cortese- A. Mattone- M.N. Miletti, Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, vol. I, Bologna, Il Mulino, p. 371 Melis, G. (a cura) 2007, Il Consiglio di Stato nella Storia d’Italia. Le biografie dei Magistrati (1861-1948), II vol., Giuffrè, Milano, pp. 1398-99 G. Mukarovsky (a cura), Leo Reinisch. Werk und erbe, Österreichischen Akademie des Wissenschaften, Wien, pp. 279-288 Nallino, C. A. 1949, “Bibliografia degli scritti di Carlo Conti Rossini”, Oriente moderno 29, ff. 7-9, pp. 103-112 Peca Conti, R. (a cura di) 1976, Carteggio Graziadio Ascoli-Emilio Teza, Napoli Pettazzoni, R. 1935-37 “L’Etnologia come scienza storica”, Rivista italiana di Antropologia, XLI,, 455-457. Pollera A. 1913, I Baria e i Cunama, Roma, Reale Società geografica, Unione Ed. Ricci, L. 1986, “Studi di etiopistica”, in Atti del Convegno «Gli studi africanistici in Italia dagli anni ’60 ad oggi» (25-27 giugno 1985), Roma, Istituto Italo Africano, pp. 159-166 Ricci, L. 1987, “Leo Reinisch e Carlo Conti Rossini”, in G. Mukarovsky (a cura), Leo Reinisch. Werk und erbe, Österreichischen Akademie des Wissenschaften, Wien, pp. 279-288 Rivista di studi orientali 1927, Gli studi orientali in Italia durante il cinquantenario 1861-1927, fasc. II (vol. monografico) 1919-1927 Scardigli, M. 1999, Il braccio indigeno.
Ascari, irregolari, e bande nella conquista dll’Eritrea 1885-1911, Milano, Franco Angeli Summerauer, E.R. 1988, Der nachlaß Reinisch in der österreichchischen Nationalbibliotek, Wien, WUV, Universität Verl. Teza, E. 1903 “A proposito del nome "Cunāma. Lettera al Presidente della Società geografica italiana”, BSGI, ser. IV, vol. IV, fasc. 12 (dicembre), pp. 1016-18( estr. Stab. Civelli, Roma, 1903s) Zaccaria, M. 2009, Le note del commissario. Teobaldo Folchi e i cenni storico amministrativi sul commissariato di Massaua (1898), Milano, Franco Angeli Zagnoni, S. 1993, L’Eritrea delle piccole città. 1896-1936, in C. Gresleri- et alii (a cura), Architettura italiana d’oltremare 1870-1940, Venezia, Marsilio, pp. 145-193





















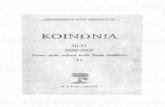





![La psicologia italiana tra scienza e filosofia: Una prassi senza teoria? [Italian psychology between science and philosophy: A practice without theory?]. Il Giornale Degli Psicologi,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314759a3ed465f0570b27d9/la-psicologia-italiana-tra-scienza-e-filosofia-una-prassi-senza-teoria-italian.jpg)