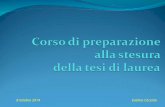Bozza di tesi
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Bozza di tesi
Annoscolastico 2008/2009
Con questo termine venne contrassegnato lo stile di vita, ilmondo di alcune classi sociali alla fine del XIX e inizio XXsecolo.
Lo sviluppo commerciale ed industriale, l’assenza di guerre,l’espansionismo coloniale furono elementi fondamentali perl’arricchimento della vecchia nobiltà teriera e permiserol’affermazione della nuova aristocrazia imprenditoriale.
Le scoperte e le invenzioni apportarono una svolta dal punto divista tecnologico: si diffusero il telefono, il microfono, ilgrammofono, la fotografia, il cinematografo dei fratelliLumiere, pochi anni dopo Torino diviene capitale del cinemaeuropeo precursore di Hollywood.la bicicletta, l’automobile, lamacchina da scrivere, l’energia elettrica che lentamentesostituisce le macchine a vapore.
Nel 1913 con Ford, è applicata nell’industria l’organizzazionescientifica del lavoro, proposta da Taylor, che basandosiesclusivamente su esigenze di tipo economico, contribuirà allamassificazione ed all’alienazione del singolo operaio.
Si assiste anche ad un notevole incremento demografico (nel1913 la popolazione europea arriva a 468 milioni di individui),controbilanciata, tuttavia, da una forte spinta versol’America.
All'alta borghesia europea faceva da contorno una piccolaborghesia di provincia e la nuova classe dei colletti bianchiche si identificava negli impiegati, artigiani e professionistinecessari per mandare avanti l'apparato industriale. Le città
2
crescevano a dismisura con l'inurbamento degli operai e di paripasso andava la frequenza scolastica che riduceva, partendodalle classi una gigantesca emigrazione che vide partire circa5.000.000 di persone nei primi 50 anni dell'Unità del paese.
I caffè letterari erano sempre pieni di giovani autori dallavita sociale molto brillante (D'Annunzio), i teatri colmi perle grandi dive (Duse e Bernhardt).
Le rotative dei giornali ora sfornavano decine di riviste acolori e quotidiani, sui quali a puntate comparivano gli ultimiromanzi dei francesi (Feuilleton), di Conan Doyle (SherlockHolmes).
Parallelamente al progresso, si assiste anche ad una nuovaattenzione per il lusso e la mondanità, ossia emerge lanecessità di esibire il proprio status mediante virtuosismiartistici e spettacolarizzazione della vita.
I ceti alti si dedicano fondamentalmente alla vita notturna, al3
viaggio e all’arte: i cabarets offrono la possibilità diapparire e di far parlare di se mediante scandali evicissitudini amorose; il cosmopolitismo non è più finalizzatoad un fatto culturale, bensì ad un interesse per la novità eper l’esotico.
Se nella bacchettona Inghilterra vittoriana gli eccessifrancesi del Moulin Rouge non arrivavano, arrivava comunque laricchezza delle colonie e dei prodotti esotici attraverso ilcanale di Suez. Edoardo, erede al trono inglese, suppliva dasolo alla mancanza di mondanità di corte vivendo in piantastabile a Parigi.
Contemporanei ai grandi successi economici e sociali, c'eranoi grandi bluff, scandali o truffe che dir si voglia. Un trenoesotico ed esclusivo, l'Orient Express, collegava Parigi con ladecadente Costantinopoli ed un altro si preparava a partire daMosca (1901) per la lontana Cina. L'automobile non volle essereda meno e nel 1907 (10 giugno) da Pechino partirono 10equipaggi destinazione Parigi.
Due costruttori di biciclette, i fratelli Wright davano formaal sogno di Icaro; si poteva volare, era il 1903. I nuovi mezzie le conoscenze tecniche spingono i nuovi esploratori nelleregioni del globo che fino a quel momento sono rimastesconosciute. Edwin Peary nel 1909 viola il Polo Nord e due annidopo tocca a Amundsen per quello meridionale. Il 31 maggio 1911dai cantieri navali di Belfast esce la più grande nave delMondo, il Titanic: nel freddo mare del nord, al largo dellecoste britanniche, una collisione con n iceberg faceva colare apicco il transatlantico che da solo rappresentava il trionfodella tecnologia e con essa le speranze e i sogni di un interosecolo, l’800.
Oltre 1600 uomini e donne perirono nella tragedia. I più poverierano stati rinchiusi nelle stive. Non dovevano contendere aipiù ricchi il posto sulle poche scialuppe di salvataggio.
Speranze e sogni che in quella fredda mattina di primavera del
4
1912 affondavano anch’esse aprendo le porte ad un secolo tra ipiù turbolenti della storia umana, ma anche ll più ricco dirapide trasformazioni nella vita e nei costumi.
ROYAL MAIL STEAMER TITANIC
5
Con più di dieci anni di ritardo rispetto alle date riportatesui calendari, si concludeva definitivamente il XIX secolo, ilsecolo della "belle epoque", periodo di stabilità politica edindiscussa supremazia europea che era troppo a lungosopravvissuta a se stessa.Centinaia di migliaia di tonnellate di acciaio, saloni e cabinearredate con lo stile e con la ricchezza di stucchi e dipreziose tende e raffinato mobilio che caratterizzavano lecorti ed i teatri di tutto il Vecchio Continente. Gli scaloni ei ponti facevano invidia alle scalinate ed ai ballatoi diVersailles o dei migliori teatri viennesi. Le pietanzepreparate nelle cucine di bordo e i vini conservati nelle stivegareggiavano tranquillamente con i cibi e le bevande servitenei più raffinati ristorati di Roma e di Parigi.Come l'Oriente Express, il Titanic simboleggiava il predominioincontrastato della meccanica e della scienza. Incarnava, così,il simbolo del pensiero positivista ottocentesco per il qualela scienza e la tecnologia risolverebbero tutti i problemidegli uomini arrivando, per alcuni, anche a sconfiggere lamorte. Giuste speranze e giusti riconoscimenti allo sviluppodegenerati da fede granitica nel progresso a una sorte didelirio collettivo.Bastarono pochi metri cubi di ghiaccio per porre fine a tuttociò.
Lo choc nelle coscienze europee fu enorme. Ciò cherappresentava tutti i valori in cui si era fino a quel momentocreduto senza dubbi o remore naufragava miseramente in baliadelle forze della natura portandosi dietro le vite di centinaiadi uomini rimasti imprigionati nel ventre della nave.
Il Titanic anticipò solo di un paio di anni quella frattura nella storia europea che nella primavera del 1914 avrebbe definitivamente spazzato via intere nazioni e causato la Prima Guerra Mondiale.Infatti, a soli 24 mesi dal naufragio del transatlantico ritenuto inaffondabile, i popoli europei si combatterono gli
7
uni con gli altri ponendo fine ad un equilibrio tra le nazioni.
Come ha scritto qualcuno, dopo "Nulla fu più come prima".Tecnologia e scienza non furono più usate per migliorare e allungare la vita degli uomini, ma per creare armi di distruzione di massa e di sterminio collettivo.Ciò che fino ad allora era stato la speranza dell'umanità divenne il suo peggiore incubo.Anche la cartina dell'Europa uscì completamente ridisegnata dalconflitto.Tre millenari imperi, Impero d'Austria - Ungheria, Impero ottomano, Impero zarista, cesseranno di esistere e saranno smembrati.
Ma L’immagine della Belle Epoque è legata, proprio per laconnotazione di "età gaudente" che ha assunto nella nostramemoria, a eventi e caratteristiche sociali e di costume, piùche ad avvenimenti politici e storici.
IL MALIZIOSO CAN CANL’audacia e la malizia di questo ballo fu tale che il can can divenne il simbolo universalmente riconosciuto della Belle Epoque. Naturalmente osteggiato con forza dai benpensanti. Purtroppo per quest’ultimi, il Moulin Rouge fece scuola, e sorsero per tutta la città (soprattutto nella zona di Pigalle) club e locali dello stesso tipo come le Folies Bergère.
Contemporaneamente si sviluppava lo spettacolo del music-hall,i cui eroi furono Maurice Chevalier, la Bella Otero, LinaCavalieri. In quegli anni non era solo un audace can can acostituire motivo di scandalo.
Oscar Wilde
Grandi clamori susciterà l’arresto dello scrittore e poeta diorigine irlandese Oscar Wilde. L’accusa, omosessualità, loporterà a scontare due anni di lavori forzati. L’autore di "Il
8
Ritratto di Dorian Gray", "Salomè" e "La Ballata dal carcere diReading" (nata dall’esperienza in prigione) morirà il 30novembre 1900 a Parigi.E’ durante l’età vittoriana che egliemerge come uno dei più particolari scrittori dell’epoca che siimpose per la scelta estetica e per il tipo di vita:
.
Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde (16 October 1854 – 30 November1900) was an Irish playwright, poet and author of numerous shortstories and one novel. Known for his biting wit, he became one of themost successful playwrights of the late Victorian era in London, andone of the greatest celebrities of his day. Several of his playscontinue to be widely performed, especially The Importance of BeingEarnest. As the result of a widely covered series of trials, Wildesuffered a dramatic downfall and was imprisoned for two years hardlabour after being convicted of "gross indecency" with other men. AfterWilde was released from prison he set sail for Dieppe by the nightferry. He never returned to Ireland or Britain.
In the outstanding figure of this “fin de siècle” generation. he wasborn in Dublin from aristocratic Celtic parents, and from his mother,who was very disappointed at not having a girl, he received the bestfemale upbringing. In Oxford he distinguished himself for his talent,and later in London attracted attention by his eccentricity and hisinsulting wit. His collections of tales, among which “The happy prince”(1888) and “a House of Pomegranates” (1892) are the most famous,
9
display a certain fantasy and artificiality. The writer expressedhimself unreservedly in “the picture of Dorian Gray”(1891) where hisaestheticism is found in all its aspects: from the search for raresensations to the ban of every feeling or belief which might in someways hinder the faculty of enjoyment, to the superiority of the artistover the rules of society and morality.
Wilde’s real popularity, however, came from a series of comedies hewrote, starting with “Lady Windermere’s Fan” (1892) and reaching itsclimax with “the importance of Being Earnest (1895). These playsrevitalized the English stage which had lain dormant for over a centuryand showed Wilde’s gifts for dramatization, for sophisticated dialoguesand for gay absurdity; but sound rather empty to today’s audiences.
Married and with two sons, Wilde fell the victim of homosexuality andunfortunately mixed hi aesthetic theories with real life stubbornlycarrying his fight into the English courts. During the trials, whichbecame the scandal of he age, he rejected his friends’ advice to escapeto France and answered disrespectfully to the prosecution’s charges ofhomosexuality. He was condemned to two years of hard labour in ReadingGaol. His wife left him, his plays were taken off the stage and hisproperties sold at auction; but distress natured his utterance andinspired two of his best works: the explanatory letter “De Profundis”(1896) written during the years of imprisonment, and “the Ballad ofReading Gaol” (1898) written in France, where hi had retired to spendthe last years of his life in squalor and poverty.
10
Gabriele D’Annunzio
La figura di Gabriele D’Annunzio, con i suoi eccessi, le suegrandezze e piccolezze, è indissolubilmente legata con ilperiodo della Belle Epoque nella Roma di fine secolo.Riconosciuto talento sin dalla più giovane età, il giovaneGabriele giunse a Roma con la reputazione già consolidata dellapromessa e dell’adolescente prodigio di scuola carducciana.Accolto con tutti gli onori dai salotti importanti, strabiliatidalle prime opere del diciottenne, come "Canto nuovo".
Eroe decadente, raffinato cultore del bello, abbraccia lateoria di Nietzsche del “superuomo” uniformandolo a se e aisuoi personaggi, visionari di una solitudine vissuta consuperiorità e disprezzo. Egli stesso visse senza regole emorale giacchè “fatte dai deboli per i deboli”.
Maestro nel rielaborare le correnti letterarie con un usoelegante della lingua, estetizzante, per l’uso raffinato,
11
prezioso e musicale del linguaggio.
Le caratteristiche della sua scrittura furono appunto lamusicalità, l’estetismo (le vergini delle rocce, il fuoco), ilsuperomismo, il panismo (le laudi). Sue le opere teatrali “lafiglia di Iorio” e “la Gioconda” e i romanzi “l’innocente” e“il trionfo della morte”.
Correva il 1883, e lo stesso annol’apprendista "vate" si sposava con la duchessina MariaHardouin. Due stagioni distinte a Roma caratterizzarono la vitadel poeta di Pescara, la prima in giovane età, la seconda daautore affermato de "L’innocente" e "Il Trionfo della morte".In quest’ultima Roma la vita sociale scorreva al ritmofrenetico della vacuità, e anche D’Annunzio vi si immerse dasubito. Tra flirt riconosciuti (Barbara Leoni, detta"Barbarella") o meno, D’Annunzio condusse una vita tra laprolifica creazione letteraria, l’attività giornalistica sugiornali come la "Tribuna" e la partecipazione agli eventicittadini, come ad esempio la frequentazione del famoso CaffèGreco.
Cresciuto in fama e riconoscimenti, Gabriele D’Annunzio avrebbeseguito il richiamo della "Ville Lumiere". Parigi lo accolse dasubito a braccia aperte, da sempre favorevole ad accogliere nelproprio seno le novità letterarie. In quel periodo era arrivatonella capitale francese con alle spalle buona parte della suapiù nota produzione: "Il Piacere", "Giovanni Episcopo", "Le
12
Elegie Romane". Contemporaneamente al trionfo dannunziano interra francese, arrivava a Parigi anche l’attrice EleonoraDuse, che vi avrebbe mietuto molti successi, in concorrenza conun altro mito, Sarah Bernhardt. La Duse giungeva a Parigi conla fama non solo della grande artista, ma anche con quella delgrande amore di D’Annunzio. Con l’anno 1900 si concludeva ilsecolo diciannovesimo, ma solo formalmente.
Il piacere
Nel Piacere, d’Annunzio delega il compito di raccontare gran parte della vicenda a un narratore in terza persona singolare, inoltre, nel capitolo quarto del libro secondo, il narratore a sua volta lascia che parte della vicenda venga appresa mediante il diario di un personaggio.
Per distinguersi dal narratore, d’Annunzio fa si che il narratore lo citi ben due volte: una volta come un “poeta contemporaneo” che Sperelli predilige, e una seconda volta come autore di un “emistichio sentenziale” caro allo stesso personaggio.
Questo narratore-autore è un narratore onnisciente: interviene a integrare il punto di vista dei personaggi, a spiegare e a puntualizzare; si lascia andare ad anticipazioni e a premonizioni; non esita a farsi avanti in prima persona per attestare la veridicità di qualcosa. Tuttavia l’onniscienza del narratore non gli impedisce a volte di utilizzare il punto di vista interno di svariati personaggi.
Il narratore è solito intrecciare i piani temporali, tagliando e saldando a suo piacere momenti diversi, anche attraverso ellissi che provvede poi a integrare mediante il ricorso a più o meno diffusi flashback.
L’oggettività di partenza viene quasi sempre sopravanzata e cancellatadagli interventi personali e soggettivi del narratore, che anche nel corso delle descrizioni si inserisce continuamente con le sue valutazioni personali introdotte da formule come “quasi direi
Il mondo raffinato ed elegante di Andrea Sperelli trova a livello espressivo una precisa corrispondenza nella lingua con cui viene descritto: una lingua preziosa e ricercata che si adatta tanto alle descrizioni d’ambiente cui il narratore si abbandona quanto al suo gusto per l’analisi degli stati d’animo dei personaggi. Infatti, le
13
forme arcaiche e letterarie (conscienza), il continuo uso delle tronchedi tradizione illustre (l’epansion) e, nell’edizione originale, la forma antiquata di articoli e preposizioni articolate (li) contribuiscono ad impreziosire le pagine del libro e a creare l’atmosfera alta e nobile che caratterizza il romanzo.
La prosa utilizzata è ricca ed elegante ma allo stesso tempo allusiva, suggestiva e musicale: la lingua del romanzo perde spesso la sua funzione comunicativa per acquistarne una espressiva.
Il romanzo è appiattito su un solo registro linguistico: quello ricercato e un po’ troppo eloquente classico del d’Annunzio di quegli anni.
Lo scrittore ricorre spesso allo strumento della comparazione e della metafora che molte volte rende complicato o sfuocato ciò che dovrebbe invece chiarire e smorza i già scarsi nuclei di tensione narrativa.
Per quanto riguarda la sintassi, è da sottolineare l’uso quasi esclusivo della struttura paratattica, la più adatta ad accentuare la tendenza alla comparazione, all’anafora e all’elencazione.
L’utilizzo del flashback permette di evitare le situazioni e i passaggipiù scontati e prevedibili, vitalizzando una narrazione generalmente statica e coinvolgendo il lettore in un gioco di collaborazione e di ricostruzione degli eventi.
INTERPRETARE
Nel 1889, quando il naturalismo e il positivismo sembrano oramai conquistare pienamente la cultura italiana e Verga pubblica in volume il Mastro don Gesualdo, D'Annunzio dà alle stampe il romanzo attraversocui entra nella nostra letteratura il personaggio dell'eroe decadente. Così come quasi un secolo prima l'eroe dalle passioni sconvolgenti e assolute Jacopo Ortis aveva diffuso la cultura e la sensibilità romantica in Italia, ora il protagonista del Piacere, Andrea Sperelli, si fa propulsore e mediatore della tendenza più recente e raffinata della cultura decadente europea, l'estetismo. Come sottolineò Croce, con D'Annunzio «risuonò nella letteratura italiana una nota, fino ad allora estranea, sensualistica, ferina, decadente».
Servendosi dei più svariati materiali, soprattutto francesi
14
( Baudelaire, Flaubert, Huysmans, Verlaine, Moréas, i preraffaelliti, Wagner e molti altri ancora ), quasi volesse costruire con la sua opera- dice Mario Praz- «una monumentale enciclopedia del decadentismo», D'Annunzio si propone di uscire dai limiti del naturalismo, non più imitando, ma continuando la natura. Quindi, inaugurando con Il Piacere un tipo di prosa introspettiva - psicologica che conoscerà in seguito notevoli favori, tenta di scandagliare le complicazioni e le deviazionidella vita mondana e amorosa del protagonista «ultimo discendente d'unarazza intellettuale», educato dal padre a costruire la propria esistenza come «un'opera d'arte».
Il culto dell'arte, la risoluzione della vita stessa nell'arte, la ricerca del bello e di tutto ciò che è prezioso nel più assoluto distacco da ogni convenzione morale, il disprezzo per la volgarità del mondo borghese, accomunano l'Andrea Sperelli di D'Annunzio al Dorian Gray di Oscar Wilde e al Des Esseintes di Huymans, e ne fanno la versione Italiana dell'esteta decadente.
Non solo, ma 1' «anima camaleontica, mutabile, fluida, virtuale» di Andrea Sperelli rivela quella mancanza di autenticità , di forza moralee di volontà che si ritroverà in tanti personaggi decadenti, crepuscolari, inetti e indifferenti che affollano la letteratura del secolo scorso. Duplice e ambigua appare dunque questa figura in cui convivono sia il grandioso che il meschino; e in modo altrettanto duplice, D'Annunzio si immedesima e si distacca da essa.
L'estetismo dannunziano inoltre, abbagliando ed incantando il lettore, trionfa nell'elencazione e nella descrizione delle opere d'arte, degli oggetti raffinati e preziosi di cui ama circondarsi la frivola e mondana Roma degli anni Ottanta, nuova capitale, centro del nuovo giornalismo e della nuova editoria. Non la Roma classica «dei Cesari, …degli Archi, delle Terme, dei Fori» - che al tempo de Il Piacere aveva il suo vate in Carducci- ma la Roma tardo-rinascimentale e barocca «delle Ville, delle Fontane, delle Chiese» era il grande amore di Andrea Sperelli. Ma da tutta quella magnificenza spira un senso di decadenza e di disfacimento per cui Roma sembra adagiarsi «tutta quantad'oro come una città dell'Estremo Oriente, sotto un cielo quasi latteo,diafano» in «una primavera de' morti, grave e soave». Roma, capitale dell'estetismo, sembra una nuova Bisanzio, capitale del declino imperiale. E Il Piacere diviene il romanzo della Roma bizantina.
15
Il Fuoco
L'autore, il titolo, la storia, le indiscrezioni che hanno preceduto lapubblicazione, tutto concorre a far pensare che le pagine del romanzoraccontino l'amore di cui tutti parlano. L'amore dell'uomo più famosodel giorno, D'Annunzio, e la donna più famosa del giorno la Duse.
Un amico della Duse, avendo letto il manoscritto, l'aveva scongiuratodi non permettere la pubblicazione. Lei aveva risposto: «conosco ilromanzo ho autorizzato la stampa perché la mia sofferenza, qualunqueessa sia, non conta, quando si tratta di dare un altro capolavoro allaletteratura italiana: E poi, ho quarant'anni e amo». Molti,nell'acquistare Il fuoco, pensano assai più alla possibilità di unaindiscreta incursione in quell'amore che non alla scoperta di un nuovocapolavoro.
Pubblicato nel 1900, Il fuoco è un romanzo autobiografico, che descrivela complessa e tempestosa relazione di D'Annunzio con Eleonora Duse.Protagonisti della vicenda narrata, che ha come seducente sfondo unaregale Venezia, sono infatti "L'Imaginifico" Stelio Effrena, evidentealter ego dello scrittore pescarese, poeta, "anima appassionata eveemente", che aspira a un'esistenza ricca e impetuosa, in cui arte evita si fondano, e Foscarina, "la grande attrice tragica", già avantinegli anni, incarnazione letteraria di Eleonora Duse.
Il loro amore vive di esaltazioni e di disperazioni, di armonie e digelosie; la Foscarina rappresenta per il "superuomo" Stelio Effrena lamusa ispiratrice, la carica vitale, la catalizzatrice della suacreatività artistica. Esalta la sua potenza spirituale e sensuale.
Tuttavia sul loro amore incombe la giovane cantante Donatella Arvale,dalla quale il poeta-superuomo si sente attratto. Di qui i dubbi, leamarezze, le disperazioni di Foscarina, sempre pronta al sacrificio peril suo più giovane amante.
Sulla scena veneziana compare inoltre un Richard Wagner vecchio emalato, modello da imitare per Stelio, che, nel contempo, avverte diesserne l'ideale continuatore dell'opera artistica.Personaggio minore è Daniele Glauro, amico ed estimatore di Stelio, ingrado di gioire della bellezza, ma non di crearla.
Tipica espressione del dannunzianesimo, Il fuoco si fa apprezzare peril linguaggio impiegato, ricco, duttile, preciso, lontano dall'odiernastandardizzazione televisiva e per lo stile carico di metafore, visioni
16
e simboli, specchio di una cultura genuinamente classica.
Contrariamente ai critici più accreditati che apprezzano, nel romanzo,più la seconda parte che la prima, più i momenti di malinconia e diripiegamento che non l'esaltazione dionisiaca, io ho trovatoassolutamente travolgenti le prime cinquanta pagine del romanzo, che sidistinguono per impeto, energia e anticonformismo.C'è in D'Annunzio la capacità, abbastanza estranea alla tradizioneletteraria novecentesca, di esprimere sentimenti "positivi", quali l'entusiasmo, la grandezza, la potenza. Lo fa talvolta con iperbolipacchiane, ma prevale quasi sempre, a mio giudizio, una visione ampiadelle cose e della vita, tipiche dello scrittore di genio.
Una benefica, megalomane, narcisistica sfrenatezza attraversa il libro;le pagine di palpitante erotismo si alternano al dispregiodell'angustia dell'esistenza comune; soltanto il culto della Bellezzapuò vincere le miserie, le inquietudini e il tedio dei giorni comuni,il bisogno e il dolore. Il superuomo dannunziano non è tuttavia sempre attività, baldanza,sicurezza; alla luce subentra spesso l'ombra, rendendocelo più umano eamabile.
Con il nome di Liberty si intende un vasto movimento artistico che, trafine Ottocento ed inizi Novecento, interessò soprattutto l’architetturae le arti applicate. Il fenomeno prese nomi diversi a seconda delle nazioni in cuisorse.
17
In Francia prese il nome di «Art Noveau», in Germania il nome di«Jugendstil», in Austria fu denominato «Secessione», in Spagna«Modernismo», in Gran Bretagna <<modern style>>. In Italia ebbe inizialmente il nome di «Floreale», per assumere poiil più noto nome di «Liberty» dal negozio di un commerciante inoggetti orientali a Londra, Arthur Lasenby Liberty. Il Liberty nacque dal rifiuto degli stili storici del passato chenell’architettura di quegli anni fornivano gli elementi di morfologiaprogettuale. Il Liberty cercò invece ispirazione nella natura e nelle formevegetali, creando uno stile nuovo, totalmente originale rispetto aquelli allora in voga. Caratteri distintivi del Liberty divennero l’accentuato linearismo el’eleganza decorativa. Nato inizialmente in Belgio, grazieall’architetto Victor Horta, il Liberty si diffuse presto in tuttaEuropa divenendo in breve lo stile della nuova borghesia in ascesa. Esso si fondò sul concetto di coerenza stilistica e progettuale traforma e funzione. Adottando le nuove tecniche di produzione industriale, ed i nuovimateriali quali il ferro, il vetro e il cemento, di fatto il Libertygiunse per la prima volta alla definizione di una nuova progettualità:quella progettualità che definiamo industrial design. I centripiù importanti dello "Stile del '900" furono Torino, Palermo, Firenze,Lucca, Viareggio, Milano, Roma, Emilia Romagna. Nella nostra penisola il Liberty si sviluppa in un paese sostanzialmente pigro e che sembra aver dimenticato le recenti spinte ideologiche e popolari del risorgimento, in una nazione convinta di aver superato tutti i suoi problemi per il solo fatto di essere stata finalmente unita. In questo clima di stasi, tuttavia, va generandosi nel campo artistico, una "minoranza modernista" desiderosa di affacciarsi sul resto d'Europa e che vuole opporsi concretamente alla trita e ritrita mescolanza di stili storici dell'arte "ufficiale".Questa corrente modernista si muove verso una direzione stilistica,che sfocierà nell'Art Nouveau secondo i criteri già affermatisi nellealtre nazioni europee, e verso una direzione tecnica originata dallenuove scoperte industriali e da nuove tecniche strutturali,soprattutto nel campo architettonico.
18
I Pavoni 1912Vetrata realizzatada Umberto Bottazzi
La Cascina delle Civette, Stanza dei ciclamini, Villa Torlonia, Roma
19
Lampada manif. Ginori.
Rimini
Il percorso del movimento artistico nel periodo liberty, si pone lo scopo di sfatare un luogo comune, nato anche dal clima di diffusa lamentela degli intellettuali italiani, secondo il quale il Liberty avesse tardato molto nella sua diffusione in Italia.Seppure in parte vera, questa tesi non rende ragione dell'apporto innovativo e profondo di alcune personalità artistiche italiane, che pure parteciparono al dibattito estetico europeo. Il fenomeno estetico culturale della così detta Arte Nuova, è chiamato anche "floreale" per il gusto di forme biologiche, naturali e fitomorfe. Queste sfere della natura vengono concepite come un unico ed armonioso universo dal quale trarre ispirazione artistica.
20
Germinano nella pittura, nella scultura, nelle arti applicate e in ognioggetto della vita quotidiana: motivi floreali, delicate nervature boschive, ambienti vegetali, viticci, modanature. Contemporaneamente, in un clima di primaverile fioritura, l’arte si popola delle creature animali più piccole e indifese, di insetti e piccoli molluschi acquatici, insoliti e schivi. Le forme con cui vengono raffigurati questi soggetti sono sempre linee curve, forme flessuose provenienti dal movimento preraffaellita ottocentesco.
In italia intanto nasce e muore un epoca che per importanza dell’impronta prese il nome del suo autore, età giolittiana:
21
Giovanni Giolitti (Mondovì, 27 ottobre 1842 – Cavour, 17 luglio 1928) èstato un politico italiano, più volte presidente del Consiglio dei ministri. È considerato uno dei pochi statisti della storia dell'Italiacontemporanea, esercitò un’influenza così autorevole sulla vita politica dell’Italia che questo periodo venne comunemente definito “etàgiolittiana” - nonostante feroci critiche di alcuni contemporanei come, in particolare, quelle di Salvemini -.
Lo sviluppo economico ed industriale dell’Italia sotto il governo Giolitti, fu favorito da alcune condizioni particolari: le commesse statali e la politica protezionistica che favorì notevolmente lo sviluppo del Nord mentre danneggiò il Sud che vide chiuse le porte dei mercati esteri proprio per i propri prodotti tipici (olio, vino, agrumietc).
Il suo modo di far politica venne definito “doppio volto”:
aperto e democratico nell’affrontare i problemi del Nord, conservatore e corrotto nello sfruttare i problemi del Sud dove i suoi interventi, ad eccezione dell’acquedotto pugliese, furono di carattere sporadico edeccezionale con pesati repressioni.
Per quanto riguarda il Nord egli consentì gli scioperi facendo assumere al governo posizione di neutralità di fronte ai conflitti sindacali. Si ottenne così:
l’aumento dei salari, la riduzione dell’orario di lavoro per un massimodi dieci ore, venne riorganizzata la Cassa nazionale per l’invalidità e la vecchiaia dei lavoratori, si iniziò a considerare la tutela della maternità delle lavoratrici ed il lavoro dei fanciulli (l’età minima venne elevata a 12 anni).
Giolitti ritenne opportuno riavviare la politica coloniale dichiarando guerra nel 1911 alla Libia; fu un’avventura che comportò notevoli spesea cui non corrispose affatto la creazione di grandi opportunità per gliemigrati italiani in quanto non era quella terra fertile e rigogliosa quale veniva descritta dalla propaganda favorevole all’impresa coloniale.
Ma la principale riforma democratica dell’età giolittiana fu
22
l’approvazione, nel maggio 1912, di una nuova legge elettorale che introduceva il “suffragio universale maschile”. Con questa legge furonoammessi al voto, senza alcuna limitazione, i cittadini maschi che avessero compiuto il trentesimo anno d’età. Per accedere al voto all’età di ventuno anni, era invece necessario aver adempiuto gli obblighi del servizio militare o saper leggere e scrivere. Non era ancora il vero e proprio suffragio, che sarebbe stato conquistato solo nel 1946, ma fu senza dubbio un grande passo avanti sulla strada della democrazia.
Il diritto al voto
23
1900 si diffonde l’uso dell’aspirina
ll 900 può essere considerato "il secolo dell'aspirina", J. O. Gasset nella rivolta delle masse scriveva: "Oggi, per l'uomo della strada la vita è più facile, più comoda e più sicura che per i potenti di ieri. A lui importa poco di non essere più ricco del suo vicino, se il mondo intorno a lui gli dà strade,ferrovie, alberghi, un sistema telegrafico, benessere fisico e aspirina".In questo secolo è stato il farmaco più venduto. L'influsso che il farmaco ha avuto nel novecento lo si può desumere dal fatto che nel Trattato di Versailles, tra le condizioni imposte dai vincitori della prima guerra mondiale agli sconfitti imperi centrali, c'era la rinuncia della Bayer al brevetto sull'aspirina.Nel 1969 il medico della Nasa incluse l'aspirina nel kit di ogni astronauta in partenza per la missione lunare Apollo 11. Ma com'è nata l'aspirina?Per rispondere a questa domanda bisogna ricostruire lasua storia avventurandoci in un dedalo di miti e leggende.
24
Origine dell' aspirina : Ippocatre (460-377 a.C.), il padre della medicina, conosceva l'azione analgesica della linfa estratta dalla corteccia di salice che conteneva, come oggi sappiamo, l'acido salicilico. Nel Medioevo, invece, le venditrici di erbe aromatiche e medicinali facevano bollire la corteccia del salice, dopo di che somministravano l'amaro decotto alle persone afflitte da dolori. Da un certo momento in poi, però, la raccoltadei rami di salice venne proibita, perché la pianta veniva utilizzata per la fabbricazione di cesti. Fu così che il medicamento cadde in disuso. L'utilizzodell'acido salicilico venne ripristinato nel 1806. In quell'anno, infatti, Napoleone impose il blocco continentale e divenne quindi impossibile importaredal Perù il chinino, l'antipiretico allora più diffuso. Fu così che a qualcunoallora tornarono in mente i poteri benefici dell'estratto ricavato dalla corteccia della betulla. Ma come si è arrivati poi alla produzione della piccola pasticca bianca? Il processo è stato lento e complesso.
I primi studi risalgono al 1828. Nel 1838, il chimico italiano, Raffaele Piria, scoprì l'acido salicilico e nel 1853 Charles Frédéric Gerhardt, un chimico francese, produsse l'acido acetilsalicilico, anche se in forma impura, con gusto sgradevole e spesso con riflessi negativi sulla mucosa gastrica. Il merito di aver ideato un farmaco ben tollerato dai pazienti, e avente gli stessi effetti, va appunto a Felix Hoffmann, che può essere definito il vero e proprio inventore dell'Aspirina.Nel 1897 un giovane chimico della Bayer, Felix Hoffmann, iniziò a condurre degli studi per trovare un composto efficace e tollerabile, per alleviare i dolori reumatici del padre, che non tollerava il salicilato di sodio. Hoffmann tentò di nobilitare l'acido salicilico per migliorarne la
tollerabilità e riuscì nel suo intento mediante l'acetilazione, cioè attraverso la combinazione di acido salicilico con acido acetico. Il 10 agosto1897 egli descrisse nelle sue note di laboratorio l'acido acetilsalicilico (ASA), da lui sintetizzato in forma chimicamente pura e stabile.Prima della sua registrazione, l'ASA fu sottoposto a sperimentazione clinica - una prassifino ad allora sconosciuta-. I risultati furono così positivi che la direzione dell'azienda non esitò ad avviare la produzione del farmaco.Il 1° febbraio 1899 venne depositato il marchio Aspirina che un mese dopo, il 6 marzo, fu registrato nella lista dei marchi di fabbrica dell'Ufficio Imperiale dei Brevetti di Berlino. Iniziava così una marcia trionfale senza precedenti.
25
Le malattie del 1900
Con altre malattie infettive comuni e frequenti nell’epoca, certamente un ruolo importante è occupato dalla tubercolosi.
La tubercolosi
La tubercolosi è una malattia infettiva contagiosa provocata dal bacillochiamato Mycobacterium Tuberculosis o BK bacillo di Koch da Robert Koch che loscoprì nel 1882.
E’ una malattia che nella maggior parte dei casi interessa i polmoni, anche sepossono essere interessati altri organi quali il rene, le ossa e l’intestino.
Alla fine del 1800 e nei primi decenni del 1900 la TBC ha rappresentato unadelle cause principali di morte in tutta la popolazione mondiale.
Il miglioramento delle condizioni di vita e le scoperte dei farmaciantitubercolari hanno ridotto moltissimo la diffusione e la pericolosità dellamalattia nel mondo occidentale; anche se si calcolano 8 milioni circa di nuovi casil’anno con circa 3 milioni di morti soprattutto nei paesi in via di sviluppo doveil problema è drammatico per la inadeguatezza delle cure costose per molte nazioni.
26
Il decorso della Tubercolosi è suddiviso in tre stadi:
1° Stadio – Stadio Primario
2° Stadio – Tubercolosi post-primaria
3° Stadio – Stadio terziario
Ordinariamente la prima infezione tubercolare avviene per via aerea o inalatoria.Ilbacillo penetra direttamente attraverso l’albero respiratorio localizzandosi neilobi polmonari e raggiunge le estreme ramificazioni bronchiali dopo aver superatole difese di tipo meccanico (muco e ciglia) e le difese di tipo immunitario. Quiprovoca un processo flogistico di tipo essudativo necrotico con la formazione deltipico essudato caseoso; vi è adenopatia con interessamento dei linfonodi.L’insieme di queste lezioni costituisce il “complesso primario”.
Piu’ raramente l’infezione avviene per via alimentare e in tal caso lalocalizzazione è intestinale; talvolta può verificarsi attraverso la cute e lemucose del cavo orale, congiuntivale e delle vie genitali.
2° Stadio : Tubercolosi post- primaria. E’ caratterizzato dalla propagazioneper via ematica e linfatica con localizzazioni secondarie in altri organi e tessuti: si ha la formazione dei tipici tubercoli cioè formazioni granulomatose e la lorotendenza è di evolvere verso la necrosi caseosa
3° Stadio. E’ lo stadio della tubercolosi cronica isolata che comunemente colpiscei polmoni; possono essere interessati altri organi : reni, ossa. Lo stadioterziario sopraggiunge generalmente dopo anni che il focolaio primario si èsmorzato.
Sorgenti di infezione: Le fonti di infezione sono l’uomo e in misura minore ibovini. Il malato elimina i bacilli per via aerea e molto piu’ di rado attraversole feci con la tubercolosi intestinale, le urine con la tubercolosi renale. Levie di penetrazione sono prima di tutto quella inalatoria: i bacilli eliminati dalmalato vengono inalati con le goccioline di Flugge o con il pulviscolo atmosfericodopo essersi depositati su materiale ambientale(suppellettili,polvere)Le altre viesono la via orale con il latte e derivati e quella cutaneo-mucosa (attraversolesoini cutanee, la mucosa congiuntivale, genitale).
27
Carenze Alimentari
Altre cause di morte, soprattutto nella fanciullezza e nella popolazione povera chesicuramente non partecipava ai movimenti della “bella epoque” erano le carenze alimentari.
La carenza di vitamina D non portava a morte ma nella popolazione più misera frequentemente si potevano vedere bimbi affetti da rachitismo; la pellagra fu
28
grande causa di morte nell’infanzia data da una carenza di vitamina pp o niacina presenti nella carne, nel fegato,nel germe di grano, arachidi e lievito di birra.
Lo scorbuto era invece causato da alimentazione priva di frutta fresca cioè vitamina c.
Questa vitamina svolge ruoli importanti nella difesa dell’organismo dalle infezioni, nel metabolismo, nella riparazione e nel mantenimento di diversi tessuti. Lo scorbuto è caratterizzato da emorragie diffuse in tutto il corpo. L’acido ascorbico viene escreto rapidamente con l’urina se assunto in eccesso; le fonti di approvvigionamento sono:
gli agrumi, le fragole fresche, il melone, l’ananas, il cavolfiore, i pomodori, glispinaci, i peperoni verdi (crudi o cotti non troppo a lungo).
L'ecatombe infantile Nella foto, una scuola rurale del 1910. I bambini ritratti sono praticamente gli
scampati a una mortalità infantile spaventosa. Spiega il "Sommario delle statistiche storiche" edito dall'Istat che nel
decennio1900-1910 morirono in media 719.565 italiani l'anno dei quali 296.576bambini al di sotto dei 5 anni: il 41%. Nello stesso decennio furono registratemediamente 1.138.373 nascite. Il che vuol dire che uno su quattro dei piccoli nonarrivava ai cinque anni. Eppure in passato i dati erano stati perfino peggiori:basti dire che l'età media in cui si moriva, nel decennio 1881-1890, era di sei
anni e quattro mesi. Oltre dieci volte più bassa di quella che si sarebberegistrata tra il 1951 e il 1955 (69 anni) o di quella di oggi.
Se nella “bella epoque” poteva essere motivo di scandalo e moda l’utilizzo di oppioo morfina, nelle frange più povere, si diffondeva, assieme ad una alimentazione approssimativa, un’altra causa di degrado: l’alcolismo.
29
Nello stesso 900 in Italia si sviluppa l’attivismo che influenza iniziative di rinnovo educativo principalmente all’istruzione primaria e infantile e all’educazione popolare.
La rivoluzione di Maria Montessori
30