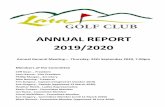Art Nouveau di Lara-Vinca Masini
Transcript of Art Nouveau di Lara-Vinca Masini
Lara-Vinca MasiniProgetto grafico e collaborazione di Alessandro Vezzosi
UN'AVVENTURA ARTISTICA INTERNAZIONALETRA RIVOLUZIONE E REAZIONE, TRA COSMOPOLITISMO E PROVINCIA
TRA COSTANTE ED EFFIMERO, TRA "SUBLIME" E STRAVAGANTE
INTRODUZIONE
Con questo libro ci siamo proposti, per la prima volta in Italia, una riletturaglobale del fenomeno Art Nouveau, nelle sue manifestazioni internazionali; peroffrire un parametro di lettura critica che consenta di superare i limiti di un'ot-tica settoriale, indotta spesso a perdere di vista l'equilibrio dei. rapporti, nelpur necessario" tentativo di colmare lacune a lungo perpetuate nella vasta let-teratura internazionale.
Siamo convinti che l'Ari Nouveau offra ancora un vasto campo di indagine,anche in senso sociologico, tenendo pure conto delle involuzioni ideologichee della travisante mercificazione-kitsch.
Nello studio abbiamo seguito un procedimento a ritroso, partendo, cioè,dalla riscoperta abbastanza recente del fenomeno, nelle sue componenti di re-visione critica, di revival e di moda stilistica.
Abbiamo preso in esame tutti gli aspetti delle manifestazioni artistiche dellavisione, dall'architettura al design di interni, alla pittura alla scultura allagrafica alla decorazione all'oggetto d'uso, senza distinzioni gerarchiche; conparalleli con le altre manifestazioni artistiche {letteratura, poesia, musica...).
Attraverso l'analisi, poi, di quello che si da come motivo conduttore del-l'estetica art nouveau, cioè della ' linea strutturale ', generatrice di forma, ab-biamo anche cercato dì cogliente le ' costanti ' negli antecedenti e nelle suc-cessive proiezioni nell'arte di questo secolo, dall'Espressionismo, al Futurismo,a! Surrealismo, dall'Action Painting alle proposte ottico-percettive recenti;'costanti' reperibili fino alle soglie delle attuali poetiche della inon-Arte\che, con il precedente de! momento dada, esce necessariamente da un tipo dilettura di carattere formale.
L.-V.M.
Un ringraziamento particolare all'aulico Renzo Gherardini che mi è staio prezioso di aiuto perla collaborazione e i consigli sulla situazione poetica e letteraria del periodo.
Ringrazio inoltre tutti coloro che hanno agevolato ii reperimento del materiale fotografico ; tragli altri Wotfram Prinz dell'Università di Francoforte, Natlian Shaplra dell'Università di Las An-geles, Massimo Becattinì, Enzo Creslini, Liliana Martano, Guida Perocco delta Galleria d'ArteModerna di Ca' Pesaro, e, in particolare. Luigi Cartuccia che mi ha messo gentilmente a dispo-sizione il suo archivia di fotocolor!.
- La fortuna critica. Confronti e paralleli.
Prima di proporre una ennesima rilettura dell'Alt Nouveau, nellesue diverse manifestazioni, anche cercando di cogliere le ragionidella esplosione, sul finire del XIX secolo, del movimento, comefenomeno internazionale (il primo, tra l'altro, che, oltre l'Europa,investe anche l'America), ci sembra più attuale e meno scontato chie-derci il significato della sua riscoperta relativamente recente, a livellodi revisione critica e di gusto, sul piano socio-culturale, politico enella sua componente psicologica.
Jugendstil e Art Nouveau, quando se ne escludano saggi partico-lari e monografici, furono riscoperti, prima di tutto, dagli studiosi edagli storici dell'arte tedeschi, e poi dai belgi, dai nord-europei.
Tralasciando, infatti, i primi saggi quasi contemporanei al movi-mento (di Jean Emile Bayard, " El Estilo Moderno ", uscito a Pariginel 1919; dì Andre Fontainas, " Mes souvenirs du Symbolisme ",Parigi, 1924), il primo studio sistematico si deve a Ernst Michalski(" Die entwichlungsgeschichtliche Bedeutung des Jugendstils "), eusci sul « Repertorium ftìr Kunstwissenschaft », a Berlino, nel 1925.
Fecero seguito, a Bruxelles, " Trente années de lutte pour fan,1884-1914", del 1926, di Madeleine Octave Maus; " L'Art nouveau1895-1925 ", di Thor B. Kielland, uscito a Oslo, su « Fransk Mòbel-kunst », nel 1928; " The Artists of thè 1890's ", di John Rothenstein,(Londra, 1928); "L'Art décoratif au temps du romantisme ", diP. Schommer (Parigi, 1928); " L'art et la vie en Belgique, 1830-1905 ",di M. Octave Maus (Bruxelles, 1929). È del 1929 anche la prima espo-sizione sull'argomento, sia pure settorializzata: " Die Wiener Werk-stìitte, 1903-1928", al Moderne Kunstgewerbe Museum di Vienna.Si pubblicano a Parigi, nel 1931, " Le mouvemenl esthétique et dé-cadent en Angleterre (1873-1900)", di Alberi John Farmer e "LeStyle romantique ", di Vaslav Husarski; nel 1933 esce, di SalvadorDalì, sul n. 3/4 di « Minotaure », a Parigi, " De la Beauté Terrifìanteel comestible de l'Archìtecturc Modero' Style " (con fotografìe diMan Ray); pure nel 1933 il Museum of Modern Art di New Yorkpresenta la rassegna " Objects 1900 and today ".
Il primo saggio italiano sull'argomento si deve a Vittorio Pica," Revisione del Liberty ", ed esce su « Emporium » (Bergamo, ago-sto 1941, XCIV).
Il sorgere dell'attenzione storico-critica verso l'Ari Nouveau sicolloca, dunque, praticamente, tra le due guerre, quando si assistead un risveglio delle correnti idealiste e alla diffusione degli studisulla fenomenologia e sulla psicologia della forma, che portano avanti(scuola dì Lipsia e di Berlino), anche i risultati delle ricerche psicana-litiche, sorte proprio in pieno Art Nouveau, e alle quali è strettamentelegata gran parte della ideologia del movimento. Faranno seguito le
1 - La fortuna critica. Confronti e paralleli.
grandi rassegne internazionali, che allargheranno l'interesse per l'ArtNouveau sul piano del gusto e della moda.
Ma per questo occorrerà arrivare al secondo dopoguerra, quandoil fenomeno si riproporrà come ' revival ' culturale e quando, soprat-tutto in Italia, si manifesterà prima nella cultura architettonica e neldesign di arredo, al momento della ricostruzione, dopo la Resistenza.E si manifesterà come reazione ulteriore ai postulati dell'architetturarazionale, dopo il naufragio delle proposte di un'architettura organi-ca, tenute dietro alla scoperta di Wright (Zevi, Scarpa, Ragghianti),naufragio, come scriveva, nel 1963, Paolo Portoghesi, " come scuo-^ regionale... per l'inadeguatezza di una classe dirigente immatura,nella gratuità di uno stile subito tramontato ", che lasciò " nella co-scienza delle nuove generazioni il rifiuto per una prospettiva acco-modante e accademica della modernità che confondesse la ragionestorica concreta, evidenziata dal pensiero scientifico contemporaneo,con la ragione astratta e illuministica di certo costruttivismo"1.
Quello che andò sotto il nome di ' neo-liberty ' italiano, che sorsea Torino (Gabetti, d'Isola), a Milano e Novara (Gregottì, Mene-ghetti, Stoppino, Canella, Fiori,..), per certi aspetti sostenuto da
Rogers nelle pagine di « Casabella », fu fortemente stigmatizzatocome espressione di involuzione formalistica da « L'Architettura »di Zevi, che pure aveva già portato avanti ampiamente, nelle rubriche" Eredità dell'Ottocento " e " La tradizione moderna ", il tema dellevalenze ancora aperte e non storicizzate delle esperienze del passato,
1 •- La fortuna critica. Confronti e paralleli.
e non aveva mancato di distinguere chiaramente tra manifestazionie manifestazioni, presentando spesso, ad esempio, opere di Gabettie d'Isola, notando come " quando la loro sensibilità esige uno stru-mento espressivo che il razionalismo e il movimento organico nonposseggono o rifiutano, si rivolgono al patrimonio semantico delliberty... senza sofisticherie e snobismi, senza la mediazione di rancidicrepuscolarismi..."2; e dichiarando, pur nell'allineamento con lapolemica .anti-neo-liberty del Banham: " L'Art Nouveau costituisceil primo capitolo del movimento moderno o l'ultimo dell'eclettismo?Banham opina sia l'ultimo, non si capisce per quali criteri. Noi rite-niamo il contrario, per considerazioni storiche acquisite " 3. All'este-ro, poi, il ' neo-liberty' italiano (e c'è da notare che fu, forse, più ladenominazione ' neo-liberty ' ad urtare tante suscettibilità, che nonla manifestazione reale, che di ' liberty ', veramente, non ebbe molto,se non una velleità di recupero di modi storicizzati, forse più vicinia istanze espressioniste che non art nouveau), trovò una opposizioneaccanitissima, soprattutto, come abbiamo accennato, in ReynerBanham, che pubblicava, nell'aprile del 1959, su « ArchitecturalReview », un articolo di fuoco (" Neo-liberty - thè italian retreatfrom modern architecture "), che suscitò una lunga polemica, ter-minata, praticamente, nel dicembre dello stesso 1959, con un se-condo articolo di Banham, sempre su «Architectural Review ». (Magià il Pevsner, nel 1956, su « Architects' Journal » di Londra, dichia-rava: " Ciò che oggi ci sembra moderno nel senso più recente deitermine, a cominciare dalla folle e del tutto arbitraria perforazionedelle pareti della cappella a Ronchamp, di Le Corbusier, ... mi sem-bra un neo-Art Nouveau " !). Comunque sia, l'accusa di ' andro-pausa ' per la giovane architettura italiana si dimostrò prematura eavventata, non tanto per quel che riguardava, appunto, la ripropo-sta stilìstica - del resto subito superata e interpretata come ricerca diuna dignità linguistica attraverso la linea (e anche come ironica allu-sione alla condizione imperante medio-borghese) - quanto perché,proprio dal superamento di questa impostazione dovevano nascerele premesse, se non proprio della nuova architettura italiana, almenoper la definizione delle linee di quel ' design ' italiano che ha domi-nato il panorama internazionale fino alla sua crisi recentissima, do-vuta ad una sua sempre più pressante strumentalizzazione, anche neisuoi aspetti contestatari, ironici, dissacratori, di ' anti-design '.
Cito ancora, a questo proposito, Portoghesi: "La critica ador-niana all'arte di avanguardia fornì di argomenti lucidi e inquietantila polemica teorica del neo-liberty, di carattere però alquanto discon-tinuo giacché il gruppo stretto intorno a «Casabella» non ebbe maisulla rivista diritto di parola in sede polemica. Nell'atto in cui timi-damente apparivano nelle pagine delle riviste le prime realizzazionineo-liberty, già una precisa linea autocritica aveva incrinato il frontedei suoi rappresentatiti che con un certo divertito distacco sperimen-tavano l'ipotesi di un design nato in antitesi ai procedimenti del designportando nella scala dell'arredamento e del disegno di oggetti unavolontà stilistica spesso impostata sulia poetica del brutto e del carai-
1 - La fortuna critica. Confronti e paralleli.
levistico. D'altra parte - e in ciò è evidente un difetto di comunica-zione e di vero impegno linguistico - queste immagini, nate da uninteresse quasi ascetico e comunque rigorosamente intellettuale, ve-nivano interpretate, anche dai ragazzi della generazione successiva,come una deviazione edonistica e quindi giudicate senza tener contodel movente ideologico che le aveva determinate " 4.
Comunque sia l'in quietudine, l'insoddisfazione nei confronti diquella speranza di libertà che aveva animato la Resistenza, la spe-ranza in un ( giorno dopo ' che aveva visto, invece, un risveglio con-formista in un clima generale di ' ritorno all'ordine ', sta alla basedi questo revival culturale, di carattere del tutto intellettualistico.
1 fatti di moda che ne sono scaturiti, la corsa all'oggetto ' liberty ',ormai superata all'estero, da noi un po' in ritardo e ancora in auge,si devono a fattori economici, a interessi di mercato, al boom cheha caratterizzato gli anni or ora trascorsi, e rappresentano, ai finidella cultura estetica, un fatto secondario.
Ci preme invece ritrovare, guardando alle ragioni che hanno deter-minato il nascere dell'Ari Nouveau, quali possano essere le affinitàe le divergenze che ne hanno determinato allora la nascita, ieri ilrisveglio, prima in una partenza a livello intellettuale (e intellettuali-stico), poi come fatto di costume.
Come, perché, quando nasce, che cosa è dunque questo Art Nou-veau tornato cosi in auge da qualche anno, del quale, invece, si è ta-ciuto per quasi mezzo secolo, come fosse un fantasma iliusorio ouna cattiva intenzione, di cui si è cercato di distruggere ogni traccia,senza pietà, escludendolo da quel filo conduttore del quale si intessela storia, relegandolo, semmai - e il suo definirsi ' stile ' è stato an-che la sua condanna - nell'ambito dell' ' ameublement ', come unLuigi Filippo, uno stile Reggenza, uno stile Impero: fenomeni chenon sono mai andati, nella loro globalità, oltre il fatto di gusto.
Come spesso accade, la ragione sta in mezzo, anche se l'Art Nou-veau, anticipando, in questo, le avanguardie, non ammetteva com-promessi. Volle essere espressione di giovani, volle essere nuovo intutto, dovunque si manifestasse, sia che si definisse Liberty dallaLiberty & Co. di Londra, come fu chiamato generalmente in Italia(oltre che Floreale), o Jugendstil, dalla testata della rivista « Jugend »di Monaco, o Arte Jóven, come in Spagna (oltre che Arte modernista,
/ - La fortuna critica. Confronti e parai/eli.
in Catalogna), sia che accettasse la denominazione comune, appunto,eli Ari Nouveau, generalizzala dal 1900 in tutti i paesi (tranne che inquelli di lingua tedesca, che continuarono ad usare il termine Jugend).benché derivala, anche questa, dal nome dì un negozio aperto daSigfried Bing a Parigi nel 1895.
Se poi si voglia tener conto delle caratteristiche diverse delle varieregioni ci occorrerà il termine mouvement belge o /igne belge (movi-mento o linea belga), e si parlerà di Sezessionstil (Stile Secessione),riferendoci al gruppo di avanguardia di artisti che nel 1897 fonda-rono la Wiener Sezession (la Secessione viennese) o ai gruppi prece-
1 - La fortuna critica. Confronti e paralleli.
denti delle Secessioni di Berlino (1892), o di Monaco (1893).Nel suo ultimo volumetto uscito in italiano per il Saggiatore, Tchudi
Madsen, che resta uno dei più autorevoli studiosi dell'Ari Nouveau(la sua opera fondamentale sull'argomento " Sources of Ari Nou-veau " è del 1956), riporta tutta una serie di definizioni a livello po-polare del fenomeno Art Nouveau, elaborate dai contemporanei:da Paling Sijl (in fiammingo, stile anguilla), a Style Nouille (stilespaghetti), a Style dea Vingt, a Belgische Stil, a Veldesche Siti, an-cora in Belgio; da Style 1900, a Modern Style, a Stil van de Veide.In Germania si parla anche di Belgoscher Bandwurm (tenia belga),e di Schnorkestil (stile a spirale): la rivista « Kòlnischer Zeìtung »parlò dì Wellenstil (stile onda); furono usati anche i termini GereìtzerRegenwurm (lombrico arrabbiato), moderne Strumpfbandlinìen (lineagiarrettiera moderna). Ma sì parlò anche di Neustil (stile nuovo), diNendeutche Kunst (nuova arte tedesca), di Style Morta, in Belgio,di Style Guimard, in Francia, dove lo si definiva anche Style Mètro,dalle note entrate alle stazioni della metropolitana a Parigi, appunto,di Guimard o Style Jules Verne; si era parlato anche di Style Morris,di Style coup defouet (stile colpo dì frusta), di Glasgow Style, di Lilien-stil (stile giglio), Edmond de Goncourt, a proposito dei mobili diVan de Velde, esposti da Bing a Parigi, aveva usato la definizionedispregiativa di Yachting Style (stile yacht). In Spagna si parlò diArte Jóven e dì Stile Modernista, come si è visto.
Basta questo, in ogni caso, per renderci conto che si tratt,a del pri-mo stile internazionale, e a diffusione generale, del mondo moderno.
La ragione sta in mezzo, dicevo: perché, se è vero che l'Art Nou-veau si manifesta come movimento di tipo rivoluzionario (trae lesue origini, come vedremo, dal socialismo utopistico di Ruskin e diMorris, si concretizza nella divulgazione quasi apostolica di Van deVelde; è, intenzionalmente, contro l'eclettismo storicistico imperante- anche se non sfugge a tutti i revivals -, assume a termine dì confrontola letteratura e la musica di avanguardia, ha delle intuizioni di unaanticipazione incredibile - e saranno quelle che ci permetteranno deiconfronti e che chiariranno le ragioni più profonde dell'interesserecente), d'altro lato è anche vero che, col suo andare a ritroso, colproclamare il ritorno al pezzo unico contro lo standard industriale,col riabilitare il lavoro artigianale contro la meccanizzazione, si poneinevitabilmente, in nome di un nuovo ideale estetico, di una sortadi nuova ' divina esecuzione ' (di winkelmaniana e canoviana me-moria), su una posizione reazionaria, o almeno tale da poter esserrecepita in maniera reazionaria. Opporsi al progresso industrialesignificava proporre l'oggetto di lusso, realizzato a mano, perciò aprezzo enormemente più alto dell'oggetto di serie, per i nuovi ricchi,
1 - La fortuna critica. Confronti e paralleli.
CITY*OFIVERPOCHOOLl
per i nuovi detentori del potere economico. Ciò di cui non mancòdi far tesoro la società borghese, neocapitalista, quella che proprioattraverso la speculazione industriale aveva risposto all'appello inte-ressato dei governi dell'epoca déWenrichissez-vous.
L'oggetto offerto dagli artisti dell'Art Nouveau fu assunto dallanuova società come uno degli strumenti più utili, perché forniva, oltrea tutto, un alibi dì straordinaria eleganza, per sentirsi à la page conla raffinata intellegentia dell'epoca, e, in nome dell'arte, al sicurodalla volgarità, partecipi, quindi, della nuova aristocrazia dello spirito.
Scrive Adorno: "Se l'emancipazione dell'arte fu possibile solocon la ricezione del carattere di mercé quale apparenza dell'essere-in-sé dell'arte, cosi, capovolgendo la situazione, con lo sviluppo suc-cessivo il carattere di mercé cade di nuovo fuori delle opere d'arte;lo stile floreale ha non poco contribuito a ciò, con l'ideologia dellacitazione a domicilio dell'arte nella vita ed altrettanto con le sensa-zioni di Wilde, D'Annunzio e Maeterlinck, preludi dell'industria cul-turale. Il progredire di una differenziazione soggettiva, la crescita el'ampliamento della sfera degli stimoli estetici, rese questi ultimi di-sponibili; essi poterono essere prodotti per il mercato culturale. L'ac-cordo dell'arte con le reazioni individuali più fuggevoli si alleò conla reificazione dell'arte, la sua crescente somiglianzà col soggettiva-mente fisico la allontanò, nella ampiezza della produzione, dalla suaobbiettività e si raccomandò al pubblico; pertanto la parola d'ordine' l'art pour l'art ' fu la copertura del contrario " s.
D'altronde, col battere l'accento sul momento della invenzione,della progettazione artistica come premessa sine qua non anche perla produzione di serie (molti esponenti dell'Art Nouveau, tra cui lostesso Vaii de Velde non furono sempre contro la produzione indu-striale, purché la si riqualificasse), l'Art Nouveau poneva le basi delconcetto attuale di Design.Fattore, questo che, anche tenendo conto delle considerazioni po-sitive, non smentisce affatto le dichiarazioni di Adorno.
Come nasce, dunque. l'Art Nouveau? Questa domanda ci ponedi fronte al problema delle fonti del movimento.
I punti di riferimento sono, naturalmente, di vario genere: di lipoformale, culturale, sociale, politico.
L'Art Nouveau rappresenta il momento immediatamente prece-dente, addirittura il primo accenno delle avanguardie artistiche delNovecento, ma, a differenza di quelle, si manifesta come fatto co-rale, sia pure a gradi e in modi diversi da ambiente ad ambiente eda paese a paese.
In nome dell'Arte per l'Arte, definizione che le deriva dal Simbo-lismo e dall'Estetismo letterari, investe tutta la vita e intende tra-sformarla secondo i cànoni di un ideale che considera i'arte espe-
} - Lei fortuna critica. Confronti e paralleli.
lienza totale, di carattere etico, culturale e che, come tale, trascendeli vita e tende a sublimarla.
Per le fonti e le diverse componenti e le implicazioni, si va, dunque,da William Blake a William Morris, a James McNeill Whistler, dalmovimento preraffaellita (e attraverso questo all'arte medievale ita-
ana, all'arte del tre e quattrocento, dai senesi a Botticelli a Leonardo),ille Arts and Crafts, dal Giapponismo e Orientalismo al GothicRevival, al Celtic Revival; dall'arte classica, rivissuta in modo auto-
1 nomo a del tutto particolare (Beardsley), al Manierismo (dal Pol-hiolo al Pontormo al Parmigianino); dal Simbolismo (da Baudelaire
Maliarmc a Rimbaud; da Gerard de Nerval ad Alain Fournier.a Guslave Morcau a Odilon Redon, a Puvis de Chavannes, a Bócklin.i Nabis); al Neospiritualismo, da Macterlinck a Rilke. da Oscar
Wilde a Proust, a Gidc, da Schopenhauer a Nietzsche; da DebussyStrawinskij, da Mahler a Schònberg, da Grieg a Strindberg; dalie
coperte archeologichc di Creta e Micene (gli affreschi del palazzoii Cnosso, i vasi di Kamares, la brocchetta di Gurnià, decorata conn immenso polipo che la avvolge a spirale); alla psicanalisi di Freud;la Appia a Gordon Craig; da Diaghilcv a Nijnskij a Bakst; da LoieFullcr a Isadora Dimenii.
1 - La fortuna critica. Confronti e paralleli.
Prima di approfondire il problema delle fonti ci preme notare co-me sia soprattutto la posizione dell'intellettuale e dell'artista nellanuova società che si è formata in seguito all'instaurarsi della civiltàdella tecnologia industriale che determina, prima, un movimento dirottura come l'Art Nouveau (e questo resta vero malgrado i tenta-tivi, spesso riusciti, di inglobamento da parte della società stessa, dìcui abbiamo detto), poi Pesplosione delle avanguardie (dalla Brtickeal Blaue Reiter, dal Cubismo al Futurismo al De Stijl...).
A questo punto riprendiamo il discorso relativo all'interesse recentee attuale per l'Art Nouveau. Che, come ha notalo lo Hauser a pro-posito dell'interesse, pure attuale, per il Manierismo, non significa" che nell'arte contemporanea si ripeta e continui quello stile " fi, mainduce a considerare in parallelo certi fatti specifici che avvicinano,come coincidenza di situazioni, i due momenti (e perciò, per la leggeIransitativa, i tre momenti).
Si deve guardare, dunque, alla posizione dell'intellettuale e del-l'artista nella società, sia nel '500, con la crisi di trasformazione dellacultura, nel passaggio dal pensiero scolastico, chiuso e dogmatico,alle metodologie sperimentali aperte e continuamente in evoluzione.con la scoperta del significato delle 'tecniche' in senso moderno:sia alla fine dell* '800, con la caduta del pensiero positivista e col dif-fondersi delPindustrialesimo ; sia nell'ultimo dopoguerra, col pre-valere delle tecnologie sulle tecniche e con l'asservimcnto forzatodella scienza al sistema industriale-capitalistico.
È già col Manierismo che l'intellettuale viene escluso (o meglio, ècostretto ad escludersi, per suo rifiuto preciso), dal mondo della pro-duzione, per il crearsi di un sistema rigido di rapporti e di organiz-zazioni, per il dissociarsi dell'economia dalla società (con la Rifor-ma protestante la salvezza non è più nell'opera; il lavoro umano è.scisso da fini di trascendenza: è la base su cui si imposta il lavorodell'industria). L'alienazione dell'individuo (come alienazione dalproprio lavoro), ha inizio proprio col '500; di qui la fuga nell'incon-scio, nel mito anti-classico, la rottura con le regole tradizionali, l'Anti-rinascimento. Di qui la ricerca di salvezza dell'arte nell'estenuazionedella forma (la linea serpentinata di Lomazzo), nello stravagante,nel magico, nell'involuto. E basteranno una serie di immagini, dallagrottesca delle Stanze di Raffacllo (e già in Villard de Honnecourt),ripresa dal mondo classico, per passare attraverso, .ad esempio, il
1 - La fortuna critica. Confronti e paralleli.
Pollaiolo, il Pontormo (con la visione della linea attraverso lo spec-chio deformante), il Parmigianino, El Greco.
Di qui il ricorso allo stravagante, al magico, all'involuto. È il pe-riodo delle deformazioni ottiche, delle prospettive illusionistiche.
All'ideale del Bello si sostituisce l'ideale sociale dell'Eleganza,associata a tutti gli atti della vita.
I problemi che hanno tenuto dietro all'ultimo dopoguerra sononoti a tutti e si ripropongono quasi sugli stessi termini: l'intellettualee l'artista, esclusi dal mondo della produzione, hanno tentato direinserirsi nella struttura attiva della società. L'arte si è proposta, acerti livelli, come modello di comportamento; ha preteso di instau-rare una nuova visione del mondo attraverso una sorta di ipotesi di' spazio estetico totale '.
Sarà poi da notare come l'affievolirsi del rinnovato interesse versol'Art Nouvcau coincida col superamento di tali posizioni, con lepoetiche attuali della ' Non-Arte '.
L'età ' industriale ' ripropone più aspramente questa situazione. Lacultura e l'arte, o diventano oggetto di produzione e di consumo- perciò asservite al sistema -, o vengono escluse senza riserve.
L'Art Nouveau pone per la prima volta il problema dei rapponoira arte e società, sostituendolo a quello tra economia e società.
L'arte si propone come ' avanguardia ', cioè come forza capace diintervenire sulle strutture sociali e modificarle.
È la crisi del mondo moderno, che, su rapporti diversi, affronteràanche il Bauhaus.
Superati i termini della geometria euclidea (nel 1868 era uscital'opera del matematico Bernhard Riemann " Sulle ipotesi che riguar-dano i fondamenti della geometria ", che sviluppava la scoperta diNicolaij Lobacewskij, del 1826, sulla possibilità dì porre le basi diuna geometria non-euclidea: sarebbe poi venuto il Poincaré), le regoleclassiche non contano più: si tende a rompere l'equilibrio statico, sicerca il dinamismo, l'asimmetria; si inizia il rapporto con I' ' oggetto 'artistico non come ' immagine ', ma come valore di ' segno ", comefatto 'significante' (la lìnea serpentinata, dinamica, 'strutturale').
Alla fine del '500 il problema si risolve nella dinamica esplosivadello spazio che si configura all'interno e si proietta all'esterno (daMichelangelo a Borromini).
Alla fine dell1 '800 si tenderà, come vedremo, all'annullamentodello spazio volumetrico nella superficie e Io spazio si ricreerà dal
di fuori, dall'avvolgimento dinamico della linea: uno spazio conti-nuamente: autodistruggentesi e riproponentesi nel gesto come attodi esistenza, E già nel secondo periodo dell'Ari Nouveau si arriverà,appunto, allo spazio come opera aperta, come dinamica pluridimen-sionale (già con Mackintosh, con Sullivan, con Loos, e, soprattutto,col primo Wright).
Una serie di immagini, che vanno dal minareto persiano, ad unaraffigurazione ideale della Torre di Babele, a Borromini, a Boullée,a Obrisl, a Gaudi, fino a Tatlin, saranno sufficienti a dimostrarecome si passi dallo spazio bloccato, chiuso, del mondo antico, a quelloserrato e ' disegnato ' del Barocco, attraverso lo spazio ' lineare ',' a guscio ', dell'Art Nouveau, fino allo spazio filtrante, dinamicoe acreo delle avanguardie. E tutto questo attraverso una delle im-magini più dichiaratamente simbolica dì ogni tempo, quella della' spirale '.
/ - La fortuna critica. Confronti e paralleli.
1 - La fortuna crìtica. Confronti e paralleli.
Anche al momento della ripresa culturale recente il problema dellospazio tornava a dominare e si poneva in termini dinamici: da un'ar-chitettura inquieta e problematica, con molte fughe nell'utopia, siriversava nell'urbanistica, in proposte di soluzioni che non hannoancora trovato una società preparata ad accoglierle: siamo di fronte,comunque - poiché la situazione perdura - ad uno spazio ' negato ".e negalo agli architetti e urbanisti, proprio dalle strutture socio-eco no miche.
Ma l'avvicinamento dei tre momenti si riporta soprattutto al ten-tativo di presa diretta dell'arte sulla realtà, caratteristico di un certomomento culturale che si colloca dal secondo dopoguerra a ieri,per cosi dire, all'impostazione, cioè, del problema estetico in terminidi spazialità totale, con la quale l'artista (cito McLuhan), " tende aspostarsi dalla torre d'avorio a quella di controllo ".
"Nella nostra epoca" egli aggiungeva, e questo suo testo usciproprio nel 1966, al momento in cui questa esigenza era maggior-mente sentita " come l'istruzione superiore non è più un ornamentosuperfluo o un lusso ma una precisa necessità della produzione, cosìPartista è indispensabile per formare, analizzare e comprendere lel'orme e le strutture create per la tecnologia elettrica " 7.
II Barocco tenderà, dunque, a coinvolgere la vita nel suo spaziototale. Con PArt Nouveau Parte intende assumersi il compito diricostituire il mondo attraverso l'estetica (la vita come arte, già inVan Gogh). Nel recente periodo di ripresa dei motivi art nouveau.dopo le diverse esperienze, dalla ' enviromnental art ' (lo spaziocreato dagli artisti come fuga dallo spazio tecnologico), ai tentatividi strutturazione dinamica, organizzata, dell'arte programmata, cine-tica, tecnologica, si arrivò al momento in cui la soluzione sembravariporsi nell'atto della progettazione, nel ' design ' (come metodolo-gia e tecnologia alle quali si intreccia l'ideologia)s.
Superate queste linee, in un recupero di gestualità individuale, colrifiuto del ' programma progettuale ' finalizzato alla realizzazionedell'oggetto, quando si assiste al rovesciamento delle impostazioni(non più ' vita come arte ', ma, semmai, ' arte come vita ', o meglio.1 arte come idea '), e al tentativo del recupero di uno spazio non tecno-logicizzato (con la ' land art '), riducendo a spazio di intervento lostesso corpo umano (la ' body-art '), o di uno spazio acquisibilenel gesto (arte di ' comportamento '), anche l'attenzione diretta adun momento culturale come PArt Nouveau, si fa meno urgente, sene perde il senso di necessità.
Ma proprio perché il momento cruciale è superato, si può megliocapire, oggi, il significato dell'interesse recente per PArt Nouveau:ie coincidenze sono state, talvolta, a livello grafico-sperimentale, peruna impostazione di ricerca comune sulia linea interpretata come
I - La fortuna critica. Confronti e paralleli.
nastro svolgentesi e come ritmo lineare (si veda, ad esempio, il rap-porto di affinità tra la famosa coppa in ' favrile glass ' di Tiffany,del Metropolitan Museum di New York, anteriore al 1896, e certeesperienze americane e anche italiane - da Bridget Riley a FrancoGrignani, da JefTrey Steele ad Alviani, a Marina Apollonio...) o alivello ottico-percettivo, come appare chiaro dal lavoro grafico diKolo Moser in questo disegno per il quale egli ha sfruttato le op-portunità ' ottiche ' di una carta marmorizzata.
Oggi il discorso è cambiato: il design, sempre più rifiutato comefinalizzazione oggettuale, produttivistica, si recupera solo a livellodi creatività mentale, alternativa, anti-produttivistica. È un altro
/ - La fortuna critica. Confronti e paralleli.
fatto, dovuto alla situazione socio-economica sempre più compro-messa, se anche queste proposte alternative vengono, poi. inglobatedal sistema produttivo e consumistico del mercato, a cui non si sfugge...
L'avvicinamento, comunque, del Manierismo all'Ari Nouvcau. miè servito a mettere in luce un tipo di affinità di condizione di vita chesfocia, anche, per alcuni aspetti, in un tipo di affinità formale, masoprattutto mi ha permesso di cogliere, nelle due manifestazioni, unaconsimile capacità interna di propagazione e di penetrazione neltempo, che altri momenti culturali non presentano, e che. per l'ap-punto, si possono riconoscere e verificare nello svolgimento del feno-meno artistico della prima metà, e oltre, del nostro secolo.
Si tratta, infatti, di due espressioni composite, di riiettura di tamifatti, come una sorla di " poesia della poesia ', in cui, più direttamenteed esplicitamente che in altri momenti culturali, le diverse compo-nenti, psicologiche, fìlosofìche, letterarie, musicali, socio-politiche,convergono nell'espressione artistica, come unico comun denomina-tore, che si fa accentratore e sintesi di tutte le altre componenti. Laloro forza di penetrazione e di propagazione è più sotterranea, menodiretta, ma più 'inquinante1 (in cui 'inquinante' non assume si-gnificato negativo, ma vuole indicare l'azione di trasformazione, d:infiltrazione, di alterazione, comunque, della sostanza dei fatti», piùpersistente, e non può non manifestarsi anche a livello formale: non.ovviamente, negli stessi termini, ma in trascrizioni, talvolta, del luttoopposte, che sia pure come fatto di reazione, come 'scatto a ro\e-scio ', come gesto di rifiuto, di contestazione, si rifanno, peraltro, allastessa componente di base. Il filtro può agire consapevoli o inconsape-voli gli artisti stessi, può esser mediato o diretto, può assumersi solocome fatto di gusto o può complicarsi di termini e di motivi di altraorigine (appunto psicologica, psicanalitica, meta-artistica, in ogni ca-so); può darsi come esplicito riferimento formale ed emblematico,sempre, peraltro, mediato attraverso componenti deformanti, e. tal-volta, fuori della norma, aberranti.
Questa premessa serve, mi sembra, a spiegare le ragioni, anche,del fallimento dei tentativi di ' revival ' stilistico sul piano dell'archi-tettura e dell'arredamento italiani, a cui abbiamo accennato prima,quando siano rimasti a questo livello, senza superarsi in propostadi linguaggio e in autenticità di espressione.
2 - Precedenti dell'Ari Nouveau.
I precedenti più diretti dell'Alt Nouveau sono, tutti o quasi, inglesi,e per il particolare tipo di fervore culturale dell'Inghilterra, all'indo-mani della rivoluzione industriale, quando l'urgenza di uscire dallestrettoie di un costume passatista, " puritano, costringente, qualequello vittoriano, produceva reazioni tutte particolari e vivacissime.e perché contemporaneamente, all'altro apice del mondo culturaledell'epoca, Parigi, un clima diverso stava facendo sorgere, come nu-cleo intorno al quale si sarebbero svolti gli altri movimenti, l'Impres-sionismo.
Questo spiega anche come l'Art Nouveau sia stata, in definitiva, lacorrente che ha meno rapporti degli altri fatti artistici contemporaneicon l'Impressionismo stesso.
Anche se, invece, subirà l'ascendente dell'immagine morfologica evisuale delle grandi strutture dell' ' architettura del ferro ' (dallagrande serra di Chatsworth, del 1834, al Palazzo di Cristallo di Lon-dra, del 1850, di Paxton, agli edifici delle esposÌ7Ìnnì mondiali), cherappresentano, in realtà, il corrispettivo strutturale dell'Impressio-nismo en plcin air, che sarà la caratteristica essenziale dell'archilei-tura e dell'oggetto art nouveau,
L'esperienza di WILLIAM BLAKE (1757-1827), il poeta-pittore visio-nario e messianico inglese, è determinante in quanto incarna alcunidei caratteri che saranno alla base della poetica del Simbolismo edell'Ari Nouveau.
Già si esprime per simboli (il fiore di fuoco, come sintesi di elementi.la pianta e il fuoco, che stanno all'origine della vita); affida il suo lin-guaggio formale, eminentemente letterario, ad una figurazione fiabe-sca, tortuosa e magniloquente, se pure tecnicamente gracile, senzaconsistenza volumetrica, di un sentimentalismo misticheggiante. bio-morfico, ma che già intuisce e codifica un significato nuovo, anti-realistico, nel fatto decorativo.
Nei suoi Songs of Innocence, del 1789, il primo dei suoi libri1 miniati ', di chiara allusione alla miniatura medievale come sintesidi genuinità elementare e di eleganza calligrafica - in questo prece-dendo il Gothic Revival ottocentesco -, egli, oltre ad illustrare lesue poesie attraverso un metodo particolare di stampa simultaneadel testo e della parte illustrativa ornamentale, cercò di elaborarein unità formale Ì due fatti, testo-illustrazione, integrandoli in unasintesi di pura ornamentazione, dal ritmo fluido, dal movimento con-tinuo, dalla linea di superficie che si richiude su se stessa, dall'anda-mento asimmetrico, ondoso, morbido, che lo Schmutzler riportaall'ascendenza e al superamento della ' rocaille ', elemento manieristaper eccellenza 9.
•ecedenti dell'Ari Noi
Ma soprattutto incarna per la prima volta, dal Rinasci r.<; n;i inpoi, in epoca in cui già si delinca il concetto di specializzazione (haluogo, in questo momento, in Inghilterra, la rivoluzione industriale),l'ideale dell'artista polivalente, il tema della ' sintesi delle arti '. dellavita intesa come arte.
2 - Precedenti dell'Ari
È questa, oltre al suo medievalismo e al suo estetismo mistico eallegorico, la caratteristica di cui, a distanza di più di mezzo secolo,fecero tesoro i Preraffaelliti.
Gli altri artisti che avranno indubbia incidenza sulle poetiche pre-raffaellite, e alla lontana, attraverso quelle, sui modi Art Nouveau.
•^ saranno lo svizzero JOHANN FUSSLI (1741-1825) e il tedesco CASPAR•-'•** DAVID FRIEDRICH (1774-1840). Il primo verrà recuperato, per via
2 - Precedenti dell'Ari Nouveau.
indiretta, nella lezione delia poetica di Mallarmé (la parola si da.ne! contesto poetico, come smelatrice di immagini), nel filtro de!clima simbolista francese, ritornando, quindi, all'Inghilterra (dovepure era lungamente vissuto); e sarà un filtro inquietante, in bilicotra una visione onirica e allucinata e il ricorso a istanze proto-ro-mantiche e neo-classiche. Il secondo sarà un innegabile punto diriferimento per la sua concezione simbolica della natura, conside-rata un universo arcano, segreto, impenetrabile nella sua imperscru-tabilità, di fronte alla quale l'uomo verifica la sua solitudine, che siesprime in angoscia esistenziale, in " sublime" malinconia.
Né può essere ignorata l'ascendenza indiretta della lucida, rag-gelata sensualità dello smaltato ' classicismo ' di JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUIÌ INGRES (1780-1867).
2 - Precedenti dell'Ari Nouveau.
Ma per tornare all'ascendenza dì Blake, fu DANTE GABRIKL ROS-SETTI (1828-1882) che nel 1847 acquistò un taccuino di appunti, poe-sie, disegni di William Blake (il " Manoscritto Rossetti "), che fu perlui lo strumento di formazione e la fonte principale di ispirazionedella poetica della Confraternita dei Preraffaelliti alla quale egli, coipittori Holman Hunt e John Everett Millais (e col consiglio e l'ap-poggio di John Ruskin), dette inizio a Londra tra il 1848 e il 1849,nello stesso periodo in cui dipinse il suo primo quadro The Girlhoodof Mary Virgin (L'infanzia della Vergine Maria).
La poetica preraffaellita, che ha un suo precedente negli ideali deiNazareni e dei Chiaristi, fatti conoscere in Inghilterra da WilliamDycc (1806-1864) e nel misticismo severo di Ford Madox Brown(1821-1893), che aderirà al gruppo (che ha rapporti con la mìsticaerotico-magica del francese Ser Péladan, lo stravagante fondatoredell' " Ordine cabalistico della Rosacroce" nel 1888, e del Salondei Rosacroce, antirealista, in opposizione al Salon ufficiale di Pa-rigi), è basata, infatti, su una sorta di vago misticismo simbolicointellettualistico, che in realtà non ha niente, nella pratica opera-tiva, di simbolista, che si affida a forme chiuse, realisticamente de-finite, seppure tradotte in termini di idealizzazione quasi metafisica,non-naturalistica.
Il modello formale e ideologico è l'arte precedente a Raffaello(considerato sinonimo di classicismo naturalistico e di intellettuali-smo, e perciò rifiutato), l'arte dei ' primitivi ', il Medioevo coi suoimiti anti-classici, il mondo cristiano degli eroi delle Crociate, le Chan-sons de geste cavalieresche.
Per l'architettura d'altronde, John Ruskin, il maggior critico delmomento, sostiene parallelamente il ritorno al Gotico.
Gli artisti preraffaelliti non sono soltanto pittori, ma anche poeti:sì occupano di arti applicate, di arredamento, di pittura su stoffa.Vantano, con William Morris, la spiritualità del lavoro.
Ognuno di essi fa della propria vita un romanzo cavalieresco, nelquale l'ideale cristiano, il concetto di sacrificio mìstico, si unisce al-l'idea dell'amore terreno, inteso in maniera stilnovista, come spintaall'elevazione spirituale.
Tutte le poesie di Rossetti dedicate alla " blessed damozel " (labeata fanciulla, la moglie morta), i titoli stessi dei suoi quadri (Gir-lhood of Maryyirgin ; Anelila Domini; Dante drawing an Angel on thèAnniversary of Beatrice's Death...) fanno fede di questo preciso, in-derogabile, programma.
È interessante notare come, al momento della fioritura, a Londra,della Confraternita Preraffaellita - di un carattere, in fondo, ancoracosi puritano e vittoriano, malgrado si colleghi alla corrente del cosid-detto ' risveglio cattolico ', cosi avulsa da qualsiasi implicazione di-retta con la vita reale -, a Parigi esplodeva l'impressionismo, tantopiù direttamente partecipe dei problemi reali del proprio momentostorico, anche se meno aperto come impostazione umanitaria.
James Abbott McNeill Whistler, il pittore americano cosmopolita,amico di tutti i pittori francesi del momento, innamorato dell'arte
2 - Precedenti dell'Ari Nouveau,
francese, e che avrà pure una parte non indifferente nella formazionedell'Art Nouveau, ebbe, a Londra, dimestichezza con Dante GabrìelRossetti, almeno fino alla rottura col mondo culturale inglese in se-guito al famoso processo per diffamazione contro John Ruskin.
Pur manifestando un'ammirazione rispettosa verso Rossetti, il' Maestro ' (" artista no, sapete, però affascinante e gentiluomo "),non poteva esimersi da una sua causticità tipica, dovuta anche aduna visione tanto più distaccata e oggettiva e criticamente attualiz-zata dei fatti artistici contemporanei. Cosicché un giorno, mentreDante Gabriel Rossetti chiedeva consiglio circa una cornice ade-guata (problema, quello della cornice, che avrà tanta importanzaanche per l'Art Nouveau - e, a dire il vero, pure per lo stesso Whist-ler -), nella quale racchiudere una sua composizione che illustravadei versi: " perché non incorniciare il sonetto? " domandò.
HOLMAN HUNT (1827-1910), rappresenta, nel gruppo dei Preraf-faelliti, il momento più tipico: la descrittività analitica minuziosa.la religiosità enfatica, danno ai suoi dipinti un carattere particolare,quasi.di surrealtà, in una siglatura chiaramente riconoscibile.
2 - Precedenti dell'Ari Nouveau.
11 mondo dì JOHN EVERETT MILLAIS (1829-1896) è più naturalistico,malgrado gli assunti della poetica preraffaellita, contemplativo, idil-liaco, tende ad una idealizzazione lirica, elegante, della natura, suun piano di affabilità e di quieta accettazione della vita quotidiana,secondo una visione romantica, goticheggiante, che stempera, pe-i litro, l'allucinata fantasia alla Blake, in un aneddotismo sentimen-tale di maniera.
EDWARD BURNE JONES (1833-1898), acquistato alla causa preraf-faellita prima da un incontro con William Morris nello Excter Col-lege di Oxford (1852), poi con Dante Gabriel Rossetti (1855), che lodistolse dall'intenzione di seguire la carriera ecclesiastica per dive-nire pittore, fece rivivere nei suoi personaggi, dolcissimi e manierati,dai variopinti costumi medievaleggianti, la leggenda di re Artù e deicavalieri della Tavola Rotonda, finché il linearismo sinuoso e pun-gente di Botticelli, visto in Italia, e il monumentalismo di Mantcgna,non lo conquistarono in pieno. Si vedano, di lui, i bei disegni dellastrie Orfeo.
11 corrispondente più diretto, per la poesìa, della poetica preraf-faellita, la voce più adeguata, fu quella dì Walter Pater (1839-1894).
Ecco alcuni dei suoi preziosismi: "ardere sempre di questo fuocogemmeo, ecco il successo nella vita ". Ad uno studente che gli chie-deva: "Ma perché dovremmo essere buoni?" rispose: "Perché ètanto bello! »...
Precedenti dell Ari Nouveau.
Ma il movimento preraffaellita è di grande interesse nei suoi rap-porti, prima con JOHN RUSKIN (1819-1900), scrittore, disegnatore, cri-tica e moralista inglese, poi con WILLIAM MORRIS (1834-1896), chedi Ruskin riprese e portò avanti il programma di moralizzazione delcostume attraverso l'arte, intesa nella sua espressione di più direttorapporto con gli atti della vita, nella sua applicazione, cioè, nell'og-getto di artigianato.
Il carattere dottrinale, moraleggiante, di un socialismo cattoliciz-zante e utopisticamente riformatore, impostato sull'odio contro lamacchina e contro l'industria, trova un rapporto diretto nel medie-valismo preraffaellita, e si inserisce, in posizione dialettica, ma allostesso tempo perfettamente in linea, per l'incitamento ad una riqualifi-cazione della progettazione per l'industria, nella campagna portataavanti dal governo inglese per l'incremento delle scuole di educazioneartistica, anche se il " College of Arts and Crafts " (Scuola di Ari:e Mestieri), fondalo a Birmingham nel 1821 e la Commissione Parla-mentare istituita nel 1835 allo scopo di "diffondere la conoscenzadel disegno nel popolo ", si rivolgevano particolarmente alle mae-stranze impiegate nell'industria {manufacturing population): cioè -ir.
2 Precedenti dell'An Xouremt.
completo disaccordo con lo spirito di Ruskin e Morris la cui lottariformatrice era soprattutto rivolta contro la produzione industriale.
Quando, nel 1861, William Morris, con Philipp Webb (l'archi-tetto che aveva creato per lui, a Upton, nel 1860, la Red House, laCasa Rossa, impostata su principi di semplificazione del linguaggioarchitettonico, seppure ancora legata ad un medievalismo di manie-ra), con Burne-Jones, Rossetti. Faulkner, Marshall, fondava, a Lon-dra, la ditta Morris, Marshall & Co., per la quale gli artisti sì definì-
2 - Precedenti dell'Ari Xouveau.
vano " operai d'arte in pittura, scultura, arredamento e vetrate ",dava avvio a quel vasto movimento dì riforma che avrebbe interes-sato ogni genere di produzione artistica, dall'architettura alle artifigurative, alle arti applicate, ivi comprese le arti tipografichc - Morrisaprì nel 189Ó a Mcrton Abbey (dove dal 1881 aveva trasferito il suo' atelier ', dopo la defezione di Brown, Rossetti, Marshall), la Kelra-scott Press, da cui usci, nel 1896, il " Kclmscott Chaucer " - e ten-tava soprattutto il superamento della dissociazione tra produzione eartista, individuando il rapporto tra arte e società su cui sarà impo-stato tutto l'Art Nouveau. Nel 1888 Morris fondava poi con Mack-murdo, Crane, Ashbee. la " Arts and Crafts Exhibitions Society ",alla quale affidava la dimostrazione delle sue teorie.
11 rapporto, invece, al quale ho accennato, dei Preraffaelliti con'americano JAMES ABBOTT MCNIÌILL WHISTLER (1834-1903), così di-verso per impostazione mentale e per tipo di interessi, così libero darèmore puritane e da moralismi - ma anche cosi egoisticamente chiusoad ogni interesse sociale ed umanitario - si può spiegare attraverso lealtre componenti, che pure confluiranno nell'Art Nouveau, tra lequali l'amore comune, sia agli esteti francesizzanti sia ai Preraffaelliti,per l'Oriente e soprattutto per il Giappone, che anzi Whistler diffuse
2 - Precedenti dell'Ari Nouveau.
a Londra, al suo ritorno da Parigi (dove l'orientalismo furoreggiava,importato dai fratelli Goncourt), nel 1859.
Whistler incarna a Londra, con Oscar Wilde, il tipo del perfetto• esteta ': è la contropartita di Ruskin, col quale ebbe, infatti, un pro-cesso clamoroso che può considerarsi il simbolo dell'opposizione didue mondi, quello del puritanesimo vittoriano, e quello rivoluzionario,dichiaratamente scandalistico e dì rottura, che vedrà nelle sue filei più grandi personaggi del mondo letterario e artistico de! tempo:da Baudelaire a Verlaine, a Rimbaud; da Beardsley a Gauguin a
2 - Precedenti dell'Ari Nouveau.
Van Gogh; da Wìlde a Swinburne, da Ibsen a Strìndberg, a Prousta Gide; che quasi tutti bruciarono la propria vita nel fuoco distrug-gitore di una libertà conquistata e pagata caramente con la compro-missione più violenta della propria umanità.
Anche l'abbrutimento, anche la fine miserevole, coraggiosamenteaffrontata e talvolta cercata, di tanta parte di esponenti della culturadi questo ' fin de siècle ', è un'altra prova dell'alienazione della cul-tura dalla società e avvicina, per molti aspetti, queste figure, che colsacrificio di sé hanno dato avvio alla lotta per la salvezza del mondomoderno, per un lato a quella ' beat generation ' americana deglianni '20 (la ' generazione perduta ', come la defini Gertrude Stein.dei Fitzgerald, di Henry Miller), e anche a certe manifestazioni re-centi di ribellione degli intellettuali contro la società massificata: si
Precedemì dell'Ari Noi
pensi ai movimenti bcat e allo sfrenato rifiuto della società costituita.da parie dei poeti americani, da Kerouac, a Ginsberg, a Corso.
Quanto alla passione per l'arte orientale che accomunò la culturaartistica della seconda metà del XIX secolo, sarà proprio Whistlerche, tra il 1876 e il 1877 decorerà, a Londra, la famosa e bellissimaPeacnck Roani (la Stanza dei Pavoni), per Francis Leyland. anzicontro la sua volontà, approfittando di una sua assenza momenta-nea - e in quell'occasione dipinse sopra la preziosa tappezzeria anticain cuoio di Russia, fece a pezzi un tappeto persiano i cui colori nonarmonizzavano coi suoi - come cornice ad un suo quadro La Prin-ccs.se chi Pays de la Porcelaine (1863-1864), chiaramente ispiralo amotivi giapponesi (si pensi alle xilografie di Utamaro).
Nella Peacock Rootn la disposizione del disegno nello spazio dellepureti non è più impostata in maniera tradizionale, ma in un giocolineare di asimmetria di superfìcie, lontana dalle regole della prospet-tiva classica. Tutto un movimento continuo, avvolgente, sale degrandi ventagli a linee serpentinate dei pavoni fino a ricadere mor-bidamente nelle gocce luminose delle piccole lumiere a soffino. osCsoffuso splendore di un verde-oro luminoso e trasparente. Aucte os:quadri, che Whistler intitolava a guisa di pezzi musicali, come, acesempio, Notturno in blu e oro. Sinfonia in bianco, l'ascendenza giap-ponese è diretta nella libertà delFimpaginazione, nell'uso del colore.nell'armonia (che però testimoniano anche dell'amore di Whist3erper l'Impressionismo).
Oltre al motivo del pavone, che attraverso Beardsley diverrà, co:cigno, il giglio, la ninfea, una delle sigle più caratteristiche dell'AriNouveau, è di Whistler - ma anche dei Preraffaelliti, come si è visto -la ricerca di accordo tra quadro e cornice, quasi a fare un tutto unico.Si veda il Notturno in blu e oro: il vecchio ponte di Battersea (1872-1875). La cornice, decorata a scaglie blu e oro è come la naturaledefinizione del quadro, tutto sugli stessi toni. A destra il motivo dellafarfalla, che Whistler usava a mo' di sigla in ogni sua opera, nelle suelettere, disposta sempre in posizione asimmetrica, secondo l'usogiapponese. E suo è il ' giallo farfalla ' (tutta la sua casa era impo-stata su questo colore, dalle pareti ai tovaglioli, in accordo col biancoe blu delle porcellane cinesi). E col blu e verde, col viola e turchese.sarà anche uno dei colori preferiti daH'Art Nouveau.
Sarà soprattutto il senso dell'armonia generale che emana da tuttociò che accompagna ogni atto delia vita, fino all'estenuazione piùraffinata, il motivo di cui l'Art Nouveau farà più tesoro . -
L'interesse verso l'Oriente si manifestava intanto in una serie ditesti sull'arte giapponese, tra i quali il più autorevole resta quello diCHRISTOPHER DRESSER del 1876, " Japan, its Architecture, Art and
2 - Precedenti dell'Ari Noi
A t M inifactures ". E Dresser e anche autore di " The TechnicalEl tor " (1870), nel quale individua il significato della struttura
n ca e funzionale degli elementi vegetali, dando avvio ad uno1 otivi più perspicui dell'Art Nouveau, quello del ritmo lineare,l 11 n rgìa dinamica insita nelle forme della natura, nelle piante,
gì o gani dì volo degli uccelli. In realtà, non è tanto la natura cheI L oggetto di studio e fonte dì suggerimento, quanto l'individua-
e dello schema costruttivo, simbolico, della matrice strutturalei 11 ggetto naturale, espresso in mòduli geometrici piani, secondol orientale. Ma il carattere bidìmensionale dell'ornamentazioneor entilc era già stato avanzato come postulato teorico dalla " Gram-n a of Ornament " del 1856 di OWON JONIÌS, sulla quale era impo-r t o 1 metodo educativo della scuola di South Kensìngton, e chebbe tanta ascendenza sui Preraffaelliti, prima, e, in pieno Ari Nou-
anche su Van de Velde.Al Gothic Revival, già insito nel medievalismo di Ruskin, di Morris,
I Pre-affaelliti, e per il quale si dovrà anche fare il nome del fran-e \ JLLET-LE-DUC (1810-1879), da cui deriverà l'interesse cosi vivo
p 1 struttura, nella quale egli diceva consìstere l'espressione piùte tea dell'architettura (e riduceva i mòduli dell'architettura me-
de le nelle ornamentazioni ' strutturali ' in ferro), rimarranno le-"at attraverso Ruskin e Morris, anche gli inglesi ARTHUR MACK-MURDO (1851-1942), WALTER CRANIÌ (1846-1915), CHARLES ASHBEE(1863-1942), che promossero il movimento di " Arts and Crafts ",prima con la " Century Guild " (1882), intesa alia riqualificazione
2 - Precedenti dell'Ari Noureau.
di tutti i settori della produzione artistica, poi con la " Arts WorkersGuild " (1884), fino alla " Arts and Crafts Exhibition Society ",fondata nel 1888.
Ma con questi personaggi il primo Art Nouveau inglese può dirsigià nato.
Simbolismo, Estetismo, Neo-spiritualismo, che si potevano rias-
2 - Precedenti dell'Ari Nouveau.
sunicic m quello che si definiva decadentismo , non possono piùconsiderarsi premesse, bensì componenti parziali o essenziali, e co-munque partecipi di un'aria generale di gusto Art Nouveau.
È interessante, semmai, vedere come l'Art Nouveau riesca ad uti-lizzare queste premesse, come se ne serva in maniera razionale, quasiilluministica, per così dire, così come, ad esempio, Pìranesi si ser-viva dell'antichità classica e dì motivi egizi.
Si veda infatti la differenza tra il modo con cui si manifestanoi diversi revivals del momento (i vari neo-romanico, neo-gotico,neo-neo-classico...} e come l'Art Nouveau, invece, si serva di questistessi motivi, dello stesso concetto di revival, ad esempio, non inmaniera storicistica, ma razionalmente, a mo' di ' collage ', come ri-ferimento emblematico, come implicazione simbolica, trasformandotutto ed assorbendolo in un problema di 'stile': si pensi a comeAubrey Beardsley usa il ' classico ', nell'illustrazione Ave atque valedel carme di Catullo "In morte del fratello"; con una purezzadi trascrizione, con un rivivere assoluto del motivo, risolto nella di-namica tensione della linea; o a come, ad esempio, Gaudi si servedel Gotico, rivivendone con intensa adesione il carattere corale, reli-gioso; reinventandone e mettendone in crisi le leggi costitutive, for-zando certe leggi statiche e dinamiche del Gotico stesso, con unalibertà di interpretaziòne e di revivescenza straordinarie; o, anche,a come lo Jugend usa i motivi monodimensionali, prospettici, egizi,come fatto emblematico (di qui il ricorso, anche, al Piranesi delledecorazioni).
2 - Precedenti deli'Ar! Nouveau.
E sarà, comunque, questa forza di infiltrazione, capace di trasfor-mare, plasmare a sua immagine ogni motivo, da qualsiasi parte leprovenga, che darà vita a quel filo sotterraneo, che già al suo mani-festarsi non si tradusse, nello stesso Art Nouveau, in movimento risol-vente, accentrante, globale, ma venne a costituire quel sottofondoche ogni tanto riemerge e svolge le funzioni, non di basso continuo,ma anzi di ' vibrato ', di guizzo ricorrente, che, comunque, appunto.' inquina ' (nel senso che incide, segna, infine ' trasforma ') tanti fat-ti che si sono verifìcati dopo, anche tra loro lontani e contraddittori.contribuendo a caratterizzarli.
Per tornare alle varie correnti: Simbolismo, Estetismo, Neo-spiri-tualismo, che, come si è detto, si possono considerare componentidell'area generale di gusto art nouveau, poiché rappresentano, a lorovolta, correnti autonome e contemporanee, sarà opportuno, di voltain volta, registrarne le tangenze. Anzi, per quanto è possibile, diquel momento di cultura cosi variamente intersecato e ricco di rap-porti e di scambi, vorremmo riuscire a cogliere i fatti più autonomie caratterizzati.
Questo, non tanto per l'architettura e per le arti applicale, per cuii chiarimenti sono stati già assai vasti, ma soprattutto per le arti pia-sliche, che generalmente si ritengono solo parzialmente interessate(anche se contributi notevoli, stranieri e italiani, permettono di im-postare il problema in maniera precisa).
Il Madsen, per esempio, scrive che "in regola generale... il ter-mine Art Nouveau non può essere usato per la pittura, sia perchéil fenomeno interessò soprattutto l'architettura e le arti applicate.sia perché la pittura viene di solito distinta in periodi ben determi-nati, secondo una suddivisione che le è particolare" 10.
Proprio per questo, invece, ci sembra opportuno riuscire a cogliere.nei caratteri essenziali, le personalità, che non saranno molte, maautonome, che caratterizzano il momento.
Anche perché proprio la distinzione in periodi ben determinatidella pittura è ormai un'eredità dì momenti di cultura nei quali l'ap-porto dell'Art Nouveau era completamente e volutamente ignorato(di Klirat, ad esempio, non sono molti anni che si è ripreso a parlare),anche per la forza propulsiva di fatti come l'Impressionismo, prima,poi dei vari movimenti che ebbero come centro di diffusione Parigie la Francia, e nei quali sembrava sfociare qualsiasi evento artistico(il Post-Impressionismo, i Nabis, i simbolisti ecc), e per il subentrare,alla vigilia della prima guerra mondiale, dell'Espressionismo e dellevarie avanguardie, che, rovesciando il concetto tradizionale di 'arte',si posero.subito, intenzionalmente, contro quell'ideale del bello',al quale, comunque sia. l'Art Nouveau si ispirava, riponendo anzi suquello ogni sua ipotesi di moralizzazione e di riscatto della vita comune.
3 - Caratteri dell'Ari Nouveau.
\nche se il movimento, così dilatato e così vasto, presenta fatti emodi diversi a seconda dell'humus culturale e storico nel quale si in-t LSLI e i seconda del tempo, tuttavia è possibile cogliere, nelle diversein mitestazioni, alcune caratteristiche generali e alcuni aspetti cheuniranno variazioni e modificazioni nei diversi momenti e luoghi.
ni \ che si rifaranno sempre ad un denominatore comune.
L'Art Nouveau si poni;, intenzionalmente, come ' stile ornamen-tale \
Una lunga tradizione razionalista e purista ci ha abituati a diffi-dare dei termini ' ornamento ', ' ornamentale ' e dell'aggettivo af-fine • decorativo \
Vediamo, invece, che cosa si debba intendere con questi termini.che l'Art Nouveau contrappone a ' naturalismo ' e ' naturalistico \tacciando di naturalisti anche gli impressionisti, in quanto, in accordocoi simbolisti, videro in loro, e per molti versi a ragione, come beneebbe a dimostrare, in un saggio pubblicato su « Comunità ». MilaLevi Pistoi, l'estremo portato del naturalismo ottocentesco.
" Nelle illuminazioni dei simbolisti come nelPallusività dell'Ar:Nouveau spira, è vero, un'aria di fine secolo, ma la crisi più grave ssenza possibilità di soluzioni è innegabilmente nel filone del Naturi*lismo. Oggi questa constatazione pare una realtà banale e quasi scon-tata, eppure per lungo tempo fu velata da cause secondarie e non de"tutto artistichc tra cui va certamente messo il fatto che l'incomprer.-sionè del grosso pubblico e la derisione della critica ufficiale contri-buirono e confortarono gli impressionisti stessi a credersi dei vessil-liferi di una rivoluzione del gusto. In effetti furono l'estremo pro-dotto del Naturalismo ottocentesco e a ragione furono attaccati po-lemicamente dai contemporanei simbolisti" n.
Aggiungerei che l'intuizione e l'anticipazione di attualità dei sim-bolisti e dell'Art Nouveau, rispetto agli impressionisti (naturalmentequeste osservazioni sono esclusivamente rivolte ad un certo tipo diimpostazione mentale e non intendono minimamente sottovalutarel'interesse dell'Impressionismo sul piano artistico), sta nel fatto che.mentre quelli assumono, sia pure con sprezzante violenza, la realtàborghese, l'Art Nouveau e i simbolisti tendono a trasformare la realtàcontingente, sublimandola nel mito del Bello, di un Bello trasportatodirettamente nella vita, confinante, perciò, con l'Eleganza, e non tra-scendente - anche col rischio, non sempre evitato, dell'evasione -.
La dichiarazione di Werkade, un Nabi belga, " non ci sono quadri,c'è solo decorazione ", è abbastanza dimostrativa di questa situazione.Ed è altresì sintomatico che Alois Riegl, nell'introduzione al suo " Stil-fragen " (Problemi di stile), uscito nel 1893, scriva: "...il bisogno
3 • Caratteri dell'Ari Nouveau.
di decorazione è... uno dei più elementari bisogni dell'uomo, più ele-mentare di quello della protezione del corpo ".
L'ornamento dell'Art Nouveau è la forma simbolica nella qualeè racchiuso il messaggio, e tende ad impadronirsi dell'oggetto pertrasformarlo nella sua essenza ' strutturale ', nel suo vitalismo se-greto, nel ' simbolo ' della sua funzione.
Perciò l'ornamento si concretizza nella linea avvolgente, dinamica,sinuosa, dal tratto netto e definito, che determina, sul piano, due for-me complementari, come un positivo-negativo, che hanno significatociascuna per proprio conto. E sì sdoppia e moltiplica, poi, come l'ecodi un'onda, in fasci di linee che si diramano in parallelo o a venta-glio, in svolgimenti liberi.
Walter Grane, nel 1889, parla del significato della linea come forzaevocatrice. E aggiunge; "La linea è di importanza assoluta: nellarealizzazione dell'opera d'arte il disegnatore, perciò, deve servirsi dilinee di ogni tipo; linea determinante, linea enfatica, linea delicata,linea aggressiva, linea che controlla e unisce".
Félix Bracquémond, incisore e ceramista francese, in " Du dessinet de la couleur " del 1885, scrisse: " Ciò che nella vita è gesto, movi-mento, espressione di carattere, manifestazione di esseri viventi edisposizione di oggetti, nell'opera d'arte diventa linea ".
Van de Velde, nel 1898, scriverà che la linea è " una forza attiva
come tutte le forze elementari ". E Endell, architetto tedesco, autoredel famoso atelier Elvìra a Monaco, dalla fantasiosa libertà nella de-corazione ornamentale della facciata e della scala (l'atelier, del 1896-1907, è stato distrutto dai nazisti), scriveva nel 1898: " Stiamo assi-stendo al sorgere di un'arte completamente nuova, un'arte con formeche non significano o rappresentano niente, non evocano niente, mapossono stimolare il nostro spirito altrettanto profondamente diquanto possono farlo i toni musicali ".
Nello stesso tempo Debussy parlava di " rottura della cellula melo-dica ", e nel 1901 scriveva nella « Revue Bianche»: "L'arabescomusicale, o piuttosto, il principio dell'ornamento, è hi base di tutte
- le forme d'arte ".
3 - Caratteri dell'Ari Noureuu.
I legami col mondo musicale erano mollo stretti: lo stesso Debussyeseguì la Damoìselìe élue, ispirata al poema e al quadro The ble.ssedDamozel (1874) di Dante Gabriel Rossetti alla inaugurazione dellaprima mostra di "La Libre Esthétique ", nel 1894. E fu il franceseMaurice Denis che illustrò l'edizione francese del poema sinfonicodi Debussy e delle poesie di Rossetti. Addirittura di " liberty " e di" esoterismo ", parla Marco Bortolotto a proposito di alcuni Lie-der (dai Fiinfzehm Gedichte del Buch der hangendem Garten Op. 15 aiLicder deìl'Op. 22) di Schònberg, usando il termine " curvilinei " l2.
E la danza, come proiezione nel tempo, in senso ' musicale ', rit-mico, del movimento, è una delle espressioni più ricorrenti nell'ico-nografìa dell'Art Nouveau.
Anche la figura umana è assunta in senso simbolico, come espres-sione del dinamismo essenziale nel quale si concretizza la vita.
L'immagine femminile è ridotta a sottile simbolo scorporato, dìcui rimane, sotterraneo e segreto, un sensualismo sofisticato e sfug-gente, leggermente equivoco, e l'immagine della danzatrice è tipicadel tempo.
3 Caratteri dell'Ari Nomali.
Il gesto rituale della danza, poi, è uno dei mezzi di esorcizzazionedel sesso (come direbbe Barthes), perché allontana il corpo nel favo-loso (come l'esotismo, che, come ben sappiamo, è un altro dei mo-tivi più amati dall'Ari Nouveau).
E in realtà, in un'epoca in cui Stanislav Przybuszewski, grandeamico di Nietzsche, poteva scrivere: " In principio era il Sesso. Nullaera all'infuori di Lui, tutto era in Lui" (1893), si temeva veramenteil sesso.
Era l'inizio della emancipazione femminile, in una società ancorapermeata di puritanesimo.
Nietzsche vedeva nella donna una creatura pericolosa, infida, sen-suale (forse, anche, per l'abbandono della stravagante Lou Salomè).
La donna angelicata dì Dante Gabriel Rossetti e di Bume-Jonessi stava trasformando nella donna vipera di Beardsley e di Klimi.
(E anche a questo proposito verrebbe la voglia di fare un raffrontocon la situazione attuale: mai si è parlato di sesso come ora, mai siè svolta una campagna di pubblicizzazione del sesso come oggi. Lelotte per la parità civile e sociale tra uomo e donna, portate avantidal movimento femminista, troppo spesso male interpretato solo co-me sinonimo di liberalizzazione erotico-comportamentale - ne SODOun esempio alcune tra le riviste femminili italiane sulPargomemo -portano, come contropartita, questa pubblicizzazione del sesso, chirappresenta, ancora, una difesa interessata, e inconsciameme ap-poggiata proprio da tante soi-disant ' femministe ', da parte de-Zeistituzioni borghesi configurate per una società retta daH"uoroo ;che, squalificando la dignità femminile, tentano le estreme difese ciuna condizione statica, di comodo).
Ma nel periodo di cui ci occupiamo le idee non assumevano, sr-cora, almeno all'apparenza, tali forme di parossismo esteriore, aaz:si ponevano come simbolo astratto, cioè si scorporavano.
Perciò, dunque, il simbolo più ricorrente dell'Ari Nouveau è l'tm-
3 - Caratteri dell'Ari Nouvt
magine della danzatrice serpentina (la Serpentintànzerin), nella qualesi concretizza e si personifica, giustificando una sorta di amore-odioviolento, l'idea della linea serpentinata.
La Loie Fuller, !a danzatrice dai veli (che faceva fluttuare il suolunghissimo manto aiutandosi con un'asta sottilissima, invisibile, econ alcuni ventilatori), è per questa ragione l'idolo dei poeti (Mal-larmé, Rodenbach) e l'ispiratrice di tanti artisti, da William Bradley
a Raoul Larche, a Pierre Roche, che, con l'architetto Henry Sauvage,le dedicò anche, a Parigi, per l'Esposizione Universale del 1900,un teatro la cui facciata si modeliava secondo la spirale dei suoi veli,a Rivière, Hoelger, Lerche, Lucas, Van de Velde, fino a Rodin, aToulouse-Lautrec, a Kolomar Moser, a Jules Cheret...
*'... La Loie Fuller che faceva turbinare attorno a sé metri e metridi veli leggeri, cavaturaccìoli, trottola, splendente nella luce coloratacome un vaso iridato di Tiffany, fino a trasformarsi, con serpentinesempre più ardile, in un enorme ornamento, la cui metamorfosi, dauno slancio luminoso a un improvviso abbandono fino all'annulla-mento nella gola dell'oscurità e del sipario, ci appare nel ricordo comeil simbolo dello stile Floreale" (Friedrich Ahlers-Hestermann) 13.
3 - Caratteri dell'Ari Nouveau.
Non posso fare a meno di osservare, a questo punto, una stranacoincidenza simbolica:
La danzatrice americana Isadora Duncan, la cui vita fu tutta estro-versa, esclusivamente rivolta al riscatto della libertà, inseguita an-che nella sua tecnica, intesa alla definizione della ' danza libera ',naturale, spontanea (sia pure, in parte, secondo le teorie di F. Dei-sarte), per cui rifiutò, anche, effetti scenografici e decorativi, si dimo-stra, in effetti, nei suoi rapporti, nelle sue idee politiche (moglie delpoeta comunista russo Essenin, che poi abbandonò, come già avevaabbandonato Gordon Craig, cercò di diffondere, in accanite serate dispettacolo-manifestazione, in America, idee di sinistra), la meno le-
j - Caratteri dell'Ari Nouveau.
gata all'immagine tipica, di grazia perversa, di raffinata estenuazione,di decorativismo lineare dell'Art Nouveau. Ma la sua morte si rias-sume, stranamente, in una tipica raffigurazione art nouveau: mentresi lasciava trasportare nella sua veloce macchina scoperta, da un gio-vane accompagnatore, la sua lunghissima sciarpa di velo, agitata nelmovimento frustante del vento, sollevato dalla corsa, rimase impi-gliata in una ruota della macchina e la strangolò. Come se l'amore -odio per la donna, che si personifica, a sua volta, nella linea serpen-
3 - Caratteri dell'Ari Nouveau.
tina, sì chiudesse su se stesso, in una sorta dì tautologia riflessa ;r.una coincidenza di suggestiva, tragica, dannunziana drammatici!
Nell'immagine in movimento, dì cui la linea serpentina è dunqueil simbolo, si concretizza anche l'idea di spazio dell'Art Nouveau.che, per la prima volta, si pone come ' spazio esistenziale ".
Lo spazio definito secondo la geometria euclidea viene completa-mente annullato. Alla ' regola ' classica sì sostituisce il ritmo, allasimmetria l'asimmetria: lo spazio non si da come esistente, ma sicrea contìnuamente, dall'esterno, dal ritmo della linea avvolgente,nell' ' atto ' del farsi.
Non è uno spazio esplosivo (come quello del Barocco), ma implo-sivo. Si crea dalla superfìcie, dal nastro sinuoso che si curva, e cometale esiste come involucro che si modula e arricchisce come una pre-ziosa scorza, sia all'esterno che all'interno.
Si pensi a Horta, a Van de Velde, a Hoffmann, a Endell e, per altravia, anche a Gaudi (solo che, se il simbolo fitomorfico si adatta aiprimi, per Gaudi bisognerà ricorrere ad un paragone più organici-stico, zoomorfìco. Si ricordino le parole di Dali, nel testo sopra ci-tato " De la beauté terrifiante et comestible de l'Architecture Mo-dern' Style ", su « Minotaure », del 1933, quando accenna al piacereche gli provocava l'arte di Gaudi, quando penetrava nelle " grotteattraverso tenere porte di fegato di vitello ").
Finché con Adolf Loos (che ormai griderà: l' l'ornamento è delit-to "), con Louis Suìlivan, con Wright, lo spazio si aprirà comple-tamente, la linea strutturale non sì risolverà più in simbolo, torneràad essere struttura reale, ma struttura aperta.
Resta da considerare quella che è stata forse la scoperta più ri-schiosa e più attualizzata dell'Art Nouveau: l'aver posto le basi delconcetto moderno di ' design ' come mezzo di integrazione sociale,in quanto, per la prima volta, la produzione è considerata come unadelle funzioni della società.
Anche in questo si deve cogliere il tentativo dell'arte di colmarela frattura arte-società ed anche il rischio nel quale l'arte si pone, didiventare essa stessa strumento della società dei consumi. Ciò a cuinon sfugge, nel suo degenerarsi, l'Art Nouveau,
E così si capisce la sua tarda involuzione negativa, il suo scaderea livello di gusto (e il rifiuto oppostogli dalle successive avanguardierivoluzionarie, e anche l'inizio della degenerazione, come imposizio-ne di gusto da parte dell'industria interessata, del design, che troverànel Bauhaus l'ultima difesa e l'ultimo tentativo di riabilitazione finoalla crisi, estremamente salutare, dei nostri giorni).
3 - Caratteri dell'Ari Nouveau.
Nell'accenno ad una degenerazione dell'Ari Nouveau in fenome-no di gusto, è implìcito il riconoscimento di una sua impostazioneeccessivamente intellettualistica, raggelata, di un'accensione tutta diLesta, anche nella sua inquietudine sensualistica, nel suo erotismofreudiano.
Analizzando il movimento secondo i suoi diversi caratteri e le suelinee di svolgimento vedremo come non sia quasi possibile distin-guerne le manifestazioni in periodi successivi: mentre per alcuniaspetti (grafica, arti applicate), alcune regioni hanno la precedenza(l'Inghilterra, ad esempio, la Francia, gli Stati Uniti), per altri aspetti(architettura, pittura, scultura), c'è un netto slittamento, con puntedi precedenza che vanno, invece, dal Belgio alla Francia, alla Cata-logna, agli Stati Uniti, all'Austria e Germania, alla Scozia, alle altreregioni continentali.
Semmai la distinzione può darsi tra primo Art Nouveau e secondoArt Nouveau e tra diversità di caratteri, di regione in regione, e diascendenze.
Nei caratteri generali e per alcuni motivi dominanti le manifesta-
3 - Caratteri dell'Ari Nouveau.
zioni, invece, sono quasi contemporanee: si pensi al famoso motivodel ' coup del fouet ' (il colpo dì frusta), per il quale, come primoesempio dichiarato ci si riporta al ricamo La frustata di Obrist inun paravento del 1892-1894 (anche se lo si fa derivare dalla copertinadi Mackmurdo di " Wren's city churches " del 1883, che, a sua volta,si riporta a motivi di William Blacke e di Morris; ma si è parlatoanche di riferimenli alle prime sedie di Thonet, verso il 1835), che poisi ripropone, in soluzione plastica, nell'architettura di Horta, in Belgio," nell'arricciatura delle membrature e delle cornici " l4, (ma giàin questo senso si esprìmeva in Gilbert, inglese, la cui Fontana di Erosin Piccadilly Circus, a Londra, iniziata nel 1887, svolge plastica-
mente il motivo, in versione, peraltro, di estrazione barocca), tornain Austria nelle decorazioni murali di Endell (facciata deìY AtelierElvira, del 1896-1907), a Parigi con il prospetto decorato come unfluttuar di veli del teatro dì Loie Fuller dì Pierre Roche (prima del1900), nell'opera di Gaudi, in Catalogna (la rosta sul portale di pa-iacio Giteli, a Barcellona, 1885-1890, un particolare decorativo nelravilla di Bellesgudrd, 1900-1902)...
Per il primo manifestarsi dell'Alt Nouveau sul continente e negliStati Uniti Tschudi Mad'sen parla di " tendenze latenti: motivi fio-reali in Francia, ornamentazione di ispirazione celtica in Belgio, si-nuose volute algheiformi in Spagna, il gioco astratto della linea nel-l'opera di artisti come Van de Velde e persino un curioso intrecciodi rampicanti in quella di Sullivan. Ma si tratta " egli aggiunge " difenomeni individuali; non legati tra di loro, anche se ogni singoloartista indicava una direzione verso l'Ari Nouveau" 1S.
3 - Caratteri dell'Ari Nouveau.
- Caratteri dell'Ari Nouvi
Comunque preferisco adottare la presentazione per regioni, siapure arbitraria, senza pretendere di seguire una esatta successionecronologica, per evitare, quanto più possibile, di costituire una dif-ferenza gerarchica tra i diversi aspetti della produzione artìstica, an-che perché, proprio con l'Art Nouveau, si ha il primo tentativo realeper il conseguimento di quell'ideale (seppure sempre utopisticai1 sintesi delle arti ', che anche il Bauhaus cercherà di realizzare eche proprio nel caso dell'Art Nouveau troverà la sua definizione piùesatta, non come aspirazione astratta, ma come conseguimento, nel-l'estrinsecarsi dell'attività individuale dei diversi artisti, che cerca-rono di realizzarla in se stessi, nel polimorfismo del loro interesseoperativo e, direi, nella loro prospettiva ottica ideale, che unificavale diverse manifestazioni artistiche e le diverse .attività, nella sola gra-dualità della scala.
Se abbiamo riconosciuto, giustamente, all'Inghilterra, la prece-denza diretta nella formazione della cultura nella quale si inserisceil movimento di Art Nouveau, e se non abbiamo rifiutato del tuttol'accusa di 'naturalismo' formulata dall'Art Nouveau e dal Sim-bolismo verso la grande esperienza dell'arte francese dell'800, nonpossiamo neppure non notare come tutta la cultura inglese sia im-prontata ad intellettualismo cerebrale, come anche i Preraffaelliti nonabbiano rifiutato il naturalismo come fatto figurativo, ma si sianolimitati a snaturare l'immagine umana, trasformandola in ' allego-ria ', ignorandone le implicazioni sensibili, conturbanti, violente, an-che volgari, che al contrario la Francia evidenziava senza pietà oritegno.
Non si può ignorare in tutto T800 inglese un moralismo puritano,da collegio femminile, che cova anche sotto le ribellioni e riesce asoffocarle e inglobarle.
Questo spiega la violenta reazione degli intellettuali fine-secolo(con l'anticipazione dì Whistler, non inglese, che, come abbiamovisto, non ebbe la vita facile, anche se non si rassegnò troppo docil-mente), e l'ostilità con cui anche dagli elementi considerati di avan-guardia (ormai ' integrati ') furono accolte le coraggiose - e osten-tatamente equivoche - ribellioni degli esteti e degli artisti, da OscarWìldc, che fu letteralmente messo al bando, a Aubrey Beardslev.che rappresenta la personalità più viva e più rivoluzionaria del primoArt Nouveau inglese e che, in patria, non incontrò nessun sostegnonella cultura divenuta ufficiale, né da parte dei Preraffaelliti - se siesclude Burne-Jones -, né da parte di Morris (e, stranamente, nep-pure da parte di Whistler, che avrebbe dovuto sentirlo immediata-mente ' dei suoi ', se le amarezze di un continuo rifiuto da parte dellasocietà, la perdita della sua bella Whìte House - la Casa Bianca, chesi era fatto costruire, quasi in gara con Morris, da Edward WilliamGodwin -. e un naturale, snobistico disprezzo per gli altri, non ioavessero soffocalo in un livore egoistico e misantropo).
Come anticipazioni formali del nuovo stile si citano le ceramichedella Grainger & Co., presentate alla Esposizione Internazionale diLondra del 1851, a spiegare anche la priorità inglese nelie manife-stazioni Art Nouveau.
Abbiamo già parlato di WALTER CRANE (1845-1915), fondatore,con Mackmurdo e Ashbee, del movimento di " Arts and Crafts ",la cui attività grafica, dì illustratore e decoratore, resta fondamentaleper la definizione delle linee direttive dell'Art Nouveau. Studioso delQuattrocento fiorentino, soprattutto di Botticelli, è anche autore delvolume didattico " Lines and outlines " (1875).
4 - Inghilterra.
4 - Inghilterra.
L'archi letto e designer ARTHUR MACKMURDO (1851-1942), fu inItalia con Ruskin; è tra i fondatori della Century Guild e, nel 1884,della rivista dell'associazione « The Hobby Horse >>, che diresse conHerbert P. Horner, e che contribuirà in maniera determinante al rin-novamento della impostazione grafica nella illustrazione del libro.Abbiamo già accennato alla sua anticipazione del motivo ' à coupde fouet ' sulla copertina di " Wren's City Churches " (1883).
Per l'illustrazione del libro, campo in cui l'Inghilterra raggiungerà,in questo momento, una posizione preminente per la raffinata qua-
4 Inghilterra.
lità formale e tecnica, citeremo anche i nomi di Jessìe M. ICìng, pe-raltro più vicina ai modi ' scozzesi ' (studiò infatti alla Scuola d'Artedi Glasgow) e che perciò illustreremo brevemente in quell'ambito,di Lawrence Housman, di William Brown Mac Dougall, di SclvynImage... Ma tutti gli artisti del tempo si occuparono preminente-mente di questo settore.
Ma è con AUBREY BIÌARDSLEY (1872-1898), che si esprime, soprat-tutto nella grafica (di lui si ricorda un solo quadro ad olio, e fu an-che scrittore, poeta, traduttore finissimo), che la forza dì rottura espio-siva, folgorante, del nuovo stile, si manifesta in tutta la sua intensità.
Dopo un inizio apparentemente legato al mondo dell'ideologiapreraffaellita, con le illustrazioni per la "Morte di Artù", di ThomasMaiory (1891-1892), dove già l'acuta perversità del suo segno lasciava
HOWSl^TKJSDf\ANKOFTHELOVE DKINK
4 - Inghilte
intendere il rifiuto netto di ogni compiacimento ' storicistico ' e mo-ralìstico, cominciò ad esser presente in quasi tutte ie riviste di avan-guardia dell'epoca. Nel 1893 « The Studio », la nuova rivista di cosiimprovvisa e subita penetrazione in tutta Europa (tanto da giusti-ficare un'altra definizione dei nuovi modi stilistici come Style Studio).ha il coraggio, in una Londra impregnata di honorability, di dedi-cargli il suo primo numero. Nel 1894 Beardsley diviene quasi il soloprotagonista di « The Yellow Book » (che però scompare con la di-struzione della fortuna di Oscar Wilde, suo principale sostenitore).Nel 1896 nasce, quasi esclusivamente per Beardsley, «The Savoy ».una splendida, raffinata rivista illustrata, per bibliofili e collezionisti.
The Yellow BookAn Illustrateci Quarterly
Volume IV January 1890
Price$1.50Net
London:John LaneBoston: Copeland fe Day
Price
Net
4 •- Inghilterra.
(Si deve ricordare che l'Inghilterra, proprio in questo periodo, hafornito i prototipi più importanti di editoria: la copertina del libroe stata studiata da tutti gli artisti del tempo, da Ruskin - prima, anzi,da William Blake -, a Morris, ai Preraffaelliti, a tutti gli esponentidcll'Art Nouveau, e i libri per l'infanzia di Walter Crane e di KateGreenway restano insuperati a tutt'oggi).
Ma il nome di Beardsley è legato soprattutto alle illustrazioni perla " Salomè " di Wilde, di cui egli interpreta con magistrale pungenzal'estenuato, ambiguo, raffinato estetismo, aggiungendo una sua asso-lutezza ineguagliabile, un'asciuttezza di gusto e di sensibilità - purnella esasperata follia di decorativismo -, un'essenzialità di segno,che la prosa di Wilde, nella sua modernità, non ha mai raggiunto.
Il divario sta forse nella sottilissima ironia (che in Wilde fu semprepiù compassata, più ' inglese '), nell'equilìbrio serrato, tagliente, nellalibera fantasia e nell'invenzione con cui egli fa uso del repertorio
Art Nouveau: dalla linea serpentinata, che egli tende fino all'esaspe-razione, sottomettendole tutta la composizione, agli elementi-chiave,come il motivo della farfalla e del pavone (si veda lo splendido dise-gno The Peacock Skirt (La gonna-pavone, 1894), che pure non na-
4 - Inghiltei
sconde la sua discendenza dalla Peacock Room di Whistler, ma tra-sporta gli elementi in una macroscopizzazione fastosa della veste,contro la sottile acutezza della piccola testa viperina della donna,dalle narici vibranti, in uno slancio scattante, nel percorso inconsuetodel motivo decorativo, in alto a sinistra, che si riporta, come in con-trasto timbrico e di scala, ad una microscopizzazione veramente' corpuscolare ').
Il bìdìmensìonalismo, Pappiattimento dei piani, il capriccioso in-tersecarsi dei percorsi grafici, l'avvolgimento ascensionale di una lineacontìnuamente sottesa, la pungente esasperazione di un sensualismosegreto e insieme scoperto e quasi provocatorio, immaginifico, qualeWìlde raggiunge solo raramente, fanno di Beardsley una delle figurepiù favolose dell'ultimo '800. Vi si aggiunge Palone fantastico di unagiovinezza bruciata, di un intenso passaggio a meteora, una fama dienfant terrible mai compiaciuto e mai ripiegato su se stesso.
Abbiam,o detto che Beardsley non cede mai alle lusinghe del revi-
4 - Inghilterra.
al m nz quando interpreta motivi ' antichi ' (non, secondo lamoda, medievali, ma classici), lo fa con una chiarezza di visione scon-certante. Ho già accennato alla purezza di trascrizione del suo splen-dido Ave atque vale (da « The Savoy », n. 7 del 1896) per la sua tra-duzione del carme CI di Catullo, altrettanto espressivamente inten-sa, sia pure con una diversa direzione di aggressività, quanto certi
4 - Inghilterra.
disegni ' classici ' di Picasso.Non possiamo esimerci dal ricordare che il carme CI di Catullo è
quelio, dolcissimo, per la morte del fratello, e che Beardsley, minatodalla tubercolosi, non aveva che due anni di vita, e lo sapeva benis-simo. (Già a diciotto anni, egli aveva scritto, infatti: - " Ora ho 18anni, con una salute debole, un viso pallido e occhi incavati, lunghicapelli e schiena curva " -). Ma nessun intenerimento sentimentale
4 - Inghilterra.
e nessuna traccia di tragedia personale vengono ad incrinare la puralucidità del suo segno, incisiva e senza abbandoni, come lama didiamante.
Il testo letterario più noto di Beardsley, in cui egli ha profuso apiene mani la caustica oscenità di una invenzione verbale e calligra-fica esasperate, è Under thè Hill, che egli lasciò incompiuto e che nonfu pubblicato, in edizione integrale, fino al 1907, e anche allora pri-vatamente, a Londra. Un erotismo platonizzante e ossessivo, per-verso, di una sensualità acuta e dissacrante, pervade questo lavoroche unisce testo e illustrazione in una unità iiiseindibile.
4 - Inghilterra.
L'altro famoso illustratore dei testi dì Wilde è, a Londra, CHARLESRICKETTS (1866-1933), la cui estenuata raffinatezza differisce daquella di Beardsley per un'adesione più indulgente ad un mondoarcadico, e per un più scoperto uso dei simboli. Nonché, poi, perla minore acutezza e causticità del segno. Con la rilegatura di " AHouse of Pomegranates " (La Casa dei melograni, del 1891), egliraggiunge forse il grado più alto della sua incantata visione calli-grafica.
Nella stessa corrente di gusto sono da citare ì nomi di James Pryde(1872-1949) e William Nicholson (1869-1941).
Un'altra personalità emergente nella Londra fine secolo è quelladel regista e scenografo EDWARD GORDON CRAIG (1872-1966). unodei maestri del teatro moderno che, negando, con Adolphe Appia.ogni giustificazione naturalistica alla scena, avocò al regista luttala responsabilità dello spettacolo, relegando l'attore al ruolo di stru-mento (la supermarionetla). " II teatro del futuro sarà teatro di vi-sioni, arte che sorge dal movimento, in cui è il simbolo della vita "egli scriveva, allineandosi, cosi, pienamente, nella ideologia ArtNouveau. Autore di saggi fondamentali sul teatro {" The art of thèThealre ", 1905; "The Actor and thè Uber-Marionette ". che uscìsu « The Mask », la rivista a cui egli dette vita tra il 1908 e il 1929:" On thè Art of thè Theatre ", 1911; " Toward a new Theatre "".1913). Nelle xilografìe, Craig raggiunge una sintesi di linguaggio anti-cìpatricc di più tarde astrazioni geometriche.
4 - Inghilterra.
Già in un linearismo di più tarda definizione, contro l'architetturaancora revivalistica di Philip Webb (autore, come abbiamo detto,della medievaleggiante Red House di Morris), e di Norman Shaw.si inserisce il linguaggio architettonico di CHARLES FRANCIS ANNESLEYVOYSEY (1857-1951), già allievo di Mackmurdo, noto per una suapurezza lineare, di ispirazione giapponese, che lo avvicina a certesoluzioni proto-costruttiviste di Mackintosh.
Come tutti gli esponenti dell'Art Nouveau egli fu anche arredatore,autore di mobili .interessanti, dalla linea semplice e funzionale, purnella raffinata strutturazione dinamica, e dì belle tappezzerie geo-metriche.
CHARLES ROBERT ASHBEE (1873-1942), architetto, decoratore, desi-gner, fondatore, con Walter Crane e Mackmurdo, del movimento di" Arts and Crafts ", è un'altra delle personalità che emergono in que-sto clima ormai aperto ai nuovi aspetti assunti dall'Art Nouveaunel continente; mentre CHARLES HARRISON TOWNSEND (1852-1928),un collaboratore assiduo di « The Studio », è noto per la chiesa diGreat Warley, nell'Essex (1904), dove l'Art Nouveau si manifestapiù nella ricchissima e. fantasiosa parte decorativa, dovuta a Sir WilliamReynolds-Stephens, che non nella struttura compositiva.
4 - Inghilterra.
Un altro notevole pp n h onmomento e MACKAY HUGH BAILLIG SCOTT (1863-1945), architetarredatore, decoratore raffinato, legato alla cultura preraffaellita, Linsieme affascinato dalla scuola scozzese, autore di molte case inInghilterra, in Germania (è noto soprattutto per la sistemazione delpalazzo del Granduca di Hesse a Darmstadt nel 1898), in Russia,in Polonia, in Svizzera. La si a delicata maniera, che si esplica in undecorativismo lineare geometrizzante, affidata a delicatissimi toni da' nursery ' gli valse grande fama e contribuì a farne uno dei princi-pali esponenti dello ' stile inglese ' all'estero.
4 - Inghilterra.
Il più legato, tra gli artisti londinesi, al continente, particolarmenteal neo-barocco e al neo-rocosò francese, è invece lo scultore ALFREDGILBERT (1854-1934), autore, come ho già accennato, della esube-rante Shaftesbury Memoria! Fountain, in Piccadilly Circus (1887-1893), macroscopico gioiello pletorico, ma con interessanti soluzioniplastiche di motivi lineari.
Gilbert è anche noto per disegni di ricchi gioielli figurativi; si ri-corda, di lui, un centro da tavolo per la regina Vittoria (1887).
5 - Francia e Scuola di Nancv.
In Francia le manifestazioni più dirette di Art Nouveau si hannonell'architettura, nelle arti applicate, nella grafica pubblicitaria, nel-l'editoria. Mentre per la pittura e la scultura si assiste ad una adesionedi gusto, parentetica, formale, di quasi tutte le personalità emergentinel momento, che, per alcuni periodi della loro attività, assumonomòduli art nouveau. Nella stessa adozione del cloisonnisme (deli-mitazione della forma, a zone piatte di colore, con un contorno netto),che sfociò, da Emile Bernard, attraverso Anquetin e la Scuola diPont Averi, nel Sintetismo di Gauguin (1889-1890) e fu uno dei mo-tivi ricorrenti anche nel gruppo dei Nabis, si possono vedere con-vergenze formali con l'Ari Nouveau (l'insistenza della linea, ad esem-pio, sia pure di origine diversa; nel cloisonnisme è chiaro un riferi-mento all'arte medievale delle vetrate). E anche ideologicamente al-cuni motivi coincidono: il simbolismo, ad esempio (che assume,pure, consonanze diverse erotico-psicologìche per l'Art Nouveau.ideologico-mistiche per le correnti simboliste, malgrado le molleimplicazioni reciproche), l'esotismo, l'antistoricismo...
Si assiste anche al fenomeno dì artisti che lavorano contempora-neamente secondo mòduli art nouveau e secondo modi più auto-nomi; si pensi, ad esempio, a Gustave Moreau, a Odilon Redon.
Toulouse Lautrcc troverà intonazioni art nouveau soprattuttonei manifesti, che si prestano in modo particolare alla stesura del co-lore in superfìcie uniforme, bidimensionale, e allo scatto dinamicodella linea.
Anche il primo Kandinskij, a Parigi, prima del suo arrivo a Mo-naco, nel 1896, impostava sul motivo della linea, con atteggiamenti,però, di tipo fauve, la sua deliziosa, fresca figurazione.
E pure Pietoso, lino a! periodo blu. non resta estraneo ad intona
5 - Francia e Scuola di Nancy.
zioni art nouveau. Coincidenze di modi si possono ritrovare neirilievi in legno e nei bei vasi a soggetto tahitiano di Gauguin (ma ilcarattere, di un primitivismo violento, è all'opposto delle intenzionidell'Ari Nouveau), nella fluida continuità del gusto lineare di Maillol(di cui si ricorda la deliziosa statuetta della lavandaia, con la vesteche si apre a ventaglio); nelle sculture di Louis Roche (che è forse ilpiù dichiaratamente art nouveau degli scultori francesi).
Ho già parlato della facciata del teatro da lui e da Henry Sauvagededicato, prima del 1900, alla danzatrice Loie Fuller, e riproducete,
5 - Francia e Scuoia di Nancv.
in lieve modulazione plastica, l'ondoso, sinnoso andamento dei suoiveli (' à coup de fouct').
Comunque personaggi come Lévy-Dhurmer, Aman-Jcan, De-svallières, De Feure gravitano ugualmente nella sfera dell'Ari Nou-veau e in quella simbolista,
Se dunque l'esperienzi ai t nomi.au, nelle arti figurative, in Fran-cia, si assume nel suo aspetto formale, e solo marginalmente e tan-genzialmente, data la forza di resistenza dei postulati delle prece-denti manifestazioni, l'architettura e le arti applicate, invece, grazieanche alla presenza del mercante inglese Bing col suo negozio-galleria" Art Nouveau " {aperto nel 1896), col quale egli seppe attrarre aParigi le personalità più importanti dell'arte da tutto il mondo, rag-giungono un grado di maturità e di diffusione notevolissimi.
5 - Francia e Scuola di Nancy.
Il nome più prestigioso, tra gli architetti francesi, è quello di HEC-TOR GUIMARD (1867-1942), autore del fantasioso caste! Béranger(1894-1897), e delle entrate del Mètro a Parigi (1889-1904). Questaseconda opera, dove il motivo fitomorfìco, organicistico, floreale,espresso attraverso le strutture portanti in metallo smaltato in verde
J - Francia e Scuola di Nancy.
»ràayy«i*kyb£
et,etile ol^e e unì 1 bert t ta t t o d e aipiù importante per il carattere di diffusione capillare del gusto chepotè svolgere.
Tra le altre opere di Guimard sono da citare la villa Flore, a Pa-rigi, YEcole Humbert de Romans (1902), ora demolita, in cui la de-corazione esaltava simbolicamente i mòduli costruttivi. Nessun altroarchitetto francese riuscì a raggiungere la sinteticità stilistica, com-posita e vitalistica, di Guimard, anche se un peso notevole ebbe pure,basata più specificatamente sulla dinamica strutturale della linea,l'opera di GEORGES CHEDANNE {Magazzini Lafayette 1900, edificiodel Parisien libere, a Parigi, 1903). E si noti l'affinità tra lo scalonedei Magazzini e quello dell'edera di Garnier, del 1918.
Non mancano, tuttavia, in Francia, altri esempi isolati, in cui ilnuovo stile si propone con una evidenza e fertilità linguistica straor-dinarie. Ricordiamo la facciata del Liceo Leonard de Vinci in rueSedillon, 12, a Parigi, di Lavirotte (1899), la casa di Yvette Guilbert,già in boulevard Berthier, 23 bis, a Parigi (ora demolita), progettatada Xavier Schollkopf.
E ì nomi di Henry Sauvage, di Louis Bonnet, Charles Plumet,Tony Selmersheim, Gustave Rive, sono, almeno marginalmente, le-gati al movimento.
Per gli interni va ricordato il ristorante Chez Maxim (1899), di
5 - Francia e Scuola di Nancy.
Lou Mira z e lei p t re Le 1 o 11 e Me ìt e A t le de Bau-1 t et, e \ llet le D e e not per ivere it lizzato mod 1 art
l e u 1 un ed ficio religio o 1 eh esa d St Jea de M t tcrtreP p n e e i p t a l altro d eh e i con truttun n ce-
ìe it rmt
Ma saia AuGLSit PEKRLT (1874-1954), che, istituzionalizzando,anche, l'uso del cemento armato a vista, trasformerà in anticipazionidel ' movimento moderno ' in architettura, alcune delle più vivaciistanze art nouveau, nell'uso delle strutture portanti, evidenziate.
5 - Francia e Scuola di Nancy.
Il carattere particolare dell'architettura francese art nouveau re-sta, comunque, la sintesi elegantissima e raffinata di linee dinamicheasimmetriche, che combinano reminiscenze rococò (e, talvolta, tardo-gotiche), con un contesto strutturale di aperta intenzione innovatrice.
Per quanto riguarda le arti applicate, queste troveranno in Franciaun terreno estremamente fertile, anche perché, in questo perìodo,particolari condizioni cconomìche e sociali favorirono la diffusionedi un gusto raffinato e, soprattutto, il mercato artistico.
Si ricordi ancora che Bing aveva aperto a Parigi il suo negozio-galleria, arredato da Van de Velde, e che vi esponevano gli artistipiù importanti di tutti i paesi, da Beardsley a Mackintosh, da Bour-delle a Rodili, da Bradley a Tiffany, da Galle a Lalique.
L'Esposizione dell'Union Centrale des Arts Décoratifs. del 1884.l'Esposizione Internazionale del 1889, oltre ad altre manifestazioniimportanti, contribuirono moltissimo alla diffusione del gusto.
Si pensi al Salon du Champ de Mars del 1891, al Salon des ChampsElisées, del 1893, alla formazione del gruppo " Les Cinq " (Char-pentier, Dampf, Aubert, Selmersheim, Moreau-Nélaton), cui si uni-rono, nel 1896 Plmnet e nel 1897 Nocq e Sauvage. Nel 1897 il criticoMeicr-Graefc apriva a Parigi la Galleria '" La Maison Moderne ".
Si aggiunga, poi, come riflesso su Parigi, la vivacità della Scuoladi Nancy, sia pure impostata in modo più tradizionalista che nonParigi (vi fiorirono infatti motivi floreali più figurativi di quelli pla-stico-lineari parigini).
Alle grandi Esposizioni di Parigi, soprattutto a quella Universaledel 1900 trionfarono i mobili e gli arredamenti di Guimard, dove siriproponeva lo stesso carattere simbolico-lineare della sua architet-tura, quelli di de Feure, di Colonna, di Charpentier, di Perol, assiemea quelli degli esponenti della Scuola di Nancy (Gaillard, Majorelle).
Nancy, resa celebre dalla presenza di Emile Galle, già verso il 1890si distingueva, nel campo delle arti applicate, per il suo accento piùnaturalistico di quello espresso da Parigi in questa epoca, per unapiù viva adesione ai motivi tradizionali del rococò francese e, infine,per il gusto orientalizzante.
EMILE GALLE (1846-1904), fondatore e direUore (1901) della Scuo-la di Nancy (di cui furono vicedirettori Antonin Dauci, Louis Majo-relle, Eugène Vallin), studiò all'estero filosofìa, botanica, disegno;dal 1874, a Nancy, si dedicò al laboratorio vetrario del padre, comedirettore.
I suoi vetri, dalie forme libere e dal colore prezioso, spesso opale-scenti, nei quali egli amava, a ribadire il concetto di parità tra le arti,incidere versi di poeti simbolisti, da Baudelaire a Maeterlmck, sonolegatissimi al carattere di crescita spontanea, organica, fitomorfica;il motto di Galle " le nostre radici giacciono nel suolo dei boschi,nel muschio, presso l'orlo dello stagno ", è il simbolo della sua poe-tica. Studioso e sperimentatore di nuove tecniche vetrarie, ha legatoil suo nome ad opere - particolarmente dal 1898 in poi -, di grandis-
5 - Francia e Scuola dì Nancy.
5 - Francia e Scuola di Nancy.
sima importanza artistico-culturaie.Autore anche di mobili, non raggiunge, peraltro, in questi, la stessa
felice creatività che nei vetri. Del 1904 è il famoso- letto a farfalla,dove, però, il simbolo arriva a sovrastare l'oggetto come funzione,indicando il punto di trapasso, di degenerazione, quasi, del motivodi partenza.
5 - Francia e Scuola dì Nancy.
Con quello di Galle si dovranno ricordare, in Francia, i nomi dìLouis MAJOKELLE (1859-1926), della Scuola di Nancy, la cui produ-zione si distingue per la plastica mossa ed elaborata e per l'ornatonaturalistico che prevale sull'interesse funzionale, quelli di Char-pentier, dì Vallin, di Gruber, quasi tutti anche architetti, per i mo-bili e gli arredi a proliferazione vegetale, che segnano il trionfo delmotivo floreale: per i vetri si dovrà fare anche, legato alla Scuola diNancy, il nome dei due fratelli DAUM (Auguste, 1853-1916; Anto-nin, 1864-1931), anche per la particolare lavorazione plastica dellamateria vetrosa, e quello dei fratelli Muller.
RENE JULIÌS LALIQUE (1860-1945) rappresenta, nel campo del gioiello,il corrispettivo di Galle per il vetro. Studiò a Parigi, si perfezionò aLondra (1878-1880), Tornato a Parigi, vi aprì un laboratorio (1885).Del 1894 sono i suoi primi gioielli per Sarah Bernhardt; quasi imme-diatamente, in seguito anche al nome prestigioso dell'attrice, la suafama si diffuse ed egli divenne il gioielliere più ricercato in Europa.
Sperimentatore, innovatore di tecniche orafe e riproduttive, deve,soprattutto, il suo nome, alla fertile inventività, alla sensibilità, allamodernità delle sue creazioni, che rinnovano alla base la tradizioneorafa. I suoi gioielli, abbarbicati come lussureggianti piante paras-site dai colori smaglianti, commentano, con una simbologia rafHna-tissima, il concetto satanico-mistico di una inquietante femminilità.E l'immagine femminile, conturbante, sensuale, preziosa nella minia-turizzazione, è uno dei suoi motivi ricorrenti, mentre fiori, serpenti,insetti ne divengono quasi attributi simbolici. '
Per trovare una corrispondenza adeguata, sia per quanto riguardai vasi di Galle, sia per quanto riguarda i gioielli di Lalique, dovremoarrivare a Louis Confort, Tiffany, americano, figlio del famoso gioiel-liere newyorkese; con Louis Sullivan, uno dei più interessanti archi-letti della scuola di Chicago, Tìffany sarà un esponente straordinariodel movimento e il divulgatore Hel misto art nrtTivp.fln fimri ri'F.urnna
6 - Belgio - Bruxelk:
Il fatto che la prima manifestazione di Art Nouveau, al suo stadiopiù maturo, con una dilatazione e diffusione internazionale, si abbiain Belgio, a Bruxelles (e basterebbero i nomi di Horta, Serrusicr-Bovy, Vaii de Velde, Hankar, per indicarne la portata), è fenomenoche si spiega considerando l'insolita vivacità della vita culturale, dellaletteratura e della pittura, soprattutto, del periodo.
Nel 1886 usciva il Manifesto dei Simbolisti: il poeta Verhaerenportava a Vati Rysselberghe, il pittore simbolista belga, il messag-gio di Seurat (al quale, poi, egli dedicherà il suo " Les Aubes ", 1898).
" Se in Francia il simbolismo è un fenomeno di contestazione nelmondo borghese della III Repubblica in chiave di élite e di aristo-crazia intellettuale, analoghe condizioni non possono verificarsi nelBelgio che non aveva conosciuto la dura lezione di Sedan. Qui, sem-mai, l'isolamento della letteratura trova la sua verifica nella prefe-renza per i temi di un passato primitivo e barbarico. Ma con questoaffiora anche il mito sociale, l'esaltazione dei contadini e degli ope-rai, l'ipotesi di una fratellanza universale perché, ' si les patries sontbelles, douces au coeur, vivantes à la mémoìre, les nations arméesde frontières sont tragiques et funestes ; et le monde entier reste encore
6 - Belgio - Bruxelles.
hérissé de nations '. Così Invasione poetica si ricollega alla fortunadel movimento socialista. Verhaeren, poeta della questione sociale,del miraggio che porta le folle contadine verso les ville.s tentaculaires,che si fa apostolo della scienza e del progresso, trova il suo riscon-tro in Horta, che fa della Maison du Peuple il suo capolavoro " l('.
La presenza, a Bruxelles, di un personnaggio come Octave Mausè sufficiente garanzia perché si capisca come il Belgio si ponga subitoin primo piano tra i centri continentali compresi nella vasta area didiffusione dell'Art Nouveau.
Vivacissimo organizzatore culturale, direttore della rivista « L'Arimoderne » (1881), fondatore della " Société des vingt ". (1884-1893),e di "La libre Esthétique " (1894-1914), egli pose Bruxelles nellacondizione di tramite necessario tra l'Inghilterra e il continente, traLondra e Parigi. Organizzò mostre, incontri, conferenze; nel Ì883esponeva a Bruxelles Ford Madox Brown, nel 1884 vi organizzavanopersonali Rodin, Ashbee, Image, Summer, Morris, Beardsley, Whist-Icr, Liebermann, Khnopff; nel 1886 Renoir, Monet, Redon, Minne:nel 1887 Seurat, Pissarro, Morisot, Toulouse'Lautrec e Signac,nel 1889 Gauguin; nel 1890 Cézanne e Van Gogh; nel 1891 Crane,
6 - Belgio - Bruxelles.
Larsson, Filligcr, Chéret.La " Société des vingt " accoglieva intanto i protagonisti più in
vista in campo internazionale nelle arti (da Van de Velde a Cézannc.a Van Gogh, Toorop, KhnopfT, Rcdon).
TI terreno sul quale si trovò, quindi, ad operare VICTOR HORTA (1861-1947), era tra i più fertili. Lui stesso aveva avuto rapporti diretti conìa cultura francese e conosceva certamente i testi e le opere di Viollet-le-Duc e di Vaudremer.
La casa Tassel, a Bruxelles, di Horta (1892-1893), può conside-rarsi il prototipo di Art Nouveau continentale. Ed è documentocompleto, maturo, simbolo di una nuova visione architettonica,assolutamente libera da riferimenti storicistici e insieme perfetta-mente coerente nei particolari.
6 - Belgio - Bruxelles.
LrmporUnzd di Horta è nell'esser riuscito ad assumere 1 modulidi un tipo edil zio comune a Bruxelles e alla tradizione storica belga(la casa di abitazione singola, articolata in organismo autonomo) edi averne fatto un discorso armonico, nuovo, impostato, appunto, sulmovimento agile e scattante della linea ' à coup de fouet ' (a schioccodi frusta) che,- dalla facciata, serpeggia all'interno, nell'atrio luminoso,
dominalo dalla celebre scala ' a giorno ', scandita dalla sottile colon-na in ferro, quasi stelo di un enorme fiore esotico, e invade le pareti,dove la struttura metallica, in vista, diventa la protagonista di unnuovo spazio fluido e avvolgente.
Circa il motivo della linea ' à coup de fouet ', abbiamo già accen-nato alla sua diffusione contemporanea. Per quanto riguarda Horta,
Borsi e Portoghesi X1 citano come ascendente anche la linea estrema-mente anticipatrice delle strutture in legno curvato dei famosi mobiliiniziati da Thonet nel 1836 e già esposti a Bruxelles.
Il motivo innovatore della struttura metallica in vista, usata gene-ralmente per edifici civili (da Paxton, Balat...) sarà dominante, inHorta, anche nella Maìson du Peuple (1897), pure a Bruxelles, per ilSindacato Lavoratori Socialisti (una delle pochissime opere di Art
iiorta, Nouveau destinate ad uso sociale), di una rara coerenza tra strutturaIg%. e decorazione, uno dei primi documenti del mondo artistico con-
temporaneo che la speculazione edilizia attuale, malgrado l'appelloe (°eei della cultura internazionale, non si è peritata a distruggere (1965).iucer_ II motivo delle travi portanti si proiettava dall'esterno, dove le
grandi pareti vetrate servivano da diaframma, fino alla sala dei con-
6 - Belgio - Bruxelles.
gressi, inusitatamente all'ultimo piano deiredìflcio, in cui la funzionesi trasformava in fatto decorativo, di esaltante espressività simbolica.
La casa Sohay (1895), YHótel Morta (1898), sono altri notevoliesempi, tra i molti, della raffinata sensibilità di Horta che, tra tuttigli esponenti dell'architettura art nouveau, riesce a rompere col pas-salo con più discrezione, con minore invadenza.
PAUL HANKAR (1861-1901), rappresenta, a Bruxelles, il polo oppo-sto, per certi aspetti, nei confronti dì Horta. Vólto ad una semplifi-cazione lineare della struttura, che si estrinseca nella sottile tensionedelle superfici (si veda il gioco degli archi inflessi e delle linee rettenella facciata della casa Chamberlanì, 1897, a Bruxelles), crea, per
6 - Belgio - Bruxelles.
così dire, un ponte " tra la tradizione medievale e l'Art NouvcauDi lui sì conservano, documento esemplare, un gran numero dì
disegni e dì progetti, di grande minuziosità e finezza, testimonianza,anche, dì una rigorosa serietà professionale. La distruzione degliarchìvi di Horta, voluta da lui stesso, rende più preziosa questa straor-dinaria documentazione.
Hankar condivise con Horta l'interesse per Viollet-le-Duc; nonsfuggi alla moda orientalizzante né a certo revivalismo neo-rinasci-mentale. Seguì infine, con compiaciuta ostentazione, i motivi dellaornamentazione lineare inglese propria delle " Arts and Crafts " edi Cranc.
6 - Belgio - Bruxelles-
Ma, senza niente togliere all'importanza ìnnovatrice di Horta.Hankar e Vati de Velde, a Bruxelles il fenomeno Art Nouveau inarchitettura fu un fatto esteso a dimensione urbanistica: interi quar-tieri assunsero globalmente carattere art nouveau, dalle case borghesiai progetti di case popolari, Questo anche in rapporto al tipo ediliziocittadino - di cui si è accennato a proposito di Horta - che divienequasi il modulo per l'acquisizione di una nuova morfologìa urbana.In questo senso architetti come ERNEST BLÉROT, come GUSTAVESTRAUVEN, OCTAVIÌ VAN RYSSELBERGHE, spesso collaboratore di Vande Velde, EMILE VAN AVIZRBEKE, PAUL VIZZAVONA, e poi MACQS.MORICHOR, PAUL CAUCHIE, ALBERT ROOSENBOOM, PAUL SAINTENOY.tanto per citarne alcuni, rappresentano presenze autorevoli e perso-nalizzate, sìa pure sulla scia di Horta, Hankar, Van de Velde. Il fattoche l'opera più importante dì Josef HofTman sia a Bruxelles (il Pa-lazzo Stoclet, del 1904-11) non è certo senza significato.
Ma HENRY VAN OÌÌ VELDE (1863-1957) resta forse la personalità piùinteressante del movimento per la poliedricità, l'attività promozionaledi divulgazione culturale delle nuove idee, per l'impegno di chiarifica-zione dei motivi di fondo dai quali si enuclea la sua ricerca, che, se-condò gli insegnamenti di Ruskin e Morris, è di tipo ètico-culturale,
6 - Belgio - Bruxelles.
e intende affidare all'arte il compito di guida della società attraversoil controllo diretto dei metodi di produzione e di distribuzione deglioggetti d'uso, intervenendo così, direttamente, negli atti della vita.
Perciò, abbandonata la pittura, per la quale è legato al Post-impres-sionismo francese e alla Scuola di Pont-Aven, di carattere simbolico-sintetista (si vedano i suoi quadri attorno al 1890-1893), si dedicòall'architettura, all'arredamento, al design di oggetti.
Con la sistemazione della sua casa a Uccie (la Bloemenwerf, del1895-1896), presso Bruxelles, nell'armoniosa coerenza di ogni par-ticolare, come componente essenziale dell'ambiente considerato' organo vivente ', in chiave fitomorfica, studiato sui movimenti esulle funzioni espressi dagli utenti (questo interesse dominante loporta a raccordare tra loro tutte le linee, in un andamento continuo,morbido, quasi senza soluzioni di continuità, dalle pareti alla scala,ai mobili, alle suppellettili, fino agli abiti degli abitanti), egli proponeun discorso totale, attraverso uno studio sistematico dì tipo struttu-rale, funzionale, per la prima volta, anche, ecologico, col rifiuto diogni compiacimento per una decorazione che non sia essenziale e,appunto, ' strutturale \
La sua attività fu tra le prime ad esser conosciuta all'estero: Sieg-fried Bing, che intanto aveva aperto a Parigi il negozio " L'Art Nou-veau ", desumendo la definizione dalla « Revuc moderne», (1884)lo invitò a disegnare arredamenti per lui; il crìtico d'arte Meier-Graefe lo rese celebre in Germania, anche attraverso la rivista « Pan ».
E in Germania Van de Velde lavorò molto (elaborando un lin-guaggio architettonico che andò assai oltre l'esperienza ari nouveau,
6 - Belgio - Bruxelìc
inserendolo direttamente tra gli esponenti del movimento moderno)e con gli artisti tedeschi rimase costantemente in rapporto.
Aveva continuato, intanto, con conferenze, scritti, esposizioni, lasua attività di propaganda culturale, che rimane, coi suoi bellissimioggetti di arredamento - mobili, posate, candelabri - (e a questoproposito è utile ricordare quanto egli debba, pur ricavandone unlinguaggio personale, al mobile ' stile inglese ' di Serrmier-Bovy, chefu il primo a portare in Belgio ii nuovo gusto), con la sua opera gra-fica - legature di libri, caratteri, marchi e un bel manifesto, Tropon,
6 Belgio - Bruxelles.
del 1898 , la parte più importante della sua lunga, impegnatissimaattività.
Anche il suo linguaggio è legato alla bidimensionalità della lineadinamica (la linea belga), di riferimento vegetale-fitomorfico, di cui,anzi, egli diviene un riferimento stilistico (lignc Van de Velde).
6 - Belgio - Bruxelles.
Anche se per l'andamento ritmico della forma lo scultore RickWouters, nella sua solidità costruttiva, può essere citato per unacerta adesione al nuovo stile, in Belgio il solo scultore che possa de-finirsi del tutto esponente dell'Alt Nouveau, è GEORGES MINNE(1866-1941).
Le sue immagini plastiche, figure umane trattate come steli alloro nascere, mosse da un ritmo delicato e fragile, furono definiteda Meier-Graefe •" ornamento plastico ".
In effetti, anche se in lui confluirono esperienze diverse, dal GothìcRevival all'orientalismo alla scultura luministica di Rodin, e anchese la sua voce si accorda, per così dire, su una sola gamma, pure glisi deve riconoscere la scelta dì un linguaggio autonomo e perseguitocoraggiosamente. Oltre a tutto egli ebbe più ascendenza di quanto sipotrebbe pensare su tutto un filone di attività plastica (e anche sucerta grafica e certa pittura) fin de siècle, riconoscibile, in Italia, peresempio, nella raffinata calligrafia di Arturo Martini (Fanciulla cheodora un cespo di rose, 1913; Fanciulla piena d'amore, 1913) nellaestenuata, gelata fluidità delle forme di Adolfo Wildt, nel flessuosoallungamento della linea del primo Casorati.
Il pittore e critico d'arte FIÌRNAND KHNOPFF (1858-1921), rappre-senta invece, in Belgio, il punto di passaggio dal tipo di esperienzapreraffaellita, confluente nell'Art Nouveau, e il Simbolismo francese.
Le sue figure femminili uniscono, infatti, il carattere fisico delledonne-angelo di Rossetti e Burne-Jones ad una espressione .di stre-gata, perversa astrazione, quasi ipnotica.
L'arte fu, per lui, una missione sacra, magica, rituale. Interessato
6 - Belgio - Bruxelles
Wl all'idealismo mistico di Péladan (tra i fondatori, nel 1888, dell' " Or-dine cabalistico della Rosacroce ") fu molto legato ai Preraffaelliti.
E anch'egli fece della sua vita stessa un'esperienza simbolica: inuna stanza vuota della sua strana, inquietante casa, articolata a labi-rinto, due anelli di bronzo, recanti incisi ì nomi di Burne-Jones e diGustave Moreau, campeggiavano su una tappezzeria di broccatogiapponese, perfetto simbolo della sua poetica.
Fu il più legato alla Secessione viennese: scrisse di Otto Wagnere fu anche il primo, tra i belgi, a cui fu dedicato un numero della ri-vista viennese della Secessione « Ver Sacrimi », alla sua prima an-nata (1898).
I nomi di Delville, Fabry, Degouve de Nunques, Spillaert (che,(.un ENSOR, aprirà la via al Surrealismo) sono alcuni punti di un va-sto panorama
7 - Spagna - lì Modernismo e Gaudi.
Quella lucidità intellettuale, quell'acutezza di sintesi che si è rico-nosciuta in personaggi come Beardsley e che si riconoscerà in Klimt,trova in ANTONI GAUDI (1852-1926), a Barcellona, il corrispettivopiù autentico per quanto riguarda l'architettura.
Nessuno come lui seppe interpretare con più libertà e con più auten-tica adesione emozionale, trasformandole in fatto vitale, non intel-lettualistico, le istanze più profonde dell'Art Nouveau: germinazione,crescita spontanea, espansione della lìnea come simbolo vitalistico.distruzione dello spazio geometrico, statico, bloccato, per uno spazioin espansione, che nasce come un elemento naturale, come una pian-ta, come un animale, e si sviluppa espandendosi, in un ritmo sfrenatoe senza fine; distruzione del concetto di esterno-interno in quanto laparete diventa, sia all'interno che all'esterno, come una pelle sensi-bile che si increspa e si raggrinza al mìnimo contatto e segue il movi-mento della struttura e lo accompagna: integrazione tra le arti, espres-sa attraverso l'organismo architettonico (la parete, il soffitto, il mo-bile, la maniglia, il muro di un parco, la scagliosi! eresia di un tetto.
7 - Spagna - 11 Modernismo e Gaudi.
la vetrata, tutto è trattato alla stessa maniera, curato nel particolare,visto come ' oggetto ' da plasmare, da far vibrare, da far ' vivere ').
La componente goticizzante, in lui, non si pone come fatto di ' re-vival ' metalinguistico, ma in virtù di fervore, di lucida follia religiosa,assunta a livello di forza personale da un humus locale primigenio:si pone come necessità spirituale e psicologica, come espressione dicoralità popolare.
Perciò egli è potuto divenire, per i catalani, il simbolo più prò-bante della loro rivendicazione nazionalistica, espressa in quel movi-
7 - Spagna - // Modernismo e Gaudi.
mento federalista al quale era informata tutta una nuova correnteletteraria, quella che aveva promosso la rinascita della ' lingua ' ca-talana, bandita forzatamente dalle città catalane durante il predomi-nio castigliano, che sollecitava gare poetiche, festìvals medievali dipoesia, di musica, di folklore regionale (come i Jocs ~Floraìs, ripristi-nati nel 1867).
La curva iperbolica, che caratterizza il tipo di ricerca spaziale diCJaudi, è una curva in espansione, che dal piano tende a proiettarsiplasticamente nello spazio. Si veda, ad esempio, come egli interpretain ferro battuto il motivo ' a foglia di palma ', caratteristico dell'orna-mentazione lineare art nouveau {seppure desunto da motivi orna-mentali micenei e greci, come ben si vede in Riegl, nel suo " Stilfra-gen ", uscito, non a caso, come sì è detto, nel 1893).
Usato ' in piano ' nella decorazione art nouveau internazionale,questo motivo viene, da Gaudi, già nei cancelli di casa Vicens (1878-1880), svolto come elemento plastico, secondo un ' iperboloide '. Non
itta, comunque, della curva sinuosa, vitalistica ma non organici1 icarc e non spaziale, generalmente svolta da altri esponenti del mo-
e ( nel e e o ne e on può e lidere 1 ppo dC I 1 co l pò eo od o t i L u un
7 - Spagna - 11 Modernismo e Gaudi.
curva continuamente variata nella direzione, forzata dall'espansionenaturale, da una sorta di carica interna che sembra sempre sul puntodi farla esplodere in tutte le direzioni e di distruggerla come entità.
La sua curva, contrariamente, ad esempio, a quella di un Borro-mini (dinamica ma serrata, a contenere all'interno un rapporto diforze bloccato ed elastico, resistentissimo anche quando sì attorcenella spirale in fuga, verso l'alto, come nella lanterna-guglia del San-t'Ivó), cresce lottando e contorcendosi come un elemento naturale,ammette sezioni di retta, sì spezza, riprende, si esalta, afferra o re-spinge lo spazio, considerato come forza resistente, si contrae sinco-pandosi, E arriva il momento in cui la fantasia inestinguibile, ' pro-duttivista ' (anche in senso psicanalitico), di Gaudi, si fa evocatricedi mostri, e, interprete della sua necessità, a livello di subconscio, ar-riva ad immedesimarsi con l'oggetto creato, scaglia materia informecontro la sua stessa struttura, la fa esplodere e ricadere su se stessa,quasi ad evocarne una rinascita magica, da araba fenice.
Questo personaggio strano, chiuso, solitario, cattolicissimo, cheva in processione, che muore sotto un tram, involuto, ideologica-mente addirittura reazionario, sempre, apparentemente, isolato dalresto del mondo (apparentemente, perché, poi, si scopre che i suoiinteressi culturali sono vasti e aperti, che segue le riviste di avan-guardia straniere, che conosce a fondo e ama Viollet-le-Duc, che nonignora affatto gli avvenimenti culturali contemporanei nel mondo- e spesso li anticipa -), da solo, nella Spagna fine Ottocento, potèlasciare, grazie all'illuminata generosità di Eusebio Glieli, un'improntadi incredibile vastità in una città come Barcellona, ancora così le-
7 - Spagna - lì Modernismo e Gaudi.
gata a motivi tardo-barocchi e mudejar, malgrado quello sfrenatodesiderio di rinnovamento, nell'ambito, appunto, della renaixen^acatalana, che aveva già dato notevoli prove attraverso nomi comequello di Lluìs Domènec y Montaner, Martorell, Vilaseca, Beren-guer, Cadafalck, Grandi, Rubió i Bellver.
Ma opere come casa Vicens (1878-1880), Casa Cahet (1898-1904),
Spagna - II Modernismo e Gaudi.
come il fantasmagorico Parco Giteli (1900-1914), come casa Battio(1905-1908), come casa Mila (1905-1910), la Pedrera, anticipatricestraordinaria di istanze espressioniste, come la cappella dì SantaColonia di Cervello (1898-1915), o come quella Sagrada Fatnìlia (ini-ziata nel 1883 e che ancora, dopo la morte dì Gaudi si continua a co-struire, come un enorme polipo rovesciato, tutto gangli e ventose),restano esemplari di un linguaggio altissimo, fertile di spunti e diidee, difficilmente catalogabile.
Gli altri architetti spagnoli, anzi catalani, già citati, anche se hannodato un notevole contributo alla trasformazione della fisionomia diBarcellona in senso ' modernista ', si mantengono su un piano assaimeno personalizzato di quello di Gaudi, risentono del Floreale in-ternazionale, seppure innestato su un substrato locale assai carat-terizzato.
Le arti applicate, in Catalogna, durante la renaìxenca, trovaronomolto incoraggiamento dall'Ateneo di Barcellona e le esposizioni simoImplicarono, dalla metà dell'800 in poi. Ma l'impronta generalefu di carattere morrisiano, ostile alla macchina e favorevole alla revi-talizzazìone dell'antico artigianato locale.
A questo contribuì l'accesa rivendicazione nazionalista.Perciò, tranne quando si espressero nell'ambito di operazioni to-
tali, come parte integrante del discorso architettonico e nell'operaindividuale (come i mobili, i ferri battuti, le vetrate di Gaudi, i mo-bili di Domènec ì Montaner, di Antoni M. Galissà), restarono, ge-neralmente, ancorate a motivi di tradizione regionale o di revivali-smo (come in Francese Vidal).
Si distaccano però, nettamente, nel campo del mobile, due ebani-sti straordinari: GASPAR HOMAR (1870-1953) e JOAN BUSQUET (1874-1949). Il primo, poco dopo il 1890, già elaborava, nei mobili e negliarredamenti di interni, forme secondo mòduli art noitveau (' à coupde fouet '), che andava sempre più semplificando, fino ad arrivaread una stilizzazione strutturale fortemente espressiva ; si ricordano dilui, eseguite verso il 1910, le stanze da letto di casa Oller (a floreali-
7 - Spagna - II Modernismo e Gaudi.
smi quadrati e linee rette) e di casa Barret.Joan Busquet, che lavora dal 1898, elabora, nei suoi mobili, un
linguaggio strutturale curvilineo che risente, sia pur mantenendo unapropria autonomia, dell'ascendenza francese di Guimard. Sono no-tissimi, di lui, i mobili tutti curve, anch'essi ' à coup de fouet ', perJosefina Bringas (1899). Egli passa, poi, attraverso una progressivasemplificazione lineare, finché abbandonerà definitivamente il ' mo-dernismo ', passato, intanto, di moda, per dedicarsi a riproduzionistilistiche (degli Adams e degli Sheraton).
Per la ceramica il pittore Jujól, collaboratore dì Gaudi per i mo-saici ceramici del parco Gùell, dette avvio a nuove tecniche e a nuoveelaborazioni con notevole intuito e vitalità espressiva.
» Scozia - La Scuola di Glasgou - Mackhtlosh.
Bisogna passare alla Scozia, al 'Gruppo dei quattro' (Mackin-losh, McNair, le due sorelle Macdonald), per trovare, in Inghilterra,una nuova posizione di avanguardia che, se per un lato si riportaalla tesa grafia di Beardsley, in special modo nelle Macdonald (anche,probabilmente, per pura coincidenza, per adesione spontanea ad uncerto clima, perché le prime manifestazioni scozzesi precedono l'attivitàdi Beardsley), senza peraltro la sua implicazione di inquieto e sofisti-calo sensualismo, dall'altro, particolarmente in Mackintosh, si inse-risce nel dibattito della cultura europea del '900, in linea con quellepremesse del movimento moderno in architettura, che, passando at-traverso la sintesi simbolico-astratta del Rayonnisme e, poi, del Co-struttivismo russo, sfoceranno nel Razionalismo.
Vedremo come le caratteristiche di svolgimento dell'Alt Nouveau
in Scozia, di tipo eminentemente lineare-simbolico,1 si riportino amotivi già svolti nel continente; come il movimento si presenti, qui,quindi, alla sua fase più matura, già superata la follia decorativa delprimo Art Nouveau, per un duetus più composto, per un'adesionepiù concorde alla linea retta, anche se questa nascerà, sempre, a guisadi stelo, da un bulbo tondeggiante, da una sorta di seme originarioappena schiuso, di morbida fattura.
L'attività del ' Gruppo dei quattro ' era stata preceduta, in Scozia,da quella dei cosiddetti ' Glasgow Boys ' (Guthrie, Lavery, A. Wal-ton), tre pittori che avevano esposto a Londra nel 1890.
8 - Scozia - La Scuola di Glasgow - Mackintosh
Mackintosh e il suo gruppo (le due MACDONALD divennero poile mogli, rispettivamente, di Mackintosh e di MCNAIR), esposero perla prima volta a Londra, nel 1890, a quella " Arts and Crafts Exhi-bition." fondata nel 1888 da Mackmurdo, Crane, Ashbee e WilliamMorris, e già nel 1897 Mackintosh otteneva i primi incarichi impor-tanti : il nuovo edifìcio per la Scuola d'Arte di Glasgow e le prime saleda thè di Miss Catherine Cranston.
Intanto, l'intelligente direttore di « The Studio », Gleeson White,era venuto a Giasgow, interessato al lavoro del gruppo, e ne diffon-deva il nome attraverso la sua rivista, già lanciatissima.
8 - Scozia - La Scuola di Gktsgaw - Mackintosh.
Nelle Macdonald e in McNair è riconoscibile un andamento li-neare, nella definizione formale, di una morbidezza e di una lentezzadolcissime, che si configurano in simboli di carattere figurativo o geo-metrico; la sottile, aerea immagine femminile, con la testa reclinatanella curva caratteristica, che tiene in mano la rosa, una rosa vistadi piatto, aperta - seppure desunta, come lo stesso Mackintosh af-ferma, dalla sezione di un cavolo (vengono in mente gli ironici, poe-tici ' timbri naturali ' di Bruno Munari) -, che diverrà la sigla delgruppo e che Mackintosh profonderà in ogni suo oggetto, dall'archi-tettura esterna, in definizioni decorative in ferro, agli interni, nelladecorazione murale, nei suoi bellissimi mobili; la figurazione di tipoallegorico; l'impostazione della composizione in ritmo simmetrico(come se ogni immagine, ribaltata al centro, si riproducesse per fe-nomeno meccanico, specularmente, come perle macchie di Rorschack);solo che, in questo caso, il ribaltamento è tutt'altro che meccanicoe casuale: anzi la linea, lentissima e misurata, è tenuta con limpidapulizia; oppure una figura allungata, di estrema stilizzazione, si ponecome pendant di un'altra, identica, in posizione simmetrica.
Questo particolare della simmetria distingue il tipo di figurazionedel ' Gruppo dei quattro ' da ogni altro tipo precedente: la asimme-tria caratteristica della decorazione ari nouveau, si compone, qui,in una simmetria perfetta, con un risultato di astratta contempla-tività.
Queste composizioni, come accade per quasi tutte le opere pitto-riche di Art Nouveau, non sono concepite, o raramente, come ' qua-dri ', ma come decorazioni murali in arredamenti, e sono spessofirmate dal gruppo o da Mackintosh e Margaret Macdonald, come ipannelli per il salone di musica di Frau Wàrndorfer, tra i quali ilnoto Opera of thè sea (1902), ispirato al poema di Maeterlinck " TheDead Princess " (la principessa morta), dove il carattere erboreo.fHomorfico, si trasforma in motivo acquoreo, tutto vibrazioni e lucigemmate in mezzo alle quali si impostano le testine femminili, atto-nite, ritmate, come folletti delle acque, intorno al volto e alla chiomafiorita della pìccola principessa morta.
CHARLES RENNIE MACKINTOSH (1868-1927) riesce a portare nell'ar-chitettura e nelle soluzioni di interni una misura di autenticità e dichiarezza di visione che ne fanno uno degli anticipatoli più presti-giosi di certi modi espressivi contemporanei, che trovano la loro ma-trice, come ascendenza diretta, nei motivi delle prime avanguardie(per certi aspetti il più vicino ai modi di Mackintosh - si pensi all'in-contro a croce, netto, delle strutture lignee portanti la galleria supe-riore nella splendida biblioteca della Scuoia d'arte di Glasgow del1907-1909 - sarà il Costruttivismo russo, beninteso come derivazionedal simbolismo astratto raggìsta); ma anche il De Stijl non sarà esen-
8 - Scozia - La Scuola di Glasgow - Mackintosh.
te da certi riferimenti lineari reperibili nell'Art Nouveau, consideratoin questa sua fase più matura.
Alcuni mobili di Mackintosh raggiungono la condizione di ' clas-sici ' dell'arredamento moderno, liberi ormai da contenutismi e dapreoccupazioni stilistiche, e siamo veramente lieti che siano, final-mente, in produzione come archetipi dell'attuale design di arredo,assieme alla Barcellona di Mies, alla Wassili di Breuer, alla sediarosso-blù di Rietveld, alle sedie di Le Corbusier... (Ci auguriamo,
8 - Scozia - La Scuola di Giasgow - Mackintosh.
soltanto, che siano appunto accolti come ' archetipi ' e che non di-vengano, a loro volta, sollecitazione per una " moda revivalistica 'per una produzione imitativa ' in stile '). Si deve all'architetto napo-letano Filippo Alison la ricostruzione di molti mobili di Mackintosh.(presentati all'ultima Triennale di Milano), realizzati con forme, di-mensioni, materiali rilevati dagli originali. Alison ha considerato.nella sua ricerca sull'ambiente di Mackintosh, soprattutto la sedia" come " polo ' della sua articolazione ambientale " |y.
l'or restare un attimo sui mobili, si veda il delizioso tavolinetto-scalTals, della collezione della Glasgow University, dove i moduliart nouveau, combinali con un raffinato orientalismo, sono ormaicontenuti nelle curve lente e nell'assottigliamento di tutta l'imma-gine, dalle gambe piatte, appena convesse, quasi ricavate dalla curvamorbida di una sezione di canna di bambù, fino al primo ripiano,quadrangolare, da cui si levano i sostegni rastremati del piccolo ri-piano superiore, circolare.
Non si può ignorare l'ascendenza giapponese, vivissima ma com-pletamente filtrata e tradotta in linguaggio personale, per questopiccolissimo, bianco robot, questo dolce-ridente personaggio (si pensi,per una trascrizione simile di linguaggio raffinato e libero, ma inchiave di contestazione e di ' anti-design ', agli ironici ' mobili-spi-rito ' di Ettore Sottsass Jr.).
L'architettura di Mackintosh, anche se non rinuncia alla sua ade-sione programmatica ai modi dell'architettura baronale scozzese (ilsolo stile, egli diceva " che si possa in tutto e in parte definire no-stro " 20) - Thomas Howarth ne ha ben notate le incidenze nell'operadi Mackintosh -, pure non rifiuta alcun apporto o stimolo gli possa
8 - Scozia - La Scuola di Glasgow - Mackintosh,
venire dalla storia artistica del passato (il Rinascimento italiano, peresempio; Mackintosh fu due volte in Italia, nel 1892 e nel 1902): o ilmondo orientale - il Giappone: fatto, anche questo, peraltro, in chiavecon il clima art nouveau -, e costituisce il primo apporto, forse ilpiù importante, per il rinnovamento e il superamento del modulostesso art nouveau.
La scuola d'arre di Glasgow, che si da come l'opera più complessadi Mackintosh (realizzata in due tempi. 1897-1899 e 1907-1909), èuna grande struttura compatta, serrata, verticalizzata. dove il giocoplastico si compone in superficie, in un equilibrio straordinario trasimmetria e asimmetria: la facciata, scandita in otto assi, dovrebbeeludere ogni accento di esatta centralità; invece il portale, pure inse-rito sul quarto asse da sinistra, occupa l'esatta metà della facciata,che mantiene questo bilico straordinario anche in virtù di una sin-tesi mirabile di pieni e vuoti, in un'armonia sottile, di grande freschez-za, in un equilibrio dinamico.
Straordinaria conquista di Mackintosh è la scansione degli spaziinterni, concepiti secondo un filtraggio continuo di luce (luce intesaanche come purificazione spirituale), in una dinamica aperta, sot-tolineata dai ricorsi delle travi portanti in legno, come nella biblio-teca della scuola, al cui linguaggio anticipatone già abbiamo accen-nato, e dai tralicci lineari di diaframmi quasi trasparenti.
Talvolta il linguaggio di Mackintosh si fa di una preziosità calli-grafica, come nella raffi nati ssima porta, gioiello-gigante, della Roanide Luxe, delle Willow. Tea-Room di Glasgow, del 1904.
- Scozia - La Scuola di Glasginr - Mackinlmh.
11 fatto di trattare l'architettura, il mobile, l'arredo, come un ' og-getto '. come componente di un tutto unitario, in una visione linearedi estrema purezza, travalica l'adesione stilistica e anticipa, lo ripe-tiamo, intenzioni di estrema novità.
Pure, malgrado l'iniziale fortuna dì Mackintosh, subito notissimo al-l'estero, invitato, dopo la mostra londinese de! 1896, a tutte le maggiorirassegne internazionali (Parigi, 1896; Liegi, Vienna, 1900; Vili mo-stra della Secessione ; Esposizione di Torino, 1902 ; e, dal 1903 al 1913. aBudapest, Monaco, Dresda, Venezia - invitato da Diagjìlev -, Mosca).non fu accettato dalla società inglese. Nel 1913 lasciò Glasgow permirarsi sulla costa del Suffolk, dove si dedicò alla pittura. A pro-posito di questa attività, le opere di Mackintosh raggiungono unapurezza espressiva, una felicità di sintesi tra figurazione e scansioneritmico-lineare che hanno, ci sembra, un solo possibile confronto,quello con Paul Klee, che nella sua esperienza iniziale, d'altra parte.
8 Scozia - La Scuola dì Glasgow - Macintosh.
interpreta con adesione finissima e creativa, certi motivi dell'AriNouveau- andamento lineare, "corpuscolarismo" 21, orientalismo... -.
Nel 1915 Mackintosh, a Chelsea, presso Londra, ebbe alcuni inca-richi per abitazioni che non furono mai realizzate; nel 1920 progettòun teatro, che non vide alcuna attuazione. Isolato completamente,stanco e avvilito, dedito all'alcool, dimenticato da tutti, ritrovò unsolo momento di fertilità creativa, con una serie di straordinarì oliie acquerelli, quando si rifugiò a Port Vendres, in Francia. Nel 1927,gravemente ammalato di cancro alla bocca, moriva in assoluto ab-bandono.
Per le arti applicate, in Scozia, oltre alla straordinaria personalitàdi Mackintosh (che si dedicò anche alla creazione di gioielli) e allalinea seguita da tutta la Scuola di Glasgow, si parlerà del grandeimpulso dato al rinnovamento del ricamo (sotto la guida di JessieNeuberg), dei lavori in metallo (con lo stesso Mackintosh e le sorelleMacdonald), delle belle realizzazioni grafiche di Jessie King, inglesema educata in Scozia, tra i nomi più noti nell'ambito del rinnova-mento del libro. Ma sarà un discorso che non potrà essere isolato
8 - Scozia - La Scuola di Glusgtm- - Miickinlash.
8 - Scozia - La Scuola di Glasgow - Mackimosh.
e settoriale, data la forza di concentrazione espressa da queste per-sonalità.
L'attività decorativa scozzese, non fu, peraltro, di lunga durata:sia per la mancanza di una impostazione teorica, sia perché, pocodopo la fine del secolo, i quattro della Scuola di Glasgow si divisero.
Abbiamo già parlato della misera fine di Mackintosh, che segna la
8 - Scozia - La Scuola di Glasgow - Mackintosh.
perdita di una delle più espressive unità stilistiche del tempo e costi-tuisce la chiusura definitiva di tutta una linea unitaria di attivitàartistiche, che sul suo nome aveva fondato le premesse del suo con-sistere.
In Olanda i motivi dell'Ari Nouveau si innestano in un tipo dicultura borghese meno aperta a quelle leggiadrie e a quella libertàdi fantasia, rese possibili in ambienti di più raffinata cultura e di avan-guardia letteraria.
C'è poi da tener conto, per l'architettura, di una tradizione storicaimpostata ad una semplicità strutturale essenzializzata, basata anchesull'uso del laterizio, come materiale fondamentale e quasi univoco.
Questo carattere che, per certi aspetti, può costituire un limite(per le arti figurative, in parte, la condizione olandese lo costituì),per l'architettura si risolve, con HENDRICH PETRUS BERLAGE (1856-
9 - Olanda.
1934). in una l'or/a di coerenza e in una chiarezza espressiva che loporteranno verso una sorta di Razionalismo avant-lettre, per un latosorretto, appunto, da una fedeltà consapevole alla tradizione olan-dese, in mòduli di allusione romanica, dall'altro da un continuoaggiornamento culturale, attento, soprattutto, alle esperienze proto-razionaliste statunitensi di Richardson e della Scuola di Chicago.
In lui le incidenze del linearismo art nouveau si riducono a motividi semplificazione volumetrica, a sottile decantazione, in superfìcie,dei rapporti tra materiali diversi, alla trasformazione di fatti plasticiin fatti cromatici. Caratteristiche che egli, nel palazzo della Borsa diAmsterdam (1898-1903), innesta in un medievalismo discreto, in unasevera spartitura dei piani, in superficie, ponendosi come uno deiprecursori europei di istanze razionaliste.
Di Berlage, più legati al nuovo stile internazionale certi mohili.attorno al 1894, che conservano, peraltro, la sua caratteristica disemplice linearità strutturale e di adesione ' storicistica ".
9 - Olanda.
Tra gli altri architetti olandesi, sensibili alla nuova impostazionedel gusto, Herman Pieter Mutters {autore del floreale Wassenaarsewega L'Aja, 1898. e del padiglione olandese per l'Esposizione Universaledi Parigi del 1900, che realizzò in collaborazione con Karel Shuy-terman); da citare anche William Kromhout {American Hotel diAmsterdam, 1900) e P. J. H. Cuijpers, allievo di Viollet-le-Duc. auto-re del Rijksmust'um di Amsterdam, neo-romanico, più noto, peral-tro, nell'ambito delPArt Nouveau. per le arti applicate.
9 - Olanda.
9 - Olanda.
1 nomi di Jan Toorop, di Christopher Karel de Nerée Tot Babbe-nck. di Johan Thorn Prikker, proprio per le ragioni di chiusura unpo' provinciale dell'Olanda, avranno più incidenza nel campo dellagrafica che della pittura.
Mentre un carattere autonomo, sia pure non insensibile alte espe-rienze inglesi, alla moda orientaleggiante (espressa, però, in Olanda.da motivi giavanesi), mostravano le nuove esperienze di arte applicata.
In questo campo, nell'ambito di quel movimento internazionale,
che vedeva sorgere, quasi dovunque, iniziative in favore dell'artigia-nato e della qualificazione del prodotto industriale, in Olanda, dopoche il governo ebbe dato vita ad una commissione di studio (1871).si moltiplicarono attività promozionali, didattiche, culturali, dallarivista « En Industrie » (1878) al " Rijkschool voor Kunstnijveheid "(scuola di Arti applicate e decorative di Amsterdam. 1881).
Nel 1884 sorse l'associazione " Arti et Industriae ", che si propo-neva di coordinare i rapporti tra arte, artigianato e industria; del 1885è la fondazione dell'associazione di artisti " Labor et Ars " (Dijssel-hof, Nieuwenhuis, Zwollo e Mendes de Costa).
Le riviste e i testi inglesi sull'argomento si diffondevano intanto,tradotti, in Olanda (« Everyday Art ». di Lewis Bay, uscito in Inghil-terra nel 1884 veniva tradotto già nel 1886; si traducevano libri diWalter Crane. si esponeva la grafica inglese).
Mentre nascevano periodici olandesi come « Bouw - en Sierkunst »
9 - Olanda.
(1888) e « Arts and Crafts », sotto la direzione artistica di ThornPrikker.
Nei caratteri generali, pertanto, le manifestazioni di arte applicatadi tipo Art Nouveau (o " Nieuwe Kunst '), in Olanda si distinguonoper la semplicità lineare, la bidimensionalìtà, l'equilibrio, di cui sifece promotrice la galleria " Nieuwe Kunst " di Amsterdam.
Oltre ai mobili di Berlage si ricordano gli arredamenti di WillemDijsselhof (noto per la elegante stanza Dijssethof, 1890-1892), ora al(.ìemeente Museet di L'Aja), quelli di Carel Adolph Leon Carchet.quelli del pittore Johan Thorn Prikker.
Per la grafica è caratterìstico il riferimento al batik giavanese inKarel Petrus Cornelis de Basel, architetto, e in Theodorus Colen-hrander (disegnatore anche di tessuti); mentre più legato a motivisimbolici inglesi è Theodor Willem Nieuwenhuis.
Per la ceramica e la porcellana olandesi, di grande finezza ed ele-ganza, si può citare il nome di Jurriaan Kok. per i metalli in-cisi F. Zwollo.
II pittore JAN TIX)ROP (1858-1928) unì ad un simbolismo di carat-tere quasi surreale un'intenzione misticheggiante. Opere come Lacanzone dei tempi (1893) e come Le tre spose (prima del 1893) restanoesemplari per una loro sottile e segreta magia, per il linearismo tesofino al calligrafismo, nel fluire di matasse larvate di membra lamel-liformi (antenne di insetto, braccia di polipi, celenterati?).
La stessa tendenza ad affusolare l'immagine, secondo un'intenzioneche si rifa a moduli ornamentali giavanesi (Toorop, tra l'altro, eranato a Giava, aveva vissuto a Londra e a Bruxelles), si ritrova neisuoi cartelli pubblicitari (e si ricorderà come la cartellonistica sia unodei motivi più autonomi dell'Ari Nouvea), come Delftsche Slaolìe
9 - Olanda.
(anteriore al IS97). mentre in altre opere piliorichc Toorop oscillaIra un sinbolismo raggelato, alla Hodler. e il Divisionismo francese,del quale prova la tecnica.
Renato Barilli tende a vedere, sia ne! linearismo che in quello che.con felice intuizione, chiama " corpuscolarismo " (che egli individuain quasi tutte le manifestazioni pittoriche Art Nouveau) " due solu-zioni dello stesso problema, fuse e integrate, per esempio, in Seurat.associate e applicale alternativamente, in Toorop " 21.
Anche JOHAN THORN PRIKKBR (1868-1932) è legato ad un simbo-lismo mistico-esoterico estetizzante, che si affida ad una esaspera-zione lineare di estrosa rarefazione. Si vedano, ad esempio, De Druid(La Sposa, 1893) e la Madonna dei tulipani (1892).
Talvolta il suo segno grafico si fa scattante e si spezza, abbando-nando la continuità ondulata della linea per incresparsi in segni vir-golati ripetuti, spezzati e fittamente addensati, che ricordano moltoda vicino il segno vertiginoso, ossessivo, pre-espressionista, di VanGogh. Del resto questo tipo di segno si ritrova anche in certi lavoripittorici iniziali di Van de Velde.
In un secondo tempo Prikker subirà l'ascendenza del De Stijl. checomplicherà di reminiscenze art nouveau.
9 - Olanda.
181 IO - Germania.
La Germania, rimasta per lungo tempo legata a mòduli di carat-tere neo-rococò, si teneva in disparte, per quanto riguarda la parte-cipazione a istanze di rinnovamento. Fu l'esposizione di Chicagodel 1896 che provocò il risveglio dell'attività artistica in senso ArtNouveau {Jugend, come si diceva in Germania). Ma fu anche, dal1899, la frequente e assidua presenza in Germania di Van de Velde,che contribuì in maniera determinante al rinnovamento.
Lo Jugendstil ebbe due momenti successivi: il primo di tipo flo-reale, naturalistico; il secondo astratto-geometrico; ebbe diffusionesoprattutto a Monaco e rimase limitato quasi esclusivamente allearti applicate.
A HIÌRMANN OBRIST (1869-1927), naturalista e scultore, che Ton-do, tra l'altro, un laboratorio di ricami a Firenze, dove si trasferì, nel[892, si deve il pannello murale in lana e seta, a ricamo giallo su fondoturchese, del famoso Peitschenhieb (La frustata, 1895; ma il tema realee una pianta di ciclamini nel suo fluire vitalistico, nella sua crescita),che sintetizza in un ' gesto ' astratto, di rara immediatezza, tutta laforza elementare di cui l'Art Nouveau vuoi farsi interprete. A lui sifa risalire l'uso più diretto e la diffusione del motivo ' à coup de fouet 'Anche certe sculture di Obrisl, come Entwurf fùr ein Denkmal (pro-getto per monumento, prima del 1902), si risolvono in uno slancioverticale, spiraliforme, del tutto astratto, che. nel caso del progettosuddetto, fa dimenticare le piccole figure umane esistenti, tanto chele ali dell'angelo, sulla sommità, sembrano naturale prosecuzionedel motivo ascensionale.
Obrist fu anche autore di mobili interessanti, di tipo floreale, sim-bolico-strutturale.
AUGUST ENDELL (1871-1925), berlinese, che fece parte, per qualchetempo, del gruppo della Secessione di Monaco, è noto per il rifaci-mento della facciata dell'Atelier Elvira (1897-1898), che, come ab-biamo già detto, fu distrutta nell'ecatombe di opere che i nazisti bol-larono come ' arie degenerata *. Si trattava di una enorme ornamen-tazione astratta, ' à coup de fouet ', di allusione zoomorfica, esaltantela violenza espansiva di una crescita spontanea.
Con la facciata, Endell aveva rifatto anche la parte interna del-l'atelier (uno studio fotografico), inserendovi una scala dove la suafantasia si espandeva con una ricchezza esasperata. Dì Endell ilBunti's Theater, il 'Teatro variopinto' di Berlino (I90H jpjù pie-
10 - Germania.
IO - Germania.
colo dell'Atelier Elvira, svolge ancora più organicisticamente il temaallucinato, protoplasmatico, allusivo di mostruose materializzazioniche gli è caratteristico. Una sorta di cielo stellato, da cui pendonolampade puntute, è limitato da un Iregio popolato di animali marini;le pareti sono decorate di ramificazioni e le balaustre e le aperturedella scena sono enormi ragnatele in ferro. " Endell vi profuse l'in-tero magazzino di fuochi d'artificio del suo ornato tutto corna, denti,punte, zampilli, fiammelle. Le file di sedie erano in colori diversi a
IO - Germania.
seconda del prezzo. Le serventi, vestite in verde e viola, indossavanogrembiuli terminanti a punta sia in alto sia in basso. Insomma. ilteatrino stesso era, per gli spettatori, il primo numero del program-ma " (Ahlers-Hestermann).
OTTO ECKMANN (1865-1902), considerato il maggiore esponentedello Jugendstil di Monaco, si dedicò, dapprima, all'attività pittorica(Le quattro età della vita, di carattere simbolista). Dal 1890 passò,invece, quasi totalmente, sotto la spinta della moda giapponese, allagrafica e alle arti applicate. Fu uno degli illustratori più apprezzatidi « Jugend ». la cui pubblicazione era iniziala nel 1896 (e dette il
IO - Germania.
Si/V\PLÌCÌSSÌA\US}u Sjeinricfi stinte fhm&erfflem (BeHur
nome al movimento). Ma la rivista tedesca più qualificata era « Pan »,che usciva a Berlino sotto gli auspici del critico Julius Meier-Graefe.dal 1895. Vi collaborarono i più noti artisti e scrittori del tempo eOtto Eckman vi profuse il meglio della sua vena sottile, agile, in di-segni morbidi, ondosi, di soggetto floreale, ma vòltt ad una astra-zione simbolica che rivela la sua propensione per i motivi ornamentali
giapponesi. È noto anche per la progettazione di caratteri di stampadove raggiunse un dinamismo astratto assai vicino a quello della' linea belga ' e, in particolare, di Van de Velde.
IO - Germania.
Nello slesso 1895 Van de Velde teneva un corso al Museo lessiledi Krefcld; nel 1896, come si è detto, usciva « Jugend », nel 1897« Kunsl und Handwerk » e « Dekorative Kunst », tutte a Monaco;a Darmstadt, nello stesso anno, uscivano « Deutche Kunst und De-koration » e « Kunsl und Dekoration ». Nel 1897 veniva fondata aMonaco la " Vercinigten Werkstàtten fùr Kunst und Handwerk '".nel 1898, a Dresda, la " Drcsden Werkstàtte tur Handwerkskunst ".
BERNHARD PANKOK (1872-1943) passò, come molti altri artisti delperiodo, dalla pittura alle arti applicate, per arrivare anche all'archi-tettura e alla decorazione di interni. Gli ambienti per l'EsposizioneUniversale di Parigi del 1900 e per quella di St. Louis del 1904 sonole sue realizzazioni più conosciute.
Anche RICHARD RIEMERSCHMID (1878-1957). architetto, autore delMiinchenn Schauspielhaus. il teatro di prosa di Monaco, di stile neo-rococò, si distinse, nell'ambito dello Jugendstil, soprattutto per Tatti-vita nelle arti applicate e per i mobili, di una semplicità e purezzaesemplari.
PETER BEHRENS (1869-Ì940) rappresenta, nell'architettura tedesca.il passaggio diretto tra lo Jugend e l'architettura moderna, tenendo
10 - Germania.
dichiaratamente ad abbandonare il decorativismo per una più direttaintenzione costruttivista. Tra i fondatori della Secessione di Monacodel 1893, passò poi a Darmstadt, dove fece parte di una comunitàdi artisti di cui era componente anche Olbrich e, nel villaggio dellacomunità, costruito da Olbrich su commissione del granduca ErnstLudwig von Hessen, Behrens edificò la propria casa.
IO - Germania.
10 - Germania.
Divenuto direttore dell'Ufficio Progetti della A.E.G. (1907), fu ilprimo ad instaurare lo studio sistematico di tutta la linea riguar-dante la produzione della A.E.G.
Ku autore della Turbinhaile (1909), una fabbrica di turbine, nellaquale interpreta, per la prima volta, la fabbrica come 'contenitore'architettonico, facendo, infine "giustizia" - scrive Argan - "delsimbolismo tecnologico"23. Egli vi traspone, però, forse involon-tariamente, in termini di razionalizzazione funzionalista, un tipo disimbologia monumentale, quasi una sorta di stilizzazione astrattadel mòdulo del tempio greco: il fronte con la vetrata inclinata quasirovescia il concetto di gerarchizzazione scalare classico; nel retrole colonne del repertorio classico sono sostituite dalla spartituraverticale della parete muraria a mezzo di finestrature a tutta altezza:il timpano è sostituito da una copertura sagomata, delimitata da unaspezzata poligonale a otto lati; tutta la parete rispetta la deforma-zione prospettica, di tipo classico. Si tratta perciò, più che di un ri-fiuto della simbolizzazione tradizionale, di una trasposizione di sim-bologie. Egli unificò, peraltro, tutto lo stile della A.E.G., dalla pub-blicità ai prodotti, secondo la concezione moderna della ' immagine
10 - Germania.
coordinata '. Fu. cioè, il primo designer in senso attuale.E, aggiungerci, con tutti i rischi del designer attuale; in quanto,
(e non a caso ho parlato di trasferimento di simbologie espressive),dava avvio a quel tipo di monumcntalìzzazìone funzionalista, che di-verrà caratteristica della attuale tecnologia industriale, come espres-sione di potere e, quasi direi, dì terrorismo tecnocratico.
Il riferimento al tempio è un fatto sintomatico.Con Behrens, comunque, come appare chiaro dalle opere succes-
sive, siamo già in tema di architettura contemporanea. Mies van derRohe. Gropius, Le Corbusier, usciranno, tutti, dal suo studio.
Tramite costante con l'arte belga, Van de Velde lavorava, intanto.
10 - Germania.
sia in Belgio che in Germania, dove, tra l'altro, costruì, alla Espo-sÌzione di arti industriali di Colonia, il teatro del Deutscher Werk-bund (1914).
È alla sua continua ascendenza che si deve la trasformazione delladecorazione Jugend da floreale (più vicino alla maniera inglese) adastratto-geometrica.
Ma al momento della Esposizione organizzata a Colonia dal Deut-scher Werkbund l'Ari Nouveau poteva dirsi esaurito. La crisi latentedel mondo moderno stava per esplodere nella guerra, e anche Vande Velde aveva abbandonato i modi di uno stile superato per unaaperta adesione al razionalismo.
In questo periodo viveva in Germania, a Berlino, il pittore nor-vegese EUVARD MUNCH (1863-1944), la cui poetica è " direttamenteo indirettamente collegata con il pensiero di Kierkegaard " (G. C.Argan 24), in quanto espressione della straziante incomunicabilitàdell'io e della ricerca continua di una comunione oltre il tempo ela storia.
Quando espose a Berlino, nel 1892, su invito della " Verein Ber-lincr Kùnstler ", sollevò tale scandalo che la sua mostra dovette es-ser chiusa, ma suscitò anche tanli fermenti che nacque la " Berliner
IO - Germania.
IO - Germania.
Sezessìon " (la Secessione di Berlino), guidata da M. Liebermann.A questo periodo si ascrive l'adesione di Munch allo Jugend, che
si esplica, oltre che nell'ideologia simbolista, nella tensione febbriledella linea, nella trasformazione dell'immagine in 'segno'; si pensia // Bacio, 1892, a Pubertà, 1895, e, soprattutto, al notissimo II grido1893, che si esasperano nello scatto ad arco della linea, nel colorestridente, nel contorno vivamente segnato, secondo il modo sinte-tista, ma che già, di fondo, anticipano quel clima ' esistenziale ' chenon è più quello dello Jugend, ma quello dell'Espressionismo.
E si veda, ad avvalorare quanto ho scritto a proposito di ' antici-
IO - Germania.
pazione espressionista ' per Gaudi, relativamente alla copertura dicasa Mila (1905-1910), la inquietante affinità espressiva tra // gridodi Munch (1893) e uno dei camini issati sopra il fastigio di casa Mila,appunto, che, pur risultando da un gioco geometrico di paraboloidi,assume, nella violenta simbolicità antropomorfa, la stessa angosciosa,acuta drammaticità, pre-espressionista, di Munch.
L'altro avvenimento arlistico importante, per la Germania, oltrealla mostra di Munch, che dette occasione alla fondazione della Se-cessione di Berlino, fu la formazione del " XI Group ", esemplificatosu " Les XX " di Bruxelles. Ne fecero parte, tra gli altri, Max Klinger.Walter Leistikow e Ludwig von Hofmann.
MAX KLINGER (1857-1920), seppure fedele a un tipo di pitturamonumentale, romantico-realista, può essere ascritto tra gli aderentiiillo Jugend per due fattori: il carattere ' simbolista ' della sua tema-tica e il tentativo di raggiungimento dì quella ' sintesi tra le arti * chel'u l'ideale del momento. Il suo Giudizio dì Paride (1885-1887), adesempio, tenta l'unione tra pittura e plastica, proseguendo il tema deldipinto nella grande cornice intagliata.
Anche LUDWIG VON HOFMANN (1861-1945), autore di paesaggi dilirica resa emotiva, vi inserisce spesso immagini simboliche di ca-rattere Art Nouveau.
10 - Germania.
IO - Germania.
Abbiamo già accennato alla fondazione della Secessione di Berlino(1892), formata da centotrenta aderenti, capeggiati da Liebermann,(il più noto pittore impressionista tedesco), e dalla Secessione di Mo-naco del 1893; vi aderì, tra gli altri, FRANZ VON STUCK (1863-1928),che risenti profondamente del linguaggio simbolico-letterario dellosvizzero Arnold Bòcklin, elaborando, peraltro, un suo stile personaledi un simbolismo erotico un po' enfatico, peccaminoso, oscuro, chetrovò una feroce opposizione critica in " Che cos'è l'arte " di Tol-stoi (1897) e in "Pittura e scultura futurista" (1914) di Boccionì.Fu considerato, peraltro, un po' come il Michelangelo della Ger-mania bismarkiana; ed ebbe qualche ascendenza su De Chirico esu Dalì.
Per la scultura basterà fare, per la Germania, oltre al nome che giàabbiamo citato, di Obrist. quello di ERNST BARLACH (1870-1938).Studiò ad Hannover e a Dresda, fu a Parigi, ma, forse unico tra gliiiiliiti del momento, non subì l'ascendenza francese. Collaboratoregrafico di « Simplicissimus » e di « Jugend », verso il 1905 fece un\ leggio in Russia, dove si entusiasmò per la scultura popolare. Studiòu scultura medievale tedesca e quella popolare in legno; usò pre-valentemente terracotta e legno, elaborando un linguaggio arcaiciz-zante, estremamente sintetico e lineare, enfatico nella gestualità, di-namico. 1 suoi temi furono tratti dalla vita del popolo, dei contadini,dalle leggende popolari.
Ha una sua esatta collocazione nell'ambito dell'Espressionismo te-desco, ma la sua ricerca di dinamica formale non è lontana da certimòduli che saranno definiti e concretizzati dal futurismo di Boccioni.
Quando, nel 1897, sotto l'ìncitamente entusiasta di Gustav Klimtsi formò a Vienna la " Vereinigung bildender Kùnstler ÒsterreichSezession " (Associazione dei pittori e scultori della Secessione austria-ca) e sì inaugurò una mostra internazionale che accoglieva opere diBernard, Bòcklin, Grasset, Klimt, Klinger, K.hnopff, Liebermann,Meunier, Puvis de Chavannes, Raffaelli, Rodin. Sargent, Stuck,Uhdc, Van de Velde, si apriva uno dei momenti estremi e più ful-gidi (anche se, appunto, con un certo ritardo rispetto ad altri paesieuropei, e con caratteri diversi) dell'Art Nouveau.
11 - Austria.
L'uscita di « Ver Sacrum », l'edificazione di un palazzo per espo-sizioni, progettato da Olbrich, una serie di importanti esposizioniinternazionali, sono le prime dichiarazioni di una nuova impostazionearlistico-culturale che si orienta sempre più sul tema della integra-zione delle arti, di cui si ergerà a simbolo il palazzo Stoclel, l'operapiù importante eseguita da Hoffmann a Bruxelles, che porterà leraffinatissime decorazioni murali di Klimt.
D'altra parte, come ho accennato altrove (cap. Ili) nell'ambitodegli studi che fanno capo alla Scuola viennese di Storia dell'Arte.per la raccolta e lo studio comparato delle arti, Alois Riegl, studiosodi storia dei tessuti medievali e di arte ' popolare ' (come conserva-trice e tramite di caratteri arcaici), già nel 1893 pubblicava " Stilfra-gen " (Problemi di stile), in cui tracciava un profilo di storia dell'or-nato dall'età pre-egiziana a quella tardo-bizantina, rivendicando
(contro il Semper) il carattere creativo, inventivo, dell'opera d'arte,come " immanente impulso artistico " dell'uomo.
Ma già l'architettura aveva trovato in OTTO WAGNER (1841-1918)l'iniziatore del rinnovamento austriaco nel senso della rottura dellarigidità del blocco edilizio e il distacco dalle formule tradizionali,malgrado certe sue costanti storicistiche, che lo porteranno, peraltro
in particolare il ricorso al neo-classico, alla ' Luigi XVI ' -, ad unaprogressiva e significativa semplificazione, e che faranno di lui, so-prattutto, un maestro di eccezione.
Di Wagner, di vivo interesse, anche come opera di uso sociale.come quella di Guimard a Parigi, le stazioni della Metropolitana diVienna, soprattutto quella della Karlsplatz, del 1897; e inoltre laNussdorfer Nade/wehr (1897), la Majolika Hau.s (1898 circa), nellaWienzeile di Vienna, dalla bella facciata rivestita di ceramica a mo-tivi fiammeggianti. Ma l'importanza fondamentale di Wagner restasoprattutto quella di maestro. Nel 1895 uscì il suo libro " ModerneArchitektur " che divenne un classico e che contribuì alla diffusionedel nuovo stile 'viennese', in Germania, dopo il 1901. e poi. so-prattutto, in Italia (dove, peraltro, come vedremo, si guardò moltoanche a Glasgow).
Suoi allievi sono, infatti, JOSEPH MARIA OLBRICH (1867-1907). (dicui già abbiamo citato la Haus der Wiener Sezession, l'edificio peresposizioni del gruppi della Secessione di Vienna, organizzato astrutture interne mobili e adattabili ai diversi tipi di esposizione).
autore anche del villaggio per artisti a Darinstadt (1901-1908). la cuiraffinata, libera sensibilità si manifesta nella cura estrema dei par-ticolari, e JOSEPH HOFFMANN (1870-1956), autore del palazzo Stodeta Bruxelles (1905-1914). che trasferisce nella libera impostazione deipiani, secondo una bidimensionalità lineare, evidenziata dal croma-tismo decorativo delle pareti, la visione autonoma di una architet-
tura ' astratta '. Noti, prima che come architetti, come grafici e il-lustratori attraverso le pagine di « Ver Sacrum », Olbrich e HofTmannvi svolsero e svilupparono temi grafico-lineari impostati sul quadratoe sul cerchio (temi, in realtà. anti-Art Nouveau: ciò che dimostracome la loro adesione al movimento fu del tutto particolare e proiet-tata in avanti; in Austria, in effetti, l'Art Nouveau si manifesta tardi,come si è detto, e viene superato assai presto).
Fautori di una impostazione operativa che realizzasse un rapportointegrativo tra natura e architettura, fecero grande uso di elementidecorativi naturali - anche inserendo alberi veri o simbolici all'in-terno delle loro architetture; si veda anche il bellissimo fastigio-cupolain rame traforato della Haus der Wiener Sezession di Olbrich, di cuiabbiamo detto, emulante la chioma tondeggiante di un albero -.Di Hoffmann, già impostato ad un proto-razionalismo di grandemodernità, ricordiamo anche il sanatorio Purkesdorf, presso Vien-na (1903-1904).
Olbrich e Hoffmann si dedicarono anche alle arti applicate, se-condo, peraltro, una intenzione strutturale e costruttivista, che si
riconosce sia nei mobili elegantissimi e lineari, sia negli oggetti, cherifiutano assolutamente ogni ricorso a stili del passato, sia nell'orna-mentazione (in effetti, per loro, ' aggiunta ' alla struttura), che 01-brich svolse con grande ricchezza, seppure facendo intervenire comefattore risolvente del ritmo decorativo lineare, ripetuto, basato sulcerchio, la superficie; Hoffmann si attenne ad una maggiore sempli-ficazione dell'ornamento, che basò sul quadrato e sul gioco del bianco-nero cui si aggiungevano, talvolta, come nel mobile inglese, argento,avorio, marmi preziosi.
Il - Austria.
Per le arli applicate, nell'ambito della grafica (illustra/ione del li-bro e grafica pubblicitaria), e per la progettazione di oggetti, un al-tro nome prestigioso, in Austria, è quello di KOLOMAR MOSER {1868-1916), allievo, come gli altri, di Wagner. Aveva studiato pittura, masi dedicò, costantemente, soprattutto alla grafica; adottò uno stilegcometrico-lineare elegantissimo, attraverso il quale passò poi al-l'uso di un ritmo composito, basato sul quadrato e sul cerchio, e aduna figurazione simmetrico-frontale, anche sulla scia delle contem-poranee esperienze scozzesi. Di lui noti anche alcuni allestimenti diesposizioni (come quella di Klimt a Vienna).
ADOLF LOOS (1870-1933), nato in Cecoslovacchia, fu, come gli al-tri, tra i fondatori della " Wiener Sezession ", ma si schierò semprecontro ogni forma di decorativismo art nouveau.
Autore del saggio " Ins Leere gesprochen ", (Ornamento e crimi-ne. 1897-1900), rappresenta l'indirizzo architettonico astraente e ri-solutivo verso il definitivo affrancamento, anche, da quelle stesseanticipazioni già contenute in molte esperienze art nouveau. maancora irrisolte, che pure costituiranno una molla di scatto verso ilRazionalismo. 11 suo stile "cubico levigato" (R. Schmutzler 25). seancora, nella dilatazione della scala proporzionale, può ascriversi allardo Art Nouveau (e si vedano, di lui. il bellissimo bar Kramer, aVienna. 1907, ma anche la casa per Tristan Tzara, a Parigi. 1926e il progetto per la casa di Josephine Baker, 1928) pure si aprirà di-rettamente verso l'architettura moderna.
GUSTAV KLIMT (1862-1918) è, comunque, la personalità più in-quietante della Secessione viennese e il pittore più rappresentativodell'Ari Nouveau.
Formatosi sullo studio dei grandi del Rinascimento, ai quali siaccosta con una sensibilità e finezza straordinarie, si esprime, dap-prima (sia pure col ritardo dovuto alla situazione culturale locale),nei modi di un inquieto, sottilissimo post-impressionismo (si veda ilRitrailo di Sonia Knifs, 1898); ma elabora, ben presto, un linguaggioautonomo, esuberante, dove motivi di astrazione simbolica si uni-scono ad una pienezza emozionale e ad una carica sensuale che tro-vano in un'eleganza fastosa, da nuova Bisanzio (non era lontano iltempo della " Salambò "' di Flaubert. e Yeats scriveva allora " Silineto Byzantium "), una sorta di sublimazione di intensa e vibranteautenticità. La sua sensibilità ' tattile ' trova soluzioni insolite (l'in-serimento di pietruzze, di schegge di metallo sulla tela, come nellaGiuditta del 1901) e volge poi ad uno studio della superfìcie dipinta(dal fondo della quale emergono le immagini), concepita come fatiodecorativo autonomo, pullulante, in un gioco di vibrazioni colore-
luce ottenuto a mezzo di minutissimi disegni geometrici o di piccolis-simi sìmboli, gettati là come efflorescenze (e verso il 1905-1906 sitratta veramente di ' efflorescenze ', che niente più hanno a che farecon la stilizzazione dei motivi floreali del primo Art Nouveau. magià impostano il problema del quadro come superficie continua - sivedano il Giardino con girasoli del 1905, e quasi tutti i paesaggi --),fino alle decorazioni musive a fondo oro, in vetro, metallo e smalto,per il palazzo Sioclet (1905-1909), dove l'immagine diventa sigla,linea in tensione fino allo spasimo, di un'aggressività tutta segreta;solo in Beardsley si è potuta trovare un'intensità dello stesso grado,ma più equivocamente ambigua, affatto partecipe della carica e dellaricca sensibilità di Klimt. Sembra siano passati secoli dalla compas-sata allegoria dei Preraffaelliti!
Uno spirito di erotismo panico, un'inquietudine tutta vibrante sen-sualità sono le dominanti di opere come la Danne (1902), La Vergine(1913. dove la ruota incessante di immagini femminili si disponecome un grande vortice decorativo), opere che segnano l'acme e in-sieme il superamento dei motivi fondamentali dell'Ari Nouveau.
Uno dei lavori più interessanti di Klimt era quello preparato peril soffitto dell'Aula Magna dell'Università di Vienna, dedicato a(re facoltà dell'Ateneo (Filosofia, Medicina, Giurisprudenza), mentretu quarta (la Teologia) era stata affidata a Matsch. Dopo anni diluvoro (dal 1901 al 1908), le opere furono rifiutate. Acquistate sepa-rutamenie {la Filosofia da August Lederer, la Medicina e la Giuri-sprudenza da Kolo Moser) finirono in fiamme, nel 1945, quando inazisti in fuga incendiarono il castello di Immendorf, dove eranoriunite, assieme ad altre opere di Klimt.
La tensione emozionale di Klimt sarà poi portata al massimo, alpunto di esasperata rottura, nell'opera più tarda, quasi essenzial-
mente grafica, del giovanissimo KGON SCHIELE (1890-1918), che co-nobbe Klimt nel 1907, quando era già un idolo incontrastato sia deigiovani artisti che della buona società viennese. Nel 1909 Schieleabbandonò l'Accademia di Vienna e costituì, con Wiegele, Paris vonGutersloh e Faistaner. il gruppo dei " Pittori nuovi ".
Dal 1909 il suo linguaggio, di tipo simbolico-erotico, in cui la li-nea incastona, avvolgendole, le immagini, scatta e si esaspera in gro-vigli e impuntature, trasformando la sua carica di erotismo, lieve-mente sadica, in una forma di denuncia contro la miseria, il sesso,il mondo politico. Da questo momento il filone art nouveau, dalui assunto in maniera particolarmente esasperata, si trasforma inEspressionismo parossistico, inquieto, allarmato.
In carcere nel 1912, come * pittore pornografico ', nel 1915 Schielesposava Edith Aams e, dopo tre giorni, veniva chiamato in guerra.Tornato a Vienna nel 1917, nel 1918 moriva di febbre spagnola.
Anche OSKAR Kokoshka (1886) approdò all'Espressionismo at-traverso una esasperata tensione della linea, che, da un andamenlomorbido e sensuale, di origine klimtiana, si inaspri e si contorse, ac-cavallandosi e increspandosi, con violenta drammaticità, appunto,nelle opere più tarde. Ma con Die tràumenden Knaben (1908, Vien-na), un suo splendido, fiabesco, lirico libro per un'infanzia ancorafelice, in cui il testo (che si rifa a canti popolari infantili) e le illustra-zioni si ispirano ad un folklore coloratissimo, siamo ancora in pienoJugendstil viennese, nella sua espressione di più raggiunta maturità.
La Svizzera enira nell'ambito dello Jugendstil-Mulerei (secondo iltermine adottato, in genere, dagli studiosi tedeschi, da Ernst Mi-chalski in poi - ad indicare, peraltro, tutto il Post-impressionismo -.mentre secondo Schmalenbach il termine, per la pittura, si usò sol-tanto dal 1914) come tramite tra la Francia, la Germania e l'Austria.
I suoi pittori più noli, come Ferdinand Hodler, come Arnold Bòcklin.passano spesso dalla Francia a Monaco (all'Italia, per Bòcklin). fil-trando i modi diversi nell'unico denominatore comune del Simbolismo.
FERDINAND HODLER (1853-1918) studiò a Ginevra, fu in Spagna -dove scoprì Velàsquez -, a Parigi, dove espose, nel 1891, una tra lesue opere più note, La Notte (1890). che poi trasferì a Monaco. AParigi fu in contatto coi Nabis, attraverso i quali si avvicinò alla pit-tura preraffaellita; trovò, peraltro, maggiore affinità con Puvis deChavannes, da cui desunse il gusto per la composizione ritmica (chePuvis de Chavannes usò soprattutto per la pittura murale). La pit-tura di Hodler, di impostazione monumentale, scultorea, si svolgesecondo un ritmo compositivo sapiente, basato sulla disposizionesimmetrica, sul gesto ripetuto, sul movimento delle figure umane,assunte, quasi sempre, come simboli di concetti astratti. // Sonno(1899-1900), // Giorno (1900), La Notte (1890), La Primavera (1901),sono alcune tra le sue opere più note.
12 - Svizzera.
ARNOLD BÒCKLIN (1827-1901) visse a Monaco e nei suoi ultimianni a Fiesole (Firenze). Il suo simbolismo si permea di una sortadi magia silente, di astratta, onirica immobilità. Si veda, ad esempio,il suo notissimo L'isola dei morti (1880), che avrà molta incidenzaanche sulla visione metafìsica di De Chirico. e sul successivo Sur-realismo.
13 - Paesi scandin
Nei paesi scandinavi e in quelli nord e centro-europei, dove un'ariadi rinnovata cultura letteraria e filosofica traeva ancora i suoi motivida una vivissima e ancora operante tradizione popolare {e si pensiai nomi di Grieg, di Sibelius per la musica, di Strindberg, di Hansumper la letteratura), lo Jugendstil di origine tedesca si innesta in mododel tutto particolare e stimolante nella situazione locale - per cuifondamentale era, ad esempio, l'uso del legno per l'architettura -anche in virtù dello storicismo nazionalista imperante; ne deriva unibrido interessante che riesce, tuttavia, ad evitare il revivalismo me-dievaleggiante per trovare una reinterpretazione sottile e attualizzatadella tradizione architettonica popolare.
In Danimarca MARTIN NYRUP fa uso di motivi floreali, particolar-mente negli interni (Hotel de la ville, Copenhagen).
Per la pittura Richard N. R. Holst esprime il suo simbolismo mi-stico, con ricordi preraffaelliti e rosacrociani, in termini di linearismodecorativo. Mentre il mondo di JENS FERDINAND WILLUMSEN ( 1863-1958), scultore, ceramista, pittore, si svolge dall'Impressionismo al-l'Espressionismo attraverso il Simbolismo, di carattere natur?';,:,tico.
Georg Jensen, scultore, ceramista, orafo, unisce a motivi di tra-dizione locale, vigorosi spunti art nouveau, in una combinazionelibera e spontanea. Si vedano soprattutto i suoi oggetti d"uso.
In Norvegia HOLM MUNTHH (1848-1898) è l'autore dell'Imperiailiuniing Lodge (11 casino di caccia imperiale, 1891), a Rominten, edel Frognerseteren Restaurant (1890-1895); di HIÌNRICH BULL sono ilMuseo storico (1897-1902) e il Palazzo del Governo a Oslo. Abbiamogià accennato a Edvard Munch, norvegese, che, verso il 1880, si unial gruppo di artisti bohemiens di Christiania (Oslo), per passare poi.su invito del " Verein Berliner Kunstler ", a Berlino, nel 1892, dovevisse a contatto con la cerchia di artisti e poeti di cui erano parteanche Augusl Slrindberg, norvegese, e il critico Meier-Graefe. ABerlino usci il primo libro su Munch. di Stanislav Przybuszewski.Ibndatore, nel 1894 della " Genossenschaft Pan " (Società Pan} enel 1895 della rivista omonima. E quando l'artista, nel 1896. tenne
!3 - Paesi scandinavi e Danimarca.
una esposizione a Parigi, fu lo stesso Strindberg a recensirla nellarivista « La Revue Bianche ». Halfdan Egedius. illustratore sensi-bile di saghe nordiche, è peraltro, in Norvegia, figura notevole per lasua interpretazione quasi impressionista di un mondo popolaresco,visto come in un sogno. Anche Harald Sohlberg appartiene al grup-po dei giovani artisti che, con Munch, combatterono il naturalismo,facendo uso dell'immagine (nel suo caso, prevalentemente, di paesag-gio), per esprimere stati d'animo.
Quella degli arazzi e dei tessuti è una tradizione che, assieme aquella del legno e a quella delle porcellane (assai diffuse, sul finiredel secolo, anche nel resto d'Europa), è riuscita a mantenere, neipaesi nord-europei, una vitalità e una freschezza inesauribili.
Sulla fine del secolo si distinsero, in questo campo, Vaino Blom-stedt, in Kinlandia, Gerhard Munthe, di Copenhagen, e Frida Han-sen, norvegese. Pur tenendo vivo il carattere primitivo, barbarico,trovano, nei loro disegni, una schematizzazione lineare interessanteili finì di una dichiarata adesione art nouveau.
Le manifestazioni culturali nordiche, ispirate allo Jugendstil. fi-niscono sempre, peraltro, col legarsi più ad esasperate vibrazioniespressionislc che non alle evasi ve, estetizzanti, raffinate fantasieari nouveau.
1 nomi di EI.IEI. SAARINEN (1873-1950), e dei suoi collaboratori,Herman Gescllius e Armas Lindgren, rappresentano, per la Finlan-dia, la voce più avanzata e più aperta verso il movimento modernoin architettura. Tra i loro lavori, il padiglione finlandese all'Esposizionedi Parigi del 1900 e una serie di edifìci a carattere collettivo che con-feriscono all'ambiente una particolare fisionomia, recuperando'mo-tivi di una tradizione decorativa ancora viva di accenti medievali,tenuti su un piano di forte carica espressiva, assieme ad una libertàcompositiva di un razionalismo quasi organico. Si vedano la Stazionedi Helsinki (1906-1914), del solo Saarinen, il particolare della bellascala elicoidale di un edificio per una compagnia dì assicurazione aHelsinki (1901), eseguito in collaborazione, la banca " Nordiska " aHelsingfors (1903). Tra gli architetti operanti in questo periodo dacitare anche SELIM A. LINDQUIST,
Per le arti figurative l'accentuazione art nouveau si rivela nellaallucinala fantasia di HUGO SIMBERG (1873-1917), allievo di Gallén-Kallela, che interpreta in un linearismo grafico, come sovrapposto
ali m i n i a m i / , sii . I X J U J m i l . u o k q u a s i p a n t e i s t i c h e . p o p o l i l e d i g l i o m i ,del mondo nordico. Menlre ARSELI GALLÉN-KALLLLA (1865-1931).più noto per le arti applicate, svolge con accesa fantasia espressionistaanche i temi più legati a immagini di paesaggio. Egli si distingue anchecome grafico e illustratore (già con accenti espressionisti - si vedanole sue illustrazioni del " Kònigslied " di Nietzsche sul primo numerodi « Pan », 1895), e come creatore di graziose sedie in legno di betul-la, ricoperte di splendide tappezzerìe disegnate da lui, in cui riescea far rivivere, modernamente, lo spirito artigianale, tradizionale,del paese.
14 - Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia.
Per l'Ungheria, l'adesione al nuovo stile si riconosce nell'architet-tura di Joszef e Laszló Vagò (Teatro de! legno, 1913, a Budapest) edi Odon Lechner, autore della Cassa di Risparmio (1899-1902) aBudapest, oltre che di edifìci medievaleggianti.
Ma dove lo spirito della Secessione ha più ascendenza, è, anchequi, nelle arti applicate. Ad insegnare al Museo di Arti decorativedi Budapest era stato chiamato, infatti, Walter Crane. Edmond Wie-gand si riporta, nei suoi arredi di interno, a moduli caraneristici diVan del Velde, creando unità composite. Per la pittura il nome piùimportante, noto soprattutto come raffinato ritrattista, è quello diPhilip A Làszlo
14 - Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia.
iIn Polonia la lotta per l'autodeterminazione, condotta nel 1863
contro la Russia, sta alla base di un tipo di romanticismo naturalistico,di carattere nazionalistico che vede in JACEK MACELCZEWSKI (1854-1929) uno di:i '•noi nuuiiion cs|iu]icnli. Anche il suo passaggio, in
14 - Ungheria, Polonia. Cecoslovacchia, Jugoslavia.
pillimi, diil Naluralismo al Simbolismo acquista un carattere parti-colare per una sua visione malinconica della natura, in mezzo allaquale egli colloca i suoi personaggi reali circondati da fauni, sirene,angeli, di un sensualismo spesso sottile ed ambiguo. Anche Witold
14 - Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia.
iella cattedrale di Fri- Wojkiewicz, dell'ultima generazione simbolistica polacca, si distin-9g 99 gue per il carattere fantastico e per la tensione drammatica che oscilla
dal lirico al grottesco; JÓZEF DESKUR (1861-1915) e STANISLAS W Y -SPIANSKI (1869-1907) evocano saghe nordiche e miti classici in temidrammatici espressi in un linguaggio enfatico, monumentalizzante.JOZEF MEHOFFER (1869-1946) è noto per le sue decorazioni (vetratedella collegiata di Saint-Nicolas di Friburgo, Svizzera, 1896-1934)che restano tra i migliori esempi di Jugendstil in Europa. Il suo li-nearismo allegorico si arrichisce di motivi sontuosi tratti dal folklorelocale.
14 - Ungheria. Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia,
Già dal 1863 il linguaggio dell'architettura in Serbia (Jugoslavia),cercava un riscatto dall'accademismo di origine straniera in un re-cupero romantico dell'improvvisazione e della fantasia, appoggian-dosi anche alla tradizione folkloristica locale, di tipo serbo-bizantino.Su questa base, e in concomitanza col movimento di liberazione na-zionale si innestano le istanze di rinnovamento che si esprimonoin una acquisizione delt'Art Nouveau in una variante particolare,serba, che unisce il motivo ' floreale ' con gli elementi dello stile na-zionale (forme di apertura delle finestre, policromia decorativa...).Tra i nomi dei protagonisti e dei promotori culturali quelli degli ar-chiietti DRAGUTIN MILUTINOVIC, MIHALLO VALTROVIC, BRANKO TA-NAZEVIÓ (Ministero della pubblica Istruzione a Vranje, e Centrale te-lefonica a Belgrado), A. STEPANOVIC e N. NESTOROVI^ (case a Bel-grado, 1900-1914), M. RuviDif, M. ANTONOVI^, V. AZRUEL (GrandiMagazzini a Belgrado. 1907).
Nelle arti figurative la corrente romantica si esprime in una ade-sione vivace all'Impressionismo, alle teorie del ' plein air '. al Pointil-lisme; mentre riferimenti di carattere simbolista si ritrovano, soprat-tutto, in LEON COEN (Primavera).
Un'attività particolarmente importante, in Jugoslavia, è quelladella ceramica, che trova nel momento art nouveau grande rilievonella vitalità delle fabbriche di JOSIP KALLINA, un industriale impren-
14 - Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia.
MANCO TANAZEVit, facciata, Belgrado. 1912.ANDCEA STEPANOVIC-, NIKOLA NESTOROVlt.Belgrado, via T giugno. 1907.k i. KALLINA. decora»oti« di un edifìcio ti Z.iguhri.i.
14 - Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia.
ditore che riesce a diffondere il nuovo stile nelle ceramiche da rive-stimento (si veda la decorazione nella facciata della costruzione del1903 a Zagabria, chiaramente ispirato alla Casa della Porcellana diWagner a Vienna, del 1898) e nella fabbricazione delle stufe a de-corazioni floreali, con ricordi rinascimentali, rococò, orientali e delfolklore locale, esportate, fino al 1900, all'estero, poi limitate alladiffusione nei paesi balcanici.
Anche in Cecoslovacchia il nuovo stile trova applicazioni di grandeinteresse, innestate in un tipo di tradizione locale di raffinata e pre-ziosa espressività linguistica. Si può parlare, così, di assetti urbani-stici di interi quartieri di Praga di carattere art nouveau, e di notevolimanifestazioni isolate. Tra gli esempi, il bel Teatro Smetana, a Pra-ga (1881-1887), dei viennesi Fellemer e Helmer, in cui i motivi artnouveau si manifestano soprattutto nella distribuzione interna, conil caffè, la birreria, la scala con la gabbia fiorita dell'ascensore, i por-lamanifesti in ghisa appesi ai vari piani, il foyer e la sontuosa salada spettacolo (con le pitture murali di Veitek), riferibili, per gusto- particolarmente per quanto riguarda la scala e il caffè a pianter-reno - più alla scuola di Glasgow che non alle Secessioni.
14 - Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavi
A Praga resta importante il lavoro pittorico e decorativo di VITEZ-LAV KAREL MASEK (1865-1927), pittore e architetto, ispirato all'esal-tazione della storia della Boemia, mitizzata in termini simbolici.Jan Preisler fece parte del circolo artistico Mànes e collaborò alla ri-vista « Volné Smery ». Il suo simbolismo antìnaturalistico lo avvicinaal primo Munch. Da ricordare l'opera grafica di ALFRED KUBIN (1877-1959) per l'inclinazione simbolico-fantastica, con accentuazioni di uncarattere ' nero ' e demoniaco che lo avvicinano piuttosto all'Espres-sionismo. Ma la sua storia, che passerà attraverso le vicende del " BlaueReiter" (1911), ne farà piuttosto un precursore del Surrealismo.
14 - Ungheria, Polonia. Cecoslovacchia, Jugt
Ma il personaggio che raggiunse maggior fama internazionale eche espresse con vivace e raffinata freschezza le istanze art nouveau(sia pure contaminate da una adesione diretta al gusto Belle Epoque- visse molto, nella sua giovinezza, a Parigi -) fu, tra i cecoslovac-chi, quello di ALPHONSE MUCHA (1860-1939).
Come Lalique, deve in gran parte l'inizio della sua fama al fattodi aver lavorato per Sarah Bernhardt, per la quale disegnò, per pri-mo, il manifesto Gismonda (1894) - ne sarebbero seguiti molti al
tri -, e per cui, ancora come Lalique, progettò alcuni gioielli, eseguitidal noto gioielliere parigino Fouquet (si ricordi il bel bracciale Ser-pente in oro cesellato e smalto, con opali incisi, che si avvolge a dop-pia spirale al polso, invade il dorso della mano, dove poggia la testa,spinge la lingua, risolta con catenelle multiple, a serrare le dita, in
14 - Ungheria, Polonici, Cecoslovacchia, Jugoslavia.
un avvolgimento simbolicamente espressivo, che Sarah Bermi i 1.1portò, sembra per la prima volta, alla prima rappresentazione della•' Medea " a Parigi, il 28 ottobre 1898).
11 ' cloisonnisme ' della scuola di Pont-Aven, l'andamento curvi-lineo del segno basato sull'organicismo fitomorfico, la decorazionelineare caratteristica dell'architettura moresca e del disegno deco-rativo islamico, il trattamento delle stoffe tipico delle xilografie giap-ponesi; sono tutte le componenti che. nei manifesti, nei disegni,nei pannelli decorativi, nelle illustrazioni, Mucha combina, con fre-sca partecipazione emotiva, ad un ricorso continuo alla tradizionepopolare del suo paese di origine. Una nota particolare va all'uso, ab-bastanza raro per l'epoca, ma costante negli impressionisti, della fo-tografia in posa, delle cui linee essenziali egli si serviva come base disviluppo per il suo disegno, il cui tema fondamentale è sempre l'im-magine femminile, trasfigurata a simbolo di erotismo magico, inca-stonata in una cornice, spesso circolare, intricata e densa di intreccilineari e floreali, con una vena inesauribile e doviziosa di motivi.
Nel 1905 Mucha pubblicò " Figures décoratives ", un documento
14 - Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia.
725 -726 -727 -728 -729 -
730 -mede
DUSAN J
DUSAN J
VLADIMIR
di Rodin
RKOV1C
ZOPANS
aPrag
dei piano - II lago.villa di Reseli.
ASEK. La Profetessa, esala da pranzo nella
1909.
1893.villa d
KY, copertina del catalogo di u, 1902.anifesto per l'Esposi•ines». 1903.
Ra
W
importante per lo studio del suo procedimento operativo e della suaconcezione stilistica.
Una nota a parte merita il nome di FRANTISEK KUPKA (1871-1957).Personaggio strano, meditativo, imbevuto di occultismo e di astrolo-gia, egli passa da una visione onirico-magica,-surreale, ad un lineari-smo geometrico spezzato, tassellato, fondato su sistemi e simbolifilosofici, che lo porterà ad esprimere una sorta di ' cubismo orfico 'particolare, in cui il trapasso da una figurazione simbolica all'astra-zione si coglie in modo quasi paradigmatico. Il lavoro del 1909, /tasti de! piano - II lago, che riproduciamo, presenta, in maniera evi-dente e stranamente coincidente, questo passaggio.
In Russia, dove la vita culturale è. in questo periodo, intensamenteviva e dinamica, lungo un unico filo conduttore che unifica arte,letteratura, teatro, musica, l'Art Nouveau, di origine secessionista,si innesta in un contesto che già aveva revitalizzato, a fini didattico-sociali, motivi tradizionali slavi (soprattutto ad opera del gruppodei Vagabondi, fondalo nel 1863).
Tra il 1880 e il 1882 SAVVA MAMONTOV (1841-1918), ricchissimomercante, con l'aiuto della moglie ELIZAVETA (1847-1908), svolse,prodigandosi fino alla rovina, una azione di promozione culturaleimportantissima, raccogliendo nella sua fattoria di Abramtsevo, vi-cino a Mosca, un gran numero di artisti e aprendo una scuola di• arti e mestieri ' per i suoi dipendenti. Fu allora progettata, edificata,decorata secondo i canoni dell'antica arte popolare russa, dai mem-bri dei gruppo, una chiesetta e, in seguito, fu fondato il Teatro del-l'Opera Privata, dove fu rappresentata, come prima opera, " LaFanciulla delle nevi "" di Rimskij Korsakov. la cui scenografia, fattoassolutamente nuovo, fu studiata appositamente da un artista, VictorVasnetsov. Da questa nuova impostazione presero spunto il registateatrale Konstantin Stanislawskij e, in seguito, Diaghilev, col Bal-letto Russo. L'iniziativa di Mamontov fu seguita dalla principessaMARIA TENISHEVA (1857-1928) che, sollecitata da Elena Polenov(che dal 1884 si era rivolta allo studio dei motivi ornamentali po-polari) e con l'aiuto dei pittori Miliuti e Roerich, fondò un istitutodi arti decorative a Talashkino.
È nella pittura, particolarmente, che le istanze art nouveau si in-nestano, con grande finezza, in motivi post-impressionisti nell'opera,ad esempio, di MIKHAIL VRUBEL (1856-1910), pietroburghese. anti-naturalistico, contrario, cioè, al populismo naturalistico dei Vaga-bondi, di cui mantiene, peraltro, il ricorso al folklore russo, che in-nesta, però, in una visione favolosa, mitica, simbolica, del passato.La sua pittura è ricca di ornamentazioni e di arabeschi, di lussureg-giante intrico lineare.
A Pìctroburgo, all'interno di un gruppo di artisti, di cui era statouno degli animatori ALEXANDRE BENOIS (1870-1960), pittore, critico.studioso di teatro, sorgeva, intanto, il " Mondo dell'Arte ". che davavita a manifestazioni culturali, proponeva una serie di mostre, fon-dava una rivista. A quel momento Benois si trovava a Parigi.
Di qui usciranno LEON BAKST (1867-1924) e SERGEJ DIAGHILEV(1872-1929) e prenderà via il trionfo del Balletto Russo, che esordirà
a Parigi, nel 1909, con '* Le Pavillon d'Armide " e " 11 Principe Igor "di Borodin, in una esaltante atmosfera esotica che combinerà le ' cine-serie ' e ' giapponeserie ' del repertorio ormai corrente del coloritofolklore russo, fornendo un esempio concreto dì integrazione artistica.
Oltre a Vrubel, sulla scìa delle nuove correnti, si porrà VICTOR BO-RISSOV MUSSATOV (1870-1905), col suo linguaggio esotico-naturalista.carico di mistero.
Seguiranno il gruppo della " Rosa Azzurra": Kusnetsov, i fratelliMiliuti, ma anche MIKHAIL LARIONOV (1881-1964) e NATALIA GONT-
CHAROVA (1881-1962), che reagiranno al Simbolismo, trasformandole istanze linguistiche art nouveau in una nuova proposta formaleche li affiancherà alle nuove avanguardie del '900.
Ma sarà soprattutto NICHOLAS KONSTANTINOS CIURLIONIS (1875-1911) che spingerà "il suo decorativismo fantastico, influenzato daOdilon Redon, dal Simbolismo in genere e soprattutto dall'Art Nou-veau, verso forme di rappresentazione non oggettiva " 26.
E infine WASSILY KANDINSKY (1866-1944), che arriverà a Monaconel 1896 e che pure prenderà avvio dal Simbolismo russo, incon-trandosi col mondo secessionista, attingerà una maggiore eleganzalineare e una più libera impostazione del segno vitalistico; e sarà inlui che la linea art nouveau, divenuta ' volumetrica ', aprirà la stra-da all'Espressionismo astratto, attraverso il " Blaue Reiter".
L'architettura art nouveau in Russia contribuisce al superamentodell'eclettismo e al recupero attualizzato e vitalizzato di motivi dellatradizione popolare russa. Gli esempi più autorevoli, in questo senso.
sono dati dall'opera di FI-ODOR O. SHEKHTEL (1859-1926) {StazioneYaroslavl, 1963 e Casa Ryabuchinskij, a Mosca, 1902), dove motivisecessionisti si uniscono a espressioni di gusto tradizionale slavo e amotivi tratti dall'architettura moscovita. Tra gli altri nomi quellodi VICTOR VASNETSOV (1848-1926) autore della Chiesa di Abramtsevo(I890)27.
Per le arti applicate si ricorda, oltre all'opera dello stesso Vrubel edella principessa Tenisheva, quella dello scultore Paul Troubetskoi.Ma il nome che acquistò fama internazionale, superando le frontiererusse, è quello di CARL FABERGÉ (1848-1930), di origine francese,aulore, soprattutto, dì ninnoli vari e di bei gioielli di tipo fitomor-fici lineare, dai colori smaglianti, ispirati, anche a Lalique.
16 Stali Uniti.
Quando Oscar Wilde, nel 1882-1883, organizzò un giro di confe-renze negli Stati Uniti, si espresse con queste parole: " Sento che ilvostro popolo ha bisogno, non tanto di un'arte altissima, immaginifi-ca, quanto di quella che riguarda gli oggetti di ogni giorno... l'arti-giano dipende dalla voslra approvazione e dalla vostra opinione...Il vostro popolo ama Parte, ina non onora abbastanza gli artigia-ni... " 2N.
Ma l'arte applicata americana imitava già. dal 1870. l'arte ap-plicata inglese.
Nella esposizione " The Arts and Crafts movement in America1876-1916", tenuta al The Art Museum della Princeton University(21 ottobre - 17 dicembre 1972), al The Art Institute di Chicago (24febbraio - 22 aprile 1973), alla Renwick Gallcry of thè National Co!-leclion of Fine Arts, Smithsonian Institution (I giugno - 10 settem-bre 1973), lo sviluppo dell'arte decorativa negli Stati Uniti viene di-viso, in rapporto allo stile, in tre grandi sezioni:
1876-1893 Periodo di nazionalismo e di espansione industriale(il 1876 è l'anno della Esposizione di Filadelfia per il centenario del-l'indipendenza americana).
1893-1901 - Periodo che inizia con l'Esposizione Universale diChicago e vede il formarsi delle due linee architettoniche, la primaaccademica, l'altra vòlta al rinnovamento sul filo delle nuove tec-nologie costruttive. Il rapporto con l'Art Nouveau si ha soprattuttocon le due figure-chiave, Louis Sullivan e Louis Confort Tiffatn.Nasce in questo periodo la prima delle dodici società riguardami learti applicate che si formeranno negli Stati Uniti.
1901-1916 - Nascono, nel 1901, il " Craftsman Movement "' e larivista «Craftsman» (che cesserà nel 1916), che saranno il puntodi riferimento dì una intera generazione di designers fedeli alla li-nea geometrica, severa, dell'ultimo Art Nouveau. Intanto, col mo-vimento della " Prairie School ". nasceva la nuova architetturaamericana.
Filadelfia, New York, Boston, Buffalo, e tutta la costa orientaledegli Stati Uniti vedono, dal 1876, il sorgere di un nuovo interesseper il rinnovamento delle arti applicate.
Nascono riviste come « Ladies' Home Journal » e « House andGarden » ( 1901 ). Vi operano, nel campo del mobile, ISAAC E. SCOTI,CHRISTIAN HERTER, CHARLES ROHLFS (autori di mobili che unisconomotivi caraneristici dell'America coloniale a riferimenti " Arts andCrafts '" inglesi), WILL BRADLEY, noto, come vedremo, anche perl'opera grafica (i suoi mobili sono più vicini a quelli di Voysey e diMackintosh), Gustav Sticley (la cui produzione, più tarda, riesce arivitalizzare e attualizzare motivi autonomi, americani) e la curiosa
16 - Siali Uniti.
comunità dei ROYCROFTERS, riunita da Elbert Hubbard.Nel campo del vetro JOHN LA FARGE è noto per i vetri ' opalescen-
ti"; lavorò anche, a Boston, con l'architetto Richardson (vetrateper la Trinity Church); e a New York vivrà lo stesso Louis ConfortTiffany, il personaggio più interessante per Parte del vetro.
Per la ceramica i nomi sono quelli di JABEZ GORHAM (fondatoredella Gorham Manifacturing Company a Providence, Rhode Island),e dello stesso Tiffany.
Quasi tutti questi artisti avevano studiato in Inghilterra o in Francia.
Chicago è l'altro centro di attività artistico-culturale; qui moltiesponenti del movimento inglese, da Crane ad Ashbee, avevanoportato 11 nuovo verbo, in nome, soprattutto, di William Morris.
Vi uscirono riviste importatili (« House beautiful », 1896; «We-stern Architcct». 1902-1931: «Fine Arts Journal», 1899-1919).
I nomi di Louis Sullivan, George W. Maher, dello stesso FrankLloyd Wright, di Frances M. Glessner, costituiscono altrettante tappenell'ambito del rinnovamento delle arti applicate.
La fondazione della " Chicago Arls and Cralìs Society ". del 1897.segnava piuttosto la cristalli/vn/ione del movimento CIIL* non i suoi
16 - Stali Uniti.
inizi, mentre il momento più alto era segnato dall'architettura e dal-le manifestazioni di arti applicate di quella che è stata poi definitala " Prairie School ".
16 - Stali Uniti.
La terza zona è la costa del Pacifico, dove i due architetti CharlesSumner Greene e Henry Mather Grecne diffondono uno stile parti-colare, composito, tra revivalista e floreale.
Altri nomi, quelli di Jewett N. Johnston, di Lucia e Arthur F. Ma-theus.
Anche se, dunque, la sua matrice è innegabilmente europea, siaper ciò che riguarda l'architettura, che le arti applicate, pure l'ArtNouvcau negli Stati Uniti assume aspetti particolari e assai vivaci.Per quanto riguarda l'architettura, comunque, è forse nel modo incui si manifesta a Chicago che si può maggiormente cogliere la suafunzione dì tramite diretto tra i modi tradizionali e quelli dell'ar-chitettura moderna, anche se la sua manifestazione, nello stesso Sul-livan, può sembrare, al primo approccio, quasi soltanto esteriore elimitata al fattore decorativo.
In realtà l'opera di Louis H. SULLIVAN 0856-1924) porta avanti,nella struttura articolata e pura dei suoi edifici, quella chiarezza divisione dinamico-lineare che già, a Chicago. si era decantata e resavitale nel Monadnock Block di John Wellborn Root del 1883. e cheapriva il discorso alla concezione art nouveau dello spazio fondatosul filtro dinamico della luce che, se nel primo Art Nouveau era in-terpretato nell'avvolgimento della linea che chiude e quasi fa tur-binare l'aria, all'interno, per lanciarla verso l'alto, al periodo piùmaturo del movimento si articola (si veda la biblioteca della Scuolad'Arte di Glasgow, di Mackìntosh) in quella scansione lineare, con
16 - Stati Uniti.
intersezione dei piani ad angolo retto, che diverra caratteristica dellavisione costruttivista e, di la, dell'architettura razionale.
L'apporto decorativo di Sullivan si manifest a solo in certi parti-colari in ricche volute e in curve a tensione dinamica, di tipo neo-rococo.come nel Wainwrighl Building a Saint Louis (1890-1891), nelia de-corazione dell'edificio della Carson, Pirie, Scott & Co., di Chicago(1890-1904); altre volte si manifesta in forme di tipo gotico-vegetalecome nel bar e nel teatro fa\Y Auditorium Building di Chicago (1887-1889), nella facciata dei Magazzini Walkers, ancora a Chicago (1888-IKS9). nelle cancellate degli ascensori del Guaranty Building di Buf-falo (1894-1895), ispirati alle decorazioni neo-gotiche di Frank Fur-ness, maestro di Sullivan (e si vedano, a questo proposito, gli splen-didi disegni decorativi di Sullivan). Piu spesso si limita a lievi mo-dulazioni ritmiche, nel cornicione di coronamento, come in quellonndulato, serpentinato, del Guaranty Building di Buffalo (1894-1895).a a profili appena segnati, come quelli delle vaste aperture vetrate.Ma sempre fa parte di una necessita, direi, psicologica, che non per-mctte ancora a Sullivan di mettere al vivo, in tutta evidenza. la strut-tura, che, una volta liberata, sara il segno piu diretto della raggiuntaautonomia linguistica dell'architettura moderna.
16 - Siali Uniti.
Chicago, dopo la distruzione, in seguito al famoso incendio del1871, oltre che a dar vita a] nuovo movimento architettonico colgruppo di architetti facenti capo, appunto, alia Scuola di Chicago(Richardson, John Welborn Root, Le Baron Jenney, Louis Sullivan.Martin Roche, William Holabird, Daniel Burnham), fu anche lasede piii aperta al rinnovamento culturale statunitense.
Vi nacque la rivista « The Chap-Book », che vide le prove grafichepiii interessanti di WILL BRADLEY (1868-1962), ispirate all'opera diBcardsley, ma animate da una propria, vitalistica individuality, come
celebre The serpentine dancer (1894), dedicato alia danzatrice ame-ricana Loie Fuller, che si riduce ad una splendida, macroscopicasigla dinamica.
In questo senso si veda anche, come punto di rilerimento, e comerapporto, la ' linea serpentina ', il ' segno ', dinamico astratto. diBcardsley (1894-1895), da «Insel-Almanach auf das Jahr 1906 »(Lipsia, 1905, pag. 47) che, nella spirale avvolgcnte del fumo di unacandela, trasferisce il morbido, ondoso fluttuar di veli, di una volut-tuosa danza incessante.
16 - Slati Uniti.
Anche il primo WRIGHT (1869-1959), formatosi alia scuola di Sul-livan, Adler, Richardson, a Chicago, non sara esente da riferimenticompositi art nouveau; lo si puo notare nei suoi lavori decoraiivi.nei suoi mobili, ma anche nelle sue prime realizzazioni architetto-niche, fino aWHoiet Imperiale di Tokyo (1916-1922). Si tratta sem-prc. comunque, di riferimenti che egli traspone in termini gcometrico-
16 - Stati Uniti.
ganicistico * lineare art nouveau (con componenti orienializzanti) sitrasformera in istanza ' organica \ trasferendosi da fatto decorativo,esterno, in fattore strutturale, dinamico, di articolazione spaziale.
Nel campo della pittura. un uniecedonte al Simbolismo tin de sic-cle lo si pud riconoscere nel romanlico ALBERT P. RYDER (1847-1917).il cui linguaggio evanescente. sfumalo. legato a temi leggendari emisteriosi, per certi aspetti vicino a quello del francese Odilon Redon.rappresenta un contributo notevole, e di grande anticipazione. a qucllinguaggio lineare art nouveau che non trovera quasi altro riscon-tro piltorico, negli Stati Uniti (quando, per dire, se ne tolga. concadenze diverse, Whistler, peraltro quasi mai vissuto in America),ma che, invece, si concretizzera nel mondo oggettuale. prezioso. diLouis CONFORT TIFFANY (1848-1933). che sara il personaggio piiiautorevole per quanto riguarda la lavorazione del vetro e !e arti ap-
16 - Stali Uniti.
plicate in genere, anche se, come si e visto, non manca in America,in questo campo, un notevole e variato apporto.
Ma 1'importanza di Tiffany, come esponente delle correnti ArtNouvcau in America, supera quella degli altri, anche perche, se purelc sue origini artistiche si rifanno all'Europa, dopo il 1895 sara lasua opera a porsi come uno dei modelli piu seguiti e imitati nellastessa Europa.
Louis Confort Tiffany, prima di occuparsi di arti applicate (suopadre era il famoso gioielliere newyorkese). si dedico allo studiodella pittura (fu per questo a Parigi) e aH'arredamento di ambienti.Trasformo molte ricche residenze americane con un gusto decora-tivo fantastioso, orientalizzante, passando da ricordi moreschi a ri-fcrimenti di gusto giapponese.
E noto il suo Bella-Apartment, a New York, di tipo geometrico-bidimensionale, dove egli inseri, peraltro. mobili di tipo composito,tra cui. gia. qualche sedia Thonet, dalle curve spiraliformi. Creofabbriche che eseguivano i suoi oggetti (mobili, lampade, suppellet-tili). Si dedico poi allo studio del vetro; riusci a realizzare, come gia
16 - Stati Unili.
John La large, un tipo di vetro opalescente. iridato, che brevettoc che uso in lastre, per fineslre, in decorazioni astratte, morbide. fluide.
PiCi tardi studio altre tecniche del vetro, creando i suoi famosi vasiin ' favrile glass' (vetro ' febbrile'. per la continua vibrazione pro-dotta dalle fitte linee interne, mobili, col variar della luce, con effettodi moire, come quello reso dai retini tipografici sovrapposti).
Ma i suoi vetri restano straordinari per lo svolgimento formale:ckiborati secondo una linea ascendente, serpentina. si snodano comeimmagini in movimento. agili, leggeri. vitalistici. 11 riferimento aliad;inza ne deriva spontaneo. La loro superficie e granulosa o liscia.oppure coperta di una patina metallizzata, come i vetri persiani eromani di scavo.
Notevoli anche le sue ceramiche, e le decorazioni in metallo, a fran-
16 - Staii Uniti.
ge, a filigrana sottile. Non molti, ma ' personalizzati', come egliamava definirli. i gioielli che egli realizzo dopo il 1900 per la gioiel-leria lasciatagli dal padre. Piii tradizionali, neH'impostazione. chenon i gioielli, ad esempio, di Lalique, si svolgono secondo geometricsimmetriche. in cui si snoda una decorazione minuta, di tipo fito-morfico, di raffinata esecuzione.
77 - Italia - // Liberty.
L"esperienza italiana art nouveau assume necessariamente unaposizione di minor rilievo rispetto a quella europea in generale, per-che tranne che per alcune particolari manifestazioni, si tratta diun'esperienza di riporto, ritardataria, che sfocera nel ' 900' e nel-I'Art Deco; un 1'enomeno di adesione ad un internazionalismo di mo-da, anche se rispondente ad una reale necessita di superamento delrealismo ottocentesco degenerato in accademia. Al confronto conquelle italiane anche molte manifestazioni ' ininori' di ' moderni-smo ', come gli esempi riscontrabili nei paesi dell'est Europa, rispon-dono ad una diversa interpretazione del ' floreale, che coincide colrisveglio nazionale e favorisce il recupero di fatti decorativi folklori-stici, anche per la sua stessa istanza vitalistica e di sollecitazione dellalibera e spontanea creativita. Cio che, d'altronde, ha in se, in parten-za. la degenerazione del motivo e la sua assunzione ' spuria '. Questoin Italia e assolutamente mancato, perche e mancata una base cultu-rale capace di recepire la necessita, sentita invece dallo stato. di crearsiun prestigio come nazione; prestigic che si manifestava anche nelprodotto da imporre sui mercati stranieri e nel modo di presentarlo;questo spiega la corsa degli stati anche piii poveri ad adeguarsi conmanifestazioni dispendiose e pesanti come le grandi Eposizioni In-ternazionali; e anche perche un tentativo di recupero folkloristico.nella situazione italiana, avrebbe portato soltanto alia glorificazionedi una situazione vernacolare (non di ' cultura ' popolare) contro laquale invece Tesigenza internazionalistica del movimento cercava giu-stizia. Cosi in Italia le nuove esperienze figurative, sorrctte da impli-cazioni ideologiche, promosse e recepite solo a livello di ambienticulturali e, di riliesso, dalla borghesia. non sh'oravano la popola-zione. neppure sul piano del gusto, e non stimolavano recuperi dicreativila uutoctone; che sarebbe forse stato il solo modo di tra-sformarle in espressioni collettivc. In Italia dunque la stagione ' li-berty ' non si e presentata come spinta alia sollecitazione di valoritradizionali (rappresentati, ormai, da una trascrizione accademica emonumentalistica degli ' stili' classici). Questo tentativo era statoappena sfiorato, semmai. daH'eclettismo revivalistico, che contrap-poneva, in termini, pcraltro, troppo spesso vernacolari, la dignita' comunale" del Medioevo agli splendori imperiali di Roma, richiestidal nazionalismo risorgimentale e dalla ' nuova ' Italia.
D'altronde la situazione socio-economica e politica italiana eratra le piii difficili nell'Europa del momento, sia per il travaglio didover comporre in ' unita ' nazionale espressioni tradizionalmentese non etnicamente diverse, gonfiando la piccola struttura ' militare 'piemontese a contenere uno stato unitario; sia anche perche l'ltalia.sia pure con dislivelli di regione in regione. era tra le nazioni menosviluppate industrialmente in Europa.
D'altra parte il patto della Triplice Alleanza del 1882 aveva por-tato in Italia capitali tedeschi e austriaci. subito investiti in impreseindustriali e nella speculazione edilizia che vide la distruzione dellacompagine unitaria del centro storico di Roma, a cui contribuirono.in ambigua concordia, interessi privati, politici, curiali. E a\e\a por-
17 - Italia - II Liberty.
Kilo la necessita di un allineamento di gusto con le ultinie espcrienzedelle Secessioni; che si affiancava, e allo stesso tempo entrava in con-flilto. con la cultura letteraria, che gia si era staccata. in effetti. dal' rcalismo '. anche se ne aveva mantenuto, modificandole. Ic istanzeMK'iali, per una adesione piu sottile al Simbolismo europeo.
Per le arti figurative una prima adesione si manifesta nella forma-/ione. a Roma, del gruppo " In Arte Libertas ", Condato da NinoCosta nel 1885 e imbevuto delle ideologic morrisiane e delle tematichepivraffaellite; ne usciranno artisti come Giulio Aristide Sartorio.Hdoardo Gioia; e i suoi rapporti con gli artisti delle altre regioniiialianc. da Segantini a Previati. a Pellizza, a Morbelli. a De Carolis.a Chini, saranno diretti e significativi.
17 - Italia - I! Liberty.
Anche se non riusciranno a far scattare il ' modernismo ' italiano(nella sua connotazione ' liberty', come fu definito in Italia a livellodi termine comune), da una sua esteriorita e incertezza dovute amancanza di una adeguata e generalizzata preparazione teorico-culturale. Di questo tipo sara, ad esempio, l'adesione ' liberty" diD'Annunzio. Mentre meno ' estetizzanti' saranno le adesioni a sfon-do moraleggiante e ' spiritualistico' di Fogazzaro, di Gozzano eperfino, nel senso delta promozione sociale. di Giacosa. Invece laversione piu intimista. di piu profonda cultura letteraria e poetica(con rapporti diretti coi parnassiani francesi e coi simbolisti interna-zionali), anche col limite di una maggiore evasivita nei confrontidellc ideologic si avra nella raffinata trascrizione poelica di un DcBosis, di un Onofri, di un Corazzini, nella delicata visione lirica dcllaGiaconi, e nomi come quello di Dino Campana entreranno solo perinciso, quasi per assonanza, in un'area di vago riferimento art nouveau.
Un cenno andra fatto al teatro borghese, di istanza sociale (d;iGiacosa a Sem Benelli a Niccodemi). da un lato, al melodrammadall'altro. che trova in Puccini accenti legati al postromanticismoaccanto ad estetismi floreali e orientali/zanti.
La complessa, involuta situazione di questo momento italiano esalita agli onori della storiografia artistica da pochissimi anni, e sol-
17 - Italia - II Liherly.
tanto per merito di studiosi italiani (non esiste trattazione generalestraniera. sull'Art Nouveau, che abbia affrontato sistematicamenteanche il tema italiano). Oggi siamo, in Italia, come ha dimostratoil Convegno Internazionale " Situazione degli Studi sul Liberty "dcll'ottobre '74. in piena fioritura di questi studi e un grosso pro-gctto di " Archivi del Liberty italiano" e in via di realizzazione: sirecuperano documenti importanti, facendo giustizia, anche col ri-schio di peccare, talvolta, di eccesso e di sproporzione, di un lungosilenzio c di una grossa lacuna.
La dimensione di questo lavoro non permette di trattare esaurien-lemente I'argoment'o. Ci limiteremo ad una presentazione parziale.esiremamcnte sintetica, degli aspetti piii acquisiti della manifesta-/ione italiana, per centri di irradiazione o di confluenza. e attraversole personality emergenti.
Da evidenziare l'importanza dei testi critici del tempo, e I'azionepromozionale delle riviste, da « Arte utile », di Alfredo Melani (dal1890), a « Arte italiana decorativa e industriale » di Boito. seppureimpostata sulla difesa della tradizione; a « Emporium », dell'lstitutodi Arti Grafiche di Bergamo (dal 1895); a « L'Arte aristocratica » diVitlorio Pica, a « L'Arle decorativa moderna » (dal 1902), di Melanie Thovez, di Torino, a « II giovane artista moderno » (Torino, 1902).•A « L'architettura italiana » (1905); a "Italia che ride » (Bologna.1900). che, nella sua brevissima vita, di sei numeri. fu teatro dellepiu importanti esperienze grafiche del momento, allineate su posi-zipni di un internazionalismo laico, socialista, contrario alle modedecadenti di ispirazione prerafTaellita; all'albo « Novissima » diretloda Edoardo De Fonseca {Milano e Roma).
Gia la citazione delle rivisle permette di cogliere la dislocazioncdelle principali manifestazioni di liberty italiano: Torino, Milano.Roma, Emilia-Romagna...
Torino fu dunque il primo centro di irradiazione del Liberty; siaper quanto riguarda l'architettura che le arti applicate; non a casovi si svolse I'Esposizione Internazionale del 1902; e in questa occa-sione che l'opera di RAIMONDO D'ARONCO (1857-1932), autore delpadiglione centrale della Esposizione e di altri edifici niinori. si ma-nifesta in una nuova dimensione, che lo trova completamente liberoda medievalismi romantici (ancora presenti nella Porta Terraglia di
17 - Italia - II Liberty.
Milano. da lui sistemata nel 1882). da recuperi stilistici e da eclettismi(facciata del padiglione della I Esposizione di architettura di Torinodel 1890 e progetto del Ponte Maria Teresa). La sua perfetta adesioncalia linea delle Secessioni si esprime nei lavori per I'Esposizione del1902 e per quella di Udine del 1903, con una carica vitalistica festosa,inventiva, che egli non ritrovera piii, complicandosi poi, il suo stile,atlraverso i suoi molti lavori a Costantinopoli, di componenti orien-talizzanti, di nuovi eclettismi, di pesantezze '" riuscendo a legare perforza di talento i due estremi di una delle piu ambigue antinomie delLiberty: il frivolo e il funereo. lo stile di stazione termale e quello dicimitero " ". Argomenio, questo toccalo dalla Bossaglia. quasi de-terminante per ritalia.
Pure a Torino lavoro PIETRO FENOGLIO (1865-1927) di cui restadocumento basilare la propria abitazione in Corso Francia (1903),tra le poche, in Italia, notevole non solo per la decorazione di fac-ciata, ma per 1'articolazione strutturale e volumetrica. Fenoglio, dopoil '20, viste svanire tutte le speranze di rinnovamento e di soluzionedei problemi italiani. rinuncio del tutto al suo lavoro. chiudendosiin un isolamento scontroso.
17 - Italia - II Liberty.
Tru gli allri architctti operanli a Torino e in tutto il Piemonte (sivedano gli studi di Mila Levi Pistoi e di Pietro Tarallo nella rivista« Piemonte») Antonio Vandone, Alfredo Premoli, Giovanni Gri-bodo. Annibale Rigotti, Pietro Betta, Vittorio Ballatore di Rosana.Gottardo Gussoni, E. Velati Bellini, contribuiscono a creare. a To-rino, una immagine urbana tra le piii legate ai canoni del migliore
17 - Italia - II Lihem:
Art Nouveau europeo.II contributo dello scultore ALLOATI per i rilievi e di ALESSANDRO
MAZZUCOTELLI (1865-1938) per i ferri batluti a carattere fitomorfico.di straordinaria dinamicita espressiva, spesso contribuisce a definireplasticamente e vitalisticamente gli edifici. Mazzucotelli aveva acqui-stato rofficina di Defendente Oriani di Milano dal 1891 e i suoi la-vori, sparsi in tutta Italia (dalle Terme di Salsomaggiore a Milano.a Torino a Busto Arsizio...) rappresenlano un apporto notcvole alia
deiinizione del miglior Liberty ilaliano.Di Premoli, piu legato ad un decorativismo lineare bidimensionalc
citiamo la sede della FIAT a Torino in Corso Dante. II tema ' edi-ficio industriale ' acquista particolare risalto per una sua nuova sim-bologia tecnologica, che in Premoli, peraltro, si mantiene in unadimensione di correttissima misura.
17 - Italia - I! Liberty.
Rigotti. oltre che a Torino, lavoro a Ctigliari (Palazzo Comimale.1914) e a Bangkok (Palazzo del Trono col decoralore e ceramistatoscano Galileo Chini).
17 - Italia - II Liberty.
II Liberty lombardo trova in GIUSEPPE SOMMARUGA (1867-1917) unadelle espressioni piu complete (Palazzo Castiglioni, 1903). nella tra-scrizione simbolica dell'impianto volumetrico, nell'uso dei material],negli elementi decorativi, dove il bugnato conferisce un significatoplastico particolare alia superficie, rimandando, con estrema libertae attualizzazione, anche ad elementi di tradizione storica, rivissuticon una grande carica espressiva.
Di lui e anche la bella Villa Romeo (1908), oggi Clinica Columbus.Alfredo Campanini, G. B. Bossi, Luigi Broggi. sono altri esponenti,a Milano, dell'architettura liberty. Quasi dovunque i ferri di Maz-zucotelli aggiungono, neH'intrico floreale, una forte accentuazionevitalistica. A Milano lavorarono anche Sebastiano Locati e GinoCoppede, che esegui dei lavori per la Esposizione Internazionaledel 1906, in occasione dell'apertura del traforo del Sempione. E intutta la Lombardia (si pensi alia campagna di Varese, dove rultimaguerra ha distrutto intere zone residenziali liberty). Da citare ancheil fiorentino Ulisse Stacchini, vincitore, nel 1911-1912. del concorsoper la Stazione Centrale, realizzata nel 1925-1931. e quello del Ci-initera di Monza.
Per GINO COPPEDE (1886-1927) l'interesse si sposta da Milano aGenova (Castello Mac Kenzie, 1890), dove lavorano anche Guz-zoni (Casts Zanelli, 1908) che opera anche ad Alassio. Dario Car-bone (progelto per il palazzo della Borsa, 1912), Giuseppe Breganle;ma 1'esperienza di Coppede si realizza piu compiutamente a Roma,dove egli crea un intero quartiere ecletticamente complesso, doveun medievalismo toscano di maniera si unisce a elementi decorativiorientali dell'antico folklore europeo, del monumentalismo classicoc rinascimentale. in una sintesi assurdamente spaesante, forse perqucsto non priva di un suo fascino particolare.
A Roma lavorano anche il palermitano Ernesto Basile (la cui at-livita piu importante si svolse, come vedremo, in Sicilia); mentrek sue realizzazioni romane, tra cui I'edificio di Montecitorio, per-dono. nella variazione di scala e neli'impegno rappresentativo, illoro rapporto stilistico) e Giuseppe Sommaruga (villa Aletli, 1897,dove non raggiunge la carica espressiva che tocchera nelle operemilanesi).
17 - Italia - II Liherlv
L'ambiente culturale bolognese fu molto aperto a istanze interna-zionali, con accesi accenti ideologic!, antidecadentisti (si e accennaioalia rivista « Italia che ride »). Vi lavoro l'architetto milanese PAOLOSIRONI (1858-1927) che, acquistata una tenuta agricola, tra via Co-sta e via Saragozza la lottizzo popolandola di villette liberty. Mala presenza, ad un certo momento della sua attivita, di De Carolis.che affresco il palazzo del Podesta (1911-1928), apportandovi il peso
17 - Italia • II Lihem:
.lo) suo michelangiolismo di maniera (tra i collaborator! il ratlinato,intimista pittorc e decoratore fiorentino, Giuseppe Lunardi) con-uibui al rifiuto. da pane della cilta. di un'espansione miissificahi illjlcmcnti ardiitetlonici liberty. A Bolognu hivoro. sia pure tardi. an-:he Bistolfi {momtnwnto a Omiitcci).
A Napoli I'ambicnlc culturale era vivace e consapevolmente ricet-livo allc sollecitazioni artistico-culturali internazionali; 1'apporto cri-lico di Vittorio Pica e di Giovanni Tesorone contribui alia spintaper la dilfusione di nuove idee, particolarmente per quanto riguardule arti applicate. In questo clima sorgera, nel 1882, il Museo Indu-siriale, con lo scopo di raccogliere le piu important! realizzazioniitaliane e straniere del settore.
Tra gli architetti: G. B. Comencini (veneto di origine), si distinseper la raffinata e organica sistemazione di interni (Hotel Londru,1899; Hotel Santa Lucia, 1906); Francesco De Simone (palazzimtVelardi), Leonardo Paterno Baldizzi (casa Marotta), Michele Capo(villa Cuomo), Gregorio Botta {villa Pappone), articolano plastica-mente e asimmetricamente lo spazio architettonico. II nome piu notoc forse quello del piacentino GIULIO U. ARATA (1881-1962), autoredel palazzo Mannajuolo, 1909; lavoro anche alle Terme di Agnano.1919, e si distinse per la vivace, eccitata magniloquenza plastica nellamodellazione esterna.
17 - Italia - II Liberty.
A Palermo l'attivita modernista si incentra soprattutto nel nomcdi ERNESTO BASILR (1857-1932), la cui profonda cultura c la cui co-noscenza delle tradizioni siciliane, lo condurranno da un classicismoquattrocentesco al floreale, fino all'acquisizione di una libera auto-nomia di linguaggio e ad una interpretazione particolare del rapporloarchitetlura-decorazione, che lalvolta privilegia eccessivamente la se-conda, che caratterizzera soprattutto i suoi interni, da quello delVMino Florio (1899-1903), del palazzo Utveggio (1901-1903), di villaIgea (1899-1903), fino ai molti allestimenti espositivi. Si manifestedanche nella vivace creativita espressiva degli arredi, che si definiranell'incontro con Ducrot, della cui ditta Basile diverra il designerunico, e coi pittori De Maria Bergler e Gregorietti e con lo sculto-re Ugo.
A Palermo e a Catania lavorarono anche architetti come VincenzoAlagna, Ernesto Armo, Salvatore Benfratello, Tommaso Malerba.Francesco Fichera e Gaetano Geraci.
17 - Italia - II Liberty.
La Toscana offriva ampio margine ad effusioni liberty nelle sta-zioni balneari, dove l'adesione a modi vagamente internazionali ser-viva come dimostrazione di prestigio e contribuiva a creare ambientidiversi da quelli consueti delle citta, quindi distensivi (come del re-sto le stazioni termali) e ' vacanzieri\ Percio Viareggio, Forte deiMarmi e tutta la Versilia (ma anche molte citta dell'interno, da Luccaa Pistoia) offrono molti esempi, spesso notevoli, di architettura libertvA Firenze, dove riviste come « Leonardo », « Hermes », « I] Re-gno », riaffermavano, in nome del ' genius loci ', di un ideale classicoampiamentc e da secoli tradito, le regole di un conformismo monu-mentalistico, ancorato ad una situazione di chiusura provinciale. l'af-
lazione del nuovo stile sa di audacia, di avventura, di rischio.L'architetto GIOVANNI MICHELAZZI (1876-1920) e il solo che motiviulturalmentc la sua straordinaria fantasia creativa; una fantasiahe gli permette di tradurre in autenticita di linguaggio una sua con-lapevolc meditazione di Olbrich e degli scritti di Wagner, filtrataittraverso la lezione plastico-lineare di Horta; si vedano, soprattutto,
illino Caraceni di Firenze, svolto secondo una dinamica plastic;*
17 - llalia - II Liberty.
tulia guidata e modulata, nell'articolazione dello spazio interno (adoppio volume attorno alia scala circolare, illuminata dal lucerna-rio. dominato dalla ragnatela in ferro - che incastona i veiri - diun grosso ragno in posizione decentrata); articolazione resa evidente.all'esterno, nelle masse aggettanti e nella curvatura dei piani d'an-golo, sottolineati dalle ceramiche di Galileo Chini, non " aggiunte '.ma connalurate all'articolarsi dei volumi, e dagli slucchi di AngioloVannetii. Anche la casa-galteria di Borgo CJgnissanti, da poco tempoa lui confermata (Carlo Cresti), uno dei pochi esempi di infiltrazioncverso il centro storico del nuovo stile, relegato. generalmente, nellezone di recente espansione edilizia, inserita nello stretto spazio tradue edifici, evidenzia, nella tensione dinamica della facciata, la vio-lenza del suo inserimento, nelle linee marcapiano ricurve, quasi ba-lestre in tensione sul punlo di scattare e nelle esplosive emergenzeplastiche. II fatto che, poco dopo il ritorno dalla guerra. nel '20. Mi-chelazzi si sia ucciso. dimostra quanta delusione gli abbia creato1'involuzione accademica e ufficializzata dall'acquisizione liberty.ormai abile strumento di potere e di speculazione. lino a far si cheuna trisle situazione familiare sia stata sulriciente a far ' trabiKcart;il vaso ' della sua condizione di infelicita.
Altri nomi a Firenze, per l'architettura, quelli di Adolfo Coppede.Enrico Dante Fantappie, Paolo Emilio Andre, Ugo Giusti. TuttiTacenti parte di un gruppo artistico. di cui le figure di Michelazzi edi Chini rappresentano il fulcro, tutti di minore forza culturale. ri-spetlo a Michelazzi. pur nella generosa e coraggiosa volonta di rot-tura, e percio piu facilmente preda di proccssi involutivi.
Si aggiungano i molti casi particolari nella provincia italiana; daquello di ANTONIO SANT'ELIA (1888-1916), la cui prima produzione.dal 1905 al 1910-1911, si svolge tutta all'insegna del gusto secessio-nista, arricchito da una meditazione diretla sul lavoro di Olbrich,e, anche per lui, sui testi di Wagner. 11 suo successivo scatto nei modidel ' futurismo', resta una ulteriore conferma di quanto lo stessoFuturismo debba alia ' linea dinamica ' dell'Art Nouveau. II lavorodel primo Boccioni e I'entusiasmo dei futuristi per Previati ne sonouna prova.
Un altro importante documento, assai piu perspicuo di quelli la-sciati dallo stesso architetto a Milano, e la Cenirale eletlrica di Trez-zo d"Adda (1906) di GAETANO MORETTI (1860-1938), uno degli esempipiii interessanti di raffinata trascrizione composita di morfologieorientali e secessioniste arricchito anche da una sensibilita * pitto-rica ' nell'uso della grana policroma del materiale.
La villa Ruggeri di Pesaro (1902-1907) e Fespressione della volon-ta di un committente che riusciva ad imporre all'architetto pesareseGiuseppe Brega la sua idea di rappresentativita simbolica e le fan-
17 - Italia - II Liberty.
tasiose reminiscenze dei suoi viaggi, nci quali egli cercavu moduliper la sua ditta di ceramiche; con un risultato avvincente. pur nellaenfatica e carica vitalita espressiva.
A Trieste da citare I'architetto Zaninovic, esempio notevole di ri-cerca autonoma, isolata, fuori dalle linee ripetitive della ufficialiui.continuamenle ostacolata dalla situazione locale.
Guido Costante Sullam. nella villa a Venezia-Lido, riesce a svol-gere con chiarezza espositiva le citazioni sco?zesi e austriache, e avitalizzare il repertorio decorativo caratteristico della gratica e dellupittura simbolista e art nouveau (come il motivo del pavone e quellofloreale) neH'andamento della scala interna, nelle belle decorazioniceramiche e nell*arioso uso del ferro dei fastigi.
Si aggiungano esempi, spesso anonimi, in tutto il Veneto; per altriesempi in Italia, abbiamo gia accennato ai Cimiteri monumentali(Milano, Genova) e alle stazioni termali (Salsomaggiore, San Pel-legrino, Montecatini...).
Per quanlo riguarda I'apporto italiano al rinnovamento dclle artifigurative i nomi piu noti sono quelli di GAETANO PREVIATI (1852-1920), di GIUSEPPE PELUZZA DA VOLPEDO (1869-1907), di GIOVANNISI-;GANTINI (1858-1899), dell'area lombarda, ma partecipi di fermentidi diverse aree culturali, anche italiane, e soprattutto aperti ai pro-blemi internazionali; che trovano nel Simbolismo momenti di in-lenso significato: Previati nella linea mistico-simbolica; Pellizza in-teressato soprattutto al significato simbolico-ideale della luce e aper-to a istanze ideologico-sociali di derivazione preraffaellita; Segan-
in termini di allegoria mistico-letteraria. A Milano lavoro anchelo scultore ADOLFO WILUT (1868-191!), il piu ' purista * e astrattodegli scultori del momento, nella sua raggclata c tesa lucidita di su-perfici. .:
NelPambito torinese i nomi di Agostino Bosia, di Mario Revi-glione, di Edoardo Rubino e. per qualche tempo, del fertilissimo' poeta della morte ", come fu definito, lo scultore LEONARDO BISTOL-PI (1859-1933) e, per quanto riguarda la decorazione in ferro, delmilanese Mazzucotelli, contribuiscono a dare della citta un'immagineinternazionale.
A Treviso. in isolata chiusura, visse ALBERTO MARTINI (1876-1954),che elaboro un suo particolare linguaggio grafico, di un simbolismoerotico e virtuosistico, con intonazioni sadico-macabre, che ne fa-ranno uno degli idoli dei surrealisti.
17 - Italia - // Liberty.
A Roma, attorno al gruppo " In Arte Libertas", fondato da Co-sta, di cui si e detto, emergeranno ARISTIDE SARTORIO (1860-1932).che, come ALBERTO DE CAROLIS (1874-1928), volgera verso un mo-numentalismo estetizzante, espressione di vanaglorie ufficializzate. Aparle. la figura di DUILIO CAMBELLOTTI (1876-1960), oscillante traun antidannunzianesimo (e anti-art nouveau) di ispirazione socialee indulgenze verso manierismi decadenti, noto soprattutto per la graficae per le arti applicate.
17 - Italia - 11 Liberty.
Per la Toscana abbiamo gia citato il nome di GALILEO CHINI (1873-1956), che abbiamo visto assiduo collaborator di architetti (da Mi-chelazzi a Firenze a Rigotti in Siam), soprattutto noto per l'arte ce-
17 - Italia - II Liberty.
1NCIPHOTWAM0RIS
ramica (i suoi vasi sono tra le espressioni piu notevoli del Libertyitaliano, sia per la straordinaria ricchezza di elaborazioni tecniche,sia per la composita fantasiosita della decorazione orientalizzante),
17 - Italia - II Liberty.
per ]c decora/ioni piltorichc a caratterc klimtiano eseguite per unasala dclla Biennale di Venezia del 1914 (nel 1909 aveva realizzato tedecorazioni per la cupola del Salone centrale). Nell'opera pittoricail ritorno dal Siam segnava I'inizio di una involuzione naturalisticac postimpressionista di cui la sala della Biennale e tra le poche ec-cezioni.
A Venezia, nell'ambito di Ca' Pesaro, attorno alia figura cataliz-zante di Gino Rossi, peraltro pochissimo partecipe dell'area libertynel suo lavoro, una serie di personaggi, tra i quali il raffinato VITTO-RIO ZECCHIN (1878-1947), che trae dalla pratica velraria il rutilanie' corpuscolarismo' klimtiano. l'uso del colore luminoso. l'atmo-sfera favolosa; altra presenza e quella di Teodoro Wolf Ferrari, che.
17 - Italia - I! Liberty.
da una pittura un po' cclettica. passava con sempre maggiore interessealle arti applicate.
Da citare, a Verona, dove dal 1910 viveva Casorati (e nel suo am-bito) Guido Trentini. Romolo Romani, vicino a Previati, svolgevafrattanto a Brescia un suo discorso, soprattutto grafico, di uno stranosimbolismo astratteggiante.
I nomi di FELICE CASORATI (1883-1963). che dal 1910, a Verona,sperimenta e medita motivi vagamente klimtiani, come mezzo disollecitazione a ipotesi di rinnovamento (e li abbandonera prestoper I'acquisizione di una sua particolare, solenne monumentalitametafisica), di LORENZO VIANI (1882-1930), di UMBERTO BOCCIONI(1882-1916). entrano marginalmente nella sfera liberty per una loroiniziale adesione simbolista, come mezzo di rottura con la tradizione;ed evolveranno verso strade diverse, personali.
17 - Italia - II Liberty.
Per le arti applicate ai nomi di Chini, di Zecchin, di Wolf Ferrari.di Basile, di Mazzucotelli. si aggiungono quelli di Umberto Bel-lotto, veneziano, per I'arte del ferro battuto; di BENVENUTO BENVE-NUTI, livornese, pittore divisionista, allievo elettivo di Segantini,noto anche come decoratore; di CARLO BUGATTI (1855-1940). mila-nese, creatore di mobili di gusto eclettico, con motivi giapponeseg-gianti. caratterizzati da un elemento costante, una grande ruotain rame che unifica forme e volumi in una sfrenata fantasia decorativa:di Giacomo Cometti, torinese, di EUGENIO QUARTI (1867-1931). sco-perto a Milano da Grubicy, autore di mobili e di arredamenti di gran-de fantasia, sovrabbondanti di motivi ornamentali e di ricamate ef-florescenze asimmetriche; di Antonio Ugo, collaboratore, a Palermo,di Basile; tra i nomi delle ditte che portano avanti e diffondono inuovi moduli decorativi l'officina Beltrami, di Milano, nota per levetrate decorative, la ditta Calderoni, nota a Milano per l'oreficeria.la ditta Golia & C, poi Ducrot, di Palermo, che realizza i modelhdi Basile, la Societa ceramica di Laveno, la Societa ceramica Richard-Ginori di Doccia, presso Firenze, la Societa fiorentina dell'Arte dellaceramica, fondata da Galileo Chini, la fabbrica di mobili Girard &Cutter di Firenze, la fabbrica milanese di mobili di Carlo Zen. lapiii floreale del repertorio italiano. Da ricordare anche la " AemiliaArs ", la societa bolognese costituita da un gruppo di nobili e di ar-
17 - Italia - 11 Liberty.
listi, col programma di rinnovare le arti applicate; notissimi, dellasua produzione, i bei ricami flbreali e molte realizzazioni di arredi,dalle vetrate alle decorazioni in ferro, alle rilegature, ai cuoi sbal-
17 - Italia - // Liberty
zati, di gusto eclettico, ma sempre di grande qualita di realizzazione.Di grande rilievo, anche in Italia, e legata alia diffusione delle nuo-
vc fabbricazioni periodiche, la grafica editoriale e pubblicitaria, chepresenta una quantita di realizzazioni di grande vitalita e vivacita
17 - Italia - // Liberty.
di resa e una, notevole autonomia, malgrado i riferimenti stranicri.Tra i nomi che ci limitiamo a citare (abbiamo gia fatto quelli di
De Carolis e di Arturo Martini), emergono MARCELLO DUDOVICH(1878-1962), autore. tra l'altro. della pubblicita del Uquore Strega(1905) e del Cordial Campari (1913); LEOPOLDO MLTLICOVITZ (1869-1944), graphic designer della Ricordi, con Mataioni, Hohestein;PLINIO NOMELLINI (1866-1943). nolo anche come pittore postmac-chiaiolo, e per un certo periodo simbolisla; ALEARDO TERZI (1870-1943), palermitanp, che realizzo molta grafica editoriale e fu tra ipiii assidui collaborator! grafici di «Novissima»; LEONETTO CAP-PIELLO (1875-1942), noto cartellonista, collaboratore anche, a Parigi,di varie riviste.
18 - Ascendenze e proiezioni dell'Art Nouveau.
Per quanto riguarda una delle angolazioni piii produttive per unarevisions critica attualizzata dell'Art Nouveau, mi scmbra uiile ri-proporre la puntualizzazione di alcuni motivi che diano modo ditrarre le conseguenze, di tirare le somme sul significato del movimentostesso, in proiezione.
A dimostrazione di come I'Art Nouveau, sia pure nella sua condi-zione, in fondo, minoritaria, e pure non sviluppandosi nelle acca-demie o nei Salons (va ricordato ancora che, fino a pochi anni fa,non solo nei manuali scolastici, ma neppure nei testi di storiografiaartistica si faceva cenno al movimento), si e introdotto, attraverso1'ambiente, dalla casa alia citta al territorio. nella vita quotidianadell'uomo, ed e stato, comunque, la prima delle avanguardie delmondo contemporaneo; ed ha poi nutrito di se gran parte dei movi-menti che gli sono venuti dietro; e. a guizzi e a ritmo alterno, la suaincidenza si e fatta sentire fino a tempi recentissimi.
Se nc escludono del tutto {ed c un fatto estremamente chiarifica-torc) il movimento dada e, per l'appunto, il momento artistico at-lualc, che. non a caso, prende proprio avvio, per molti aspetti, daldadaismo; si tratta, dunque, dei due momenti per i quali la codi-ticazione del concetto di * arte" (rimasta, comunque, pressoche in-variata negli altri movimenti di avanguardia) e stata radicalmentescardinata, anche se dando luogo, sia pure a rovescio e con l'intentodi ' s-definire ' il concetto stesso di ' arte', ad un nuovo tipo di co-dificazione. E poiche I'Art Nouveau si propone, come si e gia detto,come " stile ornamentale ". vorrei partire dal concetto di " ornamen-to ' per riuscire a cogliere i momenti in cui questo tipo di ' inquina-mento ', di ' alterazione ', si insinua, diretto o mediato. ' alterando *,appunto, certi fatti, e, a sua volta, deformandosi.
E poiche si e fatto coincidere il concetto di ' ornamento ' art nou-veau con la sua configurazione ' lineare ', e sulla * linea ', sulla suadeformazione e trasformazione. che vorrei analizzare, in progres-sione, lo svolgersi dei fatti.
Considerando, dunque, il percorso di quel filo sotterraneo di cuidicevo, i primi riferimenti visivi consisteranno nei mettere in luce ilpassaggio dall'Art Nouveau all'Espressionismo; passaggio comples-so, teso, di rottura e di opposizione, ma svolto sugli stessi elementi,proprio sulia linea che, da morbida, nervosa ed elegante, si lorce. siincrespa, da arcuata si fa acuta, si spezza, si avvolge in drammaticicoinvolgimenti.
Per quanto riguarda la pittura basta passare da Van Gogh, comepremessa (e si ricordi il rapporto gia messo in evidenza - pag. 176 -
IS - Ascendenze e proiezioni dell Art Nouveau.
ira il ' segno ' di Van Gogh e quello di un certo periodo di ThornPrikker e di Van de Velde), a Munch (si e vista la forza dranimaticaespressa, come ne " L'urlo " di Munch, nell'immagine di un caminodi Casa Mila di Gaudi, che pure si origina dalle componenti geo-metriche di tanti parabolidi - pag. 194 -) per capire come il passag-gio dall'Art Nouveau all'Espressionismo si coglie alFinterno dellavoro di alcuni artisti (da Kokoschka a Schiele a Munch), in cui lalinea si torce, si acutizza, si rompe, in una tensione drammatica.
Per Tarchitettura si pensi, ancora, alia copertura di casa Mila (1905-1910) di Gaudi, in cui gia la superfine e ' in tensione '. quasi ottenutasu una struttura interna attorta secondo un movimento a spirale. sucui sia stata prodotta una sorta di colata lavica, come nella torreFinstein di Mendelsohn, del 1919-1923 (e come in esempi assai piiirecenti di espressione plastica...).
Oppure si veda il Goethenaeum di Dornach dell'architetto-teosofoRudolf Steiner (1925), che unisce alia tensione del blocco compatto.di carattere espressionista, la liquida sinuosita della linea art nouveau.Si osservi anche, di Poelzig, il Festpielhaus di Salisburgo (1920). incui la curva netta, segnata da linee fitte e ritmate, si articola e si in-crespa; fino al teatro di Luckhardt, del '22, dove tutte le curve lineansembrano aprirsi a scatto, ad angolo acuto, da una cerniera centrale.
11 passaggio dal tardo Art Nouveau al Costruttivismo si coglie.come gia abbiamo fatto notare (pag. 154),* attraverso ta Bibliotecadella Scuola d'Arte di Glasgow di Mackintosh, dove le linee gia siincrociano nettamente ad angoli retti.
Dando per scontate le diverse implicazioni ' simboliche * dei duemomenti e le diverse confluenze di motivi, non si puo negare che diqui si apre la via verso Parchitettura ' razionale ".
II modificarsi della tensione della linea potrebbe esser seguito ai-traverso tutti i movimenti delle avanguardie storiche e dell'arte con-temporanea, dall'Espressionismo all'Espressionismo Astratto al ge-stualismo dell'Action Painting, dal Futurismo al De Stijl, a cenoSurrealismo.
Si puo arrivare, addirittura, al gioco grafico-lineare di un settoredelFArte Programmata, verso il '60, incentrato sul ritmo lineare chesi dilata, si contrae, si moltiplica.
Si tratta, comunque, di un filo conduttore che resta, quasi sempre.sotterraneo, anche se avvertibile e, sia pure, ' alterante '.
Un discorso possibile sulla piu diretta attualizzazione della poeticaart noiivoau, come costituente del concetto basilare di ' design ' insenso moderno, come mezzo di integrazione sociale, porterebbe assailontano ed implicherebbe componenti contraddittorie. su temi cheesulano da questa trattazione- Basti ripetere come, per la prima volta.con l'Art Nouveau, la produzione artistica sia considerata una dellefunzioni della societa.
Con tutti i rischi e i pericoli ai quali la stessa Art Nouveau nonsfugge e ai quali, come sappiamo, non e sfuggita nessuna delle ten-denze che si sono poste su questa base (compreso, e ne abbiamo leprove recenti, lo stesso ' design ').
NOTE AL TESTO
1 - p. PORTOGHESI, L'impegno delle nuove generazioni, in " Aspetli dell'Arte contemporanea ",L'Aquila, 1963.2 - B. ZEVI, « L'Architetiura », n. 47, settembre 1959.3 - B. ZEVI, L'andropausa degli architetti moderni iialiani. in « LArchitetlura ». n. 46. ago-sio 1959.4 - P. PORTOCJHESl, op. fit.5 - T. w. ADOKNO, Societa - Critica delta calarsi; patchitineritt e volgattw. in " Teoria csteti-ca" , Francoforte 1970; Torino 1975.6 - A. HAUSER, // Manierismo, in " Storia sociale deii'Arte "', vol. I, Monaco, Torino, 1956.7 - M. MCLUHAN. Sfida e crollo - La nemesi delta treativita. in " Slrumenti del comunicare ".New York, 1964; Milano, 1967.8 - Si vedano gli interventi di G. C. ARGAN in " Atti del Convegno lnlernazionale critici e slu-diosi d 'ar te - \ San Marino, 1966.9 - R. SCHMUTZLER. Origini dell'Art Nouveau - William Blake, in " An Nouveau '", Stoccarda,1962; Milano, 1966.10 - s. TSCHUDI MADSEN, U tenderize art nouveau nella pitlura. in " Fortuna dell"Art Nouveau '".Milano, 1967.11 - M. LEVL PISTOI, Implicate aslratte dell'Arl Nouteau, in .< Comunita n, n. 134/135; novem-bre-dicembre, 1965.12 - M. BORTOLOTTO, Schdnberg. il liberty e fesoterismo. in " XXVII maggio musicale fioren-lino - L'Espressionismo ", Firenze, 1964,13 - F AHLERS-HESTERMAN '" Stilwende- Aufbruch der Jugend un 1900", Berlino 194114 - T. BORSI-P. PORTOGHESi, // Imguaggio di Horta. in " Victor Horta ". Roma, 1969.15 - S. TSCHUDl-MASDEN, op. Clt.16 - F. BORSL-P. PORTOGHESI, La formazione. in " Vjclor Horla ", Roma. 1969.17 - F. BORSl-P. PORTOGHESI, Op. cil.18 - catalogo " Bruxelles 1900" (a cura di F. WIRSI, R. L. DELCRUV, H. witstK-bESEDETTi. Bru-xelles, 1972).19 - F. ALISON, - Le sedie di Charles Rennie Mackintosh ", Lissone. 1973.20 - R. MACLEOD, "Charles Rennie Maekiniosh", Middlesex, 1969.21 - R. BARILLI, "11 Libeny ", Milano. 1966.
23 - a. c. ARGAN, in " L/Arte moderna 1770-1970". Firenze. 1970.
25 - R' SCHMUTZLER, op. cit.
26 - A. DEL GUERCIO, " Le avanguardie russe e sovietiche ", Milano, 1970.
detnismo' a Pietroburgo, negii Alti del Convegno lnternazi'onale '* Situazione degli studi sulLiberty ", Salsomaggiore, 1974.28 - R. JUDSON CLARK, "The Arts and Crafts Movement in America 1876-1916": catalogodell'Esposizione, Princeton, Chicago, Renwick, 1972-1973.29 - R. BOSSAGL1A. " I I Liberty in Italia"'. Milano, 1968.
REGESTO BIOGRAFICO E CRITICO DEGLI ARTISTIE TESTIMONIANZE CR1TICO-LETTERARIEDEL PERIODO
ENRICO ALAIN-FOURNIF.R
{La Chapelle d'Angillon, 1886 Vaux Saint Remy, 19141. Narratore francesc.La sua fama e soprattutto legata al romanzo " Le grand Meaulnes ", un'opera nella quale
di un mondo perduto, del paese dell'amma. Cosi, ravventura siraordinaria del proiagonista col*loca 1'in[era vicenda e i suoi personaggi nel clima nervaliano di una civilissima provincia, ritro-vata nella rievocazione febbrile delle inquietudini dell'adolescenza.
EDMOND AMAN-JEAN
(Chevry-Cossigny, Seine el Marne, 1859 - Parigi, 1936). Pitlore francese.Studi6 all'Ecole des Beaux Arts di Parigi sotto la guida di Lehmann e vi incontro. nel 1880,
Seurat, col quale divise lo studio dal 1881 al 1888. Amico di Verlaine, si occupo anche di criticaartistica e prese parte ai due primi salons dei " Rosacroce "> per il secondo dei quali preparoanche il manifesto sul tema di Dante e Beatrice, ispirato a Rossetti. Espose anche alia SecessioneViennese e al Salon d'Automne a Parigi nel 1903. Verso il 1925, con Rodin, fondava il Salondes Tuileries. Appartiene al gruppo dei pittori simbolisti francesi: fa uso di tutia la gamma deiriferimenti analogic!, psicologko-tnistici del Simbolismo.
ADOLPHE APP1A
(Ginevra. 1862 - Nyon, 1928). Scenografo svizzero.lmportante soprattutto per i suoi contributi teorici (" La mise en scene du drame wagne-
rien ", 1895; " La Musique et la mise en scene ", 1899).Imposta la scena secondo moduli nuovi, tridimensionah, atti a proiettare in termini vism
colore secondo la necessita di focalizzazione di un soggetto nel dramma; apporta nella sceno-giafia il contributo essenziale della strutturazione architettonica, facendone un ekmento in se
CHARLES ROBERT ASHBEE
(Isleworth, Middlesex, 1863 Londra, 1942). Archiletto, designer, scriltore inglese.Discepolo di William Morris, inizio la sua attivita promozionale proseguendo 1'azione di
Morris, nella direzione gia aperta da Ruskin, intesa alia riqualificazione del gusto e della dignitadell'operazione artistica, particolarmente nel settore rivolto alia realizzazione architetionicae dell'arredo, degenerati a causa dello sviluppo della rivoluzione industriale, personificata, perRuskin e Morris, e nella prima atlivila di Ashbee, nella ' macchina '. La rivalutazione dei si-stemi artigianali portava, peraltro, a causa degli alti costi, ad una diffusione limitata ed elitaria,contraria, fondamentalmente, alle idee socialists e democratiche degli stessi Ruskin e Morris.Ashbee, dopo aver fatto parte del movimento di " Arls and Crafts ", fondava, nel 1888, la " Guildand School of Handicrafts ", e, subito dope la " Arts and Crafts Exhibition Society ", aprendoI'attivita del mo vi memo a lie nuove idee di collaborazione con l'attivita industriale, attraverso1'industrial design, che avrebbero esercitato una ascendenza profonda sullo sviluppo del gustoc dei nuovi metodi di lavoro in tutta Europa. Mentre poi, ai suoi intzi, il gruppo di li Arts andCrafts", di cui era stato presidente Walter Crane, restava ancorato all'estetica preraffaellita(Crane vieto, tra I'altro. I'accesso alle esposizioni del gruppo alia scuola di Glasgow e a Mackin-tosh), per opera di Ashbee la nuova associazione, di cui egli fu di ret tore, si apri alle linee dellaricerca architettonica verso il movimento moderno. Ashbee fu tra i primi in Europa a cogliereil signiricato deU'architeltura organica di Wright.
Nel 1904 apri la " School of Arts and Crafts ", che ebbe vita fino al 1914. Fondo anche la" Essex House Press ", per cui disegno i caratteri dei titoli. Dal 1919 al 1925 fu consigliere civicodell'Amministrazione palestinese. [I suo linguaggio architettonico si aitiene ad una limpidachiarezza di linee, che egli riesce ad innestare nella tradizione urbana della citla di Londra, chealleggerisce con una misura di gusto straordinaria; la stessa misura che caratteri/za l'elegantelinearita dei suoi oggetti di design.
LEON BAKST
(Ljev Samojlovic Bakst Rosemberg. San Pietroburgo. 1967 - Parigi. 1924). Piltore. sce-nografo. decoratore teatiale russo,
Nato in Una famiglia numerosa, fin da bambino fu fortemente atlratio dul teatroh che fre-
quentava nascostamente, essendone allora proibito L'accesso airinfanzia- A casa, ridisegnavai costumi e le scenografie. Costretto a lasciare la casa paterna per guadagnarsi da vivere. fu perqualche tempo disegnatore di scaiole di fiammiferi. Frequento poi I'Accademia di Belle Artidi Pietroburgo, che abbandono ben presto, non soddisfatto dell'impostazione accademica delladidattica che vi si svolgeva. Nel 1890 conobbe il critico Alexander Benois, che contribuira for-temente alia diffusione delle idee di rinnovamento artistico in Russia, e con Diaghilev. che ie-niva dalla provincia, fu tra i frequentatori della casa di Benois. Nel 1898 fu tra i fondatori delgruppo " Mir Iskusstva " (11 mondo dell'arte) e col gruppo organizzo esposizioni e pubblicouna rivista. Nel 1900 Bakst inizio la sua attivita teatrale con le scenografie e i costumi per la pan-tomina " Le coeur de la Marquise ": nel 1906 apri una scuola frequentata anche da Chagall.Nello stesso anno prese parte, con Diaghilev, alia prima espo&izione dell'Arte russa, organizzatada Diaghilev al Salon d'Automne a Parigi. Nel 1908 era di noovo a Parigi dove Diaghilev or-ganizzava una stagione di musica russa; fu il creatore, per questa occasione, dei manifesti. deiprogrammi, degli inviti.
Per Tanno seguente, con lo stesso Diaghilev, preparo la stagione dei balletti russi. a Pa-rigi, che furono uno degli avvenimenti culturali piu important! di questi anni e alia reahzza-zione dei quali parteciparono i maggiori artisti del tempo. Tra le scenografie piu note di Baksiresta quella per " Sheherazade ", di Rimsky-Kordakoff, per la quale egli preparo una cornicefissa del proscenio, ispirata all'oriente, di tipo arcaico. entro la quale le scene e tutta I'azioDesi muovono in una straordinaria vitalita coloristica. II viaggio che Bakst aveva fatto in Grecia
airinterno della scena diventa, per Bakst, cosi unitario che i costumi hanno la stessa impor-
folkloristica con la quale sono realizzati. Bakst disegno anche, a Parigi, figurini di moda peril sarto Paul Poiret, anticipando motivi Art Deco. Nel 1922 era di nuovo a Pietroburgo. iuca-ricato di curare le scenografie dei balletti per la Casa del Popolo. Tomato poi a Parigi, si diviseda Diaghilev, scontento del fatto che i balletti perdevano sempre piu il sapore russo per di\e-nire francesi, e realizzo, invece, la scenografia e i costumi per la " Fedra " di D'Annunzio.
II suo primo biografo e Andre Levinson, che gli dedico un testo (" Storia della vita di LeonBakst '") nel 1921.
MACKAY HUGH BA1LLIE SCOTT
(Londra, 1863-1945). Architetto e arredatore inglese.
menti raffinati, di una delicata chiarezza, da ' nursery", in lnghilterra, in Germania. in Russia,contribuendo alia diffusione del gusto inglese art nouveau in Europa. Chiamato dal Granducadi Hesse a Darmstadt, dove sorgeva la nuova colonia per artisti per volonta dello stesso gran-duca, ne decoro il palazzo nel 1898. Si occupo anche di arti applicate e disegno stone, ricami.carte da parati.
KOSTANTIN BAL'MONT
(Vladimir, 1867 - Parigi, 1943). Poeta e traduttore russo.L'entusiasmo per la cultura occidentale. sopratlutto per il stmbolismo francese. incise pro-
fondamente neil'opera di Bal'mont, nelle cui liriche si esalta il valore musicale della forma, laricca modulazione delle immagini in una ritrovata pienezza del canto. Accanio alia sua \asnvsima opera di poeta, si coll oca 1'altrettanto impegnato lavoro di traduttore dalle lingue occi-dental], soprattutto dal francese.Gigli palustri.Pallidi. soavemente pudichi, / si sono aperti ne/la boscaglia paluslre i i fiori silenziim dei bianchi
I fiori argentei dei bianchi gigli / crescono dal profondo abisso. / dove non briliano raggi doraii.dove I'acqua e fredda e buia.E non li attirano passioni criminose. j non li chiamatto i tumulti: / inaccessibili agli occhi in-discreti, / essi vivono solo per se stessi.Compresi della ferma decisione / di vivere sognando e di innalzatsi, / sbocciano con superbo sfar-zo j i muti fiori dei bianchi gigli.Si schiudono e avvizziscono impassibili. : lontano dai bent dt'gti ito/nini, j e .\bocceranno ancora.beliissimi, / e nessuno sapra di loro.(trad. A. M. Ripellino)
ERNESTO BAS1LE
(Palermo, 1857-iy32). Arehiletto italiano.Figlio dell"architetto Giovanni Battista Basile, autore del Teatro Massimo di Palermo
(1875), fu uomo di vasta cultura, conoscitore profondo dell'architettura medievale e della sto-ria artistica e urbanistica siciliana. Pure operando lontano dai centri piu vivi dell'Art Nouveau.riusci a creare alcune opere interessanti, particolarmente a partire dal 1900, anche se non evito
Dal 1877 insegno alia Scuola di Applicazione di Palermo e dal 1880 in quella di Roma,dove rimase fino al 1890. Vinceva intanto, nel 1893, il concorso per il Palazzo del Parlumemoe per il Palazzo di Giuslizia. Fu anche autore di numerosi ' villini * a Palermo e a Roma; la suaopera piu nota e ['Hotel Villa Igea a Palermo (1898) e il progetto per 1'Esposizione nazionaledi Palermo del "92. Progetto anche Je costruzioni di accesso all'Avenida de Libertao a Rio deJaneiro, e dal Governo italiano fu incaricato della realizzazione del Monumemo per i cadutidi Calatafimi.
Autore anche delle Ville Florio, Basile. Passim, del Palazzo Municipal* di Licata.dde della Villa Lomb d C ca E 1 bba. za pe m 11 peanteriori al '900, particolartnente in quelle roniane, dette la miglior prova di se nelle opei dtipo * floreale ' dai primi del secolo, nelle quali si espresse con fs fi 1liberta di in>
Secondo m d p c 1 I m I h m z z pdi arredo e mobili ml d II oc 11
Ho immaguim I d d II d I d d IVuso. poi alia cost fi 11 h d I g g d II de delta strut ff m m d I d p I p
II villino mod, m 1 d b p pper I servizi; '1 -'• I p I I d d d da IIprimo piano p I d I I I E d
(in " La Casa "". 1909)
CHARLES BAUDELAIRE
(Parigi, 182I-LK67). Poeta francese.L'opera poetica di Baudelaire pud esser considerata la matriee da cui scaturisce tuila la
poesia moderna, e non sollanlo europea, sia per la tematica nuova ed influente, sia per la le-
telligenza deiruomo e delle cose. Pertanto, ogni fenomeno e movimento estetico successivo ri-sale inevitabilmente ad essa, e in questo diritto all'eredita bodeleriana anche l'estetica florealcpuo avanzare le sue pretese. Non riuscira quindi difficile al lettore, scorrendo le " Fleurs dumal '\ di attingerc^ in queJIe liriche, alle fonti piu genuine di altre piij tarde ed elaborate fioriture.
Piii su delle paludi. piu su delle valiale. / Dei mortli, delle itlve. delle nubi. dei tnari. Olire ilsole e le zone degli eleri solari, j Olire i confini eslremi delle sfere stellate,Tu. mio spirito ardilo, vai con agiiila, / E come un nuotatore che si bea dentro londa, : Altegra-mente solchi I'immensita profonda, / Provando una segreta e tnaschia volutta.Piu itt alto c ben lomano dai miasmi malali, / Sali a purificarti netl'aria superiore, E bevi comeun puro e divino liquore / // chiaro fuoco ch'empie gli spazi immacolati.Di la dalle irislezze. dai di di noia pieni, / Che gravan del lor peso 1'esislenza brumosa. Felicechi ha poiuto con ala vigorosa / Slanciarsi verso i campi luminosi e sereni:Chi mira i suoi pensieri, allodole festose, j Verso i cieli al mattino salir liberamenie. E sta soprala vita, e intende pianameme j II linguaggio dei fiori e delle mule cose.
(trad, di D. Valeri)
AUBREY BEARDSLEY
(Brighton, 1872 - Mentone, 1898). Grafico, poeta, scriltore inglese.
Ma LI sue spirito inquieto. la fantasia accesa e briHatueh la vivace ispirazione artistica lo por-tarono a dedicarsi al disegno e alia grafica, incoraggialo anche da Edvard Burne-Jones. Gianet 1892-1893. a Londra, illustrava, per l'editore Dent, " La morte Darthur ". di Thomas Ma-lory, di ispirazjone preraffaellita e ruskiniana.
Decisivo per Hmpostazione estetica di Beardsley Tincontro con Oscar Wilde, del qualeillustro la "Sa lome" , in una delle interpretazioni piu accese, inquietanti. ricche di slimolo.di un erotismo segreto ed equivoco. dove estetismo, simbolismo. esotismo, satanistno. si combi-
Gia nel 1863 la rivista i<The Studio» aveva dedicalo il suo primo numero all'opera diBeardsley, suscitando scandalo per la giovinezza e il tipo di disegno dell'autore, ma dandoglianche immediatamente fama. Nel "94 era uscito (e Beardsley ne fu Tart director), « The YellowBook» (che cesso le sue pubblicazioni con la fine del prestigio di Wilde, suo principal sosteni-tore, in seguito ad un processo e ad una condanna per omosessualita) e nel 1896 « The Savoy »,una rivista per bibliofili fondata da Beardsley stesso e dallo scrittore Symons.
" Hunder the Hill " (Sotto il monle), stranamente dedicato al cardinale Giulio Poldi Pezzoli("Cardinale della Sacra Romana Chiesa, Vescovo Titolare di S. Maria in Trastevere, Arci-vescovo di Ostja e Velletri, Nunzio della Santa Sede in Nicaragua e Patagonia, un padre peril povero, un riformatore della disciplina ecclesiastica, un modello di istruzione, saggozza e san-[ita di vita... dai suo umile servitore, scrivano ? pittore di cose mondane che fece questo libro ").II romanzo fu pubblicalo postumo (e purgato) nel 1904 da John Lane.
Beardsley e anche autore di una " Ballad of a Barber" (1896) di una perversione addirit-tura macabra. Nei suoi ultimi anni Beardsley illustro anche Giovenale e la " Lysistrala ". Sde-gnoso e spregiudicato, passo nella Londra fin de siecle come una meteor a. Lavorava in soli-tudine, in una sorta di ritiro a Felpham, nel Sussex, dove era vissuto anche Blake, a finest re chiusee solo con luce artificiale.
Ammalaio di tubercolosi, fu a tt ratio dai mi to dei paesi del sole. Nel 1898 moriva infatti
di distruggere i suoi disegni pornografici.E Tesponente piu vivo del primo Art Nouveau inglese.
ALF.XANDRE BENOIS
(Pietroburgo, 1870 - Pangi. I960). Slorico. criiico. illustraiore. decoraiore leairale. de-signer russo.
Personaggio versatile, animators di cultura. riuni altorno a se la maggior parie dei ejo\ammtdleliuaii russi del suo tempo: da Djaghilev a Kaket. da La nee ray a Roerich a Somo\- nelsuo circolo culturale nacque la rivista « Mir Iskusstva <> (II Mondo dell'arte, 1898). anche seal momento della sua fondazione egli si trovava a Parigi, rivista diretta da Diaghilev. FJ ira iprincipal protagonisti della realizzazione del programma culturale dei Balletli russi di Du-chilev. Dedito al lealro dal 1900 disegnd le scene, i cosiumi. compose il Libretto per il " Paviliond'Armide'". il balletlo porlalo a Parigi dalla ballerina Anna Pavlova. Net 1912 Stanislatskijlei invito al Teatro d"Arte di Mosca. Dal 1926 si trasferi definitivamente in Franeia. dove conti-
ALBAN BERG
(Vienna. 1885-1935). Compositore ausiriaco.Allievo di Schonberg dal 1904 al 1910. c uno dei principal: esponemi dell'espressionismo
musicale tedesco. Nacque dalla sua adesione al movimenlo la sua amicizia con Kokoschka.A lien berg, Kreuss. Per le sue prime composizioni adotlo 1'atonalismo. in seguito uso la dode-cafonia, seguendo I'esempio di Schonberg, da cui si distinse per la maggiore emoiivita. I'espres-sivita piu diretta. la trasposizione in linguaggio musicale di una particolare. allucinaia conce-zione di vita.
Legato inizialmente al lardo romanlicismo (Wagner, Brahms) cerco poi una emancipationsdalla grammatica tonalc; da questa nuova dimensione melodico-armonica nacque il " Wozzeck ".che pud esser consideralo il suo capolavoro e che esprime perfettamente il clima teso e ango-
SARAH BERNHARDT (Henrictle-Rosine Bernard)
(Parigi, 1844-1923). Attrice francese.Forse la piu famosa al trice del suo tempo, non tanto per le qualita di recitazione. pure in-
teressami, quanto per la ecceniricita che ne fece un personaggio di primo piano della societaculturale e mondana del periodo. Per lei gli artisti realizzavano opere, scrivevano lesii. fa«\anofollie. Mucha, Lalique, crearono gioielli, abiti, manifesli che li resero celebri; per lei scnuerodrammi Sardou. Barbier, Moreau, Lemaitre. Secondo Bernard Shaw la sua recitazione nonera " l'arte di far pensare in modo piu profondo. ma quello di Tarsi ammirare- " perche invecedi " cnirare nel personaggio. si sostituiva ad esso ". II suo grande succe-sso fu " Aiglon " di Ro-stand, nel 1923.
PETF.R BEHRF.NS
(Amburgo. 1K61 - Vienna. 1938). Archilelto e designer tedesco.Dopo aver studiato alia Scuola d'Artc di Karlsruhe fu Ira i fondatori. nel 1893. della Se-
cessionc di Monaco: si dedic6 dapprima alia piltura. poi alia grafica editoriale e pubbliciianao al design di oggetti d'uso. Pass6 in fine all'archilettura. Formatosi nel clima della Secession*se ne slacco a poco a poco, rifiutando il decorativismo lino ad aprire un discorso di lipo razio-nalista. che gia nel la sua casa di Darmsiadl (1901) e ne] padiglione delle Art! Decorative all'Espo-sizione di Torino del 1902 si annunciava chiaramenie, pur nella permanenza di temi decoraimlineari. legati alia poetica art nouveau. II tentativo di rinnovamento si evidenziava nella ten-verso varie fasi; da una soria di neoromanico (Esposizione di Oldenburg, 1905: Crematoriodi Dellstern presso Hagen. 1906), per arrivare al complesso indusiriale della A.E.G. (1909) aBerlino, in cui Pintenzione simbolica si traduce in linguaggio prolorazionalisia. Per la A E GBehrens divenne designer e consulente arlistico di lutta la linea produttiva e pubblicitaria. po-nendo le basi del ' lettering' e deU'immagine coordinata del design atluale. In mo lie opere ar-chitetloniche posteriori Behrens si accosto sempre piu ad un linguaggio espressionisia. di cmevidenzia la component romanlica (Continental-Kaulschuk und Gutlaperdrakompanie. 1912:Frankfurter Gasgesellschaft di Osthafen, 1913); mem re le opere del dopogucrra denuncianoI"adesione aU'architetlura di Wright.; I'edificio al Weissenhof di Stoccarda, del 1927. e del tin-to coerente con le poetiche razionaliste. Nel 1922 Behrens era divenuto Direuore della Scuobdi Archileitura dell'Accademia di Vienna e ncl 1936 in segno all'Accademia d'Ane di BerlinoNel suo studio si forma no Ic Cor busier. Mies van der Rohc, Gropius.
HENDRIK PtTRUS BERLAGE
(Amsterdam. IKS6 - L'Aja. 19341. Architetio e urbanista olandese.Pur rimanendo legato, per cerli aspctti. a motivi revivalistici medievaleggiami. Berlage
riusci a super a re I'accademismo e 1'ecleltismo del momento ponendo 1'accento su alcuni \ aloftessenziali dell'opera architettonica. tra cui I'esatla detinizione dei particolad costruttivi. il s*-gnificato del piano murario come elememo di per se signiflcaiivo, anche nei suoi rapporti cro-matici. la moralila coslrultiva. Tequilibrio e il rapporio Ira forme e conienuti. il tentaiivo direcupero del signifiealo sociale dell'arte: che egli persegui con un ritorno a forme semplici e
suo capolavoro e la Borsa di Amsterdam (1898-1903). svolta secondo un equilibrio perfetlo traI'impianto volumetrico. severainente contenuto. la sensibile cromaticita delle superlici. il richiamoauieniico. non folkloristico. all'architetcura romanica. L'organicita dello svolgimento spaziake la lievissima. piltorica decoralivita delle pareti sono I'unica concessione a lie istanze an nou-
LEONARDO BISTOLF]
(Casale Monferrato. 1859 Torino, 1933). Seultorc italiano.Studio a Milano, interessato, partitolarmente, alia scullura di Grandi e alia pillura lom-
barda. Da un verismo di maniera e da una pittura ispirala a Fontanesi passo. nella scultura, adn mbolismo rappresenlalivo patetico e romanlico, che lo rese celebre come scultore fune-
o fino a a . che gli fosse atiribuito Tappellaiivo di " poela della morte ". Lavoro per mold
o :he appesanti, in seguito, nei moki monumenti, il piu inieressante dei quali e forse ll Mon no S? (1906)
Chi mi dim che non e tine quesla, chi non resteru sorpreso e soddisfalto e convinlo al to-spelt,, di simiti opere. e non provera if bisogno di pensare anche inconsciameme alia mono del-I'artixta che ha lavorato pazietjlefnente, che ha sapulo piegar t'oro- sminuzzarlo, plasmarlo, in
plasma la creta, come Bislolfi plasma le slirlue, prima di xcitlpirle. come Michelttngelo scolpi il famoso Most-(L. Vicini, in « l/Artista moderno »>, 1912)
WILLIAM BLAKE
(Londra. 1757-1827). Pitlore e poela inglese.Di natura visionaria e immaginifica. imbevulo delle teorie esoteriche di J. Beohme, clas-
sicheggiante e romantico, decadente ed enfatico, lavoro dapprima come incisore presso vanartisti, finche, nel 1783, riuni i suoi versi giovanili nel libro " Poetical Sketches " (schizzi poetici)che pubblico poi, nel 1789, in "Songs of Innocence" (Canti di innocenza), coi suoi disegni.
Nel 1792, ridotto in miseria, fu costretto ad illustrare lavori commercial] ed opere non sue,come " Nighi Toughts " (Pensieri notturni) di Joung. 1796. Pubblicava. frattanto, " Gates ofParadise " (Porte del Paradiso) e " Songs of Experience " <Canti di esperienza, 1794) nei qualisi scagliava contro tutte le false leggi della moralita corrente. Nel 1799 si trasferi nel Sussex, aFelpham (dove avrebbe poi abitato anche Beardsley); qui compose " Milton " e '" PropheticBooks " (Libri profetici). Nel 1803 torno a Londra, dove dovetle ancora dedicarsi, per vivere,all"illustrazione. Convinto di avere visioni notturne di grandi spiriti, li ritraeva velocemente,come dal vero, alzando gli occhi dal foglio quasi li osservasse direttamente.
Un pittore. John Linnell, lo aiuto a superare la difficile situazione finanziaria, ed egli poteallora dedicarsi ai suoi lavori migliori, " Spiritual Portraits " (Ritraiti spiritual!}, i disegni per" The Book of Job "; dette anche inizio ai disegni per la Divina Com media, che non termini,minato nel I a salute e costretto a lasciare il lavoro. Moriva nel 1827. Si era dedicato con ugualeimpegno alia poesia e alia pittura, nella quale si era espresso in termini allegorico-mistici. I suoiriferimenti ideali furono il Medioevo (da cui trasse la passione per il libro miniato, che fece ri-
il riferimento forma le fu la' monumentalita michelangiolesca che trad usse, lalvolta anche gof-famente, in un grarlsmo lineare, fitomorfico, bidjmensionale. La sua invenzione tecnica e 1'il-luminated painting, una sorta di miniatura a stampa, che unisce il testo airillustrazione. Questa
ginifica, sara il motivo per cui sara preso a model lo dai Preraffaelliti e. attraverso quest i. dal-1-Art Nouveau.
Tra le altre opere di significato allegorico " Vision of the Daughters of Albion " (Visionedelle figlie di Albione). " America, a profecy " (America, una profezia, 1793). " The Book ofUrizen " {U libro di Urizen), " Europe " (1794), " The Songs and Book of Los"" (I canti e illibro di Los), " The Book of Ahania '" (II libro di Ahania. 1795), " Job " (1797), " Milton "," Jerusalem " (1800). in cui la poetica del ' sublime ' raggiunge il parossismo.
Le liriche di Blake, per certi aspetti vicine ai ' songs' e lisa bet tiani. sono peraltro imbevutedi romanticismo, di infantile entusiasmo, di fede assoluta, ancora una volta ' romanlica ', neidiritti dell'immaginazione.
Ignorato e considerate pazzo dai contemporanei, (nel 1811 una sua esposizione fu total-mente ignorata; le fu dedicato un solo articolo su « Examiner") fu riscoperto da Dante G. Ros-setti e dai Preraffaelliti. La prima biografia su Blake, quella di Alexander Gilchrist, e del 1863;segui un testo di Swinburne (1868), scritti di Alfred J. Story (1893). di Elwin J. Ellis (1907). Lesue lettere furono raccolte nel 1906 da Frederick Tatham.
ALLKSANDR BLOK
(Pietroburgo, I8H0-I921). Poeta russo.La sua voce puo essere eon side rata la piii alta e la piii complessa della poesia russa forma-
tasi alia scuola della cultura occidental, particolarmente del simbolismo francese. L'operatocca sia il tema del sogno e della nvelazione attraver o la one e Id favold ( \ i\ v olett notturna ". " II giardino degli usignoli"'). sia quello del mito storico (" 1 dodici '"), v uto utt v danch'esso, nonostante l'apparente violenza realistica, piii nella progressione quasi apocal tt ca
in cut si realizza un nvolsimento della stona.
ARNOLD BOCKLIN
(Basilea. 1827 - San Domenico di Fiesole. 19011. Piuore svizzero.Dopo un corso di disegno a Basilea. da] 1841 a] 1847 studio all'Accadeinia di Dusseldorf
Nel '46 era di nuovo in Svizzera e nel '47 ad Anversa e a Bruxelles. Dopo un breve soggiornoa Parigi, ne) 1848 era di nuovo a Basilea. Nel 1850, su consiglio dello storico Jacob Burckhardl.fu in Italia, a Roma, dove venne in eonlatto col poeta Paul Heyse. Durante successm viaggi aMonaco, conobbe il collezionista Schack. che gli commission*) molti lavori In Italia a piii n-prese. nel "74 e a Firenze ed enira in rapporti con Hildebrand e von Marees. In questo perio-do si dedica anche a sludi sull'areonautica e progetta modelli di aerei. Dopo un breve soggiorno
Antecedente diretto di quella sorta di h realismo magico" che trovera la sua esatta defini-?ione neila metatisica di De Chirico (non per niente discepolo ideale di Bockhn e suo grand?ammiratore), Bijcklin fa rivivere i sogni nostalgia e la parlicolare atmosfera di sogno nordicinel paesaggio italiano, che popoia di personaggi mitici. evocati con un realismo naturalistrcoche contribuisce fortemente allo spaesamento ambiguo dei suoi quadn, svolti quasi ' a trompe-I'oeil\ nella minuzia dei particolari descritlivi dell'ambiente e dei personaggi irreah che eglieolloca in luoghi misieriosi, isole scoscese, boschi sacri, in un'atmosfera magica e mislenosa.Piuttosto che di simbolismo sembra piii logico parlare, per Bocklin, di • piltura analogica '.essendo i paesaggi. le immagini che li popoiano, piuitosto analogic che simboli. II colore cupoe insieme freddo. raggelalo. perlaceo, sara quello irreale dei surrealist!.
VICTOR tLPIDlhOROVITCH BOR1SSOV-MOUSSATOV
(Saratov. IK70 - Taroussa, Mosca, 1905).Dopo essere stato allievo di Konowatov frequento la Scuola di Pittura, Scultura. Archi-
tcttura di Mosca dal 1890 al 1895, e TAccademia d'Arle di Pietroburgo (1892-1893). Fu poi aParigi nello siudio di Cormon. Dal 1903 si stabili a Podolsk, presso Mosca. Fu amico dei poeiisimbolisti Brjussov e Andrei Bely. Nel 1904 ebbe una serie di esposi^ioni in Germania, oreaniz-zate da Cassirer. Espose anche a Parigi. dove visse per un cerlo penooo. subendo Tascendenzaili Puvis de Chavannes e dei Nabis. Passo poi ad una sintesi pittorica di carattere inirospeitivo.in lermim di idealizzazione simbolica del passato. Irasformato in mito. Ebbe molla influentsui giovani pittori simboli ti ru i
F.DWARD BURNE-JONE!
(Sir Edward Coley), (Birmingham. L823 - Londra, 1898). Pittore e poeta inglese.poeta ingle e
Determinate per rorientamento della sua vita l'incontro all'Exeter College di Oxfoidton William Morris (1852) e la sua amicizia che, con quella di Dante Gabriel Rossetti, m-,e-
] camera ecciesiastica e si dedica alia pittura, ncco di un bagaglio culturale complesso. piuletlerano che estetico.
Allievo di Rossetii, ne subisce Tascendenza. fino a quando, dalla conoscenza diretta delleDpere di Botticelli e del Mantegna, che studio particoLarmente. e al rapporto di amicizia conRuskin. dai ripensamenti sulla % poeiica del sublime \ dedusse un linguaggio Lineare piii pre-u o e per onale, legato, anche, ad una sua particolare visione plastico-dinamica. Amico diSwinburne di Pater di Whi tier fece pane della Confraternita dei PrerafTaelliti, condivideitdoton loro I ammirazione per Blake e per 1'arte medievale. Visito la Francia con Morris. I Italiaton Ruskin (1862-1863). Si dedico anche alle arti applicate e alia decorazione ambientale. e.ton Morris, fu tra i fondatori della " Morris. Marshall & Co. "" (1800) e della " Arts and CrafuExhibition Society" (1888). 1 suoi soggetti, compiacentemente svolti su toni cupi. di caraiteredllegonco-mistico, si ispirarono alle leggende di re Artu e dei Cavalien della Tavola Rotonda^
hevemente ambigui, pallidi e flessuosi come efebi, le sue delicate fanciulle. costituiscono unmodello per il simbolismo decadente france e
WILL BRADLEY
(Boston, I86K Short Hill. New Jersey. 1962), Dccoratore. cartellonisla. discgnaiore. edi-
L'illustrazione del libro e la cartellonistica furono le sue attivita principali, ma egli stessoi coniiderava non solo un graphic designer ma un esponente americano del movimento di'" Arts
and Crafts". Ne] 1893 aveva aperto uno studio di grafica a Chicago che lo rese ben presto fa-moso; nel 1896 fondo una sua stamperia editrice, la " Wayside Press ", a Springfield. Massachu-setts, e in questa pubblico una rivista, « Bradley-His Book », che ebbe sette uscite, ma con la qualesi propose anche di produrre *' quadri, libri, carle da parati, tappezzerie e decorazioni murali.compresi mobili ". Egli propose anche di aprire una scuola di design per le arti decorative, manon riusci a realizzare questo progetto. Espose alia prima rassegna americana di " Arts andCrafts " a Boston, nel 1897. Nel 1900 studiava una nuova impostazione per la rivista « Ladies"Home Journal », per la quale preparo anche una serie di disegni di mobili di raffinata imposta-zione lineare, vicini, per certi aspetti, a quelli della Scuola di Glasgow, ma anche sensibili al 1a-voro degli inglesi Voysey e Baillie-Scott e deU'americano Wright. L'interesse per rarehitenurasi manifesto, in Bradley, nel disegno per tre case per la sua famiglia, una a Concord. Massa-chusetts (1902); le altre due a Short Hill, New Jersey verso il 1910 e il 1920. II suo disegno si di-stingue per un andamento lineare libero, veloce, incisivo e pieno di estro e di fantasia, vicino.talvolta, nella resa esteriore, ai modi di Beardsley.
VALERIJ BRJUSOV
(Mosca. I873-1924|. Poeta c tradultore russo.La lezione simbolista e alk radici dell'esperienza poetica di Brjuso\ tutti impre nala di
cultura occidental pur nella sua fedelta alia migliore tradizione russa. Baudelaire. Verlaine,Mallarme, Maetherlink, Werhaeren furono i maestri dai quali attinse, ollre alia duttilita dellostile, il culto della bellezza e delle sue forme sensibili. Perl ant o, accanto alia sua opera originate,un posto cospicuo occupa la sua opera di traduttore e divuigatore in Russia di quei poeti i im-bolisti francesi. alia cui scuoia si era formato.
L'ombra di inereale cteazioni / dondola nel Mtgno l come le parole delle litanie : sul muro dismaltoMarti violette / sul muro di smalio / fra sonno e veglia tracciano suoni / nel silenzio squillanteE translueidi ckioschi / nel silenzio squillante / sorgono come lustrini j dinanzi alia luna ceruieciSpunta tin disco denudato / dinanzi alia luna cerulea. / / suoni si librano fra sonno e vegliti, tuoni mi ie:zeggiano
muro di smalio
(trad. A. M. Ripellino)
DUIL1O CAMBELLOTTI
(Roma. 1876-1960). Pinore, scullore. grafico. scenografo italiano.Studio am applicate a Roma, al Museo di Ani Industriali. avendo come maestro il raor-
rmano Morani. Si dedico per gran pane della sua vita all'insegnamento e all'altivita di graphic-designer, in un continuo approfondimento di una poetica che prende avvio dall'Art Nouveauintern azionale e dalle Secession! per raggiungere una sua a mono ma semplificazione linguistica,espressione delle sue idee umanilarie, socialists di carattere didasealico, talvolta. Nel 1900 col-laborava alia rivista bolognese « Italia ridens », i cui temi riproponeva a Roma nel 1902 in « Fan-tasio ... a cui egli collaboro con illustrazioni satiriche di carattere politico-sociale. Nel 1903 col-laborava anche, contraddicendosi, a « Novissima », che portava avanti teorie estetiste. contrariea quelle di « Italia ridens » e a quelle ostentate dallo stesso Cambellotti. Questo fa parte dellacontinua ambivalenza del personaggio che aderisce al sindacalismo socialisla rivoluzionario «.allo stesso tempo, illustra " La Nave " di D'Annunzio. awiandosi. sempre piu, airaccondi-scenden;a verso forme di trionfalismo sul tema della genialita latina. in adesione alia propa-ganda tascista del momento. Resta. peraUro. una delkc personalita piu auiorevoli sul piano del-
D1NO CAMPANA
(Marradi, 1885 - Castel Pulci. 1932). Poetd italnnoLe figurazioni di alcuni "' Canti Orfici " non possono non neondurre a imnidgini emble-
matiche di tutto il movimento simbolista-noreale: ma 1'impeto originano da cm es v.diun
di creature, di col or i, le trascina in un piu ardente flusso vitale preservandole da ogm immobiledatazione: anche quell'ombra eroica, quella scommessa col mistero della vita che parrebbeimparentarle a una temperie poetica tutta impregnata di simboli, toma ad essere 1'atiribuioibillino di un impenoso e vergine de ldenci di xiu
La Chimera (da " Canti Orfici ")
Non so se tra roccie it luo patlido / Viso m'apparve- o sorriso Di lonlctnanze ignot? Fo^tila china eburnea / Fronle jutgenle o giovine / Suora de la Gioconda: / O delle primavere Spetileper i tuoi mitici pallori j 0 Regina o Regina adolescent?: I Ma per il luo ignoto poema Divolutta e di dolore / Musica fanciulla esangue, / Segnato di tinea di sangue j Nel cerchio deltelabbra sinuose, / Regina de la melodia: I Ma per it vergine capo / Rectino, to poeta nollurnoVegliai le uelle vivide nei pelaghi del cielo I lo per il luo dolce mistero j lo per il mo di\tnutattturno Non so se la fiamma pallida / Fu dei capelli il vivente j Segno del suo pallonNon so se fu un dolce vapore, I Dolce sul mio dolore. / Sorriso di un volto notturno: Quardole bianche rocce le mute fonti dei venli I EI'immobilita dei firmament! / E i gonfi rivi che lunmptangenti E I'ombre del lavoro utnano curve la sui poggi algenti! E ancora per tcneri deli lout »i.chiare ombre correnti E a/worn ti cltiattio ti chiamo Chimera
FELICE CASORAT1
(Novara, 1883 - Torino, 1963). Pittore italiano.Figlio di un ufficiale. trascorse la prima giovinezza tra Milano, Reggio Emilia, Sassari.
Padova e Verona. Studio musica e si laured in legge nel 1907. II suo primo accostamento aliapittura awiene tra il 1902 e il 1907. attraverso la Secessions intesa come superamento del na-turalismo di tipo realistico. Nel 1907 era presente alia Biennale veneziana e nel 1913 presentavaa Ca' Pesaro 40 opere di chiara adesione secessionista. Nel 1915 si trasferi a Torino e divenneubito una figura di rilievo nell'avanguardia intellettuale della citta. La sua prima ricerca, di
carattere cromatico-lineare, si riferisce a motivi internazionali, a Puvis de Chavennes, ai Pre-raffaelliti, a Von Marees e allo Jugend di tipo nordico. La sua adesione a questi motivi si svolgeempre, peraltro, sul filo della ricerca di un linguaggio personate che raggiungera la sua assolu-
tczza dal 1919. a contatto con la pittura metafisica, che egli traspose in una straordinaria stati-uta di torme, col ricorso alia tradizione quatirocentesca italiana. senza. perallro, le cadenze
nazionalistiche del ' ritorno ali'ordine' che caratterizzera it Novecento italiano.Anche il periodo di adesione a istanze secessioniste rappresenta per Casorati un innesio di
la, mefafisica. di grande rigore.Nel 1920 il periodo secessionist* di Casorati e superato. Egli si dedica, da questo momemo.
alia realizzazione di un proprio mondo espressivo e allo stesso tempo al rin nova memo dellacultura artistica italiana, svolgendo, in particolare nell'ambiente torinese, una nolevole atlivita
GALILEO CHIN!
(Firenze. 1873-1954). Decoratore, ceramista, pittore italiano.Passo dal restauro alia ceramica, aprendo, nel 1896, una piccola manifallura. Con suoi
bellissimi vasi, per i quali aveva studiato una serie di tec niche diverse, recuperando anche metodiantichi di lavorazione, si presento alle mostre internazionali di Londra (1898), di Pangi (1900).di Torino (1M2). Collaborava intanto con architetti (particolarmente con Michelazzi). per leparli decorative delle facdate e degli interni delle case. Comincid poi a dedicarsi all;: decorazione pittorica. Del 1909 sono i cartoni per la cupola della sede centrale del la Biennale di Venezia. ispirati al prezioso corpuscolarismo del mosaico murale di Kliml, al quale si riferbce ancheper il significato allegorico. Nel 1911 si (rasferisce in Persia, chiamato dallo Scia per la decora''lone del Palazzo del Trono progettato dall are hi letto Rigotti. Arncchito di motivi orientsliz-/-inti, aderisce allo spirito della Secessione fino al 1935. per volgere poi. nella piltura, ad un na-
G1NO COPPEDE
(Firen;e. 1866 - Roma. 1927). Archiietto c decor tore Ulwno
vazione seces loni ta non dngiunta da revival ism i e da formalismi ecleltici medievaleggidntie da quattrocentismi recuperati romanticamente, riflettendo le linee generali dell' arch it etturaHa liana del primo noveeento, ehe [ende a riecheggiare in forme provinciaii i moiivi stilismiinternazionall Lavoro a Genova (Castello Mac fCenzie, a Capo Santa Chiara, caleito Bru ce palazzo Pastorino) e a Roma, dove realizzo il Quartiere Coppede, presso via Po. creando un
terto fascino e di un suo colore.
SERGIO CORAZZ1N1
(Roma, 1KS6-I907). Poela italiano.La rapida parabola deila sua vita non Lascio la sua opera, per un verso cosi inquadrata nel
tempo ma anche testimone attiva di una crisi di passaggio, non la Lascio, ripetiamo, pnva dieredita fruttuose. Accanto al regisiro crepuscolare (ma di una purezza di visione e di espre&sioneche il confratello Gozzano non conosce) fedele interprele del programma decadente. si colloca
verse flessioni, in tanta successive poesia di Palazzeschi.
Toblach.
... E giovinezze erranti per le vie / piene di un grande sole malinconico, j portoni tmichiusi davanzali / deserti, qualche piccola fontano / che piange un pianlo eterntimente uguale i at pawaredi ogni funtfrale, I un cimitero immenso, un'infitiiia I messe di croci e di torone
Dialogo di marionette— Perchi, mill piicolu regina, I mi fate morire di freddo? / // re dorme: potrei quasi can tarnuna canzone. I che non udrebbel Oh.fatemi j satire sul baleone! I — Mio grazioso arnica, il hal-cone e di cartapesta, / non ci sapporterebbe! / Volete farmi morire j senza testa? j - Oh. piccolaregina. sciogliele / i lunghi capelti d'oro! j — Poela! Son vedete j che i miei capelli sonodi stoppa? I — Oh. per donate! j — Cosi? j — Cosi...? j Non mi dite una parola. io mon-ro... I—Come?per quesla sola I ragione? j — Siele ironica... Addio! / — Vi sembra? Oh.non avele rifnpianti / per I'uttimo nostro convegno / nella foresla di car tone? / - Io non ricordo.mio / dolce amore... ye ne andate?-.. ! Per sempre? Oh, come / vorrei piungere! Ma che pos-so farci, I fe il mio piccolo cuore / e di legno?
EDWARD GORDON CRAIG
(Harpender. Inghilierra. IN72-I966). Regisla, scenografo, teorico teatrale inglese.Figlio detl"altrice Ellen Terry e dell"archiletto Edward Godwin, il costrutlore della White
House di Whistler, e considerate uno Ira i maggiori innovator! del teatro moderno per la suatendenza alia stilizzazione della seen a, portata fino alia distruzione del personaggio-attore conla sua teoria della ' supermarionetta ', con la quale mira anche ad eliminare il pariato dell'at-tore che diventa uno strumemo in nwno della regia. Tra le sue realizzazioni scenograficiK quelladi "' Rosmersholm " di Ibsen e quella dell' " Amleto " di Shakespeare, messo in scena da Sta-nislawskij. Scrisse"The Art of the Theatre " (1905); "The Actor and the U be r-Marionette ".su « The Mask», 1908; " O n the Art of the Theatre", 1911; "Toward a new Theaire ". 1913.
// Piacere di D"Anr
WALTER CRANE
(Liverpool. 1845 - Londra. 1915). Pittore. grafico, illusiratorc inglesc.
Linlon.ebbe mododi studiarea fondo i lavori dei Preraffaelliti, dei quali sub'i direttamente I'ascen-denza. Lo studio delle incisioni giapponesi rappresento il secondo motivo ispiratore. Con Morns e Burne-Jones dette vila a] rinnovamenio delle arti decorative che precedette resplosionedell'Art Nouveau. Si occupo della progettazione grafica a tutti i livelli, dall^rte del libro. allccurie da parati, ai manifest]. Nel 1864 delle inizio all"illuslrazione di una serie di grazio i imilibn-giocatlolo, per i quaii pote usare solo tre eolori.
Nel 1873 illustra " The frog prince '" (II principe rana), con effetti molto legati all influenz*delle incisioni giapponesi. lllustro anche, nel 1882, le fiabe di Grimm e una delle MluMraziomquella per "" The goose girl " (la ragazza oca), fu ripresa da Morris per un arazzo. lllustro anche
Society " di cui fu, per un certo periodo. direttore e che, in parte, voile mantenere troppo le-gata alle teorie PrerafTaellite, chiudendone 1'accesso, per le esposizioni, perfino alia Scuola diGlasgow. II suo linguaggio grafico> fortemente caratterizzato dalla linea avvolgertte, sinuosa,di carattere dtomorfico e floreale, e gia chiaramente inserito nel filone delTArt Nouveau.
E anche evidente. in lui, nella pittura di carattere allegorico, il riferimento alTarte classicaitaliana. E autore di vari scritti teorici. tra i quali: " The Claim of Decorative Art " (Le rivendi-cazioni dell'ane decorativa, 1892); " Ideals in Art. Papers of the Arts and Crafts movement"'(Ideali artistici; carteggio del movimento di Arts and Crafts. 1905): " William Morris to Whist-ler " (Da Morris a Whistler, 1911).
GABRIELE D'ANNUNZIO
(Pescara, 1863 - Gardone, 1938). Poeta, romanziere iuiliano.La varieta e la ricchezza dei motivi e I'ampia cornice di cultura entro cui si sviluppa ['opera
del poeia lendono a far decampare in varie direzioni il diffuso sapore floreale d'ogni sua piodu-zione; sarebbe percio, nonche illusorio, anche criticamente non legittimo cercare di esaurireun'immagine del D'Annunzio in questo specifico ambito. Eppure, nella chiara filiazione da mo-tivi esemplan di quel momento (Teredita da Huysmans). Tesplicita adesione alle aspirazionipreraffaellite non manca (" II Piacere "), anche se piultosto rivolta agli aspetti tecnico-formahdi quel programma che non intesa alle propaggini spiriluaii dei suoi temi. E propno nell'operaanleriore al momento eroico del Superuomo, particolarmente nel " Poema Paradisiaco " (1893).non sari difficile cogliere immagini e toni che si collocano accanto ad analoghe esperienze esie-liche. nel campo figurative, piu sottomesse allo spirito del tempo
Splendon nella metnoritx i paradisi / inaccessi a cui ianima inquielii .• aspiro con un'ansia cheJu tivo / oilre i'ora, oltre I'ora fuggitiva, / ollre la luce delta sera estiva dove i fiori effondeanaituk'hc segreta j virtu da' tor femtnet orn ii i bei penduli pomi tra la fronda / puri come la carrte verginale .. parean serbare ne la polpabionda / sapori non terreslri a non morlale / boeca, e piu bianche nel silenzio interne le lalueguardatan la pro onda pace e sognavano indicibilmenle.
Qua! mistero dal gesto d'una grande / statua solilaria in un giardino ( silenzioso al vespero TIspande! j Su i culmini dei rigidi cipressi, / a cui le rose cingono ghirtande, / inargentasi il cielo\esperlino; / i fonli occuhi parlano omme tbiancheggiano ne I'ombra i curvi cori / di tnarmo. ora deseru, ove s'aduna ! if enncilio degti ulUmi poeti; j tenue sulla messe alta dei fiori / passa la falce de la nuova tuna: / ne I'ombrti tfonli parlano segreti; / rare sorgon le stelle ad una ad unaun ugno con remeggio lento fende / in logo pura imagine del cielo / (desio d'urnon umunt ancor I'accende? / memoria e in tui del nuzial suo tito?) / e ffutlua nel lene soko il veto / de fanttca Tintaride, risplende / su Vacaue il lutne de I'anltco ntito
RAIMONDO D'ARONCO
(Gcmona, 1857 - San Remo, 1932). Architetlo iialiano.Dal 1871 al 1874 fu in Austria, dove lavoro come muratore. Tomato in Italia si diplom6
in architeltura a Venezia. Dimostra la sua adesione alia Secessione Viennese nel Palazzo aelfEspn-sizione Internazionule di Torino del 1902; adesione che, peraltro, egli Iraspone in termini per-sonali con vivacita e ricchezza di imtnaginazione costruttiva, in una vjsione dinan^ica degli spaziai-chitettonici e delle superfici murarie. Di lui notevole il lavoro svolto in Turchia, dal '96, comearchitetto di siato. In questo periodo egli contribui alia diffusione della visione art nouveau,che protrasse fino ad epoca razionalista.
FRATELLI DAUM (AUGUSTE, 1858-1909; ANTON1N, 1864-1930).
Industrial! vetrari, continuarono il lavoro iniziato dal padre, notaio, che, in seguito aliadisfatla francese del '70 e al crollo finanziario, aveva acquistato una vetreria a Nancy, improv-
Nancy per 1'arte vetraria, nella quale (particolarmente Antonin) si distinsero sia per le ricerchetecniche sulla pasta vetrosa e sull'uso materico, sia per la realizzazione formale delle loro opera,che ebbero il primo riconoscimento all'Esposizione di Chicago del 1893.
FolografoClaude D
ADOLFO DE BOSIS
(Ancona, 1863-1924] Pou til mi
limpidezza e intransigenza formale, il momento squisito della poesia decadente-simboh U itliana La cura degli effclli musicali, le ricercatezze metriche, la microscopia delle immagini Ko-rea li la proiezione deila vita come in un teatro naturals di preziose, emblematiche pre nzeco titui ono il poetico labinnto in cm rcstano irretile, come in analoghe tigurazioni pittonchela vita e i gesti della realta, raggelati, anche se teneramente. in un'immobile teona di simboh
Torbida. la notte cala
Torbida. la None cala, i con un brivido. da I'arco / del cielo. — Non odi I'ala , sua ruderI'ombra del parco?.-. / Non trema vetta ne slefo: / e I'anima perche trema?... i Una in re a\uprema l ffuisce dal muto cielo, j simile ad un tardo fiume / che tragga fra Lupe mi \tn ane rombo ne lume / le vile no tre nutlvive E ne la nolle ilente laluno (o il Tullo ctginocchi. I da' suoi smisurali occhi / piange. inconsolabilmente
1 Notlurm
// tramonw di flora ue magiche ghirlande lenlo t una dokt pundi malinicma pir I ora\uolano i togm ancorti nau/raghi « ell le lande Ma I Alma il puro grande mo bano oNolle, implora. / Ben tu venga, o posse/tie j Nolle! L'augusta calma ,. piovi a le cose, ed ellebevan Voblio fiuenle / dal sen tuo vaslo: e I'Alma I vigili, con le stelle.
Cantano i rosignoli
... Odi! Ogni luce, ogni alito, ogni fronda / mesce una nota al numeroso coro. / A quando a quandoun fremilo sonoro / scuole la pace limpida e profonda... / Trema il silenzio in suoi tintinni d'oro-Nolte, cui li astri ingemman di ghirlande / I'alto zaffiro de Volimpica urnal / a conrener I'ebrieionolturna f allro vaso si porge, assai piu grande-.. / // mio cuore mortale. o Tacilurna! i 11 tnio cuoremortal tutli riceve / gt'in te diffusi spirit! lucenti: lea Vorlo del mio cuor, prona, con lenti st>ni.I'eterna sinbonda bete I Anima de le cose conviventi...
CLAUDE DEBUSSY
(Saint-Germain-en-Laye. 1862 - Parigi, 1918). Compositore francese.Import ante per lui la profonda conoscenza della musica russa, di quella orientate, del mon-
do musicale antico (soprattulto dei clavicembalisti e di Rameau) e di Wagner. In continuo rap-porlo con la culiura del tempo, musico poemi di Baudelaire, Verlaine, Mallarme. frequenid ipittori impressionisti e postimpressionisti, conobbe Gide, Whistler. Fu assai vicino ai Preraf-faelliti (musico anche " The blessed Damozel " di Rossetli) e soprattutto al teatro di Meeterlinck.( Pelleas et Melisande "). Sia il dramma wagneriano che la Iradizione musicale russa perde-
di " primftivismo '. una maggiore aderenza alia realta e alia natura, nel fascino delle sue risco-perte font! di originalita e di mi tero.
L'arabesco musicale, o, piuttosto, ilprincipio deH'ornamento. e la base di tulle le forme d'arie.(in La Revue Blanche ... 1901)
10 sogno poemi... in cui i personaggi non disculono, ma subiscono la vita e il desiino ' C De-
£ il mare e il suo rilmo mmimerevoie, poi, tra le onde argemale di lima, si ode e pa: «iil suono misterioso delle Sirene (C. Debussy, sullopera \rene I
Fu per me un piacere in/ormarla: che Chopin, nonche essere fuori moda. era il mwmslapreferito di Debusn
— To', e divertente, — mi disse la nuora con un fine sorriso, quasi fosse stalo quello unparadosso laneialo dall'aulore del Pelleas. Cio nandimeno era ormai cosa certa ch'ella d'ora innanzi non avrebbe ascoltato Chopin che con rispetlo, e anzi con piacere(M. Proust, " Da Sodoma a Gomorra ", 1921. irad. E. Giolitti)
ADOLFO DE CAROL1S
(Montefiore dell'Aso, 1874 - Roma, 1928). Pittore, incisore. xilografo italiano.Inizio i suoi studi artistici a Bologna e si trasferi a Roma, dove studio al Liceo Anistico
Industriale e dove, in seguito, entro a far parte del gruppo 'L In arte libertas fondato da Clau-dio Costa e ispirato agli ideali di ritorno alia tradizione dei Preraffaelliti.
Oscillo tra un decorativismo floreale. di un linearismo intricato e baroccheggiante. e unrealismo postimpressionista e macchiaiolo, con pesanti michelangiolismi di maniera. Tra leopere migliori le illustrazioni in xilografia per " La figlia di Jorio " e " Le Laudi " di D'Annunzio.Mentre una serie di grandi affreschi a Pisa, Arezzo. Bologna (1908-1928). denotano un acca-
GEORGES DE FEURE (Georges Joseph van Sluijters).
(Parigi, 1868-1943). Pittore francese.11 padre, olandese, fu architetto a Parigi, dove egli fu allievo di Cheret. Lavoro. tra lal-
tro. alle decorazioni del Cabaret Le Chat Noir. Collaborators di molte riviste e autore di mani-
Foiografia di Jean Deln
festi, litografie, di illuslraziom bibliograiiche. Fu anche pittore e acquerellista. La sua lspira-zione simbolista e la figura femminile. nelle sue componenti erotico-sadiche in una garbaia,allusiva simbologia floreale.
WILLIAM DEGOUVE DE NUNQUES
(Montherme, 1867 - Slavelot. 19351. Piltore belga.Di famiglia nobile. di vasta culiura, si avvia allo studio della musica; passa poi allo stu-
dio della piltura. da autodidatta. Amico di letterati e di poeti sposo, nel 1894. la cognaia di Ver-haeren. Immerso in una sua visione magico-onirica della realta, riportera dai suoi viaggi im-magini trasfigurate delle Baleari e. da un suo soggiorno a Blaricum, dal 1915 al 1919, dedurra
JEAN DELVILLE
(Louain, 1867 - Forest-lez-Bruxelles. 1953). Piltore, scrittore. animatore culturale belga.lmbevuto di teorie esoteriche, seguace di Peladan, sia nelia sua aitivita letleraria che in quel-
azione di rigenerazione morale della socieia, il cui disordine etico egli vede rappresentato nelloscetticismo. A Roma per quatlro anni, vi dipinge La Scuoladi Platone; a Parigi, dal ] 892 al 1895,si entusiasma per Villiers de TIsle-Adam e per Barbey D'Aurevilly ed entra a far parte del grup-po dei "' Rosacroce ". Piii tardi subisce I'influenza teosofica di Scriabin, per entrare poi tragli adepti di Krishna Murti. Nel 1892 era tra i fondatori del gruppo belga " Pour l'Art ". per ilquale disegno il simbolo, una Sfinge. Dette anche vita ad una rivista artist ico-letteraria « L"Artet 1'ldee ». Nel 1896 creava in Belgio " Le salon d"Art Idealiste ". al quale parteciperanno anche
II suo intento di spiritualizzazione dell'arie si esprime in una resa dell'immagine (il cui ri-ferimenlo formale e quello dell'androgino) travisata dal significato simbolico. in un alone diintensa magia. che il col ore dai toni profondi arricchisce e carica di misteriose accent uazioni.
Tra i lavori letierari: " Dialogue entre nous " (1895); " U grande hierarchie de Tocculte '";- Le frisson du Sphinx " (1897); " Mission de I'Art'" (1900). Fu professore all"Accademia diBruxelles e insegno a Glasgow, alia Scuola d'Arie. dal 1900 al 1905.
MAURICE DENIS
Frequenlo il Lycee Condorcet. a Parigi, dove si lego di amicizia con Vuillard e Roussel:all'Academie Julian conobbe Bonnard, Ranson e Serusier, tutto il gruppo col quale, nel 1888.dopo la visita di Serusier a Pont-Aven, dove Gauguin aveva dato vita alia " Scuola di Pont-Aven '", fondata sul Sintetismo simbolico, veniva fondato il gruppo dei " Nabis " (Profeti. dal-Tebraico). La sua pittura pu6 inserirsi nel filone che parte dai Preraffaelliti per arrivare. atira-verso una continua, delicata trasfjgurazione. quasi ad una sorta di neoclassicismo. II suo in*timismo, caratteristico della scuola dei Nabis, raggiunge un alone di mistero. che egli canca diistanze religiose. Le sue teorie si riassumono in una serie di espressioni divenule famose. quasidefinizioni della poetica dei Nabis e della impostazione rinnovata dell'arte moderna. " L'anista.
massimo escludendo tutto cio che non I'ha colpito, fame uno schema espressivo. Ogni lirismogli e concesso; deve far uso della metafora come un poeta. Se un albera gli sembra rosso, ha ildiritto di raffigurarcelo con un cinabro... ". La sua frase pill famosa resta quella scrilta a ven-fanni: " Ricordarsi che un quadro. prima di essere un cavallo da battaglia, una donna nuda, -un aneddoto qualsiasi, e innanzi tutto una superflcie piana coperta di colori disposti in un cer-to ordine ».
Autore delle decorazioni murali del teatro des Champs-Elysees (1913) e del Petit Palais,affresco anche molte ville private Nel 1919 fondo, con G. Desvallieies. gli " Ateliers d'Art Sa-cre ". Fu anche insegname air Academic Ranson. Tra i suoi testi teorici sul Simbolismo " Ladefense du neo-traditionisme "' (1890), " Theorie " (1912), " Nouvelles Theories " (1922).
SERGEJ PAVLOVICH DJAGH1LEV
(Novgorod, 1872 - Venezia, 1929). Lelterato, promotore culturale. impresario teuiraie russo.
tando all'estero (a Parigi), esposizioni di arte contemporanea russa; passo poi alia presenta-zione dei " Balletti russi ", da lui creati e per i quali e considerato Tiniziatore dell'evoluzionemoderna del ballet to. Nel gruppo degli artisti attorn o alia ri vista russa « Mir Iskusstva »(II mon-do dell'arie) conobbe Be no is e Bakst, che ebbero molta parte nella realizzazione dell'immaginedei suoi balletti. II balletto di Djaghilev nasce come spettacolo d'arte teatrale e coreograflca
russi e aprendo un periodo di fervida collaborazione tra coreografi, ballerini, scenografl e pit-tori europei d'avanguardia, che, quasi tutti, si cimentarono nelle scene e nei coslumi dei bal-letti, da Picasso (" II cappello a tricorno " di De Falla), a Derain {" La botique fantasque " diRespighi). Anche " Parade " di J. Cocteau, con musica di Satie, scenari di Picasso, coreografiadi Masin fu messo in scena da Djaghilev. II piu costante collaboratore di Djaghilev fu, con Bakst,
CHRISTOPHER DRESSER(1834-1904). Teonco e disegnalore inglese.
Ho ctrcato di incarnare soprattutto un'unica idea, quellu dell'energia potenziale, for a rigore come idea dominanle; e per far cio ho usalo linee sul tipo di quelle che vediamo nelle
gemme sul punta di sbocciare, quando Venergia delta crescita e at massimo... e mi sono onchtappropnato la forma di certe ossa degli uccelli cot/egate agli organi di volo che ci danno I im-pressione di una grande polen.a("Principles of Ornament ", Londra, 1862 e The Technical Educator". Londra. 1870)
ISADORA DUNCAN
(San Francisco. 1878 - Ni«a. 1927). Danzatrice stalumtense.Espcmente della cosiddeua ' danza libera ', il cui teorico fu Laban. e una delle personality
artistiche piu singolari dei primi anni del '900.La ' danza libera " si propone come reazione polemica contro la danza accademica: mira
alia naturalezza, intends esprimere gli stati d'animo. Vuole essere 1'equivalente visivo di quellache e stata 1'emancipazione della musica e delle arti figurative dai legami della iradizione acca-demica, avviando al balletto * astratto ". La Duncan si ispiro alia Grecia classica, aboli eostumiL cenografia (in questo senso in contrasto con 1'ideale di Bellezza estetica del suo tempo) \tMiia una emplice tunica, sul palcoscemco vuoto. La vita, invece. della Duncan, fu una dellemamtestazioni piu esemplan del tempo; arnica, per un certo perjodo. di Gordon Craie mogliedel poeta russo Essenin, col quale, in America, organizzo serate di propaganda soMetica inI ma sempre per 1'emancipazione femminile, libera da remore moralistiche. non si semi legau
ne uno degli schemi tradizionali. Fini strozzata da]la sua sciarpa. nmasta impigliata nella
ii' iratteneia la veste assai ampin the le xcendeva dalle spalle alle•di net sandali. I! piede sinislro era avanti, e il deslro sul punio
I tmte delle dila il terreno. menlre la pianla e il calcagno si aha-, I' i moiimenlo da\a una doppia impressione: soprallutlo quella di
ii}ni in it atiililG in I pa1* o fiiti in nme amttff (juello d\ una labtlila Qtte to lihrnrst auasi tu volotontimnto tilta xicttrezza dell'incedere, conferiva all'irnmagine la sua zrazia specifica(W Jensen. Gradiva. 1906, trad. C. Musatti; cotnmento di S. Freudl
OTTO ECKMANN
(Amburgo. 1865 - Badenweiler, 1902). Grafico. piltore, designer tedesco.Studio ad Amburgo, Norimberga e aH'Aecademia di Monaco. Dedicatosi imzialmente
alia pitlura, lavoro per qualche tempo nell'ambito del naturalismo postimpressionista. Dal 1894abbandotio la pittura per dedicars! alle arti applicate, aderendo allo " Jugend " di Monaco,secondo una elaborazione lineare. di allusione giapponese, del rloreale. Collaboro attivamenlecome disegnatore e grafico alle riviste « Pan » e « Jugend » e pubblico " Dekorative Enlwurfe "(1907), ehe esercito grande influenza sulla grafica tedesca del tempo. Fu anche disegnalore. assainoto, di caratieri tipogranci, ma anche di oggetti di arredamento, tappezzeric, mobili-.-
Dal 1897 tenne la catiedra di grafica editoriale alia Kunstgewerbeschule di Berlino.
AUGUST ENDELL
(Berlino, 1871-1925). Archiletto e designer ledesco.Sulla scia di Obnst, di cui subi inizialmente 1 ascendenza. aderi allo "h Jugend di Nionaco
Ben presto, distaccatosi dal linearismo di Obrist elaboro un linguaggio personate fantastico e
iraverso la drammatica involuzione della linea, senza peraltro perdere di vista I'unita stilisiicanelle diverse applicazioni artistiche. Autore dello Studio Elvira a Monaco (1897-1898) (distrutiodai nazisti nel '44 come espressione di " arte degenerata ", uno degli esempi piu impressionantidi decorativismo simbolico. naturalistico, lineare, nell'enorme motivo della facciata. quasi al-lusivo di una mostruosita in forme, violent a. e nella ramificata efflorescenza del pi last ro dellascala), e noto anche per il Buntes Theater di Berlino (1901), in cui la sua fantasia decorativa explo-de in tutto il suo vitalismo inquieto e involute e per il Sanatoria di Fohr (1901), piu contenuiostilislicamente. Disegno anche tessuti, gioielli, mobili, in cui la sua carica vitalistica si manifesusenza alcuna remora. Fu anche teorico e scrittore. Dal 1918 fu direttore della Akademie fucKunst Und Kunstgewerbe di Breslavia
Stiamo assistendo al sorgere di un'arte complelameme nuova. un'arle con forme che nonignificano e rappresenlano nienle, non evocafto niente ma possono stimolare il nostro spinto
allrenanto profondamente di quanta possono fario i loni muskali(1898)
CARL FABERGE
(San Pietroburgo, 1846 - Losanna, 1930). Artigiano-artista orafo russo.Note vole interprete della societa deeadente della Russia imperiale, annoiata del reale e
avida di «mozioni artificiali, egU forni i nobili russi dei suo tempo di una varieta infinita di de-liziosi ninnoli. Di origine francese (cio che gioco bene in suo favore, data la esierofilia dei russi).diresse il laboratorio di gioielleria aperto dal padre a San Pietroburgo. EgU si interesso direi-tamente di ogni pezzo che usciva dal suo laboratorio. Prima di fare eseguire un nuovo modelloteneva una conferenza coi suoi tecnici specializzati. La sua caratteristica e il colore degli smalti.che egli riusciva a variare in una gamma quasi infinita. portandone la temperatura dai 600° ai700°, agli 800 , ricorrendo a sovrapposizioiti per ottenere sfumature e ombre.
Una piccolissitna carrozza, riproducente quella della incoronazione del 1893. richiese quin-dici mesi di lavorazione. Era noto per questi ramnatissimi giocattoh per adulti, molti dei quali.
zione. Divenulo famosissimo apri filiali a Mosca, Odessa. Kiev, Londra (1911-1915). ed ebbeun personale di cinquecento persone. legalissime, quasi alia maniera degli artigiani delle bot-leghe medievali, al lavoro del maestro. Questo per6 non pole impedire, airavvicinarsi dellarivoluzione russa. che le maestranze scioperassero contro la direzione. Allo scoppio della primaguerra mondiale Faberge soslitui i metaHi preziosi col metallo da cannone. Nel "17 la Casa Fa-berge. con la rivoluzione e di fronte ad una societa che non aveva pni bisogno dei ninnoli pre-ziosi e raffinati, chiuse una prima volta; riaperta subito dopo fu chiusa delinifivamente dai bol-scevichi nel 1918. Faberge fu coslrelto a lasciare il suo sludio di punto in bianco. Partito perRiga, fu esiliato e fini la sua vita a Losanna.
(Thann. Alto Reno. 1S63 - Brest. 1928). Pitlorc belga.Frequcnta a Parigi l'alelier Colorassi, poi si stabilisce, dal 1869. in Bretagna. Amico di
Gauguin. Serusier. La Rochefoucauld, e attratto per qualche tempo dalla poetica sintetistadella Scuola di Pont Aven. A partire dal 1903 elabora un linguaggio di tipo geometrico. ispiraiosnche dalle icone bizantine e dalle vetrale medievali. Nel 1B92 aveva esposto una serie di operereligiose e mistiche al Salon dei " Rosacroce ". c nel 1891 col gruppo " Les Vingts " di Bruxel-!es. presentalo a Octave Maus da Gauguin.
LOIE FULLER
(Fullersburg. L862-1928). Danzatrice statunitense.Come la Duncan, segue la corrente della ' danza libera '. ma carica il suo personaggio di
tale cornice " estetica ' fino a diventare un idolo simbolico del periodo. Lavorava in teatro finda bambina. ma il suo successo ebbe inizio quando, appunto, riusci a creare atlorno a se un alonequasi magico e di leggenda, con la sua immagine: vestiva una gonna amplissima e lunghissima,di seta trasparente, che faceva volteggiare nella danza in volute vertiginose, aiutandosi con duesottili e lunghe aste invisibili, col soffio di un ventiiatore. e con gli efTetti luminosi che giocavanotra i veli. Divenuta il simbolo astratto della ' danza ' e della linea spiraliforme caratteristica del-l'Arl Nouveau, fu soggetto multiforme di quasi tutti gli artisti del tempo, che per lei reahzzavanoquadri. manifesto perfino un teatro preseniato aiTEsposizione del 1900 (da Henri Sauvage)
della illuminazione e per la scenografia.
EMiLh GALLL-
(Nancy. 1846-1904). Progeltista e ricercatore di tecniche e di impasii materici nell'ane ve-
e a Saint Clement, dopo aver seguito gli studi classici presso il Lycee Imperial di Nancy, nel 186:era a Weimar, disegnatore in una fabbrica di ceramiche. Nel "64 era disegnatore nella fabbnea
trafia, subito dopo passava a Meisenthal, soprattutto per studiare la chimica vetrana.Nel '70, scoppiata la guerra, partiva volontario. Nel '71 visito Londra e Parigi. Nel '74 i!
padre gii affido la direzione della sua fabbrica di ceramics di Saint-Clement, che egli riuni a Nanc>.nella fabbrica vetraria, attorno ad un laboratorio di ricerca sulle tecniche e sui maleriali vetrosi.che diverra la base delle future officine.
Nel 1883 allargava i locali degli studi di ceramica e vetreria, aggiungendovi anche deglistudi di ebanisteria. Una inter a schiera di artisti disegnatori e di teen id lavorava per lui e rea-lizzava i suoi progetti: si formo una vera scuola che Emile Galle avvio ad un floreale naturali-stico per il quale egli raccomandava sempre il modello dal vero. L'Esposizione Universale del '79.alia quale parted po con una grande persona le, lo rese famoso in tutto il mondo.
Da questo momento partecipo a tutte le grandi rassegne internazionali e nel 1900 fu ac-colto all'Accademia Stanislas di Nancy. Nel 1901 fondava la " Scuola di Nancy " di cui fu pre-sidente (vicepresidenti Antonin Daum, Louis Majorelle, Eugene Vallin). Partecipo poi alia fon-dazione dell'Universita Popolare con Victor Prouve ed altri amici e fu tra i fondatori del gior-nale « L'Etoile de TEst v. Al colmo della sua gloria, copiato, imitato, chiamato ovunque, morinel 1904 di leucemia.
Di grande cultura letteraria, filosofica, artistica, Emile Galle riassume, accanto al patri-monio culturale di una citta viva di tradizione artistica come Nancy, i risultati dei suoi perso-nal! interessi, che vanno dall'arte egiziana, lungamenie studiata al Louvre, all'antichita greco-romana, all'arte del vetro nel Rinascimento, che egli indaga nei procedimenti tecnici. dal Me-dioevo all'arte araba, agli Impressionisti, nei quali egli trova un'affinita straordinaria.
La letteratura romantica e anche una fonte inesauribile di ispirazione per il suo sensibilespirito creativo. Le stampe giapponesi di Hiroshighe e di Utamaro sono dei termini diretti per
Ma il riferimento costante resta sempre la natura. filtrata, sia pure, da una sensibilila let-
lico -. ma anche nell'eiaborazione tecnica della materia che gli permette soluziom di grandeinteresse e scoperte importanti.
L'uso di smalti vetrificabili. opachi e traslucidi, gli permette variazioni pressoche infinite:la sovrappewione dei due tipi di smalto. l"uso di smalli traslucidi a ' piccolo fuoco " (gli ' smalti-
Fotografia diGallen-Kallelanel laboratoric
A. Gallen-Kallela.
gioieito ') , gli smalti a " champleves \ a imitazione degli smalti seicenteschi su cristaMo di rocca.gli maid ' acquerellati alia cinese su porcellana di vetro ', il velro ' eglomise" (tecnica eon istente nel chiudere a caldo degli ' smalti-gioiello * dipinti o incrostati tra due strati di \etro)le applicazioni su vetro. 1'incisione diretta o aII"acido, sono aicune tra le mollissime lecnicheipphcate da Galle, che gli permettono effetti partiuolan e irrepetibih. daII imitazione di pieireJure al craquele. ai riflessi ottenuti con vapori parlicolari, all'iridescenza, alia patina
Si tratta di ricerche quasi alchemiche, che Galle custodiva gelowmenteFu legato di amicizia coi maggiori poeti simbolisti del suo tempo, da Baudelaire a Mai Urine
Autore anche di mobili " art nouveau ', li canca spesso di significati simbolici che i mamte tano in un decorativismo eccessivo. che non ha la straordinaria misura dei uoi vein
Scrisse anche '" Contes sur I'Art " e fu collaborator assiduo di riviste d'avanguardia
Dopo esveru ispirato al regno vegetate per le sue decorazioni. voile chiedere al regno n£*I ik' i suoi colori piu deiicati
Incorporando a caldo nel vetro bianco, ordinario, appena uscilo dal crogiuolo. preparati abase mefaltica e vetri polverizzati- Galle varia alt'infinito le ronaliui e le wasparenie dei suoipez-i e li rende simili a pietre prenose-IH. Frantz, in « The Studios, 1903)
l*t? uoslfe rtidici t(iacciono ncl sttolo dei ho.\cltt- tel wttsciiio, pte\so I'DFIO dello slusno t £. Calle
AXEL GALLEN-KALLELA
(Pori. Finlandia. 1865 - Sloccolma. 1931). Piitore finlandese.Esponente del la correme realists in Finlandia fino al 1894 e autore. a Parigi. nel 1889. del-
Ui prima scena di "" Kalevala '", 1'epopea finlandese, si convert! alia poetica simbolista dopolincontro con lo scrittore Adolf Paul, che da Berlino venne a trovarlo nel 1893. Dal 1895 si de-dico anche ailo studio delle arti applicate, soggiornando, per studio, in lnghiHerra. Tornaio inFinlandia riprese, in termini rinnovaii, i temi dell"epopea finnica del " Kalevala ", esprimen-dosi in maniera antirealistica, misticheggiante. favolosa. E autore di arazzi e di panneHt deco-rativi che elaborano in termini art nouveau le component! deila tradizione dccorativa nnlande^c.
ANTON] GAUDi Y CORNET
(RCLIS. 1852 - Barcelona, 1926). Archiletto spagnolo.Nato da una famiglia di tradizione artigiana, studia a Barcelona, alia Scuola di Archi-
tettura. fino al 1878. Grande ammiratore dell'opera di Viollet-Le-Duc, dopo un periodo revisio-nisttco dello storicismo imperante, elaooro uno stile personahssimo e un interpretazione pla^stica dello spazio archilettonico che resta senza confronti anche nell"ambito del pur vivo " Mo-dernismo catalano ", anche se il motivo piii individuabile e un'adesione, spesso un'anticipazione.dei modi e delle linee dell'Art Nouveau. Si devc alia presenza a Barcellona di un interpreie il-ium i nato e intelligente del la cultura del tempo come Eusebio Giiell se Gaudi pote eseguire unnumero di opere cosi importanti e libere da costrizioni. Del 1878-1880 e Casa Views, a Bar-cellona, in netto anticipo sull'Art Nouveau continentale per I'impostazione dinamica dello spa-zio, che in Gaudi non diviene mai, a differenza che negli esponenti piii noti deU'architettura annouveau. lineare, bidimensionale, fitomorfico, ma mantiene caratteri volumetrici, naturalistico-zoomorfici, pur nella sua flessibilila e articolazione.
Al 1884-1887 risale I'esecuzione della cripta del tempio della Sagrada Familia a Barcel-lona, che Gaudi riprendera nel 1887. nel 1903, e a cui si dedichera completamente dal 1910. finoalia morte, e che lascera incompiuto. Del 1885-1889 e il palazzo Giiell. pure a Barcellona. in cuiGaudi elabora, nei grandi portali, il molivo del cancello. creando cosi un flltro tra I'estemo elinterno del patio. Del 1887-1893 e il restauro del Palazzo Arcivescovile di Astorga. ancoralegato al revival goticheggiante. Seguono il Cotlegio delle Teresiane a Barcellona. la casa di LosBonnes a Leon (1892-1894), casa Calvet (1898-1904), la villa di Beilesguard (1900-1902). il parcoGiiell (il cui grande terrazzo terminale, in muratura, dall'andamento ondulato, presents una
la, 1900-1914), casa Miraltes \ 1901 -1902). casa Baitllo (1905-1907). la cui facciata. ricoperta inceramica. si sensibilizza nei colori verde-azzurro di una superficie marina, casa Mild (1905-1910, quasi una ondulata monlagna pietrosa, la cui so m mi la, irla di camini, anticipa elemeniidi carattere espressionisia).
Personaggio inquieto, involuto. di un cattolicesimo fanatico e intransigent*;. Gaudi faceianvivere il significato corale e religioso dello spirito medievale, in un'opera inconfondibile. lacui ascendenza si e protratta fino al superamento recente delle istanze razionali in architetturaNel I92v. mentre, come ogni giorno, si recava dal cantiere della Sagrada Familia. dove ormaiviveva, ad una chiesa dove era solito seguire la messa, venne investilo da un tram. Portato al-I ospedale dei poveri, sconosciuto a tutti, vi moriva tre giorni dopo.
Spariranno gii angoli e la materia si manifeslera abbondante neile sue rotondilii astrali: ilsole i'( penelrerd per i quattro lali e sard come i'immagine del paradiso. Si potrd trar partita daicontraxti e cosi il mio palazzo sard piu luminoso della luce (A. Gaudi).
Intanto I 'uomo non pud fare a meno di parlire dal piano per risolvere i suoi problemi. Qual-che volta ho pensato che la superiore intelligenza degli angeli consista proprio in questo: nelfalto che essi possono risolvere le cose direttamente nello spazio: e una questione che talroliaho proposto ad alcuni teologi, ma essi non hanno voluto saperne (A. Gaudi).
... immenso, insensato mosaico mullicolore e rutilante con iridescenze scintillunti. da cui e/ner-gono forme d'acqua.(S. Dali, a proposito di Casa Battlo)
...lacasa Mild, che p
(F. Pujols, 1911)
Penhe. i qneralmeme, I hdi una lealtd b,«,J<
Lane del grande
d d I d p i
•law e un sogno fan as
\a palpilazio,
i 1 I
ofior di facciala e di pareti..
dusione: la belle:
•cheremo la unitd nelta varietd (A. Gaudi).
a del cannibalismo degli oggetli giustifica i
LUISA GiACONl
(Firenze. 1878-1908). Poetessa italiinjPittrice, poetessa: il suo unico libra di versi, '" Tebaide ", stampato postumo. vide subito
una seconds edizione nel 1911 per i tipi dello Zanichelli e per le cure di G. S. Gargano. Ma fuDino Campana che la ripropose a]['attenzione della critica, inviandone a Mario Novaro, per-che la risiampas^ nella rivista « Riviera Ligure », la poesia " Dianora ", accompagnandola con
piu puro amore delle luci e delle forme " e " una sensibilita neogreca che e quella della vera poesiaitaliana moderna "\ Se alcuni cridci han fatto il nome di Pascoli (evidentemente dei " Primi
dd LUI i muove I'esperienza poelica della Giaconi, ferma rimane 1'osservazione di Campanarelitiva dll^ purezza di que ta voce la cui tensione espressiva e verita di visione si spingono benoltre la pur patetica tematica estetizzante del D'Annunzio e dei suoi honi condusi. Se la si cita,qui nell ainbito del clima floreale se ne vuole nel contempo sottolineare quella pure?za di cantoche ne sostiene, fino a consumarle nella parola-visione, le piu contingent! figurazioni.
AnelitL
Un mislero di lerre ampie cui bagni j la luna -I I q d p I Ib I hedargento un nmlero di ueli schiusi a un lento j sogno d'aurora: e albeggino git stagi placidi come ptttddi astri per lenottt infinite e deifiori, dei chiari / fiori divini come una dokezza , di stelle scesa a lunghi esilisteti: I € una pace di morte ombre cui veli / il pianto della vita, e che rischiari ani-ora Itre.za e la dolcei.a ,della vita... Profondamente tale I I n ma b I d P meun'aurora/diYina.Te.ralitotuocI fio a d o p ng I I ft d I og
Candori.
Nel logo sereno che dorme j veglialo dai lumi del tielo, i {la nolle gli affonda nel cuarei galleggialonto.no un chiarore / immobile, lacitct. informe, j piu lieve, piu dotce di un vela.Ninfee?... che dischiusero i seni / slellanti dal gran cuore d'oro / sgorgato dai placidi laghi? Cigni?ali distese su i vaghi / gktcigli detl'onda che pieni / ne culfant) il bianco tesoro?O spume? piii vaghe. piu vane / di cose, di sogni o parole: / piu brevi delt'ora tnortttle? Chia7 Qualche cosa che sale j di puro dailombra e rimane / mislero di fole. di fole...
Nei muti cam pi del Sogno
Errai nei campi del Sogno I in una bianca. divina .' luce • d'aurora. Oh risioni : di write ili martIonian!! / Oh visioni di slelle I sovra il pallore dei deli! ! Errai per dolci sentieri; : discesi ale valli profonde.
Sbocciavano i fiammei fiori j del desiderio. e di luce j parevano nei iremori j deik luminose ru-giade. / lo sola. mite, serena / in quei silenzi d'aurora j scesi alle valli projonde j ed ai martdell'mfinito.
GIUSEPPE GIACOSA
(Ivrea, 1847- - Milano, 1906). Commediografo jialiano.Educatosi nel solco della scapigliatura piemomese, la cui polemica antiborghese costituiva
uno degl'impegni peculiari, porto, nel rappreseniare sulla scena le crisi private di quell'ambienteche 1'anticonformismo scapigliato piu osteggiava, il tarlo della sua indagine critica, appuntan-dolo sui vizi e i cedimenti dei personaggi di quel mondo. La sua opera di teatro sta tra la ripro-duzione di maniera di un medioevo letterariamente idealizzalo (" La partita a scacchi ") e larappresentazione di una realta sociale (il mondo della borghesia umbertina cui 1'autore stessoapparteneva) di cui coglie piu feiicemente grinqmeti smarrimenti che non raffermazione po-sitiva degl'ideali (" Tristi amori ", " Come le foglie ").
ANDRE G1DE
(Parigi, 1870-1951). Narratore francese.
382
P. S. Kroyer,Ritratlo di Edvard Grieg cdi sua moglie Nina Hagerup.
So nelle opere giovanili (" 1 quaderni di Andre Walter ". " I nutriment! terrestri "J e inalcuni romanzi (" La porta strella '". '" La sinfonia pastorale ") si puo cogliere. nel ripiegamentomeditativo su ambienti e personaggi e nel gusto per una certa musical ita form ale, 1'eco di untono proprio del tempo, la costante indagine razionale dei propri sentimenti e di quelli altnu.
piu un testirnone critico delle vicende. anche estetiche, del proprio tempo che non un proiago-nista altivo neU'ambito di una delerminata scuola o movimento.
EDMOND e G1UL10 DE GONCOURT
(Nann 1S22 thampifenv Ib96 Parigi IS30 1*701 LettLMti L promoton Ji cultura
Po ono es ere con iderati i te timom piu informati e piu tedeh della oueta del loro tempo non oltanto per lo rupolo nel nco iruire attraver o il nimuzioso confronto con la realiaI ambiente del loro romanzi ntti m collaborazione ma part icoiar men te per la loro ossessnjpa lone per le note memoriah'tiche i loro Diaru (dal 1851 al 1895) co tuui ono un itchmo inesauribile di f Hi di persomgg: di iifenmenti i\U cultura di tutu un Lpocs Da NOI
OLCidente
GUIDO GOZZANO
(Torino, 1883-1916). Poeta italiano.Senza intervenire nella valutazione dello spessore estetico della sua opera poetica. ci h-
miteremo a indicare in questa sede il ricco valore document&rio ch'essa possiede in relazionc
fiore del suo programma sta per scindersi da una parte nel ripiegamento crepuscolare della con-solazione borghese e dalTaltra nell'esplosione rumorosa ma eflimera del vitalismo fulunsta. Diquella prima direzione ci pare che I opera eel Wostro sia una peculiare testimonianza-
In to stanza e un scintilfure ,' di pendule crisatidi sopite. • Guardo e sorrido. E un veto1 a r? tiene giii...< B h e C salidi ", 1907-1909).
in ol lo... Mai la morte seppe / piu delicato simbolo di Psiche: I Psiche ad un tempoan n e fa /alia scolpita suite stele funerarie I dagli antichi, pensosi del prodigio.I le Fa falle 1907-1909).
EUGENE GRASSET
(Losanna, 1841-1917). Cartellonista svizzero.Visse a Parigi dal 1871; studio con Viollet-Le-Duc e si interesso di arte giapponese. E auto-
rc di cartoni per vetrate e di manifesti, e anche di opere graflche di carattere proto-art nouveau.Autore di scritti teorici sulla tipografia e suH'ornamentazione lineare di camtere ntomornco.
LDWARD HAGERUP GRIEG
(Bergen, 1843-1907). Compo i t r t norvege e
senso gli fu di stimolo la cono cenza della mu ica ru sa e lava (Ciajkovskij, Dvorak) e la vi-cinanza con Ibsen e Bjornson Comunque la *ua ade tone all mquietudine simbolista e al tita-nismo non valico mai i limiti dl una evocazionc colonslica e folklonstica La presenlazione ddlesue opere a Parigi fu un insuccesso soprattutto per la posizione ironica as^unta da Debuss) neisuoi riguardi. Nei quaderni di " Lyriske Stykker " appare chiara la sua adesione al gusto nVreale, soprattutto nelt'animazione, talvolta febbrile, e nella pieghevolezza lineare della melo-dia. Si puo dire che tutta I'espressivita di Grieg si imposta sul recupero della melod ia popolaredel suo paese, che egli esprime in una forma poetica semplice, malinconica. ispirdta alia natura.vista in un alone reso magico dalla distanza e dai ncordi.
HECTOR G t I M A R D
(Pangi 1867 New York 1942) An.hiteuo e de igner francese.Studio alia Etole de Art-. Daoratif e alia Ecole de Beiux Arts a Parigi, dove poi fu in-
knunte Intere ato ai movimenti di avanguardia contemporanei guardo soprattutlo ad t4ortail mo\imento belga ma ba o il uo tile particolarmente tu motivi floreali. partendo dallalur come i piratrice di po ibihta decorative di tipo funzionale \ Caraltertzzo peraltro la
J i e uberanz^ decorativa con I u o di nuovi material] e di nuove pesso ardite lecniche cosirut-t ^t Le sue opere principal! ono il Ca let Beranger (1897 1898) un complesso di case di ami-
u ii urni i avvicmano ai modelh dl Horta eppure impo tati secondo una diversa. perso-i it i i i p Lt i/ione del imboli mo decoralivo un gruppo di appartamemi a Parigi. rue deII II (1^94 1898) la ala dei concert! Humbert de Romans (1902), ora dislrulta. con co-
n iu> Mi Ii ua opera piu nota anche perche una delle poche realizzazioni art nouveau AJtsiirwione ociale re tano le Sta torn de! Metro a Parigi (1899 1904), in cui la ghisa. dalleb i tre ai o tegm delle lampa <- alle edicole i e pande in fantasiose efflorescence che co-Mitm ono an^he oltre a motivi decorativi le irutture portanli deirinsieme. Molte di quesie
entrate no tate dislrulte: una e stala acquistata da] Museum of Modern Art di New York.Guimard e slalo anche disegnatore di mobili di tipo floreale. che carat ten zza no i iu iememe
Nel 1938 Guimard si reco negli Stati Unili dove mon nel 1942
Quando disegno o scolpisco un mobile rifletto sutio spettacato che ci viene ojferto dalla Na-tura La Beltezza ci appare in una conlirtua varieta, Non esislono parallelism,, e simmetria- lejorme si generano da movimenti del tutto dissimiti-
Mi direte che, jf itpp/no at nu/bili e tigli oggetti di uso i'esempio dei movimenti degli steli.e le dijferenze tra >/r tol ra gtungere un e elio di instability
Niente di pit/ tth • ' < impressione perche stele abituato al mobilio concepitocome i monumenli hanno un significato di sensibility e di espressione as-ai put ehqueme .1 mall re%olan che u toio usate fino ad oggt m atchi-
U V. Cliampier. in " Revue des Arts Decoratifs ". 1899)
K.NUT HAMSUN
(Lom-Gudbrandsdal. 1859 Grimstad, 1952) Scrittore norvegeseLa narraliva di Hamsun (" Pan ". 1892-1894; " Fame ", 1890: " Sot to le stcllc dauiun-
no '", 1906; " Figli del loro tempo ", 1913; " Germogli della terra ", 1917; " II cerchio s\ chiu-de ", 1936) e improntata sul tema dell'unione mistica dell'uomo con la natura che e alia basedelle poetiche simboliste. 11 suo amore per rirrazionale lo porto spesso a degenerazioni retori-che, che spiegano la sua incomprensione per i problemi storici del propno tempo e che lo por-teranno. gia vecchio, ad aderire al nazismo.
PAUL HANKAR
(Krameries, 1859 - Bruxelles, 1901). Architeito belga.Lavoro dapprima nello studio di Henry Beyaert, fino al 1894, traendone alcuni elementi
che diverranno caratteristici del suo rafflnato stile lineare: la combinazione di colori diversi (pie-tra bianca, pietra grigio-azzurra e maitone), in cui poi introdusse Tuso del ferro in funzionestatica e decorativa. graffiti parietali, reminiscenze discrete di motivi medievaleggianti; Tasim-metria fu uno dei suoi elemenii caratteristici, assieme agli arehi a sesto rialzato, bertesche. tet-toie, cornieioni sporgenti, fino a fare dell'architettura un fatto plastico e allo stesso tempo pit-art nouveau. Aveva prerjarato i progetti per una Cite des Artistes, che la morte gli impedi diportare a realizzazione. E, con Horta, la personality piu emergente neU'ambito dell'architetturaart nouveau belga.
Si resta colpiti dal carattere particolarissinw dei lavori in ferro di Hunktir. estremtintenlelineari e disegnati, in rapporto a quetli degli tthri pae.ii (Francia. Austria. OUindtt,. che sono an-cora al rimorcfiio del realismo fioreale.(«Art et Decoration.), gennaio 1901)
JOSE-MARIA DE HERED1A
(Santiago di Cuba, 1842 - Chateau de Bourdonne, 1905). Poeu tr meseFormat osi nel clima parnassiano, esalro al mas si mo grado, di quellu scuola poetic a. il culto
dell'espressione perfetta, sostenuto da un'appassionata ricostruzione dei miti cla sici ed eso-tici, i cui motivi, pure affidati a forme ed immagini rigorose, si prolungano in echi e tension] disogno. L'affinita tematica. non solo, ma anche la predilezione per la ricchezza filologica del-respressione, avvicinano singolarmente non pochi sonetti di de Heredia aU'opera pittorica diGustave Moreau.
Giasone e Medea.(a Gustave Moreau)
Nell'incanto dell ombre, sot to Vampio fogliame I dei boschi. arnica culla dei primitin aliarmi, II'aurora scende e avvivu di luminosi ptitnti ', a loro inlorno straw e ricche fiorilure.Nell'aria profumata dai magici veleni / la sua parola sparge il seme degl'incanli: I I'Eroe la segue,e un alito sulk sue belle armi / sommuove lo splendore dell'illustre Tosone.lltuminando il bosco eon voto di gioieili j grandi uccelli passarono tra le fiorile volte / e nei laghid'argento piovvero azzurri cieli.Amor loro sorrise: ma la Sposa falale j seco portava I'ombre del geioso furore / e i filtri d'Asia eil padre e il sangue degli Dei.(trad. R. Gherardini)
II risveglio di un Dio.
Con i eapelli sparsi e ie gole rnartoriale, irriutntlo ltdpianto I'a.ypru ehrczza dei \cnsi. If Icnnninedi Bibli. con i lugubri accenti, j guidano lamentando il funebre corteo.Sovra leito coniesto di violacei anemoni / ove la Morte chiuse i lunghi ticchi languenti. / riposa ora,di aromi odorato e d'incensi, j il giovine adorato dalle vergini sirie.Fino titl'atba in tal guixa hanno fatto lamento. I Ma eccoio. destar.\i ittl'iippello di Aslarlc to Spu.\omisterioso che il cinnamomo bagna.
Adonais celeste tinga di molle sangue.(trad. R. Gherardini)
FERDINAND HODLER
(Berna. 1853 - Ginevra. 1918). Pittore svizzero.Da uninfanzia difficile e povera (aveva perso il padre a 7 anni c la madre a I4i. da] 18^1
.il 1876 studio a Ginevra con Barthelemy Menn, scolaro di Ingres e amico di Corol. Durante isuoi viaggi conobbe le opere di Holbein, di Raffaello, di Vel&squez e di Diirer e ne ebbe impres-sioni discordami. Nel 1884 incontro il poela simbolista ginevrino Louis Duchosal, ammiraloredi Baudelaire e di Wagner e da allora passo al Simbolismo. esprimendosi secondo moduli di
di un colore piatto, denso, uniforme. Dal 1900 fu membra del'la Secessione berlinese: nel 1904csponeva nella sede della Secessione di Vienna, ottenendo un success^ nolevole. che gli pro-ouro molti inearichi di lavori murali. Un suo uffresco si irova anche nella casa Hohenhoff di Vando Velde a Hagen.
JOStl-" HOFFMANN
(Pirnitz, Moravia, 1870 - Vienna, 1956). Architelto austriaco.Allievo di Otto Wagner airAccademia di Vienna prima della Secessione del 1897. di cm fu.
ton Gustav Klimt e con Joseph 01 brie h, uno dei pro mo ton. La raffinata eleganza di un gustocstremamente corretto e sicuro, che si caratterizza nella raffinata trattazione delle supcrfici eche non rifiuta, come fara poi Adolf Loos, !' " ornamento " (la sua decorazione si definisce nellascansione geometrica di cere hi e quadrati), lo porta ad operare nelt'ambilo deU'Art Nouveau.da lui interpretato secondo un linearismo geometrico caratteristico, che sfocera. in un secondotempo, in un razionalismo raffinato e decantato. Opero con particolare interesse anche nel cam-po dell'arredo e dell'oggetto, si dedico alt'insegnamento, dal 1899 alia Kunsigewerbeschuk.fondava, con Kolo Moser, nel 1903, le " Wiener Werkstatte ", un complesso di sludi e di la-boratori artigiani. Le "Wiener Werkstatte" si collegavano alle "Ar ts and Crafts'* inglcsi:nei laboratori e negli studi si eseguivano oggetti di arredamento, raffinali di gusto e di esc-cuzione, che divennero i modelli piu conosciiui del gusto Viennese, II tentalivo di sanare la di*-sociazione tra artista e produzione incontro peraltro, come era accaduto in Inghillerra. 1'osta-colo della situazione di mercato.
Hoffmann fece anche pane della redazione di « Ver Sacrum », ["organo della Secewone
Nel 1907 fondava poi, con Klimt, la " Kunstschau ", detta la " Secessione della Sece*-zione " per I'indirizzo piu chiaramente avanzato.
Le sue opere an nouveau piu note sono la Casa della Famiglia Sloclel a Bruxellev alcunenotevoli ville a Vienna; nel 1903 realizza il Sanatoria a Purkesdorf. esempio di protorazionalismodalle linee limpide e purissime. Col palazzo Sioclet, a Bruxelles. del 1905, raggiunge Tacme dd*la sua visione lineare di riferimento simbolico, riuscendo a tradurre la ' linea ' art nouveau inuna calligralica, chiarissima definizione spaziale; alia fama del palazzo conlnbui anche il faltoche 1'intemo si arricchiva delle decorazioni musive di Klimt.
La sua panecipazione alia moslra del Werkbund di Colonia. ne] 1914. dove reahzzo il pa-diglione dell'Austria, lo porto a conoscere da vicino il lavoro di Gropius e a voigere la sua n-
Ne furono un primo esempio le ville costruite a Vienna-Kaasgraben (una colonia di vilkrk
Nel 1920 riprendera la sua attivita architeltonica in senso razionalista. men I re ancora tensn td le W ener Werkstatle ". Dal 1912 fu nominato Oberbaurat della citta di Vienna. Veno1 ^ con le case popolari per il comune di Vienna e con le case a sehiera della " Iniemauo-nA Werkbundsiedlung " del "32, pure a Vienna, dove Hoffmann lavoro accanto a Loos. Neu-
Rietveld, Lurcat, egli raggiungeva la sua pill diretta adesione al nuovo linguaggio. Nd "33gl decise la chiusura delle " Wiener Werkstatte " e nel '34 realizzo alia Biennale di Venezu
il padiglione dell'Austria. Continuera il suo lavoro fin dopo la seconda guerra mondiale.
Hoffmann e essenziaimeme razionale e hgko in tulle le tie opere. Le sue composizwni ntmo o ma a aganli e mat mtenzionalmente vixlose- Si limila a studiare proporziom e decora-
o emlta, senza alterarla. la belleiza delle linee originali della costruzione.
(F. Khnopff, " Josef Hoffmann. Architect and Decorator"", in «The Studio ». 190U
LUDWICi VON HOFMANN
(Darmstadt, 1861 - Pillnitz, 1945). Pitlore tede oAllievo. inizialmente, dello zio Heinrich Hofmann aMAccademia di Dresda. studio pm
all'Accademia di Karlsruhe sotto la guida di Ferdinand Keller. Nel 1889 era a Parigi. all'Aca-demie Julian, dove scopriva Puvis de Chavannes e Albert Besnard. Dal 1890 visse a Bethno.membra del " gruppo XI " attorno a Max Liebermann. A Monaco nel 1892. era a Roma nd1900. Dal 1903 al 1908 insegno alia Scuola di Belle Arti di Weimar. Si esprime in una forma par-ticolare di naturalismo, che canca di simbologie paniche. di carattere art nouveau.
VICTOR HORTA
(Gand. 1861 - Etterberck, Bruxelles, 1947). Architetto belga.Di modeste origini (era liglio di un falegname di Gand), ando a studiare a Pangi. dicia>-
settenne, contra la volonta del padre. Fini poi gli studi presso I'Accademia di Belle Ani di Bru-xelles (1881) ed entro nello studio di Balal, un architetto neoclassico. Dopo una prima realizza-zione a Gand (tre edinci in cui gia traspare un grande talento architettonico. seppure lontanoda quelle che saranno le grand! tnnovazioni future), alia morte di Balal divenne capo dd suo
studio e realizzd nel 1892-1893 V Hotel Tassel, a Bruxelles, che rappresenta quasi il manifestoprograminatico dell "An Nouveau: 1'edificio a quattro piani. inserito strettamente Ira altri edi-fici, rinnova alia base il concetto di casa di abitazione, rompendo la pianta tradizionale col so-slit ui re al class ico corridoio un veslibolo ottagonale da cui si liber a la scala che deter mina laripartizione dei piani e I'impostazione dei locali in una continuity spaziale che diverra caratte-ristica del movimento moderno.
L%impostazione lineare che unisce suuttura e decorazione crea una fluidita spaziale e unaleggerezza nello sviluppo plastico, che Tuso del ferro (usato per la prima volta come materialcda costruzione nell'edilizia privata) articola in un decorativismo vitalistico di riferimento sim-bolico naturalistico che diverra repertorio costante dell'architettura art nouveau: la linea a• coup de fouet' (che si definira anche ' linea Horta ") si traduce nel lavoro di Horta in elementoplastico tridimensionale, con "na chiarezza di significati che ha pochi confront!. A questa primarealizzazione seguiranno la Mmson Horta (1898), casa Sohay (1895-1900), THdtel Wissinger(1895-1896), Hotel Van Eetvelde (1897-1900), Hotel Aubecq (1900), i Magazzini a {'Innovation
9 d M d P p 9 0 d h g m p
r u m d m p d m p e MO B
g d p mp m
m p 'Aceademia di Belle Arti di Bruxelles, diDal '16 al M9 g
B es m d p Pi.B 9 8 pe d q od
d guerra mondiale. Dal 1935 al '45 Horta realizza, secondc
B
Q d m gggl dag
d h p dg d d d
Horta " Expose des motifs pour 1c choix denmtif d un emplacement pour la Bib]Albertine ". in « Bulletin de la Classe des Beaux Arts >.. XXI BDodi, m
che non potro mai raggiungere, vana espe md d p f> m d q
Horta, - Memorie ", a proposito dell'Ht
Quando tullo e semplke e facile, egli allora crea difficolta per il gusto di superurte e risoherle.Fa urlare e gemere la materia, e insomma un Titano(da una lettera di J. J. Eggericx, allievo di Horta, a Tschudi Madsen)
WILLIAM HOLMAN HUNT
(Londra, 1827-1910)- Pittore inglese.Tra i fondatori e membro della Confraternita dei Preraffaelliti, fu autore dei primi quadn
ispirati alle idee preraffaellite esposti in pubblico, nel 1849. Mentre fu assente dal Salon degliArtisti inglesi del '59 a Parigi (cosa di cui, in una lettera al direttore delta « Revue Francaise ».si lamentava Baudelaire, che aveva potuto ammirario alia Esposizione Universale del m55). In-coraggiato da Ruskin si volse alia pittura religiosa. Allo scopo di reallzzare scene della vita diCristo si reed tre volte in Palestine. La minuziosa aderenza al reale si unisce, nel suo lavoro, adun simbolismo alle go r ico, che aggiunge un alone di mistero e di magia arcana. Hunt e autore diun interessante libro di memorie " Pre-Raphaelitism and the Pre-Raphaeliie Brotherhood"(Preraffaellismo e la Confraternita dei Preraffaelliti, Londra 190S).
JORIS-KARL HUYSMANS
(Parigi, 1848-1907). Lelterato francese.La sua opera piu famosa, " A ritroso '* (1884), e stata definita " la bibbia del decadenti-
imo %\ Sicuramente La piu ricca di succhi simbolistico-floreali, per cui in essa puo attingere apiene mani chi voglia comporre un florilegio inesauribile delle squisite predilezioni di quel mo-mento esietico in ogni campo delle arti e delle attivita umane, dall'antichita, al medioevo linoall'eta contemporanea, essa rimane anche, e proprio per questo, la piu coll oca ta nel suo tempo,identificandosi IntegraIraente con le propric proposte e facendo di Des Esseintes, il protagoni-sla, 1'ipostasi piu completa delle aspirazioni estetiche del momento, riferendone ogni scelta,tanto nell'ambito delle arti quanto in quello della vita, ad un program ma univoco. Per un piiistretto riferimento alle arti figurative, si veda il V capitolo, con t'esaltata apoteosi del I" opera diMoreau interpretata fin oltre i suoi stessi, gia sovraccarichi, simboli.
Si acauisto cosi la reputazione di eccentrico e la completd vestendo abiti di velluto bianco,sottovesli ricamate d'oro, dando ai letterati desman di cui parlava tutta la cittd, uno fra gli ultri.ripreso dal diciotlesimo secolo. in cui. per celebrare il piu futile degli infortuni, aveva organizzatoun banchetto di lutto...("A rebours", 1884)
HENRI IBSEN
(Skier, 1828 - Cristiania. 1906). Dram mat urgo norvegese.II suo impegno di fornirc alia Norvegia una drammaturgia nazionalc. mentre apre la \ia
al dram ma di impostazione borghese, rientra nel gusto del nazionalismo romantico. al qualesi attennero molti scrittori simbolisti. L'indagine psicologica. I'introspezione, la cupa dram-maticita, fan no del dramma di Ibsen una delle fond letterarie non solo per gli sermon simboh-sti, ma informano tulta un'epoca di un carattere di inquieta ansia spirituale. alia quale si ispira
VENCESLAO IVANOV
(Mosca, 1866 - Roma. 1949). Poela russo.L'influenza del pensiero di Nietzche e gl'interessi di studioso di antichita greco-roman*
sono alia radice della passione per 1'antica religions dionisiaca da cm la sua opera e pervasa:anche il suo stile risente degli atteggiamenti di un misticismo quasi rituale. liturgico. in un con-
tecnico lende ad esaltare.
Come un logo io sonnecehiavo. Con gelide correnti i le agate delle rocce portarono dnni neiiamia aputenza, i e i pesci agghiacciarono con sinuose lame lunari • I'assopimento dei miei tin
II mio serpe maestoso, incoronato fta gli allri serpenti, / cercava recortditi gorghi ne\ia mia ca-ligine, / <• galleggiava fametista. e luccicava lumido rubino / nelle profondila di smeraldo. ac-cese dalle squame.Io ero sordo e cotmo.' ed il fondo di pietra / mi accarezzava. Ma delta coppa montuosa la co-noscevo il cratere notturno, spalancato nella voragine.Corne esprimere in breve il miti infermo languore? i hi la vita scorreva in una fluente calura nu-ittla I e la fineslra abissale beveva la torrida sorgente.(trad. A. M. Ripellino)
CHARLES EDWARD IVES
(Danbury, Connecticut, 1B74 - New York. 1954). Compositore stalunitense.Amante della sperimentazione e della ricerca, studio stereofonia, armoma e contrappunto,
esploro le pill diverse sorgenti sonore, slrumenti a percussione, pianoforte, cornetta. liolinoLa sua musica e ricca di material] tratti dal folklore americano, si distingue per le ardue esp«-rienze armoniche e ritmiche, per 1'uso della politonalita, per le soluzioni atonali, seriali. per la
ricerche europee con tern pora nee .
JUAN RAMON JIMENEZ
(1881-1958). Poeta spagnoloLa purezza del suo lirismo loglie a lie immagim di questa poesia quel polline impalpabilc
di prezio i mo che parrebbe collocarle nell'ambito di una visione accarezzata dalla " nusica "
trno dalla luce, con la memona. solo e fresco nell'aria della vita "
I Ottobre.
I // sole tia la piacida at qua puru Indiirti al flume i suoi londi verdini; ! Le loglie secche vannoI i : gel ommi Ulnmi nella luce alia \enturuI 1 erde tl cielo alia piu libera altura Della ua vastita. lascia i confini, Del mondo in un esrrem>I di giardini / D'illusione. Sera impentura'I Che pace! Cama un passero e si posa / Sultalbero. Una nube color d'aria , Svanisce. una far/alia
I Luce s'immerge nella luce. Sate ! Da lulto nun so die alito. ch'esala .. Tristc di non morire ptu
I (trad, di L. Traversoj.
I Viene una musica lunguida. . non so da dote, nel! aria. Luna. Mi sono affaccialo per \edertI che cosa ha il parco.I La luna, la dolce luna i tinge di bianco gli alberi. , e fra i lami. la fonte . alza il suo filo it
I In w/i a rif It' sielle / irentun: ionlano. il paesaggio j muove malinconiche luci. i iatraii e lunghi ahiI / uihi da un aitro orologio. I Da pena guardare il parco / pieno d'anime, alia musica triste che
I \ASSILU KANDINSKIJ
I (Mosca, 1866 - Neuilly-sur-Seine, 1944). Pittore russo.I La personality complessa di Kandinskij e uno degli esenipL piu autorevoli del rappono traI I'Art Nouveau e Ie seguenti avanguardie storiche. Quando infatti egli, abbandonati gli studi| di diritto in Russia, — e gia si era interessato alia cultura primitiva e all'arte popolare russa -.
personale. desunto dalla linea come elemenlo-sintesi della sua sensibilita musicale e decorativa.
in cui egli fondava il gruppo " Die Phalanx "" a Monaco (1901). E sara il momento di passag-gio. atlraverso il periodo fauve della " Briicke ". che approdera al suo primo Acquerello astrai-
GUSTAV KL1MT
Dopo aver seguito i com alia Scuola di Arti Decoraiive di Vienna, dal 1876 al 1883. conSaufberger e con Makart, dal 1880 lavora col fratello Ernst e con Franz Maisch per decora/ionie affreschi (soffitti per i lealri di Reichenberg, Fiume, Karlsbad, del Burgthealer e del Kunst-historisches Museum di Vienna); alia morte del fratello, nel 1892, il gruppo si disperde. E il prin-cipale esponente del Gruppo della Secessione Viennese (1897) e il primo presidente. Collabo-
grazione tra le arti. Formatosi sui maestri del Rinascimento, sulla scia di Makart, aderi dapprimaal Post impression ism o. Elaboro poi. verso la fine del secolo. un iinguaggio ispirato a lie mag-giori esperienze dell"Art Nouveau. da Tooropa Von Stuck, da Beardsley a Mackintosh a Khnopff,giungendo ad una interpretazione tutta personale del linearisnw bid intension ale decorativo.di riferimento bizantineggiante (nel 1903 era a Ravenna e i fondi oro dei mosaici bizantini e labidimensionalita lineare di questi lasciarono in lui grandi tracce). con una sontuosita di ca-
visione artistica. Dopo una serie di opere impostate su un nuovo caratlere timbrico, dai paesag-gi intesi come efflorescenze vitalistiche alle opere come GiudillafSalome, Danae, Salome, LitVerging. Le Ire eld delta donna, nelle quali, anticipando le modaiila proprie del Cubismo sin-tetico. inserisce materie diverse (pietre. metalli...) e dove il suo decorativismo si imposta comefatto di astrazione bidimensionale (si vedano i fondi dei quadri a minutissima decorazione geo-metrical, egli si trovo in lotta contro tutte le autorita accademiche: nel 1905 rifiutd il premioVilia-Romana (che aveva vinto con Hodler e Hiibner); rifiuto poi Hncarico di professore al-l'Accademia di Vienna; nel 1907, ritiratosi dalla -Secessione" fondava, con Hoffmann, la" Kunslschau " (la " Secessione della Secessione "). Nel 1906 era a Bruxelles dove eseguiva ladecorazione musiva nel palazzo Stoclet di Hoffmann.
rrattanto i panneln decorativi per il sonitto dell Auls Magna dell LJniversita di Viennagli venivano rifiutati; nel 1907 era a Londra, nel 1909 a Parigi. Dal 1912 divenne presidentedeirUnione Austriaca degli Artisti: anche il suo stile ' dorato * si trasformava con la scelta dicol or i diversi, ispirati a Matisse, e con I'acquisizione di una nuova morbidezza naturabstica.in conirasto con la rigida stilizzazione lineare che gli era stata propria.
11 suo nome si diffbndeva. intanto, all'estero e si inseriva tra i nomi di fama europea. Eraprofessore onorario all'Accademia di Vienna e di Monaco, quando. durante 1'epidemia di spa-gnola che precedette la fine della prima guerra mondiale. ne fu colpito e perse la vita.
L'ornamento di Ktimt e una metafora della materia primordiale senzu limiii e intinitatneni?mutevole - rotante e turhinanle, che si altorclglia e serpeg%iti e ifltreccia. un turbine fiammeg-gianle che assume tulle le forme, lampi guizzanti e dardeggianti, lingua di serpenti. viiicci uvi-trt-ghiati, carene inviluppale e veil slitlanli.(L. Hevesi. " Allkunsl Neukunsi. Wien 1894-1908"". 1909)
MAX KLINGER
(Lipsia. 1857 - Grossjena bei Naumburg, 1920). Pittore. incisore. scultore tedesco.Studio all'Accademia di Carlsruhe sotto la guida di Grussow che. nel 1875. lo conduce
con se a Berlino. Nel 1878 deslo grande scalpore esponendo alia esposizione annuale dell'Ac-cademia di Berlino due serie di disegni. Serie altorno al tema di Crislo e Serie sul ritrovameniodi tm Guamo. che furono. peraltro. acquistale dail'Accademia. Ma. a causa della ecceniricitiidi quest! lavori, FCIinger fu costretto a lasciare la Germania; si reco a Parigi dopo aver soguioi-nato per qualche tempo a Monaco e a Bruxelles.
In Italia dal 1888 al 1890. lavoro nello studio di Bocklin. A Lipsia nel '93 faceva della suacasa un centra di ritrovo della vita mondana e artistica cittadina. Dal 1897 insegnava all'Ac-cademia di Lipsia. Dal 1903 visse a Grossjena. Dedicalosi anche alia scukura. vi introdus^e1'uio della policromia. II suo simbolismo, per il quale egli subisce le ascendenze le piu disparate.dal mondo classico al realismo magico di Bocklin, passando per Goya. Puvis de Chavannes,Rodin, Von Marees, si personalizza in un linguaggio quasi surreale, molto intlucnzato da unafantasia portata al fantastico. ad una sorta di erolismo freddo, cerebrate, da component! psi-canalitiche. I suoi mosiri, descritti nei minimi particolari, appartengono al mondo dell'onirico,ma le sue composizioni raggiungono talvolta una incisivita fantastica che le avvicina ai collagesdi Ernst de La semaine de home. E uno degli artisti prediletti da De Chirico.
FERNAND KHNOPFF
(Gremberger-lez-Termonde. 1858 - Bruxelles. 1921). Pittore. scultore, incisore e criticod'arte belga.
Di famigla pa za I sc gl d legali all'Universita di Bruxelles. studio con XavierMellery e all'Accademia di Bruxelles. Nel 1877 si reco a Parigi dove subi fortemente Tascenden-za di Gustave Moreau. pur frequentando Tatelier di Lefevre e TAcademie Julian.
O. Kokoschka.
Alma Mahler. 1913.
Molivi simbolico-misiici si rilroveranno sempre nel suo lavoro. che si rifa anche, con uiTac-centuazione di caraltere surreale. all'idealismo mistico dei PrerafTaellili. II suo ideale esteiicoe rappresentato proprio da Gustave Moreau e da Burne-Jones, i cui nomi egli faceva campeg-£?iure, incisi in due anelh di bronzo, alia parete di una stanza completamente vuota della suainquietante, sir ana casa, dai grandi tendaggi scuri, arredala da lui slesso come un lempio \o -inio narcisisticamente alia soliludine. Man ten ne molli rapporti con la German ia, particolar-
gano delta Secessione Viennese, nel 1898. Nel 1884 fu Ira i fondatori del gruppo " Les Vingts ".Amico dei poeti della sua generazione. da Maeterlinck a Verhaeren (che scrisse anche sulla suaopera), interessato airidealismo mistico di Ser Peladan, il fondatore del gruppo dei " Rosa-croce ", permeo la sua raffinata ricerca pittorica, svolta sempre con I'uso di mezze time, di unospiritual is mo emgmatico, ambiguo, carico di mistero e di riferimenti simboiici (la donna comeessere ambiguo, misterioso. dispotico, seducente, quasi sfinge nata da un mondo di verso daquello umano - che diviene poi anche i\ simbolo deirarte e delta poesia come element! magici.misteriosi, evocativi di sogni). La sorella minore> che poso spesso per i suoi quadri. incarna ilsuo tipo di ideale femminile. L quadri di Khnopff portano spesso come titolo versi di poeti sim-bolisti e preralfaelliti. II tema delta soliludine e del mistero domina quasi tutta la produzionedi Khnopff. Partecipo at primo Salon dei " Rosacroce " a Parigi nel 1892. Decoratore. scul-tore, artista mondano e un po' dandyh si specializzo in ritratu dj bambini e come paesaggisia-Arredo rHotel de Ville di Sainl-Gilles, il Teatro de la Monnais a Bruxelles e la sua casa.
OSKAR KOK.OSCHKA
(Pochlarn. 1886). Pillore austriaco.Formalosi nel clima della Secessione di Vienna, amico di Klimt e degli alln esponenti della
Sccessione, dedico a Klimt le sue prime incision). reaLizzate per un suo delizioso Libretto per bam-hini " Sogni di fanciulli ". 1908, che coincidono col suo periodo piii vicino ai modi secession!sii.imbevuto di allusioni all'arte popolare e al folklore austriaco. L'amicizia con Tarchiietto Loos.che pone le basi della rottura col concetto di ornamento, caratteristico deirArt Nouveau isjricordi il suo libro " Ornamento e delitto " del 1908), lo porto poi sempre piii verso un attec-yiamento eversivo, che sfocera nella collaborazione alia rivista « Der Sturm », considerala unodegli organi deirEspressionismo. Da questo momento la sua storia appartiene a quella di que-
PAVEL WARFOLOML1VITCH KOUSNETSOV
(Saratov sul Volga. 1878 - Mosca, 1908). Piltore russo.Allievo della Scuola di Pittura, Scultura, Architettura di Mosca, assieme a Pelrov-Vodkine.
di cui fu amico, risenti molto della maniera pittorica di Borissov-Moussatov. Tra il 1902 e il1908 fu uno degli esponenti maggiori tra i giovani pittori simbolisti russi, attorno al gruppo" La Rosa azzurra »; fu anche legato alia rivista « La Toison d"or ». A Parigi fu membro delU.giuria del " Salon d'automne". La sua adesione al Simbolismo, che cessa col 1910. si esprimetn maniera particolare. con una ehiarezza e linearita espressive, di tipo ascetico-mislico.
FRANTISEK K.UPKA
(Opocno. Boemia. 1871 - Puteaux, 1957). Pittore cecoslovacco.Lavoro dappnma come sellaio, poi come verniciatore presso un artigiano che gli insecno
In so del co I ore. Si dette allora a disegnare insegne per negozi e il sindaco del paese lo fece slu-diare presso un professore ed en tra re poi, flno al 1888, alia Scuola di Belle Arti di Praga. Finda allora si interesso allo spiritismo. Nel 1892 era a Vienna e nello stesso anno si trasfema aParigi. Qui comincio ad illustrare giornali satirici (« Le Canard sauvage »; « L'assiette au beur-
zialmente al mondo simbolico, secondo una visione fantastica, onirica, quasi medianica. Passopoi ad una progressiva scansione ntmica dell'immagine, per arrivare a quella che Apoilinairedefini la sua * arte orflca *, vicina. per certi aspetti dinamici (anche se svolta secondo ntmi li-neari paralleli, su segment] di retta, oltre che sul cerchio) all'operazione di Delaunay nel suocubismo orfico'.
LA L1NEA
La bellezza delle forme e prodottu da linee nascent! t'lina dalt'tillra in ondula-iom graduah.(O. Jones. "Grammar of Ornament ". 1856).
Ciii che neila vita e geslo, movimemo. caraltere, espressione degli esseri rivemi e co!loca:ionedegli oggetti. nell'opera a"one divenla tinea.(F. Bracquemond. " Du Dessin et de la Couleur", 1885).
La tinea ha it compile di evocare quei complement! di cui la forma e ancora sprorvisia ma chesentiamo indispensabiti.
Quesll rapporti sono rapporli di slrullura e la tinea che li stabilise? ha il compito di suggenrelo sforzo di una energia. la dove la linea della forma palesa una riflessione la cui causa non appareevidente...
L'ornamento cosi concepito completa la forma: ne e il prolungumetilo.La nostra ornamentuzione e nuova sollanto in virtu della cttscienza da not at-quisita delta na-
tura della linea.(H. van de Velde, " La linea e una forza ", 1923).
RENE LALIQUE
(Parigi, 1860-1945|. Disegnatore. creatore di gioielli c decoratore francese.Dopo aver studiato alia Ecole des Beaux Arts a Parigi si dedica al gioiello aprendo una
gioielleria a Parigi. J suoi raflinati e preziosi gioielli si ispirano a motivi fitomorfici e floreali.di tipo naturalistico. Si dedico anche alia realizzazione di oggetti, alia creazione di vasi in vetroe all'arredo. Espose nel 1895 al Salon des Champs de Mars e partecipo alia inaugurazione delnegozio " L-Art Nouveau " di Bing, aperto a Parigi nel 1895.
RAOUL FRANCOIS LARCHE
(Parigi, 1860-1912). Scultore IVancese.Seolaro di Jouffroy. atlivo a Parigi, e Ira gli scultori francesi il piii sensibile allc isianze dcl-
I'Art Nouveau, Partecipa alle esposizioni del Salon dal 1884.
( \RL OLAF LARSSON(Stoccolma, 1853 - Sundborn, Falun, 1919). Piuore e grafico svedese.l-ormatosi sullo studio degli antichi, approdo ad un suo rafRnalo linguaggio pittorico die
Jo pond, partLColarmente nei ritratti, idealizzati in un alone di sogno, e nelle piccole composi-tion! ad acquerello, ad aderire ai modi del Simbolismo internazionale. Negli acquerelli si ag-giunge un gustoso umore popolaresco che egli non raggiunge neppure nelle sue grandi realizza-zioni, quali gli affreschi nel Teatro dell'Opera e nel Museo Nazionale di Sloccolma.
LUC1EN LEVY-DHURMER
(Aigeri, 1865 - Le Vesinet. 1953). Pi I e eSiudia dal 1879 alia Scuola Comunale di disegno e di scuitura a Parigi, per seguire, poi,
le lezioni di Raphael Collin. Premiato 11 E po z one Un ver ale d Parigi del 1900. Lavorailapprima come decoratore. In seguilo, verso il 1895, visita ['Italia e prende coscienza delle suepredilezioni per 1'arle classica ilaliana e per i Preraffaelliti. Espone nel 1896 a Parigi, presso Geor-ss^ Petit (in qucsta occasione aggiunge al suo nome. Levy, una pane del nome della madre, Gold-
ffl i ela-m Lor-
gi Eden.
•Dhurmer non voile appartenere a nessun arcolo.Rodenback. Dopo il 1901 abban-
c Do-
ADOLF LOOS(Brno. 1870 - Kalksburg. 1933). Archiletto austriaco.Studio al Politecnico di Dresda e nel 1893 era negli Stali Unili a visitare ["Esposizione di
C htcagO- Lavoro a Vienna, aderendo limitatamente ai moduli lineari art nouveau. proponendo.contro I'ideologia riduttiva del disegno, tendente a dividere nettamente i processi elaboratmdel progetlo, una piu diretla atksione alia realta con mezzi empirici; da questa sua imposia-zione teorico-pralica deriva la sua polemica con la Secessione e la distinzione esatta, da lui ri-proposta, tra ' arte ' e ' architettura '. ! so] a to rispetlo alia situazione Viennese, fu amico di espo-nenti internazionali delle avanguardie, da Schonberg a Tzara. E autore di un celebre Mggio" Ornamento e delitto " del 1908 e di una rivista « L'Altro: periodico per I'introduzione dellacivilla occtdentale in Austria ». 11 suo linguaggio architettonico si attiene ad una bneanta e aduna purezza coslruttive per le quali i suoi studi americani furono determinant!, dalla lezione dellaScuola di Chicago (come le strutture metalliche, introdotte da Le Baron Jenney nell'architetiura
memo armato in vista). Tra le sue opere: villa Karma, Montreux, 1904; Casa Sterner, Vienna.1910; palazzo per Uffici Goldman in Michaelerplatz a Vienna, 1910 e alcuni bar famosi, eomeil Cafe Americain a Vienna. Dal 1920 al 1922 diresse 1'ufficio per la pianificazione di Vienna.Nel 1923, a Parigi, entrd in rapporto con gli animatori di <> Esprit Nouveau » e col gruppo da-daista; nel 1926 costrui la casa di Tristan Tzara, Lavoro in seguito aneora a Vienna, a Praga.
... i pittori, gli scultori, gli arckitetti abbandonino i loro comodi studi, rinuncino alia bro helia(trlt i i njettarjt) atl'incudifie. at telaio, al tornio da vasaio, alia fornace, al banco del falegntttne!
vila dalle ubitudini, dalla comodita e dall'utitita.Forza compagni, Varte e qualche cosa che si deve superare.
(" Samtliche Schriften ". 1897).
JEAN LORRA1N
(1855-1906). Letlerato e critico letierario francese.Tipico esponeme della generazione dei letterati ' decadenti ', amava tingersi i capelli di
rosso (come, del resto. Baudelaire, di verde). pettinandoli in avanti sulla fronts, per far la sem-brare piu bassa. come quella di un malvivente. 1 suoi romanzi perversi, carichi di erotismo edi sado-masochismo. sono il simbolo della sua inquieta personality di disadattato, caratleristica
Sem. cancalura di
della tipologia decadentista. Tra i suoi romanzi " Tres russe" (Mollo russo, 1886);- Princessesd'lvoire el d'lvresse "" (Principesse d'avorio e di ebrezza) 1902; " Monsieur de Phocas " (1910):" Histoire de Masques " (Storia di maschere), tutti improntali a impressioni di terrore. di lus-suria. di fantasia malata e alludnata.
FRANCES MACDONALD MCNAIR
(Glasgow. 1874-1921). Designer e decoratrice scozzese.Sorella di Margaret Macdonald. studio presso la Scuola d"Arte di Glasgow e, con la sorel-
la. con Charles Rennie Mackintosh, con Herbert McNair (che sposo nel 1899). fece pane del'" Gruppo dei quatlro ", il gruppo che costitui la " Scuola di Glasgow ", esponente principalcdel movimento scozzese di Art Nouveau. tsegui molti lav on di decorazione in gruppo e conMcNair e partecipo alle principali rassegne di arli decorative internazionali. Fedele ad un raf-finato linguaggio lineare. di car a Here si m bo list a, contribui alia definizione di una immaginecaratteristica del gruppo scozzese. Dal 1907 fu insegnante di arti decorative alia Scuola d'Artedi Glasgow.
MARGARET MACDONALD MACKINTOSH
(Glasgow, I865-1933|. Designer, arredatrice, deeoratrice scozzese.Fece parte. con Mackintosh, che sposo nel 1900, con la sorella Frances, con NcNair. del
"' Gruppo dei quattro " che porto al rinnovamento dell'arte in Scozia e fu il principals esponeniedell'Art Nouveau inglese al suo secondo momento. quando gia le esperienze continental], par-(icolarmente belga, erano state universalmente assorbite.
Di lei sono noti sopraltutlo i pannelli decorativi, svoiti secondo un linearismo simbolicodi carauere fitomorfico, risolto in costruzioni simmetriche, bidimensionali. in cui un ramnalolirismo si unisce ad un senso vivo del fatto decorativo. Di pregevole fattura anche alcuni lavonin metallo e le molle opere in collaborazione con Mackintosh.
CHARLES RENNIE MACKINTOSH
(Glasgow. 1868 - Londra. 1928)- Archiletto. decoratore, designer io»ese.Studio alia Scuola d'Arte di Glasgow dal 1885. Nel 1890 era disegnatore presso la dilta
Honeyman & Keppie di Glasgow. Intanto il gruppo dei " Glasgow Boys " (Guthrie. Laver>.E. A. Walton) esponeva a Londra alia Grosvenor Gallery. Si diffondeva cosi a Londra Tinie-resse per I'attivita culturale, viva e dinamica, di Glasgow. Intanto. nei '94. su « The Magazine <•uscivano i primi disegni del futuro fondatore della " Scuola di Glasgow ", suscitando grande
calligralico, estremamente raffinato, che conciliava il Simbolismo con la struttura classica catat-icristica della sua formazione di archiielto. Nel "96 un gruppo di piltori, architetti, decoraionscozzesi esponeva a Londra, alia " Arts and Crafts Exhibition ". Subito dopo Mackintosh,che aveva formato. con le due Macdtmald e McNair il " gruppo dei quattro ", ottiene i primiimportant incarichi: il direttore della Scuola d'Arte di Glasgow, Frances Neuberg, gli afndail progetlo della nuova sede della scuola (iniziata nel '99) e gli viene commissionata la deeora-zione delle Sale da The di Miss Cranston, decorazione alia quale collaborarono, quasi sempre.anche le Macdonald, divenute mogli. Frances, di McNair. Margaret dello stesso Mackintosh.
L'architettura di Mackintosh si imposta gia secondo un linguaggio sottilmenie anticipa-tore del movimento neoplastico. Gli arredamenti e i mobili di Mackintosh rappresentano quantodi piu perfetto sia stato realizzato dall'Art Nouveau al suo stadio piii maturo. Gli element! sim-bolici, n to mo rnci, sono contenuti in un Lineansnio di raninata e semplice scansjone ritmica.secondo una visione di equilibrio perfetto, paradigmatico. Tra le molte opere di architetiurala Hill House a Helensburgh (1902-1906), la casa Bassel-Louke a Northampton (1906). la Wind-hill House a. Kilmancou(l902), un progetto di casa per un amatore d'arte (presentata ad un con
I 1911) 1 ff g h d II za Up I segne
dh dd 1 1 f m II g fi d d fi ]I 1 d fi d M k h m
T f d 1 1914 1 p 1 mp d1 :bbe piu incarichi di architettura. Esegui invece progetti di mobili che d
d l d l l d m d g f T S m 1 I1 923 f P V d Id d d p II pal disegno, raggiungendo risultati di grande raffit za d se b I tafi 1 q I puo esser paragonata sol Ian to a quella di Klee. M< I
bb d m m d II boc
Q m d I I d f I II bl I d II
Q II p d b II g g I I 1I Id I d b d su m 1 p I h I no
la loro fatlura a strutture e pannelli • d'itte, dalVaspelto Candida e grave di fancivlie pI S C I
d / h i p d d p un II m h Ias linee di una limida eteganza, simile a un'eco lenue e lonlana di van de Veide
Ilf I I mcui sono slali disposli uno smaito, un vetro coloralo. una pietta dura, un ferro baUuto, seduconogli arlisti...
Qui e'era misticismo ed estetismo, sebbene per nulla in senso cristiano. ma che sa motif dielknropio, di mani ben curate, e di una delicata sensualila.
Quasi in conlrasto con la precedents esuberanza non e'era quasi nulla in quelie stanze, eccetto.dico, quelie due seggiole dirille, con gli schienali alti come un uomo, che, poggiando su un tappeio
Charles Doudelet.
bianco si guardavano reciprncamenre I'una iallra di sopra una tavaia smilza con un'aria silenziosa
(A. Hestermann. sulle opere di Mackintosh present) ad una esposizione a Vienna. 1900).
ANTONIO MACHADO
(Siviglia. 1875 - Collioure. 1939). Poeta spagnolo.
trasparente realta oggettiva, la sua poesia e sicuramente tra le meno legate allo spirito del tempo,d a a non ignora i sapori. La protegge da ogni indulgenza alle penombre simbola Ft ape esprimere la liberta del proprio mondo affettivo pur nella per e on mn
mondo degli oggetti. in un rapporto, integro e diretto, di lineare. luminosa chi
p ga a cgg<
Q a an a n d f ag n g n d n
d M
ARTHUR MACKMURDO
(Heygaic, 1851-1942). Architetto, designer, economista inglese.Verso il 1850 fu incoraggiato da John Ruskin verso rarchitettura. Nel 1882 con Herbert
Home, Selwyn Image e Bernard Creswik, fondo la " Century Guild '", una associazione coope-rativa di artisti-artigiani. Si dedico anche alia tipografia, alia decorazione su stoffa, alia graficapubblicilaria. Scrisse, tra 1'altro, " Wren's City Churches " (Chiese di Wren nella citta di Lon-dra) che pubblico con una coperlina in xilografia. nella quale appare, per la prima volla. in In-
Dal "lu fu"anche ed^ore"^']™rivista della Century Guild, « The^lobby ^ o r s e " *Tra le operedi architettura, che egli tratto secondo un andamento lineare orizzontale, diverso da quello dellatradizione inglese. si ricordano due case a Bush Hill Park (1873-1883). la Mempes HOU.K (1399).e, in collaborazione con H. Home, il Savoy Hotel di Londra (1889). Dal 1900 si ritiro nello Esses
HERBERT MCNAIR
(Glasgow, 1870-1945). Arehitetlo. decoralc-re. illuslratore scozzese.Studio alia Scuola d Arte di Glasgow Lavoro inizialmente presso la ditla Honeyman and
Keppie. dove conobbe Charles Rennie Mackintosh, suo futuro cognato, col quale inizio unacollaborazione assidua; con lui e con le sorelle MacDonald, una delle quali, Frances, sposonel 1899. fece parte del '* gruppo dei quatlro " che rinnovo la situazione artistica scozzese. nel-1'ambito delle esperienze piu mature dell'Art Nouveau. Autore. spesso in collaborazione conUi moglie, di arredamenti e di decoraziom lamose. illustro anche molle opere lelterarie con una
FORD MADOX BROWN
(Calais, 1821 Londra, 1893).Pittore inglese. Viaggio nelle Fiandre e fu allievo. a Bruges, di Gregonus {davidiano). ad
Anversa. di Wappers. Dal 1840 visse quasi sempre a Parjgih pur avendo rapporti fiui e dirclticon Londra. Durante il suo periodo di formazione e di studio, segui le orme dei Nazareni Cor-nelius e Overbeck, incontrati a Roma. Colpito da gravi perdite affettive (la madre, il padre, unasorella. poi la moglie). ne risenti anche nel lavoro che divenne incerto, talvolta artificioso.
Fu molto legato ai PrerafTaelliti (aveva incontrato Dante Gabriel Rosseiti nel 1848), per
simbohci. propri dei Preraffaelliti, si intrecciano a motivi realistici, a tendenze monumcntalcg-gianti (ill. pag. 30).
MAURICE MAETERL1NK
|Gand. 1867 - Niz^a. 1949). Drammaturgo bclga.Laspcuo peculiare della sua arte e costituilo dalla possibilita dei continui sovrasensi che
k- >ue espressioni, anche le piu semplici e chiare, possono assumere: da qui il valore simbolicoJclle fra5i, la loro possibilita di risonanze molleplici che ne fecero, soprattutto nell'ambito delle
,i\>enne per iftesto del " Pelleas et Melisande " indisiolubilmenk leg;ito alia musica di De-bussy. Questo particolare valore carico di efletti sfumati ed ' umbratili' fa di questa poesia unaJelle piu significative del tnovimento floreale-simbolista.
1 .1 STAV MAHLER
(Kaliste. Boemia, 1860 - Vienna. 1911). Compositore e direttore d'orchestra auslriaco.In campo musicale e l'erede della tradizione classica austriaca. II contenuto intellcttuale
392 delle sue sinfonie sembra ispirato da programme lelterari e filosofici, come accade, del reslo.anehe per Berlioz e per Liszt. La musica di Mahler si caratterizza, inizialmente. in un raffinatorecupero del folklore musicale slavo-ungarico; in seguito si complies in una distorsione lonale.
adesione ai modi di Schonberg. Nominato direttore di orchestra e in seguito direttore artisticodel Teatro deU'Opera Imperiale di Vienna, fece conoscere operisti come Strauss, di cui difese-Sa lome" . Pfitzner, Wolf, Puccini. Nel 1902 sposava Alma Schindler, figlia del paesaggisia.ed aveva 1 primi rapporti con la " seconda scuola Viennese ". Dal 1897 al 1907 compose, oltrealle sinfonie IV, V, VI, VII, VIII, i " L e a d e r " su poesie di Friedrich Rukerl.
... Era Id. pallido, sotlile. di basso stalura. un riso allungaw. la frame larga e incorniciatada una capigliatura nerissima, gli occhi attenti dielro gli occhiali: il suo viso aveva un'espressioneallo stesso tempo dolorosa e sardonica... in breve, era una autentica incarnazione di quei maesxrodi cappella Kreisler appassionato dernoniaco. auloritttrfa tale e quafe appare aH'imma%ina~ionedel giovani lettori di E.T.A. Hoffmann...IB. Waller, in " G. Mahler'", di U. Duse|.
AR1STIDE MA1LLOL
(Banyuls-sur-mer. Pirenei Orientali. 1H61 - Perpignan. 1944).A Parigi all'Ecole des Beaux Arts, allievo di Gerome e di Cabanel, passava poi a studiare
scultura all'Ecole des Arts Decoratifs. Decisivo il suo incontro con Gauguin, dopo il quale egliabbandona gli studi accademici e apre un atelier di tappezzeria a Banyuls. Nel 1893 si avvicinaal gruppo dei Nabis. In seguito ad una malattia agli occhi abbandono la pittura per arazzi e sidedicd alia scultura. Partecipo nel 1898 alia Esposizione de " La Libre Esthetiuue " di Bruxel-les con una serie di piccole terrecotte. di carattere simboiista e postimpressionista. di fresca evibrante sensibilita luministica. Nel 1903 si stabiliva a Marly, vicino a Maurice Denis, del quale
LOUIS MAJORELLE(Toul, 1859 - Nancy, 1926). Decoralorc c progctlista di mobili franceseDopo aver seguilo i corsi dell'Accademia di Belle Ani di Parigi torna a Nancy, doie porta
avanti 1'azienda paterna di mobili. Dapprima si attiene alia tradizione legata alia riproduzionedegli stili, particolarmente del rococo; ma in seguito. anche sotto ('influenza di Gakle. che por-tava avanti, a Nancy, una continua attivita di promozione culturale, si volge ai modi linean efloreali dell'Art Nouveau, nella versione naturalistic propria della scuola di Nancy. Ma. a dif-ferenza di Galle, il cui stile resta lineare e bidimensionale, Majorelle e piu legalo a molu: pla-
„ r stici. E stato uno dei fornitori di Bing per il suo negozio parigino. Col decadere della scuola dii. ' Nancy, di cui resta uno dei principal! esponenti. torno all"imitazione degli stili classic!.
JACEK MALCZEWSKI
I (Radomin, 1854 - Cratovia I9"»9) Pittore pohtcoI Dopo aver studiato pittura a Cracovia fu a Parigi dal 1867 al 1877. e vi frequemo 1'EcoleI des Beau\ Arts. Viaggio poi in Asia Minore, in Grecia, in Italia, a Monaco. Di ritorno a Cra-I Lovia fu rettore dell'Accademia di Belle Arti. Partito da un realismo di carattere sociale. sulI u.ma della liberazione nazionale contro la Russia, dal 1890 passo al Simbolismo. trasformandoI anche la sua gamma coloristica in toni piii dilatati e piu chiari. I] riferimento nostalgico \erso
I lematica trasformando il suo simbolismo in maniera personalissima; egli raffigura. infattiI personaggi della vita reale, amici, persone note, collocandoli in paesaggi altrettanto reali^itciI in LUI in n ce peraltro, immagini invent ate e miticne, sirene, angeli, rarngurati second o una
f t^uello del selvaggio del suo pae' e the esprime nel Mmbolo ^pes o ritornantt. delle rnam leflatc
STEPHANE MALLARMEFi'' (Parigi, 1842 - Valvins, 1898). Poeta france e
suoi poemes [" Herodiade ", per esempio) nascondono. tra le pieghe delle immagini una \.oe
aico facendone risaltare tutta la purezza della struttura genuinamente intellettuale: ne na^cecosi un affascinante comraslo di apparente sensualita e di lucidita razionale, col re uliaio di
I rodiade
Pet me fioTt to i per nie de efta' c voi gtardttu d amen ta \oi to 'tQpetc omttie?si ienzafun in baralri sapienli e splendidi! ori / sconosciuti che il vostro antico lume • sotto il buioietargo d'una terra / originaria custodite! e voi. { pietre da cui derivano i miei occhi come pungioielli il melodioso / barbaglio! e voi metalli che il fulgore / fatale date alia mia ckioma gioto-ne ed i! flusso compaito!... Ma tu. donna, j lu che sei nata in secoli maligni / per la pencnaadei sibillini / antri. e un mortale adduci, onde dai calici / delle mie vesti, arma dai selraggi pia-Lin gorgherebbe il bianco brivido / della mia nudita. tu profetizza / eke se Vazzurro tiepidod'eslate, / verso il quale ogni donna per impulso / nativo si disvela. mi vedesse . nel mio pudoretrtmulo di stella, monrei'
M'innamora quest'orrore / d'essere intatta — e in mezzo allo spavento / vivere voglio che daimiei capelli / prorompe. per sentire, nel giaciglio / raccolta, a sera, rettile inviolato nella mm
carne inutile il baleno j freddo delta lua pallida ckiarezza, / o nolle, lu che muori. lu che brucidi castita. lu bianca di ghiaccioli : e di neve crudele. Ed io, sorella / lua solilaria, o mia sorellaeterna. / io saliro a incotilrarli, di me aogno: 1 gia tale divenula. limpidezza / rara d'uti cuoreche quel sogno fece, / ecco che sola netla mia monotona j patria mi credo — e nell'idolatntttutto mi vive intorno d'uno specchio ! che nella sua dormente indifferenza / Ei-odiade riffelte dallosguardo j lucerne di diamante... Oh si, supremo / incanto, si, Io sento, io sono sola.(trad. V. Pagano)
SAVVA IVANOVICH MAMONTOV
(Siberia, 1B4I Mosca. 191B). Industrial e mecenate russo.Con la moglie Elizaveta (1847-1908) creo. nella sua proprieta di Abrammtsevo, un impor-
tante circolo di artisti, musicisti, critici, a Ho scopo di formare una compagnia privata dell'Opcra;il primo progetto si allargo fino a proporsi come centro per la rinaseita dell'arte popolare in Rus-sia e per reducazione artistica dei contadini, che divenivano ' contadini artigiani". E chiaral"i m postal one paternal islica del programma> che rappresento perallro, nella Russia del [empo^un apporto notevole per Io sviluppo del la coscienza del I a dignita persona le del popolo. Aliacerchia di Mamontov fanno capo i nomi piu notevoh tra gli arlisti del periodo, da Korovin, aVastnetsov. a Vroubel, che contribuirono alia diffusione del Modernismo nella cultura russa,pariendo dalle teorie di Ruskin e Morris, per recuperare il signiflcato deirarie locale tradizionale.
ALBERTO MARTINI
(Oderzo, Treviso, 1876 - Milano, 1954). Incisore, pittore, e illustralore italiano.
accesa vena fantaslica i suoi richiami cullurali vanno da Diirer a Bosch, a Bruegel, a Callot, aiPreraffaelliti; esponente della tematica erotico-decadente fine secolo, nel 1902 illustrava " Lasecchia rapita " del Tassoni; piu tardi elaboro una nuova tecnica Litografica il cui nero vellutalo
penna. Tra le opere che egli illustro durante la sua atliviia figurano " II Morgante maggiore "del Pulci, la " Divina Commedia ". II suo erotismo si esprime in maniera quasi surreale, conuna intenzionaliti di esasperazione macabra e crudele che trovera la sua piu diretta esplicazionenelle illustraztoni di Poe (1905-1908) e, in seguito, di Huysmans (" A Rebours ") e di D'Annun-zio (" Cronache bizanline ""). Illustro anche Shakespeare (" Amleto ". " Macbeth "). Semprepiii imbevuto di umori surreali e magico-onirici, non voile mai far parte, peraltro, del movi-mento surrealista, malgrado i suoi rappord col gruppo che risalgono al '24.
Nel 1912 inizia il periodo dei pastelli e nel 1914 escono le due serie di litografie " 1 misteri "c " La danza macabra " che esprimono compiutamente I'ambigua fantasia del suo simbolismodecadente; del '20-'23 sono " Fantasie bizzarre e crudeli "; nello stesso periodo iniziava la suaviva e intelligente attivita di scenografo che culmina neirinvenzione del " Tetiteatro " (teatrosull'acqua). Nel 1928 si trasferi a Parigi, dove rimase fino alia seconda guerra mondiale. Eraanche I'anno in cui ebbe inizio la sua ' pittura alia maniera nera ' che riprendera poi nel 1949.Artista isolato, ostile al tonalismo e all'lmpressionismo. raggiunse grande fama, so prat tut to
c on! r as to di bianco e nero, cosi da creare una sorta di apparizione misteriosa, ossessiva, da in-
forza espressa nella grafica.
ARTURO MARTINI
(Treviso, 1HK9 - Milano, 1947). Scultore italiano.L'incontro a Burano con Gino Rossi nel 1909 e un breve periodo trascorso a Monaco alia
scuola di Hildebrand, e inoltre, la sua pratica ceramica, che Io porlo a mantenere sempre unrapporto artigianale, diretto, con la materia. delerminarono in lui una prima adesione ad istanzeliberty, attraverso le quali egli tento di accordare la linearita simbolica con la forma plastica eil significato espressivo. E il periodo delle famose opere Fanciulla piena d'amore (1913); Fan-ciulla che odora una rosa (1913) e di altre, che segnano un momento di adesione anche alle lineedi Minne; da queslo momento egli passera ad una sintesi purista e metafisica che sara una co-st ante del suo lavoro, fino all'adesione involutiva a " Valori plastici " e al • richiamo all'ordine'.
tanti e personali, per le quali la tradizione della scultura elassica italiana e i modi delle avan-
OCTAVE MAUS
Teorico belga; fondatore della rivista « L"Arl Moderne » (1881), della " Societe des Vingt "(1884-1893) e delFassociazione " L a Libre Esthetique " (1894-1914).
Era il tempo di un estetismo sopravvissuto ai preraffaellili...Nulltt era piu curioso della vernice di uno dei nostri Salon ove slavano gomito a gomirti dt/nne
eleganti dall'abbigliamenio bizzarro lunganteme medilato. le cui tuniche di veltutv verde e setacolor malva. i pepli di veti arancio. i diademi. le borsetle; i gigli che tutvoltu portavano a guisa diceri, tentavano un'armonia, tra le acconciature ruskiniane e la cornice moderna nella qualv rise >volteggiavano.(- La lanterna magica ". in " Trente annees de lutte pour Tart. 1884-1914", 1926).
VITEZLAV KAREL MASEK
(Komarau. 1856 Praga, 1927). Pillore e architetto cecoslovacco.Sludio a Praga: fu a Monaco e a Parigi, dove si inizio al Pointillisme. sulla scia di molt]
al mito nazionale e a] desiderio di liberta del suo popolo. di cui egli intende preannunciare La
I suoi personaggi sono infatti eroi e eroine nazionali. come la sacerdotessa {La proleieaaLibusa. c. 1893), una antica regina di Boemia. il cui nome e legato alle origini di Praga e che eeliraffigura. immobile e spetlrale. in un paesaggio notturno, da sogno favoloso.
FOZEF MEHOFFER
(Ropczyc, 1869 - Wadorvic, 1946). Pittore polacco.Si inizio agli studi di diritto; passo poi alia pittura, partecipando alia realizzazione delte
veiraie di Nosira Signora di Cracovia. Si reco anche. per sludio. a Vienna o a Paiigi. NeJ 18%era di rilorno a Cracovia e partecipava al concorso per le vetrate della chiesa collegiale di SanNicola di Friburgo; vincitore del concorso realizzo le velrate dal 1896 al 1934. Fu autore di molteopere ad affresco (come quelle per il castello Wavel a Cracovia). di molte decorazioni e vet rawin Polonia.
II simbolismo del suoi quadn si esprime con un ncco bagagho decorat] vo. ispifato ancheul folklore locale.
GIOVANNI M1CHELAZZ1
(Roma. 1879 - Firenze, 1920). Architetto italiano.Lavoro a Firenze, applicando nel suo lavoro i risultati dei suoi appassionati sludi sullArt
Nouveau delle Secessioni e della Scuola di Glasgow, che egli aveva approfondito culturalmentecon lunghe ricerche. Segui tutti gli scriui di Otto Wagner; da " Nuova Architettura " del 1894a tutte le pubblicazioni della Wagnerschule. Riusci a volgere in Linguaggio personale. di ram-
la sua esperienza culturale, realizzando una serie di opere che restano tra le piu important delLiberty italiano, anche se non tra le piu note: i villini Ravazzini a Firenze (1907-1908); quelloBroggi-Caraceni (1911). villa Baroncelli (1920), la casa-studio in Borgo Ognissanli. nei pressidel centro storico fiorentino, da poco tempo riconosciuta a lui (Cresti), e molte opere. oggi di-struite (come la villa Vemilari e la villa del Beccaro, 1907), e alcuni edifici in Versilia. testimo-
non restano ne progetli ne document!, andati tutti distrutti dopo il suo suicidio (che sembmavvenuto alia Badia Ficsolana), al c^uale contnbuirono delusion! sentimentali eh probabilmente.una grave crisi di scoraggiamento ^uando. al ritorno della guerra, si trovo di fronte ad una si-
JOHN EVERETT M1LLAIS
(Southampton. 1829 - Londra, 1896). Piltore inglesc.Di origini ricco-borghesi, dedilo al disegno fin dall'infanzia. studio prima alia Sass's Drawing
School, poi alia Royal Academy di Londra, dove espose nel 1846 opere di gusto romantico.Si avvicinava poi al gruppo col quale fondava, nel 1848. la Confraternita preraffaellita. SecondoLi tendenza e le linee programmatiche della Confraternita, in liianiera minuziosamente descric-nva. pur nel la trasfigurazione rom antica della realta, dipinse, tra l'altro, Lorenzo e Isabella (1849).(h'su nella casa dei genirori (1849). in questo periodo, con la Confraternita, fondava la rivista« The Germa, che durera un solo anno (1850). 1 Preraffaelliti non furono, infatti. agli inizi.molto ben visti dalla societa inglese, anche se trovarono un di fen so re acceso in John Ruskin (1851).Quando finalmente furono accettati all'Accademia, Millais vi ottenne un notevole successo colquadro Ofelia (v. pag. 32. n. 62). Millais fa uso di colon brillanti. freddi, quasi timbrici. eviden-
Una serie di lavori diffusi attraverso le esposizioni gli dettero un cerio nome (Z. online dixearcerarione. II rirratto di John Ruskin, 1853-1854. ecc.).
Continuava intanto I'attivita xilografica, che, secondo il programma preraffaellita. tendead una piu ampia diffusione e assume un carattere di divulgazione di tipo sociale.
GEORGE MINNE
(Gand, 1866 - Laethem-St-Martin. 1941). Scultore e disegnaiore belga.II padre, architetto imprenditore, non crcdeva alle possibiHta artistiche del tiglio che riusci
<i frequentare TAccademia di Gand dal 1882 al 1884; tra il 1885 e il 1889 lavoro in solitudine.subendo, in parte, 1'ascendenza lontana di Rodin. L'amicizia coi maggiori poeti simbolisti delsuo paese, da Gregoire Le Roy a Van Lerberghe a Verhaeren, accentuo la sua sensibilila mi-st icheggiante e involula; illustro Maeterlinck, subendo, per un breve periodo, I'incanto di unfavoloso medioevo. Ma i suoi lavori piu importanti furono realizzati in estrema solitudine. quasiin mi5eria, a Bruxelles, dove rimase tra il 1895 e il 1898; furono, questi Gli inginocchiaii. Luomotlell'otre, Solidarieia. Invitato nel 1890 dai " XX " di Bruxelles, entro nel gruppo nel 1891. Esposeunche a Parigi col gruppo dei " Rosacroce ". Riliratosi. nel 1899, a Laethem-Sl-Martin dnen-ne l'animatore culturale del paese, dove rimase flno al periodo della prima guerra mondiale.quando si ritiro nel Galles. Dal 1912 al 1914 e dal 1916 al 1919 tnsegno alFAccademia di GandLa sua opera piu famosa e la Fontana degii inginocchiaii, del 1898, il cui progetto, in quattrorepliche, si conserva a Gand, Essen, Vienna. Bruxelles.
GUSTAVE MOREAU
(Parigi. LS26-L898). Pitlore francese.Figlio di un architetto, studio all'F.cole des Beaux Arts di Parigi. sot to la guida di Picot,
dill 1846 al 1849. Frequento lo siudio di Chasseriau, che, con Delacroix, fu il suo pittore pre-ferito. dal 1850 al 1856. Fu poi in Italia (1S57-L859), di dove riporto una serie di copie dai mae-stn del Rmascimento.
Partecipo alle rassegne dei Salons con vicende alterne. ma visse molto isolato, lavorandoalle sue opere che riprendeva anche a distanza di molti anni, elaborando composizioni sempre
sia oninca. Misogino profondamenie innamorato della bellezza femmimle nell immagine del*l"Androgino, trae i suoi temi dai mid classici, dalle leggende e dai raeconti biblici. II tema dellaSalome, che mcarna La sua idea della donna (" annoiata> capricciosa, dalla natura animate;che si da al piacere. molto poco vivo per essa, di vedere il suo nemico a terra, lanto e disgustatada tulta la soddisfazione dei suoi desideri... che passeggia con noncuranza vegetale e bestiale neigiardini appena insudiciati da quel terribile omicidio che terrorizza lo stesso boia... che cercale emozioni malsane e che, stupida, non comprende neppure I'orrore delle siiuazioni piu spa-ventose "), che bacia la testa staccata di Giovanni Baltista, dopo averla chiesta in premio dellasua danza, ritorna frequentemente nelle sue composizioni, emergent? come un apparizione dalfondo cupo, grondante di colore smaltato. perlaceo, in mezzo ad architetture fantastiche. com-plesse ed eterogenee, ricche di prospettive e di esoliche decorazioni fastose, in un alone di mi-stero che fara di Moreau un pittore amato pnma dai Parnassiani, poi dai surrealist!. Resta, co-munque, uno dei precursor! del Simbolismo, che incarna nel suo significalo piu profondo e mi-
ll carattere sensuale, misticheggiante, suggestivo, torna nei temi piii disparati, dalle i 11 li-st razioni per le favole di La Fontaine aWEdipo e la Sfinge. sMErcote e Vidro, al Rapimemo diEuropa... Torna spesso sui suoi temi, e lascia incompiute molte opere. dove le sue qualita colo-ristiche risultano anche piu evidenti, facendone, addirittura, un precursore del tachisme. Lasua casa parigina, in rue La Rochefoucauld, e divenuta poi il Musee Moreau: vi si conservanola maggior parts delle sue opere piuoriche e grafiche e anche 11 sue sculture in cera.
Neliapvru di Mart'tm, concepita al di fuori di tutli i dati del Tcstamenlo. Des Esseintes ve-deva ftthii>>'> *:;>•• >• •:/•'.•. ". ,r.i i'ltt.^olita e sowumana Salome che aveva vttgfteggiaro. Esxa non era piusoliiiiiif ••'•• .• .• . .. •. •-uippa ad un vecchio, con urta contorsione lasciva dei feni- un grido didesidi'i'i" • .' •. •. . :it I'energia, piega la volonla d'un re, Hffbinando i sent, scuofendo ilil venire. \-:'i.,i:,i,' ,, ,r'u ,,<. cssa diveniava, per cosi dire, il simbolo indialo della insopprimibilelussuria. h deti deH'iinmoriale Isteria; la Bella maledella, elella fra tulle dalla Catalessi. the lefa di marmo le carni. diferro i muscoli: la Bcslia moslruosa. indifferenle. irresponsabile. the comeElena di Troia awelena tulta cid che \ede. lutto cid che locca.(J. K. Huysmans, -A rebours ~, 1884, trad. C. Sbarbaro).
WILLIAM MORRIS
iWuhli.im-iiitt, 1834 - Hamemrsmilh, 1896). Piltore. decorators. gratiL... : . v . . . • . ,•-.•E) in.in io di ^ludi subi una profonda crisi religiosa. Discepolo di Rusk in. : •. .i * < i •' >'
liiiKR-.lon.- J.-l qualecostitui, a Oxford, una sezione della Confratemiiii ,!.• I' ,• •un iiiiiisiui tun lui in Francia. II suo inieresse per il Medioevo si esplico alloia no.lo -nAh- dolGotico francese e nel proposito di studiare architettura. per cui gli fu maesiro F.dmund Street.
Nel 1883 aderi al Socialismo, che intese secondo una visione idealistica, romanliea, di ca-raitere utopico. Fondatore, a Londra, della rivisia «Oxford and Cambridge Magazine", scrissealcuni raeconti, come " The Dream of Jonh Boll " (II sogno di J. Bull, 1888), " New From Now-here •' (Notizie dal luogo che non esiste), di carattere avveniristico, e - Socialism: its Grouthand Outcome " (II socialismo; suo sviluppo e risultati, 1893); fu anche autore di poemi e di operein versi, lutte improntate ad una romantica visione delle leggende medievali e classiche e dellesaghe nordiche (" The Life and Death of Jason "; " The Defence of Guenevere and Other Poems ";" The Story of Sigurd the Volsung and the Fall of the Niblung "...).
Ma la sua imporlanza e legata all'attivili artistica, che egli interpreta come mezzo diriforma sociale da perseguirsi attraverso un progressivo miglioramento del gusto. Si dedico,secondo gli insegnamenti di Rtiskin, alle arti applicate, considerate lo strumento piu direttodi penetrazione in tutti gli strati sociali attraverso gli atti della vita. Fattasi costruire, daTar-chitetto Philipp Webb, la Casa Rossa a Upton (1860), ispirata a intenzione di semplificazionedel gusto, seppure plena di riecheggiamenti medievaleggianti, ne disegno personaImente. finnei minimi particolari, tutti gli accessori e, nel 1861, con Dante Gabriel Rossetti, Edvard Burne-Jones. Ford Madox Brown, Marshall, Faulckner, Webb, fondo a Londra la ditta " Morris,Marshal], Faulckner & Co. ", per la produzione di oggeiti ed elementi per I'arredamento e ladecorazione della casa, in cui tutti gli artisti si deflnivano ' operai d'arte' . Contro la degene-razione del gusto rappresentata, secondo il suo parere, dalla produzione industriale di serie, op-pose il lavoro artistico e artigiano, che, peraltro, imponeva prezzi piu alti e percio escludevadalk possibilita di acquisto proprio quella massa che Morris intendeva riqualificare atlraversoI'educazione del gusto. Percio gli arredamenti e gli oggelti eseguiti dalla " Morris, Marshall,Faulkner & Co. " divennero fruizione di elite. Nel 1881 la ditta. con ladefezione di Madox Brown,Rossetti. Marshall, si trasferi in campagna, a Merton Abbey; reslarono con Morris Burne-Jones. Faulkner. Webb.
Y)
Foiogralia di A. Mucha.
Nel 1888. con altri, Morris fondava la " Am and Crafts Exhibition Society ". con la quale
in evidenza dal sorgere deirindustrialesimo.Nel 1890 Morris apri anche. a Merlon Abbey, una tipografia, la " Kdrascotl Press ". che
divenne famosa per la pregevolissima produzione con presse a mano; tra le opere piii impor-tanti un'edizione dell" " Opera Omnia " di Chaucer, del 1896. Ma come iniziativa commer-
come aveva disegnato J motivi per le stoffe prodolte dalla ditta (i chintzes) e per le carte da parati-II fa no che Morris facesse coincidere la degenerazione del gusto e il basso livello delta si-
tuazione sociale con il progredire della macchina e dell'induslria lo pose necessariamente inuna posizione antiprogressista, di carattere reazionario, cbe rischid di far degenerare la suai m post azione umanitaria.
Le opere di Morris furono pubblicate nel 1910-1915, nei -Collected Works" (24 voll.).u cura di M. Morris, a Londra: le " Letlere " videro la luce nel 1950 (a cura di P. Henderson);nel 1927 usci a Durham, North Carolina " The Social Philosophy of William Morris ". di A. A.Helmhotz-Phelan; nel "34. di A- P. Arnot, usciva a Londra " William Morris: A Vindication ":a Walthamstow, nel *34. usciva, a cura di G. E. Roebuck " Some appreciations of William Mor-ris " (2 voll.); nel 1940, di L. W. Eshelman, " A Victorian Rebel ", a New York; il primo stu-dio italiano su W. Morris si devc a S. De Carlo, •' William Morris", Milano 1947 (ill pane24-43, 60).
KOLOMAR MOSER
(Vienna, 1869-1918). Pittore. grafico. designer austriaco.Dal 1886 al 1892 studio all'Accademia di Vienna e dal 1892 al 1895 alia Scuola d'Arte di
Vienna; nel 1897 fu tra i fondatori della Secessione Viennese. Dal 1905 fu nel gruppo della " Se-cessione della Secessione " con Klimt. Di una vivace fantasia decorativa e ira i principali col-laborator grafici di « Ver Sacrum ». Noto anche come allestitore di mostre e come arredatore.realizzo anche oggetti di cccezionale qualita formale.
ALPHONS MARIA MUCHA
(Ivancice, Moravia, 1860 Praga, 1939). Decoratore, grafico, pittore cecoslovacco.Ai suoi imzi intendeva dedicarsi alia musica e alia recitazione teatrale. A Vienna nel 1877
vi lavoro come decoratore per il " Theater am Ring ". Un mecenate e protettore, Khuen Belassi.10 fece studiare presso 1'Accademia d'Arte di Monaco. A Parigi nel 1887, col pittore Masek.suo compatriota, frequento I'Academic Julian e inizio la sua attivita di illustratore nei piu notigiornali parigini. Nel 1898 gli fu comtnissionato un manifesto per Sarah Bernhardt. Da alloradivenne noto come cartellonista, come disegnatore di gioielli. di sloffe, di abiti. come arredaioredi mostre e vetrine. Nel suo studio si raccoglieva lutto il gruppo dei simbolisli di tendenza eso-terica; era amico. tra I'altro, di un famoso specialista di ipnotismo e di parapsicologia, Albertde Rochas. Celebre in tutto il mondo per le sue realizzazioni grafiche, per le quali si serviva spessodi modelli fotografici, nel 1904, per seguire la sua passione pittorica, lascio Parigi per gli StaiiUniti. Dedicatosi completamente alia pittura realizzo opere simboliste e scene storiche. Tor-nato in patria nel 1911 realizzo una serie di dipinti dedicati all'epopea slava. Collaboratore dimolte riviste, tra cui « La Plume ». fu all'Esposizione Universale di Parigi del 1900 con le pitturemurali nel padighone sud-sloveno. Le sue decorazioni sono numerose in edifici pubblid e neiteatri di Berlino e di Praga.
EDVARD MUNCH
(Loten, 1863 - Ekely, 1944). Pittore e incisore norvegesc.Gducato in patria al naturalismo. gia ad un primo viaggio a Parigi (1H85) si accosto alllm-
pressionismo. Fu a Berlino. quando, anche in seguito ad una sua mostra rivoluzionana. chcfu fatta chiudere, si formo il gruppo della Secessione (1892); ed e a questo momento che si ascn-ve la sua adesione ai modi lineari dell'Art Nouveau, che egli, comunque, interpreta con unaacutezza e con una tensione della linea che segnano veramente il punto di passaggio tra la mor-bida ondulazione del linearismo an nouveau e la convulsa rottura della linea caraltensttcadeirEspressionismo, di cui Munch, nella viva e potente drammaticita della sua expression?, sara
MODEST PETROVICH MUSORGSKU
(Karevo-Pokov, 1839 - Pieirobuigo, 1891). Compositore russo.Precoce musicista, con Borodin, Balakirev, Cui e Rimskij-Korsakov formo il •gruppo
dei cinque 1% i cui scopi erano quelli di creare una musica nazionale russa. conlinuando Timprcuiniziata da Glinka. Studio Bach e le musiche liturgiche russe, da cui trasse. come da un grand*humus, la forza della sua musica. Partito da esperienze romantiche (Mendelssohn. Schumanni.rifiutd ogni ricorso alia iradizione polifonica per volgersi solo all'espressione piu autentica ddpopolo russo, di cui interpreto Tinquietudine. la fantasticheria, il sogno simbolico
KAREL CHRISTOPHE HENRI DE NEREE TOT BABBERICH
(Huize Babberich, Zevenaar, 1880 - Todtmoos, Baden. 1909). Pittore olandese.Di nobile famiglia, dal 1895 al 1897 frequento la Scuola di Commercio di Anversa ed entro
subito dopo nella carriera diplomatica. Ma nel 1901, per ragioni di salute, dovelte abbandourc11 servizio consolare. La sua vicenda e vicina, per certi aspetti, a quella di Beardsley. Come Im
comincio a dedicarsi al disegno tin da ragazzo, pur avviandosi ad una diversa carriera che nona quells artistica. Come per Beards ley, la malattia fu probabilmente anche un incentivo silosviluppo di un linguaggio particolare, teso e raffinato. [ suoi disegni, influenzati anche dallaindsione giapponese in legno, raggiungono una linearita grafica acuta ed espressiva di rara in-tensita. Passo gli u)ti[ni anni deUa sua vita tra un sanatono e L altro, da Arosa a Montreux a Xodt-moos. La sua prima ispirazione era sialo il lavoro di Toorop, che egli ammirava profondamen-te. Poi il suo grafismo si avvicind a quello di De Feure. E autore di almeno 375 disegni, di cut
GERARD Dli NLRVAL
(Pangi 1808 1855). Poeta IranceseAll"inquietudine biograrka e affetfiva fa risconlro, nell'opera, un'ansiosa ricerca deirideale
e del magico, con una straordinaria ricchezza di armonici; cosi, alia nettezza dassica dello stileottendono i fermenti di una materia sempre in bilico tra il miracolo deH'alchiirjia e la stupe-
tazione orfica. 1 suoi sonetti, L" Le Chimere h\ possono esser considefati tra gli archetipi irri-
Delfica.
Conosci, Dafne. quell'arnica romanza, j Ai piedi del siconwro. o iollo gli allori fiorm. i SolloI'lit'tvo* il mirto, o i salci tremanti, / Quetta canzone d'atnore che sempre ntomtneta7
Riconosci tu il Tempio dali'immenso periuilio, / £ i limoni amari dove i denti imprimevi, / Ela groua. falale ai visilalori imprudenti, j Dove 1'anlico seme del dragone vinto riposa?Riwrneranno, quesli Dei che sempre tu piangi! / // tempo e prossimo a riportare il giro anticodei giorni, / La terra ha irasalilo di un soffio profeucoTultavia ia sibilla dal viso latino j E ancora addorntentttltt sotlo larco di C ustunttmE nulta ha turbato il Portico *e\ero(trad A. Parronchi)
WALSLAV NIJINSKIJ
(Kiev, 1890 - Londra, 1950). Ballerino e coreografo russo.Siudio a Pietroburgo. Debutto nel 1905 con " Aci e Galalea ". Nel 1908 era nella compa-
gnia di Djaghilev, interprete prineipale dei "' Balletti russi " a Parigi. La sua immagine di dan-zatore rappresenfa una siniesi deUa poetica [ardoromantica, di quella expressionista, di queliacrepuscolare, in un amalgama che produce effetti irripetibili.
Nel 1912 debutto come coreografo per " L-apres-midi d-un Faune " su testo di Mallarmee musica di Debussy, entrando in rapporlo con le teorie ritmiche di Jacques Dalcroze. In '" Sacredu Printemps " di Stravinskij, Nijinskij da la sua prova di scenografia piii rivoluzionaria. ri-spetlo ai canoni accademici.
HERMANN OBR1ST
(Kiichberg, Zurigo. 1863 - Monaco, 1927). Decoratore e grafico [edesco.Dopo aver frequentalo, all'Universita di Heidelberg, la facolla di seienze, si iscrisse alia
Scuola di Arligianaio di Karlsruhe (1888). Continuo poi gli studi a Weimar. In Turingia realizzo
di scultura. Autore di cartoni per ricami e noto per il famoso arazzo Cicltitrtini (La frustaia) (1892-1904), uno dei primi esempi deUa linea ' a coup de Fouel". Nel 1892 apriva un laboratorio di ri-cami a Firenze, che spostava nel "94 a Monaco; finche, nel 1897, fondd un laboratorio per I'ar-redamento ("Veringe Werkstatten "). II suo disegno, di ispirazione fitomorfica, e molto legatoal primo An Nouveau belga. £. anche autore di un saggio sull'arte tendente a esaltare le nuovepossibilila orTerte dalla tecnica alle arti figurative.
JOSEPH MARIA OLBRICH
(Troppau, 1867 - Diisseldorf, 1908). Architetto e designer austriaco.Fu dapprima allievo di Hasenauer alFAccademia di Vienna (1890-1893). Dopo una lunga
serie di viaggi di studio in Italia e in Tunisia alia ricerca delle font! dell'architettura mediterranea,di ritorno a Vienna fu accolto nello studio di Otto Wagner nel 1894. Con lui esegue alcune sta-zioni della Metropolitana di Vienna. Nel 1897 e. con Klimt, tra i fondatori della Secessione Vien-nese, per la quale, nel 1897. progetta ed esegue la sede delle esposizioni a Vienna, dove gia si ma-nifests il suo raffinato gusto del particolare e il suo vivo cromatismo. uniti ad una libera artico-lazione dello spazio interno, concepito come un contenitore variamente componibile a mezzodi pareti mobili e quinte inseribili, anche se i moduli architettonici risentono ancora della vi-sione costruttiva di Wagner. Ma il suo linearismo geometrico di tipo ' fitomorfico ' (si pensialia cupola del palasso delle esposizioni, concepita come un albero nel traforo in rame lucente)si maniTesta net Lavori seguenli nella sua pienezza; da una serie di ville e case di abitazione a Vien-na al progetto del villaggio per artisti a Darmstadt, dove e chiamato dal granduca Ernst Ludwigvon Hessen, e dove realizza tutti gli edifici nella Malhildenhohe (esclusa la casa di Behrens) edove cosiruisce anche il palazzo per esposizioni in mattone e rame, con la famosa, colorata Torredei matrimoni (la Hichzeitsturm), alta 48 metri. In questo palazzo Olbrich realizza una nuova,articolata composizione, libera dalle regole di slmmetria tradizionali. secondo un ritmo dinamicodi mirabile sensibilita e chiarezza. Nei Magazzini Tien, a Diisseldorf (dove si stabilises nel 1908),r ultima sua opera (egli muore iniprovvisamente, menlre sta lavorando alia realizzazione del-1'edificio, lasciando oltre quaranta opere eseguite e circa 28.000 disegni), sembra che egli ri-pieghi su ripensamenti di tipo classicistico. La sua sensibilita ' pittorica ' (la sua e stata definita
'" architettura-pittura ") si unisce, peraltro. felicemente. ad un forte senso cost rum vo e ad una
di arredo, alia graflca ediloriale e alle arti applica e
// bianco palazzo sut fiutne e ultimata... Le sale si distinguono nettamente le une dalle a/tteper i colon coi quali sono dipinte, studiati nelle loro gradazioni in modo da create particolari *i^-gestioni:... un'attra particotarita e costituila do! fatlo che i vafli possono essere spostaii. analoga-menle a quanto avviene nelle case giappone pe ne o d pa e noh I d a a- Perftno te spltn-dide coppie di colonne che, disposte a forma di lira, dividono la sola cenlrale dal vano superiorenon sono altro che pezzi spostabiti.
Quesla flessibilita dello spazio e stata spinta ad un punto tale da permettere. ogni anno perdied anni cansecutivi. una diversa disposizione dei vani.
A piacere si pud fare uso delta luce lalerale o di quella che piove dall'alto. a seconda delle en-genze dell'oggetto da esporre.
A queslo riguardo ilpalazzo e una scalola magka. dalla quale pud essere eslralla qualsiasi rosi<L. Hevesi. - Otto anni di Secessione ". 1906. * proposito del palazzo della Secessions di Vienna I
GIOVANNI PASCOLI
(S. Mauro. 1855 Bologna. 1912). Poeta ilaliano.Tra i moltephci aspetii dell'opera del Pascoh. non ultimo, anche se spesso di tono e Ga-
lore piu circoscnltu s il nsvolto norcalc-sim poll star un simpolisnio an£ttivo~natiiral]siico. iui~[avia, anche se spesso pervaso> nclla soggezione a richiami segreli^ da un impulso ncorremo &identiticare, in uiVunica ombra di mistero, il finito con Tiniinito, la vita con la mone. Pur dcti-miiato da un pulilo lincarismo neoclassico, il tono. ricco di colon floreali, di certe lirichc do- Primi Poemetti " e fin anche dei " Canti di Castelvecchio " perviene. nei confini di una con-sociazione di valori semi men la li, al prolungamenlo delle immagini verso I'inde terminal o. vet-so i possibiii e misteriosi echi deli'emozione; per cui (vediamo alcune strofe del '" Geisomiaonot turn o " che qui citiamo a mo' di specimen) I'eco di un luitie prosegue nel buio nottumo lasua opera di simbolo sentimentale attuatosi nel suo spengersi, cosi come un odore conunua-mente esalato nella none vive nel suo stesso dissolversi: un'emozione. certo. equivalenle a qudladi molte emo^ioni figurative dell arte del tempo, anche se il raggelamento dell immagine nel suogesto simbolico, altro effetto tipico deircspenenza florealc. aara mvece piii evidente. c con re-sultati meno felici. nei piii tardi " Poemi Conviviah ".
... E s'tiprono i fiori notlurni. I neli'ora che penso at miei cart. / Sono apparsi in mezzo ai TIburn/ ! le farfalle crepuscolari.Da un pezzo si tacquero i gridi: . 10 sola una casa bisbiglia. ! Sono I'ali dormono i nidi, co-me gli occhi, sono le ciglia.Dai calici aperli si esala I Vodore di fragole rosse. / Splende un lume lit nella safa. \ascsI'erba sopra le fosse.
Per tuna la notte s'esala ; Vodore che passa col vento- / Passa il lume xu per la scala: , briUaal pritno piano: s'e spenlo...
JOSEPH PELADAN (deiio JOSEPH1N)
0-ione. 1859 - Neuilly-sur-Seine. 1918). Scrittore, pittore. organizzatore eulturale francese.E il sijnbolo piu stravagante deirartista decadente, Nella sua opera pinorica. in realia assai
mediocre, coitipaiono tutti gli mgredienti del gusto del tempo, dall'amore per i PTeraflaellitla quello per la Gioconda, aU'imitazione di Moreau.. Si attribuisce il soprannome di Merodackill name di ml antico re di Babilonia); nel I8S8 fonder a, con altri, - L'ordine cabbalistico dellaRosacroce " che ha tra i suoi scopi quello di " rivelare alia teologia cristiana le magnilicenzcesoteriche di cui e gonfia, a sua insaputa ". Dedito a pratiche magic he. sembra averle proposicanche per le riunioni dei partecipanti al suo ordine, uno dei quali, il poeta Edoard Dubus. im-pazzira, un altro, il marchese Stanislas de Guaita, morira. Ossessionalo dalfidea dell"andro-gino (alira caratteristica del tempo), infatuato delle sue teoric teosofiche, pretendeva, per i suoimeriti religiosi, la porpora cafdinaiizia. £ autore di 19 romanzi, tutti di carattere moralisticointesi alia riforma sociale del suo tempo, cosi pervaso da quello che egli chiama " le vice su-preme " (litolo, anche, di un suo romanzo), cioe la corruzione dell'tdea.
... Set stata bella quanta possibite sia di sentimenti che d'aspelto. hai approvato ogni parotonobile, protestato ad ogni bassa proposla. umiliato i ricchi e ouoraio gli intelleltuali. hai. con louia grazia, refi sereni tutti i volti che hai guardato ?
Ecco il tuo esame: se la tua giornata non lascia una scia gioiosa e decorativa. e perduta: eccohi ma regola.
Prima di addormentarti una strofa di un grande poeta come per epigrafare la nobilta dei luol'ugni; p na d pegne I and la o gua do al uo ft b he ti ricorda che devi soffrirrf ad ale n a e n b I pe an lla e dagt o h I fie o delle brutture moderne. Addor-mentati graziosamente. quale oorresti essei vista dal principe a urro,.,\ f\mpn 11neatre ues sciences mories — i^-ommcm on uevieni rcc . i oyj).
WALTER PATER
(Londra. 1839-1894). Saggista. romanziere inglese.
Lo si puo considerare il padre deTesletismo decadente. il cm culto della beilczza. pur cor-roso da uri serpeggianle malessere che trovera nei seguaci una piii manifesta e pre sione. e aliaun aspetto quasi religio&o della vocazione estetica. giustificando il complete* affrancamento delfatto artistico da remore e irnpacci di ogm diverso ordine di valon.
AUGUSTE PERRET
(Exelles. 1874 - Parigi. 1*»-.4| Vr^hiUtlo Ir i i i totFiglio di un repubblicano esule. di famiglia m I, I I i
nel 1881 coi fralelli Gustave e Claude. Studio all I I
delle prime ope re della nuova impresa e la casa in Ri 1 I 1 I I | I i u
chitetlura, arucolandosi. sulla facciata, in structure evidenziate. anche se una sottile decorazione ceramica di caraltere floreale. ne maschera aocora la schiettezza. Seguono YAutorime rain Rue Ponthieu (1906), dove la struttura in vista e resa piu evidenie dalla trasparenza della grande velrata che annulla la necessita del ricorso alia decorazione. L'episodio importante, seppurebruscamente inlerrolto, della collaborazione con Van de Velde nella progettazione del teatroai Champs Elysees (1912) costituisce per Perret un momento determmante. Del 1923 e la Chiesadi Noire Dame de Raincy. del 1926 la Chiesa di Sanla Teresa di Montmagny. con 1'uso innova-
rera la ricostruzione di Le Havre, utilizzando la prefabbricazione di element! inodulaii, E con-siderato elemenlo di passaggio tra I'apertura in senso bidimensionale dello spazio architelto-
I GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO
(Volpedo, Alessandria, 1869-1907). Pittore ilaliano.Di famiglia conladina frequemo dapprima I'Accademia di Brera (1883), poi quelle di Roma
e Firenze (1887-1888), dove segui le lezioni di Fattori; passo poi a Bergamo, dove insegnavaTallone- Oriertlato, inizialmente, verso il Division ism o. segui anche corsi di lelteratura. di slo-ria e di storia dell'ane all"Universita di Firen«, dove frequento ambienti in cui I'amore dei pri-mitivi e del primo Rmascimenlo, e. su questa linea, dei PrerafTaelliti. erarto in gran voga. Un
I rapporto epistolare con M or belli, che lo incoraggio ad approfondire temi sociali anche aura-verso Morris. Engels. Marx. Tolstoi, contribui fortemente a rendere operante. in lui, la ricercadi un real is mo sociale profondamente sentilo, che non esclude perallro un approfondimentosulla resa della luce nel quad™, e, sulla scia di Segantini e Previati, un momento simbolista digrande interesse. A Parigi nel 1889 e poi nel 1900. quando partecipo all"Esposizione Universal,studio Monet e Seurat, II trittico L'amore della vila resta uno dei miglion esempi di Simboli-smo italiano. II signiflcato della luce viene indagato da Pellizza sia nelle sue componenii ana-logico-simboliche che nelle sue possibility tecniche di resa; su questa via egli si avvicino sem-pre piu alle ricerche sulle vibrazioni luminose di Balla, anche se il riferimento alia realta restcra
' per lui inequivocabile, portandolo sempre piii verso forme di realismo.
I KOSMA SERGEIV1TCH PETROV-VODKINE
(Chwalynsk sul Volga, 1878 - Leningrado, 1939), Pillore russo.Studio disegno e pittura a Saratov e a Pietroburgo, e scultura e architeltura a Mosca, Tra
i piltori russi piu importanti del primo ventennio del secolo, fu a Monaco, a Londra, in Italia;soggiorno anche, per studio, a Parigi, dove tornd dopo un viaggio in Africa del Nord. Fu anche
" Teoria dei colori e dei volumi ", dove parlo di ' prospettiva sferica '. teoria che egli appliconei suoi quadri simbolisti. ispirati anche alle opere di Puvis de Chavannes e di Maurice Denis,ma personalizzati in una particolare visionc pittorica, nell'uso di un col ore pialto e secco, nel-1'atmosfera rarefatta, quasi magica. delle scene, il cui tema si svolgeva attorno agli ideali di bel-lezza. di amore, di felicita, Fu anche autore di drammi e di due racconti autobiografici " Chly-
I nowsk1- |I93O) e " Lo spazio di Euclide " (1932).
GAtTANO PREVIATI
(Ferrara, 1852 - Lavagna, 1920) Pittore italiano.Dopo aver studiato a Ferrara. alia Scuola di Belle Arti. segui. a Brera. i corsi di Bercim.
e. sulla scia di un naturalismo di maniera. si avvicino agli scapigliati lombardi. Dal 1890 ela-boro. invece. una " pittura di idee * e una teoria scientiflca sull'uso del colore. secondo la poeticadivisionista. ispirata anche da Grubicy (/I hacio, 1887; Pace, 1889.,.). La sua tecnica particolare,
vocarono Previati come innovatore. Verso il 1890 egli aveva lavorato alle lHustraziom di Poe;cio che lo avvicino al Simbolismo europeo di Rops e di Redon; di qui ebbe inizio il suo momen-
piu legato a motivi floreali {Maierniia. 1890-1891; L'amore alle soglie della vim...). Alia morte! di Segantini, nel 1899, egli rimase il maggiore rappresentante del divisionismo italiano (e Al-i berto Grubicy fondo addirittura " U societa per I'ane di Gaetano Previati " ) ; ma con Tandar
Tra il 1909 e il 1916 egli pubblico i suoi saggi teorici " Principi scientifici del divisionismo ".
I MARCEL PROUST
(Parigi. 1871-1922). Narratorc francese
L" opera di Proust e troppo nota e i semi della sua recherche altreltanto diflusi nell'aria del-la cultura contemporanea perche essa richieda in questa sede ulteriori notizie e valutazioni-
cio lo si deve, piu che all'intrinseco valore genuinamente letterario della citazione, al caraitereespressamente mondano del suo tema, sollecitati da quell'intelligente persuasione, propna del-F opera di quest'autore, di poler riuscire ad eludere l"anonimita sterile di un ambiente e di luitoun mondo, accogliendo nel proprio sguardo, e interpretandola sensibilmente, t'iniera folia dim-magini cosi veslile del colore del proprio tempo da farle considerare una realta intimamenle
Adoro gli artisti — rispose la signora vestita di rosa — sono i soli a capire le donne... Gli arlistiL- le donne d'eccezione come vol. Satiate la mia ignoranza. amico. Chi e Vaulabelle? Son (onei/iiei volumi dorati nello scaffaletto a vetri del saloltino? Sapete che mi avele promesso di prestar-meli, ne avrd moila cura.
Ella trovava in tulti i suoi gingilti cinesi delle forme divertenti, e cosi pure alle orchidee. aliacallleya soprattutlo, che insieme coi crisantemi erano i suoi fiori preferiti, perche avevano il granpregio di non assomigliare a fiori, ma d'essere di seta, di raso. - Queila sembra tagliata nella fo-ctera del rrtio manlello, - disse a Swan mostrandogli un'orchidea, con una sfrumatura di siirna perifuet fiore cosi chic, per queila soreila elegante e impreveduta che la natura le offriva, coti lontanada lei sulla scab degli esseri e tutlavia raffinala, piu degna di molte donne di avere un posto nel swi
Mostrandogli successivamenle delle Chimere dalla lingua di fuoco dipinle u un \a o o ruana n paravento. le corolle d'un mazzo di orchidee. un dromedario d'argenw nieilato dagh0 h n o a d <ibini. che stava sul camino accanto a un rospo di giada, ella affeuasa ucce siamen e di spaventarsi per la malvagitd. o di ridere per la stramberia dei mostri, d'arrossiie pet
I'indecenza dei fiori o di provare un irresistibile desiderio di baciare il dromedario e il rospo. che
("La Strada di Swan", 1913, trad. Nalalia Ginzburgl
Swan possedeva una meravigiiosa sciarpa orientate, blu e rosa. che areva comperalo perche eraidentka a queila della Vergine del Magnificat: ma sua moglie non voleva portarla.
Solo una volla lascio che il marito le ordinasse un abilo tutto eostellato di margherile, di hordal d n o o d e di campanule. imitato dalla veste della Primai/era del quadra( All-ombra delle fanciulle in fiore ", 1918, irad. F. Calamandrei, N. Neri).
Pi op o q lla a Albe na a ndo a per la prima voltti la vestaglia blu e oto ai For-n la quale rievocandomi Venezia mi faceva sentire con maggior vivezza tutto quel che le sa-t> o
1 L F gg 19 1 d P S n )
G1ACOMO PUCCINI
(Lucca, 1858 - Bruxelles, 1924). Compositore italiano.E una delle espressioni caratteristiche deU'ideologia liberty italiana per la sua rappresenia-
zione deH'imniagine femminile, espressa secondo una simbologia delicata, romantics, senti-ment ale, senza le implicazioni sataniche ed erotico-sadiche propne del Simbolismo internazionak
Debussy, di Stravinsky, di Schonberg. prese spunto dal " Quartetlo per archi " del 1893 di De-bussy per la sua " Fanciulla del WesI " (d'altronde, nel " Pelleas et Melisande " di Debussv sipossono notare reminiscenze della " Boheme "). L'invenzione melodica, I'armonizzazione. lastrumentazione. 1'economia nello svolgimento musicale, un equilibrio istinlivo sono le sue ca-ratteristiche personali.
PIERRE PUVIS DE CHAVANNES
(Lione. 1824 - Parigi, 1898). Pittore francese.Ailievo di Couture, si oriento verso 1'allegoria classicheggiante. che interpreto con una
chiarezza tonale e con una freschezza di impostazione, che danno alle sue opere un alone quasitnetaflsico, in una atmosfera di sogno. II suo simbolismo lo avvicina, per alcuni aspetti decora-uvi. ai modi deU'Art Nouveau.
PAUL RANSON
(Limoges, 1864 - Parigi, 1909). Pittore e decoratore francese.Dopo aver seguito dei corsi alia Scuola d'Arte Decorativa di Limoges e di Parigi, entro.
nel 1888, alTAcademie Julian, dove fu in rapporto col gruppo dei Nabis, coi quah divise il suo
arazzi, che faceva eseguire dalla moglie, nei quali realizzava il suo ideate (e quello dei Nabis).di una linearita bidimensionale, di gusto medievaleggiante, per molti aspetti legato ai modi pre-
quasi tutti i Nabis e altri artisti, tra cui Denis.
MAURICE RAVEL
(Ciboure, 1875 - Parigi, 1937). Compositore francese.Allievo di Gabriel Faure si accosto presto alia musica di Chabrier e di Satie Dopo gli in-
successi del " Premio di Roma " si'ritiro dalla vita musicale ufficiale, rifiutando onorificenze cincarichi, dedicandosi completamente alia composizione. Vicino a Debussy nel la sua posiziorte
mondo musicale sei-setlecentesco e ai clavicembalisti, ricercando I'essenza e il significato di
invert. Debussy riseme ancora nel fatto melodico.
ODILON REDON
(Bordeaux. 1840 • Parigi. 1910). Pitlore. indsore. scrmorc iVancese.Allievo di Stanislas Gorin. acquerellisia, a Bordeaux e. in seguilo, a Parigi, di Gerome.
segui molto i consigli del botanico Clavaud e dell'incisore Bresdin; si dedico inizialmente al-rincisione a bulino, per passare poi alia lilografia. Rifiuta inizialmente il colore. in diretta an-litesi con le teorie impressioniste; e anche quando, piii tardi, passera all'uso del colore con l'ac-querelio e con l'olio, lo fara sempre in mc<dc< antinaturalistico, per esprimere la scgrela magiaimpalpabile di un mondo iinmaginario, fantastico, assolutarnente interiore, anche quando rap-presenta fenomeni della realta visibile. Grande ammiratore di Moreau, amico dei poeti par-nassiani e dei Nabis, precorse i simbolisti. Ha illustrato Ic opere di molti poeti, da Ma liar mea Huysmans (che fu, a sua volta, tra i suoi ammiratori), a Baudelaire. Per la ricchezza della suafantasia e per I" alone tra acquoreo e pulviscolare, ha alcune affinita col filomorfismo del I" ArtNouveau. Tra i suoi album di litografie Dans le reve (1879), Les orlgines (1883), La nuil (1886),Songes (1891). Ha esposio agli " Independants", di cui fu tra i fondatori, nel 1884; invitato da" Les XX '" di Bruxelles (1887 e 1890). a " La libre Esthetique " {1894, '95, "97), alia SecessioneViennese (1903)...
Da un profondo pessimismo egli pnasa, nella sua opera, ad una progressive liberazione
CHARLES R1CKETTS
(Ginevra. 1866-1931). Pitlore, scultorc. deeoratore. graphic designer ingUse.Cresciuto in Francia, visse poi a Londra. dove, Ira il 1889 c il 1897 diressc, con Charles
Shannon, la rivista « The Dial »; con Shannon illustro anche molti volutni di cui disegno anche
tra questi " A house of Pomegranates " (1891) e " Daphnis and Chloe '" (1893) di Oscar Wilde.Nel 1886 fondo la " Vale Press ", con la quale pubblico molte opere di Morris e dei Preraffael-lili. Fu anche creatore di gioielli e di piccoli bronzi. Dal 1922 lu membra della Royal Academy
RAINER M. RILKE(Praga, 1875 - Mltwl. 1926). Poeta tedesco.Tanta e la ricchezza di modulazioni musicali di quesia poesia. e sempre cosi rapide a mu-
tare il loro valore di suono e di voce perche premute da interni significali e analogie segrete. cheanche la dove 1'immagine originaria potrebbe consentire un riferimento alia tematica piii flo-reale I ultato till mo del canto gode di una liberta e di una pienez/a che sono inconsuele alle
pche figurazioni dell'esperienza simbolista: per non ricordare la densita delle interroga^ionim t che e la genuina ansia intellettuale che. animando la ricerca di rispondenze e di simbohnell grem U ed oscu re 1 del divino e deirumano, sottraggono le immagini all'inerzia di
u z on e figure troppo scopertamente significanti.
Ap llo primevo (da " Nuove Poesie")
£ 1 1 ' mcora • spogli un maliino surge, e in quel miimenm e prmiareru
dell u o I d'ombra e lontano da! suo sguardo inctiulo. iroppo fresca ela Inmh , , -,,ln lardi ati'arco delle pure
e i da cuifoglie caduie e sparse il Here . tremito della botra releranno.q ell I I e a solo I a un sorriso da cui nitida beve ,' il canto come im'acqua
eilu gola
Un dio lo pud. Ma un uomo. dimmi, come potret xeguirlo sulla cetra impart? Disvorde e il senso.Ap II la I all arti di due vie del ctmre.(da "Sonetti a Orfeo ", 1922; trad. J. Pinion
ARTHUR RIMBAUD
(Charleville, 1854 - Marsiglia. 1891). Poeta francese.Sc la leggenda del giovane poeta prodigio illumino il mondo letterario parigino dei primi
anni '70 del secolo scorso, la sua opera, di una novita bruciante e di un vigore lucidamente vi-sionarLo, porto alle conseguenze- estreme neiresperienza umana ed artistica il valore della libertaromantica, preseniendo gia consapevolmente la crisi in cui si sarebbe dibattuta la vicenda esteticadell'eta con tempo ranea e risolvendola, personalmente, con la scelta del rifiulo. Nonostante iltono profelico delle sue iliuminazioni e la loro incandescenza d"inferno il suo mondo resta benlontano dalle falotiche omhre in cui dovette dibatiersi tanto satanismo estelizzante dei decenni
N1COLAJ ANDRblVKH RIMSKLJ-KORSAKOV
(Tichvin. Novgorod. 1844 - Pietroburgo, 1908). Compositore russo.A Pietroburgo entro in contatto col gruppo di cui faceva parie Borodin, col quale cosii-
lui poi il "' Gruppo dei Cinque ". Diretlore dei Concert! sinfonici russi, diffuse all'estero la gio-
1884; " Principi di strumentazione ", 1913, che ebbe grande ascendenza per lo sviluppo dellamusica del '900), fu anche ottimo insegnante, ebbe tra i suoi allievi i maggiori esponenti della
Egli parte dall'esperienza del poema sinfonico di Berlioz e di Liszt, superando nell'orche-strazione quanto di tradizionale vi rimaneva. abbandonando la supremazia degli archi e ' punficando * i timbri per sfruttarne i colon armonici. Secondo le istanze del momento RiinskiiKorzakov si rifa a motivi nazionali attraverso la ricerca coslante del ' fiabesco ' , 1 " o d can
GlORCilO RODEMBACH
(Tournai. 1855 - Parigi. 1898). Poela belga.Per la tematica dei suoi poemes e delle sue prose, in cui prevale un crepuscolarismo brumoso
deralo. del gruppo dei poeti belgi di lingua francese, il piu fedele interprete deH'anima deca-dcntc del Sim oolismo.
ROSALROCF.
chiamata appunio, " Rosacroce ", alia quaie abbino un Salon dedicato agli artisli '" contrarialia volgarita e al materialismo del momento ", che egli considerava il vizio del suo tempo. Gliaderenti al gruppo della " Rosacroce " si ispiravano a Gustave Moreau, amavano i Preraffael-liti. le incisioni di Rops, le citta di Venezia e Bruges. Peladan dichiaro inscindibili poesia. pitturae ntusjca. Dichiaro guerra al patriottismo, al militarismo, promuovendo il ritorno a teorie mistico-lilosoflche e ali'occultismo; esaltava le filosofie oriental]; rimmagine femminile era sinonimo.per i Rosacrociani, di peccato, di satanismo, di corruzione; era assolutamente proibito alle donnedi esporre al Salon dei Rosacroce. Per il primo Salon, del 1882, Satie comporra la musica. Viparteciparono, tta gli altri, Khnopff, Toorop, Delville, Point. Non mandarono le loro opere.
reau. Redon, che pure ammiravano Peladan.
DANTE GABRIEL ROSSETTI
(Londra, 1828 - Birchington-on-sea, 1882). Poeta e piltore inglese.Suo padre, Gabnele Rossetti, era un patrioia abruzzese riparalo a Londra dopo i moti
carbonari del 1821; a Londra aveva sposato la figlia di Gaetano Polidon, gia segretario di Al-tieri. Dante Gabriel studi6 alia Royal Academy di Londra, dove divenne amico di Ford MadoxBrown. Nel 1847 ebbe occasione di acquistare un taccuino di appunti, poesie, disegni di Wil-liam Blake (il " Manoscritto Rossetli'") che fu la fonte di ispirazione e di riferimento di tunalimpostazione formale e poetica della Confraternita Preraffellita, che Rosselti fondo con MadoxBrown, Hoi man Hunt, John Everett Millais e Edward Bur ne-J ones, nel 1848, quando mmola sua attivita piltorica in senso mistico-allegorico medievaleggiante. Rossetti senti profonda-
posta di tornare all'arte italiana anteriore a Ratfaello (considerato allora il principale rappre-seniante del classicismo accademico) e di rifarsi alia pittura di Giotto e di Simone Martini. Inrealta la lotta dei Preraffaelliti e soprattutto contro il vuoto formalismo e la meccanica leviga-lezza di un"arte che La borghesia intende vantare come prova di una rispettabilita, di una moralepuritana, dei suoi alti tdeali e del suo senso poetico. I Preraffaelliti, molto vicini agli ideali socia-Li^teggianti di Morris, sentono il bisogno di rompere con la tradizione, Organo della Confrater-nita fu la rivista « The Germ », fondata da Rossetti, che ebbe vita breve.
Dopo una serie di viaggi in Europa, Rosselti (I860) sposo Elizabeth Siddal, una model I ache fu 1'ispiratrice costante della sua poesia e dei suoi quadri, prima e dopo la sua morte < 1862)dovuta ad una eccessiva dose di laudano. Da questo momento Rossetti si chiuse sempre piu.lasciandosi andare alia paranoia. Frattanto Ruskin, per aiutarlo, aveva acquistato gran partedei suoi lavori, ma la miseria lo tormento sempre. Alia morte della moglie egli aveva seppellitocon lei i suoi manoscritti, ma gli amici lo convinsero a recuperarli nel 1869. Dedito al bere e al-1'oppio abbandono da allora la pittura, mentre dette nella poesia la sua maniera migliore. An-che in poesia e in letteratura Rossetti interpreta e rivive la necessita di tornare agli scritlori iia-
al Decade ntismo.La sua ispirazione, di carattere simbolico-mistico, di una sensibilita velata di puritanesi-
fui fondo la "Morris, Marshall. Faulkner & Co. " nel 1861.Quando ormai la Confraternita Preralfaellita, che si era ispirata agli ideali di Ser Peladan
riusci ad esporre alia Royal Academy, Rossetti, che pure era stato amico di Whistler, ostacolo.invece. la nuova visione formale di Beardsley, il piu grande rappresentante del primo Art Nou-
JOHN RUSKIN
(Londra. 1819-1900). Critico e teorico deH'arte inglese.Mise in evidenza, nelle sue opere, la stretta relazione tra arte e ambiente, tema che iara
londamentale per i Preraffaelliti e, attraverso loro, dell'Art Nouveau. Fu tra i primi difensori
dei PrerafTaelliti. La sua criiica agli aspetli mercantili delta civilta industrial (alia quale con-trappose la civilta gotica), gli procure una reazione ostile da parte di molta cultura del tempo.Da ncordare la sua polemica con Whistler, che sfocio in un famoso processo per diffamazione,
un socialismo umanilario, utopistico. Tra le opere: " Le sette lampade deirarchitettura " (1849);" Le pietre di Venezia " (1851-1853).
Non pasxa giorna sert-tf xentirt? che til nwtri urchitelli inglexi e xlato vhieslo di e\xere original!
(IR94).
ALBERT PINK.HAM RYDER
(New Bedford. Mass., 1847 - New York, 1917). Pittore sialuniiense.
tonda meta del I" 800, nfiul6 il real ism o dominante per elaborare una sua particolare visione
certi aspetti, al Simbolismo europeo. Dal 1870 a New York, studio per qualche tempo alia Na-tional Academy of Design, allievo di Marshall. Net 1375 partecipo ad una espostzione di artislidissidenti e nel 1877 fu tra i fondatori della " Society of American Artists ". I temi del suoi qua-dri, ottenuti anche con tecniche particolari, a mezzo di strati di colore sovrapposti e vernieiaturesuccessive, che creavano effetti di profondita e bagliori nella materia. sono tratli dalla letteraturaromantica, dall'epopea biblica, da Shakespeare... Assolutamente ignorato ai suoi tempi, fu ri-scoperto dagli artisti della gcnerazione successiva. tra i quali Pollock.
liLILL SAARINEN
(Rantasalmi. Finlandia, 1873 Stati Uniti, 1950). Archhctto finlandese.Dopo aver compiuto i suoi studi di architettura a Helsinki, realizzo molto lavori in Finlan-
dui. tra i quali, il piii famoso, la Stazione ferroviaria di Helsinki e molte opere in collaborazione.Fu conosciuto all'estero per la realizzazione del padigtione finlandese per 1'Esposizione Univer-sale del 1900, in cui il suo ecleuismo si complica di reminiscenze folkloristiche del suo paese edi cadenze lineari art nouveau. Nel 1923 si trasferi, col figlio Eero, allora tredicenne (uno deiI'uiuri esponenti della nuova seuola americana), negli Stati Uniti, dove il suo linguaggio romantico
LOU SALOME-ANDREAS
iPietroburgo 1861-1937) Scriltrice tedesca e nola per \.i sua utnici/ia ton Nict/schc ditui era suta allieva e ton Rilke
La violenta rottura eon il filosofo fece grande scalpore: Lou alonu |C. F. Andreas. Tutta la sua opera risente deiratniosfera spirituale treatd ilintrospettivo di Ibsen. II suo libro su Nietzsche (" Nietzsche in eme \\ IGennania il grande dibattito ulla ideologia metz hi ana col libro Ih <_ E
ANTONIO SANTEL1A
(Como, I88S - Monfalcone. 1916). Arehitetto nStudio a Como e si Trasferi poi a Milano. dove seg
quentava 1'Accademia di Brera e si laureava in architettura a Bolognistici propri delle Secession), elaboro, su questa base, una e d p galia dirmmica lineare, facendo scattare la sua prima impos a on o.slrutturale fulurista; aderi infatti al Futurismo a 24 anni. elaborandt
con Boccioni e Mannetti, alia prima guerra mondiale, ne fu una del e me ne 6
tilULIO ARIST1DE SARTOR1O
(Roma, 1860-1932). Pittore italiano.
vollo a problemi sociali. Di questo momento e il quadre Malaria. Nel 1893 aderi al movimento" In arte libertas '". fondato da Nino Costa, ispirato alle istanze di ritorno alia tradizione. dicarattere preraffaellita. Collaboro poi con D"Annunzio alia rivista « II Convito » di Adolfo DeBosis e dal 1895 al "97 insegno all'Accademia di Weimar. In seguito ebbe la catledra di pittur iall'Accademia di Roma.
Volontario nella prima guerra mondiale, fu ferito e falto prigioniero; in seguito, rilasu uper intercessione del papa, torno al fronte per dipingere. Accelto poi i compromessi del nuoviregime, fino ad esser nominalo. nel 1929, accademico d'ltalia. Le sue reminiscenze letteranusimboliche si manifestano nei suoi quadri, piuttosto decorativi che verisli, tra cui La Gorgome gli Eroi sul tema. in lui ricorrente, della distruzione dell'Eroe da parte della donna, tema svol-to in termini masochisti e sensuali insieme; Diana d'Efeso e gli schiavi, entrambi alia Galleriud'Arte Moderna di Roma. Caralteristica espressione del gusto decadente del tempo sono le
sue illustrazioni della " Isotta Gutuidauro " di D'Annunzio (1886) e quelle del " Convito "(18951.
F.GON SCHIELE
(Danau. 1890 - Vienna. 1918). Pittore e gratico austriaco.Studio airAccademia di Vienna; nel 1907 incontro Klimt, allora nd pieno della sua fama.
nel 1911 fu tra i fondatori del " Neukunstgruppe'" (gruppo arte nuova). Da una iniziale ade-sione calligrafica, di raffinata e accesa acutezza, ai modi del I" Art Nouveau, che egli non avrebbepoluto poriare avanti, con side rata la sua drammaticita e la sua adesione a istanze popu lisle,passo ad una violenza espressiva cruda e impietosa, di carattere espressionista (egli guardo infattimolto a Kubin e a Kokoschka). I suoi disegni, di cruda accensione timbrica, frontali, quasi va-
gli causarono condanne per pornografia. Nel 1915 egli, trasferitosi in campagna. a Neulleniz-back, sposo Edith Harms: un breve momento di serenita, che si manifesto anche nelle opere.lu interrotto dalla guerra. Torno dalla guerra nel 1917 e nel 1918 perse la vita in una epidemicdi spagnola.
ARNOLD SCHONBERG
(Vienna. 1874 - Los Angeles, 1961). Compositore auslriaco.Aulodidatia, la sua opera si puo dividere in tre periodi: il primo, fino al 1907, permeato di
romantic is mo postwagneriano. di simbolismo, di ' florealismo %; il secondo, precedente ta primaguerra mondiale, e il periodo espressionista, in cui, con Kokoschka, Kandinskij, Marc, vieneinlrodotto nel gruppo del " Blaue Reiter "; gia in questo periodo Schonberg abbandona t'ar-
suo terzo penodo, quello ' dodecatonico , in cut egli unifichera, in assoluta panta, nelia ^amina
SCUOLA DI CHICAGO
Si definisce cosi 1'architellura commerciale realizzata a Chicago dopo la sua quasi totaledislruzione nell'incendio del 1871. che aveva dimostrato 1'incapacita di resistenza al fuoco dellestruliure portanti in ghisa; William Le Baron Jenny nello Home Insurance Building del 1883-] 885. un ediflcio di 10 piani, detle un esempio di sistema costruttivo a struttura metaltica e ri-vestimento in muratura, anche se I'innovazione costruttiva era quasi totalmente mascheratadalla facciata tradizionale, di carattere eclettico e storicistico. Gli esempi seguenti, di Adler.Sullivan, Burnham Root, Holabird, Roche, daranno avvio alia struttura archileltonica construtture portanti metalliche, sempre pill evidenziate, che costituira il ' grattacielo' americano.II Wainwright Building di St. Louis (1890-1891) e il Guarantee Building di Buffalo (1894-1895)di Sullivan, sono tra gli esempi piu notevoli di questo tipo di architettura. Lo spazio filirante.
Anche Frank Lloyd Wright uscira dalla lezione della Scuola di Chicago.
SECESS1ONE
Ho capito qual'e il dovere dei nostri giovani viennesi e ho capilo che la low Secessione deitcvvfr^ qualcosa di tolatmente diverse da quettu di Monaco e di Parigi,
A .Wontico e a Parigi il senso della Secesxione $ stato quello di porre una nuova ane accantouliu \otvhm... Wo. per noi e allro, non lottiamo per e eonlro una tradizione che non abbiatnu nt-ItHiti... i Hit per I or Is stessa, per il uiritlo di creare uriisticonjente...HI. lijlu. " Vereinigung bildender Kiinsller Oesterreichische Secession",
... Ci rivolgiatno a tutti voi, senza distinzione di dassi o di mezzi. Non conosciamo dijferenzatra Vane vera e propria e lane industrial?, tra I'arte dei rkchi e 1'arte dei poveri.
Vane e un bene comune... E se uno di voi dice: Maperche~ mat avrei bisogno di arlisti? 1 qua-dri non mi piacciono -, vorremmo rispondergli: Se non ti piaceioni i quadri. ti adorneremo le paretidi una magnifica lappezzeria; forse ti place bere il luo vino in un bicchiere artisticamente tavorato.rieni da noi, t'indicheremo il vaso dalla forma degna delta nobile bevanda.<n. 1, 1898).
Lo spirito della gioiinezza, che soffia nella primavera. li ha riuniti. lo spirito delta giovinezza.t'ht.- trax/orma sempre il presente in ' moderno ', che £ la forza creativa nell'operato artistico. chetie re dare il name a queste pagine con I'emblema di VER SACRUM, xacra primavera. e un buontimbolo, con cui la nuova comunitd di artisti nasce alia vita: anche i'origine di Roma eierna, lacilia delle arti e delfarte, e atlribuila ad un VER SACRUM.(M. Burckhardt. inlroduzione al I nuinero di « Vcr Sacrum », 1898).
GIOVANNI SEGANT1N1
(Arco, 1858 - Schafberg, 1899). Pittore italiano.
dul IK75 al 1879 frequenlo I'Accademia di Brera, dove assimilo l-esperienza del Naturalismo
si ritiro in Brianza, a Pusiano (1881-1886), dove realizzo molte opere di ispirazione naturalisticac paesaggistica; nel 1886 si ntir6 a Savognino, nei Grigioni (1886-1894), dove i suoi interessi
Dal 1891 si volse decisamente verso modi art nouveau. ai quali egli raccorda le sue ncer-che sulla luce, di tipo divisionista. Imbevuto di ricordi letterari, allegorici, delle leiture di Tol-stoi. D'Annunzio, Goelhe. Nietzsche. Maeterlinck e innamoralo delle stampe giapponesi cdelle pitture indiane. egli riesce a fondere tutte queste istanze con una consapevole rivisitazioneddl'arte italiana. dal Tre e Quatirocento fiorentino a Giorgione {Dea pagana, 1894-1897).
A questo momento seguira un ritorno al naturahsmo [II tritlico oclle i4lpi' In natum — hiviu/ — la morie) per il quale I'uso della tecnica divisionista serve a ribadire, nella compattezzadella superficie cromatica. il signilkato religioso.
GUSTAVE SERRURIER-BOVY
(1858-1910). Decoratore, ebanista. progettista belga.Interrolti gli studi di archuettura si reco in Ingbilterra dove entro in comatto con le espe-
nenzc ucl pnmo Art Nouveau. e conobbc le dottnnc di Morns. Tomato in palna si ceoica\••all"arredamento. disegnando mobili secondo lo • stile inglese ', che avranno ascendenza anchesu Van de Velde.
L \ \ SIBFLH s
nente maggiore del nnno\ainento mu icale flnnico u ba I nazionah Le sue opere la quelki pirate al imto andinavo ia quelle interpreti della malinconica imbolica bellezza della n<itura finmca uniscono elementi di un lardo epigom mo romantico ad e pre ioni propne delcinto popolare tinlindese
HUGO IMBERG
iHimn IS71 Ahtan 19I7) Pittore finlande e olaro di Gdllen Kallela d.tl 1895 ali s y \ «i iddinttura nello tudio del mae tro a Ruove I
I M>pi ututto noto per i suoi piccoli acquerelli con ene leggendane i pirate ad una fant -, iLi.it u i pinlei lita the vede nella natura elvaggia del paese nataL una lome me unbill, di e\ocaziom feenche
Un opera d arte egli nveva nferendo i agli atquerelh di Burne ones da lui \i ti durinle un naggio in Inghilterra parla di un allro mondo e n vegha in noi il enumento ehe I ar
l_e immagim devono re tare impre nella memoria e nempire il no tro pinto Una buonaopera niturali tica puo raggiungere que to n uliato ma 10 credo che la tilizzazione permettaancora di piu di raggiungere que to opo Nei uoi piccoli quadn imberg vela qua i leimmagim fantastiche che rappre enta con una uttile raggiera hneare come in // gelo del 189i
GlUSEPPt SOMMARUGA
(Milano. 1867-1917). Architetto italiano.Di famiglia artigiana studio all'Accademia di Brera sotto la guida di Camillo Boito. Nelb
sua architettura voile staccarsi dallo storicismo dello stesso Boito e dall"eclettismo provincialeimperante, proponendo una nuova organicita vitalistica che si lego, inevitabilmente. ai modidel liberty italiano, ma fu aperla alle istanze internazionali, soprattutto delta scuola Viennese,dal la quale egli si differ enzia per la plastica matericita delle super fici e per il vigore di una de-corazione dram ma tica mente intensa; nel Palazzo Casliglioni, a Milano (1903). egli riesce a su-perare anche L'impianto ottocentesco della costruzione svuotando 1 interno e articolandolonel grande atrio a piii volumi nel quale si snoda la scala. Tra le a It re opere di Sommaruga la pu-laziina Salmoiraghi (1906), YHotel Tre Croci presso Varese (1909). la C/inica Columbus a Mi-]ano 11909), di una viva articolazione spaziale e dalla decorazione piu Imeare. il \fausoleo Fat.-tranonia Santico.
RICHARD STRAUSS
(Monaco 1864 - Garmisch. Partenkirchen 1949) Composilore tcdesco.Amico di Ritter. scopri la musica di Berlioz, Liszt. Wagner. Si converti ventenne alia poetica
deirEspressionismo tedesco. Fu wagneriano, di un wagnerismo violento. esasperato. stravollo.come appare in " Guntram " (1894). " Feuersnot " (1901). '* Salome •"(1905), " Elektra "(1909).
tali da sfiorare 1'instabilita tonale. quasi in laceranti urti politonali. " Feuersnot" e il lavoroche meglio rappresenta il Moreale musicale, per la complessa, spiraliforme linearita. per la de-corativita cromalica. II dramma piii consono allo spirito dello " Jugend " e peraltro "' Salome "(su testo di Wilde), rappresentata per la prima volta a Dresda, il 9 dicembre del 1905, E un la-voro essenzialmente or chest rale e decorative; quasi un alfresco dai toni cupi della tempesta
di specchio della Vienna fin de siecle. ansiosa di esprimere In sua volultuosa volonta di vivere.alia vigilia di una grande tragedia.
IGOR STRAVINSKU
(O n nh n 188 Pa g 1974). Compositore russo.
po zon do II in c z a con Rirmkij-Korsakov. e alia sua assimilazione dell'Im-
pressionismo pittorico. " La Sagra della Primavera " pub considerarsi im esempio di Fauvisme
contro con Djaghilev, da cui nacque " L'Uccello di Tuoco ". L*opera di Stravinskij si puo di-videre in due periodi: il primo in cui la sua musica e a programmah il secondo in cui esvolla secondo schemi astratti. Nel passaggio tra i due periodi Stravinskij scopre il Jazz, cioche lo porta ad adottare nuove tecniche musicali, Upirate a forme geometriche nette. dure. che10 collegano a] Cubismo. Nel suo conlinuo impegno di ricerca va inserito ii lavoro di rielabo-razione. di riscoperta e di rilettura dei lesti classici (da Pergolesi. ad esempio). Anche la rilet-
tcrche di Freud e di Jung.
AUGUST STR1NDBERG
(Sloccolma, 1849-1912). Scrittore e drammaturgo svedese.La sua inquieta personality espressa, prima nel suo naturalismo, poi nella fase espressa-
mente simbolista, fanno di Strindberg uno degli esponenti piii importanti dell'inquieludinedel suo tempo. Le sue passioni per la teosofia, la teologia, npnotismo, la magia. ne fanno un
zionale. Rapp resent a. inoltre. una dcllc fonti del la dramirisiturgia moderna.
FRANZ VON STUCK ;
(Tettenweis. 1863 - Monaco, 1928). Pittore e scultore tedesco.Studia dal 1881 al 1884 alia Scuola di Arti plasticbe di Monaco e poi all'Accademia. allieio
di Lindenschtnit e di Bruno Piglheim, che gli fanno conoscere i Preraffaelliti e KhnopfT. Semeanche molto I'aseendenza di Bocklin. di Thoma, di Klinger, Inizia la sua attivila dedicandosiainilustrazione e al disegno (disegni umoristici per « Fliegende Blatter» di Monaco e « Alle-gorien und Embleme»). Verso il 1880 si dedica alia pittura di carattere simbolista. nelia qualetraspone in termini allegorico-simbolici il classicismo di Von Maree e di Hildebrand. Nel 1892e. con Triibner a altri artisti, tra i rondalori della " Secessione" di Monaco; dal 1895 insegnaall"Accademia di questa citta. Nel 1898 acquista la " villa Stuck ". che rappiesenta il suo capo-
La sua fama e diventata, intanto, grandissima; il &uo accademismo un po' morboso. nccodi ricordi. lievemente satanico ed estremamenie sensuale I neon tra no il favore di una societadecadenie e inquieu. che lo considera il ' Michelangelo ' della Germania bismarckiana: Tol-stoi, nel 1897, nel suo saggio "Che cos'e I'arte " lo atiacco violentemente; cio che accrebbe
Anche Boccioni, in " Pittura e scultura futurista "', lo attacchera. Ma Von Stuck ha indub-biamente avuto un peso nella formazione di De Chirico e anche di Dali.
Divenuto nobile verso gli anni '90. si dedicd al rilratto. per il quale utilizzava modelli fo-lografici. Anche come professore ebbe una grande risonanza.
LOUIS HENRY SULLIVAN
^Boston, 1856 - Chicago. 1924). Architetto statunitense.E la personality piii interessante della Scuola di Chicago. Figho di immigrati (irlandese
11 padre, svizzera-francese la madre), durante l'infanzia resto in campagna. presso i nonni.Studio presso il Massachusetts Institute of Technology e per qualche tempo all'Ecole dei
Beaux Arts a Parigi. Trasferi quindi in America alcuni dei tnotivi an nouveau intesi come de-menti di forma funzionale. A Chicago durante la rieostruzione seguita airincendio del 1871.lavoro presso lo studio dell'ingegnere Fredrick Baumann, dedicandosi a temi di carattere sirut-turale. Nel 1879 entro nello studio di Dankmar Adler, di cui fu in seguito socio, assumendo^ile responsabilita della progettazione, mentre ad Adler restavano i problem) tecnici. UAuditoriumBuilding di Chicago, (1886-1889) e il primo edifkio in collaborazione in cui [Hdeale architetto-
scita naiurale. In questo senso Sullivan faceva sua la poetica vitalislica, naturalistico-organicau^ll"Art Nouveau. Con le opere di Sullivan come la Bona di Chicago (1898-1899) e i Magaz-zmi Adler. Pirie. Scon & Co. (1899-19001, sempre in collaboraiione con Adler, gia si ponevanole basi del futuro razionalismo americano e si creava il tipo del grattacielo moderno. L u m ustilisiica vi e raggiunta attraverso la scansione ritmica dei volumi, svoiti secondo fenditure oriz-zontali che creano le grandi finestre filtranti; il motivo decorativo, leggerissimo. serve quasi
La Fiera di Chicago del 1893 segno la fine del funzionalismo della Scuola di Chicago e lostudio Adler/Sullivan resto senza incarichi. Sullivan si separo allora (1895) da Adler e si lascioandare, nella delusione di tutte le sue certezze, all'alcoolismo. Realizzo ancom molte opere no-tevoli. come la serie di piccole banche di provincia {la People Savings Association Bank di Sidney,del 1917; la Merchants Association Bank di Grinnel, 1914; la Farmers and Merchants InumBanks a Columbus, 1919) dove la ricca decorazione souolinea la funzionalita delle scansion.
biografia di un'idea ", 1922), Sullivan sottolinea i suoi legami con la tradizione americana de.piomen, secondo una interpret azione simbolica delTarchitetttira.
Enisle una speciate attrazione fra ornamento e struttura... per enlramhi perche si vatorizzuttorecipn/eamenle. E questo... cosliluisce una valida premessa per... un sislemu organico di orna-
C Kinderganten Chats and other Writings", in "The Engineering Magazine", 1892).
igio-
ALGERNON CHARLES SWINBURNE
(Londra. 1837-1909). Poeta inglese
fini che qui interessano, alia nota dominanle della sua ispirazione. I'esasperata concezione deisuoi idoli erotici la colloca al centro della correnie da cut derivano gl'inesauribili rivoli di morbosa e cerebrale sensualita propria di molti episodi dell'esperienza floreale.il giardino di Proserpina.
\on di macchie virgulti e slerpi I Qui ne canrte paiuslri o vigna, • Ma solo il papavero til-ligna. I Acini verdi di Proserpina.Pallidi bocci senza Jiore, I Schiera di sieli the mai foglia . Apre ., ella slillar non vogiia Pamorn un moriale liquor?In campi sHtrili at gram •' Sen~a nome e nuitiero sciQtoa .• Quesia ftimigiiti in sogut vam .' P t\ula testa fino all'alhaE come uti'utuina alU/nltila. Senza cornpagm' in cielo o inferno. .•' Battuta da hqualiido n\e
Sftt- i . ' • • . , • • •• • Pallida oltre I'alrio e il portal? / La Dea che ogni t'osa moriale\rll
Pin I t l iij D anwre the muto goinmli La lurha (he da lanli Itmpt
I tQliu per ogni irealura / Ella- qui vigita per lulli: I Ne la terra madre piu cura .• \:e In ma
La prirnaverti e le semettti i E per lei le rondini alaie I La seguono ore canla esltire . E spun
Vengono amori mirribondi. : Vecchi amori dall'ali fievoli ! Qui, gti anni consunli d'oznt e\oLe cose perdute dei mondi,Sogfu morli fit ftioriii spenti, (jt'tinogli dalle nei'i sco.\si, • Di pfimavere uccise i cos\i / Greggifiiglie sehuggi HI unit...Urud. L Traverso)
MARIA TENISHEVA. Principessa di Talashkino
SuH'esempio di Mamontov reaiizzo a Talashkino, vicino a Smolensk, una scuola d anee di arti applicate> dove raccoglieva orfani per fornire loro i rudimenti della lavorazione dei campi
ceramica. Per diffondere i lavori prodotti a Talashkino, che abbracciavano molti generi di ai-tivita, daLl"arte del legno alia eeramica al ricamo. la Tenisheva apri anche un negozio a Mosca.ma I'impresa falli quasi subilo. Essa slessa forniva i modelli agli artigiani e ne chiedeva aeli ar-listi, da Golovin a Vroubel a Miliutin. Nel 1905 la Telnisheva creo in Smolensk un piccolo mu-seo di pezzi d^artigianato russc antico, dove raccoglieva circa 10.000 pezzi important! di ncarno-oreficeria, ebanisteria. Ma lo stesso anno essa chiudeva la sua scuola d) Talashkino e si trasfe-riva a Parigi, dove organizzava esposizioni di artigianato russo antico al Musee des Arts De-coratifs, pezzi che poi rimando in Russia, all'Istiluto Archeologico di Mosca. Durante il suo
all-Universita di Mosca nel 1916. Ancora a Parigi dopo la rivoluzione continuo a sosienere unruolo importanle nclla vita culturale; apri presso la sua villa il " piccolo Talashkino ". una
JOHAN THORN PRIKKER
(L'Ajit. 1868 - Coloniu, 1932|. Piltorc c dccoralore olandese.Dal 1883 al 1887 frequento 1'Accademia di L'Aja. I suoi inizi nella pitlura sono di carai-
l(?re poslimpressionista e ' pointilliste ". Dal '92 al '95 esegue una serie di opere di tipo religio-^u e. nello studio per tali scene, egli si accosta ai primitivi fiamminghi e alia loro simbologia mi-
smo di Gauguin e, attraverso Verlaine, che egli conobbe nel 1892, del Simbolismo letterario.Amico di Van de Velde, ne condivise 1'intenzione sitnbolico-lineare; la linea divenne per luit'elemento caratterizzante di ogni espressivita: L% Voglio dire agli uomini le impressiom che provodavanti a certe lineei vogho tar loro comprendere che una semplicc unea dntta non mL fa lo $tes~o effetto di una curva irregolare " scriveva in una sua lettera del 1897. La linea e in effelti la
protagonista dello sue composizionu impostate secondo un simbolismo esoterico-mistico digrande suggestione, con rimandi analogic! segreti, quasi alchemici. In rapporto con gli espo-nenti del gruppo " Les XX "'. fu anche in Belgio dove non ebbe una grande accoglienza. madove alcuni amid lo aiutarono; tra questi H. P. Bremmer che gli acquisto molte opere per latollezione Kroller-Miiller. Tra il '92 e il '96 mantenne un rapporto epistolare con il letteratoimbolista Henri Borel, che gli fu ulile per il chiarimento delle sue teorie. Nel 1895 abbandono
li pittura da caialletto per " mettere la sua arte al servizio della vita ". dedicandosi alia deco-razione ad affresco, aH'esecuzione di vetrate per chiese catioliche. di mosaici. di opere grafichc.Nel 1904 insegnava a Krefeld, alia Kunstgewerbeschule; insegno anche a L'Aja, a Essen e. piutardi, a Monaco. Diisseldorf, Colonia. Lavoro nella decorazione anche in Germania.
LOUIS CONFORT TIFFANY
(New York. 1848-1933). Disegnatore e progettista di vetri, gioielli e arredatore statunitense.Figlio del noto orafo e gioielliere Charles Tiffany, si dedico inizialmente allo studio della
pmura^ fu a Pangi. dove studio pittura di psesaggio: ma ben prtsto si dedico alte arti decora-
live. Fece esperimenti di applicazioni chimiche col vetro e nel 1876 cred la prima vetrata in vetroopalescente r dal 1880 si affermo per il vetro ad iridescenze metalhche. Nel 1879 si era formatsla " Louis C. Tiffany Company Associates Artists " che si dedico all'arredamento di interni.tra cui, nel 1882-1883. la While House di Washington. Nel 1883 Louis C. Tiffany realizzo laCtippella per I'Esposizione Universale di Chicago, che trovo poi collocazione nella chiesa di SanGiovanni a New York. In tjuesta realizzazione e evidente l'ascendenza di Sullivan. Per 1'ecce-/ionale qualila e per la caratteristica formale dei suoi vetri. Tiffany ebbe anche i'incarieo di e,e-guire velrate su disegno di anisti famosi, tra cui Vuillard, Bonnard, Toulouse-Lautrec. E nolo•.opniituito per i vetri iridescent! di tipo floreale in ' favrile glass' (vetro febbrile), nel cui spessoresombrano pirodursi degli effetti di sovramtnissione di relini tipografici. Con i suoi vetri vinse an-(.IIL- il (irjin Premio all'Esposizione Internazionale di Torino del 1902. Dopo la morte del pa-dre. Louis C. Tiffany si dedico al gioiello e alia costruzione della propria casa. la Laurellon Hal!a Long Island, arricchila di un parco alTitaliana.
Nel 1932 la Tiffany Studios falli e nel 1946 la collezione della Laurelton Hall fu lenduta
JAN TOOROP
(Pocrworedjo, Giava, 1858 - L'Aja, 1928). Pittore olandese.Nel 1897 era in Olanda. Studio disegno a Delft e ad Amsterdam: ebbe poi unj borsa di
-.ludio e parti per Bruxelles dove entro in relazione col gruppo " Les XX " che. nel IBY4. si tr.i-stormo in " La libre Esthetique ". Nel 1885 entro nel gruppo. Frequento Khnopff. Ensor. Vogeli.Van Rijsselberghe, Fich, De Groux. Nel 1884 fece un viaggio a Londra con Verhaeren. Quiincontro Ensor, col quale prosegui per Parigi per visitare i musei; da solo continuo il suo viag-
Nel 1886 incontro, a Londra, Whistler che gli fece conoscere le opere dei Preraffaelliti ele teorie socialiste e umanitarie di Morris. Tomato in Olanda, per un cerio periodo pratico latcenica ' poimilliste ". prime nel suo paese. Ma il significato simbolico della linea lo attraevain maniera inequivocabile. anche perche vicino al genere di disegno che egli aveva conosciuioa Giava. ai suoi inizi. Al tra verso il suo linearismo avvolgente. spiral if or me, egli esprime il suo
magiche. Nel 1892 entro anche in rapporto con Ser Peladan, il fondatore dei " Rosacroce":un libro di lui, " Le vice supreme '", gli fu ispiratore di molti temi. Subi anche 1'ascendenza degliscritti di Maeterlinck.
HfiNRl DE TOULOUSE-LAUTREC
(Albi. 1864 Malrome, Gironda. 1901). Pittore francese.La vicenda di Toulouse-Lautrec esce dalle linee di questa trattazione, entrandone. quasi
di denvazione impressionista. Comune alia poetica dell'Art Nouveau e la sua passione per leMampe giapponesi, che egh nversa, appunto, nei suoi manifesti, di una ramnata, vivissima rea-
i personaggi della % belle epoque ^ parigina. La sua storia, quasi di specchio straordinario delclima parigino del tempo, la sua partecipazione emotiva, realistica, spesso spietatamente cruda,ne fanno uno degli esponenli piu important! del postimpressionismo europeo.
FLL1X VALLOTTON
(Losaima. 1K65 - Parigi, 1925). Piltore francese.
vais; dal 1887 si dedico anche alia grafica; lavoro a punta secca, all"acquaforte e, dal '91. aliaxilografia. Collaboro alia « Revue Blanche » di Parigi, alia rivista americana « Chap Book ..e alia tedesca « Pan »r Elaboro un suo linguaggio di carattere quasi purista, decantato. in cuiuna certa ascendenza hodleriana si risolve nella luminosa chiarezza del coiore e nella smaltaTa
ginali, limilandosi a pure analogic tematiche.
HLNRY CLEMENS VAN DE VELDE
[Anversa, 1863 - Zurigo, 1957|. Architelto. designer, piltore. teonco belga.Di famiglia agiata. studio dal 1881 al 1884 all'Accademia di Belle Arti di Anvcrsa Passo
poi a Parigi dove prosegui gli studi di pittura e fu in rapporto coi pittori postimpressionisti e•.imbolisti. Nel 1889, a Bruxelles, faceva pane del gruppo " Les XX" , dopo aver partecipatond 1886 alia fondazione del circolo culturale " Alsik Kan " e. nel 1887, a quella de " L'Art in-
noscenza delle teorie di Morris, si dedico all"architettura e alle arti' applicate. Nello stesso annostudio I'impaginazione e i caratteri per la rivista letteraria « Van nu en Straks ». che contribuial rinnovamento del libro in Belgio.
Sul tema del rapporto tra arte e societa egli imposta il suo lavoro e la sua ricerca sull'un-Hzzazione degli strumenti offerti dalla macchina e dalle nuove tecnologie industrial], nei qualivede il solo mezzo di rinnovamento, secondo la teoria dell' " Emfuhlung ", impostato sul si-gnificato psicologico della forma che interpreta la funzione. II primo esempio delle sue teoneegli lo dette con la sua casa di Uccle, la " Bloemonwerf", presso Bruxelles (1894), che arredde decoro personalmente, fin nei particolari, secondo una fluidita di rapporti continui, rappre-
condo una visione che unifica I'arch itettura, 1'arredo. la decorazione, le suppellettili. fino aeliabiti degli abitanti della casa.
Del 1896 e la sua esposizione di Parigi, del "97 quella di Dresda, che contribuirono forte-
o esempio. dalla sua cominua preoccupazione didatiica e di sollecitazionc culturale che eglin a a a d propaganda delle idee, le sue con-
e e conosce e a Sigfried Bing. che aveva aperiod a o a egli ne divenne uno dei principal fornitori.
>prio laboratorio di ani applicaie. prendendo spunto
h k j . m a g and a d assonia per dirigere il Kunstge-rblicher Institui. che puo esser consideralo un precedent direlto del Bauhaus. Nel 1906 VanVelde ne progetlava la nuova sede. nella quale egli propone gia una linea razionale, e in cui
pietra tra le vetrate. Fu una delle figure di primo piano del " Werkbund '" (Lega del lavoro).per il quale costrui nel 1914 il teatro per 1'esposizione di Colonia. La sua ispirazione e foriementelegata al senso della • linea belga " (che ebbe anche il nome di • linea Van dc Velde '). interpie-
Inscriio foriemente nella dialeitica del movimento moderno Van de Velde ha cominuatoLi -u;i atiivitLi prolL-ssionak-. duiatinM. promozionale. fino ai suoi ultimi anni; dal 1937 al "54UMII/AI il Mim-H kniller- Uitllri .i OMcrlo; del 1957 e la progeHazione del padigliime belga al-I'l.sposi/kinc Ji P J I I H J .u i l.i su,i .nitsione alle istanze del movimemo moderno e chiaramenlenconn^-ibilo F si.n.> .HKIIU III.LJII.MIR- .ilI'Muulo Supcnore tli Arehilellura di Bruxelles. Dal1947 si stabili in Si ..-, • < > M , I_L'I\ MI/ .. ,.!.. .• -k-m., • •! ,• -in- memorie.
Traisuoiscrm I . . . I • • inascila dell'arligianaloartistico modern,- ' • : ) • . . • • -i.o. ' (1902)' "Verso unnuovoslile"(l9()T) v . - - I N I . un . i . .1. I, l(,1,v/, ..-,; U'tuinica moderna " (1917);" Formule di UTKI 1-Atctic.i nuiik-rnj " (W2.li
tMILE VERHAEREN
(Sainl-Amand, 1B55 - Rouen, 1916). Poeia belgj
tostante impegno ul fronie delle aril (le nvi te « La Jeune Belgique », « L'An Moderne >•. « La\Vallonie » lo videro fra I piu assidui collaboratori) jn difesa dei movirtienti estetici coniempo-ranei per non cilare il suo piii vasio impegno sociale (la collaborazione a n La Societe Nou-velle » ne c un aspetlo) che lo sollecilo verso forme di diffusione della cullura arlistica ad ogni
pingendolo sulla via della denuncia in una fioruura vertiginosa d^irnmagini che espnmono in
hcinli vi 10m della societa del *uo lempo.
Giorgio
Oh Animate, mie voci di speran-a. / suonate in me! Suonale soiw r rami. in ampie \ie tut-%enti e m me" o al sole! / Miche d'argento, siale t'esutianza, vor, fra le pielre! E m i *i-loli bianchi i deUacqwQ, nei ruscelh si spalanchi •' I'ucchio voxtro aliraverso quelle palpebrt'd'acqua! Paesagxio dai vertnigli Idghi. ' oh lo specchio lu sia dei \ohii di tiumnw di San Gi >r-
lt< sonu itulo un vile , e in un futile orgoglio sum, evwso . dal ntondo. Ho solte\ati i mar-mi doro d'una scie»:a ostile / a verlici sbarrali / doraculi anneriii. La signora deile MYC <•la morte, e neil'aurora j sitltanlo rischiarali i sono gli sfor2i delle genii umane. Coi toro fiortla preghiera vuoie j sboceiare. e tulle quelle labbra arcane j kanno la stesso ariinialo. Sull'ai-liiiu I di madreperla. il sole j bianco come una mano di carezza j sulla vita si sente...llrad. V. Paganoi
PAUL VERLAINE
(Pangi. 1844-18%). Poeia Trance eNella sua professione estetica esaho il valore dello sfumato. deirevanescenie. del verso di
olto nella musica deli'indeciso: e in queslo confonder&i di suoni e di toni, in queslo prolun
ohincL oltre al ribelle soprassalto del proprio diriuo ad ardere. Certe sue effusioni di lineeeerie ei ine tenzi di torn lo fanno, dei poed della sua generazione. Torse Ira i piu all uni onocon la vibratile anima del simbolismo fine ecolo
i sopore di stanco amore, i tin brividirt iti rcimi nella blandizic del \tntn^tnitt t querula di richtami
Hi /'limit tluti/ue ili fronde i nturmure vario s'ejjonde, le note e ftebili i' gate tletl'erhu Infttttntt uppenti, , .utstirri d'onda serena / sul tremolio delli- ghiitiiL'animtt die si lamenta I melodica e sounolenta. / e I'aninta nostra vent: la ntu. dininii. c himia i salami la salmodia / umile alia dolce \eraItrad. R. Palatronil
EUGEM; EMMANUELE V1OLLET-LE-DUC
(Pariyi. IS14 Losiinna. 1879). Arthitctio f tcorico dell'architeltura Irancese.
Allievo del critico E. Delecluse. fu amico di P. Merimee, che da] 1873 fu soprintendente
cese medievale. Fu anche a Roma e in Sicilia, dove studio I'architetlura classica. Si dedico poi
punto di riferimemo internazionale, anche se non fu esente da arbitri e abusi dovuti al gustocorrente, soprattutto per la sua impostazione ' interpretativa' del restauro che lo portd a fre-
ormai lo strumento piu in uso della nuova architetlura. E autore di un importante " Dizioriarioragionato deirarchiteltura francese dall'Xl al XVI secolo " (I854-1B58).
Nel 1840 Viollet-Le-Duc fu incaricato del restauro della Madelaine di Vezelay. e. con LUSMIS.collaboro al restauro della Sainie Chapelie e di Noire Dame a Parigt.
Nel 1848 era ispettore generale dei monumenli diocesani e nel "53 iniziava il grande restaurodella cittadella medievale di Curi-tuMinne.
CHARLES FRANCIS ANNESLEY VOYSEY
(Hessle. Yorkshire. 1857 - Winchester, 1941). Architetto inglese.Allievo di J. P. Seddon, fortemente influenzato da Mackmurdo. dal 1874 al 1893 si dedico
soprattutto alle arti applicate. disegnando stoffe. carte da parati, tappeti, secondo le ipotesidi rinnovamento del gusto suscitate dalle teorie di Morris. Dal 1888 si dedico anche all'architet-
che gli imitatori fecero scadere in maniera. Tra le opere: Vedificio in Bedford Park, a Londra.del 1888; stadia in Wesi Kensington a Londra. 1891: rasa di campagna Perricroft a Collwall:casa The Orchard, realizzata per se stesso a Charleywood nel 1900. che preannunzia motivi ra-
// pericolo oggi e nella sovrabbondanza degli ornamenti... Dobbiamo avvicinarci alia Saturncome sorgenle di ispirazione e guida. Allora saretntno immediatamente tiberati dalle costtizivmdello stile e del tempo, e potremmo livere e lavorare nel preseme con leggi che rivelano sempre nuo-ve possibilila.(in "The Studio », Londra, 1893).
MICHAEL ALEXANDROVITCH VRUBEL
(Omsk, Siberia, 1856 - San Pietroburgo. oggi Leningrado, 1910). Pittore russo.Portato. fin dall'infanzia, verso la musica e il disegno, studio dapprima diritto e solo nel
INS4 pote entrare all"Accademia. Collaboro. ai suoi inizi. al restauro degli affreschi della chiesa1.1] San Cirillo a Kiev, per cui realizzo anche, per I'iconostasi una serie di icone Visito 1'ltalianel 1884-1885, stabilendosi, poi, a Mosca. dove lavoro per il teatro. Grazie all'aiulo di Mamon-IOV {i] noto industriale promotore del rinnovamenlo delTarte e deile arti applicate in Russia.a Tal ash kino, e fondatore dell'opera privata russa) Vroubel si avvicino alia pittura di Nesterot.Korovine, Serov, e alle nuove rice re he internazionali. Trasse continua fonte di ispirazione dalleopere di Puskin, Lermontov e dalla musica di Rimsky-Korsakof, secondo una sua particolareatlesione al Simbolismo internazionale, che egli interpreta nella trascrizione di immagini so-ynale. espresse in una dovizia di parlicolari decorativi, rutilanti, tratti anche dal patrimoniotnlkloristicodell'antica Russia. Anche il suo mam mom o con la cantante Nadezda Zabela (1896)comribui alia sua esaltazione poetica dell'immagine femminile. Una grave malattia lo costrinse
quale egli tendeva, nella previsione di un totale sconvolgimento, a L' elevare Tanima per mezzodi grandiose immagini, al di la della meschinita quotidiana ".
OTTO WAGNER
(Petzing, Vienna, 1841 Vienna. 1918). Archilctio c urbanisla auslriaco.Inizio i suoi studi alia Technische Hochschule di Vienna nel 1857. Frequento poi. nel 1860.
la Bauakademiedi Berlinoedal 1861 a I'63 la Scuoladi Architetlura presso 1'Accademia di Vienna.Ebbe un inizio storicistico, di tipo classicheggiante, con riferimenti al Quattrocento Rorentino.secondo una chiara visione geometrica di uno spazio bloccato, rigorosamente equilibrato. chelo rese celebre, tanto che gli fu affidata la ristrutturazione urbanislica di Vienna. Di questo pianoegli pote realizzare soltanto la Meiropoiitana (1894-1897). Le stazioni della Metropolilana se-gnano un po' il punto di passaggio del suo lavoro; nel 1894 egli era divenulo di ret tore di un corsospecials di architettura all'Accademia di Vienna; fu 1'occasione per una revisione toiale e peruna presa di posizione teorica che lo apri alle nuove proposte architenoniche formulate in Bel-gio, a Parigi, a Monaco. La nuova architettura, egli dichiarava nella sua prolusione alle leziorndeve tener conto delle cambiate esigenze della vita e le sue forme devono desumersi da quesie;proponeva percio I'uso onesto ed esatlo dei nuovi materiati e delle nuove tecniche. Se le stazionidella Meiropoiitana di Vienna rappresentano il momenta di Iransizione. gia svolta sull'usocorretto delle strutture in ferro, ma ancora legate a formule decorative di tipo storicistico. le operesuccessive dimostrano la nuova visione di Wagner: la Cassa di Risparmio Posiale di Vienna(1904-1906) mosira infine una completa adesione alle leggi del movimento moderno e dell'ar-chitettura rationale, secondo una dinamica costruttiva coerente e consapevole. L'trnponanzadi Wagner resia soprattutto legata alia sua straordinaria qualita di maestro, che dara I 'amoalia formazione di quella Scuola di Vienna che ha avuto un significato particolaie nello svolgj-mento del movimento moderno. Sono stati suoi allievi Loos, Hoffmann, Olbrich. E il suo libro" Moderne Architektur'", uscito a Vienna nel 1895 (che e in parte il risultato delle sue leziooiLe st a to uno dei principali mezzi di diffusione delle nuove teorie. particolarmente in Italia-
La rivoluzione sard di tale porlala. die a malapenu piilrenm pitrlnre di win rimiscita del Rina-
(in « Moderne Architektur », 1885).
RICHARD WAGNER
(Lipsia. 1813 Vene/.ia, 1883). Musicisla ledesco.
sicale. La sua idea di un ' Lea [TO totale " che riunisse in se tutle le arli coincide con la poetica del
e la nascita di ' Leitmotive ', che compare nella sua " Tetralogia ". Fu in rapporto con l.hzl.dicui sposo la figlia Cosima e fu amicodi Nielzsche. II suo nome fu COM i:.uo i,, • i•..•:>. ,!u
e perfino i dodecafonici devono a lui la tecnica del linguaggio musicale. And .• . ••• .tra i quali Debussy. Busoni, Strawinskij, non poterono prescindere dalle -nc : 111 • t H••-. i i -. 11-• i IV1-leas el Melisande '" di Debussy, ad esempio, opera concepita come antiwagnenana per eccel-lenza, semanticamente e ngha del Tristano e Isotta . bspressione del titanic mo, del gerrna-nismo del tempo, uomo dagli aspetti molleplici, ha interessaio filosofi e lelterali quali Nietzsche,Adorno. Baudelaire, D"Annunzio, Mann. Shaw...
JAMES ABBOTT MCNE1LL WH1STLLR
(Lowell, Mass.. 1834 Chelsea. Londra. 1903). Putcire americano.Studio in America e dal 1843 a Pieiroburgo dove il padre era ingegnere I'erroviario del go-
verno russo. Tornalo in palria, dal 1851 frequento I'Accademia Militare di West Point fino al "54,quando si impiego come cartografo nel Dipartimento del la Marina a Washington. Ma la suapassione per la pittura lo costrinse ad abbandonare tutto e a trasferirsi a Parigi (1855). Fu dap-prima alia scuola di Gleyre. dove conobbe Degas, Lagros, Bracquemond. Divenne poi amicodi Fantin-Latour e con lui visito il Pavilion du Realisme di Courbet, con le opere rifiutate al-I'Esposizione Internazionale del "55. Ne fu fortemente impressionato e ne furono improntatele opere che, escluse dalla gluna del Salon, espose con quelle di Fantin-Latour nello studio diBouvin nel 1859. Intanto era passalo a Londra, portandovi la scoperta delle stampe giapponesie la passione per la raccolta delle porcellane cinesi, che trasmise ai Preraffaelliti e agli esteti in-glesi. Dal '64 la sua pittura si e liberata dal realismo, per passare a preoccupazioni di ordinetonale. sulla scia degli Impressionisti. Le opere esposte al Salon nel '65 a Parigi (Rose and Silver.The Princess of the country of the Porcelain) gia dimostrano la nuova visione, la ricerca tonalealia quak ogni cosa, anche il soggetlo, viene subordinate (in questo consisle la sua dilTerenzaprincipal dagli Impressionist!). Addirittura egli tende ad assimilare la condizione espressivadeila pittura a quella della musica; cio che appare chiaro anche dai tjtoh: armonia. sinfoma.
1'insegnamento di Courbet e le sue opere precedent! e a rivendicare alia pittura la liberta asio-luta anche dalla natura. Impregnato di estetismo letterario e di esotismo eseguira a Londra.nel "76-"77. la Peacock Room (la stanza dei pavoni) per F. R. Leyland. come cornice alia sua Prix-eipessa del paese della poreellana (ora la stanza e a Washington, alia Freer Gallery of Art I. Bencheintimo di Oante Gabriel Kossetti non ne condivide le idee urnamtane, 1 eticftta della sua lmpo-
irasta anche con quella di Morris e di Arts and Crafts. Mentre e veramente importante la suafunzione di tramite tra Tarte orientate e 1'impostazione art nouveau.
L'opera di Whistler ebbe molta risonanza presso i letlerati e i poeti. come afTermazione diuna concezione dell'arte basata sul principio della liberta dell'artista da ogni vincolo contenu-lislico e etico. Nel 1878 Whistler intenla un processo a John Ruskin che, in un arlicolo su « ForsScaligera », riferendosi al Notturno in nero e oro di Whistler, esposto alia Grosvenor Gallerydi Londra, aveva parlato di " consapevole impostura ". contestandone il prezzo. Whistler escevincitore dal processo ma. data la grande importanza di Ruskin, praticamente Whistler ne vienecompromesso. La sua casa e venduta. la sua raccolta di poreellana messa all'asta. Dal 1879 al1880 e a Venezia; poi a Parigi; nel 1883 e di nuovo a Londra e nel 1884 a Parigi. dove apreuna scuoia di pittura. Nel 1886 e invitato ad esporre alia societa des Vingl di Bruxelles e. nellostesso anno espone a Parigi con gli Impressionist!, alia Galleria Georges Petit. Scrisse "TheGentle Art of Macking Enemies " (Londra, 1880) e " The Baronet and the Butterfly " (a pro-posiio di un processo contro W, Eden).
leri I'al"-,' mri',! tr« rrr p.x-mnm a pranzo a casa sua. Verdurin, lex criiieo della « Revue »,I ' a u t a i e J ••„ • •'•'•" li ' • '•' • •• <n ilnvvera il piglio, la squisila pennellala dell'originale A/ne-
le g r a / i . ' . • , • . ••• . . • d u r i n .
(Kratclli l iuikouii . in .. U JULIIII dopo il 1891).
WALT WHITMAN
iWeM Hills, Huntington, Long Island. 1819 - Camden, 1892). Poeta statunitense.Puo csscr considerato. in poesia. il piu cospicuo rappresentante dello spirito pionieristico
americuno. Due gli aspetti pecuiiari della sua opera: I'uno, il suo contenuto, ape no a una visionetolale della vicenda urn ana e della natura, animato da una fervid a vital ita nel I'afTermazione delleproprie fedi e delle proprie passioni (panteismo ed egualitarismo democratico ne so no i terminipiu influenti). L'altro. attinente alia tecnica poetica: fu il primo dei poeti americani a ricorrereal metro libero. sciogliendo il verso da rime e schemi tradizionali. sollecitando il gioco delle im-magini e degli effetti musicali in modo da otlenere una ricchezza di risonanze e di echi da im-
OSCAR WILDF
(Dublino. 1854 Parigi. 1900). Narralore. commediograib inglcsc.La sua opera, forse perche iroppo assimilata al personaggio che Wilde si send deslinato a
rjppresentare nella vita* propone e dissolve, in una fluida divulgazione di motivi e di emblemi.lutii i terni propri dell'arte simbolista associaii inesorabilmente al concetto di decadente. " LaSlinge "- " Salome ", " il ritratto di Dorian Gray *" segnano i momenti piii tipici di quest'arrendl'ambiio del movimento floreale. congenial mente derivati ne) so Leo di nitre illustri. precedenliL'.,vrk-[]/L' (Pater. Huysmans).
(da una conferenza, 1914).
Ah! ho bacialo la tua bocca. Jokunaan, ho hticiato la lull hocca, Cera un mpore di amaro sulk'nil- labbra. Era il sapore del sartgue? No. forse eta il sapore dell'amore.
Si dice che famore sa di amaro... Ma che imporla. che imporla? Ho haciata la ma bocca. Jo-kanaan. ho bacialo la tua bocca.{" Salome ", IS93).
Ogni arte e ad un tempo epidermide e sitnbolo.Coloro che vogliono andare sotlo I'epidermide In jiinno u prnpritt rixchiii.Lo spettatore e non la vita tiene rispecchiato dall'arie...Possiamo perdonare a un uomo di aver fatto qualche cosa di ulile purche non I'ammin.tunica scusa per aver fatto una cosa inutile e di ammirarla inlensanienle.Tuna Vane e perfellameme inutile.
(" II ritratto di Dorian Gray". 1891).
ADOLKO WILDT
(Milano, 1868-1931). Scultore italiano.Alhevo, a Milano> di Grandi> rifiuto di aderire al linguaggio impressionista delia scuitura
del tempo, proponendo, invece> un suo particolare Linguaggio plastico, di un purismo linear?
La sua si avvicina per molti aspetti, alia ncerca plastica del belga Minne, di cui esaspera la stiliz-zazione, con un risultato che ne fa uno dei maggiori esponenti del liberty in scultura. U suaopera piii nota, dal 1912, e la fontana per il giardino di Villa Reale a Milano.
JENS FERDINAND WILLUMSEN
(Copenhagen. 1863 - Cannes. 1958). Pittore dani.
lismo all Espressiomsmo, col tramite del momento simbolista. Vissc saltuariamente a Pan&tra il 1888 e il 1894; negli intervalli viaggio in Spagna (dove si entusiasmo per El Greco e perGoya). Fu amico di Van Gogh, che gli fece conoscere Odilon Redon, la cui opera fu determinantsper il suo momento simbolista. In Norvegia si entusiasmo per il carattere maestoso delle grandimomagne e delle fore te
M suo simbolismo drammatico e condotto secondo una gamma di colori accesi. che tra-
SM ( e e p r e on t
I RANK. LLOYD WRIGHT
lur sul nnnovamento dello spazio interno. secondo una visione aperta e rivoluzionaria. aliaquule non sono estranei i motivi piii profondi di trasformazioite dello spazio propri deH'Arr
I ittona del nonno e da una primissima educazione froebeliana. E il massimo e&ponente della
arredi- Mentre il suo linguaggio posteriore. che esula dagli interessi di que ta trattazione si onenicra verso una interpretazione dello spazio architetlonico come protagomsta unico deH'architcttura. che ne fara uno tra i protagonisti essenziali della visione archileltonica contemporanea
WILLIAM B. YEATS
(Duhlino. 1865 - Roquebrune. 1939). Poeta irlandese.Tra i maggiori poeti contemporanei di lingua inglese. alimento la propria lirica gio\ anile
popolare. particolarmente neiTambito del teatro. Nella produzione della maturita. pur conli-nuando ad at tinge re alle so r genii della natura e del paesaggio irlandese. sviluppo temi piii com-pie i net quali un'onda di sitnboli e di piesenze mistiche aiuta le immagini a liberarsi dalle cor-renti piii misteriose del pensiero e del sangue. L'atlrazione per le dot trine misteriosofiche lo n-condusse all7opera di Blake e dei preraffaelliti.
Le wimagini, cite non /itrrava it giarno, vaporana; i sotdati imperitili / dormono neliebrez'uogni natturntt eco \apnru il canto dei viandanti ! dopo il gong delta grande caltedrate; i ni'ltuine delle stelle o delta luntt un duo/no sdegna ogni orma d'ttomo, / la furia e il fango dt'llc
Un'uttugine vugofti, ombra o uonw- , oinbra non uomo, imagine non ombra; / che nelle bendudellc nmmmie arvolta la rmca d'Ade pud snodare il nodo j dei sentieri; ana bocca ien:u fiatopin'i t'om'Ui'uf? btifr'clu? s&iiza tiato,' / to aw saiuto i\ sovFtimanoi / fftorlc in vita to chia/uo f WM
V/fV[/[-n/jj. [tixoru d'oro o uccello, i piu tniracoto che lavoro o uccvtlo, ! sul ramo d'oro at luntftk'llt' \H-lif i'tmie i galli delt'Ade pud cantare / o, amareggiato datla tuna, in gloria I di melaltoninutuihiic \<.iurniire ' peiuli e uccetli quotidiani •' e ogni traccio del fungo e delle lene
tu genera la fiamma ' >t i ultintijnomi in danza tm'agaimi • imi
s i i< Ifini in grappa / un ,/>./••• ; -n.punn i! ftuiio< , , ,i I marnu delle ah , . /. iintuimi
ntnl L. Tr^vcrso)
\ n i O R l O ZECCH1N
iVenczia. 1878-1947). Pinon. e decoratore iijliano
del lavoro piiioi i. . . . . Klimt, presente alia Biennale del 1910. La cono enza (ml i\enezwnd dellc |I,I-IM,.I .I .M i.mJic ed espressive della materia yelrosa comribui al chian
> mi deiradesione all'Art Nou\eau in llalia
B1BL10GRAFIA TESTI E PUBBL1CAZIONI Dl PROTAGONISTI
ADOLPHE APPIA: La mise en scene du drame aagnerien. Parigi, 1895. / Die Musik und die Inszenie-rung, Monaco. 1899.CHARLES ROBERT ASHBEE: A Short Hislorv of the Guild and School of Handicraft, in " Transactionof the Guild and School of Handicraft'", Londra, 1890. / A few Chapters on Workshop Recon-struction and Citizenship. Londra. 1894. • On Table Service, in "The An Journal". Londra.IS'JS IH indeavour towards the Teaching of John Raskin and It'. Morris. Londra, 1901 Mo-dn,, mglnli Siherwork, Londra, 1909.i KM sio IIA.SILL: Per il mio progetto delpalazzo di Giuslhia e per I'Arie. Roma. 1884. Progeitoper d jiulazzu del Parlamento ita/iano: premialo a! Concorso nazionale del IS89, Roma. 1890.Studi e .schizzi. Torino, 1911HERMAN BAHR Sezession. Vienna, 1900-AUBREV BEARD^LEY The Eatlv Work of Aubrey Beardslev, Londra e New York. 1899. The La-
Work .)/ Aubrey Beardslev. Londra e New York, 1901. / Hunder the Hill. Londra. 1904.i H i RI Ff-iv di", Lebens und der Kunst. Jena. 1900. / Em Dokument Deutscher Kumi.
handier Koionie in Darmstadt, Monaco. 1901.i / -Russkoi Zhivopisi v XIX Veke, Pietroburgo. 1902. / Reminiscences
I i mdra, 1941Over Archilektur. in « Tweemaandlijk Tijdschrift ». Amsterdam.
I II den Stil in der Baukunst. Lipsia, 1905.Illustrations and Essuyes. Londra, 1888-1891 (trad, a Parigi e a
Lp qeenAmenqui Parigi 189^ Salon de I'Art Nouveau. Parigi. 1896.
Record ». New York e Londra, 1902.\MLLIAM BRADLEY: « Bradley - His Books, dal 1896.HAN CHRI TFAN EN Neue Flachornamente auf Grund won Naturformen, 1889.TH. A. COOK. The curves of Life. New York, 1914.EDVARD GORDON CRAHJ ; The Art of the Theater, Londra, 1905. / The Actor and the Vber-SIa-rionette'. in « The Mask >•, 1908. / On the Art of the Theater. Londra, 1911. / Toward a nen Thea-ter, Londra, 1913.WALTER CRANE: The Claims of Decorative Art. Londra, 1892. / On the Decorative Illustrationof Books Old and New, Londra. 1896. / The Art of W. Crane. Notes hv the Artist, in « The AnJournal The Easter Art Annual », Londra, 1898. / Line and Form, Londra, 1900. / Ideals in Art.Papers ofthe Arts and Crafts Movement. Londra. 1905./ William Morris to James McNeill Whistler.L o n d r a . 1 9 1 1 .
L E W I ^ I i HI / •, • , , / , r U: V1:,.'.' / . , , , T ..» ••'„ M /.•-:, [ m u l r . i . 1882 . ,' Some Principle!
ol /.".,• , i | . . i , -" • ..• i \ -.. . I * I i u.il », L o n d r a . 1900 .
J E A N in i . i i i : I \i . !,• .! • - ' .•• . • H i u x e l l e s , 1895. .• Lagrande
hici-nnh; J, • •;• HIIIMII,- ••'!" /• •• /:, S.",..., l !-uvJ,^. 1S97. Minion de iA't.Bruxelles.. 1900.MAURICE DENIS: Theories. 1890-1910, Parigi. I 9 B (111 ed.).CHRISTOPHER DRESSER: Unity and Variety, Londra, 1859. / Rudiments of Bounty. Londra, 1S59.The Art of Decorative Design. Londra, 1862. / On Decorative Art. in « The Planet ». Londra.1862. / Development of Ornamental Art. Londra, 1862. / Studies in Design, Londra. Parigi. NewYork. 1874-1876. / Principles of Decorative Design. Londra. 1880. / Japan: Its ArchitectureArt. and Art Manufectures. Londra. 1882. / Modern Ornamentation. Londra. 1886. . The Workof Ch. Dresser, in « The Studio », Londra. 1898, XV.OTTO ECKMANS: Der Weltjahrmarkt, Parigi e Berlino, 1900. ••' Vorrede :u meiner Schrili, Offen-bach, 1900. , «Dekorative Entwiirfe ». Berlino, dal 1907,AUtJUST tNDLLL: Um die Schiinheit. Eine Paraphrase die MUnchner Kunstausstellung IK96 Mo-naco. 1896. , Moglichkeiten und Ziele einer neuen Architecktur. in « Deutsche Kunst und De-koration ». Darm«a<1t. IK47-1 «t>K (;,-dimkcn- Formkunst. in « Dekorative Kunst », MonacoI89S. I /•„,>!, -. .v™1.,..; .»..,/ l>, ••„, ,.,••,. A.vmi in « Dekorative Kunst », Monaco. 1898. II.
Loii M , . : '• I1 ,'f(iK (trad, inglese, Londra. 1913).EMI1.1 i. vlJ I VHP 1 n,,.r,,, ,!i, 1 /„/>•.•„., Mann], 1908.EMILEGAUJ-; « L 'Etoi lcde I'Est ». Nancy, circa dal 1895./ Le Salon da Champ de Mars, in « Re-vue de Arts Decoratifs », Parigi, 1891-1892, XII. / Le Decor Symboliste, discours de reception aVAcademic Stanislas. Nancy, 1900. / Exposition de VEcoie de Nancv, a Paris. I serie. Le Mobi-lier, Parigi. 1901. / Ecrin pom- I'An. IHK4-1HH9. Parigi, 1900.
EUGENE G R A S S E T : V Art Nt'itu,. , I I' i . . . Parigi . 1894, VI. / La plante et ses applicationsornementales. Parigi , 1896. / i , . , / ,TW jugee par Eugene Grasset, in « L'Emula-tion », Bruxelles, 1896, XXI / h- \n,,:r, m « Revue des Arts Decoratifs ». Parigi. 1897.XVII. ,' Eugene Grasset. in « La Plume ». Parigi. 1900, XII. / Methode de composition ornemen-tale. Parigi, 1905.HECTOR GUIMARD: Le Castel Be'ranger. Parigi, 1899. / An Architect's Opinion of ' Art \ouveau ".in «The Architectural Record », New York e Londra, 1902, XII.
Testi e pubblica/ioni di proUigonisti
DiwlL-s. IS95; XX.
lurk I'ln: HIr<>i: v \ s \ />•• U<«lt>rne SHI, S l o c c a r d a . 1899-1905. , ; Einfuche Mobel. in " D a s Intc-
« i i v i • '•' • I'lt-Raphaelitism and the pre-Raphaelile brotherhood. Londra. 1905.M I JI >K !!••.( i ( ,/. minims sur far! moderne. Bruselles,. 1925.jnms k-\nrs in vssuss. i rebours, Parigi, 1884VASsni KASUINSKIJ: Cher des Geisiige in der Kunst. Monaco, 1912. Kltmge. Monaco. 1913. .'Riwkblwkt: Berlino. l»13.o\vi-\ m s h I'll,' (tnummu of Ornament. Londra, 1856 The True and ihe False m the Deeo-
i )ss , \n i • i • .• hdumenden Knabert. Vienna. 1908.J M \ i >•! • .i " -n-i-. et le mouvement nouveau de iart detoratif, Ginevra. 1897. : LAri
I iiiiKii ii Lo. Liu.. Handbook of Sketches, Londra, 1890. / Cymric Svher, Londra, 1900.Him.! LOOS: « L'Aliro. Periodico per Tiniroduzione della civilta' occidentale in Austria ». Vien-u.i. 1908. : Ins Leere Gesprochen. 1897-1900, Parigi, 1921, Innsbruck, 1932.MAS LORRAIN: Tres russe, Parigi. 1886. ' Princesses dlvoire et d'ivresse. Parigi, 1902. . Mtm-•icur de Phocas, Parigi, I9H>< IIARLES RENME MACKlNlnsi ' h uo» University.SKIIEUR HEYGATE MACKMI n i nhis Londra, 1883. / Nature in Ornement. in... The Hobby Horse ». Loiidr.; \ I •• ... i of the Arts and Crafts Movement (manoscritto).i. IORU MADIA BROV,N Th, i , i li,rhood Londra e New York, 1907.
•, MMiimni \l nlle Freres & Cie.. Meubles d'Art. catalogo, Nancy.\ n m m / i urnns de iutte pour Van. 1884-1914, Bruxelles. 1926. fun et In <w.'ii Hflnniiif. IN.m-lvilj. Bruxelles, 1929.I M H H K R U - H Das plustische Ornament, in « Pan ». Berlino. 1898, IV. . Entwichlungsgesthichhder modernen Kunst. Sloccarda, 1904-1905WLLLLAM MORRIS « Oxford and Cambridge Magazine >», Oxford, dal 1SK5. . New From Son-hen
Sou Ii'l, -" ' ll' Hil/iam Mornv Londn 1910 19l\KIH i i i Mon mthtHe» \ \ \ 1 II ls»lfc,
hlklu !• • i • . H '• • • ': . .• • Inelanil. Bcrlinn / D i n n s i i d lI9IL //. RiirniMa.li i L J t k u i i t K J J I 1 i a t o 1404 \ l lto ' Ii MM i i i uerpenian T. Nieuwenhuis, Amsterdam. 1911H I M i \olution des Industrie!, d'urt. Parigi, 1896.HtK\i\ ii Dekorative Kunst », Monaco, 1900. V. / DieZukunst MIM'1,.1 I • I >ouir.ilive Kunst », Monaco, 1901, VII. / Luxuskunst odeiVoikskunst. in .. \'i, • k Monaco, 1901-1902. IX. : Neue Moglichkeiten in der bil-denden Kunst. is I i nJOSEPH MARIA mi i mi 1900. . Neue Garten, Berlino, 1905.kOSMA s PETRIH i Pietroburgo, 1930. , Lo spazio di Euclide. Mosca. 1932CAETANO PRFVUI (/c/ Divisionismo, Milano. 1909-1916NiroLAJ RiHSki k. i H ,'itinco di armonia. P i e t r o b u r g o , I8B4. Primipi di suit
ADELAIDE ROBIN!AL Porcelain-,, in « Keramic Studio J>, IX, 1907.JOHN RL'sklN The Works of John Ruskin. Londra. 1903-1912.CHARLES ROHLFS My Adventures in Wood-Carving, in « Arts Journal >>. 1925, 21-22.LOU SALOME A \ D R E \ S \ i, t MIIL in -.11111 \ltikii! 1894 Ibsen Frauengeualien. 1892.IRENE SARGEM T ' in ' i i l i i n Eastwood Nev, York, 1902, [].JOHN SEDDIM 1 \i iLn Londra, 189.1.
RICHARD NORMAS ill ^A , , n L n, Londra. 1878. Archiuriure. 4 Profusion oran Art. Londra, 1892.ciusEPPh S<)MMARU<JA L Arthiteltura di Giuseppe Sommaruga. Milano. 1908.AUC UST STRINDHERG f exposition d Ed\ard Munch, in « La Revue Blanche >>, Parigi, 1896, X.
Testi c pubblicazioni di protagonisti
LOL'IS H. SULLIVAN: Characteristics and Tendencies of American Architecture, in i< Inland Ar-chitect and Builder». 1885. / A System of Architectural Ornament according uith a Philosophtof Man's Poxers, New York, 1924. / The Autobiography of an Idea, New York, 1924. Kinder-garten Chats and Other Writings, New York, 1947.ALGERNON-CHARLES SWINBUBNE: William Blake. A critical Essav. Ltmdra, 1868.LDUIS TIFFANY. The Art Work of Louis Tiffany, Garden City, New York, 1914.LEW TOLSTOI, Che cos'e i'arte, 1897.CHARLES HARRISON TOWNSEND. Originality in Architecture, in "The Builder », Londra. 1902.LXXXII.HENRY VAN DE VELDE: Notes d'art, in « La Vallonie », Bruxelles, 1890, 2-3. / Artistic Wall-Papers.in «L'Art Moderne », Bruxelles, 1893, XIII. / Deblaiement d'art, Bruxelles, 1894. / Essex andCo.'s Westminster Wail-Papers, in « I/Art Moderne », 1894, XIV. / Em Kapitel uber Entwurland Bau Moderner Mabel, in i- Pan », Berlino, 1897, II. / Die Renaissancd in modernen Kunstge-werbe, Berlino. 1901. / Kunstgewerbliche Laienpredigten, Lipsia, 1902. / Gustave Serrurier-Bory.in « Zeitschrift fur Innendekoralion », Darmstadt, 1902, XII. / Von neuen Stil. Lipsia, 1907.Amu, Lipsia, 1909. / Saggi, 1910. / Formule della Bellezza architettonica moderna, 1917. Formuleiti una esfetica moderna, 1923.
EMiLE VERHAEREN: Quelques notes syr I'oeuvre de Fernand Khnopff, I88I-I887. Bruxelles. 1887.JAMES MCNEILL WHISTLER: The gentle Art of Mocking Enemies. Londra, 1880. / The Baronet and:he Butterfly, Londra, 1884. / Mr. Whistler's " Ten O' Clock", Londra, 1885.EUGENE EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC: Entretiens sur /'Architecture, Parigi, 1863-1872.CHARLES A. F. VOYSEY: Domestic Furniture, in « The Journal of the Royal British Institute ofBritish Architects™, Londra, 1894. / Individuality. Londra. 1911.
OTTO WACNER : Moderne Architektur, Vienna, 1895. / Die Kunst der Gegenwan. in « Ver Sacrum -.Vienna, 1900. III. / Aus der Wagnerschule, Vienna, 1900. / Wagner-Schule. Lipsia, 1902. EinieeSti::en. Projekte and Ausgefuhrte Baunerke. Vienna, 1892-1922.i IM Mt \wn>i The Deem- of Lying, in "Complete Works", New York. 1916. An wul /)<•,.-ration. Londra, 1920.i m \ k IKIVII WRIGHT: In the Cause of Architecture, in « Architectural Record », 1908. XXIIIOn Anhucaure. Selected Writings, 1894-1940. New York, 1941.
PERIODICI E RIVISTE DELLEPOCA
AUSTRIA
« Die Graphischen Kiinstler », Vienna, dal 1879. / « Das Interieurs », Vienna, 1900-1915. /« Kunst und Kunsthanderwerk >>, Vienna, 1898-1921. / « Ver Sacrum ». Vienna, 1898; Lipsia,1899-1903.
BELG1O
e Antwerpen, 1892-1901.
GL-RMAN1A
.< Avalan », Monaco, 1901. ; « Dekorative Kunsl », Monaco, 1897-1929. / « Deutsche Kunstund Dekoration », Darmstadt, 1897-1934 / « Fliegende Blatter », Monaco 1844-1928. / « Hy-perion », Monaco. / "Die lnsel », Berlino, 1888-1901 e Lipsia, 1902. / «Jugend», Monaco,1899-1933. / « Die Kunst fur Alle », Monaco, 1885-1899; successivamente « Die Kunst », 1899-1945. / «Die Neue Rundschau ». / « Pan », Berlino, 1895-1900. / « Quickborn », Berlino. /« Simplizissimus». Monaco, 1896-1967. / « Zeitschrift fur Innendekoration », Darmstadt,dal 1890. / "Zeitschrift fiir Biicherfreunde ». / « Kunst und Handwerk », dal 1897.
FRANCIA
•< Artet Decoration", Parigi, dal 1897. / « L-Art Decoratif", Parigi, 1898-1914./ « La Plume ».Parigi, 1889-1913. / « La Revue Blanche". Parigi, 1891-1903. / « Le Courier Francais », Pa-rigi, 1886-1894. / ,. Le Rire ». Parigi. / « L'lmage », Parigi. / « L'Ymager », Parigi. j « Reno-vation Esthetique ». Parigi. 1905-1910. / "Revue des Arts Decoratif;. ». Parigi. 1880-1902.
INGHILTERRA
« Oxford and Cambridge Magazine », Londia. / « The Century Guild Hobby Horse ». Orping-ton. 1884-1886, 1892; success ivamen le « The Hobby Horse », Londra, 1893-1894. / " T h e Dial »,Londra, 1889-1897. / « The Dome », Londra, 1897-1900. / « The Germ », Londra. 1849. / « ThePageant)), Londra. 1896-1897. / « The Savoy)-, Londra, 1896. / « The Studio.), Londra, dal1893. / «The Jellow Book", Londra, 1894-1897.
ITALIA'« Arte italiana decorativa e industrials », Roma e Venezia, 1890-1914. / « Arte utile », dal 1890. /« Edilizia moderna », dal 1895. / « Emporium", Bergamo, dal 1896.'/ «FLegrea», dal 1899. ,« Hermes », Firenze, dal 1904. / « Italia che ride », Bologna, 1900. / « La casa », Roma, dal1908. / « La Lettura », dal 1901. / « L'Ambiente modemo », dal 1910. / « L"Architettura italia-na », dal 1905. / «L"Arte», Roma, 1898-1901. / « L'Arte aristocratica », dal 1902. / « L'Artedecorativa moderna ». Torino, dal 1902. / « L'artista moderno », Torino, dal 1902 « II gio-vane artista moderno »). / « L'Eroica », dal 1911. / « LTillustrazione italiana », dal 1900. /« No-vissima », Milano e Roma, dal 1900. / « Per TArte », dal 1909.
OLANDA
« Arts and Crafts >: • « Bouw en Sicrkunst ». Harlem, 1898-1902. / « En Industrie », dal 1898.
POLONIA
« Chimera". Varsavia. ,, « Czas ». Cracovia. « Nats Kray ». Lemberg.
RUSSIA
« Apollon )). Pietroburgo. / « La Toison d'or », Mosca, dal 1906. / « Mir Iskusstwa », Pietro-burgo, 1899-1904.
SPAGNA
«Joventul». liareellona. 19(10-1903.
STAT1 UNIT!
" Handicraft », Boston, dal 1902. / « House Beautiful ", Chicago, dal 1896. •• " House and Gar-den ", Filadeifia, dal 1901. / « Interiors », New York, dal 1888. / « Keramic Studio .>, Syracuse,dal 1899. / <c Ladies- Home Journal », dal 1901. / « The Architectural Record >>, New York eLondra, dal 1891. / "The Chap-Book », Chicago, 1894-1898. / "The Craftsman », Syracuse1901-1916. / «The Evergreen", Edinburgh, Filadelfia, 1895-1897.
INDICAZIONl DI BIBLIOGRAFIA GENERALE
Per le note di bibliografia generale indichiamo in parlicolare gli apparati bibliografici dei
E. BAIRATI, R. BOSSAOLIA, M. Rosci, « Italia Liberty », Milano, 1973. / o. BOHIGAS, « Architetturamodernista », Barcellona-Torino, 1968. / R. BOSSAGUA, « II Liberty in Italia », Milano. 1968.
«The Russian Experiment in An, 1863-1922 », Londra, 1962. / H. H. HOFSTATTER, «Jugendstil-Druckkunst », Baden-Baden. / G. MASSOBRIO, P. PORTOGHESI, « Album del Liberty », Bari. 1975.H. BUSSEL HITCHCOCK, «L"Architettura dell'Ottocento e del Novecento», Middlesex, 1958.Torino, 1971. / R. SCHMUTZLER. « Art Nouveau », Stoccarda, 1962, Milano, 1966. / p. VERGO.« A n in Vienna, 1898-1918 », Londra, 1975.
E dei cataloghi: « II Simbolismo in Europa », Ro tterdam-BrujLelles- Baden -Baden- Pa rigi.1976; «The Arts and Crafts Movement in America 1876-1916 », Princeton, 1972.
PRINCIPAL! ESPOSIZIONI
1851 - LONDRA. Esposizione Internazionale.1855 - PARIGI. E po zione Intemazionale1867 PARIG1, Esposizione Imernazionale1873 - VIENNA, Esposizione Internazionale.1876 - FILADELFIA, Esposizione del centen nc1878 - PAR1GI. Esposizione Internazionale.1889 - PARIGI, Esposizione Imernazionale.1891 BRUXELLES, Esposizione del gruppo « Les Vingts ».1892 - PARIGI, Primo Salon dei « Ro acroce189.1 - BRUXELLES, Esposizione del gruppo « Les Vingis ». / CHICAGO. World's Columbian
Esposition. / MONACO, Secessione. / PARIGI, Secondo Salon dei « Rosacroce ».1894 BRUXELLES, Esposizione de «La Libre Esthetique ». / LIONE, Fiera Internazionale. /
MADRID, Esposizione Imernazionale. / PARIGI. Terzo Salon dei « Rosacroce •>. / SANFRANCISCO, Esposizione lniernazionale.
1895 - BRUXELLES, Esposizione de « La Libre Esthetique ».1896 - MONACO, Secessione. / GLASGOW, Esposizione Internazionale.1897 BOSTON, Prima Grande Esposizione di « Arts and Crafts ». / BRUXELLES, Esposizione de
« La Libre Esthetique ». / PARIGI, Sesto Salon dei « Rosacroce ».1898 BARCELLONA, IV Esposizione di Belle Arti e Industrie Artisiiche. / BRUXELLES, Espo-
sizione de « La Libre Esthetique ». / MONACO, Secessione, Mostra internazionale d'Arte, ,VIENNA, Secessione.
1899 - VENEZIA, 111 Esposizione Internazionale d'Arte.1900 - PARIGI, Esposizione Internazionale.1901 - BUFFALO, Esposizione Panamericana. / VENEZIA, Esposizione Internationale d"Arte. /
VIENNA, XII Mostra della Secessione Viennese.1902 - TORINO, Esposizione Internazionale d'Arte decorativa. / VIENNA, Secessione Viennese.1903 - MONACO, Secessione. / PIETROBURGO, V Esposizione della rivista « Mir Iskusstva ».
VENEZIA, V Esposizione Internazionale d'Arte.1904 - BRUXELLES, Esposizione di « La Libre Esthetique)). / SAINT-LOUIS. Esposizione Uni-
versale. / Mostra-vendita Internazionale della Luisiana. / VIENNA, XIX Esposizione del « Ve-reiningung Bildender Kiinstler ».
1909 - BERL1NO, Secessione. / MOSCA, Esposizione di pittura della rivista « La Toison d'or ». .VENEZIA. VII Esposizione Internazionale d'Arte.
1910 - BRUXELLES, Esposizione Universal e Internazionale.1911 - LONDRA, Esposizione dei Preraffaelliti. / TORINO. Esposizione Internazionale.1913 NEW YORK, « Armory Show ».1915 - SAN FRANCISCO Esposizione Internazionale Panama-Padfico.1926 - VENEZIA. XV Biennale Internazionale d'Arte.
1928-29 - PRAGA, Esposizione del gruppo « Manes ».1930 - BRUXELLES, Esposizione centennale d'arte belga.1933 - NEW YORK, « Objects 1900 and today ».1934 - PRAGA, Esposizione del gruppo « Manes »: mostra internazionale della eancaiura.1936 - PARIGI, Cinquantenario del Simbolismo.1937 - CREMONA, Prima Fiera Nazionale dell'800. / PARIGI, « Les Maiires de I'Arl Independam ».1947 - BIRMINGHAM, Mostra della « Confraternita dei Preraffaelliti".1948 - PORT-SUNLIGHT. Esposizione dei Preraffaelliti.1950 - VENEZIA, XXV Biennale d'Arte, padiglione belga.1951 - BOURNEMOUTH, Esposizione di pittura a grafica dei Preraffaelliti. ,' PARIGI, « Un secolo
d'Arte francese, 1859-1950 ».1952 - LONDRA, « Victorian and Edwardian Decorative Arts ». / ZURIGO, « Urn 1900, Art Nouveau
und Jugendstil )>,1954 - STOCCOLMA, « Jugend ». / VENEZIA. XXVll Biennale d'Ane.1955 - FRANCOFORTE, « Jugendstil ».1956 - VENEZIA, XXVIII Biennale d'Arte.1957 - BRUXELLES, « Le Mouvement Symboliste ».1958 - BADEN-BADEN, « Aus der Zeit urn 1900 ». / MONACO. « Aufbruch zur modernen Kunst ». /
NEW YORK, « Art Nouveau. An and Design at the turn of the Century ».1959 HEIDELBERG, « Jugendstil ». / NEW YORK, « Art Nouveau-.1960 NEW YORK, ..Art Nouveau ».
1960-61 PARIGI, « Les sources du XXeme Siecle ». / L'AJA, « Nieuwe Kunst Rond 1900 ».1962 - BRUXELLES; OTTERLO, nLegroupedes XX et son temps »./ NEW YORK. I Preraffaelliti.1964 - DARMSTADT / ESSEN, « Jugendstil » (coll. Citroen). / LAREN, n Schilder Kunst uit " L a
Belle Epoque "». / MONACO, Mostra della Secessione e del 900. / STOCCOLMA, Jugend inSvezia. / VIENNA, v Vienna nel 1900 ».
1965 - DARMSTADT, « Jugendstil ». / LONDRA, « Aulour de 1900: Lar t beige (1884-1918) ».l%6 - BERLINO, « Opere del 900 ». / BRUXELLES, Esposizione retrospettiva del gruppo dei « XX »
e de « La Libre Esthetique ».
Principali Esposizioni
DER KUNSTLER
KOLONIE IN
DARMSTADT
GEWIDMET
1966-67 HLBOKA / BRNO, « Secessione cecoslovacca » (« An Nouveau cecc. >>).1967 - BRUXELLES, « Europa 1900 ». / DARMSTADT. « Art in Vienna 1900... , VIENNA « Die
Wiener Werkstatte ».1968 - OSTENDA, « Europa 1900 ».1969 - MADRID, « \\ Modernismo in Spagna ». / TORONTO • TORINO, « II Sacro e il Profano nel-
1'Arte simbohsta ... I VIENNA, « Jugendstil ».1970 - HARVARD UNIVERSITY, « The Turn of the Century, 1885-1910 ».1971 - COLONIA, Pittura tedesca del XIX secolo. / LONDRA, « Vienna Secession », Royal Aca-
demy of Art. / PAR1GI. « Pionieri del XX secolo: Guimard, Horta, Van de Velde ». / STOC-COLMA, «Finlandia 1900». / RICHMOND, « Art nouveau ».
1972 - BELGRADO, Mostra di Architettura jugoslava 1900-1970. / BERLINO, Arte del novecemoin Germania. / DARMSTADT, « Jugendstil ». / PRINCETON UNIVERSITY / CHICAGORENWICK. «The Arts and Crafts Movement in America, 1876-1916... / ROMA. « Bruxelles1900»
1972-73 - M1LANO. Mostra del Liberty Italiano.1973 - TAMPEREEN. « Tampereen Jugend ...1974 - FRANCOFORTE SUL MENO, « Preraffaelliti... / MARBACH, « Jugend in Vienna ... PA-
LERMO, Convegno ed Esposizione « Liberty a Palermo ...1975 - VARSAV1A, Mostra di Arte polacca del XIX e XX secolo.1976 - BRUXELLES ,' PAR1GI, « Le Symbolisme en Europe ». / VENEZIA. Biennale Inlernazionale
d'Artc. • DARMSTADT, Mostra del Centenario tlella eolonia ili Arli-ti Ji Danmladi.
FONTI ICONOGRAFICHE E DOCUMENTARIE
Archivi di fotografic e documenti dell" A more, dell1 Ed i tore, di Massimo Becattini, LuigiCarluccio, Carlo Cresti, Enzo Crestini, Liliana Mariano, Guido Perocco, Alessandro Vezzosi,dell'agenzia VAAP e di alcune delle raccolle citate neH'elenco delle collezioni:la documentazione raccolta per il numero monografico « An Nouveau » della rivista <* Schema »,Bologna, 1972, n. 8-9;le riviste dell'epoca (in particolare >< The Studio »), per le quali si rimanda all'eleneo indusc-nella bibliografia (pag. 000);le pubblicazioni del protagonist! del movimento. elencale speciftcatamente nella bibliografia(pagg. 000-000);i cataloghi delle esposizioni citate nella relaiiva cronologia (pagg. 000-000).
Inoltre le seguenti pubblicazioni: AA. VV., « IZ Starog 1 Novog Zagreba» II, Zagabna.I960. / F. ALISON, « Le sedie di Charles Rennie Mackintosh », Lissone 1973. / M. AMAJA. « AnNouveau », Londra-New York, 1966. / E. ASUIN, « The Aesthetic Movement. Prelude to ArtNouveau », Londra, 1969. / AUDSLY, « Designs and Patterns from historic Ornament », NewYork, 1968. / E. BAIRATL R. BOSSAGLIA. M. ROSCI, « Italia Liberty », Milano, 1973. / R. BARILLI,« I Preraffaelliti », Milano, 1967; -ill Simbolismo », Milano, 1967; « II Liberty », Milano,1966. / O. BAZIN, « L'Evoluzione dell'Arte », Londra-Milano, 1962. / J. BLOCH-DERMANT, « L'Artdu verre en France, 1860-1914 .., Friburgo, 1974. / o. BOHIGAS, « Architetlura modernista ..,Barcellona, 1968, Torino, 1969. / F. BORSI, P. PORTOGHESI, « Horta », Roma, 1969. / R. BOSSAGLIA,« II Mobile Liberty », Novara, 1967; « II Liberty)., Firenze, 1974. / R. BOSSAGLIA, A. HAM-MACHER, « Mazzucotelli », Milano, Tubingen, 1971. / M. BUCCI, R. BENCINI, « I Palazzi di Fi-renze », Firenze, 1971. / o. CAMERANA, « Linea F1AT», Torino, 1966. / ). CASSOU, E. LANGUI,N. PEVSNER, «Le Origini dell'Arte Moderna », Parigi, Milano, 1962. / A. CIRICI PELLICER. J.GOHIS, « Barcellona 1900 », Barcellona, 1967. / i. CREMONA, « II tempo dell'Art Nouveau »,Firenze, 1964. / c. CRESTI, Liberty a Firenze. in « Antichita viva », n. 5, Firenze, 1970; Villa Rug-geri a Pesaro, (Rilievi di Gugnali-Paganelli-Vannini), in « Bolieltino degli Ingegneri », n. 11.Firenze, 1970; Un edificio Liberty a Firenze. in « Bollettino degli Ingegneri », n. 11, Firenze.1972. / A. DEL GUERCIO, « Le avanguardie russe e sovietiche », Milano, 1970. / C. DE MAEYER.« Paul Hankar », Bruxelles, 1963. / F. H. FRATINI, « Torino 1902, Polemiche in Italia per 1'artenuovai., Torino, 1970. / c. GRAY, « The Russian Experiment in Art, 1863-1922 >., Londra,1962. / M. HOWELLS, « Lost examples of Colonial Architecture », New York, 1931. / w. HOFMAKN.u. KULTERMAN, « Architettura moderna », Essen, Novara, 1969. / H. H. HOFSTATTER, « JugendstilDrukkunst », Baden-Baden, 1869. / G. HUGUES, « Modem Jewerly », Londra, 1963. / p. JULLIAN.« Dreamers of Decadence >., Londra, 1971; « The Symbolists », Londra, 1973; « The Trionphof Art Nouveau - Paris Exhibition 1900 », Londra, 1974. / KOCK, « Louis C. Tiffany, Glass-Bronzes-Lamps », New York, 1961. / M. LUZI, « L'Idea Simbolista », Milano, 1960. / R . MACLEOD,«C. R. Mackintosh ». Middlesex, 1968. / MANFREDI-NICOLETTI, « D'Aronco >>, Milano, 1955.M. MANIERI-ELIA, « William Morris e I'ideologia deH'architeltura moderna », Bari, 1976. / MA~RILLIER, « The early Works of Audrey Beardsley .>, New York, 1899, 1967. / G. MASSOBRIO. P.PORTOGHES1, « Album del Liberty », Bari, 1975. / MONTGOMERY, « America's Arts and Skills »,New York, 1957. / i. MUCHA, M. HENDERSON, A. SCHARF, « Mucha ... Londra, 1961. / NLCOLL,«The Pre-raphaelites », Suffolch, 1970. / N. PAGLIARA, « Appunti su Otto Wagner », Napoli,1968. / v. PICA, v L'Arte decorativa all'Esposizione di Torino del 1902 », Bergamo, 1903. / v.PONENTE, « U Strutture del Mondo moderno, 1850-1900 », Ginevra, Milano, 1965. / B. REAOE,« Aubrey Beardsley », New York, 1967. / M. RHEIMS, « L'Art 1900 », Parigi, 1965; « L'Objei1900 o, Parigi, 1964. / A. RIEGL, « Stilfragen », Berlino, 1893. / H. RUSSELL-HITCHCOCK, « L'Ar-
« Art Nouveau >., Stoccarda, 1962, Milano. 1966. / v. SCULLV,' « Frank Lloy Wright », NewYork, Milano, 1960. / H. TEIRLINCK, « Henry van de Velde .., Bruxelles, 1959. / s. TSCHUDI-MADSEN,
1975. / O. VERONESL «Joseph Hoffmann.>, Milano, 1956. / H. VEVER, « La Bijouterie francaiseau XIX siede», Parigi, 1906. / H. VOSS, « Franz Von Stuck", Monaco, 1973. / T. WALTERS,«Art Nouveau Graphics.., Londra-New York, 1971.
Articoli e numeri monografici delle riviste: « VArchitettura », Roma; « Casabella », Milano;« Edilizia Moderna », Milano; « Apollo ... New York, n. 142, dicembre 1973; .< France Album »,(Album de Imposition 1900), n. 61-62, Parigi, 1900..
Le esposizioni monografiche (con i relativi cataloghi):«Van de Velde », Zurigo, Kunstgewerbemuseum, 1958 / "Morns and Company, 1861-
1940 ... Londra, The An Council, 1961. /« Gustav Klimt », Graz, Neuegalerie am LandesmuseumJoanneum, 1962. / « Antonio Sant'Elia », Como, 1962. / « Art Nouveau Samplers, The Uni-versity of Michigan, 1962-63. / « Henry van de Velde », Bruxelles, 1963. / « Un Maitre de L'ArtNouveau: Alphonse Mucha », Parigi, 1966. / « Mucha », Milano-Roma, Galleria del Levante.1966. / « Johan Thorn Prikker », Krefeld, Kaiser Willhelm Museum. 1966. / « Leon Bakst...Milano-Roma-Monaco, Galleria del Levante, 1967. / n Alberto Martini », Oderzo, 1967. ,« La grafica boema nel periodo dell'Art Nouveau », Roma, Calcografia Nazionale. 1968. /« Kolo Moser... Graz, Neuegalerie am Landesmuseum Joanneum; 1969. / « Hector Guimard »,New York, The Museum of Modern Art, 1970. / « Charles A. Voysey », Santa Barbara, Cali-
Fonti iconografiche e documentarie
fornia University, 1970. / « Henry van de Velde », Bruxelles, 1970. / « Symbolismus in Belgien »,M ilano-Monaco-New York, Galleria del Levante, 1970-71. / « Tiffany », Tallahasse, UniversityArt Gallery, 1972. / « Architettura Liberty a Milano », Milano, 1972. / « Galileo Ctiini », Sal-somaggiore. 1974. / « Duilio Cambellotti », Roma, Emporio Floreale, 1975. / «Tiffany B,Sarasota. Florida. 1975.
COLLOCAZIONE DELLE OPERE RIPRODOTTE
ABRAMSTSEVO, Museo di: 739.*LM. Musee Toulouse-Lautrec: 210.AMBLRGO. Gewerbemuseum: 484.AMSTERDAM, coll. Citroen: 779. / Stedelijk Museum: 454.\NVERSA. Musee Royal des Beaux Arts: 351.AREZZO. San Domenico: 19.BARCELLONA, Los Amigos de Gaudi: 386.BASILEA. Kunsimuseum: 616, 625, 628, 63L, 632.BELGBADO. Museo Nazionale: 699.BERUNO: Slaatliche Museen Gemaldegalerie, 20. / Kunstgewerbe museum dcrSiaailichen. 781. , National Galerie: 529. / Staatliche Museen PreussischcrKuliurbesitz 630I B N * . coll. A. C. Strasser-Berlage: 445. / Kunstmuseum: 941. 621. 623.BOSTON. Museum of Fine Arts: 23.BRESCIA. Museo Civico: 943.BRFNGHTON. coll. privala: 123.BRLXELLES. Bibliotheque Royale Albert ler: 342. / Coll. Delville: 354. , Coll.J Hankar: 298, 300. / Coll. B. Thibaud de Maisieres: 345, 346. ,' Musees Royauxd'Ait et d'Histoire: 195, 263, 348, 349. / Palazzo Stoclet; 606.M.-FTALO. Albright-Knox Art Gallery; 1010.CAMBRIDGE. Fitzwilliam Museum, 60.CANDLA. Museo Archeologico: 22.CARMIGNANO. Pieve di San Michele: 25.
CHARLOTTENBURG (Berlino), Kunstbibliothek der Ehenials Siaailichen Mu-seum: 507.CWCAGO. coll. Marilyn and Wilberi R. Hesbrouck: 856. ,' Coll Mr. and Mrs.Sidney Lewis: 872. / School of Architecture Foundation: 794, 795. , The AnlaMHute 815 817-819 / University Collection: 820.CINCINNATI. Art Museum: 826.cirvELAND. Museum of Art: 197, 857.COMO, Museo di villa Olmo: 978.CRACOVIA. Muzeum Narodowe: 683.
DETROIT, Institute of Art: 1005.DRESDA, Staathche Kunstsammlungeti: 53, 633.HATTORD (Connecticut), Wadsworth Atheneum: 59.HER-^KLION (Creta), Museo Archeologico: 21.RRENZE. coll. Cesaroni-Venanzi: 1019. / Coll. Crestini: 952. / Coll. Gherardini:954. Lunardi-Gherardini: 929, 971, 972. / Coll. privata: 247. / Uffizi: 26.ntAxeoFOR-rE, Goethemuseum: 56. / Helmut Goedeckemeyer: 198.GLASGOW. University Collection: 84, 401, 404, 406, 412. 417, 418, 420, 421,428. 431, 433-436GRA2. coll. dr. Fritz Bock: 607.OELLES. Musee des Beaux Arts: 266.RRHTLD. Kaiser Wilhelm Museum: 463.LAJA. Gemeentemuseum: 451, 455, 458, 1000. / Museo di Arti Decorative: 453.LEMNGRADO. Museo Russo di Stato: 755, 760.LFTCHWORTH, coll. Miss Jean Stuart: 182.UNZ. Neue Galerie, Wolfang Gurlilt Museum: 613.L1I-5IA. Museum der Bildender Kiinste: 629.USBOSA. coll. Gulbenkian: [ frontespizio, 194, 250, 257, 259. 261.LTTLANIA. Kaunas Museum: 777.U\WPOOL. Walker Art Gallery: 63.UVORSO. Museo Fattori; 918.LON-DRA. coll. Grosvenon: 708. 995. / Coll. Malrlborough: 1007. / Coll. privata:I3Z National Gallery: 27. / The British Museum: 46, 50, 66, 133, 158, 175. /The Royal Institute of Painters in Watercolour: 188, 190. / The Tate Gallery:48 49 58 62 67 69 789 1002 / Victoria and Albert Museum: 13, 43, 80, 137,144. 172. 173. . William Morris Gallery: 146, 151.MADRID. Museo Nacional de Arte Moderna: 203.MANCHESTER, palazzo Municipale: 57.MESTRE, coll. Aristide Coin: 959.
MLLANO, coll. P. Accetti: 978. / Civica Raccolw Bertarelli: 956. / Coll. Marti-ni: 960. / Coll. Panza di Biumo: 999. / Coil. Pellini: 922. / Coll. privata: 958.1011, 1015./Coll. Ricordi: 965./Coll. Scheiwiller: 935. / Galleria Civica d'ArteModerna: 979. / Galleria del Levante: 757, 758.MONACO, Bayerische Staatsgemaldesammlungen: 350, 528, 596. / StaatlicheGraphische Sammlung: 523-525. / Miinchner Museum: 485. / StaadtischeGalerie: 201, 493. / Staadt muse urn: 96, 131, 476, 497.MOSCA, Museo Gorkij: 785, 786. / Tretjakovskaja Galeria: 761, 766. / Museodi Belle Arli Pouchkine: 756.NANCY, Musee dc 1'Ecole de Nancy: 240-245, 248, 249.NEW CANAAN (Connecticut), coll. A. Ault: 1008.NEW YORK, coll. Charell; 116. / Coll. Rothscild: 746. / Guggenheim Museum:996. /Museum of Modern Art: 214, 869, 994, 1018./The Metropolitan Museumof Art: 1, 38, 798, 800, 801, 804, SOS. / Willard Gallery; 1001.NEZZA, Musee Cheret: 239.OSLO, Kommunes Kunstsamlingen Munch Museet: 516-518, 522. / Coll. SonjaHenie, Niels, Onstad: 1016. / Nasjonal-Galleriet: 521.OTTERLO, Rijksmuseum Kr61ler-M tiller: 442, 461, 462, 467-469, 471, 472.OXFORD. The Ashmolean Museum: 70. 72.PALERMO, Hotel Villa Igea: 912.
PARIGI. Bibliotheque des Arts Decora tifs; 115. / Bibliotheque Nation ale: 724. /Coll. " Documents ": 122. / Coll. privata: 204. / Coll. privata: 206, 352. UBateau Lavoir: 37. / Musee des Arts Decoratifs: 98, 121, 124, 205, 229, 256,262, 763, 858. / Musee du Louvre: 727. / Musee Moreau: 200. / Musee Na-tional d'Art Moderne: 199, 963, 982.PARMA, coll. Ranza: 966.PENNSYLVANIA, coll. H. Gates Lloyd: 997.PERPEGNAN, Musee Hyacinthe Rigaud: 207.
PIACENZA, Galleria d'Arte Moderna: 942. / Galleria Ricci-Oddi: 950.PLYMOUTH, City Art Gallery: 65.PORT SUNLIGHT, Lady Lever Art Gallery: 105.PRAGA, Narodni Galerie: 602, 722, 725.PRATO, Galleria Falsetti: 923.RATZEBURG, coll. Barlach: 533.
ROMA, coll. Paul E. Geier: 617. / Museo Barracco di scultura antica: 975. .'Stanze Vaticane: 17.SCHWEINFURT, coll. privata: 109. / Coll. Georg Schaffer: 527.SHEFFIELD, James Dixon and Sons: 147.SOLEURE, coll. privata: 601.STOCCARDA, Landesgewermeamt; 35. / Slaalsgalerie: 61.STOCCOLMA, Moderna Museet: 34.SVITEBSK, Museo Ciurlionis: 776.TALASHKINO: 740, 745, 750, 753, 754,
TORINO, coll. Forti: 949. / coll. Martano: 962 ' Galleria civica d'Arte moderna:947.TRIESTE, Museo Revoltella: 938.VARSAVIA, Muzeum Narodowe: 684, 690.
VENEZIA, coll. privata: 964. / Galleria d'Arte Moderna: 598.VIENNA, Albertina: 28, 54, 118, 535. / Banca Nazionale austriaca: 582. / Coll.privata: 40. / Coll. Rudolf Leopold: 610, 611, / Direzione austriaca Poste eTelegrafi: 578-581, 583, 584. / Kunsthistorisches Museum: 526. / Osterreichi-sches Museum fur Angewande Kunst: 258. 413, 572. 585, 597, 600, 603-605.615, 1013.WALTHAMSTOW. William Morris Gallery: 15.WASHINGTON, Smithsonian Institution Free Gallery: 79. 81, 85, 87, 855. .' TheNational Gallery of Art: 859.ZURTGO, Kunstgewerbemuseum; 33, 183, 322. 492. / Kunsthaus: 196, 622,939, 940.Collezioni: Grant, 714. / J. Mucha: 671, 709. 712. 715.
Nel ringraziare, ci scusiamo per eventual! erroii I'd omissioni.
INDICE DEI NOMI
BEETHOVEN, L. - p. 389.
BEHBENS, P. - pp. 188, 189, 191, 397; ill. 498-500(p. 188). 502-507 (pp. 189-1901, 509-512 /pp. 190.191. 193): sch. p. 370.BELASSI, K. - p. 396.
BELLOTTO, U. - p. 346.BELTRAMI, G. - p. 334.
BELTRAMI, officine - p. 346.BELV, A- - p. 372.
BENOIS, A. - pp. 276, 368, 377; ill. 765 Ip. 280).p. 170: sch. p. 370.BENVENUTI, B. - p. 346; ill. 918 (p. 131).BEOHME, I. - p. 371.
BERO, A. - sch- p. 370.BERLAGE, H. P. - p. 167; ill. 441-450 (pp. 167-169):sch. p. 370/71.BERLFOZ, H. - pp. 392, 402, 405.BERNARD, E. - pp. 83, 203.BERNHARDT, s. - pp. 100, 263, 267, 396; ill. p. 370sch. p. 370.BESNARD, A. - p. 384.BETTA, P. - p. 322.BILIBIN, i. - ///. 782 ip. 283).
BILL. M. - ill. 1006 (p. 361).BLNG. S. - pp- 13, 14, 85, 93, 120, 382, 392, 409.msTOLFl, L. - pp. 327, 337; ill. 944 (p. 340). 946.
947 (p. 341). ill. p. 371: sch. p. 371.
BLAKE, w. - pp. 16, 25, 29, 32, 58, 69, 369, 412;ill. 18 (p. 16), 46 (p. 25). 48-52 (pp. 26. 27), 133(p. 59). p. 371: sch. p. 371.BLANCHE, ). E. - ill. p. 400.
BLEROT, E. - p. 117; ///. 310, 311 (p. 319).BLOK, A. - ill. p. 371; sch. p. 371/72.BLOMSTEDT, V. - p. 244.BO, c. - p. 386.aocciONi, u. - pp. 201, 333, 345, 399, 403, 406;;//. 958 (p. 145). 979 (p. 354); 994 (p. 358).BOCKLlN, A. - pp. 16, 201, 203. 235, 237, 387, 406;ill. 628-611 (pp. 237-240). ill. p. 372; sch. p. 372.BOITO, c. - pp. 320, 405.BOLDINI, a, - ill. 961 (p. 347).BONNARD, p. - pp. 377, 408.
BONNET, L. - p. 91.BOBEL, H. - P. 407.
sch. p. 372.BORODIN, A. P. - pp. 277, 396. 401.BORROMINI, F. - pp. 19, 20, 138; ill. 28 (p. 20).BOBSI, F. - pp. 110, 365.
BORTOLOTTO, M. - pp. 47, 365.BOSCH, ). - p. 393.BOSSAGL1A, R. - pp. 321, 365.BOSIA, A. - p. 337.BOSSI, G. B. - p. 325; ill. 902 (p. 326).
BOTTICELLI, s. - pp. 16, 32, 63, 372.BOULLEE, E. L. - p. 20; ill. 31 (p. 20).
BRACQUEMOND, F. - pp. 46, 388, 411.BRADLEY, w. - pp. 50, 93, 287; ill. 107 (p. 49). 119(p. 54). 126 Ip. 55). 796-798 (pp. 289, 290), 800,801 (p. 290). 804. 805 (p. 291), 843, 844 (p. 304).846 (p. 306), 848. 849 (p. 306); ill. p. 415; sch.
AAMS, E. - p. 230.
ACHILL1, M. - ill. 7. (p. 12).
ADAMS, R. - p. 147.
ADLER. a. - pp. 306, 404. 406, 412.
ADORNO. T. w. - pp. 15. 365, 410.
AEMILIA ARS - p. 346; ill. 967 (p. 348).
AHLERS-HESTERMANN, F. - pp. 50, 148, 365.ALAGNA. V. - p. 328.
ALA1N-FOURN1ER, M. - p. 16; SCh. p. 367.
ALISON.' F. - p p . 158, 365.
ALLOATI, o. B. - p. 323; ill. 897 (p. 124).
ALVIANI, O. - p. 22.
AMAN-IEAN, E. - p. 85; ill. 205 (p. 86), scl) p 367
ADREAS, C. F. - p. 403.
ANDRE, P. E. - p. 333.
ANQUETIN, L. - p. 83.
ANTONOVIC, M. - p. 257; ill. 693 (p. 257).
APOLLONIO, M - p 22
APPIA, A. - pp. 16, 77; sch. p. 367.
ARATA, O. V. - p. 327.
ARGAN, G. C. - pp. 190, 194. 365.
ARM6, E. - p. 328.
ARNOT, A. P. - p. 396.
ASHBEE, c. R. - pp. 36, 40, 63, 79. 106, 151, 293;
ill. 182-184 (p. 79). sch. p. 367.AUBERT, 1. - p. 93.AZRUEL, v. - p. 257, ill. 692 (p. 257).
BAHR, H. - p. 404.
BAJLLIE SCOTT, M. H. - pp. 80, 372; / / / . 191-193
(p. 81); seh. p. 368BAKER, ]. - p. 220; ill. 592 (p. 221).BAKST, L. - pp. 276, 377, ill. 757-759 (p. 278). 762.763 (p. 279). pp. 368, 369, 406; sch. p. 367/8.BALAK1REV, M. A. - p. 396.
BALAT, A. - p p . 110, 384.
BALOESSAR[, L. - ill. 99!, 998 (p. 357).BALDIZZ], P. - P . 327 .
BALLA. G. p. 399.
BAL'MONT, K. - 5ch. p. 3 6 8 .
BANKAM, R. - p. 11.
BARBIER, H. A. - p. 370 .
BARENTZEN, T. - ill. 640 (p. 242).
BARILLI, R. - pp . 176, 365.
BARLACH, E. - p. 201; ill. 532. 533 (p. 201).BARTHES, R. - p. 49.
BASILE, E. - pp. 325, 32S, 346; / / / . 900 (p. 325), 908,
910 (p. 328), 911. 912 (p. 329); sch. p. 368/9.BAUDELAIRE, c. - pp. 16, 37, 95, 376, 380, 384, 385,401, 411; sch. p. 369.BAUER, L. - ill. 547 (p- 207).
BAUMANN, F. - p. 406.
BAYARD, J. E. - p, 9.
B. B. P. R. (Banfi, Belgioioso, Peressutti, Rogers) -ill. 992 (p. 359).BF.ARD5LEY, A. - pp. 16, 37, 39, 42, 49, 63, 67-69,71, 73, 75, 77, 93, 106, 135, 149, 227, 371, 387,395, 397, 402, 411; ill. 68 (p. 33), 82 (p. 37), 86(p. 39). 91 (p. 41), 100 (p. 46), 103 (p. 47), 108(p. 49). 110 (p. 51), IS9 (p. 62), 152-171 (pp. 67-76,), 174 (p- 77). p. 369. p. 418; sch, p. 369.BEEHHOHM, M. - ill- 789 (p. 287). p. 395-
p. 372.
BRAHMS, I. - p. 370.
BRANCUSI, c. - ill. 1008 Ip. 361).BREGA, G. - p. 333; ill. 931-933 Ip. 336).BREGANTE, G. - p. 3 2 5 .
BREMMER, H- P. - p. 4 0 7 .
BREUER, M. - p. 155.BRIGGLE, A. V. - ill. 822 (p. 297).
BRIGIDIN1, D. - ,11. 7 (p. 12).
BRJUSOV, v. - p. 37] , sch. p. 372.
BROGG1, L. - p. 325.
BRTOZOWSKI, S. A. - HI. 384 (p. 2S4).
BRUCKNER, A. - p. 411 .
BRUEGEL, P. - p. 393.
BUFFA, G. - ill. 925 (p. 334).
BUKOVSKJ. J. - ill. 687 (p. 255).BULL, H. - p. 243.
BURLIUK, D. - ill. 995 (p. 358).BURNE-JONES, E. - pp. 32, 34, 49, 63, 128. 129, 369375, 388, 395, 402, 405; ///. 61 (p. 30). 69. 70 (p. 33:.74 (p. 34), ill. pp. 372. 395; sch. p. 372.BURNHAM, D. H. - ill. 830 (p. 300). 404.BURTON, D. - HI. 44 (p. 25).BUSON], F. - p. 411.BUSQUET, J. - pp. 146, 147; / / / . 398 (p. 147).
CABANEL, A. - p. 392.
CADAFALCK, I. P. - p. 141.CALAMANDRE[, F. - p. 400.CALDEROM, dilta - p. 346.
CALLIMACO - ill. 975 (p. 353).CALLOT, I. - p. 393.
CAMPANA, D. - pp. 319, 381; sch. p. 373.
CAMPAN.N,, A. - p. 325.
CANELLA, O. - p. 10; (//. 7 (p. 12).
CAPO, M. - p. 327.
CAPPELLO, C. - ill. 1004 (p. 360).
CAPP1ELLO, L. - p. 349.CARBONE, D. - p. 320.
CARCHET, C. A. L. - p. 172.
CARRIERS, E. - ill. p. 409.
CASORATI, F. - pp. 128, 345, ill. 949 Ip. 3411. sch
p. 373/74.
CASTIGUON!, E.' - (//. 993 Ip. 359).
CATULLO - pp. 42. 72, 73.
CAUGH1E, P. - p. 117. ill. 306 Ip. 118).
CEZANNE, P. - pp . 106, 107.
CHABRIER, E. - p. 400.
CHAGALL, M. - p. 393.
CHARPENTLER, A. - pp. 93, 97. ill. 229 Ip. 93). 239
(p. 97).CHASSERIAU, T. - p. 394.
CKAUCER, G. - p. 396; ill. 74 (p. 34).
CHEDANNE, O. - p. 90. ill. 221 (p. 90).
CH'EN YDNG - ill. 23 (p. 17).CHERET. ). - pp. 50, 107, 376, ill. 115 (p. 53,.CHINI, G. - pp. 324, 328, 333, 342, 346, ill. 913(p. 330). 930 (p. 335). 953 (p. 343), 970 I p. 350,;ill. p. 374. sch. p. 374.
CIURLIONK, K. N. - p. 283, ill. 776, 777 Ip. 282,CLARK, s. - ill. 845 (p. 305).
Indice dei nomi
FOGAZZARO, A. - p. 319.FONTAJNAS, A. - p. 9.
FONTANA, L. - HI. 1014 e 1015 Ip. 363).
FORK - ili. 677 fp. 252).
FOUQUET - p. 265.Fox - ili. 45 (p. 25).FRANTZ, H. - p. 380.FREUD S. - pp. 16, 378.FRIEDRICH, C. D. - p. 27; (//. 53 (p. 28).FUCHS, E. - HI. 1012 (p. 362).FULLEB, L. - pp. 16. 50, 84; iti. 111-126 (pp. 52-55); sch. p. 379.FUNI, A. - p. 403.FURNESS, F. - p. 300.FUSSLI, l. H. - p. 27; i/1. 54 e 56 (p. 28).GARETTI, R. - p. 11.CAB.», N. - ,7/. 1002 (p. 360).GAILLARD, E. - p. 93.
GALLE E. - pp 93. 95, 97 100 375- ili. 231-238(pp. 94-96). 243 Ip. 97). 245 fp. 98); sch. 379/380.GÀLLEN-KALLELA, A. - pp. 245, 246. 405; ìli. 664(p. 24S). p. 380; sch. p. 380.GARNlER, T. - p. 90; ili. 219 (p. 90).
GAUDI, A. - pp. 20, 42, 55, 60, 135, 137, 138, 146,147, 196, 353; ili. 32 (p. 20), 94 e 95 (p. 42). 128(p. 56). 130 Ip. 57), 356 (p. 134), 358-383 fp. 135-143), 392-394 (p. 146), 519 (p. 994). p. 380; sch.p. 380.GAUGUIN, P- - pp. 37, 83, 84, 106, 379, 392. 407;ili. 195 (p. 83). p. 392.GEORGE-PETIT (galleria) - p. 389.CERACI, G. - p. 328.GEROME, 1. L. - pp. 392, 401.CESELLIUS. H. - p. 245; ili 658 (p. 2481. 660-662(p. 248).GHERMAND], Q. - HI. 1009 (p. 361).GHERARDINI, R. - p. 383.GIACOMI, L. - p. 319; ili. p. 381; sch. p. 381.GIACOSA, G. - p. 319; sch. 381.GLDE, A. - pp. 16, 38, 376; sch. p. 381/382.GILBERT, A. - pp. 58, 81 ; ili. 134 (p. 59), 188 e 189(p. 80). 190 (p. 81).G1LCHRIST, A. -- p. 3 7 1 .G1NZBURG N - p 400CIOL1TT1. E. - p. 376 .
G1ORG1ONE - p. 4 0 5 .
CIOTTO - P. 402.GIOVANNI DI PAOLO - ìli. 20 (p. 17).
GIOIA, E. - p. 318; ili. 879 (p. 317).GIOVENALE - p. 369.GIUSTI, E. - p. 333.GLAUZONOV - p. 402.
GL1NKA, N. I. - P. 396.GODWIN, E. w. - pp. 63, 374; ili. 140 e 141 fp. 63),143 e 145 (p. 64).GOETHE, w. - p. 405.GOLIA & e. (ditta) - p. 346.GOLOVIN, A. J. - p. 407.
411; sch. 382.GONTCHAROVA. N. - p. 280; ili. 787 fp. 285).
GORHAM, J. - p. 293.
DE MARIA BERGLER, E. - p. 328; ili. 911 (p. 329).
DENIS, M. - pp. 47, 392, 399, 400; ili. 104 (p. 48).
199 (p. 84). p. 377; sch. p. 377.DENT, E. o. - p. 369.
DERA1N, A. - P. 377.
DEEBOUT1N, M. - ili. p. 398.
DESKUR, J. - p. 256.
DESVALLJÈRE, G. - pp. 85, 377.
DJACHILEV, s. p. - pp. 16, 273, 276, 368, 370; ili
p. 377; sch. p. 377.
DIEZ, i. - ili 10 (p. lì).D1J5SELHOF, G. W. - pp. 171. 172; ili. 455 (p. 171),457 (p. 152).
D-[SOLA-p. 11.
DOBOUUNSKY - ;//. p. 417.
DOMENEC Y MONTANEB, L. - pp. 141, 146; ili 391
(p. 145). 396 fp. 147).
DOUDELET, C. - ili pp. 198. 391.
DRAGUTTN - p. 257.
DRESSER, c. - pp. 39, 40, 65; ili H9, 90 (p. 40). 147.
148 (p. 65) ; sch. p. 377/378.
DUCHOSAL, L. - p, 384
DUCROT, ditta - pp, 328, 346.
DUDOVICH, M. - p. 349.
OUNCAN, i. - pp. 16, 52, 379.
DURER, A. - pp. 384, 393.
DUSE, u. - p. 392.
DVORAC, A. - p. 382.
DYCE, W. - p. 29.
ECKMANN, o. - pp. 184, 186; ; / / . 8 tp. 12). p. 181.
484-4S6 (p. 184), 488 e 490 (p. 185). pp. 214, 235;sch, p. 378.EDEN, w, - p. 410.
EGED1US, H. - p. 244.
EL G R E C O - pp. 19, 412; iti, 27 (p. 19).
ELLIS, E. J. - p. 371.
ELNISLIE, G. G. - ili. 816 fp. 295), 818 fp. 296).
ENDELL, A. - pp. 46, 55, 60, 182, 183; sch. p. 378.
ENGELS, F. - p. 399.ENSOR, J. - p. 129, 408; HI. 351 (p. 131).
E5SEN1N, S. A. - pp. 52. 378.
FABERGÈ, c. - p. 285; iti 775 e 779 (p. 282), 780 e
781 (p. 283), 783 (p. 284): sch. p. 378/379.
FABRY, E. - p. 129; ili. 353 (p. 132).
FA1STANER - p. 230.
FALUS, E. - ili. 678 (p. 252), 707 (p. 261).
FANTAPPIÈ, E. D. - P. 333.
FARMER, A. ì. - p. 9.
FAULKNER, J. C. - pp. 34, 395, 402.
FAURÉ, G. - pp. 389, 400.
FELLEMER - p. 261.
FENOGLIO, p. - p. 321; ili 893 (p. 322).
F,CH - p. 408.
FtCHERA, F. - p. 328.
FIDUS (H. HOPPENER) - ili. 41 (p. 23).FILIGER, c. - p. 107; HI. 37 (p. 22), p. 379; sch.
p. 379.
FIORI, L. - p. 10; iti. 3 tp- 10).
FLAUBIIRT. G. - p. 222.
FLUDD. R. - P. 402.
CLAVAUD, A. - p. 401.COCTEAU. J. - p. 377, ili. p. 413.COEN, L - p. 257, ili 699 fp. 259)COLUN, R. - p- 389.COLONNA, E. - p. 93.coMENClNt, O. B. - p. 327; ili. 906 (p. S27J.
COMETTI. G. - p. 346.COPPEDÉ, G. - pp. 325, 326, 333, Ut. 903-905 (p.327). sch. p. 374.CORAZZIMI, s. - p. 319, sch. 374.CORWON. F. - p. 372.
cS'cST-l>p.V3fW.~ "' m'TORSO. O - p- 39.TOSTA, N. - pp. 318, 340, 376, 403.COSTFTTI. C. " Ut. 848 (p, 341).TOLRBET, Q. - p. 411.CRAIG. G. - pp. 16, 52, 77. 378; ili 176. 177 (p. 17):sch. p. 374.CRANE. T. - p. 375.CRASE. L. - p. 375.CIANE, w. - pp. 36, 40, 46, 63, 69, 79, 106, 115.151. 171, 251. 293, 367; ili pp, 41, 101 (p. 46). 106p 49). 142, 144 (p, 64). 146 fp. 65). ili p. 375;
sch. p. 375.
c u s n . e. - pp. 333, 365. 394.CM5W1K B - p. 391evi. e. A. - p. 394.CLUPERS. p. H. - p. 169, ili. 452 (p. 170).CZBCHKV c. o. - ;//. 614 (p. 231).DALCROZE, i. — p. 397.D U I . s. pp. 9. 38, 55, 201, 380, 406.DAHMOUSE. A. - ili 244 (p. 98).D'ANNUNZIO, G. - pp. 15, 319, 368, 373, 376, 381,393. 403. 405, 4M; ili. 943 (p. 343); ili. p. 375;sch. p. 375.D" ARONCO, R. - p. 320; ili 886-889 (p. 321). 892
xh. p" 375.DALM. fratelli - pp. 95, 97, 379; ili. 246-24S (pp. 99.100.. sch. p. 375.DE BASEL. K. P. C. - p. 172.DE BALDOT. A. - p. 92.DE BOSIS. A - pp. 319, 403; seh p 376DEBLSSY. e. - pp. 16, 46, 47, 382, 389. 391, 397,400. 4M: Ut. p. 376; sch. p. 376.W CARLI), S - p. 396.DE CAROLIS. A. - pp. 326, 328, 340, 349; ìli. 937p. 338, 953 Ip. 343) ; sch. p. 376
DE CHIRICU. G. - pp. 201, 237, 372, 387. 406.DE COSTA, M. - p. 171 ; ili 453 (p. 170),
DE FALLA. M. - p. 377.DE FELRE, G. - pp. 85, 93. 397; Ut. 208 (p. 87), p.3'6; sch. p. 376.DE FONSECA. E. - p. 320 .
DEGOUVE DE NUNQDES, W. - p. 129; Sch. p. 377.DEGROL-X. G. DE - p. 408.DELACRO1X, E. - p. 394.
DELCROY. ». L. - p. 365.DELECLUSE E. - p. 410ML GUERCIO. A. - p. 365.DEL5AHTE, F. - p. 52.
DELMLLE, i. - p. 129; ili 352/p. 132). 354 (p. /.'-V355 :p. 133). pp. 377. 402; sch. p. 377.
Indice dei nomi
GORIN. S. - p. 401.GOVA. F. - pp. 387, 412.COZZANO, G. - pp. 319, 374; sch. p. 382.
GRANDI, G. - pp. 371, 412.GRAN1NGER - p. 63.
GRASSET, E. - p. 203; sch. p. 382.GRECA-JINOV, A. - p. 402.GREENWAY, K. - p. 69.
GREGORETTC - p. 328.
GREGOTTI, v. - p . 16; ili. 5 (p. IO).
GR1BODO, G. - p. 322.GRiEG, E. H. - pp. 16, 241; iti. p, 382; sch. p. 382.GBiGNANi, F. - p. 22; ìli. 39 fp. 22), IIÌIS (p. 364).C;RIMM. J. L. K., W. K. - p. 375.GROPLUS, w. - pp. 192, 370, 384.
GROSVENOR, G. - HI. 791 Ip. 288).GRUBER, F. - p. 97.GRUBICY, A. - pp. 346, 399. 404.GRUSSOV - p. 387.
GUA1TA. S. DF. - p. 398.GUELL, E. - pp. 138. 380.GUIMARD, H. - pp. 89, 90, 93, 147. 205; Ut. 211-217 (pp. 88. 89). p. 382; sch. p. 382/383.GUSSONI, G. - pp. 322, 325.GUTERSLOH, P. VON - p. 230.GUTHR1E, T. - pp. 150, 390.HAMSUN, K. - p. 241; sch. p. 383.HANKAR. p. - pp. 105, 113, 115, 117; Ut. 292-301(pp. 114-1/6), p. 383; sch. p. 383.HANSEN. F. - p. 244; ili- 634 (pp. 241-249), 652(p. 246).HARMS, E. p. 404.
HARTUNG, H. - HI. 1016 (p. 363}.HASENAUER - p. 397.HAUSÈR. A. - pp. 18, 365.HEGERMAN ///. 666 (p. 249).
HELMER - P. 261.HENDERSON, P. - p. 396; ili. 45 (p. 25).
HfcSTERMANN, A.' - p. 391.HEVES1 L. - pp. 397, 398.HEYSE, P. - p. 372.HILDEBRAND A VON - pp 372 393 406HIROSHJGHE - P. 379.HODLER, F. - pp. 176. 235, 387; ///. 621-623 (pp. 235.236). 625 (p. 236). 627 (p. 237). p. 384; sch. p. 384.HOETZGER, B. - p. 50; HI. 112 (p. 52).
HOFBAUER, A. - ili. 705 (p. 261).
HOFFMANN, i. - pp. 55. 204, 211, 214, 387, 410; iti.539 (p. 205). 565 ip. 213), 567 (p. 213). p. 384;sch. p. 384.HOUHANN, L. VON - p. 198; Ut. 527 (p. 198), p. 384;sch. p. 384.HOHENSTELN - p. 349.HOLABIRD, W - p 404HOLHEIN, H. - P. 384.HOLST, R. N. R. - p. 241.
HONNECOURT, V. DE - p. 18; Ut. 16 |>. 16).HORNER, H. P. - pp. 66, 391.HORTA, v. - pp. 55, 58, 105-110; 113, 115, 117, 322,382, 383; iti. 127 (p. 56); 135 Ip. 59), 268-291
'pp. 106-1131, p. 385; sch. p. 384/385.HORTI. p. - HI. 680 (p. 253).HUHBARD, E. - p. 293.HOUGHTI1N, E. E. - Hi. 13 (p. 14).
HUNDERTWASSER. F. - HI. 1011 (p. 362).HUNT, w. H. - pp. 29, 30, 402; ili. 59 Ip. 30), 63(p. 31), p. 385; sch. p. 385.HU AR M v p. 9.HL\ M*N i K. pp. 375. 393. 395. 401. 411 • sch.p. WIB EN H pp. 38. 382, 403; sch. p. 386.IMM,E s pp. 67, 106, 391: ili. p. 417.INIRFS j A D pp. 28, 384; ili 55 Ip. 2$).I \ANO\ v sch. p. 386.I \FS i E sch. p 386.ÈN EN (, - p 243.EN EN KLLNT P \ ili. 639 Ip. 242}. 641 (p. 242).
JEN EN * p. 37!.
JOHN TON J N p. 297.MINES i» pp. 40, 388- ili 88 Ip. 40)JULFHIOY p. 389.
JLDON CLARK, R. - p. 365.JUJOL G1LBERT I M - p. 147 .
JLRKOVIC D (7/. 726, 728 (p. 269). •kAEZIANG E ili. 679 (p. 253).
KAKET - p. 370.
698 (p. 259).KANDiSKU, w. - pp. 83. 284, 404; ili. 201 (p. 85).767 ip. 280), 772 (p. 2SI). 996 (p. 35S), p. 386;sch. p. 386/387.
KANZ, F. - ili. 811 fp. 293).
KENDRCCK, (J. F. - ìli. 827 fp. 299).
KHNOPFF,' F. - pp. 106, 107, 128. 203. 384, 387.402, 406, 408; ili. 343 (p. 128), 345-350 (pp. 129-131). pp. 388. 416: sch. p. 387/388.
KJELLAND, T. B. - P. 9.
KIESLEB. F. ì. - ili. 990 (p. 359).
KING, J. M. - pp. 67, 163; ili. 414 (p. 155).KIPP, K. - ///. 812 tp. 293).K1RCHNER, E. L. - ili. p. 409.
K1RCHER, A. - HI. 30 (p. 20).
KLEE, P. - pp. 160, 387; ili. 624 (p. 236), 941 <p.339).KL1MT, E. - p 387KLIMT, o. - pp. 43, 49, 135. 203, 204, 215, 222,227, 229, 230, 374, 384, 396, 397, 404 413- ili536 (p. 203). 596-607 (pp. 222-228), p. 387. 388;sch, p. 387.KLiNGER, M. - pp. 198, 203, 406; ili. 523-526 (pp.196-198); sch. p. 387.KOBLIHA, F. - ili 734 (p. 271).KONOWATOV - p. 372.KOKOSCHKA, o. - pp. 233, 353. 404; HI. 616-619(pp. 232-233). p. 388, 389, 404; sch. p. 388.KIINIO, F. - ili p 396
KOROVIN, C. A. - pp. 393. 410.KOTERA, J. - ili. 733 (p. 271).KOUSNETSOV, P. w. - pp. 279, 393; ili. 38S. 766(p. 280) ; sch. p. 388.KREISLER - p. 392.
KR1SHNA MURTT - p. 377.KUBJN, A. - pp. 262, 404.KUPKA, F. - p. 268; ili. 722-725 (pp. 267. 26%). 982
LA FARGE, j. - p. 313; ili. 813 Ip. 294;.
LALLQUE, R. J. - pp. 93, 100, 263. 265. 285. 314.370; ili. 114 (p. 53), 194 (p. 82), 250 Ip. 101), 253-262 (pp. 102. 103) ; sch. p. 389.LANCERAY. E. -ili. 736 (p. 272), 770 fp. 281), p. 370.LARCHE, R. - p. 50; ili. 124 (p. 55); sch. p. 389.LARIONOV, M. - p. 279; ili. 778 (p. 282), p. 406.
LARSSON, e. o. - p. 107; ili. 667 (p. 249), 668 fp.249), p. 389; sch. p. 389.
LASZLÓ, p. A. -*p. 251; iti. 676 (p. 252).LAVERY - pp. 150, 390.LAVJROTTE, I. A. - ìli. 226 (p. 92).LE BAHON JENNEY, w. - pp. 389. 404; ili. p. 404.LECHNER, o. - p. 251; iti. 672 (p. 251).LE CORBUSIER - pp. 11, 155, 192. 370.LEDERER, A. - p. 229.
LEMAITRE'- p. 37Ó.
LEONARDO - p. 16.LERCHE, s. ST. - ili. 120 (p. 541, 642 Ip. 242). 644fp. 243).
LE ROY, O. ' - p. 394.LEVINSON, A. - p. 368.LEVI P15TO1, M. - pp. 45. 322, 365.LEVY-DHURMER, L. - p. 85; HI. 204 tp. 86); sch.p. 389.LEYLAND, F. R. - p p . 39, 4 1 1 .LIADOV - pp. 377, 402.L1EBERMANN. M. - pp. 106. 195, 203. 384.L1NDENCRONE - ili. 666 (p. 249).UNDENSCHMIT - p. 406.LlNOOREN, A. - p. 2 4 5 ; HI. 650 Ip. 245). 658 e 660-662 (p. 248).LiNDQUiST, s. A. - p. 245; ili. 659 (p. 2481.L1NNEL, J. - p. 371.L1SS1TSKY, L. EL - ili. 981 Ip. 353).LiszT, F. - pp. 392, 402, 405, 411.
LOCATI, S. - p . 325.LOCK, M. - ili. 47 (p. 26).
LOOS, A. - pp. 20, 56, 220, 384, 388, 410; ili. 589-595 (pp. 220-221). p. 389; sch. p. 389.LORRAIN, ). - ili. p. 389; sch. p. 389.
LOUVET, L. A. - ìli 218 (p 90)LUCAS, M.-F. H. - p. 50; HI. 123 Ip. 54).LUCKARDT, H. - p. 353; ìli. 985 (p. 356i.LUNAUDI, G. - p. 327; HI. 929 (p. 335). 971 e 972ìp. 350).LURCAT, J. - p. 384.
163. 390; HI. 409 e 410 (p. 152). p. 154.413 ip. /<5.436 Ip. 163); sch. p. 390.MACDONALD MACNAIR, F. - p p . 149, 151. 154. 163.
391; HI. 434 Ip. 163). 440 (p. 165); sch. p. 390MAC DOUGALL, W. B. - p. 67.MACHADO, A. - SCh. p. 391.
Indice dei nomi
MACKAKT - p. 387.
VACKINTOSH. e. R. - pp. 20, 78, 93, 149, 151, 154
155. 158-161. 163, 164, 287, 299, 353, 367, 387
390, 391; ili. 399-409 (pp. 148-132). 411-418 (pp153-157/. 420-433 (pp. 158-162). 435 (p. 163)437 ip. 164), 980 fp. 3SS). p. 390; sch. p. 390-391MACKMURDO, A. - pp. 36, 40, 58, 63, 66, 78, 79
151.410; ili. 136 (p. 60). 149-15! (p. 66) ; sch. p. 391MACLEOD. R. p. 367
MACQUS - p. 117.««-ni . u - p. 391.
MADOX BROWN. F. - pp. 29, 36, 106, 395, 402; ili
?~ p. 29,. 66 (p. 32). p. 391; sch. p. 391.
MAETERLISCK, M. - pp. 15, 16, 95, 154, 376. 388
394. 405, 408; sch. p. 391.
HAHLER. G. -' pp .^6 , 392, 411 ; ili. p. 392; sch. p.
391 392.
UAJAM. A. - HI. 877 (p. 316).
MAILLOL. A. - p. 84; ìli. 198 (p. 84), 207 (p. 871
p. 392; sch. p. 392.
MAJORÉLLE. L. - pp. 93, 9S, 97, 379; / / / . 98 (p. 45)
240 Ip. 97) ; sch. p. 392.
MAIXZEWSKI. J. - pp. 252, 394; ili. 685 (p. 254)
WS ip. 255). 690 (p. 256). p. 392; sch. p. 392.MALERBA, T. - p. 328; ili. 909 (p. 328).
MAUtTIN. S. - ili. 747 (p. 275).
MALLARMÈ. s. - pp. 16, 28. 50, 376, 380, 397, 401
ili. p. 392; sch. p. 392.MALORV. T. - pp. 67, 369.
HAMON-TOV. E. - pp. 273, 393; ili. 738 (p. 273).
MAMONTOV. s. [. - pp. 262, 273, 407, 410; ili. 731
p 173,. p. 393; sch. p. 393.
MAVTEGNA. A. - pp, 32, 372.
MCLLHAN. M. - p. 365.
*ARC, r. - p. 404.
«MUSETTI, F. T. - p. 403; ili. p. 403.
MVRNEZ. L. - p. 92; ili. 223 e 225 (p. 91).
MAROTHI. a. - ili. 682 (p. 253).
MAHSHALL - pp. 34, 36, 395, 402, 403.
MARTTS. H. - P. 394.
MARTINI, ALHERTO - pp. 337, 349; iti. 884 (p. 320)
956 -p. 344). 960 (p. 346); sch. p. 393.MARTINI, ARTURO - p. 128; / / / . 955 (p. 344); sch
p. 393.
MARTORELL, B. p. 141.
MARX. K. - p. 399.
«A5IK. K. v. pp 262, 396- i// 727 (p. 269) ; sch
p. 394.
«ASIN - p. 377.
MATALONI (ditta) - p. 349.
HATHER GREENE, H. - p. 297.
MATHEL'S, L. e A. - p. 297; ili. 824 (p. 297).
WATtSSE. H. - p. 387.
MATSCH. F. - pp. 229, 387.MALS. M. o. - pp. 9, 106. 379; sch. p. 393.
MAXENCE. E. - (//. 206 (p. 86).
MAZZUCOTELLI, A. - pp. 323. 325. 346; ìli. 89f
p. 322>. 897 (p. 324).
UC LtHAN, M. - pp. 21, 367.
MCNAIR, H. - pp. 149, 151, 154, 390; ili. 438 Ip
164,. 439-441 (p. 165); sch. p. 391.WEHOFFER, j. VON - ili. 684 (p. 254). 689 fp. 256)
p- 394; sch. p. 394.
MEIER-GRAEFE, i. - pp. 92. 120, 128. 186, 243. 409
MELAVI, A. - p. 320.
MELLERY, X. - p. 387.WEWELSIIHN. E. - p. 353; ///. 974 Ip 352) 983Ip 1W).MENDELS )HN, F. - p. 396.MENEGHETTI, L. - p. IO; ìli. 5 Ip. 11).MENGON1, G. - HI. 882 (p. 318).
MENN, B - p. 384.MERIME. P - p. 410.
METLICOVITZ, L. - p. 349; ìli. 965 Ip. 348)
MEUNJfcR k. - P. 203.
MJCHALSM E. pp. 9, 235.
MICHELANGELO - pp. 19, 371.MJCHELAZZl, G. - pp. 332, 333, 142, 374; ili. 913,914. 916 (p. 330), 917, 919 e 920 (p. 331), 921Ip. 333); sch. p. 394.MICHELI, A. - ili. p. 320.
MiLiUTi. v. e N. - pp. 273, 279, 407; ///. 764 (p. 279).
MLLLMS, ). E. - pp. 29, 32, 402; ili. 60 (p. 30), 65 e (57(p. 32). p. 394; sch. p. 394.M1LLER, H. - p. 38.MILLET, ]. F. - ;7/. 815 fp. 294).
MTNNE, G. - p p . 106, 128, 393, 412; ///. 341. 342 e344 Ip. 128); sch. p. 394/395.MIRÒ, j. - ili. 1010 (p. 362).MODLOL1AN1, A. - ili, 1007 (p. 361). p. 368.MOHOLY-NAGY, L. - ili. 1005 (p. 360).MONDRIAN, P. - HI. 1000 (p. 359).
MONET, r. - pp. 106, 399.MI1NTALD, C. - ìli. p. 409.MONTESQUIOU. R. DE - HI. 963 Ip. 347).MOORE, H. - ili. 1003 (P. 360).MORBELLI, A. - pp. 328, 399.MORANI - p. 373.MOREAU, a. - pp. 16, 83, 129, 377, 383, 385, 387,388, 398, 401, 402; iti. 200 Ip. 84). p. 395- schp. 395.
MORETTI, G. - p. 333; ///. 924 (p. 333). 927 e 928(p. 334).MORISOT, B. - p. 106.MORRIS, w- - pp. 14, 16, 29, 32, 33, 34, 36, 40. 58,63, 69. 78, 106, 117, 151, 293, 367, 372, 375, 393,399. 401, 402, 405, 408-41!; Ut. 15 (p. 16). 43 Ip.
sch. p. 39S.MOSER, K. - pp. 22, 50, 215, 229, 384; iti. 2 (p. 9).40lp.22), I18(p.53).p. 188.pp. 198. S3S (p. 203).540 fp. 205), 573-585 (pp. 216-219). 587 e 5S8fp. 219). p. 396; sch. p. 396.MOULINS - iti. 220 Ip. 90).MUCHA, A. M. - pp. 263, 267, 370; ili. 671 ip. 250,.708-721 /pp. 262-266). 735 Ip. 271). p. 396; sch.p. 396.MULLER, o. - p. 97; ili. 249 Ip. 100).
MUNCH.'E. - pp. 194-196, 243, 244, 262. 353; iti.516-518 (p. 193). 520-522 (pp. 194. 195). 647 e648 (p. 244), p. 396; sch. p. 396.MUNTHE, G. - p. 244; HI. 651 Ip. 245).MUNTHE, H. - pp. 243, 244.
MUSATTI. C. - p. 378.MUSORGSKU, M. P. Sch. p. 396.MUTTERS, H. P. - p. 169.
NASICA - (//. p. 375.
NEBIOLO (ditta) - HI. 973 (p. 351).
NERÉE TOT BABBERICH, K. C. H. DE - p. 170; ili. 470(p. 177). p. 397; seti. p. 396/397.
NLRI, N. - p. 400.
NERVAL, O. DE - p. 16; SCh. p. 397.
NERVI. P. L. - ili. 9S9 (p. 357).
NESTEROV - p. 410.
NESTOROVIC, N. - p. 257; Ul. 697 (p. 258). 700 e
701 (p. 259), 706 (p. 261).
NEUEERG, F. - p. 390.
NEUBERG, J. - P. 163.
NEWCOMB COLLEGE POTTERY ìli. 826 <p. 299).
NICCODEM1, D. - p. 319.
NCCHOLSON, W. - p. 77.
NEIUWENHUB, T. - pp. 171, 173: ìli. 451 (p. 170).
459 (p. Ì7Ì).
NIETZSCHE, F. - pp. 16, 49, 246, 386, 403, 405, 411.
NuiNSKiJ, w- - pp- 16, 377, 397; sch. p. 397.
NJJBUP, M. - p. 251; ili. 636 e 637 fp. 241).
NOCQ, H. - p. 93.
NOMELLINC P - p 349.
OBRIST, H. - pp. 20, 53, 181, 201, 378; / / / . 33 (p. 21).
42 ip. 23). 94 (p. 44). 131 (p. 58). 474 e 475 (p.
181); sch. p. 397.OESTBERG, H. - / / / . 635 (p. 241).
OKUN, E. - ili. 6S6 (p. 255), 691 (p. 256).
OLBRLCH, J. M. - pp. 189, 204, 205, 209, 211, 214.
232, 233, 384, 412; ili. 534 (p. 202), 537 (p. 204).
554-564 (pp. 209-212). 586 fp. 219), p. 397. 419;sch. p. 397.ONIIFRI, A. - p. 319,
ORAZI - iti. 122 !p. 54),
ORIANI, D. (fabbrica) - p. 323.
ORLIK, E. - ili. 12 (p. 13). p. 384.
OSBERT - p. 393.
OVERBECK, J. F. - p, 391.
PAGANO, v. - pp. 393, 409.
PALATRON., R. - p. 409.
PALAZZE5CH!, A. - P. 374.
PANKOK, B. - p. 188; ili. 495 e 497 (p. 187).
PARMIGIANINO - pp. 16, 19; ili. 26 (p. 19).
PARRI SPINELLE - (//. 19 (p. 17).
PARRONCHI, A. - p. 397.
PASCOLI, G. - pp. 376, 381; sch. p. 398.
PATER, w. - pp. 32, 372, 411 ; sch. 398/399.
' « » * • • ••- - p - » ' •
PAVLOVA, A. - p. 370.
PAXTON, J. - pp. 25, 110; ili. 44 e 45 (p. 25).
PÉLADAN, i. - pp. 29, 129, 377, 388, 389, 402, 408;
ili. 64 (p. 31), p. 398; sch. p. 398.
(•ELLIZZA DA VOLPEDO, G. - P. 337; (//. 942 (p. 339) ;
sch. p. 399.
PEBOL - p. 93.
PERREI, A. - p. 92; ili- 228 (p. 92); sch. p. 399.
PERRET, C. - p. 399.
PETROv-vODKiNE, K. s. - p. 388; ili. 768 e 769 Ip.
280). p. 399; sch. p. 399.
PHILIPS, T. - ili. p. Ì7L
PHYLE. D. - ili. 799 <p. 290).
PICA. v. - pp. 9, 320, 327.
PICASSO. P. - pp. 73, 83, 377; ili. 203 Ip. 85).
P[COT, p. 395.
P1LGHE1M, B. - p. 4 0 6 .
Indice dei nomi
PIRANESI. G. B. - p. 42 ; / / / . 977 (p. 353).
PISSARRO, C. - p. 106.
PLUMET, c. - pp. 91, 93 ; ; / / . 230 (p, 93).
POE, E. A. - p. 393.
POEL2IO - p. 353; ili 984 (p. 356).
POINCARÈ - p. 19.
peata - p. 402.
POIRET, P. - p. 368.
POLSNOV. E. - p. 273.
POLLAIOLO - p P . 16, 19.
POUDOW, G- - p. 402.
PIILLOCK. l. - p. 403; ili 997 (p. 358).
PONTORMO - pp. 16, 19; ìli 25 (p. 18).
PORTOGHESI, p. - pp. 10, 11, 110, 365.
PREISLER, J. - p. 262; ili. 730 Ip. 270/.
PREISS1NG. V. - ili 732 (p. 271).
PREMIILI, A. - pp . 322, 323.
PREVMT1, G. -• pp . 333, 337, 345, 368; ili 938 Ip.
338). p. 399; sch. p. 399.
PROUST, M. - pp. 16, 38, 376; ili p. 400; sch. p.
399/400.
PROUVÈ, v. p. 379.
PRYDH, J. p. 77.
PRZYBUSZEWSK], S. - pp . 49, 243.
PUCCINI, G. - pp. 319, 392; sch. p. 400.
PULCI, L. - p. 393. ' '
PUSKIN. A. S. - p. 410.PUVIS DE CHAVANNES, P. C. - pp. 16, 203, 235, 372,373. 384. 387, 399; ///. 209 Ip. 87). p. 400; sch.
p. 400.
QUARTI, E. - P. 346.
RACINE, J. B. - P. 370.
RAFFAELLL, J. F. - p. 203.RAhFAELLO - pp . 18, 29, 384, 402; / / / . 17 (p. 16).
RAGGHIANTI, C. L. - p. 10.
RAMEAU, I. P. - p. 376.RANSON, p. - p. 377; sch. p. 400.
RAPIN, R. - ili 224 Ip. 91).
RARSKAND Ut. 665 (p. 248).
RAVEL M SCh. p. 400/401.
REDON o pp. 16, 83, 106, 107, 283, 309, 399,
402, 412; ili. 197 (p. 83). p. 401; sch. p. 401.
RtVI(,LIONE M p. 337.REÌNOLD TEPHEN W p. 79.RHErtD F H ///. 828 Ip. 299).
RHOUE ìli. 638 Ip. 242).
RICHARD ON H H pp. 168, 293, 306, 404, 406;
(//. 831 (p. 300).
RRkETTS c p. 77; ili, 132 (p. 58). 172 e 173 Ip.76). 175 (p. 77,), p. 77. 414; sch. p. 401.
R[< ORDÌ (edizioni) - p. 349.
RIEOL A pp. 45, 137. 204.
R[hMER CHMID R p. 188; ili. 491-493 Ip. 186).
496 fp 187), 501 Ip. 188).
RIETVELD G T pp. 155, 384.
RICOTTI, A. - pp. 322, 324, 342, 374.
RUSSELBERGHE, T. VAN - p. 408.
RILEV, B. - p. 22; ili 1017 (p. 364).
RILKE, R. M. - pp. 16, 403; sch. p. 401.
RIMBAUD, A. - pp. 16, 37; ili. p. 401; sch. p. 401.
RiMSKU-KORSAKOv, N. A. - pp. 273, 368, 394, 402.
405. 410; sch. p. 401/402.RIPELUNO. A. M. - pp. 368, 373, 386.R1PPL-RONA], J. - HI. 392 Ip. 146).BITTER, W. - p. 405.RIVA, u. - ili. 4 Ip. 10).
RIVIÈRE,' n.F-' p. 'sO; ili. 125 Ip. 35).ROBINEAU, A. A. - iti. 821 (p. 297).
ROCHAS, A. DE - p. 396.ROCHE, H. - p. 404; Ut. 829 (p, 300).
ROCHE! P. - pp. 50. 60; ili. 121 Ip. 54).RODENBACH, G. - pp. 50, 389; sch. p. 402.RODIN, A. - pp. 50, 93, 106, 128, 203, 367, 387, 394.
ROEBUCK, Ci. i. - p. 390.ROERICH, N. - pp. 273, 370; Ut. 743 (p. 274).
ROCERS, E. N. - p. 10.ROHLFS, c. - p. 287; iti. 806-808 (pp. 292, 293).ROLLER, A. - Ut. 538 Ip. 204). p. 205.ROMANI, R. - p. 345; ///. 943 (p. 340).
ROOT, J. W. - p. 404.ROPS. F. - pp. 399, 402.RORSCHACK - p. 154.ROSSETTI, D. G. - pp. 29, 30, 32. 34. 36, 47, 49, 128,367, 371, 372, 376, 391. 411 ; Ut. 58 Ip. 29), 62 Ip.30). 105 Ip. 48). p. 395, p. 402; sch. p. 402.ROSSETTI, G. - p. 409.ROSSI, G. - pp. 344, 393.
ROSTAND, E. - p. 370.ROSTER, G. - III. 883 Ip. 319).
ROTHENSTETN, J. - p. 9.ROYCROFT (Gruppo) - p. 293; ili. 809 e 810 Ip. 293).RUBINO. E. - p. 337.RUBJÓ 1 BELLVER. ]. - p. 141; ///. 390 Ip. 145).RUCK.ERT, F. - p. 392.
RUSK1N. J. - pp. 14, 29, 30, 33. 34, 37, 40, 46, 66,69. 117, 367, 372, 385. 391, 393-395, 402, 403, 411;ili. 72 Ip. 34), p. 402; sch. p. 402-403.RUVCDCC, M. - p. 257; Ut. 703 Ip. 260).RYDER, A. P. - p. 309; i/A 855 e 857 Ip. 309). S59Ip. 310). p. 403; sch. p. 403.RYSSELBERCHE, T. VAN - pp. 105, 117; ili. 264-267
(p. 105). p. 304.SAAR1NEN, EERO - p. 4 0 3 .
SAARINEN, ELIEL - p. 245; Ut. 655-658 (pp. 247, 248),660 (p. 248). 662 e 663 Ip. 248), p. 403; sch. p. 403.
SALOMÈ-ANDREA5, L. - p. 4 9 ; Sch. p. 403 .
354). p. 403; seh. p. 403.SARAZIN, C. - ìli. 222 Ip. 91).
SARGENT, 1. S. - p. 203.SARDOU, V. - p. 370.
342); sch. p. 403/404.
SATIE. E. - pp. 377. 400.
SAUVAGE, H. - p p . 50,84,91,93, 379; iff. 117 (p. 53).222 Ip. 91).
SCARPA. C. - P. 10.
SCHACH - p. 372.
SCHIELE. E. - pp. 230. 353; iti. 608-613 (pp. 229. 230).615 Ip. 231). p. 403; sch. p. 403.SCHINDLER, A. - p. 392.
SCHMALÈNBACH - p. 235.
SCHMUTZLER, R. - pp. 25, 220, 365.
5CHÓNBERG, A. - pp. 16, 47, 370, 389, 392. 400:
HI. p. 404; sch. p. 404.
5CHÒPENHAUER, A. - p, 16.SCHUMANN, R. - p. 396.
scorr , i. E. - p. 287; Ut. 794 e 795 (p. 289/.
SCR1ABIN, A. - p. 377.
SEGANTINI, G. - pp. 328, 337, 399; ili. 939 e 940
(pp. 338, 339).
SELMERSHEIM, T. - pp. 91. 93.
SBRINI, P. - p. 400.
SERRUR1ER-BOVY, G. - pp. 105. 125; Sch. p. 405
SERUSIER, P. - pp. 377 379
SEURAT, o. - pp. 106, 176, 367, 399: ili. p. 367.
SHAKESPEARE, W. - pp, 374, 393.SHANNON C - P 401
SHCHERBOV, P. - ìli. 742 (p. 274).
SHEKHTEL, f. - p. 285; Ut. 771 e 773 tp. 281/. 785
ip. 284), 786 (p. 2$5).
5HERATON, T. - p. 147.
SIBEUUS, J. - p. 241 ; sch. p. 405.
SIONAC, P. - p. 106.
SIMHERG, H. - p. 245; ìli. 649 (p. 245r, sch. p. 405.
SIRONI, p. - p. 326.
///. 968 Ip. 349).
346; iti. 969. p. j ^A L 1 A N A R I C K A R C G 1 S ( ) R I
P
954 (p. 343). D E L L A C E B A M ' C A
SOCIETÀ O1RARD & CUTTER - p. 346.
SOHLBERG, H. - p. 2 4 4 .
SOMMARUGA, G. - p. 325; ili. 894-896 (pp. 323. 3241.
899 (p. 325): sch. p. 405.SOMOV, K. - p. 370; ìli. p. 371.
SONN1ER. L. - p. 92 ; HI. 293 (p. 91).
SOTTSASS, E. JR. - p. 158; ili. 419 (p. 158,.
SPADINI, A, - HI. 961 (p. 346).
SPENDER, E. - (//. 847 (p. 305).
SP1LLAERT - p. 129.
STACCHINI, u. - p. 325; / / / . 898 Ip. 324).
STANISLAWSKII, K. - pp. 273, 374.
STEELE, J. - p. 22; HI. 36 !p. 21).
STEINER, R. - p. 353; HI. 986 e 987 Ip. 356).
STEIN, G. - P. 38.
STEFANOVic. A. - p. 257; Ut. 697 Ip. 258). 700 e 701
Ip. 259). 706 Ip- 261).
STICLEY. G. - p. 387; HI, 793 Ip. 288).
STOPPINO, G. - p. IO; HI. 5 Ip. i l ) .
STORY, A. J. - p. 371,
5TKAU5S. R. - p. 392; sch. p. 405.
STRAUVEN, G. - p. 117; Ut. 302-305 Ip. 117).
STRAWiNSKU, i. - pp. 16. 397, 400, 402, 413; HIp. 413; sch. p. 405/406.
STRINDBERG, A. - pp. 16, 38, 241, 243; sch. p. 406.
STUCK. F. VON - pp, 201, 203, 387; ili 109 Ip. 50-.
528 (p. 199). 529-531 Ip. 200).
SULLAM, G. c. - p. 335; Ut. 934 e 936 (p. 337).
SULLIVAN, L. - pp. 20, 56, 60, 100, 287. 294, 299,
300, 306, 404, 412; ///. 138 (p. 61), 815 Ip. 294,.
Indice dei nomi
832-842 fpp. 300-304!. P- 406; sch. p. 406.SUMMER GREENE, e. - pp. 106. 297; ili 825 Ip. 298).SVABINSK1, M. - HI. 731 (p. 270).SWINBURNE, A. e. - pp. 38, 371, 372; sch. p. 407.SVMONS, A. - p. 369.TANAZEVIC, B. - p. 257; ;//. 696 fp. 258). 704 {p.260).TARALLO, P. - p. 322.TASTONI, A. - P. 393.TATHAM, F. - p. 371.TATLIN, v. - p. 20; ili. 34 fp. 21).TÉNISHEVA, M. - p. 273; ili. 740 e 743 (p. 274), 746ip. 275). 750 (p. 276). p . 407; sch. p. 407.TERRY, E. - p. 374.
TESORONE, OP - p. 327.
THOMA. H. - p. 406.THONET, M. - pp. 58, 311; HI. 129 fp. 57).THORN PKIKKER, i. - pp. 170, 172, 176, 353; ìli. 464ip. 176). 468-472 Ipp. 177-179). p. 407; sch. p. 407.THOVEZ, E. - p. 320.TIFFANV, CHARLES - p. 407.
TiFFANY, L. e. - pp. 22, 50, 93, 100, 287, 293, 301,309; ili 1 (p. 8), 38 (p, 22), 788 (p. 286). 814 (p.294). 858 e 860 Ip. 310). S61-867 Ip. 312), 868-876 (pp. 313-315); sch. p. 407/408.TOBEY, M. - ili. 1001 (p. 359).TOLSTOi, L. - pp. 399, 405.
TOOROP, J. - pp. 107, 170, 173, 176, 387, 397, 402,413; ili. 442 Ip. 166), 458 (p. 173). 460-463 Ipp.174. 175). 467 fp. 176), p , 408; sch. p. 408.TOULOUSE-LAUTREC, H. DE - pp. 50, 83, 106; ili.116 (p. 53), 210 (p. 87). p . 408. 412; sch. p. 408.TOWNSEND, e. H. - p. 79; ili 186 e 187 Ip. 79).TRASCHEL - HI. 620 Ip. 234).
TRAVERSO, L. -• pp. 386, 407, 413.TRENTINI, G. - p. 345.TRUBETSKOJ, P. - p. 285.TRUBNER, W. - p. 406.
TSCHUDC MADSEN, S. - pp. 14, 43. 60, 365, 385.TLTT, H. - ìli. 823 Ip. 297).TZARA, T. - P. 389.LGO A. - pp. 246, 328.LHDE, F. VON - p. 203.UTAMARO - pp. 39, 379.VAGÒ, J. p. 251.VAGÒ. L. - p. 251; ìli. 681 fp. 253).
VALLGRES, V. - HI. 653 Ip. 247).
VALLIN, E. - pp. 95, 97, 379; ili, p. 92, 241 e 242•P- 97,.\ ALLOTTON, F. -HI. 196 Ip. 831. 202 fp. 85). p. 408;sch. p. 408.
VAN AVERBEKE, E. - p. 117; ///. 309 Ip. 119).
VAN DE VELDE, H. C. - pp. 14, 40, 46. 50, 55. 60, 93.105. 107. 120, 127, 176, 181, 187, 188, 192, 193,203. 251. 353, 384, 388, 405, 407; ili p . 32. 9? fp.45). 99 (p. 46), p. 56. p. 57. 263 Ip. 104), 312-340'pp. 120-127), 466 (p. 176). 487 e 489 Ip. 185).513-515 Ip. 192). p. 394. 399. 409; sch. p. 408-409.\ANDONE, A. - p. 322; ili 897 fp. 324).V A \ GOGH, v. - pp. 21, 38, 106, 107, 176, 353, 354,412; ili. 465 fp. 176).
VAN LERBEROHE - p. 394.V ANNETTI. A. p. 333.
VEDOVA, E. - ;7/. 998 fp. 359).
\ELÀSQUEZ, D. R. - pp. 235, 384.
VELATI-BELLINI - p. 322; iti. 891 (p. 322).VERHAEKEN, E. - pp. 105, 377, 388. 394, 408; ili.p. 409; sch. p. 409.VERLAINE, P. - pp. 37, 367. 376. 407; HI. p. 409;sch. p. 409.VIANI L. p. 345; ili. 923 (p. 333).VICINI, l. - p. 371.VIDAL. F. p. 146.
VILLIERS DE LISLE-ADAM, P. A. M. DE - p. 377.VIOLLET-LE-DUC, E. E. - pp. 40; 92, 107, 115, 138,169; 380. 382; ///. 92 e 93 (p. 41): sch. p. 509/510.VIZZAVONA, P. - p. 117; iti. 308 (p. 118).VOOELS, G. - p. 408.VON ESSEN, L - p 397VON MARÉES, H. - pp. 372. 373, 387. 406.VOYSEY, e. F. H. A. - pp. 78, 287, 372; iti. 102 fp.47). 178-181 (p. 78). 185 (p. 79); sch. p. 410.VUILLARD, E. - p. 408.VRUBEL, M. A. - pp. 274, 285, 407; Ut. 751 e 752fp. 276). 755 e 756 (p. 277), 760 e 761 fp. 279).p. 410; sch. p. 410.WACNEB, o. - pp. 129, 205, 215, 332, 333, 384. 388.
394, 397; ili. 541-546 (pp. 205. 206). 548-553 (pp.207 208); sch. p. 410.WAONER, R. - pp. 370, 376, 384. 405; sch. p. 411.WAGON - ili. 227 (p. 92).WALLANDER, A. - ili. 669 (p. 249).WALTTIR. B. - P. 392.WALTON, E. A. - pp. 150. 390.
WEBB, p, - pp. 34,'78, 395; ///. 7} (p, 34).WELLBORN R(MJT, J. - p. 299; ili. 830 (p 300)
WERKADE - p. 45.WHARTON EDWARDS, G. - HI. 847 (p. Ì05).
WH1STLER, J. MC NEILL - pp. 16, 29, 30, 36, 37, 39,63, 71, 106, 309, 372, 374-376, 402, 403, 408; ili.
78-81 (p. 36). 83-85 (pp. 37. 38). 87 (p. 39), p. 411;sch. p- 411.
WH1TMAN, W. - SCh. p. 4 M .
WIGAND, EDOUARD - (7/. 673-675 (p. 251).W1EGELE - p. 230.WILDE, o. - pp. 15, 16, 37, 38, 63. 68, 69, 71, 77,287, 370, 401, 405; HI. p. 412. 414; sch. p. 412.WILDT, A. - pp. 188, 337; HI. 935 (p. 337); sch.p. 412.W1LLUMSEN, I. F. - p. 241; HI. 645 (p. 243). p. 412;sch. p. 412.
WOLF, H. - p . 392.WOLF FERRARI, T. - pp. 344, 346; ;//. 959 Ip. 345).WOOD, C. - ili. 181 (p. 78).WOUTERS, R. - p. 128.WRIGHT, F. L. - pp. 10, 20. 56, 294, 306, 367, 370,372- ili 792 (p. 288). 817 (p. 295). 819 Ip. 296).820 (p. 297). 850 e 851 (pp. 307. 308). 853 e 854
(p. 308). 856 Ip. 309). p. 412; sch. p. 412.WYSPIANSKI, s. - p. 256, iti. 683 Ip. 254).YEATS, w. B. - p. 222; sch. p. 412/13.ZABELA, N. - p, 410,ZAN1NOVIC - P. 333.
ZECCHIN, v. - pp. 344, 346; ili. 962 (p. 346). 964Ip. 347). p. 413; sch. p. 413.ZEN, e. (ditta) - p. 346; ili. 966 (p. 348).
ZEVI, a. - pp. 10, 365.
ZINOVIEV, A. - ili. 745 Ip. 2751. 75Ì ip. 277).ZUMBUSCH, L. VON - HI. 9 ip. lì).ZUPANSKY, V. - ili. 729 Ip- 270).ZWOLLI», F. - p p . 171, 172.
INDICE GENERALE
pagina 7 Introduzione.
PREMESSE
8 Capitolo 1 - La ibrtuna critica. Confronti e paralleli storico-estetici.24 Capitolo 2 - Precedent^ dell"Art Nouveau.44 Capitolo 3 - Caratteri deil'Art Nouveau.
ESTENSIONE DELL ART NOUVEAUCOME MOVIMENTO 1NTERNAZI0NALE
62 Capitolo 4 - Inghilterra.82 Capitolo 5 - Francia e Scuola di Nancy.
104 Capitolo 6 - Belgio - Bruxelles.134 Capitolo 7 - Spagna - II Modernismo e Gaudi.148 Capitolo 8 - Scozia - La Scuola di Glasgow - Machintosh.166 Capitolo 9 - Olanda.180 Capitolo 10 - Germania.202 Capitolo 11 - Austria.234 Capitolo 12 - Svizzera.240 Capitolo 13 - Paesi scandinavi e Danimarca.250 Capitolo 14 - Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia.272 Capitolo 15 - Russia.286 Capitolo 16 - Stati Uniti.316 Capitolo 17 - Italia - II Liberty.
CONTINUITA DEL FENOMENO
352 Capitolo 18 - Ascendenze e proiezioni dell'Art Nouveau.
APPARATI
365 Note al testo.367 Regesto critico e biografico degli artisti e testimonianze critico-
letterarie del periodo.
BIBLIOGRAFIA
414 Testi e pubblicazioni di protagonisti417 Periodici e riviste dell'epoca.418 Indicazioni di bibliografìa generale.
419 Principali esposizioni.421 Fonti iconografiche e documentarie.423 Collocazione delle opere riprodotte424 Indice dei nomi.
LA STAMPA DI QUESTO VOLUME£ STATA ULTIMATA IN FIRENZE
NEL NOVEMBRE 1978DA: LA ZINCOGRAFICA FIORENTINA
CON I CARATTERI DELLA PANDA FOTOCOMPOSIZIONELEGATORIA L. DEGLI ESPOSTI, BOLOGNA
© 1976 - BY ALDO MARTELLO - GIUNTI EDITORE S.P.A.
116 (B) 1978 • STAMPATO IN FIRENZE DA LA ZINCOGRAFICA FIORENTINA