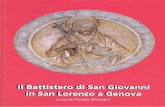Annio da Viterbo e i toponimi, in Nel cantiere degli Umanisti per Mariangela Regoliosi, a cura di L....
Transcript of Annio da Viterbo e i toponimi, in Nel cantiere degli Umanisti per Mariangela Regoliosi, a cura di L....
NEL CANTIERE DEGLI UMANISTI
PERMARIANGELA REGOLIOSI
a cura di
LUCIA BERTOLINI, DONATELLA COPPINIe
CLEMENTINA MARSICO
Estratto
Edizioni Polistampa
2014
1. Nell’agosto del 1498 il frate domenicano annio da Viterbo, che di lìa qualche mese sarebbe stato nominato Magister Sacri Palatii da ales-sandro Vi, pubblicò le Antiquitates, dedicandole ai re di spagna isabellae Ferdinando.1 si tratta di un’opera composita, strutturalmente abba-stanza disorganica, destinata però a un’ampia e lunga fortuna e insiemedestinata a suscitare per anni molte e ben fondate polemiche a causa deifalsi documenti che vengono pubblicati e dei metodi usati dall’autoreper commentarli.2 in queste pagine accantonerò completamente la que-stione della contraffazione dei testi, così come quella dell’inattendibilitàdelle storie anniane, come ormai da qualche decennio si comincia a faredopo anni in cui l’attenzione era quasi monopolizzata dall’esigenza didistinguere verità e menzogne nei testi del nostro frate domenicano.
tranne che in qualcuna delle sezioni in cui appare divisa, l’opera ècostituita da una serie di documenti antichi o contraffatti o del tuttofalsi, ai quali annio aggiunge un vastissimo apparato costituito daun’ampia premessa introduttiva, di carattere storico e formale, e da unfittissimo commento analitico. premessa e commento nell’editio prin-
Vincenzo de caprio
aNNio da ViterBo e i topoNimi
1 cito l’opera dall’editio princeps, uscita a roma nel 1498 nella bottega inCampo Florae dell’importante tipografo eucario silber. i rimandi saranno fatti indi-cando fra parentesi nel testo la numerazione moderna del foglio, scritta a penna sullacopia conservata presso la Biblioteca apostolica Vaticana (inc. ii, 274), appartenuta aegidio da Viterbo, con postille che meriterebbero di essere studiate.
2 senza contare la fortuna editoriale della versione in italiano dei testi anniani,riprodotti sia nella loro integralità, sia antologizzati, sono state individuate 19 edizionidel ponderoso testo in latino, stampate in diverse città europee fra il 1498 e il 1612(W. stephens, Giants in those Days: Folklore, Ancient History, and Nationalism, lin-coln, university of Nebraska press, 1989, pp. 344-45). alcune informazioni sulla for-tuna della storiografia anniana in N. popper, Walter Ralegh’s History of the World andthe historical culture of the late Renaissance, chicago, chicago university press, 2012,pp. 39-44.
475
ceps dell’opera circondano completamente il testo di questi documenti.l’impianto della pagina, caratterizzato anche dall’uso di due diversicaratteri di stampa per separare visivamente i testi antichi e il com-mento, danno al libro, come è stato osservato, l’aspetto di un volumeliturgico.
annio si presenta come teologo e come scrittore e commentatoredi origines; nella cui ricostruzione assegna un ruolo centrale al lavoro suitoponimi e sugli antroponimi. i nomi presenti in opere, tradizioni, lin-gue, epoche diverse, vengono ossessivamente messi a confronto daannio, collegati o separati (separazione che egli chiama aequivocatio),fino a diventare l’impalcatura che sorregge la ricostruzione anniana delpassato, la sua delineazione delle vicende, dei luoghi, dei tempi e deisignificati. il nominalismo e l’onomastica appaiono come il fonda-mento della storiografia e, contemporaneamente, come il cardineintorno al quale si organizza un avventuroso ed audace sincretismo reli-gioso, fondato sull’idea di una originaria rivelazione ad adamo.
il significato di ciascun documento edito nelle Antiquitates puòessere ricavato dall’interazione, dal rimando continuo fra “testo antico”e apparato (introduzione e commento); avendo però ben presente che,per annio, è nel proprio commento il baricentro, la vera chiave di let-tura, perché è solo esso che consente di evitare gli errori di interpreta-zione che a suo dire si sono accumulati sui testi che egli pubblica. ana-logamente il significato d’assieme di questa vastissima, labirintica e far-raginosa opera, potrà cogliersi solo cercando di tener conto dei reciprocirapporti fra le diverse sezioni che la compongono.3
3 segnalo solo alcuni studi che sono alla base di questo lavoro: r. Fubini,L’ebraismo nei riflessi della cultura umanistica. Leonardo Bruni, Giannozzo Manetti,Annio da Viterbo, «medioevo e rinascimento», 2 (1988), pp. 283-322; V. decaprio, La tradizione e il trauma. Idee del Rinascimento romano, manziana, Vec-chiarelli, 1991, pp. 189-260; a. grafton, Traditions of Invention and Inventions ofTradition in Renaissance Italy: Annius of Viterbo, in id., Defenders of the Text. The Tra-dition of Scholarship in a Age of Science 1440-1800, cambridge-london, Harvarduniversity press, 1991, pp. 76-103 e 268-76; g. Ferraù, Riflessioni teoriche e prassistoriografica in Annio da Viterbo, in Principato ecclesiastico e riuso dei classici. Gli uma-nisti e Alessandro VI, a cura di d. canfora, m. chiabò, m. de Nichilo, roma,istituto poligrafico e zecca dello stato, 2002, pp. 150-93.
476
Vincenzo de caprio
Nella princeps il titolo completo è Commentaria fratris IoannisAnnii Viterbensis ordinis praedicatorum Theologiae professoris super operadiversorum auctorum de Antiquitatibus loquentium confecta. questotitolo, ponendo in primo piano il commento anniano e concentrandol’attenzione su di esso più che sui testi commentati, molto probabil-mente riflette l’impostazione originaria dell’opera e risponde a un sug-gerimento di lettura proposto dall’autore (torna anche nella letteradedicatoria ai sovrani di spagna). il rapporto gerarchico fra testi antichie commento però s’inverte quasi subito, appena pubblicata l’opera,come ben mostra l’evoluzione del titolo nelle successive edizioni. peresempio, nell’edizione parigina del 1515 i testi pseudo-antichi sonoormai decisamente posti in primo piano: Antiquitatum variarum volu-mina XVII. A Venerando et sacrae theologiae et predicatorii Ordinis pro-fessore Io. Annio hac serie declarata. sulla stessa linea si muovono, anzi inmaniera radicale, le edizioni che pubblicano solo i testi antichi, senzaaccompagnarli col commento anniano. la prima edizione di questotipo esce addirittura con la stessa data della princeps.4
Nel pensiero anniano antroponimi e toponimi fanno riferimento adue differenti insiemi problematici. qui mi soffermerò solo sui nomidei luoghi, concentrandomi sul commento anniano al nome Viterbumcontenuto nella prima parte del cosiddetto Decretum Desiderii; senzaperò entrare nel merito né del testo del Decretum stesso, né del manu-fatto che lo conserva ancora oggi. sono comunque entrambi (testo elapide marmorea) dei falsi particolarmente grossolani: il testo venneredatto dal domenicano e fatto scolpire su una lastra di marmo ancoraesistente; per essere poi dissepolta nel quartiere medievale della città(forse nel 1493), con un certo battage pubblicitario, in un ritrovamentoarcheologico sempre orchestrato dal frate.5
4 Auctores vetustissimi nuper in luce editi, Venezia, Bern. Venetus, 1498; ma perqueste edizioni senza commento ho tenuto presente Fragmenta vetustissimorum auto-rum summo studio ac diligentia nunc recognita, Basilea, apud io<hannem>Beb<elium>, 1530, che contiene solo alcuni dei testi anniani.
5 sul testo e sull’epigrafe che lo contiene, una contraffazione di annio, ora con-servata nel museo civico di Viterbo, cfr. J. rubini, Annio da Viterbo e il DecretumDesiderii. Storia e miti del libero comune viterbese, Viterbo, edizioni sette città, 2012.
annio da Viterbo e i toponimi
477
sul modello pliniano, al quale annio esplicitamente rinvia, i sedicilibri delle Antiquitates sono preceduti da un primo libro di carattereintroduttivo che fornisce un sommario dell’opera e un repertorio dellefonti usate. in questo primo libro, «qui est secundi libri et aliorum dige-stio», annio indica il secondo libro come avente per oggetto le Institu-tiones etrusche: «secundus liber est de novem institutionibus etruscis»(f. 3). di esse, la settima è dedicata al Decretum Desiderii.6
Nella princeps, subito dopo il primo libro introduttivo viene invecestampato il libro contenente il commento a mirsilo lesbio (ff. 11-17),che nello schema era indicato come sesto e come tale continua ad esserepresentato nel titolo (Eiusdem fratris Ioannis Annii Viterbensis commen-taria super Myrsilum. Liber VI - f. 11). seguono via via i libri contenentii commenti agli altri testi antichi. l’opera si conclude infine con unlibro dedicato alla Etrusca simul et Italica emendatissima Chronographia(ff. 161-164). al termine di quest’ultimo libro, è stampato l’explicitdella Chronographia ma anche dell’intera opera, con il registro e conl’indicazione dei dati tipografici: «commentaria fratris ioannis anniiViterbensis ordinis praedicatorum theologiae professoris super operadiversorum auctorum de antiquitatibus loquentium confecta finiunt.romae in campo Florae anno domini mccccxcviii die x mensis iuliiimpressa per eucharium silber alias Franck. sedente sanctissimo inchristo patre et domino domino alexandro papa vi. anno eius sexto.laus deo» (f. 164)
subito dopo ha inizio un secondo blocco tipografico dell’opera,contenente le Institutiones Etruscae e le 40 Anniae quaestiones. l’agget-tivo anniae non sta a indicare che le quaestiones sono poste dal nostroannio bensì che esse riguardano piuttosto l’ambito familiare e gli sonostate poste da suo cugino, tommaso annio, anch’egli domenicano eprofessore di teologia, alle quali il nostro frate risponde (f. 188). leAnnianae quaestiones vengono perciò sviluppate nella forma di una let-tera responsiva al cugino. ad essa segue infine il libro De primis tempo-
6 l’ordinamento dei libri indicati da annio non corrisponde a quello presentenella princeps. cfr. g. petrella, L’officina del geografo. La «Descrittione di tutta italia»di Leandro Alberti e gli studi geografico-antiquari tra Quattro e Cinquecento. Con unsaggio di edizione (Lombardia-Toscana), milano, Vita e pensiero, 2004, pp. 59-64.
478
Vincenzo de caprio
annio da Viterbo e i toponimi
479
ribus et quatuor et viginti regibus primis Hispaniae et eius antiquitate (f.209). la stampa di questo secondo blocco risulta terminata a circa unmese di distanza, come viene registrato a conclusione del volume, ripe-tendo quanto stampato al f. 164 ma cambiando la data: «anno dominimccccxcviii die iii mensis augusti» (f. 213v.).
le nove Institutiones iuventutis Etruscae affrontano vari argomentiruotanti intorno al mito dell’etruria primordiale: De equivocis (f. 165r);De definitione nominum Turrenae, Volturrenae, Etruriae et de forma veterieiusdem urbis (f. 168r); Ubi sit tetrapolis Etruria (f. 169). diversamenteda quanto indicato da annio al capitolo i, ora il Decretum ed il suocommento fanno parte della quarta Institutio, dedicata all’illustrazionedi alcuni testi epigrafici, conservati su lastre marmoree alcune dellequali furono contraffatte dallo stesso annio: De excisis marmoriis (ff.171v sgg.). di queste, la Quinta tabula epigrafica contiene il DecretumDesiderii regis Italiae (ff. 181-184v) e viene così introdotta da annio:
Hactenus de quatuor excisis tabulis: nunc de quinta idest decretodesiderii regis.quinta tabulaquinta tabula est ingens semirota alabastrina litteris longobardicisexcisa: effossa in vico demi atu para tussae, sive coronatae tussae.in ea continetur revocatio eorum quae contra etruscos antea tule-rat aistulphus (f. 181).
Nel racconto di annio, i longobardi divisero la regione intorno altevere in tre ducati che ebbero a capo tre città: etruria, spoleto, Bene-vento. astolfo, duca di Benevento, era ostile agli etruschi, mentre desi-derio, duca di etruria, era loro amicissimo. divenuto re dei longo-bardi, astolfo creò una situazione difficile per l’etruria: «longholamsive para tussam iussit dici longbardulam: et ab eis abstulit lacum Vol-siniensem et ius cudendi monetas et multa alia, ut solent reges infestiurbibus agere». come già nell’accenno al ritrovamento epigrafico ancheora annio riconduce la vicenda a una toponomastica arcaica, legata allemitiche origine degli etruschi e della città. alla morte di astolfo gli suc-cede come re desiderio, che era «dux Vetuloniae sive etruriae». eglidiede al proprio ducato «plura beneficia» anche perché voleva assicurar-
sene la fedeltà, dal momento che il papa adriano stava chiamandocarlo magno contro di lui per difendere la libertà della chiesa e del-l’italia. da questa situazione, continua annio, nasce il Decretum Desi-derii, che revoca ciò che astolfo aveva stabilito. esso «dividitur in trepartes. in prima ponit beneficia collata Viterbi. in secunda quae contu-lit toti thusciae, de cuius desolatione accusabatur. tertio preparariiubet ad obsistendum pontifici» (f. 181v).
del Decreto, che nelle Antiquitates è accompagnato da un com-mento particolarmente fitto e minuto, di ampiezza decisamente esorbi-tane rispetto al testo al quale si riferisce, qui interessa solo la parte dellarifondazione della città e del nuovo nome, Viterbum, che le viene dato.7
il primo dei benefici concessi dal decreto, secondo l’ordine stabi-lito da annio nel suo commento, è la restituzione del lago di Bolsena aViterbo; il secondo è l’abolizione del nome Longhobardula, cui si leganoil terzo beneficio (l’unificazione di quattro centri preesistenti a formareun’unica città cinta da un’unica cerchia muraria); il quarto (la restitu-zione del diritto, per questa nuova città, di battere moneta contraddi-stinta «quatuor litteris sacris Faul», argomento questo che annioaveva già esposto nel commento alla seconda tavola e nella prima Insti-tutio e che più ampiamente sarà oggetto della XVi delle Anniae Que-stiones)8; il quinto (la sostituzione di ercole con san lorenzo comepatrono della città); infine il settimo beneficio (il sesto in questa sedenon interessa), vale a dire il beneficio di aver dotato la nuova città di unnuovo nome, quello di Viterbum.
7 Nella seconda Institutio, il Decretum Desiderii era stato allegato come prova delfatto che le originarie quattro parti urbane erano distinte e separate fra loro, in unpasso che sintetizza le convinzioni anniane sulla storia dei luoghi: «quod vero heaequatuor partes essent discretae, non sub unis menibus, non modo decretum deside-rii probat, sed etiam plinius, qui eas distincte enumerat in iii Naturalis Historiae ca.vi, dicens: “Harbanum, tuscanienses, Vetulonienses, Volturreni cognomine etrusci”.institutio hec secunda erudit iuvenes nostros, si nomina in contentionem et signifi-cata veniant, asserere regiam sedem thuscorum tribus sinonimis eandem esse etru-riam, turrenam et Volturrenam, et eam fuisse tetrapolim cuius partes regias autoresnominant Harbanum, tussam sive tuscam, Vetuloniam et Volturnam uti exposui-mus» (f. 169).
8 cfr. Antiquitates, ff. 195v-197.
480
Vincenzo de caprio
desiderio si pone così come il fondatore di Viterbo, perché nonsolo crea una nuova città con l’unificazione di quattro centri preesi-stenti, ma la fortifica dotandola di mura, le fa battere moneta propria,le stabilisce un nuovo culto religioso sostituendo una divinità paganacon una cristiana; infine completa e suggella questo atto fondativoimponendo il nome alla nuova città. egli cioè svolge la stessa funzionefondativa svolta da quelli che annio chiama antichi dei, i re e gli eroiprimordiali sacralizzati dal nostro domenicano.9 il nome imposto allanuova città si rivela perciò carico di tutti i significati e valori conoscitividi cui sono carichi, per annio, gli antichi nomi imposti alle origini dellastoria umana.
la modalità dell’atto fondativo di Viterbo da parte di desideriosegnala una strana anomalia: Viterbo è una città molto più antica dellasua stessa fondazione e del suo stesso nome, risalendo la sua vera origineaddirittura all’età dell’oro, agli albori della civilizzazione umana, al tempodella venuta nel lazio di Noé-giano e della fondazione di una cultura edi una società sapienziale e sacerdotale. desiderio, però, è un «sapientissi-mus rex», che quindi conosce la «scientia nominis»: la scelta del nuovonome per una città che è l’unione di altre città molto più antiche non èun’operazione semplice e non può essere un atto arbitrario. Nel nuovonome Viterbum continuerà a permanere e a condensarsi il segno diun’identità originaria, di un remoto e sempre attuale nucleo sapienzialeprimitivo. l’identità originaria e il nucleo sapienziale primitivo devonoautoriprodursi anche nel nuovo nome scelto da desiderio, in cui conver-gono infatti anche tutte le parziali e “storiche” identità urbane prese inconsiderazione dagli altri autori che si sono occupati della città pur senzaessere stati in grado di decrittare il codice del suo nome.
si legge nel testo del Decretum:
et ut sub uno muro cingant sua tria oppida longholam, Vetulo-niam et turrenam Volturnaque dictam etruriam; totamque urbemnostra adiectione Viterbum pronuncient (f. 181v).
9 Nell’età dell’oro, «cum nulla esset idolatria, principes iustos appellabant deoset numina». Nella dedica ai re di spagna precisa: «iustos principes deus vult deos diciper communionem nominis, non per essentiam» (f. 2).
annio da Viterbo e i toponimi
481
ed annio annota:
postremum beneficium est adiectio nova nominis ut, sicut unisnovis menibus cingebatur urbs, ita uno novello nomine dicereturViterbum.Hoc loco queritur: unde dicatur Viterbum et quid significet.pro quo notandum est quod in prima parte docet beatus thomasdicens: aliud esse a quo nomen imponitur et aliud ad quod signifi-candum imponitur. Nam, teste peritissimo donato, nomen signifi-cat substantiam et qualitatem propriam vel communem; quianomina imponuntur a proprietate rei quae est eius qualitas propriavel communis; et tamen significat substantiam, idest aliam essen-tiam: sicut lapis imponitur a proprietate communi, unde diciturlapis, quasi ledens pedem, et tamen significat aliam essentiam cor-poream. itaque cum desiderius litteratissimus adiecit urbi antiquis-simae novellum nomen, ab eius utique qualitatibus propriis vel com-munibus Viterbum nomen imposuit, et tamen aliud significavit.primo igitur videndum est a quibus qualitatibus Viterbum nomendicatur; deinde quid substantialiter significet (f. 182).
il nostro domenicano svolge una appassionata disanima etimologica perappurare le qualità proprie e comuni presenti nel toponimo Viterbum.egli qui sembra muoversi nel solco della tradizione dell’etimologismomedievale e non appare nemmeno molto più avventuroso rispetto aisuoi predecessori in queste sue spiegazioni; anche se appare davvero bor-der line, perfino rispetto all’elasticità dottrinale del tempo di alessandroVi, quando la sua ricostruzione etimologica viene a coinvolgere la suacomplessa ricostruzione mitica e sapienziale della civiltà etrusca, laricerca di radici ebraiche ed aramaiche, le approssimative componenticabalistiche della sua cultura mediate dalla consulenza di un più voltemenzionato «talmudista»10. ma questi sono aspetti importanti dell’in-dagine ma non centrali. l’essenziale nella ricerca anniana sul significato
10 su cui cfr. m. procaccia, Talmudistae caballarii e Annio in Cultura umani-stica a Viterbo, a cura di t. sampieri e g. lombardi, Viterbo, università degli studidella tuscia, Facoltà di lingue; comune di Viterbo, assessorato alla cultura;associazione roma nel rinascimento, 1991, pp. 111-21.
482
Vincenzo de caprio
annio da Viterbo e i toponimi
483
di Viterbum è che egli va oltre questo tipo di ricerca etimologica. annioelenca minutamente e riassume tutte le diverse interpretazioni delnome della città che sono state date nel passato. ma in esse vede solol’indicazione di “qualità proprie o comuni”, aspetti cioè esteriori, set-toriali, accessori che caratterizzano il luogo; ma non in modo essen-ziale. il suo scopo è invece quello di cogliere attraverso il nome la“sostanza” stessa della sua città, di definirne hillmanianamente l’anima,fissatasi ab origine, nell’età dell’oro, e conservatasi immutabile nei luo-ghi pur nel mutare di secoli, storie politiche e religiose, toponimi. e perannio cogliere cosa significhi substantialiter il nome di Viterbum, signi-fica, per ciò stesso, cogliere anche, con l’anima del luogo, pure il suodestino immodificabile, tracciato una volta per tutte fin dalla notte deitempi e rimasto inalterato nei secoli come in un tempo immobile. Findalle sue remotissime origini sulla città è impresso il sigillo di una ine-luttabile predestinazione, alla quale non può sottarsi nemmeno desi-derio, il suo secondo fondatore. dandole il beneficio di un nuovonome con l’obiettivo di assicurarsi la sua fedeltà contro il papa, desi-derio le può però dare l’unico nome che può esserle proprio, quelloappunto di Viterbum, che nell’esegesi anniana significa substantialitercittà regale e pontificia.
con questa complessa operazione, insomma, annio tenta l’ambi-ziosissima strada della messa a punto di un’immagine identitaria diViterbo capace di racchiudere, per lui, l’essenza stessa della città. men-tre recupera anche le immagini urbane già presenti in altri scrittori, ilnome della città unisce un suo passato remotissimo insieme con il suopresente e il suo futuro. Nel momento culminante dell’atto fondativo,quello con cui desiderio impone il nome di Viterbum, geroglifico in cuisi raggruma l’essenza della città, la visione anniana fonde insieme, in ununico momento, due diverse e separate idee della città già presenti nellacultura viterbese del suo tempo, quella che fa riferimento alle sue ori-gini etrusche e quella che fa riferimento alle sue origini medievali.
il significato del toponimo va colto alla luce soprattutto del fattoche esso viene da annio inserito in un sistema ampio di riferimenti chelo collocano al centro di una peculiare, affascinante quanto creativa,storia della civilizzazione occidentale e della trasmissione primaria dellarivelazione divina del sapere. Nella Viterbiae Historiae Epitoma annio
aveva già messo a fuoco un’immagine sapienziale della sua città. 11 Nellaperduta Historia Etrusca Pontificia il tema veniva sviluppato sottoline-ando la mediazione etrusca in direzione dell’istituzione pontificia. NelleAntiquitates la creazione di una siffatta immagine viene più ampia-mente elaborata, su parametri di riferimento non solo più vasti maanche diversi rispetto a quelli egiziani usati nell’Epitoma.
questi parametri si fondano su una peculiare idea di prisca theolo-gia elaborata da annio, in cui il mito delle origini tende a trasporsi damito della genesi e della storia primordiale dei popoli occidentali inmito dell’esistenza di una sapienza primordiale, piena e sacra per la suaestrema vicinanza alla diretta rivelazione divina ad adamo; sebbene siaimproprio parlare di trasposizione. per annio infatti non esiste unadistanza fra storia politico-istituzionale e storia della rivelazione, datoche per lui gli antichi re sono i depositari di un potere sapienziale e dicivilizzazione del mondo. in loro la funzione politica e istituzionale equella religiosa e sapienziale sono inestricabilmente collegate. il Noè diannio è il patriarca biblico che però, contemporaneamente, è ogige,giano, Vertumno, proteo, cielo. egli non è tanto, come nell’esegesimedievale, il costruttore dell’arca, figura del pontefice che guida la navedi pietro. egli è soprattutto il re-sacerdote giusto, civilizzatore delmondo, depositario di un potere sapienziale: «celum vero omnium rexsempiternus ianus docuit perfectam phisicam, theologiam et ritus etnaturalem magicam» (f. 116v). è il mediatore fra il divino e l’umano,l’elemento bifronte (giano), ancipite fra cielo e terra, che trasmette agliuomini la primitiva rivelazione e col suo essere giano, legato al topo-nimo del gianicolo, il colle di roma vicino al Vaticano, appare adannio come prefigurazione del pontefice romano.
dunque, delle verità rivelate da dio ad adamo hanno partecipatotutti i popoli antichi tramite la funzione mediatrice, svolta da Noè; percui la trasmissione dell’originaria sapienza divina parte dalla rivelazionericevuta direttamente da adamo e, per successive trasmissioni, approdaai caldei. anche la rivelazione presente nel Vecchio testamento in qual-che modo sembrerebbe talora non provenire direttamente da dio ma
11 edita in g. Baffioni, Annio da Viterbo. Documenti e ricerche, i, roma, c. N.r., 1981.
484
Vincenzo de caprio
mediata dai caldei: «adam scripsit primus ex revelatione de mundiatque sui creatione, et texuit historiam gestorum usque ad enoch cuiper se quendam reliquit historiam, enoch autem prosequendam reli-quit lamech prophete patri Noae; Noa vero reliquit post diluvium cal-deis, a quibus Habraam et residui veritatem rerum gestarum scripse-runt» (f. 101).
la prisca theologia anniana, dunque, appare in netta controten-denza rispetto alle più diffuse concezioni umanistiche della prisca theo-logia (e basterà pensare a marsilio Ficino) che facevano perno su unalinea greca di trasmissione dell’antica sapienza (ermete trismegisto -lino - orfeo - museo). una linea, questa greca, che secondo annio èassolutamente erronea e deviante. infatti la cultura greca, per lui, nelcampo del sapere ha scelto la strada dell’innovazione, della scoperta,della ricerca del nuovo, invece di seguire l’unica strada corretta par-tendo dal presupposto che c’è già stata, all’origine dei tempi, una pri-mitiva rivelazione sapienziale: la strada cioè, diametralmente opposta,della conservazione e del recupero del patrimonio originario di questaprimordiale rivelazione divina. se la sapienza è stata trasmessa diretta-mente da dio ad adamo, e poi rivelata ancora da Noè, ogni innova-zione non è un grado successivo di avvicinamento alla verità ma è solouna dispersione del patrimonio primitivo, un passo di allontanamentodall’autentica sapienza originaria.
per cui la strada verso la conoscenza elaborata dai greci non puònon essere – organicamente, strutturalmente, intrinsecamente – cheapostasia dalla verità, scisma, culto del falso e della menzogna, sovverti-mento delle leggi del sapere e del conoscere.12 i greci, secondo annio,attraverso la sapienza egiziana conobbero la verità originaria possedutadai popoli barbari: «lynus et museus et orpheus ab egyptiis et in
12 sull’antiellenismo di annio, cfr. anche F.N. tigerstedt, Ioannes Annius andGraecia Mendax, in Classical Medieval and Renaissance Studies in Honor of BertholdLouis Ullmann, a cura di c. Henderson, ii, roma, edizioni di storia e letteratura,1964, pp. 293-310; W.e. stephens, The Etruscans and the ancient Theology in Anniusof Viterbo, in Umanesimo a Roma nel Quattrocento, a cura di p. Brezzi e m. depanizza lorch, roma, istituto di studi romani-New york, Barnard college,columbia university, 1984, pp. 309-22.
annio da Viterbo e i toponimi
485
egypto didicerunt orgia et theologiam et rerum scientiam; et ea inrudissimam et absque litteris greciam retulerunt. […] quare philoso-phia a barbaris inicium sumpsit, non a grecis. preterea a septem sapien-tibus philosophia greciae cepta est, qui omnes ab egyptiis didicerunt»(f. 118). il particolare che i greci non possedessero ancora la scritturanon vuole solamente sottolineare la loro rozzezza, vuole anche mostrarela loro estraneità alla rivelazione divina, dal momento che per annio lascrittura faceva parte dell’originaria rivelazione di dio ad adamo. ma igreci si allontanarono subito dalla verità originaria ricevuta dagli egi-ziani, «sua sponte e quaestus gratia». i greci infatti non vollero seguire la«doctrina maiorum», l’unitario e vero sapere originario, e preferironoinvece trovare «novae opiniones». Non solo annio afferma l’opposi-zione fra “conservazione” e “novità”, ma anche oppone “dottrina” ed“opinioni”: l’abbandono della dottrina originaria e la perdita dellaverità fa nascere nella cultura greca la varietà delle opinioni che a suavolta produce lo sviluppo delle arti del convincimento e quindi deilenocini della retorica.13 è un attacco in piena regola alla concezioneumanistica della dialogicità della cultura, del culto della pluralità delledottrine, dell’arte dello scrivere e in particolare del dialogo.
c’è dunque alle origini stesse della cultura greca un atto volontariodi apostasia collettiva dalla verità che non ha alcun corrispettivo nellealtre mitiche vicende narrate dal domenicano nelle Antiquitates, mentrerichiama molto da vicino la formulazione con cui era stata caratterizzatala nascita delle eresie in un’opera anteriore, dedicata al commento del-l’Apocalissi in chiave profetica, sviluppata con gli strumenti dell’esegesiletterale e dell’indagine astrologica. Nel De futuris Christianorum trium-phis (1480), in cui l’antiellenismo di annio non investe ancora massic-ciamente la cultura greca classica, ma si limita alla condanna della chiesa
13 i greci «tarde ad philosophiam accedunt, paululumque in ea morati, vertun-tur ad questum lucri gratia; et neque de more doctrinam parentum sequuntur, sed suasponte variis studiis incumbunt, et lucri gratia novis semper opionionibus studentes,deque maximis disciplinis altercantes, incertos discipulos reddunt. […] sua sponte infabulas et nugas inciderent, quibus hominum animos a vero perverterent. […] et utmendacia facilius seminarent, studerunt ornatui verborum. Nihil enim magis proficitad decipiendum quam delectabilis fabula et lenocinium ornatus» (f. 100).
486
Vincenzo de caprio
greca, la vera fede, la dottrina di cristo, viene contrapposta alle “opi-nioni” di ario e degli altri eretici: «evangelium et scienciam cristi macu-laverunt, nolentes subjici fidei sed propriae opinioni».14
per questo, oltre che per sottolineare il carattere di verità immuta-bile attribuito da annio al sapere noaico, credo corretto parlare diun’apostasia a proposito dei procedimenti conoscitivi messi in atto dalpensiero dei greci. Nelle Antiquitates, infatti, esistono anche altri epi-sodi di sovvertimento della verità originaria: per esempio la perversionemorale e sociale, ad opera di cam (camese, cameseno, saturno),introdotta in egitto e poi in etruria nei confronti dei valori dell’età del-l’oro. ma sono episodi facenti capo a un singolo personaggio e, purequando hanno prodotto un traviamento collettivo, sono ben prestorientrati col ristabilimento della verità (la venuta di Noè nel lazio rista-bilirà l’ordine dopo il sovvertimento di valori operato da cam).15 l’ini-ziale apostasia greca sembra invece uscire fuori dalla norma eponimicaanniana, configurandosi come una costante ed indifferenziata azionecollettiva di perversione.
ma c’è un’altra postilla da fare, perché annio non rifiuta solo itesti ed il portato sapienziale della prisca theologia dei greci. insieme allasapienza greca e ai testi che essa ha prodotto, la prisca theologia annianadeve edificarsi abbandonando anche i metodi di ricostruzione dellaverità seguiti dalla filologia umanistica, che trae il proprio alimento pro-prio dalla lezione dei classici.
ai nuovi metodi di conoscenza che nel corso del quattrocentoerano stati messi a punto ponendo al centro la filologia, l’analisi dellefonti e dei testi considerati nella loro relativa storicità, annio sostituisce
14 cito dalla ristampa intitolata Glosa super Apocalipsim de statu Ecclesie. Abanno salutis presenti, scilicet mcccclxxxi usque ad finem mundi. Et de preclaro et glorio-sissimo triumpho Christianorum in Turcos et Maumetas, lovanio, Jo. de Westfalia, s.d.,f. 8. per l’apprezzamento positivo della prisca theologia greca, cfr. f. 56. sull’opera e sulrapporto con le Antiquitates, cfr. c. Vasoli, I miti e gli astri, Napoli, guida, 1977, pp.17-30.
15 annio torna spesso sulla capacità corruttiva di cam (ff. 108v, 111v-112, 122r e v). sulla figura di cam nelle Antiquitates, cfr. d.m. Whitford, The Curse of Hamin the Early Moderen Era. The Bible and the Justification for Slavery, Farnham e st.andrews, ashgate, 2009, pp. 43-66.
annio da Viterbo e i toponimi
487
488
Vincenzo de caprio
ambiziosamente metodologie diverse della conoscenza, basate sul disve-lamento, attraverso una particolare analisi dei segni, dei contenutisapienziali affidati in maniera velata ai documenti antichi.
2. la questione del nome di Viterbo imposto da desiderio allanuova/antichissima città rimanda dunque a questioni d’ordine generale.per annio uno dei segni più importanti attraverso cui è possibile nonsolo ricostruire la storia ma anche cogliere la verità primordiale è costi-tuito dai nomi originariamente imposti alle città nel momento stessodella loro fondazione.
l’argomentum a nominibus è uno dei criteri metodologici del sapereche è più recisamente e ripetutamente affermato nelle Antiquitates. esseinfatti sostengono la sua assoluta superiorità conoscitiva, persino rispettoa qualsiasi antico auctor: «argumentum a nominibus vetustis gentium etlocorum est validius quocunque authore, quia authores quandoque fal-luntur et fallunt, non autem nomen impositum» (f. 118v). sul piano sto-riografico la superiorità dei nomi rispetto agli auctores deriva dal fatto cheil nome consente di cogliere direttamente, saltando tutte le mediazionistoriografiche successive, il momento stesso dell’atto fondativo, com-piuto dai mitici protagonisti della storia anniana. infatti l’imposizionedel nome fu compiuta appunto perché esso restasse come signum omonumentum delle imprese compiute dagli antichi re. essi «imposueruntnomina gentibus et locis» soprattutto con tre obiettivi: «in signum expe-ditionis a iano patre commissae»; ad «monumentum posteris ut scirentquis eorum fuerit conditor»; ad «fulgorem et memoriam eorum et prae-cedentium maiorum» (ff. 118v-119v).
ma le finalità di questa attività nomenclatoria, per cui il nomediventa un’importantissima fonte per la storia, costituisce solo unaspetto del problema; ed è anche quello meno rilevante. Nelle Antiqui-tates, la questione dei nomi consiste in due aspetti problematici: «a quonomen imponitur» e, con chiara derivazione tomistica, «ad quod signi-ficandum imponitur». ed è appunto sulla base di questo secondoaspetto («ad quod significandum») che la validità dell’argumentum anominibus passa dal piano storiografico (il ricordo delle imprese) a unpiano ben diverso e più ampio, in cui si realizza l’ambizione anniana asvelare i significati nascosti della realtà, fino a giungere a cogliere, attra-
verso i nomi, la sua vera essenza. Nella continua interrelazione fra i testidegli “antichissimi” autori e il relativo commento anniano, i toponimio anche i nomi dei re e degli eroi si configurano come microtesti dadecodificare. essi sono i segni perenni e, nella sostanza, immutabili diun potere fondativo sacralizzato. si pongono in un rapporto analogicocol testo delle scritture e insieme si pongono come un gerogligico nonfigurativo che nasconde al suo interno un contenuto non evidente. lastoria passata e futura, come mostra la vicenda del nome della rifonda-zione di Viterbo da parte di desiderio, è già contenuta nei nomi in cuiè immobilmente rappreso il segno di una sapienza arcaica sacrale. scriveannio: «Nomen significat et substantiam et qualitatem propriam velcommunem, quia nomina imponuntur a proprietate rei quae est eiusqualitas propria vel communis, et tamen significat substantiam, idestaliam essentiam» (f. 182v).
in queste posizioni anniane convergono sia la tradizione tomistica,sia un’infarinatura cabalistica, sia, ed anzi soprattutto, in un teologo cheera stato maestro di scuola, la tradizione grammaticale, di donato(esplicitamente citato, insieme a s. tommaso) e di prisciano; sebbeneannio sembri poggiarsi piuttosto sulla tradizione di quei commenti adonato che combinavano il suo insegnamento con quello di pri-sciano.16 comunque con queste affermazioni siamo al centro dei pre-supposti teorici che sorreggono l’asserzione dell’assoluta validità cono-scitiva dell’argumentum a nominibus come strumento generale di cono-scenza e non solo come strumento d’indagine storiografica.
i toponimi, dunque, contengono in se stessi la traccia fedele, con-servatasi immutata attraverso i secoli, degli aventi passati, ma anche ilsenso profondo e completo di una realtà non immediatamente avverti-bile, ma che è possibile cogliere appunto attraverso la corretta indaginesulla substantia e sulle qualità proprie e comuni significate dal nome. inomi non designano solamente le cose, ma ne condensano, in un unicoblocco verbale, essenza e caratteristiche, proprietà sostanziali e qualità
16 cfr. l. Holtz, Donat et la tradition de l’enseignement grammatical. Étude surl’«Ars Donati» et sa diffusion (IV-IX siècle) et édition critique, paris, cNrs, 1981. ilbrano corrispondente dell’Ars maior, p. 614. la definizione di nome in annio sem-brerebbe più vicina a quella di prisciano (GL 2; 2, 56, 29-57, 1).
annio da Viterbo e i toponimi
489
accessorie. al di sotto del fluire della storia, dello svolgersi degli avveni-menti, del modificarsi delle fisionomie statuali ed urbane, il persisteredei nomi consente di cogliere una realtà immobile e sempre uguale a sestessa. persino quando i toponimi divengono altri da quelli che erano,essi si modificano restando però fedeli alla designazione originaria del-l’essenza di una stessa realtà, come abbiamo visto nel caso del nome diViterbo: nome nuovo che conserva in sé anche il significato dei prece-denti toponimi perché serve per designare una città nuova ma nata dauna realtà urbana molto più antica di cui continua a conservare la fun-zione. i nomi finiscono così col configurarsi non solo come prodottostorico e patrimonio storicamente posseduto, ma soprattutto comesegni immobili e perpetui, da decifrare nel loro significato; in qualchemodo simili a un corrispettivo verbale dei geroglifici fatti di immagini,quelli che annio propriamente chiama sacrae litterae, «quae mox cer-nentem cogunt petere quid haec significent. sacrae enim litterae dicun-tur quae magis ad secretum aliquod significandum quam ornatumapparent cuilibet aspicienti institutae» (f. 26v). la sacralità attribuita aigeroglifici deriva oltre che dalle loro origini nella rivelazione adamiticaanche dalla loro capacità di esprimere significati occulti, non immedia-tamente percepibili. sembrerebbe allora che anche l’idea anniana delnome come segno profondamente polisemico, complesso e misteriosoperché non immediatamente attingibile nelle sue valenze nascoste, diaad esso il carattere della sacralità. il riferimento alla sacralità si fa espli-cito nel commento al Decretum Desiderii: «quia dignum erat nomen,supremo studio et sudore excogitatum quod veram substantiam lociantiquissimam cum qualitatibus propriis et communibus exprimeret,non perderetur, sed sacrilegio simile videbatur mutando violare» (il cor-sivo è mio). si tratta di una successiva specificazione di quanto affer-mato nel testo del Decretum contenuto in un inedito trattatello annianopubblicato solo nel 1962: «cuius nomen aut a nobis constituta decretasi quis violaverit, aut capite puniatur aut laqueo stranguletur».17
17 cfr. r. Weiss, An unknown Epigraphic Tract by Annius of Viterbo, in ItalianStudies presented to E.R. Vincent, a cura di c.p. Brand, k. Foster e u. limentani,cambridge, Heffer & sons, 1962 p. 113 (ma cfr. pp. 101 sgg.).
490
Vincenzo de caprio
sviluppando il filo del suo discorso sul nome di Viterbum, anniosi sofferma prima sulle qualità della città che in quel nome vengonoindicate. per annio sono vere tutte le qualità di Viterbo indicate più omeno esplicitamente da scrittori menzionati alla rinfusa: classici edenciclopedisti medievali; umanisti e scrittori di storie locali (Fazio degliuberti, ermolao Barbaro, Biondo Flavio, marziale, plinio, straboneecc.). solo una non lo è perché, ponendo la fondazione della città dopola distruzione di troia, contrasta con le origini remotissime di questache è sì una nuova entità urbana ma che in realtà risale all’età dell’orodei primi atti fondativi di Noè e la cui realtà sostanziale è ben più anticapersino della sua fondazione.18
18 «qualitates plures habet Viterbum: et ideo a pluribus originem habet: et obid omnes opiniones verae sunt: excepta prima. Nam dicit: a primis fundatoribustyburtinis dici Viterbum quasi vi tybur idest parvum tybus. quod equidem falsumest, quia tybur novissimis temporibus post troiae ruinas conditum est: sed Volturnaprimis etatibus et aureo seculo, ob quod Volturrena, idest antiquissima turrena, dici-tur. […]
secunda opinione dicit: quod desumitur a qualitate particulari: qua thebanusegyptius Hercules in arbana parte palatium munitissimum extruxit in colle musarno[…]. ab hac igitur qualitate Viterbum quasi vi thebe dicitur.
Fatius vero de ubertinis Florentinus a proprietate alia qua vita suapte naturadeliciosa vivitur, ait urbem, que antea tusca et Veiuza dicebatur, postea dictam Viter-bum quasi vita erbidum.
tertius est raymundus in post cesarianis comentariis qui, ab alia qualitate quaemeriti militia romani illo victuri se conferebant, ait Viterbum vita in ermium dic-tum.
quarti: a thermis saluberrimis asserunt dictum Viterbum quasi vi thermu-lum, aut vi thermum […].
quinta qualitas, communis nunc sed olim propria, est quia tursita est et Vol-tursena a tursibus dicta. […] a proprietate igitur tursium sive turrium, a qua et Vol-tursena sive Volturrena dicta est, ab ea docti inter quos Blondus dicunt appellariViterbum quasi vi turrium». l’elencazione delle qualità indicate dal nome di Viterboprosegue poi in lunga serie: «Viterbum quasi vita Heroum»; «Viterbum Vi triumurbium» «Viterbum quasi Veiterbum idest curule»; «Viterbum dictum curule ter-bum: unde longholam terbum [desiderius] dici iussit et totam urbem Viterbum,quasi Vei terbum». (ff. 182r-v).
annio da Viterbo e i toponimi
491
Nella conclusione di questa parte del suo commento, annio cosìsintetizza le diverse qualità proprie e comuni comprese nel nome diViterbo che, «per qualitates vero proprias, significat Veiterbum, idestcurule terobum: Vita Heroum: Vi trium urbium: Vita urbium et anti-quitus Vi turrium. et per qualitates comunes significat: Vi thebum:Vita Herbum: Vita in ermium: Vi thermum et eiuscemodi compluri-mas qualitates. Hec de beneficiis Viterbo collatis» (f. 183r). segue poi ilcommento della seconda parte del Decretum Desiderii con l’esame deibenefici dati dal re longobardo all’intera tuscia.
ma, tornando al commento alla prima parte del Decretum, più chele qualità incluse nel nome di Viterbum ad annio interessa soprattuttomettere in luce la nominis sustantia che desiderio intendeva indicaredando alla città proprio quel nome: vale a dire che gli interessa definireil vero significato del nome, che racchiude la sostanza stessa della realtàda esso designata. continua infatti il commento anniano:
ergo eruditissimus rex desiderius, impositurus novellum nomenquod qualitates proprias et communes supradictas includeret,dixit: adiectione nostra dicant Viterbum. adiectione inquitnostra nova sed mirabili, que omnes proprietates includat ettamen substantiam aliam significet, ut in definitione nominisdonatus autor est.quae autem sit ista nominis substantia, utique est eius vera signi-ficatio quae a compositione partium pendet. sane sciendum estViterbum in omnibus excisis antiquis lapidibus et titulis subleone insigni definiri Viterbum vetus verbum. unde inscriptioilla intiquissima est sub leone: “Non timeo verbum; leo sum quisigno Viterbum”. Nec te moveat quod posuit litteram “i” et non“e”. Non enim Veterbum sed Viterbum dixit. etenim in compo-sitione sepe vocales mutantur, precipue ubi subest causamutandi, qualis fuit in hoc loco, ubi opus fuit ita componerenomina et sinerizare ut omnes qualitates cum substantia include-ret. si autem dicis Veterbum, equidem substantiam que est vetusverbum et qualitatem unam includis a Veis, et non omnes. sivero dicis Viterbum, non modo substantiam, sed etiam omnesqualitates proprias et communes includis. et ideo rectius dixitViterbum quam Veterbum. (ff. 282v-183).
492
Vincenzo de caprio
annio da Viterbo e i toponimi
493
insomma, osserva annio, i nomi dei luoghi possono cambiare; comein effetti cambiano nel corso della storia. ma, affinché i nuovi nomisiano quelli giusti, adeguati alla realtà designata, è necessario che essinon solo racchiudano in sé le qualità, ma siano tali da significare l’es-senza sostanziale di quella realtà. dunque ciò che muta col nuovonome è solo la forma fonica, che può essere cambiata a patto che ilvalore segnico del nome nuovo continui ad essere identico a quello delnome antico; perché tale valore segnico in realtà coglie e fissa per sem-pre l’essenza stessa della realtà designata a cui il nuovo nome deve con-tinuare ad essere fedele. chi conosce la tecnica per cogliere questoimmutabile valore segnico del nome, che permane al di sotto dellamutazione fonica del toponimo, è in possesso di un formidabile stru-mento di conoscenza. al di sotto del mutamento delle apparenzeesterne, al di là delle stesse barriere che separano le diverse lingue, eglipuò cogliere infatti la sostanza stessa, immobile ab origine ed immuta-bile, della realtà della città ed abbracciare il suo passato così come ilsuo futuro.
quid autem sibi velit hec substantia nominis vetus verbum nuncexponendum est.Verbum multis modis accipitur.uno modo, pro voce articulata; et sic omnes partes orationis suntverba.alio modo, ut est una ex octo partibus orationis.item pro dicto et imperio, uti est illud: “Verbo domini celi firmatisunt”. et illud: “Facito iuxta verbum regis”; idest iuxta dictum etimperium, unde, a dicendo imperative, dictator apud romanosappellatur.Verbum quoque rationem et supputationem significat, ut de Logosdicit divus ieronimus in epistula ad paulinum.utrumque autem officium dictandi populis et presidendi supputa-tionibus sive suffragiis, lucumones etrurie habebant. dictandiquidem et imperandi, quia xii lucumones erant xii reges, ut autorest servius super viii eneidos. de suffragiis vero patet propter idquod dionisius scribens in iiii libro: aderant, inquit, ex tota civi-tate etruriae hii qui suffragiis preerant, et velati infulis a tullodeprecabantur iram. mitram enim currules tantum lucumones et
larthes ferebant. unde insigne Vetuloniae est currus sive Veia cummitra lucumonia.et hoc modo accipitur verbum in nomine Viterbo, pro dicto siveimperio et presidentia suffragiorum atque dictaturam. Hinc Viter-bum est veterum dictatura et presidentia suffragiorum in Fano Vol-turnae. (f. 183).
l’analisi di annio può infine addentrarsi nell’indagine del toponimoViterbum condotta lungo una ancora più avventurosa linea di ricerca,anch’essa di ascendenza nelle cronache cittadine del medievo, in cuiViterbo si collega alla storia bizantina dei paleologhi (collegamento peraltro approfondito in un’altra sezione delle Antiquitates).
494
Vincenzo de caprio