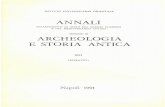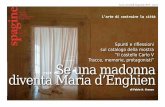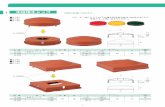A. Brelich Politeismo recensione
Transcript of A. Brelich Politeismo recensione
STIJDI E MATER{ALI DI
STORIA DELLE RELIGIOi\I
pubblicati dal Dipartimento dj Str"rdi storico-religiosidell'Unir.ersità di Roma .La Sapienza"
E? ,/ovcl /1dalla fon<lazione
JAPAI'Rtr }iDITilRgL'AQL-iLì . .[lù\i -.
Anno 2008 n.s. XXXll, 1
205
Afraate; non sembra inoltre che essi abbiano un unico autore, men-tre si può ipotízzare che le prime dieci Dimostra,zioni, che si diffe-renziano dalle altre, siano da attribuire a Giacomo di Nisibi. A que-sto proposito occorre rilevare che non è singolare che dal V sec. inpoi Giacomo fosse indicato come "Sapiente persiano", soprattutto daparte di chi non viveva in territorio sottoposto ai Persiani, cui Ni-sibi fu ceduta nel 365. Le Dimostrazioni XI-XX sono forse opera dialtri autori successivi; non è da escludere che si tratti di un uni-co autore. A parte è il caso della Dim. XIV che è una lettera en-ciclica, la quale denuncia gravi situazioni nella Chiesa siro-orien-tale. Le ultime tre Dimostrq,zioni sono forse opera di autori diver-si dagli altri, come sembra postulare il loro differente orientamen-to teologico. Per quanto concerne Ia Dim. XXm si può rpotízzareche I'autore avesse il nome di Afraate, nome che è prevalentemen-te connesso con questo scritto. Egli avrebbe riordinato Ie Dimostra-zioni presentandole come piccoli trattati. Si tratta naturalmente diipotesi, come lo sono del resto altre proposte di soluzione di que-ste intricate questioni.
Alla traduzione delle prime dieci Dimostrazioni Pericoli Ridolfi-ni fa precedere un sommario di ciascuna di esse, mentre prima del-la traduzione è riportata una lettera di richiesta in merito ai fon-damenti della fede cristiana che, secondo la versione armena, Gre-gorio I'Illuminatore avrebbe rndírizzato a Giacomo di Nisibi. All'in-terno della traduzione sono puntualmente indicati i riferimenti bi-blici e nelle note vengono segnalati accuratamente i casi in cui iltesto scritturistico è ampliato e arricchito di particolari. In ultimaanalisi si tratta di un lavoro altamente meritorio, condotto con me-todo rigoroso da un grande specialista qual è Pericoli Ridolfini chefornisce un contributo assai utile alla migliore comprensione di untesto rilevante della tradizione siriaca, nonché di un settore impor-tante del cristianesimo orientale.
Sergío Zincone
A. Bnnltctt, Politeismo, Collana "Opere di Brelich", r. 2, a cura diM. Massenzío e A. Alessandú, Prefazione a cura di M. Augé,Editori Riuniti, Roma 2007, pp. 143.
Nell'ambito del progetto di riedizione dell'opera di Angelo Bre-lich, esce il volume Politeísmo, che riproduce, con qualche lieveadattamento, iI testo delle dispense del corso universitario del-l'A.A. 1957-1958. Il lavoro, a distanza dí cinquanta anni, ha man-tenuto integra la sua validità: esso, infatti, si caratterízza, comedel resto l'intera opera di Brelich, per l'estrema profondità del per-corso di ricerca, coniugata con un linguaggro al tempo stesso rigo-roso e accessibile.
Dopo aver rilevato la scarsa incidenza quantitativa degli studidedicati al tema, Brelich pone la questione preliminare del supe-
206
ramento, in senso cronologlco, del politeismo da parte del monotei-smo cristiano, nell'ambito dell'esperienza storica dell'Occidente. L'a.esprime un energico rifiuto nei confronti degli apriorismi ermeneu-tici, che nello specifico sono rappresentati da due indirizzi teorici,razionalistico (da cui derivava l'approccio evoluzionista) e irraziona-listico (da cui si sviluppò, tra I'altro, l'ipotesi del monoteismo pri-mordiale): questi índírízzí, divergenti nelle conclusioni, appaiono aBrelich simili nelle premesse, in quanto entrambi proiettavano sufenomeni antichi rI concetto di dio, che l'Occidente era andato ela-borando nel corso sua storia. Esso rappresentava pertanto un ana-cronismo, se applicato ad epoche antecedenti alla sua insorgenza, enon possedeva alcuna validità ermeneutica: non era, in questo ca-so, un concetto scientifico, ma un pre-concetto dogmatico. Per com-piere una ricognizione dei problemi storici connessi alla formazío-ne del politeismo, Brelich ritiene pertanto di dover partire sì daun'idea di dio (anche in questo caso, infatti, la base è costituita dalteismo), che sia tuttavia desunta dalla viva vita di questi sistemireligiosi; più agevole appare all'a. il percorso che procede per me-todiche esclusioni. In tale prospettiva, seguendo Brelich, si posso-no escludere dal novero degli dei del politeismo: 1) gli esseri miti-ci non divini; 2); gh antenati; 3) gli esseri del tempo delle origini; ) gh spiriti. Questi diversi tipi di esseri non intervengono più nel-la realtà; in alcuni casi sono di origine umana; hanno un campo diazione assai limitato ed una personalità evanescente. Per contro, laqualifica di divinità pertiene, secondo I'a., a ((un essere personalenon umano e non di origine umana, permanentemente efficiente inuna larga sfera d'azione, che è oggetto di culto non esclusivamenterievocativo.D (p. 29). Parallelamente, Brelich rinviene un legame disolidarietà (non totale né esclusiva) tra il politeismo, come formareligiosa, e le civiltà superiori, come struttura sociale. Ciò non de-termina, tuttavia, una corrispondenza perfetta: a tale proposito, I'a.ricorda il caso degli Yoruba, una cultura <primitiva> dotata però diun complesso politeismo, e il caso della Cina, una civiltà superio-re, che nella sua.fase più antica non avrebbe espresso un autenticopoliteismo (il riferimento è ai rinvenimenti relativi all'epoca Shang,per i quali cfr. A. Bnnltctt, Introduzione alla Storia delle religioni,Roma 1966, pp.24L-244). Sulla base di questi elementi, Brelich simuove all'individuazione delle tendenze del politeismo: ciò che egliintende svolgere è un'analisi storica e non-morfologica e pertanto alconcetto statico di <carattere> viene preferita la categoria dinami-ca <tendenzaD. Per prima cosa, lo studioso si interroga sull'esigen-za che avrebbe portato all'elaborazione dei sistemi religiosi politei-sti: a tale proposito emerge I'insuffrcienza del iorrente di pensieronaturalista, che vede nelle divinità delle semplici copie o redupli-cazioni di fenomeni naturali. <Se Indra è il temporale owero il so-le - obietta Brelich - perché mai è il dio dei guerrieri, perché mainel mito si ubriaca della bevanda detta soma, perché mai uccide atradimento un suo avversario, eccetera?>. Evidentemente, nel siste-
207
ma politeista, Ie figure divine non si limitano a riprodurre i feno-meni naturali, ai quali pure sono associati, rta li esprimono eppu-re li superano in una dimensione più organica e più complessa. Atale proposito, Brelich esamina, a livello paradigmatico, il dio vedi-co Agni, portatore di un nome 'trasparente', che lo associa al 'fuo-co': come il fuoco non è concepibile allo stato elementare, ma assu-me sempre un aspetto culturale, allo stesso modo, Agni esprime lefunzioni religiose e culturali del fuoco, in aggiunta ad altre valen-ze non immediatamente riconducibili alla sua natura ignea (ad es.,è lui a consegnare ad Indra 7I uajra, simbolo di comando e stru-mento di realizzazíone dell'ordine cosmico). In questa parte dell'in-dagine, Brelich sembra riprendere alcune conclusioni alle quali eragiunto con il suo studto Il cammino dell'umanitd, elaborato all'ini-zio degli anni Cinquanta, ma rimasto inedito fino al 1985. In quellavoro, I'a. aveva indicato alla base della genesi del politeismo, nonil <dinamismo del distacco)r bensì il raggiungimento dell'<equilibriodi una distanza fissa> tra I'uomo e la natura (A. Bnelrcw, Il catn-mino dell'umqnità, Roma 1985, p. 85). In tale prospettiva, acqui-sta valore e si chiarisce anche il senso di un'altra tendenza pro-pria del politeismo: I'antropomorfismo. La tensione continua tra di-stacco e riawicinamento può essere risolta nel quadro di un'uma-nízzazione complessiva di quegli aspetti della natura <cristallizza-ti> nelle divinità. <Esprimere in forme umane tutto ciò che circon-da I'uomo e determina il suo destino, significa contemporaneamen-te due cose: il mondo, pur senza perdere nulla della sua sovruma-na potenza e grandezza, appare più comprensibile, più trasparen-te, meno informe e mostruoso; allo stesso tempo I'uomo, ritrovandole proprie forme nel mondo non-umano, acquista non solo un mag-gior senso di sicurezz,a e di confidenza con la realtà, ma anche unamaggiore dignità, poiché conosce se stesso come simile agli dei chereggono l'universoD (p. 59). A questo punto, si dispiegano le poten-zialità offerte dall'umanízzazíone degli dei: è possibile attribuire lo-ro un nome e, entro certi limiti, un sesso; una genealogia e, spes-so collegata ad essa, una gerarchia; è possibile narrarne le impre-se ed entrare con loro in rapporto attraverso operazioni rituali ap-propriate e diversificate. In aggiunta, si può erigere una <dimora>terrena, un luogo di culto stabile, la cui ubicazione all'interno del-lo spazio urbano esplicita e rafforza il profilo mitico-cultuale delladivinità cui è destinato.
Pur definendo iI politeismo (uno stupendo sforzo messo in attoda talune civiltà per conferire senso al mondo>, Brelich non ne oc-culta i limiti: nel quarto capitolo, interamente dedicato all'argomen-to, l'a. indica tra le spinte in controtendenza del politeismo, la teo-crasia, l'enoteismo ed il declassamento di divinità in figure minoriscarsamente differenziate. Tale fluidità viene ricondotta alla dialet-tica propria delle società complesse che si presentano, per loro na-tura, stratificate, con dislivelli interni di cultura. Si tratta, quindi,di riconoscere al di sotto di queste dinamiche Ie forze che agisco-
208
no e i fattori storici che le determinano, tenendo sempre presenteche I'equilibrio raggiunto dal politeismo, come quello di ogni prodot-to culturale, è per sua natura instabile. In conclusione, I'a. sviluppaun'ampia riflessione sul tema dell'origine storica del politeismo. Inquesta parte, Brelich riprende e discute, in una sorta di percorsocircolare, le tesi evoluzioniste e la teoria deII'Urmonotheismus giàconsiderate in apertura. Se il politeismo non rappresenta uno sta-dio necessario nell'evoluzíone della religione da forme più elemen-tari a forme progressivamente più complesse, né si configura comeil risultato di un processo di disgregazione a partire da un ipoteti-co monoteismo primordiale, se neanche il rapporto di solidarietà ri-levabile a livello storico tra politeismo e civiltà superiori offre unasoluzione perfettamente soddisfacente (si veda a proposito il casodei popoli polinesiani politeisti eppure <primitivi>, o per conversoil caso della religione degli Ebrei, approdata ad una forma mono-teista direttamente da una fase non-teista), l'unica strada percorri-bile appare quella del diffusionismo. Tale ipotesi si giustifichereb-be, secondo Brelich, non solo a livello logico (il che non sarebbe diper sé sufficiente) ma anche a livello storico: le analogie struttura-li di forma e di contenuto rilevabili tra i diversi politeismi potreb-bero in effetti sostenere I'ipotesi della monogenesi di questa formadi religione. Tali analogie, tuttavia, per poter assumere il valore didati probanti, avrebbero richiesto un'analisi sistematica e approfon-dita; in attesa di questo lavoro di indagine, Brelich preferì lasciareper il momento aperta la questione. Come è noto, nell' Introduzio-ne aIIa Storia delle religioni, lo studioso tornò sul tema dell'originestorica del politeismo, pronunciandosi in maniera più decisa a fa-vore della tesi diffusionista; in quest'opera, Brelich accentua infattiil legame intercorrente tra struttura sociale e forma religiosa e ri-solve la questione dell'origine del politeismo legandola indissolubil-mente a quella della nascita delle civiltà superiori. Resta sottinte-so che il processo che avrebbe portato alla formazione di entrambidovrebbe intendersi come un processo di rivoluzione.
Sappiamo che Brelich non si riteneva pienamente soddisfattodelle conclusioni espresse nell'.[rztroduzione alla Storia, delle religio-ni, e che aveva concepito il progetto di sottoporre a verifica tali con-clusioni confrontandole con la realtà di un sistema religioso: nel la-voro luppiter e Ia formq,zione del politeismo rotrtqno, lo studioso siproponeva, sulla base del comparativismo storico-religioso, di rico-struire il processo di formazione del politeismo romano. Il proget-to rimase incompiuto, ma dai due lavori preparatori pubblicatí, Ap-punti sul flamen Dialis (<ACUSD> 8 (L972), pp. l7-2L) e luppiter e
le ldus (ín Ex orbe relígionum. Studia Geo Widengren oblata, Lei-ùen 1972, pp. 299-306) è possibile farsi un'idea dell'impianto teori-co e metodologico del lavoro.
Dopo Brelich, come ricordano i curatori M. Massenzio e A. Ales-sandri, il problema è stato affrontato tra gli altri da M. Augé (cheha anche firmato Ia Prefazione del volume in questione) e da D.
209
Sabbatucci, a riprova del fatto che il tema, cui Brelich ha appor-tato un determinante contributo, resta in posizione centrale all'in-terno del dibattito scientifico. E se è vero che i nostri anni appaio-no propensi ad analisi minuziose piuttosto che ad organiche sinte-si, la riproposizione dell'opera di Brelich assume un valore orienta-tivo ancora superiore.
Cla,ud,ia Santí