5.2 De arcana imperii
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of 5.2 De arcana imperii
V.1 – De Arcana imperii
Wo Es war, soll ich werden
Freud Sigmund, 1933
Das Sollen – ist es Nichts? Keineswegs.
Einführhung in die MetaphysikHeidegger Martin, 1953
Di che si cava una regola generale, quale non mai, o raro falla, che chi è cagione che uno diventi potente, rovina; perché quella potenza è causata da colui o con industria, o con forza, e l’una e l’altra di queste due è sospetta a chi è divenuto potente.
Il Principe84
Machiavelli Nicolò, 1513
Nelle società umane chi può pre-scrivere un paradigma è l’élite, nel senso di chi detiene
il potere sulla comunità dei giocatori: la FIFA può cambiare le regole del gioco del
calcio, non lo possono fare le squadre del campionato, e per questo le sono subalterne.
L'élite è élite esattamente per questo motivo. Così, chi detiene il potere regola, in base
alla propria cultura, il paradigma che dà il gioco e limitando, perciò, la strumentalità dei
giocatori – in che cosa possono estendersi appropriandosi. Nel calcio un attaccante non
deve colpire con le mani la palla, la minaccia è la sanzione; ma allo stesso tempo deve
fare goal, la promessa è la vittoria. Si possono individuare almeno due importanti
conseguenze a quanto detto finora: i) tanto è maggiore la conoscenza dell’élite più il
gioco ha fit strumentale, ii) tanto è maggiore la grandezza del campo di gioco più il
gioco-del-Potere sembrerà il gioco-del-Mondo – ab absurdo se la Terra fosse un
grandissimo campo da calcio saremmo tutti calciatori. Occorre però precisare un
84 Accessibile all'URL http://goo.gl/0wpWP
59
dettaglio non di poco conto: la dirigenza della FIFA non gioca a calcio, ma ad un gioco
altro. Il rovescio della questione è appunto che i subalterni si danno nel mondo creato
per loro dall’élite – vengono dunque giocati e ne divengono estensione –, e questa,
l’élite, si allontana dal gioco creato in un gioco gerarchicamente superiore. Di converso
l’élite è tale finché i partner del gioco-del-Potere, i subalterni, partecipano al gioco-del-
Potere come tali e perciò sono strumento dell’élite.
La libertà dell’élite è comunque apparente. Ricordando il terzo assioma della
pragmatica della comunicazione umana85 della scuola di Palo Altro, la «punteggiatura
della sequenza degli eventi» permette di interpretare i pesi della relazione, ma un
sistema asimmetrico rimane tale se e solo se perdura la relazione asimmetrica.
L'esempio che fa Watzlawick è quello della cavia che crede di controllare lo
sperimentatore, “ogni volta che tiro la leva lui mi dà da mangiare” e ciò in un certo
senso è vero. Entrambi sono stimolo e rinforzo per l'altro, ma l'asimmetria è a monte ed
è nel potere. La chiave di volta per riconoscere una relazione asimmetrica è nella
interpretazione di Agamben della formula aristotelica oudén éstai adýnaton contenuta
nel libro theta della Metafisica: il potente può passare all'atto solo nel punto in cui
depone la suo potenza di non essere (la sua adynamia)86. Se il topo si chiedesse se può
non essere una cavia si accorgerebbe della relazione complementare, perché non può in
nessun modo non esserlo qualora entri in contatto con lo sperimentatore.
Nell’interdipendenza sistemica, cioè potenza-passata-all'atto, non è possibile per la parte
nessuna Libertà, poiché rigorosamente per il ruolo del libero si deve dare il ruolo del
non-libero, così nemmeno il libero è veramente indipendente – libero – perché
dipendente dal suo opposto, ha dalla sua parte solamente più gradi di libertà, vale a dire
più potenza. D'altro canto perché ci sia uno sperimentatore è necessario che ci sia una
cavia. Per un inciso ontologico, l’indipendenza intesa come libertà sistemica si ha
laddove si è Nulla e, quindi, non è una caratteristica dell’Esserci.
Per una analisi del Potere vorrei cambiare registro e ricordare le «3 m» di Latouche87 – i
missionari, i mercanti e i militari – dalle quali possiamo scorgere il tetragono essenziale 85
Watzlawick, P. et al. (1967) Pragmatica della comunicazione umana 86
Agamben, G. (1995) Homo sacer87 Latouche, S. (1989) L'occidetalizzazione del mondo
60
con cui il Potere si dà ai subalterni: i) il far-credere ad un gioco – soprannaturale e
indimostrabile nel caso dei missionari – per cui si legittimi la deontità, ii)
l’amministrazione dell’esistente, iii) il sorvegliare e iv) il punire con l’offesa. Quando
dico tetragono essenziale intendo che, contingentemente, nelle relazioni umane è
invariante per scala e senza di questo non si dà Potere. Sebbene il Potere senza i suoi
quattro modi non sia veramente Potere, il far-credere – o con-vincere – è la condizione
degli altri tre: il tetragono non è esattamente un quadrato, ma un rombo sbilanciato sul
primo vertice, chiamato altresì «quarto potere»88, quel modo che per poiesi del mondo
contemporaneamente lo giustifica e, giustificandolo, legittima il tetragono ai subalterni.
I quattro modi del Potere sono, in una parola sola, la Politica e questa è solo in seconda
battuta l’amministrazione dell’esistente, perché la sua più autentica vocazione è quella
di presiedere all’amministrazione del «campo negoziale continuo» della verità, ed è così
in quanto lo scopo del Potere non è già il raggiungimento della Verità – si può dare
Potere nella Falsità –, lo scopo del Potere è, senza fare tante perifrasi, il raggiungimento
della Potenza attraverso l’accumulo di potere. Per argomentare ulteriormente l’aspetto
costruzionista della mia interpretazione cito uno stralcio di Robert Nozick:
Spiegazioni potenziali fondamentali insoddisfacenti riguardo ai fatti possono avere una grande
capacità di chiarificazione, se le loro condizioni false sarebbero potute essere vere; perfino
condizioni iniziali del tutto false possono riuscire illuminanti, talvolta in grado molto elevato89.
Ebbene, in questo passo viene svelata la più importante conseguenza del riconoscere le
illusioni di cui accennava Marleau-Ponty nella Fenomenologia della percezione: è
possibile creare il mondo dal falso e non è necessario che da una illusione riconosciuta
ne consegua la conquista di una verità. Ovvero, come argomenta in un altro contesto
Guy Debord, il vero è un momento del falso90. Ancora meglio, per essere strettamente 88
I padri della sociologia continentale, nello svolgersi del proprio pensiero, non hanno potuto fare a meno di occuparsi di religione: Weber, M. (1905) L’etica protestante e lo spirito del capitalismo; Simmel, G.(1906) Die Religion; Durkheim, É. (1912) Le forme elementari della vita religiosa. Lo stesso Karl Marx, nella Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico (1884), accusando la religione di essere l’oppio dei popoli, non poteva ancora sapere che fonderà una nuova religione profana in cui di sacro si può rintracciare il valore come semplice-presenza, la classe messianica eletta dalla dialettica materialista della Storia, ecc.89
Nozick, R. (1974) Anarchia, stato, utopia90
Debord, G. (1967) La società dello spettacolo
61
logici, si può creare il mondo verso il quale gli enunciati acquistano senso in quanto la
verità o la falsità sono qualificazioni delle proposizioni sul mondo. Verità e falsità non
sono qualificazioni della Realtà, la Realtà non può essere né vera né falsa. La domanda
ora è la seguente: come è possibile creare un mondo?
Guardando a ritroso nella storia occidentale, i sofisti sono i primi teorici del
performativo e cultori dell'arte della
retorica. Arte poi abbandonata a
favore delle disciplinate grammatica
e dialettica scolastiche, ma ricordato
da Morris e da Austin91 che il dire è
anche un fare, a metà del Novecento
persino l'entimema torna splendido e
di moda nel Trattato dell'argomentazione (1958) di Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-
Tyteca. È un fatto che nella dimensione della comunicazione umana si cela, per noi, il
primo tautologico assioma degli Arcana imperii: È VERO CIÒ CHE SI CREDE, ed è
l’arcanum della «Fede».
È nel momento preciso in cui la narrazione viene creduta che, nel darsi autopoietico, il
Potere insuffla nel programma-incompleto quel dispostivo del logos che è il mythos e lo
rende subalterno. Di seguito dal sacrum nel mythos si dà per inflorescenza il cosmos sul
quale il Potere domina auto-legittimandosi. Per dare una definizione deontologica di
sacrum, il concetto di «regola costitutiva» avanzato da Rawls92 e reso paradigmatico da
Searle93 è il più calzante. La regola costitutiva è necessaria a ciò a cui verte, è il prius di
ciò che regola, per contro ciò a cui verte è tale e non altro perché quella regola lo
definisce. La «regola regolativa» invece disciplina ciò a cui verte e ciò a cui verte ha
una indipendenza ontologica dalla regola regolativa. Facendo un esempio calcistico le
cosiddette regole tattiche sono regole regolative dello svolgimento del gioco, sono
regole nel calcio. Il loro errato adempimento non porta conseguenze al calcio come
praxis. Se invece al posto delle porte metto dei canestri da basket allora il calcio in 91
Austin, J. L. (1962) How to do things with words92
Rawls J. (1955) Two concepts of rule93
Searle, J. R. (1995) La costruzione della realtà sociale
62
Pino Procopio, Naufragio
quanto tale smetterebbe di darsi perché violato in una delle sue regole costitutive e, ipso
facto, la practice che sto ponendo in essere non è espressione della praxis del calcio. Il
sacrum è appunto il corpus delle regole costitutive la cui violazione comporta il collasso
del gioco come tale.
L'anomia in questo senso, come Durkeim rileva ne Il
suicidio (1897), può portare all'auto-distruzione come
reazione. L'improvvisa dissoluzione del paradigma
precede la consapevolezza del del gioco-del-Potere
come Cosmos dominato dal Potere. Il corpo si trova a
reggere la pesantezza del Nulla – l'insensato e
l'insignificante – e il Potere – la Potenza arbitraria
occultante il Nulla – senza mai esserne mai stato a contatto prima. Il già citato in
precedenza Amedeo Giovanni Conte espone una ulteriore classificazione delle regole
costitutive in cui queste sono, pongono o presuppongono una condizione e sono
necessarie, sufficienti o necessarie e sufficienti al regolato. Quello di Conte è senza
dubbio un risultato imponente e la teoria della costitutività della sua scuola ha ben pochi
rivali. La classificazione delle regole costitutive sintetizzata dal suo allievo Giampaolo
Azzoni94 è la seguente:
i) regole che sono condizioni necessarie a ciò a cui esse vertono, «eidetico-costitutive»
La situazione di gioco in cui il re non può essere sottratto allo scacco con nessuna mossa è uno
scacco matto nel gioco degli scacchi
ii) regole che pongono condizioni necessarie a ciò cui esse vertono, «anankastico-costitutive»
Il testamento olografo deve essere sottoscritto di mano del testatore
iii) regole che presuppongono condizioni necessarie a ciò a cui esse vertono, «anankastiche»
Per visualizzare il documento bisogna aver installato Adobe Reader ®
iv) regole che sono condizioni sufficienti a ciò a cui esse vertono, «thetico-costitutive»
94 Azzoni, G. (1988) Il concetto di condizione nella tipologia delle regole
63
La regola X è abrogata
v) regole che pongono condizioni sufficienti a ciò a cui esse vertono, «metathetico-costitutive»
È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica
vi) regole che presuppongono condizioni sufficienti a ciò a cui esse vertono, «metathetiche»
Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi
professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti
commerciali
vii) regole che sono condizioni necessarie e sufficienti a ciò a cui esse vertono, «noetico-costitutive»
La norma fondamentale di un ordinamento, se concepita come condizione necessaria e sufficiente
della possibilità di validità delle norme dell’ordinamento da essa individuato
viii) regole che pongono condizioni necessarie e sufficienti a ciò a cui esse vertono, «nomico-
costitutive»
Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell’atto della nascita, oppure con un’apposita
dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o
davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di
questo
ix) regole che presuppongono condizioni necessarie e sufficienti a ciò a cui esse vertono, «nomiche»
L'essere iscritto a un albo professionale per l'abilitazione all’assistenza tecnica come descritto nella
regola metathetica
La regola eidetico-costitutiva viene proposta da Conte in Regola costitutiva in
Wittgenstein nel 1981. L'autore spiega che le regole eidetico-costitutive sono quelle
regole la cui costitutività consiste nell’essere condizione necessaria di pensabilità, e
perciò di possibilità, di ciò su cui esse vertono. Caso esemplare di regole eidetico-
costitutive sono, sulla scia di Wittgenstein, le regole del gioco degli scacchi: tali regole
non vertono su una attività ad esse pre-esistente e da esse indipendente, bensì sono le
regole stesse a rendere pensabile e possibile il gioco. Nel caso di una regola eidetico-
costitutiva, Conte dice esplicitamente che la trasgressione di una tale regola è essa stessa
64
impossibile.
Le regole eidetico-costitutive sarebbero costitutive del gioco nel senso che esse
costituiscono la praxis del gioco: riprendendo dei passi di Wittgenstein Conte afferma
che il gioco degli scacchi [...] è il gioco che è in virtù di tutte le sue regole e chi giochi
secondo altre regole che le regole degli scacchi, [...] non è che giochi male [...];
semplicemente, egli gioca un altro gioco. Praxema è, nel linguaggio di Conte, la unità
d’una praxis costituita da regole eidetico-costitutive e sta al pragmema come il type sta
al token.
Conte sviluppa una ulteriore specificazione delle regole eidetico-costitutive in ontiche e
deontiche. Entrambe sono accomunate dall’essere la condizione necessaria di
pensabilità e di possibilità di ciò a cui esse vertono. La regola eidetico-costitutiva ontica
è, a detta di Conte, il tipo ideale di constitutive rule searliana, ma tale regola non ha la
natura della regola ed è un oxýmoron, una contraddizione in termini. Le regole eidetico-
costitutive deontiche sono costitutive del type e la difformità dalle regole è destitutiva
del token.
Le regole eidetico-costitutive deontiche sono tali che una deviazione [«afwijking»] da esse è (come
scrive William van Belle, Taal, kode, subject, 1977) “una deviazione dalla realtà stessa” [“een
afwijking van der realitet zelf”]95 .
Le regole eidetico-costitutive (deontiche) sono ulteriormente suddivise da Conte in
«regole paradigmatiche» e «regole sintagmatiche». Quelle paradigmatiche regolano le
forme d’azione, determinano la forma delle possibilità del gioco. Negli scacchi una
regola eidetico-costitutiva (deontica) pre-scrive la forma stessa del movimento: l’alfiere
deve muoversi in diagonale. Le regole sintagmatiche, invece pre-scrivono una
determinata prosecuzione del gioco: per esempio in caso di scacco il re deve essere
sottratto allo scacco. Tra le possibilità del corso d'azione nella configurazione
contingente del gioco sono condizionato ad un unico corso d'azioni: evitare lo scacco.
Le regole sintagmatiche non descrivono l’azione ma regolano il corso d'azione per come
si deve dare necessariamente per obbligatorietà deontica. Conte spiega che la medesima 95
Gargani, A. G. et al. (1983) Wittgenstein: momenti di una critica del sapere
65
azione può darsi in ottemperanza sia della regola paradigmatica e sintagmatica allo
stesso tempo, cita quale esempio di questo fenomeno il caso del giocatore sotto scacco
che sottrae il re allo scacco spostandolo di una casa: la regola per cui il re deve essere
sottratto allo scacco è una regola sintagmatica, mentre la regola per cui il re si deve
spostare esattamente di una casa è paradigmatica (ad eccezione del caso
dell'arroccamento).
Le regole eidetico-costitutive sintagmatiche, per così come descritte, non sono regole
costitutive, ma sono regole che pre-scrivono determinati corsi d'azione a un gioco già
altrimenti nell'ordine del pensabile. Sono regole che pongono necessità a ciò a cui
vertono, sono cioè regole anankastico-costitutive. La pensabilità del gioco rimane intatta
sebbene il re non fosse sottratto allo scacco obbligatoriamente, di fatto la regola
proposta disciplina ciò che già ha un corso d'azione instradandolo verso una traiettoria
pre-stabilita. D'accordo, non togliere il re dall'imminenza dello scacco matto ceteris
paribus non è giocare a scacchi, ma esaminando il caso concreto in cui un giocatore non
muova in modo da evitare lo scacco matto trasgredendo alla regola, non si è dato nulla
in più che non sia già stato reso pensabile da altre regole.
L'impensabilità del gioco degli scacchi sussiste qualora non fossero sostenuti dalle
regole eidetico-costitutive i type dello spazio di gioco, dei vari pezzi, delle possibilità
dei pezzi, dell'ordine degli stessi al principio del gioco, degli eventi che scatenano i
pezzi date le loro combinazioni nello spazio di gioco. Il resto delle regole sono sì regole
costitutive, ma regolative del gioco degli scacchi già reso pensabile; sono regole, cioè,
che disciplinano un gioco già nell'ordine del poter essere posto in essere.
Di nuovo, la regola eidetico-costitutiva è garante della pensabilità del gioco – è l'eîdos,
il type del praxema – oltre ad essere costitutiva del gioco come tale. Nel caso del calcio,
se il pallone ha interamente superato la linea di porta tra i pali e sotto la traversa (p.
105) nel calcio non si dà il caso che non sia una rete. È impossibile che quello non sia
un goal date le condizioni poste dalla regola, ma allo stesso tempo il goal è pensabile
solo per la regola che lo descrive. A me pare che la regola stia al fulmine come il goal
sta al tuono, sono due aspetti della stessa realtà. L'uno in mancanza dell'altro non può
darsi, si sono necessari e sufficienti circolarmente. È questione di interpretazione, certo,
66
ma mi pare che la regola eidetico-costitutiva divenga noetico-costitutiva qualora sia
regola eidetico-costitutiva di un gioco già posto in essere, sia lo status della regola
eidetico-costitutiva lorsque les jeux sont faits.
Ciò che una regola eidetico-costitutiva fa – performs – è l'aggiungere un oggetto o un
evento nel Mondo altrimenti non esistente. E lo fa in modo molto semplice,
nominandolo, assegnando un nome ad un fenomeno. Il performativo, l'atto linguistico
della pragmatica austiniana, deriva da performance, parola introdotta nell'italiano dalla
letteratura inglese e utilizzata per designare normalmente la prestazione in termini di
resa economica. Sostantivo del verbo to perform – che possiamo tradurre come portare
a compimento, mettere in scena o fare e può essere sia transitivo che intransitivo –,
performance, guardandola con attenzione, ha dentro di sé la parola form, la stessa radice
da cui deriva la parola information. La parola inglese performance deriva a sua volta dal
francese antico parfornir – portare a compimento – che nulla ha che spartire con forme,
ma nonostante questo è evidente che la regola eidetico-costitutiva come performativo ha
dato al Mondo – ha portato a compimento – l'informazione del 'goal' ed è ex ante il
senso e il significato del goal che descrive. Bene, ora che conosco il type del 'goal' posso
giudicare proposizioni aletiche sul goal e sentenziare FALSO se qualcuno asserisce che
l'evento del pallone che non ha superato la linea di porta è un goal. Soprattutto ora sono
testimone di un evento che per me ha un significato, lo qualifico come goal nel contesto
del gioco del calcio.
Una regola eidetico-costitutiva è a tutti gli effetti il contenuto di un performativo allo
stesso tempo poietico, ostensivo e deontico: mostra ciò che crea nominandolo e di
seguito dà carattere di obbligatorietà al suo creato. Se ad personam coinvolge la mia
conoscenza del Mondo, ad systema sostiene il mondo-istituzionale a cui si riferisce. È
un caso in cui, ribaltando la formula, è il mezzo a giustificare il fine. Prendiamo ad
esempio il primo articolo della nostra Costituzione, il pronunciamento l'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro96. Nella formula con cui è enunciato
l'articolo, non si direbbe che sia una regola; non c'è il modale dovere. È sottinteso
dall'«articolo zero» che deve darsi un gioco nel Mondo che si chiama Italia e questa –
96 Costituzione della Repubblica, accessibile all'URL http://goo.gl/uUJGC.
67
articolo 1 – deve avere la forma ludens di Repubblica democratica. Nella Costituzione
l'articolo 83 pre-scrive che il Presidente della Repubblica è [deve essere] eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri. In questo caso siamo di fronte ad una
regola anankstico-costitutiva – regola che pone una condizione necessaria – e la regola
eidetico-costitutiva per la quale in Italia deve esserci un Presidente della Repubblica la
Costituzione la omette97. È così necessario che si debba dare quel ruolo? Non lo è. È
possibilità nel gioco-del-Mondo. Le regole eidetico-costitutive spesso sono utterance
deontiche sebbene la loro forma linguistica non lo renda noto – viene usata la copula è
ad esempio – oppure tali regole vengono direttamente omesse98. Il fatto è che né l'Italia
né il suo Presidente sono enti mondani e non si darebbero al Mondo senza che qualcuno
li ponga in essere e senza che qualcuno li faccia esistere credendoci. O come spiega
Searle non sono «fatti bruti», non sono fatti del Mondo indipendenti dall'osservatore. Da
qui sorge la necessità di una «ontologia sociale» per tutti quei fenomeni, «fatti
istituzionali», che non si darebbero se non fossimo giocatori del gioco sociale.
Quando sono da solo nella mia stanza, quella stanza contiene almeno i seguenti oggetti sociali: un
cittadino degli Stati Uniti, un impiegato dello Stato della California, un guidatore patentato e un
contribuente. Dunque, com'è possibile che vi siano così tanti oggetti nella stanza? Ve n'è
esattamente uno: io99.
La formula searliana della «funzione di status» è X count as Y in C. Il termine X è un
fatto bruto, un evento o una cosa indipendente dall'osservatore; Y è un fatto istituzionale
97 La «regola 0» è sempre eidetico-costitutiva ed è la posa auto-referenziale nel Mondo del gioco come
praxis: deve darsi un gioco nel mondo che si chiama Scacchi. La stesso vale dunque per la Costituzione italiana la cui regola 0 è deve darsi un gioco nel Mondo che si chiama Italia. 98
È possibile linguisticamente introdurre una eidetico-costitutiva in una anankastico-costitutiva. Nel regolamento del Giuoco del Calcio la regola anankastico-costitutiva il pallone deve essere sferico, che pone una condizione necessaria, in primis il pallone [da calcio] deve essere [nel calcio]. Nello stesso momento in cui dico che il pallone deve essere sferico dico che il pallone deve essere e creo il type 'pallone da calcio'. Ricordando la distinzione tra paradigmatico e sintagmatico proposta da Conte, le regole possono vertere ai tre tipi di enti mondani. Quando una regola mi obbliga a dover salvare il re dall'imminenza dello scacco matto, si riferisce all'evento 'scacco' e all'oggetto 're', ma regola il gioco nel suo corso d'azione, nel suo divenire. Tanto che oserei dire che tutte le regole che non si riferiscono al gioco in quanto praxis sono eidetico-costitutive. 99
Searle, J. R. (2003) John Searle reply to Barry Smith
68
dipendente dall'osservatore; C è il gioco in cui la funzione di status ha validità deontica.
Quel count as viene reso in italiano alla lettera con conta come, ma possiamo renderlo
con altre due formule linguistiche perspicue: fa da, rappresenta [performs as] o con
deve essere [has to be]. Chiaro che sia la stessa formula sottesa alla pre-scrizione dei
giochi nelle regole eidetico-costitutive: la situazione di gioco in cui il re non può essere
sottratto allo scacco con nessuna mossa [X] è [fa da, deve essere] uno scacco matto nel
[in] gioco degli scacchi [C]. Soprattutto è la stessa formula sottesa al processo
semiotico per cui assegno il segno 'albero' [Y], il significante, all'oggetto mondano [X],
il referente. Quando leggo o qualcuno mi dice 'albero', tale segno è un significante e
significa – rende segno, si riferisce a – tale oggetto mondano. Il segno 'albero' fa da
oggetto albero nella mia mappa-del-Mondo [C] per giocare con l'Altro al mio gioco-
del-soggetto. D'accordo con Alfred Korzybski che la mappa non sia il territorio, però
ora non posso certo dire che la mappa non sia il mio territorio. Così sorge spontanea la
domanda: viene prima la parola o la funzione di status?
Se effettivamente esiste un «performativo poietico» e questo si esprime con le regole
eidetico-costititive, si svela con esse un uso del verbo dovere che non è né «buletico» e
né «axiotico». Nelle Ricerche logiche (1900) Husserl individua del verbo sollen,
dovere, due possibili significati. Se dico che il lettore deve leggere quanto scrivo, l'uso
del verbo dovere esprime la mia volontà, in greco boúlesis: io voglio che il lettore legga
quanto scrivo. È quindi un dovere buletico. Se invece dico che un lettore attento deve
essere interessato, non sono io che voglio che un lettore attento legga interessato. In
questo caso l'uso di dovere pone una condizione necessaria per come un qualcosa – il
lettore attento – sia – interessato. L'uso del dovere axiotico è perciò passibile di analisi
logica e può essere reso da una implicazione – se il lettore è attento allora il lettore è
interessato. L'uso di dovere della regola eidetico-costitutiva non è né un dovere buletico
– non sono io che voglio che X sia Y in C –, né axiotico – X non è una condizione
necessaria di Y, lo deve essere. Si tratta, per me che obbedisco, di una forma particolare
di dovere, il «dovere eidetico»100.
D'altra parte è al contempo vero che se io ho l'obbligo di immaginare, dal versante
100 Di Lucia, P. (2003) (a cura di) Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive
69
opposto un qualcun altro ha voluto che io lo faccia. Non si è dato da sé che abbia
iniziato ad immaginare una cosa che non è così e mi devo rappresentare la sua forma.
L'attore pone la maschera sul suo viso e mi spiega ora io [X] sono [count as, faccio da,
devo essere] la maschera [Y] (nel nostro gioco [C]) e tu devi [io voglio che tu inizi a]
credere che io sia la maschera in modo che il gioco sia. Il count as della funzione di
status è in fin dei conti anche un dovere buletico in cui manca il soggetto emittente, è un
si impersonale che vuole.
La voce del si è il veicolo prediletto dell'imperio di un demiurgo, celato dal suo stesso
gioco, che plasma dai fatti bruti un mondo-come-se. Presiedere all’amministrazione del
«campo negoziale continuo» della verità, è diventare un si dal quale porre il gioco-
sociale, uno di quei giochi in cui il dovere eidetico viene espresso con la necessità del
dover-esser-così perché così è. Parimenti, svela il carattere di risorsa della verità – come
limitata nella quantità vel nell'accessibilità e oggetto del desiderio – così la verità stessa
si appiattisce nella dimensione delle risorse. Se mi chiedo se il goal sia, se Presidente
della Repubblica sia, se il denaro sia o se qualsiasi altro fatto istituzionale imposto in
questo momento sia, e rispondo FALSO sto commettendo un errore logico. I fatti
istituzionali sono. Sono, per il teorema di Thomas, VERI nelle loro conseguenze.
Searle ipotizza una determinante della realtà istituzionale nella «intenzionalità
collettiva». Non bastano le regole costitutive e la funzione di status per organizzare i
rapporti sociali, per renderle efficaci. Ma una intenzionalità collettiva accanto ad un
individualismo metodologico è una nota dissonante, non ha cittadinanza nella civitatem
luporum. L'intento di Searle d'altronde è quello di descrivere la realtà sociale
naturalisticamente, come diretta conseguenza di fatti fisici e chimici.
L'intenzionalità collettiva è un fenomeno biologicamente primitivo che non può essere ridotto o
eliminato in favore di qualcos'altro. Ogni tentativo che abbia visto di ridurre l'«intenzionalità del
noi» all'«intenzionalità dell'io» è soggetto a controesempi101.
101 Searle, J. R. (1995) La costruzione della realtà sociale
70















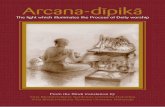





![Le monastère des Saints-Boniface-et-Alexis sur l'Aventin et l’expansion du christianisme dans le cadre de la 'Renovatio Imperii Romanorum' d’Otton III [1990]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313afb03ed465f0570ac9b6/le-monastere-des-saints-boniface-et-alexis-sur-laventin-et-lexpansion-du-christianisme.jpg)











