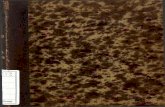USAI A., COSSU T., DETTORI F. 2009, Primi dati di scavo sul nuraghe Nuracale di Scano Montiferro, in...
-
Upload
archeocaor -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of USAI A., COSSU T., DETTORI F. 2009, Primi dati di scavo sul nuraghe Nuracale di Scano Montiferro, in...
1
PRIMI DATI DI SCAVO SUL NURAGHE NURACALE DI SCANO MONTIFERRO*
Alessandro Usai, Tatiana Cossu, Federica Dettori
Testo autografo
1. Nonostante le numerose notizie presenti nella letteratura scientifica, concernenti diversi monu-menti nuragici del territorio di Scano Montiferro1, finora nessuno di essi era stato indagato con rigo-rosi criteri stratigrafici al fine di ricostruirne le vicende, né alcuno era stato interessato da un proget-to di valorizzazione destinato alla pubblica fruizione.
L’avvio dei lavori di scavo, consolidamento e valorizzazione del grande complesso di Nuracale2 segna l’apertura di un fronte assai impegnativo per il Comune e per la Soprintendenza Archeologi-ca, che hanno concordemente impostato un programma integrato, mirato non solo all’acquisizione dei dati scientifici e storici concernenti la principale emergenza archeologica del territorio scanese ma anche a incentivarne lo sviluppo culturale ed economico. Anzi, il progetto non si limita al pur maestoso monumento nuragico e ai resti del grande insediamento che lo circonda, ma si dilata sino ai confini del grande parco archeologico-ambientale creato intorno ad essi.
Preceduto da altri monumenti più arcaici a corridoio o a camera embrionale, che però non man-tennero a lungo un ruolo dominante nel territorio, Nuracale venne eretto poco più tardi in una fase di vera e propria esplosione del tessuto insediativo, che appare precocemente organizzato in forme gerarchiche. I resti dei nuraghi semplici e complessi, degli insediamenti e delle tombe megalitiche testimoniano l’occupazione capillare del pianoro di Sennariolo e Scano Montiferro, delimitato a Nord dalla gola del Riu Mannu e in ascesa verso Est con quote comprese tra 200 e 500 metri slm3 (fig. 1). Come molti altri grandi nuraghi, è molto probabile che Nuracale abbia funzionato per alcu-ni secoli (apparentemente dalla fase tarda del Bronzo Medio a un momento ancora indeterminato del Bronzo Finale o della Prima Età del Ferro, cioè pressappoco dal XIV al X-IX sec. a. C.) come centro di coordinamento delle attività economiche svolte, sotto il controllo di uno o più gruppi fami-liari egemoni, nell’ambito di un organismo tribale policentrico articolato in diversi insediamenti e abitato da alcune centinaia di persone; ma esso costituì certamente un punto di riferimento di prima-ria importanza anche per le comunità sarde prima punicizzate e poi romanizzate che continuarono a vivere in quella zona secondo uno schema di popolamento sparso almeno fino a tutto l’Alto Medio-evo.
Nonostante le manomissioni, la vegetazione e i grandi accumuli di materiale di crollo depositati-si all’esterno e in tutti i vani interni, ancor prima dell’inizio degli scavi il nuraghe Nuracale non na-scondeva gli elementi essenziali della sua poderosa struttura complessa4 (fig. 2). Infatti erano rico-noscibili i ruderi della torre centrale (A) e del grande bastione quadrilatero con ampio cortile all’interno (B), delimitato da quattro cortine murarie rettilinee e provvisto di altrettante torri secon-darie disposte agli angoli (C, D, E, F); inoltre erano visibili a tratti i resti di numerosi edifici appar-tenenti all’insediamento disteso intorno al monumento principale, in parte sulla superficie pianeg-giante ad esso adiacente e in parte sul versante della vallata del Riu Mannu. * Testo rielaborato da A. USAI – T. COSSU – F. DETTORI, Primi dati sul contesto tardoromano e altomedievale dal nu-
raghe Nuracale di Scano di Montiferro, in Oristano e il suo territorio dalle origini alla quarta provincia, in stampa. 1 A. USAI, La ricerca archeologica di Pietro Pes: dal 1954 al 2008 (pp. XV-XXIII in questo volume). 2 Le prime tre campagne di scavo hanno avuto luogo nel 2003 (maggio - dicembre), nel 2005 (agosto - novembre) e
nel 2006 (giugno - agosto). Progettazione e direzione dei lavori a cura dell’arch. Gabriele Manca con la collabora-zione dell’arch. Donatella De Rinaldis; direzione scientifica di Alessandro Usai con l’assistenza di Tatiana Cossu (2003, 2005) e Mauro Perra (2006) e con la collaborazione di Federica Dettori, Maria Antonietta Obinu e Giuseppe Pes. Alla campagna 2006 hanno collaborato anche il prof. Robert H. Tykot e gli studenti dell’università di Tampa (USA). I lavori sono stati finanziati dal Comune di Scano Montiferro e dalla Provincia di Oristano. Oltre al testo ci-tato a nota *, una prima notizia di scavo in A. USAI - T. COSSU - F. DETTORI - G. MANCA, Nuracale. I primi scavi, Scano di Montiferro 2006.
3 A. USAI, Cenni sul Montiferru e la Planargia meridionale in età nuragica (pp. 263-296 in questo volume). 4 Si veda in questo volume la scheda redatta da Pietro Pes (pp. 45-47, fig. 7:1, tavv. XVI-XVII); inoltre G. LILLIU, Il
nuraghe di Barumini e la stratigrafia nuragica, in “Studi Sardi”, XII-XIII, 1952-54, p. 175 e passim, fig. 6:2.
2
Con la rimozione di alcune centinaia di metri cubi di blocchi basaltici, pietrame di crollo e terric-cio d’infiltrazione, sono emerse le strutture prima occultate (figg. 2-3; appendice 1: figg. 22-23). È stata completamente liberata e indagata la camera superiore della torre centrale (A2), le cui pareti si conservano per un’altezza di circa m 4,50; è stata messa in evidenza la rampa della scala che colle-gava l’andito della camera superiore con la sommità della torre centrale dove poteva forse trovare posto una terza camera non conservata; il vastissimo cortile (B), che con una superficie superiore ai 90 mq. occupa tutto lo spazio compreso tra le cortine Est e Sud e la torre centrale, è stato liberato fino a una quota leggermente inferiore agli architravi degli accessi alle camere A1, C, D e E; è stato riaperto l’ingresso principale nella cortina Est (L); è stato completamente indagato il piccolo silo (G) ricavato nella muratura compresa tra la torre centrale A e la torre F; è stata liberata dai crolli la scala (H) ottenuta nello spessore della cortina Ovest, destinata a consentire il passaggio dal cortile B al vano G e alla camera della torre F tramite un ambientino sopraelevato e mal conservato (I). Re-stano ancora inaccessibili la camera inferiore della torre centrale (A1) e la relativa rampa di colle-gamento con la camera superiore (A2); l’ispezione del vano (A1) a fini di verifica statica ha rivelato una struttura di sapore piuttosto arcaico con alto andito a sezione angolare apparentemente privo di garitta, con due sole nicchie ai lati della camera e col finestrone sopraelevato della scala adiacente all’apertura della nicchia destra. La scala mostra una curiosa struttura mista, in qualche modo spe-rimentale e tendente a forme architettoniche più evolute: inizia come scala di camera e prosegue ol-tre il pianerottolo della camera superiore come scala d’andito, tuttavia sempre molto ripida come nel tratto inferiore. Al momento non è chiaro se il nuraghe sia sorto tutto insieme da un coraggioso e articolato progetto unitario, o se il corpo quadrilobato si sia sviluppato successivamente addossan-dosi a un’originaria torre isolata.
Un contesto materiale nuragico indisturbato è stato recuperato solo nei livelli inferiori del silo G; invece nella camera A2 gli strati di occupazione nuragica sono stati seriamente compromessi dall’intensa occupazione tardoromana e altomedievale in condizioni di evidente integrità strutturale, a partire dai battuti direttamente sovrapposti al piano lapideo di base, prima della formazione del più basso strato di crollo. Nel cortile B è stato ordinatamente rimosso un accumulo di conci in are-naria formatosi nella parte sud-occidentale, derivante dal crollo o forse anche dall’intenzionale de-molizione di una struttura nuragica isodoma d’incerta natura e funzione, che forse era collocata nel-la parte superiore della torre E; quindi lo scavo è proseguito con l’esplorazione estensiva degli strati altomedievali. In particolare, nella campagna 2005 è stato possibile identificare alcuni muretti alto-medievali con una sola faccia a vista, composti con mensoloni e con blocchetti squadrati dei para-menti sommitali, aventi lo scopo di contenere gli accumuli di crollo già presenti nell’ampio spazio aperto e consentire l’accesso alle diverse camere senza un più impegnativo intervento di sgombero.
Nel 2006 lo scavo è stato esteso al settore antistante la cortina orientale del bastione quadrilobato (fig. 2; appendice 1: fig. 23); in tal modo si è reso più agevole l’accesso al monumento e si è posto in luce un ampio cortile esterno (M). Questo è delimitato a Sud-est da un possente muraglione arcu-ato, e a Nord-est da due edifici nuragici preesistenti di pianta circolare (N, O), ciascuno dei quali provvisto di ingresso rivolto a Sud. In tutta l’area è stato posto in luce il piano di calpestio della fase altomedievale, durante la quale furono profondamente alterati i depositi e gli edifici nuragici, come testimoniano alcuni mensoloni provenienti dalle parti sommitali del nuraghe, poggiati sul suolo in attesa di reimpiego nelle nuove strutture. Probabilmente in questo periodo vennero occlusi gli in-gressi degli edifici N e O; inoltre il secondo presenta una breccia nell’originario muro di delimita-zione occidentale, che venne sostituito da un muretto costruito con piccoli conci nuragici di reim-piego.
Gli edifici altomedievali (P, Q, R, S, T, U) sfruttano in parte le strutture nuragiche, sovrapponen-dosi o addossandosi ad esse o anche semplicemente reimpiegando il materiale lapideo disponibile (fig. 2; appendice 1: fig. 23); le strutture altomedievali poste in luce sul lato nord-orientale del corti-le esterno, a valle dei roccioni che costituiscono la base degli edifici nuragici N e O, sono in cattivo stato di conservazione a causa della pendenza del suolo. In quest’area (vano S) è stato rinvenuto un piccolo dolio coperto da una lastrina di pietra, conservatosi integro tra gli spuntoni di roccia; nella
3
stessa area (vano T), al di sotto delle strutture e degli strati altomedievali, è stato individuato un fo-colare nuragico con abbondante ceramica e semi carbonizzati di farro.
I paragrafi successivi illustrano i risultati più significativi conseguiti con la campagna di scavo 2003 nella camera A2 e nel cortile B, con particolare riferimento ai documenti del riutilizzo tardo-romano e altomedievale. (A. Usai) 2. Le indagini di scavo hanno consentito di ricostruire le ultime fasi di frequentazione del vano su-periore della torre centrale (A2) fino al suo abbandono e al crollo di parte della struttura (fig. 3).
In età tardoromana l’ambiente fu riutilizzato rimovendo e asportando parzialmente le tracce dell’ultima frequentazione di età nuragica, di cui residuano, oltre a numerosi frammenti di ciotole carenate (fig. 4:3), parti di uno ziretto con anse a X (fig. 4:5-6) adoperato per la conservazione di derrate alimentari (granaglie?), e un’ansa a gomito rovescio decorata con punti impressi appartenen-te probabilmente a un vaso a collo alto, una tipologia funzionale a contenere liquidi. Questi reperti, che possono essere inquadrati nel Bronzo Finale o nella Prima Età del Ferro, sono stati rinvenuti di-spersi per tutto il vano in associazione stratigrafica (US 85) con le ceramiche di età storica (fig. 4:1-2,4).
Alla fase tardoromana risalgono vari frammenti di recipienti da fuoco in ceramica d’impasto. Si tratta di casseruole o pentole con due o quattro prese applicate poco al di sotto dell’orlo, lavorate probabilmente a tornio lento (fig. 4:1-2). Sebbene la loro fattura faccia pensare ad una lavorazione a mano, in realtà, come appurato anche dall’esame di materiali simili rinvenuti nell’area cimiteriale di Cornus e in varie località dell’alto oristanese, dovette essere usato un qualche tornio rudimentale ol-tre all’ausilio della stecca o brunitoio per lisciare le pareti, fatto che potrebbe spiegare la standardiz-zazione di queste forme ceramiche nel Mediterraneo occidentale5.
In particolare una pentola (fig. 4:1) è stata trovata in frammenti, ma quasi completa, presso l’ingresso del vano A2, sul lato sinistro per chi entra: ha l’orlo ingrossato (diam. cm 18/19) e appli-cate poco al di sotto quattro prese orizzontali ad arco di cerchio; il fondo (diam. cm 15,8), origina-riamente piano, è deformato per l’esposizione diretta al fuoco; le superfici sono prive di lucidatura, quelle interne regolarizzate e lisciate mediante l’uso di una stecca; l’impasto, con inclusi medio-piccoli, è di colore marrone nerastro, tendenzialmente più scuro nella parte mediana, forse a causa di una cottura del vaso a temperature non elevate. Questo tipo di recipiente, che si ritrova in vari contesti isolani, dall’insediamento di Santa Filitica di Sorso6, alla necropoli tardoromana di Scoglio Lungo e al centro urbano di Portotorres7, al nuraghe Losa di Abbasanta8, al vano A del nuraghe Co-bulas di Milis9, fino all’area cimiteriale di Cornus10, appartiene a quell’insieme variegato di forme ceramiche genericamente definito “ceramica grezza” o “ceramica grezza modellata”, corrispondente alla céramique modelée
di F. Villedieu11. 5 Cfr. M. G. FICHERA - M. L. MANCINELLI, Ceramica da cucina e da fuoco, in A. M. GIUNTELLA, Cornus I, 2. L’area
cimiteriale orientale. I materiali, Oristano 2000, p. 255; M. G. Fichera elenca manufatti simili in depositi del VI sec. d. C., diffusi nel Mediterraneo occidentale dall’Africa (Cartagine) alla Spagna sudorientale (El Monastir, El Sambo). G. BACCO, Il nuraghe Losa di Abbasanta. II. La produzione vascolare grezza di età tardoromana e altomedievale, in “Quaderni della Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano”, 13, 1997 – Supplemento, pp. 41-42.
6 D. ROVINA, Ceramiche di importazione e produzione locali dall’insediamento altomedievale di Santa Filitica (Sor-
so-Sassari), in L. SAGUÌ (a cura di), Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di John W. Ha-yes, Roma, 11-13 maggio 1995, Firenze 1998, pp. 787-796, fig. 3:1-8.
7 F. VILLEDIEU, Turris Libisonis. Fouille d’un site romain tardif à Porto Torres, Sardaigne, BAR I.S. 224, Oxford 1984, p. 164, figg. 198-199, tipo 36, in depositi del secondo quarto del V-VI secolo d. C. (forma ben rappresentata soprattutto nello strato VIA).
8 G. BACCO, Il nuraghe Losa di Abbasanta cit., p. 16, tav. XIII:3-7. 9 P. B. SERRA, Campidano maggiore di Oristano: ceramiche di produzione locale e d’importazione e altri materiali
d’uso nel periodo tardoromano e altomedievale, in “La ceramica racconta la storia”, Atti del I Convegno “La ce-ramica artistica, d’uso e da costruzione nell’Oristanese dal neolitico ai giorni nostri”, Oristano 1995, p. 190, tav. XII:2.
10 M. G. FICHERA - M. L. MANCINELLI, Ceramica da cucina e da fuoco cit., p. 255, tav. XLII. 11 F. VILLEDIEU, Turris Libisonis cit., pp. 155-156.
4
Presente in Sardegna soprattutto a partire dal IV sec. d.C., la ceramica grezza si diffonde nel V-VI sec. per perdurare anche oltre. Nell’alto oristanese è documentata in vari siti, dai nuraghi Losa di Abbasanta12, Sa Jacca di Busachi13, Bau Mendula di Villaurbana14, Santa Barbara di Bauladu15 e Santa Barbara di Villanovatruschedu16, all’area santuariale di San Lussorio di Fordongianus17, al contesto abitativo di Bonorchis di Sorradile18, al vano A e alla struttura 2 del nuraghe Cobulas di Milis19, oltre al già citato sito di Cornus, solo per indicare alcune delle località più note fra quelle edite. Nell’ampio insieme della ceramica grezza, G. Bacco ha distinto due gruppi fondamentali (gruppo A e gruppo B), in base a differenze di carattere tecnologico, chiaramente percepibili ad oc-chio nudo e al tatto20. Al gruppo B, cioè alla ceramica grezza semidepurata e tornita in modo rudi-mentale, sono attribuibili i reperti del vano A2, di cui alla fig. 4:1-221.
Nello stesso strato del vano A2 del nuraghe Nuracale (US 85) sono stati trovati, in associazione con la ceramica grezza modellata, i frammenti di un’anforetta tornita (diam. orlo cm 10,8) con cor-po rigonfio, in argilla abbastanza depurata; il collo e la spalla sono decorati delicatamente da sottili e fitte steccature verticali interrotte sul corpo del vaso da una decorazione a brevi impressioni che può essere stata ottenuta imprimendo una estremità della stessa stecca (fig. 4:4). L’anforetta, che ha le pareti sottili e il fondo umbonato22, risale alla fase tardoromana, ed è forse assimilabile a produ-zioni in ceramica comune, quali le brocche steccate di tipo campidanese rinvenute nella necropoli di Pill’ ‘e Matta di Quartucciu in contesti tombali del IV/V secolo d. C..23 È possibile che anche i tre piccoli vaghi di collana, uno in ambra e due in pasta vitrea blu, aventi un diametro di mm 8 e uno spessore di mm 4, siano riconducibili a questa stessa fase storica.
Dopo un periodo di abbandono del vano, segnato da uno strato quasi del tutto sterile (US 84), si ebbe il crollo della volta a tholos, che formò quasi un letto di pietre. Lo strato sovrastante (US 61) ha restituito alcuni reperti di epoche differenti.
A ridosso della parete, presso l’ingresso del vano, sulla sinistra per chi entra, erano collocati i frammenti di un recipiente cilindroide (fig. 5:1) in ceramica grezza probabilmente lavorata a mano, con tre o forse quattro piccole prese impostate all’orlo (diam. cm 13), le pareti lievemente convesse e il fondo piano; l’impasto è duro, con piccoli inclusi, di colore marroncino come le superfici; tipo-logicamente è confrontabile con le tazze in ceramica grezza del nuraghe Sa Jacca di Busachi24. Seb-bene non sia tornito, il nostro esemplare potrebbe rientrare nel Gruppo B della ceramica grezza per gli impasti parzialmente depurati o, comunque, con inclusi di granulometria uniforme.
Dallo stesso strato (US 61) provengono un probabile peso in ferro di g 300 (fig. 5:2)25, corri-spondente a 11 once romane (Deunx), cioè a poco meno di una libbra (12 once = 327 g), e alcuni frammenti di un piattello in maiolica policroma, risalente all’età rinascimentale (fig. 6).
Della forma incompleta di quest’ultimo, residua la calotta emisferica e il piede a disco concavo; l’argilla è ben depurata, dura e compatta, di colore avorio; lo smalto bianco coprente è suddipinto in 12 G. BACCO, Il nuraghe Losa di Abbasanta cit., pp. 9-21, tavv. IV-XXVIII. Per un quadro articolato sulla diffusione
della ceramica grezza nell’oristanese rimando a questa monografia di Ginetto Bacco, in cui si offre il primo studio approfondito sulla ceramica grezza in Sardegna, a lungo trascurata, quando non anche confusa con le produzioni protostoriche.
13 G. BACCO, Il nuraghe Losa di Abbasanta cit., pp. 21-32, tavv. XXXI-XLIX. 14 P. B. SERRA, Campidano maggiore di Oristano cit., pp. 184-187. 15 P. B. SERRA, Campidano maggiore di Oristano cit., pp. 178-180, tav. XVIII:5. 16 G. BACCO, Il nuraghe Losa di Abbasanta cit., pp. 32-35, tavv. LI-LIII. 17 P. B. SERRA, Campidano maggiore di Oristano cit., pp. 193-196, tav. XVIII:1-4,6. 18 G. BACCO, Il nuraghe Losa di Abbasanta cit., pp. 36-38, tav. XLII. 19 P. B. SERRA, Campidano maggiore di Oristano cit., pp. 190-191. 20 G. BACCO, Il nuraghe Losa di Abbasanta cit., pp. 40-42. 21 Il recipiente di fig. 4:2 è raffrontabile con esemplari rinvenuti a Portotorres (F. VILLEDIEU, Turris Libisonis cit., p.
165, fig. 189, tipo 31, appartenente a depositi del V-VI secolo d.C.) e a Santa Filitica (D. ROVINA, Ceramiche di im-
portazione e produzione locali cit., fig. 2:18). 22 Il fondo, insieme ad altri frammenti delle pareti e delle anse, è venuto alla luce nella campagna di scavo del 2005. 23 D. SALVI (a cura di), Luce sul tempo. La necropoli di Pill’ ‘e Matta, Quartucciu, Cagliari 2005. 24 G. BACCO, Il nuraghe Losa di Abbasanta cit., p. 27, tav. XXXVII:1-2. 25 Dimensioni: cm 5,5 x 5,3; alt. cm 3,1.
5
blu, giallo-ocra, arancio e giallo. Due linee concentriche blu separano il motivo centrale del piattello da quello della fascia esterna, bordata da due bande anch’esse concentriche, rispettivamente di colo-re giallo e di colore arancio (ne residuano pochissimi tratti); tutti i motivi decorativi, invece, sono in giallo-ocra. Nella fascia esterna del piatto vi è un motivo “a fiamme” o “a monticelli” alternati a tratteggi verticali scalati. Questa sintassi decorativa a raggi sfolgoranti è particolarmente diffusa in Umbria, Toscana ed Emilia e nelle fabbriche alto-laziali, a partire dalla seconda metà del XV fino al XVI secolo. Si tratta, infatti, di motivi secondari standardizzati che ripropongono il tema a raggiera solare che accompagna il simbolo cristologico di S. Bernardino da Siena26, rappresentato probabil-mente al centro del nostro piattello, dove la croce potenziata poggia sul monogramma IHS (Iesus
Hominum Salvator), del quale si conservano le prime due lettere27. Sigillava il vano superiore della torre centrale un secondo e ultimo crollo di pietre avvenuto in
età post-rinascimentale (US 59). (T. Cossu) 3. Del cortile sono stati indagati solo gli strati di crollo del monumento risalenti ad età storica (fig. 3). Anche in questo caso i reperti rinvenuti sembrano attestare una intensa frequentazione del sito di Nuracale in età tardoromana e altomedievale, tra il IV e il VI secolo.
Dagli strati di crollo più superficiali del cortile (US 49 e 64) provengono alcuni recipienti fram-mentari in ceramica grezza (fig. 7:1), che si differenziano decisamente da quelli rinvenuti nella ca-mera A2 per la lavorazione a mano piuttosto grossolana, per gli orli irregolari, le superfici nude, non lisciate, e gli impasti particolarmente sabbiosi con inclusi medio-grandi (anche superiori ai mm 5), per i fondi piani ma irregolari, plasmati separatamente dalle pareti e uniti ad esse con semplice pressione digitale, e soprattutto per la pesantezza complessiva dei recipienti28. Questo tipo di cera-mica, diffusa soprattutto nell’entroterra isolano, è ben documentato anche nell’alto oristanese ed è stato inserito da G. Bacco nel gruppo A della ceramica grezza29.
Sono stati rinvenuti anche numerosi frammenti di dolia con l’orlo decorato a tacche, aventi im-pasto duro e compatto di colore rossiccio chiaro, tendente talora al marroncino o al colore arancio, con numerosi inclusi di dimensioni piccole e medio-grandi (9 mm); le superfici regolarizzate con la spatola, un po’ ruvide all’esterno e lisce all’interno, sono di colore marroncino chiaro.
Sono presenti anche recipienti in ceramica da fuoco modellata a tornio lento, con impasti tenaci, molto duri e compatti, di colore rossiccio nella parte mediana, e marroncino verso le superfici, con
26 A. CORSINI, Vulci. Ceramiche dal “butto” della Torre, Progetti Museali Editore, s. l., 1995, p. 74, fig. a p. 75. Gli
stessi motivi decorativi della fascia esterna si riscontrano in piatti rinvenuti a Roma in una fossa del cortile del Pa-lazzo della Cancelleria, cfr. L. PEREGO, Palazzo della Cancelleria. Notizie preliminari sul rinvenimento di maioliche
rinascimentali di produzione romana da un contesto della metà del XVI secolo, in E. DE MINICIS (a cura di), Le ce-
ramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna, Atti del I Convegno di Studi (Roma 19-20 marzo 1993), Roma 1994, pp. 40-42, tav. II:2-3; in ceramiche di produzione padovana della prima metà sec. XVI, cfr. F. COZZA, Ceramiche dal Bacchiglione al museo di S. Martino della Vanezza di Cervarese S. Croce – Padova, Padova 1998, p. 44, fig. 37; in ceramiche della Toscana e dell’Emilia, cfr. G. GARDELLI, Ceramiche del Medioevo e del Rinascimen-
to, Belriguardo, Ferrara 1986, pp. 146-147, fig. 21, tav. IL (piatto, Borgo S. Sepolcro-Arezzo, seconda metà del sec. XV), pp. 180-181, tav. LXVI (Imola, fine sec. XV); sulla spalla di alcuni albarelli del XV secolo, di Deruta, cfr. C. FIOCCO - G. GHEPARDI, Ceramiche umbre dal Medioevo allo Storicismo, parte prima, Orvieto e Deruta, Faenza 1988, pp. 250-252, figg. 153-155; infine il motivo radiale circonda anche la crocifissione in rilievo di una targa di Deruta, risalente al sec. XVII, cfr. C. FIOCCO - G. GHEPARDI, Ceramiche umbre cit., pp. 142-143, fig. 94.
27 Sotto il monogramma bernardiniano del nostro piattello sono dipinti i tre chiodi della crocifissione di Cristo; si veda la ceramica smaltata policroma di importazione trovata nel palazzo della Ministreria dei Poveri di Novara (M. SUBBRUZIO, Dipinto di blu. Ceramiche policrome a Novara fra XVI e XVII secolo, in “Ceramica in blu. Diffusione e
utilizzazione della ceramica”, Atti XXXV Convegno Internazionale della ceramica, Centro Ligure per la storia della ceramica, Albisola 2002, pp. 154-155, figg. 26-28, 30-31).
28 L’esemplare di fig. 7:1, avente un’altezza di cm 12,7, le pareti concave e il diametro all’orlo uguale al diametro del fondo (cm 24), è formato da un impasto di colore marrone, duro, ma poco compatto, sabbioso, con grandi inclusi (fino a mm 7); lavorato malamente a mano, ha le superfici nude irregolari, quella interna marrone, ruvida, con inclu-si affioranti, quella esterna meno ruvida, con una colorazione nerastra nei due terzi superiori della parete fino all’orlo, irregolarmente appiattito.
29 G. BACCO, Il nuraghe Losa di Abbasanta cit., pp. 40-41.
6
inclusi anche grandi; le superfici sono marroncine o nocciola chiaro, a tratti di colore rosso-arancio, lisciate a stecca, quella interna in modo irregolare talora con inclusi affioranti, quella esterna più re-golare. Si tratta di casseruole, pentole e olle, con prese impostate poco al di sotto dell’orlo solita-mente ingrossato (figg. 7:6, 8:2-4). I confronti morfologici ci riportano ai già citati contesti tardo-romani di Portotorres, di S. Filitica di Sorso e del nuraghe Cobulas di Milis.
A questo insieme di reperti ceramici appartengono anche i coperchi, sempre piani, a disco, con presa centrale, talora decorati a cerchielli semplici impressi (figg. 7:5, 9)30, ben attestati a Turris Li-bisonis e al nuraghe Losa31. Non mancano infine frammenti di olle e pentole con listello interno per la posa del coperchio (fig. 8:1,5)32, assimilabili per gli impasti e il trattamento delle superfici agli esemplari rinvenuti nel vano A2 (fig. 4:1-2).
Sono stati rinvenuti anche frammenti di brocchette costolate, nonchè numerose pareti e alcuni puntali sagomati di anfore da trasporto di produzione tardoafricana del tipo Keay LXII (fig. 7:3-4), della fine del V-VI secolo d.C.33, e del tipo Keay XIX (fig. 7:2), prodotto dalla fine del III fino alla metà del V secolo d.C34.
Di grande interesse il rinvenimento dei frammenti di due piatti in sigillata africana chiara D (forme Hayes 103 e 104), uno dei quali reca stampigliati sul fondo due cupidi che camminano verso destra con il braccio destro sollevato e forse con un otre di vino sulla spalla (fig. 10:4). Si tratta di un motivo appartenente allo stile E (ii) che Hayes inquadra cronologicamente nel VI secolo d.C., e che può trovarsi associato alla rappresentazione di una figura umana stante ricoperta dalla dalmatica con croce astìle sorretta dalla mano sinistra35.
Sono stati trovati anche alcuni frammenti di una lucerna africana tipo Atlante X, con la spalla decorata da motivi cuoriformi e il disco occupato da una croce monogrammatica in rilievo, con na-stro ornato da piccoli rombi, pallini e cerchi concentrici, e con infundibulum sulla destra (fig. 10:1).
Dei rari frammenti vitrei di colore verde chiaro sono degni di nota un orlo (diam. cm 8), arroton-dato e ingrossato verso l’interno, e un piede a disco (diam. cm 4), con anello di base a sezione tubo-lare e stelo corto, riconducibili forse ad un bicchiere a calice (fig. 10:2-3). Generici confronti con la forma Isings 111 e con gli esemplari di piedi a disco rinvenuti in varie località della Sardegna, quali i già citati contesti di Pill’ ‘e Matta di Quartucciu e di Cornus, consentono un loro inquadramento cronologico in epoca tardoromana e altomedievale, con una maggiore diffusione nei secoli V-VI36.
Infine, alla base di questi primi strati di crollo, in corrispondenza dell’altezza degli architravi de-gli accessi alle camere poste agli angoli del bastione quadrilobato, sono stati individuati alcuni re-perti dipinti altomedievali (fig. 11). (F. Dettori) 4. Le prime campagne di scavo del nuraghe Nuracale, per quanto limitate al monumento complesso 30 I coperchi di fig. 7:5 e fig. 9:1 hanno il diametro di circa cm 30, mentre il coperchio di fig. 9:2, proveniente dalla
cortina ovest (US 54), ha il diametro di cm 21. 31 F. VILLEDIEU, Turris Libisonis cit., pp. 160-161, figg. 175-178 (fine IV-fine V sec. d.C.); G. BACCO, Il nuraghe Lo-
sa di Abbasanta cit., p. 50, tav. IX:3-4. 32 Il nostro esemplare di fig. 8:1, con orlo ingrossato, arrotondato e pronunciata profilatura interna per il coperchio, è
simile tipologicamente all’esemplare di Cornus, in M. G. FICHERA - M. L. MANCINELLI, Ceramica da cucina e da
fuoco cit., pp. 256-257, tav. XLI:133. 33 Si veda in particolare la variante E, n. 10 della fig. 162 a p. 344, in S. J. KEAY, Late Roman Amphorae in the We-
stern Mediterranean. A typology and economic study: the Catalan evidence, Part (i), BAR I.S. 196 (i), Oxford 1984. 34 Cfr. F. VILLEDIEU, Turris Libisonis cit., p. 179, fig. 236; D. P. S. PEACOCK - F. BEJAOUI - N. BELAZREG, Roman
Amphora production in the Sahel Region of Tunesia, in Amphores Romaines et histoire économique: dix ans de re-
cherche, Actes du colloque de Sienne (22-24 mai 1986), École française de Rome, Roma 1989, pp. 198, 222, fig. 4:3.
35 J. W. HAYES, Late Roman Pottery. A Catalogue of Roman Fine Wares, The British School at Rome, London 1972, pp. 222, 263, fig. 50, 227h, plate XIXa (form 104).
36 Cfr. D. SALVI, Bicchieri, calici e coppe nella necropoli di Pill’e Matta (CA), in C. PICCIOLI - F. SOGLIANI, Il vetro
in Italia meridionale ed insulare, Atti del Secondo Convegno Multidisciplinare, VII Giornate Nazionali di Studio Comitato Nazionale Italiano AIHV (Napoli 5-7 dicembre 2001), Napoli 2003, pp. 120-121; D. STIAFFINI, I materiali
vitrei, in A. M. GIUNTELLA, Cornus I, 2. L’area cimiteriale orientale. I materiali, Oristano 2000, pp. 118-123, tav. XVII:7.
7
e non ancora estese all’abitato circostante e pur non mettendo in luce contesti chiusi, danno un pic-colo, ma significativo, contributo a due questioni importanti e ancora da valutare nella loro portata per la ricostruzione della storia sociale ed economica della Sardegna tardoromana e altomedievale.
Innanzitutto, l’analisi della ceramica grezza rinvenuta a Nuracale mostra che si tratta di una clas-se ceramica molto variegata, soprattutto sotto l’aspetto tecnologico; sarebbe auspicabile una ulterio-re suddivisione interna rispetto ai due gruppi finora individuati, possibilmente con l’ausilio di anali-si delle argille e di sezioni sottili al fine di comprendere quanto è da attribuire ad una produzione strettamente locale e quanto invece è prodotto per una circolazione più ampia micro-regionale o an-che extra-insulare. Inoltre, l’incerta cronologia di questa ceramica deve portare ad un esame più ac-curato delle associazioni con le ceramiche comuni e quelle di importazione. In questo caso il conte-sto del vano A2, per quanto ridotto nei suoi elementi di cultura materiale, sembra indicare una col-locazione tra V e VI secolo d.C. per un tipo specifico di ceramica grezza del gruppo B.
Un secondo aspetto non trascurabile, evidente a Nuracale come in numerosi siti nuragici dell’alto oristanese e di altre aree della Sardegna, è la decisa intensificazione della frequentazione in età tar-doromana, che va letta a largo raggio all’interno di un processo di ruralizzazione e di diversa ge-stione del territorio. Quali mutamenti di carattere socio-economico siano associabili a questo feno-meno, è la questione che dovrà essere affrontata più approfonditamente da storici e archeologi, compresi gli studiosi di protostoria ai quali spetta il compito di non trascurare gli strati superiori e recenziori degli scavi eseguiti in aree dominate dalla imponente presenza di strutture nuragiche. (A.
Usai, T. Cossu, F. Dettori)
8
Fig. 1. Carta topografica dei complessi nuragici del territorio di Scano Montiferro (dis. T. Cossu su base I.G.M.).
9
Fig. 2. Planimetria del nuraghe Nuracale al termine della campagna di scavo 2006 (ril. G. Manca, T. Cossu, F. Dettori, A. Usai; dis. A. Usai).
Fig. 3. Sezione stratigrafica del vano A2 della torre centrale e del cortile B (ril. T. Cossu, F. Dettori, M.A. Obino, G. Pes; dis. T. Cossu).
10
Fig. 4. Reperti tardoromani e nuragici dal vano A2 (dis. T. Cossu).
Fig. 5. Recipiente in ceramica grezza e peso in ferro dal vano A2 (dis. T. Cossu).