Il nuraghe Nolza di Meana Sardo: lo scavo e i materiali della torre F, in Erentzias 1, Sassari 2011,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Il nuraghe Nolza di Meana Sardo: lo scavo e i materiali della torre F, in Erentzias 1, Sassari 2011,...
119
Il nuraghe Nolza e il suo territorio
Questo lavoro è il frutto di un programma di ri-cerca oramai quindicinale, avviato nel febbraio del1994 con i primi scavi del nuraghe Nolza e conl’approfondimento delle ricerche di superficie av-viate da G. Lilliu negli anni ’80 nel territorio diMeana Sardo (NU), nella Barbagia-Mandrolisai1,e da E. Atzeni nel territorio di Laconi (NU), nelSarcidano, negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso2.
Lo scopo principale delle ricerche era mirato al-l’indagine scientifica di un monumento di grandeinteresse come il nuraghe Nolza, per individuarnele seriazioni stratigrafiche e le fasi culturali, e al-l’indagine del territorio circostante ai fini della ri-costruzione dell’assetto socio-economico di unacomunità nuragica ben circoscritta.
All’orizzonte di questa scelta stava e sta la con-sapevolezza di quanto pochi siano i contesti nura-gici conosciuti e ben pubblicati nella Sardegnacentro-settentrionale a fronte di una situazione me-glio definita nella Sardegna meridionale, soprat-tutto grazie alle stratigrafie messe in luce dallaFerrarese Ceruti nel nuraghe Antigori di Sarroch,che associano materiale indigeno del BR con cera-miche di provenienza egea3.
Il problema è reso ancor più rilevante dalla dif-ficoltà di verificare una cronologia affidabile delleceramiche decorate a pettine nel centro-nord, con-cordemente attribuite al BM2-3, BR4, e dall’evi-dente differenziazione locale nella produzione di
ceramica grigia nuragica nel meridione della Sar-degna durante il BR5. Si trattava e si tratta ancorapertanto di comparare stratigrafie di contesti affi-dabili e la tipologia dei fittili in essi recuperati, alfine di cominciare a colmare lo iato apparente fra idue ambiti culturali isolani fra la fine del BM(BM3) ed il BR.
Inoltre il nuraghe Nolza ed il suo territorio se-gnano una sorta di confine culturale nella produ-zione dei tegami decorati a pettine, se è vero chenel nuraghe Adoni di Villanovatulo (NU), distantecirca 15 km in linea d’aria a SE dal nuraghe diMeana, non n’è stata trovata traccia6, così come nelnuraghe Is Paras d’Isili (NU)7, distante una ventinadi km in linea d’aria a SSE.
Le indagini di superficie hanno consentito diidentificare un complesso sistema territoriale ge-rarchizzato di circa 100 kmq, in un’area collinareconchiusa entro il bacino idrografico del rio Ara-xisi, comprendente circa 18 nuraghi dei quali 5sono complessi, 10 monotorre, mentre 3 erano deimonotorre ora andati completamente distrutti, e 8insediamenti, 3 dei quali privi di nuraghe di riferi-mento. Tutti questi monumenti comunicano fraloro attraverso delle strade, oggi di penetrazioneagraria, che conservano ancora l’originale selciatoottocentesco e che ricalcano antichi tratturi neo-eneolitici8.
All’interno di questo sistema i nuraghi mono-torre svolgono funzioni di controllo dei passi e deiguadi principali, i nuraghi trilobati sono a controllo
MAURO PERRA
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU):lo scavo e i materiali della torre F
1 LILLIU 19892 ATZENI 2004, ivi bibliografia precedente3 FERRARESE CERUTI 1979, 1981, 1982, 1983, 1986; v. anche RELLI 19944 FADDA 1984, 1998; SANTONI 1985; LILLIU 1988; UGAS 1989, 1998; FERRARESE CERUTI, LO SCHIAVO 1991-92; SEBIS 1995; USAI 1998;
DEPALMAS 2009a5 LO SCHIAVO et Alii 20046 SANGES 2000; CAMPUS 2001; CAMPUS, LEONELLI 2006a7 MORAVETTI 2001; COSSU 2001; COSSU, SABA 20008 COSSU, PERRA 2004; COSSU, PERRA 2008; PERRA 2008
degli snodi viari, mentre il nuraghe quadrilobatoNolza ha la funzione di caposaldo interno del ter-ritorio.
Il nuraghe Nolza si trova a circa 8 km a sud delmoderno abitato di Meana Sardo, costruito sul ri-lievo più alto (Cùccuru Nolza) di un altipiano sci-stoso (Su Prànu), a m 739,60 sul livello del mare.Il monumento domina, con i residui 12 m di al-tezza della torre centrale, il circostante agglome-
rato di capanne, che occupa un’area stimata in 2,5ettari.
Nell’articolazione edilizia del nuraghe sono leg-gibili diverse fasi costruttive (Fig. 1): la torre cen-trale (A), due torri perimetrali (E, F) e le cortinemurarie rettilinee volte ad oriente e a settentrionesono state innalzate utilizzando blocchi di scisto inassetto sub-filarico; le altre due torri (C, D) e le re-lative cortine esposte ai quadranti meridionale e oc-
120
Mauro Perra
Fig. 1. Meana Sardo, Nuraghe Nolza. Planimetria del nuraghe Nolza (Ril. R. Pitzalis, G. Pisano; dis. S. Sechi).
121
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU): lo scavo e i materiali della torre F
cidentale sono state costruite adoperando blocchidi porfido disposti in tecnica poligonale.
Gli scavi effettuati all’interno dei diversi am-bienti del bastione hanno permesso di verificareche queste due fasi costruttive corrispondono ad al-trettante fasi archeologiche: la più antica relativa alBR, quando il nuraghe era un quadrilobato in sci-sto, e la più recente relativa al BF19, quando le cor-tine meridionale e occidentale e le torri C e Dfurono smantellate e ristrutturate con blocchi diporfido10.
La prima e più antica fase archeologica non hapurtroppo corrispondenza con alcuna delle strutturefinora messe in luce in quanto la si è potuta docu-mentare solo su base tipologica, data la provenienzada uno strato di discarica di materiale misto del BM3, BR e BF, rinvenuto tutto attorno alle strutture delbastione, sotto potenti strati di crollo11. Si tratta inparticolare di alcuni frammenti di pisside decorata instile metopale recuperati nelle US 17 e 23 a ridossodella cortina SSE.
La seconda fase (BR) è stata ben enucleata du-rante lo scavo del vano I, un ambiente originaria-mente cupolato dislocato fra la torre A e la cortinanord del bastione, crollato e parzialmente trasci-nato verso la base del muro rettilineo a seguito delcollasso delle strutture12. Durante lo scavo si è po-tuto verificare che l’ambiente I è stato costruito de-molendo parzialmente la scala H, che in originecollegava la torre con gli spalti del bastione. Sui re-sidui muri della scala s’intervenne giustapponendoun vespaio di lastre di scisto, sul quale è stato stesoun doppio battuto di argilla concotta intervallato dadue strati cinerini di occupazione. Questi due strati
(US 31 e 35) erano separati da un battuto pavi-mentale di pochi cm di spessore, ma diversi fram-menti di ceramica dello strato cinerino superioreconnettevano con quelli dello strato cinerino infe-riore, così chiarendo che si trattava di due livellicoevi del BR. Fra i materiali più significativi sonostati rinvenuti tegami, coppe di cottura, scodelle,ciotole carenate, vasi a collo, olle a colletto. Nel re-pertorio dei frammenti decorati spiccano i fondi in-terni di tegame ornati a bande parallele e radialiimpresse a pettine, a bande circolari e cerchi pen-denti campiti a pettine ed un frammento di olla glo-bulare decorata a stralucido con leggere solcaturedisposte in ordito metopale.
Per ciò che concerne i raffronti del repertorio va-scolare rinvenuto nell’ambiente I con i contesti me-ridionali e dell’Oristanese, che in questo caso ciinteressano in modo particolare, coppe di cottura etegami non presentano particolari differenziazioni.Le scodelle, soprattutto quelle a profilo superior-mente convesso ed orlo rientrante13, trovano pun-tuale riscontro a Sarroch, nella torre F del nuragheAntigori14, nel vano BS del nuraghe Su Mulinu diVillanovafranca (CA)15, nella grotta Pirosu di San-tadi (CA)16 e nelle US 52 e 53 della torre centraledel nuraghe Su Sonadori di Villasor17. Una ciotolacarenata18 è affine ad altra ciotola della medesimatipologia dal pozzo, prima fase, di Cuccuru Is Ar-rius di Cabras (OR)19, mentre un’altra ciotola ca-renata20 è tipologicamente assimilabile ad unreperto proveniente dallo strato III della torre C delnuraghe Antigori (CA)21. Così anche due olle a col-letto22 si raffrontano con l’olla della torre F del nu-raghe Antigori23 e con altre olle dal nuraghe Piscu
9 PERRA, COSSU 200310 COSSU, PERRA 1998, 200211 PERRA, COSSU 200312 COSSU, PERRA 199813 COSSU, PERRA 1998, fig. 3:1/ fig. 3:5 = CAMPUS, LEONELLI 2000, forma 260 scod. 48 B; COSSU, PERRA 1998, fig. 3:7 = forma CAM-
PUS, LEONELLI 268 scod. 5614 FERRARESE CERUTI 1983, fig. 5: 18 e 20, fig. 6: 615 UGAS 1987, fig. 5.5: 916 LO SCHIAVO, USAI 1995, fig. 4: 2 e fig. 5: 117 USAI, MARRAS 2005, figg. 7:3 e 8:318 COSSU, PERRA 1998 fig. 3,9 = forma CAMPUS, LEONELLI 376 cio. 2519 SEBIS 1982, tav. II: 920 COSSU, PERRA 1998, fig. 3:16 = forma CAMPUS LEONELLI 429 cio. 7821 RELLI 1994, tav. V: 6222 COSSU, PERRA 1998, fig. 4,8 = CAMPUS, LEONELLI, 904 ol. 139 e COSSU, PERRA 1998, fig. 4:9 = CAMPUS, LEONELLI, 906 ol. 14123 FERRARESE CERUTI 1983, fig. 6:19
122
Mauro Perra
di Suelli (CA), cap. 1 str. V e dal vano F1 del nu-raghe Su Mulinu 24. L’olla a colletto svasato25 trovaimmediati riscontri a Monti Mannu di Massama26
e a Su Muru Mannu di Tharros27, nonché nel pozzonuragico della chiesa di S. Maria Maddalena diGuamaggiore28. È pienamente condivisibile la pro-posta di F. Campus di inquadrare l’orizzonte delvano I del Nolza nel BR 1-229, così come acclaratodalla stratigrafia e dai raffronti.
Il quadro delle comparazioni con i contesti me-ridionali, effettuato su rigorosa base tipologica,rende conto di un comune modo di plasmare, purnelle differenze d’ambito culturale, alcuni tipi diforme vascolari nel BR, specie quelle meno artico-late, come coppe di cottura, tegami, scodelle, cio-tole e olle a colletto. Un altro elemento di grandeinteresse crono-stratigrafico è dato dalla presenza,anche nei contesti meridionali, di un tipo di deco-razione a leggere scanalature a stralucido che sem-bra esclusivo delle olle a colletto e dei vasi a collo,come per es. nel nuraghe Arrubiu di Orroli30, chenei contesti centro-settentrionali si accompagnaalla decorazione a pettine come nel nuraghe S. An-tine di Torralba31 e nel nuraghe Duos Nuraghes diBorore32.
Le differenze osservate nell’ambito cronologicodel BR fra Sardegna meridionale e Sardegna cen-tro-settentrionale sono da ascrivere più all’ambitotecnologico e delle decorazioni che non a quellostrettamente formale. Così, mentre nel meridione sidiffondono forme e tecnologie legate alla produ-zione della ceramica grigia nuragica (soprattutto leconche, assenti nel settentrione), nel centro-nord sisperimentano tecnologie che non conoscono la ce-
ramica grigia e decorazioni che prevedono l’utilizzodi complesse ornamentazioni impresse o strisciate apettine (assenti o sporadiche nel meridione).
Per quanto concerne l’analisi comparativa pro-posta con i contesti centro-settentrionali, i raffrontipiù convincenti sono con i materiali del nuraghe S.Antine di Torralba (SS)33 , con il villaggio nuragicodi Serra Orrios di Dorgali (NU)34 e con gli strati in-feriori dell’insediamento di S’Urbale di Teti35, colnuraghe S. Barbara di Macomer (NU)36 , col nura-ghe Monte Idda di Posada (NU)37, con il nuragheDuos Nuraghes di Borore (NU)38 e con i materialidella US 43 dal vano A del santuario nuragico di SuMonte di Sorradile39.
La terza fase archeologica del nuraghe Nolza èstata evidenziata negli scavi del cortiletto sopraele-vato B e all’interno della camera superiore della torrecentrale40, dove, sotto gli strati del crollo, è apparsoun livello omogeneo nuragico relativo al BF iniziale.
Le strutture del villaggio non sono state ancoraindagate, se si fa eccezione per la capanna 1, aduna decina di metri a sud del quadrilobato, nellaquale sono state rinvenute le chiare tracce ed i ma-teriali relativi ad un riutilizzo delle strutture in etàromano-imperiale, intorno al II sec. d. C..
La torre F: lo scavo e i reperti fittili.
La torre F è la più piccola del complesso qua-drilobato e si dispone a cuspide, in appena percet-tibile aggetto, fra le due cortine in scisto volte adest e a nord (Figg. 1 e 2). È pertanto una delle strut-ture più antiche del bastione del nuraghe Nolza. Si
24 SANTONI 1992a, tav. III: SP 1-896; UGAS 1987, fig. 5.16: 4-525 COSSU, PERRA 1998, fig. 4:4 = CAMPUS, LEONELLI, 824.ol.5926 SEBIS 199527 SANTONI 198528 CANINO 2008, figg. 4:7 e 5:729 CAMPUS, LEONELLI 2006b30 CAMPUS 2003, fig. 24:6; v. a confronto COSSU, PERRA 1998, fig. 5: 231 BAFICO, ROSSI 1988, fig 16: 3-432 WEBSTER 2001, fig. 3.8: 633 BAFICO, ROSSI 198834 COCCO 198035 COSSU, PERRA 1998, p. 9836 MORAVETTI 198637 FADDA 198438 WEBSTER 200139 SANTONI, BACCO 200840 COSSU, PERRA 1998, 2002
123
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU): lo scavo e i materiali della torre F
Fig. 2. Meana Sardo, Nuraghe Nolza. Planimetria e sezione stratigrafica della torre F (dis. M. Vacca).
124
Mauro Perra
conserva per un diametro di m 6 circa, sull’attualepiano di calpestio esterno, e per un’altezza mas-sima di m 2,50.
La torre F è la più degradata fra le strutture delcomplesso monumentale di Meana. Durante loscavo dei crolli esterni ci si rese conto che, mentrela tholos della camera si conservava quasi intattafino alla chiusura dell’ogiva, mancando appenapochi filari, il paramento esterno era collassato e lestrutture rimanenti erano abbondantemente fessu-rate. Si è proceduto quindi ad un intervento di con-solidamento, sostituendo alcuni blocchi degradati erisarcendo l’alzato della torre fino ad altezza con-sona a conservare adeguatamente le strutture resi-due della tholos.
Si è poi proceduto allo scavo della camera vol-tata, nel settembre del 2000, partendo dal foro dellacupola, dato che la torre non ha accesso dal-l’esterno. Lo scavo si è protratto per una profon-dità di m 2,50/2,90 circa, fermandosi al pavimentodella camera voltata. È stato messo in luce un vanosul quale si aprono ben cinque feritoie e un corri-doio-scala che collegava la camera inferiore dellatorre F con il cortile B ed il bastione. I montantidelle feritoie e del corridoio erano costituiti da ele-menti lapidei in scisto fortemente fratturati, per cuitutta la muratura era a rischio di cedimento. Nel2008-2009, a seguito di un finanziamento dell’As-sessorato alla P.I. della Regione Autonoma dellaSardegna, si è proceduto con successo al consoli-damento degli stipiti del vano scala e delle feritoie,sostituendo gli elementi lapidei fratturati e allet-tandoli con malte di calce e argilla, e inserendonelle aperture stesse dei supporti in acciaio che so-stenessero le spinte e prevenissero eventuali cedi-menti.
Lo scavo della camera ha evidenziato la pre-senza di tre sole unità stratigrafiche:
US 79 (quota relativa da -6,86 a -8,47): strato diterriccio polveroso ocraceo, misto a pietre di sci-sto di medie e piccole dimensioni e conci a coda ditrachite, sterile, probabile strato di crollo della voltadella camera;
US 80 (da -8,47 a -9,21/9,50): strato di terricciocarbonioso, argilla rossastra in polvere, pietre discisto di piccole e medie dimensioni, talora calci-nate dal calore, ricco di conci a coda in trachite dipiccole dimensioni, ceramiche, manufatti litici e al-cune sfoglie di sughero carbonizzate, probabile di-
scarica di età nuragica tesa a costipare di materialeeterogeneo la camera e le feritoie;
US 83 (-9,21/9,50): pavimento argilloso che ri-copre il basamento roccioso in scisto, in forte pen-denza da ovest verso est.
Fra questi strati quello che più ci interessa è laUS 80, che ho definito un “butto” di età nuragica.Lo scavo è proceduto per livelli artificialmente de-terminati, e frequenti sospensioni sono state effet-tuate per rilevare la posizione dei frammenticeramici nello spazio della camera. Non sono statidistinti altri strati o livelli sulla base della compo-sizione, della natura e del colore della terra. I ma-teriali erano distribuiti in tutto lo spessore dellostrato (in media 80 cm), in frammenti caoticamentedisposti su tutta la superficie dello scavo, dei qualinumerosissimi pezzi provenienti dai livelli supe-riori connettono con quelli recuperati nelle quotepiù basse, a conferma dell’omogeneità e unitarietàdell’azione e quindi dello strato. L’impressionenetta che si è avuta durante lo svolgimento delleindagini è quella di un riempimento voluto dellospazio della camera e dei vuoti delle feritoie al finedi costipare le strutture, forse a causa del pericolodi incombenti crolli.
I dati di scavo ci consentono di affermare che lacamera della torre F non venne più utilizzata dopoil butto e pertanto già durante il BR. Non ho suffi-cienti elementi per poter ipotizzare la provenienzadei materiali e del terriccio carbonioso della US 80ma, in ogni caso, essi quasi certamente sono ilfrutto di un intervento di demolizione e asporto daaltri ambienti interni del nuraghe.
Un altro elemento importante che mi sento didesumere dai dati di scavo della camera della torreF è che il vano I venne costruito ed utilizzato suc-cessivamente alla formazione del deposito della US80, cioè quando la scala H, che raccordava la torreF agli spalti del bastione, non venne più utilizzata.Ne consegue che i materiali fittili che presenterò inquesta sede, sono leggermente più antichi di quellirinvenuti nell’ambiente I41 e sono invece coevi aquelli rinvenuti nella scala H42. Fra le categorie va-scolari sono rappresentate le teglie ed i tegami sialisci, sia decorati, le coppe di cottura, gli scodel-loni e le scodelle, le ciotole e le tazze, varie classidi olle.
La teglia con fondo non distinto, foggiata con im-pasto bruno e inclusi minuti e piccoli di quarzo, ha
41 COSSU, PERRA 199842 PERRA 2008, fig. 4
125
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU): lo scavo e i materiali della torre F
Fig. 3. Meana Sardo, Nuraghe Nolza. Teglie, tegami e coppe di cottura dalla US 80 della torre F (dis. S. Sechi).
126
Mauro Perra
le superfici beige, annerita quella esterna, lisciatesommariamente (Fig. 3:1). È confrontabile con iltipo CAMPUS, LEONELLI 14 tg. 10 (p. 8, tav. 7:4-5) ecioè con la teglia dal nuraghe a corridoio BruncuMadugui43 e con il frammento dallo strato III dellatorre C del Nuraghe Antigori di Sarroch44. La cro-nologia varia dal BM3 al BR, così dimostrando lapermanenza in uso della forma nel tempo.
I tegami (Fig. 3: 2,3, 5,6) hanno il fondo non di-stinto, impasti che variano dal bruno al grigio alnerastro sempre compatti e arricchiti da inclusi diquarzo, con superfici beige, brune e nerastre, an-nerite quelle esterne, sommariamente trattate o sca-bre, mentre quelle interne sono lisciate. Una solaforma permette la ricostruzione del diametro che èdi cm 36. Il reperto di Fig. 3:245 è simile ai fram-menti di Monte Idda di Posada46 e S. Antine di Tor-ralba47. Il frammento di Fig. 3: 3 rimanda allaforma CAMPUS, LEONELLI 78 Te. 15 variante A (p.28, tav. 34), cioè al reperto da Su Muru Mannu diTharros, Cabras48 di cui è verosimile proporre uninquadramento cronologico alla fine del BronzoMedio, e al frammento dallo strato 51 della torrecentrale del nuraghe Su Sonadori49. Il tegame diFig. 3: 5 richiama la forma CAMPUS, LEONELLI 80Te. 17 (p. 29, tav. 36: 3-5), dal nuraghe S. Antine diTorralba50, dal nuraghe Funtana di Ittireddu (ine-dito) e dal nuraghe Nuracc’e Figu di Oristano51
compresi in un arco cronologico definito fra BR eBF iniziale. La forma di Fig. 3: 6 richiama il tipoCAMPUS, LEONELLI 68 Te. 5 (p. 25, tav. 29: 3) pro-veniente dallo scavo della tomba di giganti SeleniI di Lanusei52, contesto da riferire al BM3.
Le coppe di cottura non si distinguono, da unpunto di vista tecnologico, dai tegami precedente-
mente esaminati, se non per la presenza di un fondomarcatamente convesso e talora profilato. Hannodiametri variabili fra i 40 ed i 54 cm. La coppa diFig. 3: 4 richiama la forma CAMPUS, LEONELLI 133Cop. 3 (p. 99, tav. 59: 9), proveniente dallo scavodel vano I del nuraghe Nolza di Meana Sardo, ri-feribile al BR53. Il pezzo di Fig. 3: 7 è affine allaforma documentata nello strato del BR della torreA del nuraghe Arrubiu di Orroli54. La Fig. 3: 8 pro-pone un tipo assimilabile al 131 Cop. 1 di CAMPUS,LEONELLI, anch’esso proveniente dal vano I del nu-raghe Nolza55.
Nella Fig. 4: 1 si documenta l’unica forma discodellone (diametro cm 29), con orlo semplice aprofilo rettilineo e un’ansa a nastro frammentaria,con impasto argilloso e grandi inclusi di feldspatie quarzo, superfici rosse sommariamente trattate.È affine al tipo CAMPUS, LEONELLI 138 Sco. 1 (p.109, tav. 61: 2), proveniente dallo strato IV dellacapanna 1 del nuraghe Piscu di Suelli56 riferibilead un BM tardo o ad un BR iniziale.
Le scodelle a calotta, con orlo semplice (Fig. 4:2) o ingrossato (Fig. 4: 3) e talora con risega nellavasca (Fig. 4: 4-5), con presine bifide insellate,hanno impasti generalmente argillosi e compatti,talora depurati di colore bruno, rossiccio o nera-stro, e superfici esterne nocciola, marrone e ros-sicce ben lisciate a stecca e superfici interne nere,talora lustrate alla stecca.
La scodella a calotta con orlo semplice di Fig.4: 2 si confronta con il tipo CAMPUS, LEONELLI 227Scod. 15 (tav. 108: 11) dai livelli del BR del nura-ghe Adoni di Villanovatulo, mentre la scodella acalotta con orlo ingrossato di Fig. 4: 3 trova ri-scontro nella forma 228 Scod. 1657, proveniente
43 BADAS 1992, tav. VIII: GBM 12844 RELLI 1994, tav. V: 3045 CAMPUS, LEONELLI 2000 forma 66.Te.346 FADDA 198447 BAFICO, ROSSI 198848 SANTONI 1985, p. 135, fig. 7: 16549 USAI, MARRAS 2005, fig. 5:2150 BAFICO, ROSSI 1988, p. 113, fig. 26: 951 SANTONI 1992b, fig. 7: 852 PERRA 2003b, fig. 183: 353 COSSU, PERRA 1998, p. 103, fig. 2: 1154 CAMPUS 2003, fig. 22: 1655 COSSU, PERRA 1998, p. 103, fig. 2: 1356 SANTONI 1992a, p. 180, tav. II: 81257 CAMPUS, LEONELLI 2000, tav. 109: 18
127
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU): lo scavo e i materiali della torre F
Fig. 4. Meana Sardo, Nuraghe Nolza. Scodelloni e scodelle dalla US 80 della torre F (dis. S. Sechi).
128
Mauro Perra
dalla grotta Tanì di Carbonia58. La fig. 4: 4,5 rap-presenta il tipo 232 Scod. 2059 e cioè la scodella acalotta con risega interna di S’Iscia ’e sas Piras diUsini60.
Le scodelle emisferiche (Fig. 4: 7-9) hanno dia-metri compresi fra i 20 e i 24 cm e impasti rossiccie nerastri ricchi di inclusi di quarzo, superfici ros-sastre o marrone talora lisciate entrambe con lastecca.
La forma di fig. 4: 7 non ha immediati riscontri,anche se si avvicina molto al tipo 248 Scod. 36 Adi CAMPUS, LEONELLI (p. 186, tav. 116: 4-5) e cioèai frammenti di scodella del nuraghe Don Micheledi Ploaghe61 e del nuraghe Adoni di Villanovatulo:per la caratteristica presa doppia il confronto im-mediato è da effettuarsi con la simile presa dal vanoF1, livello 4 (BR 1) del nuraghe Su Mulinu62 e coni frammenti dalla tomba II di Seleni - Lanusei63. Lascodella di Fig. 4: 8 richiama la forma CAMPUS,LEONELLI 248 Scod. 36 B (p. 186, tav. 116: 8) pre-sente nel nuraghe a corridoio Fruscos di Paulila-tino64 e nello strato 61/IV (BM3) della fonte diMitza Pidighi di Solarussa65. La forma di Fig. 4: 9è simile al tipo CAMPUS, LEONELLI 251 Scod. 39 (p.187, tav. 118: 2-3) dalla grotta di Sas Furmicas diDorgali66 e dal nuraghe S. Antine di Torralba67.
Sono più rare le scodelle a profilo superiormenteconvesso ed orlo rientrante (Fig. 4: 10-11); hannoimpasti neri e grigi e superfici nerastre o grigiesommariamente lisciate. La prima si confronta con
la forma 260 Scod. 48 B dal sito di S. Marco diSettimo S. Pietro68 e dal vano I (BR) del nuragheNolza69; la seconda richiama il tipo 270 Scod. 5870
da Punta Niedda di Portoscuso71, ma si raffrontaanche con reperti simili dal nuraghe Su Sonadori,strato 5172.
Le scodelle con profilo angolare e pareti al disopra della vasca rettilinee (Fig. 4: 6, 12-13; Fig. 5:1-2) hanno diametri calcolabili fra i 12,5 ed i 20cm, impasti neri o grigi semidepurati, con radi eminuti inclusi di quarzo e superfici esterne dal noc-ciola al marrone accuratamente lisciate a stecca,superfici interne nere lustrate, in due casi con stec-cature orizzontali sull’orlo e radiali sulla vasca(Fig. 4: 6, 12). I frammenti di Fig. 4: 6 e 12 sono ineffetti tanto simili, pur non connettendo le fratture,da non far dubitare che siano pertinenti allo stessovaso. La forma di riferimento del catalogo CAM-PUS, LEONELLI è la 286 Scod. 74 (p. 198, tav. 132:6), frammento proveniente dallo scavo della Ma-donna del Rimedio di Oristano73. La stessa forma èpresente nel repertorio dello strato 61/IV di MitzaPidighi74. Alla stessa tipologia appartiene il fram-mento di Fig. 4: 13. La scodella di fig. 5: 1 è similealla forma 300 Scod. 88 dal nuraghe S. Antine75 edal nuraghe Adoni di Villanovatulo76.
La scodella passante a ciotola di Fig. 5:3 hal’ansa verticale impostata appena sotto l’orlo, im-pasto grigio ricco di inclusi di quarzo e superficirosse sommariamente lisciate. È simile al tipo 323
58 FERRARESE CERUTI 1995, fig. 13: 259 CAMPUS, LEONELLI 2000, p. 182, tav. 111: 960 CASTALDI 1975, p. 59, fig. 72: 661 FADDA 1979, tav. IV: 162 UGAS 1987, fig. 5.16.263 PERRA 2003b, fig. 187a: 12-13 e 187b: 2464 MANCA DEMURTAS, DEMURTAS 1984, fig. 21: 165 USAI 2000, tav. VI:166 FERRARESE CERUTI 1980, tav. XX: 767 BAFICO, ROSSI 1988, p. 69, fig. 4: 1268 NUVOLI 1990, p. 45, tav. II: 1069 COSSU, PERRA 1998, p. 104, fig. 3:170 CAMPUS, LEONELLI 2000, p. 194, tav. 127: 1071 FERRARESE CERUTI 1978, tav XXXVI: 1072 USAI, MARRAS 2005, fig. 5: 1873 SANTONI, SEBIS 1985, p. 103, n. 574 USAI 2000, tav. VI:775 CAMPUS, LEONELLI 2000, p. 201, tav. 135: 10; BAFFIGO ROSSI 1988, p. 105, fig. 22, 176 CAMPUS 2001, tav. 3: 4
129
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU): lo scavo e i materiali della torre F
Fig. 5. Meana Sardo, Nuraghe Nolza. Scodelle e ciotole carenate dalla US 80 della torre F (dis. S. Sechi).
130
Mauro Perra
Scod. 11177 dall’esedra della tomba II (BR) nelbosco di Seleni a Lanusei78.
Numerose sono le ciotole carenate con diame-tro all’orlo approssimativamente equivalente aquello alla carena (Fig. 5: 4-11), quasi standardiz-zato e compreso fra i 20 ed i 25 cm: hanno impastiargillosi molto compatti di colore grigio o nerastro,piuttosto depurati, con superfici dal nero al grigio,varie tonalità di marrone e color nocciola, spessoaccuratamente lisciate a stecca. Il vaso di figura 5:4 non trova riscontri nella tipologia di Campus eLeonelli ma è rappresentato nell’insieme dei ma-teriali dello strato 61/II-III (BR) di Mitza Pidighi79.
Il frammento di Fig. 5: 5 richiama la formaCAMPUS, LEONELLI 374 Cio. 23 (p. 256, tav. 125:7) proveniente dalla località Tana di Gesturi(BADAS 1985, p. 342, tav. XLVI: 626), mentre ilframmento di Fig. 5: 6 rimanda al tipo 382 Cio. 31(p. 258, tav. 155: 12) proveniente dal tempio apozzo di Cuccuru Is Arrius, II fase, relativa al BF80.La figura 5: 7 propone un pezzo assimilabile allaforma CAMPUS, LEONELLI 390 Cio. 39 (p. 260, tav.157: 7) recuperato nei vecchi scavi del nuragheLosa di Abbasanta81. Le forme documentate dallaFig. 5: 8-11 sono tutte appartenenti al tipo 392.Cio. 4182. I nn. 8 e 9 richiamano la forma dal tem-pio a pozzo di Cuccuru Is Arrius di Cabras83, men-tre il n. 10 si confronta con il frammento dal vanoF1, livello 4 (BR) di Su Mulinu di Villanova-franca84. Il n. 11 richiama un frammento simile dalnuraghe S. Antine di Torralba85 e i vasi dello strato61/IV (BM3) della fonte di Mitza Pidighi86.
Quasi altrettanto numerose sono le ciotole care-
nate con diametro all’orlo superiore a quello allacarena (Fig. 5: 12; 6: 1-5), compreso fra i 24 e i 26cm, con impasti simili a quelli della categoria pre-cedente, dai colori rossi, neri e grigi e superfici ros-sastre annerite, marrone e nocciola, accuratamentelisciate. I frammenti di Fig. 6: 1 e 3 trovano con-fronto con il tipo CAMPUS, LEONELLI 411 Cio. 60(p. 263, tav. 162: 5) che proviene dal villaggio diSerra Orrios di Dorgali87, mentre quello di Fig. 6:4si raffronta col frammento dal nuraghe Don Mi-chele di Ploaghe88. La ciotola di Fig. 6: 2, conflesso interno fra parete e vasca, è simile al tipo 414Cio. 63 (p. 264, tav. 163: 7-9) dallo strato 5 deltempio a Pozzo di Cuccuru Nuraxi di Settimo S.Pietro89 e dal S. Antine di Torralba90. La figura 6: 5documenta il tipo CAMPUS, LEONELLI 436 Cio. 85(p. 270, tav. 171: 1) dal sito di Giubba Niedda diDolianova91.
La ciotola con carena a spigolo arrotondato diFig. 6: 6 è un unicum e non trova precisi riscontrinel repertorio vascolare dei diversi contesti insulari.
Le ciotole a corpo arrotondato (Figg. 6: 7-12; 7:1-2), con diametri compresi fra i 20 e i 26 cm,hanno prevalentemente impasti grigi, talora bruni,semidepurati e superfici di colore vario dal mar-rone al nocciola, dal beige al grigio, lisciate con lastecca. Quasi tutti i frammenti (nn. 7-10) con dia-metro all’orlo approssimativamente equivalente aquello alla massima espansione appartengono altipo CAMPUS, LEONELLI 483 Cio. 132 (pp. 277-278,tav. 182: 1-5) con immediati raffronti che riportanoai contesti di Sa Serra di Serrenti92, alla I fase delpozzo di Cuccuru is Arrius93, e ai contesti del nu-
77 CAMPUS, LEONELLI 2000, p. 205, tav. 140: 1178 PERRA 2003b, fig. 187a: 879 USAI 2000, tav. VII:680 SEBIS 1987, p. 116, tav. II: 481 SANTONI 1994, p. 88, tav. XIII: 282 CAMPUS, LEONELLI 2000, p. 260, tav. 158: 4-683 SEBIS 1982, fig. 9:284 UGAS 1987, p. 113, fig. 5.15: 585 BAFICO, ROSSI 1988, p. 107, fig. 23: 186 USAI 2000, tav. VI: 14-1587 COCCO 1980, tav. XXXVII: 588 FADDA 1979, tav. IV: 289 ATZENI 1987, tav. VII: 790 BAFICO, ROSSI 1988, fig. 8:1191 SANTONI 1987, p. 73, fig. 4: 592 USAI 1989, p. 74, tav. II: 2093 SEBIS 1987, p. 115, nn. 12 e 16
131
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU): lo scavo e i materiali della torre F
Fig. 6. Meana Sardo, Nuraghe Nolza. Ciotole carenate e a corpo arrotondato dalla US 80 della torre F (dis. S.Sechi).
132
Mauro Perra
Fig. 7. Meana Sardo, Nuraghe Nolza. Ciotole a corpo arrotondato, tazze, vaso a collo e olle dalla US 80 dellatorre F (dis. S. Sechi).
133
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU): lo scavo e i materiali della torre F
Fig. 8. Meana Sardo, Nuraghe Nolza. Olle dalla US 80 della torre F (dis. S. Sechi).
134
Mauro Perra
raghe Chessedu di Uri94, della fonte nuragica diMitza Pidighi di Solarussa, sia dagli strati del BF95
sia dagli strati del BR96, e della struttura circolaredel nuraghe Adoni di Villanovatulo97. Il frammentodi Fig. 6: 11 rimanda alla forma 485 Cio. 134 diCAMPUS, LEONELLI (p. 278, tav. 182: 13) dal Nu-raxi Mannu di Narbolia98. La ciotola di figura 6: 12trova un immediato riscontro nel vaso provenientedallo strato 61/II-III di Mitza Pidighi99 e nella US52 del nuraghe Su Sonadori100.
Le rare tazze carenate (Fig. 7: 3, 5) hanno il dia-metro superiore o approssimativamente equivalentea quello della massima espansione, compreso fra i21 ed i 22 cm. La prima è stata foggiata con un im-pasto di colore nero all’interno e rossastro verso laparete esterna, con inclusi piccoli quarzosi; le su-perfici sono lisciate a stecca. La seconda ha l’im-pasto nero con rari inclusi; la superficie esternavaria fra il marrone e il beige, mentre quella internaè nera lustrata. Il vaso di figura 7:3 è simile al tipo572 Taz. 64 del catalogo CAMPUS, LEONELLI (tav.205: 12, p. 337), proveniente da Serra Orrios diDorgali101. La tazza di Fig. 7: 5 non ha confronti.
La tazza a corpo arrotondato (Fig. 7: 4) possiedeuna presina insellata alla carena ed il diametro al-l’orlo è di cm 20. L’impasto è nero con medi e pic-coli inclusi di quarzo; la superficie esterna è dicolore marrone lisciata, quella interna nera ugual-mente lisciata. È simile al tipo 586 Taz. 78 di CAM-PUS, LEONELLI (tav. 208: 2, p. 339) della domusnuragica di La Dana di Lu Mazzoni, Stintino102.
Nel repertorio vascolare è presente un solo vasoa collo imbutiforme (Fig. 7: 6) con diametro di cm20. L’impasto è di colore rosso, argilloso, con in-clusi medi quarzosi; le superfici sono rosso-brune,lisciate a stecca. Si confronta con la forma 735 Vc.
7B103 dal nuraghe S. Itroxia di Sinnai104.Il vaso a listello interno è interessato dalla pre-
senza nella parete di forellini ottenuti prima dellacottura. Il diametro all’orlo è di cm 24. L’impastoè grigiastro con inclusi medi e grandi di quarzo; lasuperficie esterna è lisciata di colore bruno-rossic-cio, l’interna è grigia lisciata a stecca. Non sonoproponibili confronti con i tipi conosciuti in altrisiti della Sardegna.
L’olla ad orlo non distinto dalla parete (Fig. 7: 8)è stata ricostruita con numerosi frammenti prove-nienti da diverse quote (-8,50, -8,83, -9,21). Il dia-metro all’orlo è di cm 20. L’impasto si presentanero, ricco di inclusi quarzosi medi e piccoli; le su-perfici sono scabre o grossolanamente lisciate, dicolore nerastro quella esterna, quella interna riccad’incrostazioni calcaree. La forma è assimilabile altipo 779 Ol. 14 di CAMPUS, LEONELLI, (tav. 281: 3,p. 475) proveniente dal sito di Su Muru Mannu diTharros105.
Le olle ad orlo distinto dalla parete, sempre sva-sato, in taluni casi sono semplici (Fig. 7: 9-10) inaltri presentano la variante di un cordone a spigolofra l’orlo e l’attacco della spalla (Fig. 8: 1-4). I dia-metri sono compresi fra 18 e 33 cm dell’esemplarepiù ampio. Presentano impasti bruni o grigiastriquasi sempre ricchi di inclusi medi e grandi quar-zosi. Le superfici sono di colore variante fra le to-nalità bruno-rossicce e grigio-nerastre, soventelisciate a stecca quelle esterne. Per il frammento diFig. 7: 9 si propone il confronto con la forma CAM-PUS, LEONELLI 824 Ol. 59 (tav. 299: 15, p. 486) re-cuperata nell’ambiente I del nuraghe Nolza106,mentre per l’olla di Fig. 7: 10 il richiamo più im-mediato è quello istituibile con la forma 812 Ol.47107 proveniente dal nuraghe S. Antine108 e dai li-
94 LILLIU 1982, p. 112, fig. 123, terzo a destra dall’alto95 USAI 1996, p. 69, tav. VII: 1696 USAI 2000, tav. VII: 11-1497 CAMPUS, LEONELLI 2006a, tav. 15:798 SANTONI 1992b, p. 151, fig. 3: 699 USAI 2000, tav. VII:10100 USAI, MARRAS 2005, fig. 7:13101 COCCO 1980, tav. XXXVII: 11102 CASTALDI 1975, fig. 71: 21103 CAMPUS, LEONELLI 2000, tav. 256: 9, p. 438104 GIORGETTI 1986, fig. 2:2, p. 30105 SANTONI 1985, fig. 6: 107, p. 134106 COSSU, PERRA 1998, fig. 4: 4, p. 104107 CAMPUS, LEONELLI 2000, tav. 296: 11, p. 484108 BAFICO, ROSSI 1988, fig. 17: 8
135
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU): lo scavo e i materiali della torre F
Fig. 9. Meana Sardo, Nuraghe Nolza. Olle dalla US 80 della torre F (dis. S. Sechi).
136
Mauro Perra
velli del BR del cortile B del nuraghe Arrubiu diOrroli109. Le olle con cordone a spigolo richiamanola forma simile dal nuraghe Arrubiu, recuperata neilivelli del BR110.
Le olle ad orlo ingrossato a sezione triangolare(Fig. 8: 5-6) hanno diametri alla bocca variabili frai 20 e i 26 cm. Presentano impasti grigi o rossastriricchi di inclusi medi e grandi di quarzo; le super-fici esterne, lisciate a stecca, variano dai coloricrema al rossastro, talora annerite all’orlo, quelleinterne dal grigio al rossastro, sempre sommaria-mente lisciate. L’olla di Fig. 8: 5 richiama la forma843 Ol. 78111 proveniente dallo strato IV del vanosuperiore della torre C del nuraghe Antigori112 e lagrande olla dalla buca 51B della torre centrale delnuraghe Su Sonadori113. La Fig. 8: 6 rimanda allaforma 869 Ol. 104114 dalla torre F del nuraghe An-tigori115.
Le olle a colletto distinto sono ben rappresentatenel repertorio vascolare della US 80 della torre F(Figg. 8: 7-12; 9: 1-8; 10: 1-2). I diametri varianodai 18 ai 37 cm, ricadendo soprattutto nelle di-mensioni intorno ai 20 cm. Gli impasti sono grigi,nerastri o bruno-rossicci, rare volte parzialmentedepurati, spesso ricchi di inclusi medi e piccoli diquarzo; le superfici variano dal nero al grigio, dalbruno al rossastro, quelle esterne sempre fittamentelisciate a stecca. Le olle di Fig. 8: 7-8 richiamanola forma CAMPUS, LEONELLI 903 Ol. 138A (tav.
345: 3, p. 513) recuperate sia negli scavi del nura-ghe La Prisciona, trincea A, strato 4o116, sia nel sitodi Monti Mannu di Massama117. La Fig. 8: 9 si con-fronta con il tipo 904 Ol. 139A118, dal nuraghe acorridoio Bruncu Madugui di Gesturi119 e dal sitodi Su Cungiau e Funta’ di Nuraxinieddu120 che do-cumentano, dal BM al BF, la lunga durata dellaforma. L’olla di Fig. 8: 10 è simile alla forma 905Ol. 140D121, dal villaggio di Sa Traia di Assemini122
e dalla cap. 1, strato IV del nuraghe Piscu diSuelli123, entrambi relativi al BR. Mentre la formadi Fig. 8: 11 non presenta confronti, quella di Fig.8: 12 trova riscontro nel tipo 906 Ol. 141A, (tav.349: 1-4, p. 515), dalla cap. 1, strato V del nuraghePiscu124, dalla cap. ζ dell’abitato di Su MuruMannu di Tharros125 e dall’ambiente I del nuragheNolza126, contesti databili fra il BM tardo ed il BR.L’olla a colletto ingrossato della Fig. 9: 1 è assimi-labile al tipo 903 Ol. 138 (tav. 345, p. 513) ma nontrova un riferimento preciso, mentre quella di Fig.9: 2 trova immediato riscontro nel tipo 909 Ol. 144(tav. 351: 16, p. 516) rinvenuto nella Grotta Pirosudi Santadi127 e nei livelli del BM3 della fonte diMitza Pidighi128 . Il tipo è stato rinvenuto anche nelsito di Kommos a Creta129, in livelli del LH IIIB,coevi ai contesti a ceramica grigia nuragica del BRisolano. In realtà anche le forme di Fig. 9: 3-4 do-cumentano il tipo precedentemente descritto e piùprecisamente quello di tav. 351: 10130 riferibile al
109 CAMPUS 2003, fig. 23: 15110 CAMPUS 2003, fig. 24: 5111 CAMPUS, LEONELLI 2000, tav. 308: 3, p. 491112 RELLI 1994, tav. IV: 46, p. 69113 USAI, MARRAS 2005, fig. 6:1114 CAMPUS, LEONELLI 2000, tav. 321: 13, pp. 499-500115 FERRARESE CERUTI 1983, fig. 7: 16, p. 196116 CONTU 1966, fig. 14: 1, p. 177117 SEBIS 1995, tav. VIII: 38, p. 118118 CAMPUS, LEONELLI 2000, tav. 347: 8, 11, pp. 513-514119 BADAS 1992, tav. VIII: GBM 47b, p. 74120 SEBIS 1994, tav. VII:3, p. 105121 CAMPUS, LEONELLI 2000, tav. 348: 12-13, p. 514122 SANTONI 1986, fig. 5:3, p. 104123 SANTONI 1992a, tav. IV: SP 1-1031, p. 182124 SANTONI 1992a, tav. III: SP 1-896125 SANTONI 1978, fig. 4:2, p. 93126 COSSU, PERRA 1998, fig. 4:10, p. 105127 LO SCHIAVO, USAI 1995, fig. 10:7128 USAI 2000, tav. V:9129 WATROUS 1989, fig. 3: c, p. 79130 CAMPUS, LEONELLI 2000
137
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU): lo scavo e i materiali della torre F
Fig. 10. Meana Sardo, Nuraghe Nolza. Olle e tegami decorati a pettine dalla US 80 della torre F (dis. S. Sechi).
138
Mauro Perra
Fig. 11. Meana Sardo, Nuraghe Nolza. Tegami decorati a pettine dalla US 80 della torre F (dis. S. Sechi).
139
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU): lo scavo e i materiali della torre F
Fig. 12. Meana Sardo, Nuraghe Nolza. Tegami decorati a pettine dalla US 80 della torre F (dis. S. Sechi).
140
Mauro Perra
frammento in ceramica grigia dall’abitato proto-storico di S. Gemiliano131. Tutte le forme seguentidella Fig. 9 e della Fig. 10: 1-2 appartengono altipo 912 Ol 147 (tavv. 353-54, pp. 517-18). Il fram-mento di Fig. 9:5 e quello relativo alla Fig. 10: 1 siconfrontano con un pezzo da S. Gemiliano diSestu132, con frammenti dallo strato BR del cortileB dell’Arrubiu di Orroli133 e con un’olla dall’esedradella tomba di Bidistili di Fonni134, ma il tipo è pre-sente anche a Kommos135 . La forma di Fig. 9: 6 èdecorata da un motivo ad angoli con linee rette ver-ticali secanti ottenuto con leggere solcature astecca. Motivi simili sono conosciuti nel reperto-rio vascolare del vano I del nuraghe Nolza, in uncontesto caratterizzato dalla presenza di ceramichedecorate a pettine136, nel nuraghe S. Antine di Tor-ralba137 e nel nuraghe Arrubiu di Orroli, in un con-testo del BR138 . I due frammenti di Fig. 9: 7-8 siriferiscono al tipo 912 Ol. 47F139 proveniente dalsito di Madonna del Rimedio ad Oristano140. La de-corazione si ritrova nei frammenti assolutamentesimili dal vano F1, livello 4 (BR) del nuraghe SuMulinu di Villanovafranca141 e dal nuraghe Sarda-iara di Nurri142.
La scodella miniaturistica di Fig. 10: 3 non trovariscontri convincenti.
Gli impasti dei tegami decorati a pettine im-presso (Figg. 10: 4-11; 11 e 12) sono prevalente-mente neri o grigi, meno spesso bruni o rossicci,argillosi, con inclusi medi e piccoli quarzosi. Lesuperfici interne sono generalmente grigie e li-
sciate, mentre quelle esterne sono brune o rossicce,scabre.
I frammenti raffigurati nella Fig. 10: 4-11 sonoforse tutti pertinenti a pareti e fondi di un unico te-game decorato a pettine impresso, con un motivo ascacchiera formato dall’alternanza di rettangolilisci e rettangoli campiti da fitto punteggiato. L’or-nato a pettine documentato nei frammenti suddettiè abbastanza diffuso nell’ambito culturale della ce-ramica a pettine: nel nuraghe S. Antine143, nel vil-laggio di Serra Orrios di Dorgali144, nel nuraghe S.Pietro di Torpè145, nel nuraghe Don Michele diPloaghe146, con sensibile variante nella decorazionedelle pareti nella tomba di Moru di Arzachena147 enella tomba I di Seleni a Lanusei148.
I motivi decorativi rappresentati dai due tegamidella figura 11: 1-2 sono delle varianti di un mede-simo schema compositivo. Il n. 1 contempla contutta probabilità un cerchio centrale campito dafitto punteggiato dal quale s’irradiano altri cer-chielli: il tutto è circondato da una banda concen-trica dalla quale si dipartono quattro bande angolari“a braccio” alle quali si collegano altrettanti cer-chielli. Il tegame n. 2 propone invece uno schemasimilare, nel quale però i cerchielli pendenti sonocollegati direttamente alla banda concentrica tra-mite brevi segmenti radiali. Il motivo del tegamen. 1 trova riscontro in un frammento dal vano I delnuraghe Nolza149 mentre il n. 2 è rappresentato dalframmento proveniente ancora dal vano I delNolza150. Lo schema a bande concentriche e cer-
131 FORCI, RELLI 1996, tav. IV: 33, p. 53132 FORCI, RELLI 1996, tav. II:14, p. 51133 CAMPUS 2003, fig. 23: 7, 10134 LILLIU 2010, fig. 1:3135 WATROUS 1989, fig. 3a, p. 79136 COSSU, PERRA 1998, fig. 5:2137 BAFICO, ROSSI 1988, fig. 15:3; fig. 16: 3-4138 CAMPUS 2003, fig. 24: 6139 CAMPUS, LEONELLI 2000, tav. 354:5, p. 518140 SEBIS 1995, tav. X:7, p. 120141 UGAS 1987, fig. 5.16:5142 LEONELLI 2001, tav. 14: 4143 BAFICO, ROSSI 1988, fig. 31: 16, fig. 32:3, p. 130144 COCCO 1980, tav. XXXVI: 11, p. 125145 LO SCHIAVO 1978, p. 58, n. 343146 FADDA 1979, p. 55, n. 24147 ANTONA 2008, fig. 4:2148 PERRA 2003b, fig. 183: A1149 COSSU, PERRA 1998, fig. 5: 6150 COSSU, PERRA 1998, fig. 5:5
141
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU): lo scavo e i materiali della torre F
chielli pendenti è stato rinvenuto nei livelli più pro-fondi del villaggio di s’Urbale a Teti151. I motivi rap-presentati nella figura 11: 3-7 possono essereattribuiti indifferentemente ad entrambi gli schemicompositivi descritti, in quanto i materiali sonotroppo frammentari. L’ornato a cerchielli campitida punteggiato a pettine, ma piuttosto differente daquello schematizzato nei tegami del nuraghe Nolza,si rinviene anche all’interno dello strato 61/II-III delBR, nella fonte di Mitza Pidighi di Solarussa152.
I due tegami decorati di figura 11: 8-9 sono as-solutamente simili: un ampio cerchio centrale e duebande concentriche. Il motivo non trova riscontriimmediati se non in un dubbio frammento prove-niente dagli strati del Primo Ferro (?) della torre Adel monotorre Duos Nuraghes di Borore153. Per loschema a bande ortogonali rappresentato nella fi-gura 11: 10 non vi sono raffronti.
Il motivo decorativo rappresentato nella Fig. 12:1 con schema di bande ortogonali si ritrova neglistrati del MBA1b e MBA2 (?) della torre A del nu-raghe Duos Nuraghes di Borore154 e nel repertoriodi Serra Orrios di Dorgali155.
I frammenti di cui alla figura 12: 3-5 propon-gono uno schema a bande radiali che si ritrova frai materiali del nuraghe S. Antine di Torralba156 eancora nel vano I del nuraghe Nolza157.
Per il motivo decorativo a bande curvilinee e ret-tilinee di Fig. 12: 6 non conosco confronti convin-centi. Lo schema a bande curvilinee intersecanti diFig. 12: 7, 9 trova riscontro nei materiali della torreA (LBA2 ?) di Duos Nuraghes158.
Il motivo con cerchio centrale e bande radialiche si dipartono da esso (Fig. 12: 8) si ritrova nelcontesto del S. Antine159.
I frammenti di figura 12: 10-11, decorati da seg-
menti di file a profondo puntinato, raffigurano unmotivo similare presente nel repertorio di Serra Or-rios160 e nella trincea 42 di Duos Nuraghes, stratidel Primo Ferro (?)161.
Infine il motivo raffigurato nella figura 12: 12 pre-senta uno schema circolare campito da fitto e disor-dinato punteggiato a pettine che si ritrova nei contestidel vano I del Nolza162, del S. Antine163 e della torreA del Duos Nuraghes164 e nei tegami decorati dellaUS 43 del vano A di Su Monte di Sorradile165.
Alcune considerazioni conclusivesull’evoluzione delle ceramiche a pettinee sui rapporti con le facies meridionali
La lunga e puntigliosa analisi tipologica che pre-cede queste note si è resa necessaria per identifi-care i contesti del BR isolano, particolarmentequelli della Sardegna meridionale, caratterizzatidalla presenza della ceramica grigia nuragica, coni quali i reperti recuperati nello scavo della US 80della torre F del Nolza condividono una comunetradizione di forme. Si può agevolmente osservarein tal modo che le similitudini formali osservate alconfronto con i reperti del nuraghe Antigori (torreC e torre F) rimandano tutte ai contesti nei quali èpresente la ceramica egea del LH IIIB (1340-1190a.C. in cronologia calibrata). I confronti con i con-testi del livello 4, vano F1 di Su Mulinu, di Su So-nadori, della prima fase del pozzo di Cuccuru isArrius, degli strati del BR del nuraghe Arrubiu nonpossono che confortare questi riferimenti cronolo-gici. Gli stessi richiami al repertorio fittile dei con-testi centro-settentrionali, S. Antine, DuosNuraghes e Serra Orrios nonché Su Monte di Sor-
151 COSSU, PERRA 1998, p. 98152 USAI 2000, tav. VIII: 14153 WEBSTER 2001, fig. 4.30:4154 WEBSTER 2001, fig. 3.10:13, 20 e 3.31:12155 COCCO 1980, fig. XXXVI:18156 BAFICO, ROSSI 1988, p. 130, figg. 31:15 e 32:2157 COSSU, PERRA 1998, fig. 5: 7,8-10158 WEBSTER 2001, fig. 4.2:5159 BAFICO, ROSSI 1988, p. 126, fig. 31:5160 COCCO 1980, tav. XXXVI:5161 WEBSTER 2001, fig. 4.41:13162 COSSU, PERRA 1998, fig. 5:3163 BAFICO, ROSSI 1988, p. 130 fig. 31:14164 WEBSTER 2001, fig. 4.52: 6165 SANTONI, BACCO 2008, figg. 21:2, 5-6 e 22:1
142
Mauro Perra
radile, contribuiscono a suffragare l’ipotesi che lecategorie fittili della torre F siano da riferire ad unafase iniziale del BR isolano. La struttura del vano I,lo abbiamo già detto, è stata costruita quando furonoabbandonati una serie di ambienti fra i quali la ca-mera F e la scala H. Lo stesso repertorio fittile delvano sembra indicare una certa recenziorità rispettoa quello analizzato nella US 80 della torre F, cheappare relativo ad una fase iniziale del BR (BR 1), astretto contatto cronologico con gli esiti del BM 3,ovvero con la fase della ceramica a decoro metopale.Il quadro dell’analisi tipologica precedentementeenucleato contribuisce a confermare tale ipotesi se sidà il giusto peso alla presenza di caratteri tecnico-formali e decorativi del contesto in questione, chechiaramente richiamano un retaggio culturale rife-ribile al BM3. Mi riferisco particolarmente alle sco-delle con flesso interno (Fig. 4: 5-6), alle scodelle ealle ciotole con presine bifide, talora con trattamentodelle superfici interne al nero-lucido, da intendersichiaramente come un precedente delle tecniche spe-rimentate nella ceramica grigia (Fig. 4:12), alle pro-fonde tazze carenate (Fig. 8:3,5) con simile trat-tamento delle superfici interne, al vaso a listello in-terno, e infine la stessa decorazione “metopale” a ri-quadri campiti di fitto punteggiato della fig. 10: 4-11che rimanda all’ornamentazione di alcune pissidi eche da esse presumibilmente deriva. Gli stessi ri-chiami al nuraghe Bruncu Madugui, a Su MuruMannu e a Seleni I di Lanusei, tutti da riferire alBM3, sono dirimenti in tal senso. Sia Su MuruMannu sia Seleni I in particolare sono attribuibili adun orizzonte tardo del BM3, cronologicamente con-tiguo al BR, orizzonte enucleato chiaramente nellostrato 3c del cortile B del nuraghe Arrubiu166, ancoracaratterizzato dalla presenza delle pissidi e dai fram-menti dell’alabastron miceneo datato da Lucia Va-gnetti alla fine del LH III A:2, cioè alla secondametà del XIV secolo a.C.167. La cronologia dell’ala-bastron dell’Arrubiu costituisce pertanto il terminuspost quem per la datazione del contesto della US 80
della torre F. La datazione ottenuta con l’idratazionedell’ossidiana nello strato 10 del vano “a” dell’An-tigori168, caratterizzato dalla presenza di ceramicagrigia associata a ceramiche egee del LH IIIB, perquanto da utilizzare con estrema prudenza, riportaproprio al BR1, con un range cronologico compresofra il 1340 e il 1250 BC.
Di recente si è voluto ribadire169 la tesi che il BRisolano si possa distinguere in due facies distinte,BR1 e BR2, sulla scorta di una proposta di G.Ugas170, ripresa negli Atti del Convegno “Il BronzoRecente in Italia”171 . I due aspetti, cronologicamentedistinti, prendono il nome dai contesti di Su MuruMannu172, che sarebbe il più antico, e di Antigorirappresentante quello avanzato, quest’ultimo carat-terizzato dalla comparsa della ceramica grigia nura-gica. Osservo in primo luogo che la facies di SuMuru Mannu (BR1) è ancora caratterizzata dallacompresenza di pissidi decorate secondo stilemi me-topali e da tegami decorati a pettine, quindi relativaad una fase tarda del BM3 che precede immediata-mente il BR, la stessa identificata nello strato 3c delcortile B del nuraghe Arrubiu173 e datata dall’alaba-stron miceneo. Solamente chi ha scarsa dimesti-chezza con la ceramica decorata a pettine puòconfondere frammenti pertinenti pissidi ornate se-condo lo stile metopale dei triangoli con verticeverso il basso con l’ornato del fondo di un tegame “apettine”. La chiara tendenza a sottovalutare l’unita-rietà e l’omogeneità dei contesti di Su Muru Mannue del nuraghe Arrubiu, che presentano una nettacommistione di tratti formali e tecnologici fra BM3e BR, viene spesso asserita sulla base di una pretesa“confusione di strati”. Sono al contrario sempre piùnumerosi i contesti della Sardegna centro-setten-trionale che possono essere riferiti a questa fase, ca-ratterizzati dalla prima apparizione della ceramicadecorata a pettine associata con gli esiti della fase aornato metopale (o BM 3B): ad es. le tombe di Se-leni I di Lanusei174 e Sa Pattada di Macomer175; l’in-sediamento di Su ’e Predi Giaccu di Meana (scavi
166 COSSU 2003167 LO SCHIAVO, VAGNETTI 1993168 MICHELS et Alii 1984169 CAMPUS, LEONELLI 2006b; DEPALMAS 2009b170 UGAS 1998171 UGAS et Alii 2004172 SANTONI 1985173 COSSU 2003174 PERRA 2003b175 FADDA 1998
143
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU): lo scavo e i materiali della torre F
inediti T. Cossu e M. Perra) e la fonte di Mitza Pidi-ghi strato 61/IV176. Nei contesti meridionali oltre al-l’Arrubiu si evidenziano con una certa nettezza irepertori fittili del villaggio di Mitza Purdia177, delnuraghe Trobas di Lunamatrona (scavi inediti C. Pu-xeddu), e del nuraghe Pitzu Cummu, nello stesso am-bito comunale178, dove la decorazione metopale ècaratterizzata dalla presenza dell’ornato strisciato ea radi punti impressi non più circoscritti in campituretriangolari. In secondo luogo è utile evidenziare ilfatto che sia nel nuraghe Arrubiu (strato 13 della torreA), sia nel nuraghe Antigori (ambiente “a”, torre Cecc.) le ceramiche grigie sono già presenti negli stratipiù profondi del BR. Sulla base di queste osserva-zioni mi pare di poter asserire che sono ancora rari icontesti nei quali si possa distinguere su base strati-grafica una fase antica del BR da una più evoluta eche pertanto le proposte finora avanzate si basano piùsu delle interessanti suggestioni che su una solidacampionatura statistica dei contesti e dei tipi cera-mici; esse appaiono in sintesi come delle semplifica-zioni di un problema ben più complesso.
Bisogna dare atto a Salvatore Sebis e alle sue ri-cerche nel Campidano di Oristano di aver perprimo intuito che la ceramica a pettine si articola indue fasi cronologicamente distinte: una relativa agliesiti del BM che si accompagna alla presenza dellepissidi e l’altra del BR179. Alle due fasi di Sebis sene potrebbe aggiungere una terza, che abbraccial’orizzonte cronologico del BF iniziale (seguendoin questo il simile percorso della ceramica grigianuragica), come appare verosimile in diverse loca-lità della Sardegna fra le quali ad es. S’Urbale diTeti (ciotole carenate inedite esposte nel Museo Ci-vico) e Mitza Pidighi di Solarussa180.
A seguito di tali considerazioni mi sembra dipoter asserire che quella delle ceramiche decorate apettine non è una facies archeologica nell’ampiosenso datole da Renato Peroni181, così come non loè quella della ceramica grigia nuragica. In questosenso faccio mie le perplessità di diversi autori182 ela definizione di facies archeologica proposta in un
recente contributo di Daniela Cocchi Genick183. Inaltri termini l’identificazione di una facies deve tenerpresenti tutti gli aspetti che il record archeologicooffre all’osservazione degli studiosi, dalle modalitàd’insediamento alla sfera funeraria, dai contatti e lecomunicazioni esterne all’ideologia religiosa ecc..In tal senso sia la ceramica decorata a pettine sia laceramica grigia possono essere più utilmente defi-nite come gruppi locali di una facies unitaria: quellanuragica dell’età del Bronzo Medio o del BronzoRecente o del Bronzo Finale. I cambiamenti e le tra-sformazioni del corpus fittile nuragico si accompa-gnano e spesso sono il portato di trasformazioni piùvaste coinvolgenti la sfera sociale e politica, religiosaed economica ecc.. Fra il BM 3 ed il BF inizialesono in atto profonde trasformazioni, quali la stabi-lizzazione dell’insediamento, l’adozione della formacompiuta del nuraghe complesso a tholos e taloral’abbandono di quella del nuraghe a corridoio, il pro-gressivo abbandono della tomba di giganti classicae dei rituali ad essa connessi e poi la prima frequen-tazione di sacelli e templi a pozzo, fonti, templi amegaron, rotonde ecc.184 . Per quel che riguarda laproduzione fittile, i più evidenti ed importanti cam-biamenti, più che fra BM3 e BR, nel corso dei qualiè evidente una notevole continuità, si osservano fraBR e BF 1, con la progressiva scomparsa di forme edecorazioni e l’apparizione/affermazione di catego-rie vascolari di pregio particolarmente legate al bere,quali i boccali e le brocchette, gli attingitoi, i vasi adalto collo imbutiforme con anse a gomito rovescio,le scodelline con risega nella parete interna (10/12cm di diam.) ecc.
La rara pubblicazione di contesti archeologicinuragici completi di catalogo e disegni dei mate-riali, specie nel Nuorese dove è un male cronico,impedisce di fatto un approccio analitico alla com-plessità del problema della seriazione fra le diversefasi dello sviluppo storico della civiltà nuragica,nonché il costante incrocio fra i dati del contestoed una rigorosa tipologia del repertorio fittile edella cultura materiale in genere.
176 USAI 2000177 SANNA 1986178 LOCCI 2001179 SEBIS 1992180 USAI 2000, p. 49181 PERONI 1978, 1994, 1998182 PERONI 1996, pp. 168-169; CAMPUS, LEONELLI 2006b, p. 378; DEPALMAS 2009b, p. 134183 COCCHI GENICK 2005, p. 7184 PERRA 2009
144
Mauro Perra
ANTONA A. 2008, Tombe di giganti in Gallura. Nuove ac-quisizioni, in Atti del Convegno “La civiltà nuragica:nuove acquisizioni” Senorbì 14-16 dicembre 2000, Vol.II, Dolianova, pp. 713-728.
ATZENI E. 1987, Il tempio a pozzo di Cuccuru Nuraxi, Set-timo S. Pietro, Cagliari (nota preliminare), in “La Sar-degna nel Mediterraneo tra il secondo e il primomillennio a. C.”, Atti del II Convegno di Studi “Un mil-lennio di relazioni tra la Sardegna e i Paesi del Medi-terraneo” Selargius – Cagliari, pp. 279-297.
ATZENI E. 2004, La scoperta delle statue-menhir. Tren-t’anni di ricerche archeologiche nel territorio di La-coni, Cagliari.
BADAS U. 1985, I materiali nuragici, in LILLIU C. (a curadi) “Territorio di Gesturi – Censimento Archeologico”,Comune di Gesturi, Amministrazione Provinciale, As-sessorato alla Cultura R.A.S., pp. 151-175.
BADAS U. 1992, Il nuraghe Brunku Madugui di Gesturi.Un riesame del monumento e del corredo ceramico, inQuaderni della Soprintendenza Archeologica per leProvince di Cagliari e Oristano 9, pp. 31-76.
BAFICO S., ROSSI G. 1988, Il nuraghe S. Antine di Tor-ralba: scavi e materiali, in MORAVETTI A. (a cura di), Ilnuraghe S. Antine nel Logudoro – Meilogu, Sassari.
CAMPUS F. 2001, Il nuraghe Adoni di Villanovatulo: i ma-teriali, in SANGES M.(a cura di) “L’eredità del Sarci-dano e della Barbagia di Seulo, Patrimonio diconoscenza e di vita, Muros, pp. 197-201.
CAMPUS F. 2003, L’età del bronzo recente: dal contenitoreal contenuto; le ceramiche del nuraghe Arrubiu: ca-ratteristiche, funzioni, uso, distribuzione, in COSSU T.,CAMPUS F., LEONELLI V., PERRA M., SANGES M. (a curadi), La vita nel nuraghe Arrubiu, Quartu S. Elena, Do-lianova, pp. 57-74.
CAMPUS F., LEONELLI V. 2000, La tipologia della cera-mica nuragica. Il materiale edito, Viterbo.
CAMPUS F., LEONELLI V. 2006a, Due contesti del Bronzorecente dal nuraghe Adoni di Villanovatulo (NU), Cro-nache di Archeologia 5, pp. 13-45.
CAMPUS F., LEONELLI V. 2006b, La Sardegna nel Medi-terraneo fra l’età del Bronzo e l’età del Ferro. Propo-sta per una distinzione in fasi, in Studi di Protostoriain onore di Renato Peroni, Firenze, pp. 372-392.
CANINO G. 2008, Il pozzo nuragico nella chiesa di SantaMaria Madalena a Guamaggiore (Cagliari). Nota pre-liminare, in La civiltà nuragica. Nuove acquisizioni,Atti del Congresso (Senorbì 14-16 dicembre 2000), VolII, Dolianova, pp. 391-404.
CASTALDI E. 1975, Domus nuragiche, Roma.COCCHI GENICK D. 2005, Considerazioni sull’uso del ter-
mine “facies” e sulla definizione delle facies archeo-logiche, Rivista di Scienze Preistoriche, LV, pp. 5-27.
COCCO D.1980, Il villaggio nuragico di Serra Orrios: Imateriali fittili, in Dorgali. Documenti archeologici,Sassari, pp. 115-140.
CONTU E. 1966, Considerazioni su un saggio di scavo alnuraghe La Prisciona di Arzachena, Studi Sardi XIX
(1964-65), p. 149-260.COSSU T. 2001, Il nuraghe Is Paras di Isili: campagna di
scavo 1998, in SANGES M. (a cura di), L’eredità del Sar-cidano e della Barbagia di Seulo, Patrimonio di cono-scenza e di vita, Muros, pp. 174-175.
COSSU T. 2003, L’età del Bronzo Medio: i primi nuraghie l’occupazione dell’altopiano di Pran’e Muru, inCOSSU T., CAMPUS F., LEONELLI V., PERRA M., SANGES
M. (a cura di ), La vita nel nuraghe Arrubiu, Quartu S.Elena, Dolianova, pp. 15-31.
COSSU T, PERRA M. 1998, Two Contexts of the BronzeAge in the Nuraghe Nolza of Meana Sardo (Nuoro), inMORAVETTI A. (a cura di), Papers from the EAA ThirdAnnual Meeting at Ravenna 1997 Vol. III: Sardinia =BAR International Series 719, pp. 97-109.
COSSU T., PERRA M. 2002, Rinvenimenti da siti nuragicidella Sardegna Centrale, in Etruria e Sardegna centro-settentrionale tra l’età del bronzo finale e l’arcaismo,Atti del Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Sassari,Alghero, Oristano, Torralba, 13-17 ottobre 1998, Pisa –Roma, pp. 511-522.
COSSU. T, PERRA M. 2004, Le pendici occidentali e sud-occidentali del massiccio del Gennargentu, nelle re-gioni storiche della Barbagia di Belvì (Meana Sardo edel Mandrolisai (Teti, Sorgono, Atzara, Samugheo), inLO SCHIAVO ET ALII 2004, pp. 363-365.
COSSU T., PERRA M. 2008, I sistemi territoriali della Bar-bagia-Mandrolisai e della Marmilla, in CAMPUS ET ALII
(a cura di) Il paesaggio nuragico sull’altopiano di Pra-n’e Muru, Arrubiu 1, Comune di Orroli, pp. 119-130.
COSSU T., SABA A. 2000, Il nuraghe Is Paras, Isili.DEPALMAS A. 2009a, Il Bronzo Medio della Sardegna, Atti
della XLIV Riunione Scientifica, La preistoria e la pro-tostoria della Sardegna, Vol. I, Firenze, pp. 123-130.
DEPALMAS A. 2009b, Il bronzo recente della Sardegna, Attidella XLIV Riunione Scientifica, La preistoria e la pro-tostoria della Sardegna, Vol. I, Firenze, pp. 131-140.
FADDA M. A.1979, Il nuraghe Don Michele di Ploaghe, inContributi su Giovanni Spano, Sassari, pp. 47-57.
FADDA M. A.1984, Il nuraghe Monte Idda e la ceramicaa pettine in Sardegna, in The Deya Conference of Pre-history, B. A.R., International Series 229, pp. 671-702.
FADDA M. A.1998, Nuovi elementi di datazione dell’Etàdel Bronzo Medio: lo scavo del nuraghe Talei di Sor-gono e della tomba di giganti Sa Pattada di Macomer,in BALMUTH M. S., TYKOT R. eds, Sardinian and AegeanChronology. Towards the Resolution of Relative andAbsolute dating in the Mediterranean, Proceedings ofthe International Colloquium “Sardinian Stratigraphyand Mediterranean Chronology” Tufts University, Med-ford, Massachusetts, March 17-19, 1995, pp. 179-193.
FERRARESE CERUTI M. L. 1978, in FERRARESE CERUTI M.L., GERMANÀ F., Sisaia. Una deposizione in grotta dellacultura di Bonnannaro, Quaderni della SoprintendenzaArcheologica delle province di Sassari e Nuoro 6, Sas-sari.
FERRARESE CERUTI M. L.1979, Ceramica micenea in Sar-
BIBLIOGRAFIA
145
Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU): lo scavo e i materiali della torre F
degna (Notizia preliminare), in Rivista di Scienze Prei-storiche XXXIV, pp. 242-252.
FERRARESE CERUTI M. L.1980, Grotta Sas Furmicas, inDorgali. Documenti Archeologici, Sassari, pp. 71-78.
FERRARESE CERUTI M. L. 1981, Documenti micenei nellaSardegna meridionale, in Ichnussa. La Sardegna dalleorigini all’età classica, Milano, pp.605-612.
FERRARESE CERUTI M. L.1982, Il complesso nuragico diAntigori (Sarroch, Cagliari), in Magna Grecia e mondomiceneo, Nuovi documenti, catalogo a cura di L. Va-gnetti = XXII convegno di studi sulla Magna Grecia,Taranto 7-11 ottobre 1982, Napoli 1982, pp. 167-176.
FERRARESE CERUTI M. L. 1983, Antigori: la torre f delcomplesso nuragico di Antigori (Sarroch, Cagliari) –Nota preliminare, in Magna Grecia e mondo miceneo,Atti del XXII convegno di studi sulla Magna Grecia,Taranto 7-11 ottobre 1982, Taranto 1983, pp. 187-206.
FERRARESE CERUTI M. L.1986, I vani c, p, q del complessonuragico di Antigori (Sarroch, Cagliari), in Traffici mi-cenei nel Mediterraneo, Problemi storici e documenta-zione archeologica = Atti del convegno di Palermo,11-12 maggio, 3-6 dicembre 1984, Taranto 1986, pp.183-188.
FERRARESE CERUTI M. L. 1995, Nuovi elementi dallagrotta funeraria di Tanì (Carbonia), in SANTONI V. (acura di), Carbonia e il Sulcis, archeologia e territorio,Oristano, pp. 97-113.
FERRARESE CERUTI M. L., LO SCHIAVO F.1991-92, La Sar-degna, in L’età del Bronzo in Italia nei secoli dal XVIal XIV a. C., Rassegna d’Archeologia 10, pp. 123-141.
FORCI A., RELLI R. 1996, Ceramiche vascolari nuragichein pasta grigia da S. Gemiliano di Sestu (Ca), in Qua-derni della Soprintendenza Archeologica per le pro-vince di Cagliari e Oristano 12, pp. 41-53.
GIORGETTI S. 1986, Il villaggio di S. Itroxia nel territoriodi Sinnai, Studi Sardi XXVI, (1981-1985), pp. 17-30.
LEONELLI V. 2001, Il nuraghe Sardaiara di Nurri: i mate-riali, in SANGES M. (a cura di), L’eredità del Sarcidanoe della Barbagia di Seulo, Patrimonio di conoscenza edi vita, Muros, pp. 178-182.
LILLIU G.1982, La civiltà nuragica, Sassari.LILLIU G.1988, La civiltà dei sardi dal paleolitico all’età
dei nuraghi, Torino.LILLIU G.1989, Meana dalle origini all’alto medioevo, in
Meana. Radici e tradizioni, Cagliari, pp. 29-100.LILLIU G. 2010, La tomba di giganti di Bidistili e i templi
a “megaron” della Sardegna nuragica, Sardegna Ar-cheologica, Scavi e ricerche 4, Sassari.
LOCCI M. C. 2001, Il nuraghe Pitzu Cummu di Lunama-trona, in “Territorios Megaliticos del Mediterraneo(Gorafe (Granada, Espa a) Sa Corona Arrùbia (Ca-gliari, Cerde a, Italia), Granata”, pp. 132-140.
LO SCHIAVO F.1978, Nuraghe S. Pietro, Torpè, in SardegnaCentro-orientale dal neolitico alla fine del mondo an-tico, Sassari, pp. 109-110.
LO SCHIAVO F. ET ALII 2004, La Sardegna. Articolazionicronologiche e differenziazioni locali. La metallurgia,in (a cura di COCCHI GENICK D.) L’età del bronzo re-cente in Italia, Atti del Congresso Nazionale 26-29 ot-tobre 2000, Viareggio – Lucca, pp. 357-382.
LO SCHIAVO F. , USAI L.1995, Testimonianze cultuali dietà nuragica: la grotta Pirosu in località Su Benatzu diSantadi, in SANTONI V. (a cura di), Carbonia e il Sulcis.Archeologia e territorio, Oristano, pp. 147-186.
LO SCHIAVO F., VAGNETTI L. 2003, Alabastron miceneo dalnuraghe Arrubiu di Orroli (Nuoro), Rendiconti del-l’Accademia dei Lincei serie IX, IV, 1, pp. 121-148.
MANCA DEMURTAS L., DEMURTAS S. 1984, I protonuraghi(nuovi dati per l’Oristanese), in The Deya Conferenceof Prehistory, BAR International Series 229, pp. 629-672.
MICHELS J. W. ET ALII 1984, Obsidian Hydratation datingin Sardinia, en BALMUTH, ROWLANDS (eds.), Stu-dies in Sardinian Archaeology, pp. 25-53.
MORAVETTI A. 1986, Nota preliminare agli scavi del Nu-raghe S. Barbara di Macomer, Nuovo Bullettino Ar-cheologico Sardo 3, Sassari, pp. 49-113.
MORAVETTI A. 2001, Gli interventi del 1975-77 nel nura-ghe Is Paras di Isili, in SANGES M. (a cura di), L’ereditàdel Sarcidano e della Barbagia di Seulo, Patrimonio diconoscenza e di vita, Muros, pp. 170-173.
NUVOLI P. 1990, Il villaggio nuragico di S. Marco, SettimoS. Pietro, Quaderni della Soprintendenza Archeologicadelle Province di Cagliari e Oristano 6, pp. 35-49.
PERONI R.1978, Le prime popolazioni dell’età dei metalli,in FASANI L. (a cura di), Archeologia. Culture e civiltàdel passato nel mondo europeo e extraeuropeo, Milano,pp. 139-170.
PERONI R. 1994, Introduzione alla protostoria italiana,Roma-Bari.
PERONI R. 1996, L’Italia alle soglie della storia, Bari.PERONI R. 1998, Classificazione tipologica, seriazione
cronologica, distribuzione geografica, Aquileia NostraLXIX, pp. 10-27.
PERRA M. 2003a, L’età del bronzo finale: la “bella età”del nuraghe Arrubiu e la ricchezza delle genti di Pra-n’e Muru, in COSSU T, CAMPUS F., LEONELLI V., PERRA
M., SANGES M. (a cura di), La vita nel nuraghe Arrubiu,Quartu S. Elena, Dolianova, pp. 77-91.
PERRA M. 2003b, Lanusei (Nuoro). Località Seleni, Bol-lettino di Archeologia 43-45, pp. 258-265.
PERRA M. 2008, Un sistema territoriale nuragico nellaBarbagia-Sarcidano e il nuraghe Nolza di MeanaSardo (Nuoro), in Atti del Convegno “La civiltà nura-gica: nuove acquisizioni” Senorbì 14-16 dicembre2000, Vol. II, Dolianova, Soprintendenza per i Beni Ar-cheologici per le province di Cagliari e Oristano, pp.659-670.
PERRA M. 2009, Osservazioni sull’evoluzione sociale epolitica in età nuragica, Rivista di Scienze Preistori-che LIX, pp. 355-368.
PERRA M., COSSU T. 2003, Meana Sardo (Nuoro). Loca-lità Su Pranu. Nuraghe Nolza. Campagne 1994-97, inBollettino di Archeologia 43-45, pp. 247-253.
RELLI 1994, La torre C del complesso nuragico di Antigori(Sarroch): seconda nota allo scavo del vano superiore,in Quaderni della Soprintendenza Archeologica per leProvince di Cagliari e Oristano, 11, pp. pp. 41-72.
SANGES M. 2000, Il nuraghe Adoni di Villanovatulo, inSANGES M. (a cura di), L’eredità del Sarcidano e della
146
Mauro Perra
Barbagia di Seulo, Patrimonio di conoscenza e di vita,Muros, pp. 193-196.
SANNA R.1986, Materiali nuragici da Mitza Purdia (De-cimoputzu-Cagliari), Studi Sardi XXVI, pp. 63-91.
SANTONI V. 1978, Il villaggio nuragico di Tharros. Cam-pagna 1977, in Rivista di Studi Fenici VI, pp. 81-96.
SANTONI V. 1985, Il villaggio nuragico di Su MuruMannu, in Rivista di Studi Fenici XIII, 1, pp. 33-140.
SANTONI V. 1986, Le stazioni nuragiche dello stagno di S.Gilla (Cagliari), in S. Igia – capitale giudicale, Contri-buti all’incontro di studio “Storia, ambiente fisico e in-sediamenti umani nel territorio di S. Gilla”, Cagliari3-5 novembre 1983, Pisa, pp. 59-117.
SANTONI V. 1987, Le stazioni nuragiche all’aperto nel-l’entroterra del golfo di Cagliari, in La Sardegna nelMediterraneo tra il secondo e il primo millennio a.C.,Atti del II Convegno di Studi “Un millennio di rela-zioni tra la Sardegna e i Paesi del Mediterraneo” Selar-gius – Cagliari, pp. 63-88.
SANTONI V. 1992a, Nuraghe Piscu di Suelli: documentimateriali del Bronzo Medio – Recente, in La Sardegnanel Mediterraneo tra il Bronzo Medio e il Bronzo Re-cente (XVI-XIII sec. a.C.), Atti del III Convegno diStudi “Un millennio di relazioni fra la Sardegna e iPaesi del Mediterraneo”, Selargius-Cagliari 19-22 no-vembre 1987, pp. 167-185.
SANTONI V. 1992b, Il nuraghe Baumendula di Villaurbana– Oristano. Nota Preliminare, in Sardinia Antiqua.Studi in onore di P. Meloni in occasione del suo set-tantesimo compleanno, pp. 123-151.
SANTONI V. 1994, Il nuraghe Losa di Abbasanta. L’archi-tettura e la produzione materiale nuragica, in AA.VV.,Il nuraghe Losa di Abbasanta 1, Quaderni della So-printendenza Archeologica per le province di Cagliarie Oristano, vol. 10, supplemento, pp. 5-110.
SANTONI V., BACCO G. 2008, Il bronzo recente e finale diSu Monte – Sorradile (Oristano), in Atti del Convegno“La civiltà nuragica: nuove acquisizioni” Vol. II, Se-norbì 14-16 dicembre 2000, Dolianova, pp. 543-656.
SANTONI V., SEBIS S. 1985, Il complesso nuragico “Ma-donna del Rimedio” – Oristano, Nuovo Bullettino Ar-cheologico Sardo 1, Sassari, pp. 97-114.
SEBIS S.1982, Cuccuru S’Arriu. Nota preliminare di scavo(1978-79-80), in Rivista di Studi Fenici X, 1, pp. 102-127.
SEBIS S.1987, Ricerche archeologiche nel Sinis centro-meridionale. Nuove acquisizioni di età nuragica, in LaSardegna nel Mediterraneo tra il secondo e il primomillennio a. C., Atti del II Convegno di Studi “Un mil-lennio di relazioni tra la Sardegna e i Paesi del Medi-terraneo”, Selargius – Cagliari, pp. 107-116.
SEBIS S.1992, Siti con ceramica “a pettine” del Campi-dano Maggiore e rapporti con la facies Bonnannaro B,in La Sardegna nel Mediterraneo tra il Bronzo Medioe il Bronzo Recente (XVI-XIII sec. a. C.), Atti del IIIConvegno di Studi “Un millennio di relazioni fra la Sar-degna e i paesi del Mediterraneo”, Selargius-Cagliari19-22 novembre 1987, Cagliari, pp. 135-144.
SEBIS S. 1994, I materiali del villaggio nuragico di SuCungiau ‘e Funtà nel territorio di Nuraxinieddu, Qua-derni della Soprintendenza Archeologica per le pro-vince di Cagliari e Oristano 11, pp. 89-109.
SEBIS S.1995, La ceramica nuragica del Bronzo Medio((XVI-XIV sec. a. C.) e del Bronzo Recente ((XIII-XIIsec. a. C.) nell’Oristanese, in AA.VV. La ceramica ar-tistica, d’uso e da costruzione nell’Oristanese dal neo-litico ai giorni nostri, Oristano, pp. 101-120.
UGAS G. 1987, Un nuovo contributo per lo studio dellatholos in Sardegna. La fortezza di Su Mulinu di Villa-novafranca, in Studies in Sardinian Archaeology III ,B.A.R. 387, pp. 77-128.
UGAS G.1989, L’età nuragica. Il Bronzo medio e il Bronzorecente, in Il museo archeologico nazionale di Cagliari,Sassari.
UGAS G.1998, Considerazioni sulle sequenze culturali ecronologiche tra l’Eneolitico e l’epoca nuragica, in M.S. BALMUTH, R. TYKOT (a cura di), Sardinian andAegean Chronology. Towards the Resolution of Rela-tive and Absolute dating in the Mediterranean, Procee-dings of the International Colloquium “SardinianStratigraphy and Mediterranean Chronology” TuftsUniversity, Medford, Massachusetts, March 17-19,1995, pp. 251-272.
UGAS G. ET ALII 2004, La ceramica, in L’età del bronzorecente in Italia, in COCCHI GENICK D. (a cura di ), Attidel Congresso Nazionale 26-29 ottobre 2000, Viareggio– Lucca, pp. 399-410.
USAI A. 1989, La stazione nuragica di Sa Serra (Serrenti– Cagliari), Quaderni della Soprintendenza Archeolo-gica per le province di Cagliari e Oristano 5, pp. 65-76.
USAI A.1996, Gli insediamenti nuragici nelle località diMuru Accas e Pidighi e la fonte nuragica di Mitza Pi-dighi (Solarussa, OR), campagne di scavo 1994-95,Quaderni della Soprintendenza Archeologica per leprovince di Cagliari e Oristano 13, pp. 45-71.
USAI A.1998, Scavi nelle tombe di giganti di Tanca ‘e Sueie di Tanca ‘e Perdu Cossu (Norbello, OR), in Quadernidella Soprintendenza Archeologica per le province diCagliari e Oristano, 15, pp. 122-149.
USAI A. 2000, Nuove ricerche nell’insediamento di nura-ghe Pidighi e nella fonte nuragica “Mitza Pidighi”(Solarussa – Or). Campagne di scavo 1996-1999, inQuaderni della Soprintendenza Archeologica per leprovince di Cagliari e Oristano 17, pp. 41-68.
USAI A., MARRAS V. 2005, Scavi nel nuraghe Su Sonadori(Villasor – CA). Campagne 1994-2000, in La civiltànuragica. Nuove acquisizioni, Atti del Congresso (14-16 dicembre 2000), Vol. I, Quartu S. Elena, pp. 181-207.
WATROUS L. W. 1989, A preliminary report on imported“Italian wares” from Late Bronze Age site of Kommoson Crete, in Studi Micenei ed Egeo-Anatolici XXVII,2, pp. 69-79.
WEBSTER G. S. 2001, Duos Nuraghes. A Bronze Age Set-tlement in Sardinia, Vol. 1, The Interpretive Archaeo-logy, BAR Int. Series 949, Oxford.





































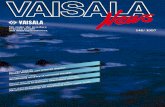









!["Painting and the Counter Reformation in the Age of Rubens", in [Cat. Exhib.], The Age of Rubens, Museum of Fine Arts, Boston, 1993, pp. 131-146.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631bcd81d5372c006e04201f/painting-and-the-counter-reformation-in-the-age-of-rubens-in-cat-exhib-the.jpg)

