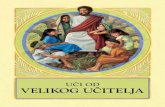Una proposta esegetica per Od. 10.80-86
-
Upload
mondodomani -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Una proposta esegetica per Od. 10.80-86
reDazione:“Sapienza” Università di Roma, dip. di Scienze dell’Antichità, piaz zale A. Moro 5, I00185 Roma; tel. ++3906.49913604, fax ++3906.4451393 email [email protected]à di Roma “Tor Vergata”, dip. di Antichità e tradizione classica, via Columbia 1, I00133 Roma; tel. ++3906.72595066; fax ++3906.72595046 email [email protected]
amministrazione:Edizioni Quasar, via Ajaccio 4143, I00198 Roma; tel. 0684241993 email [email protected]
© Roma 2012, Edizioni Quasar di Severino Tognon srl, via Ajaccio 4143, I00198 Roma; tel. 0684241993, fax 0685833591, email [email protected]
ISSN 11295953
direttore responsabile: Roberto Nicolai
Registrazione Tribunale di Roma n. 146/2000 del 24 marzo 2000
Finito di stampare nel mese di marzo 2012 da dynago Solutions
Od. 10. 8086eJxh'mar me;n oJmw'" plevomen nuvkta" te kai; h\mar: 80eJbdomavth/ d∆ iJkovmesqa Lavmou aijpu; ptoliveqron,Thlevpulon Laistrugonivhn, o{qi poimevna poimhvnhjpuvei eijselavwn, oJ dev t∆ ejxelavwn uJpakouvei.e[nqa k∆ a[u>pno" ajnh;r doiou;" ejxhvrato misqouv",to;n me;n boukolevwn, to;n d∆ a[rgufa mh'la nomeuvwn: 85ejggu;" ga;r nuktov" te kai; h[matov" eijsi kevleuqoi.
Per sei giorni navigammo di continuo, notte e giorno; 80al settimo giungemmo alla scoscesa rocca di Lamo,Telepilo Lestrigonia, dove un pastore rientrando salutal’altro pastore, mentre quello, uscendo, risponde.Lì un uomo insonne prenderebbe doppio stipendio,uno pascolando i buoi, l’altro le pecore argentee: 85vicini infatti sono i sentieri della Notte e del Giorno1.
Questi versi provengono dalla sezione dell’Odissea, ll. IXXII, nota già nell’antichità come ∆Alkivnou ajpovlogoi, ovvero i racconti che Odisseo fa alla corte di Alcinoo del proprio novsto", da quando l’eroe acheo con la sua flotta salpa da Troia fino al suo approdo sull’isola di Calipso, dopo aver perduto tutti i compagni. I versi introducono all’avventura nella terra dei Lestrigoni, la quarta terra sconosciuta toccata dall’eroe dopo la tempesta di Capo Malea: prima vi erano stati i Lotofagi, i Ciclopi, l’isola vagante di Eolo. È noto che Odisseo, con i suoi compagni, dopo la tempesta che lo coglie nel doppiare il capo Malea, si perde in un universo anomalo, popolato da esseri magici o mostruosi, lontani dal mondo raccontato nell’Iliade, con i suoi eroi campioni
* Vorrei esprimere la mia gratitudine ai proff. Emanuele dettori, Riccardo Palmisciano, Livio Sbardella, che hanno seguito questo lavoro fin dalle prime fasi di elaborazione e mi hanno sostenuta con i loro consigli e indicazioni.
1 Come emergerà dal confronto con testimonianze parallele che chiaramente rimandano allo stesso contesto tematico, qui la mia scelta di tradurre con la lettera maiuscola si giustifica per il fatto che il testo non fa riferimento a notte e giorno come fenomeni astronomici ma come entità mitiche autonome (così già intendeva Klausen nel 1834, apud Meuli 1931, col. 538, e così Arrighetti 1975, p. 148 ss.; vd. inoltre infra in particolare § 1).
PaoLa argenziano
«Vicini sono i sentieri della Notte e del Giorno»: una proposta esegetica per Od. 10. 8086
estratto
72 P. Argenziano
di grecità e la familiare solennità degli dei olimpici. La narrazione odissiaca, ricorrendo a nuclei tematici che assomigliano ai nostri racconti di fiaba, vuole sottolineare la completa alterità del mondo in cui il suo eroe si trova a vagare. Giovanni Cerri2 recentemente ha posto in rilievo con molta chiarezza che per i greci dei secoli bui oltre il canale di Sicilia scorreva l’impetuoso e terribile Oceano, con tutto il suo corredo di terre sconosciute. L’Oceano è trattato anche nella poesia cosmogonica e cosmologica come limite al di là del quale scompare ogni traccia di umanità e la realtà si confonde gradualmente in un’unità caotica3, dov’è il dominio oscuro di divinità preolimpiche.
I versi dell’Odissea oggetto della presente analisi risultarono di difficile interpretazione già nel mondo antico: gli scoli al passo rimandano ad ipotesi interpretative risalenti almeno a Cratete di Mallo (fr. 50 Broggiato). La difficoltà esegetica non è stata superata, a mio modo di vedere, dagli studi moderni, nonostante le molte interpretazioni proposte. Intendo dunque proporre una nuova ipotesi interpretativa che si fonda esclusivamente sul confronto con altri testi della letteratura greca arcaica; questi, infatti, costituiscono un sistema di riferimenti molto coerente ed omogeneo sul piano cronologico e del contesto culturale.
Il passo dà l’impressione di un vero e proprio enigma nel quale si sovrappongono e si incrociano varie difficoltà interpretative, legate ai nomi propri che ricorrono ai vv. 81-82 (1), di carattere concettuale (2) e “topografico” (3):
1) chi o che cosa è Lamo? Nel sintagma Thlevpulon Laistrugonivhn qual è l’aggettivo e quale il sostantivo?
2a) perché in quel luogo un pastore potrebbe guadagnare doppio stipendio? Quali sono le condizioni che in quella terra lo rendono possibile?
2b) cosa significa che i sentieri della Notte e del Giorno sono vicini?3) e dove lo sono?È chiaro che i punti 2 e 3 devono spiegarsi a vicenda; lo sottolinea anche
il testo omerico con la congiunzione esplicativa gavr al verso 864. Premetto subito che in queste pagine proporrò un’ipotesi interpretativa per questi ultimi due punti. Non credo infatti che possa trovarsi una soluzione definitiva per gli interrogativi del punto 1: sono nomi che compaiono solo in Omero o in altri luoghi letterari che sembrano dipendere direttamente dal brano omerico5. La loro origine è sconosciuta, la loro forma fa pensare ai nomi parlanti delle fiabe, piuttosto che a luoghi e personaggi del patrimonio mitico greco6.
2 Cerri 2006.3 Mi riferisco in particolare ai versi 720819 della Teogonia di Esiodo.4 Come già evidenziato da Germain 1954, p. 518, e Vos 1963, p. 18.5 Vd. Meuli 1931, coll. 537538.6 Il nome Lavmo" appartiene ad una famiglia di parole che implicano tutte l’idea di voracità, sfron
tatezza (DELG s. v. lamurov") e Lamia nella tradizione popolare greca, ma anche latina, fino alla tarda antichità, è un’orchessa divoratrice di bambini (Aristoph. Pax 757, Vesp. 1035, Strab. 1. 2. 9 [C 19],
estratto
73«Vicini sono i sentieri della Notte e del Giorno»: una proposta esegetica per Od. 10. 80-86
1. Luoghi letterari paralleli: la porta della Notte e del GiornoIl v. 86 è un verso formulare che ricorre quasi identico (salvo che per il
primo metro e mezzo e per il caso di kevleuqo") in Parmenide, B 1. 11 d.K.7. Si tratta dei primi versi del poema sulla natura dove il poeta, con un’allegoria che è volta a significare la veridicità della sua dottrina8, racconta di essere stato trasportato su un carro guidato dalle figlie del Sole alle porte della Notte e del Giorno, dove dike gli rivela il «cuore saldo della verità ben rotonda». Per riprendere le parole di Cerri9, siamo in un contesto di tipo “astronomico”:
Parmen. B 1. 621 d.K. a[xwn d∆ ejn cnoivh/sin i{ei suvriggo" ajuthvn aijqovmeno" (doioi'" ga;r ejpeivgeto dinwtoi'sinkuvkloi" ajmfotevrwqen), o{te spercoivato pevmpeinÔHliavde" kou'rai, prolipou'sai dwvmata Nuktov",eij" favo", wjsavmenai kravtwn a[po cersi; kaluvptra". 10e[nqa puvlai Nuktov" te kai; “Hmatov" eijsi keleuvqwn,kaiv sfa" uJpevrquron ajmfi;" e[cei kai; lavino" oujdov":aujtai; d jaijqevriai plh'ntai megavloisi qurevtroi":tw'n de; Divkh poluvpoino" e[cei klhi>>'da" ajmoibouv".th;n dh; parfavmenai kou'rai malakoi'si lovgoisin. 15pei'san ejpifradevw", w{" sfin balanwto;n ojch'aajpterevw" w[seie pulevwn a[po: tai; de; qurevtrwncavsm∆ ajcane;" poivhsan ajnaptavmenai polucavlkou"a[xona" ejn suvrigxin ajmoibado;n eijlivxasaigovmfoi" kai; perovnhisin ajrhrovte: th'/ rJa di∆ aujtevwn 20ijqu;" e[con kou'rai kat∆ ajmaxito;n a{rma kai; i{ppou".
Suono d’organo l’asse mandava nelle sue sedisurriscaldato (era mosso da entrambe le ruote rotanti
Tertull. adv. Valent. 3. 3): il nome forse anticipa l’incontro con il popolo di mostri cannibali. La parola Laistruvgone" ha origine sconosciuta e nessuna delle spiegazioni etimologiche proposte risulta pienamente soddisfacente (vd. Ebeling 1885 s. v. Laistruvgone"). Tra le interpretazioni più recenti segnalo quella di Tsopanakis 1992, p. 8, il quale riconnette il nome al sostantivo lh/sthvr facendolo derivare, in modo a mio avviso poco convincente, da una forma *lhi>strogovne" «con mutamento eolico (Cipro) di o > u [...] e conservazione del carattere ionico della radice e una indefinita funzione di gen/gon-». Tuttavia, anche se il legame etimologico non è corretto (e la funzione del suffisso lasciata indefinita) il processo di associazione di idee, come mi ha suggerito Emanuele Dettori, potrebbe funzionare ugualmente per paretimologia: anche questo nome alluderebbe alla violenza degli esseri a cui si lega questa avventura. Thlevpulo", infine, la “porta lontana” o, come vorrebbe Page 1983, p. 43, la “porta possente”, è nome perfettamente in linea con l’idea di lontananza cosmica che il poeta vuole conferire all’ambientazione dell’episodio; ma su quest’argomento vd. infra.
7 Od. 10. 86 ejggu;" ga;r nuktov" te kai; h[matov" eijsi kevleuqoi ~ Parm. B 1. 11 d.K. e[nqa puvlai Nuktov" te kai; “Hmatov" eijsi keleuvqwn. Come mi ha fatto notare Emanuele dettori l’avverbio di luogo presente in Parmenide (e[nqa) lo ritroviamo, nella stessa posizione del verso, in Omero subito sopra, al v. 84.
8 Vd. in proposito Cerri 1999, p. 96 ss.9 Cerri 1999, al v. 11.
estratto
74 P. Argenziano
da una parte e dall’altra), mentre a spronare si affaticavanole figlie del Sole, appena uscite dalla casa della Notte,verso la luce, dopo essersi tolte il velo dal capo. 10Lì è il portale che segna il cammino della Notte e del Giorno,un architrave gli fa da cornice e una soglia petrigna,lo chiudono grandi battenti che toccano il cielo:la Giustizia preposta alle pene detiene le chiavi girevoli.Rivolgendosi a lei le fanciulle con dolci parole 15seppero ben persuaderla e togliere subito viadalla porta la spranga a serrami; attraverso i battentischiuse la porta un vuoto infinito, mentre s’aprivaruotando nelle bandelle argute i cardini di bronzo,con ferramenta e chiodi ben fissi; dritto lì dentro 20le fanciulle guidarono lungo la strada le cavalle ed il carro.(trad. di G. Cerri)
La formularità del v. 11, oltre che il tema, indicano con chiarezza che i due luoghi svolgono un tema mitico comune, con il quale il pubblico di età arcaica doveva avere evidentemente confidenza; rispetto al passo dell’Odissea, Parmenide porta informazioni supplementari. Sappiamo, cioè, che i sentieri di Notte e Giorno passano attraverso una porta che arriva fino al cielo, dai grandi battenti, con soglia di pietra e cardini di bronzo, al di là della quale si apre una voragine immensa10; questo ci autorizza a sottolineare un dato del testo omerico, la menzione di Thlevpulo" (v. 82), che altrimenti sarebbe poco significativo e di interpretarlo come allusione alla porta cosmica, elemento chiave di questa immagine mitica. Il testo parmenideo, inoltre, fa riferimento alla dimora della Notte, abitata tuttavia anche dalle figlie del Sole, dato che esse l’abbandonano per guidare il filosofo verso la porta cosmica.
Queste informazioni non sono isolate ma compaiono già nella Teogonia di Esiodo (vv. 720819), in versi che contribuiscono ad ampliare ulteriormente l’immagine mitica che stiamo cercando di delineare. Si tratta di una sezione di testo particolarmente problematica, in cui Esiodo in modo catalogico descrive l’aldilà con le creature che lo abitano11, utilizzando avverbi di luogo assai generici (e[nqen, provsqen, pevrhn)12, con localizzazioni che di volta in volta sembrano suggerire una strutturazione orizzontale o verticale di questa parte
10 La presenza di dike sembra un’invenzione di Parmenide estranea al tema mitico originario; sulla sua funzione all’ingresso della porta e sul suo significato nel proemio vd. Cerri 1995, p. 462, e Cerri 1999, p. 104 ss.
11 I Titani imprigionati nel Tartaro (vv. 720735; 813814); il grande abisso (cavsma mevga) dove si confondono i principi dei quattro elementi (736743; 807819); Atlante, Notte e Giorno, la dimora e la porta di Notte (743757); Sonno e Notte (758766); Ade e Cerbero (767773); Stige (775806).
12 Sul valore di tali indicatori spaziali nelle descrizioni relative all’aldilà vedi, ad esempio, West 1966, pp. 357, 370, 379, Arrighetti 2007, p. 538, Cerri, in particolare 1995, p. 438, Johnson 1999, p. 10.
estratto
75«Vicini sono i sentieri della Notte e del Giorno»: una proposta esegetica per Od. 10. 80-86
di universo13. I luoghi che interessano al nostro ragionamento sono principalmente quelli che si riferiscono al Giorno e alla Notte. Le informazioni tratte da questi versi, oltre ad essere coerenti con quelle già ricavate da Parmenide, costituiscono un ulteriore segnale del fatto che il passo dell’Odissea oggetto della presente analisi faccia riferimento proprio a tale collocazione cosmologica.
Esiodo descrive la voragine immensa che si apre ai confini del mondo, dove si confondono le radici ed i confini di terra, Tartaro, mare e cielo14:
Hes. Th. 744757 [kai; Nukto;" ejremnh'" oijkiva deinave{sthken nefevlh/" kekalummevna kuanevh/si.]15 745tw'n provsq∆ ∆Iapetoi'o pavi" e[cei oujrano;n eujruvneJsthw;" kefalh'/ te kai; ajkamavth/si cevressinajstemfevw", o{qi Nuvx te kai; ÔHmevrh a\sson ijou'saiajllhvla" proseveipon ajmeibovmenai mevgan oujdovncavlkeon: hJ me;n e[sw katabhvsetai, hJ de; quvraze 750e[rcetai, oujdev pot∆ ajmfotevra" dovmo" ejnto;" ejevrgei,ajll∆ aijei; eJtevrh ge dovmwn e[ktosqen ejou'sagai'an ejpistrevfetai, hJ d∆ au\ dovmou ejnto;" ejou'samivmnei th;n aujth'" w{rhn oJdou', e[st∆ a]n i{khtai:hJ me;n ejpicqonivoisi favo" poluderke;" e[cousa, 755hJ d∆ ”Upnon meta; cersiv, kasivgnhton Qanavtoio,Nu;x ojlohv, nefevlh/ kekalummevnh hjeroeidei'.
… e di Notte oscura la casa terribiles’inalza, da nuvole livide avvolta. 745Di fronte ad essa il figlio di Iapeto tiene il cielo ampioreggendolo con la testa e con le infaticabili braccia,saldo, là dove Notte e Giorno venendo vicinisi salutano passando alterni il gran limitaredi bronzo, l’uno per scendere dentro, l’altro attraverso la porta 750
13 Vd. in particolare il commento di Arrighetti al passo. Ma la contraddittorietà di indicatori spaziali nelle descrizioni dell’aldilà o comunque di terre al confine dell’universo sembra un “universale antropologico” proprio delle culture primitive, vd. infra n. 47.
14 Sono i principi costituenti del mondo visibile (phgai; kai; peivrata, v. 738 = 809), le sue radici (rJizaiv, v. 728); concetti che richiamano, anche lessicalmente, la speculazione dei futuri filosofi naturalisti. Sull’argomento vd. Solmsen 1950, p. 242, Fränkel 1997, pp. 168172, West 1966 ad. loc., e soprattutto Cerri 1998. Sul significato di pei'rar nella poesia greca arcaica si veda Bergren 1975, in particolare pp. 105115.
15 West atetizza i vv. 744745 per ragioni essenzialmente stilistiche. Per argomenti contrari a quelli di West vd. Arrighetti 2007, p. 362, e Johnson 1999, pp. 1718. L’intera sezione dedicata al Tartaro (vv. 720819) è apparsa problematica per il fatto che in essa sembrano susseguirsi visioni del mondo incoerenti tra loro; Jacoby 1930, pp. 2227, ad esempio, individua per questa sezione le voci di ben otto poeti. Sulla opportunità di evitare ricostruzioni analitiche così spinte vedi Stokes 1962; Solmsen 1950, p. 237 ss., evidenzia che l’intera sezione dedicata al Tartaro, sia essa opera di Esiodo o di più poeti, è comunque antica ed ugualmente importante ai fini della ricostruzione del pensiero arcaico.
estratto
76 P. Argenziano
esce, né mai entrambi ad un tempo la casa dentro trattiene,ma sempre l’uno fuori della casala terra percorre e l’altro dentro la casaaspetta l’ora del suo viaggio fin che essa venga;l’uno tenendo per i terrestri la luce che molto vede, 755l’altra ha Sonno tra le sue mani, fratello di Morte,la Notte funesta, coperta di nube caliginosa.(trad. di G. Arrighetti)
Siamo dove Atlante (v. 746) regge instancabile il vasto cielo, ovvero a i c o n f i n i d e l l a t e r r a , d i f r o n t e a l l e E s p e r i d i d a l l a v o c e a c u t a (v. 510): siamo cioè agli estremi occidentali del mondo, al di là della corrente di Oceano16. Atlante sta di fronte alla dimora della Notte, spaventosa, avvolta da nubi scure (vv. 745 e 767)17. Proprio lì18 Notte e Giorno “venendo vicini” si salutano attraversando in modo alterno la grande soglia di bronzo: mentre l’una esce l’altro rientra, e mai la dimora racchiude insieme entrambe le entità, perché quando l’una è fuori l’altra dentro aspetta il momento in cui dovrà uscire, e l’una porta luce ai mortali, l’altra ha tra le mani il Sonno fratello di Morte. L’espressione a\sson ijou'sai costituisce un evidente legame con l’enigmatico passo omerico (cf. ivi ejgguv" del v. 86) consentendo di accostarlo al gruppo di testimonianze che chiaramente si riferiscono alla porta della Notte e del Giorno. Ma c’è anche un altro elemento che lega il brano omerico a quello esiodeo: l’azione di Notte e Giorno che, traversando la grande soglia, si salutano sembra un preciso parallelo dell’azione che l’Odissea attribuisce ai pastori lestrigoni19. Su questo elemento ritornerò più ampiamente in seguito. Per ora basti notare che la presenza di questa azione nei due passi paralleli di Omero ed Esiodo fa pensare che essa probabilmente era parte del mitema dell’alternarsi di Giorno e Notte attraverso la porta cosmica. La sua ripresa, variata, nell’Odissea sarebbe un’ulteriore prova che questi versi si ispirano esattamente al mitema in questione.
16 Ai vv. 274276 si parla delle Gorgoni «che abitano al di là dell’inclito Oceano, al limite estremo del dominio della Notte, dove sono l e Esper id i da l la voce acuta».
17 Secondo Cerri 1999, p. 174, l’oscurità della dimora della Notte è rintracciabile anche in Parmenide nel sintagma wjsavmenai kravtwn a[po cersi; kaluvptra", v. 10, riferito alle figlie del Sole (cf. il suo commento ad loc.).
18 o{qi al v. 748 è avverbio che circoscrive ad una superficie ristretta l’azione mitica dell’attraversamento della soglia, come sottolinea West nella nota ad loc. Questa osservazione (cui si aggiunge il confronto con Od. 10. 86 ejggu;" ga;r nuktov" te kai; h[matov" eijsi kevleuqoi) esclude la possibilità di identificare con l’intero perimetro della superficie terrestre il punto in cui Notte e Giorno si incontrano, soluzione cui aderisce Johnson 1999, pp. 2122, e che pure consentirebbe di evitare l’imbarazzante paradosso implicito nel testo esiodeo per cui Notte e Giorno sorgono e tramontano sulla terra da uno stesso punto ad ovest (ma su tale problematica vd. più ampiamente infra n. 47). Essenzialmente per le stesse ragioni, ovvero per il valore di o{qi e per il confronto con Od. 10. 86, West preferisce la lezione a\sson ijou'sai a ajmfi;" ejou'sai, una variante comunque antica dal momento che sembra echeggiare in Parmenide B 1. 12 d.K.
19 Tale azione, inoltre, in entrambi i passi è introdotta dall’avverbio o{qi (Od. 10. 82; Th. 748).
estratto
77«Vicini sono i sentieri della Notte e del Giorno»: una proposta esegetica per Od. 10. 80-86
Il testo di Esiodo, come ho detto, non è chiarissimo e le indicazioni spaziali appaiono confuse; in questa sezione della Teogonia più volte sono nominate delle porte che segnano il passaggio da una realtà cosmica ad un’altra20:
1. vv. 73273321: le porte di bronzo innalzate da Posidone a serrare la prigione dei Titani, nell’oscurità nebbiosa del Tartaro;
2. v. 74122: porte varcate le quali si piomba in una voragine immensa, battuta da venti terribili, dove si confondono i principi dei quattro elementi23;
3. vv. 74975024: la porta dalla soglia di bronzo attraverso la quale passano Notte e Giorno;
4. v. 77325: le porte dell’Ade sorvegliate dal terribile Cerbero;5. vv. 81181326: le porte luccicanti, dalla soglia di bronzo, autogenerate,
piantate saldamente sulle radici dei quattro elementi. Per Cerri le porte di Notte e Giorno (3) e quelle che introducono al cavo"
cosmico (2 e 5) vanno interpretate come porte dell’Ade (4): l’Ade, luogo di centralità cosmica ed epistemologica, coinciderebbe con la voragine sconfinata (cavsma mevga) dove si confondono i principi primi della realtà fisica27. Ma a me sembra che né nel testo di Esiodo né in testimonianze poetiche parallele ci siano elementi sicuri che consentano questa interpretazione28.
Mi sembra abbastanza chiaro che per i punti 2 e 5 (vv. 741 e 811813) il referente mitico sia lo stesso: i due passi sono immediatamente preceduti dalla menzione del luogo tenebroso dove si confondono i principi dei quattro elementi (vv. 736738 = 807809): la porta affaccia su questo abisso cosmico (cavsma, v. 740, e cavo", v. 814)29. Non sembra che ci siano dati che accomunino questa porta con quella che introduce all’Ade (4, v. 773). Ancora differente è
20 Sul valore delle porte come passaggio, spesso irreversibile (almeno per gli uomini), da una realtà ad un’altra vd. West 1966, al v. 741. Le porte cosmiche per antonomasia dovevano essere quelle di Ade e d’altronde l’antichità della formula ∆Aiv>dao pulavrtao è assicurata anche per ragioni linguistiche (vd. Passa 2008, p. 123). Ma più in generale io direi che le porte, almeno nei poemi omerici, compaiono nei luoghi di confine, metafora del passaggio da una dimensione ad un’altra, senza implicare necessariamente l’idea di irreversibilità; si pensi alle porte dei Sogni limite del passaggio alla dimensione onirica (Od. 4. 809; 19. 562 ss.), alle porte del cielo (Il. 5. 748751 = 8. 392395) nonché alle porte della Notte e del Giorno di cui stiamo parlando (nominate anche in Od. 24. 12, su cui vd. infra p. 81). Tale significato metaforico che può assumere l’immagine delle porte si può rintracciare anche nella pittura vascolare, vd. d’Agostino 1982.
21 toi'" [scil. Tith'si] oujk ejxitovn ejsti, quvra" d∆ ejpevqhke Poseidevwn / calkeiva".22 Th. 736741 e[nqa de; gh'" dnoferh'" kai; tartavrou hjerovento" / povntou t∆ ajtrugevtoio kai;
oujranou' ajsterovento" / eJxeivh" pavntwn phgai; kai; peivrat∆ e[asin, / ajrgalev∆ eujrwventa, tav te stugevousi qeoiv per: / cavsma mevg∆, oujdev ke pavnta telesfovron eij" ejniautovn / ou\da" i{koit∆, eij prw'ta pulevwn e[ntosqe gevnoito.
23 Sui principi degli elementi nominati in questo passo vd. supra n. 14.24 Vd. supra p. 75 s.25 ejsqivei [scil. deino;" kuvwn, Cerbero], o{n ke lavvbh/si pulevwn e[ktosqen ijovnta.26 e[nqa de; marmavreaiv te puvlai kai; cavlkeo" oujdov", / ajstemfh;" rJivzh/si dihnekevessin ajrhrwv", /
aujtofuhv".27 Cerri 1995, Cerri 1998, p. 201, e Cerri 1999, p. 176.28 Sul problema vd. infra, in particolare n. 40.29 Sull’identità di significato di cavo"cavsma vd. soprattutto Solmsen 1950, p. 238.
estratto
78 P. Argenziano
la porta innalzata da Posidone che racchiude i Titani in fondo al Tartaro (1, vv. 732733)30.
Per il momento, dunque, sono distinte nella descrizione esiodea del Tartaro tre porte: 1; 2+5; 4. Resta da esaminare la porta del punto 3 (vv. 749750), dalla soglia di bronzo, attraverso la quale passano Notte e Giorno. È chiaro che non si tratta della porta che serra la prigione dei Titani, isolata in fondo al Tartaro e sorvegliata dai Centimani (1); né è possibile identificarla con la porta di Ade davanti alla quale, guardiano, c’è il terribile Cerbero (4). È questa la parte dell’interpretazione di West cui aderisco, mentre invece dissento dallo studioso inglese quando respinge l’associazione della Porta di Notte e Giorno (3) con quella al di là della quale c’è il cavo" dei quattro elementi (2+5)31.
A mio avviso nella descrizione esiodea del Tartaro ci sono sufficienti elementi che permettono di associare ad un unico referente la porta della Notte e del Giorno (3) e quella che si spalanca sul cavo" primordiale (2+5), sicché si possono riconoscere tre porte: quella creata da Posidone a serrare la prigione dei Titani (1), quella che introduce all’Ade (4) e la porta eterna dalla soglia di bronzo, che si apre su una voragine spiegata, attraversando la quale si avvicendano Notte e Giorno sulla terra (2+5+3). A sostegno di questa interpretazione interviene innanzitutto un’osservazione interna al testo: dal momento che le varie sezioni che compongono la descrizione del Tartaro si susseguono le une alle altre secondo una associazione di tipo tematico, la menzione improvvisa della dimora di Notte (v. 744) subito dopo la descrizione del grande cavsma sembrerebbe implicare che essa coincida con tale abisso, e che dunque la soglia che introduce a tale abisso (v. 741, 2+5) è anche l’ingresso alla dimora di Notte (3) (così anche Johnson 1999). Il confronto con Parmenide costituisce un’ulteriore prova a favore di questa lettura. In primo luogo, in Parmenide, la grande porta di Notte e Giorno si apre su un cavsm∆ ajcanev", una voragine spiegata (B 1. 18); abbiamo visto che nella Teogonia la porta dei passi 2+5 è un varco che introduce ad una voragine immensa (cavsma mevga, v. 740, e cavo", v. 814): nell’immaginario mitico greco arcaico c’era una grande porta che introduceva ad un abisso cosmico e, attraverso questa stessa porta, Giorno e Notte passavano per portare luce o sonno ai mortali. Inoltre al v. 811 del poema esiodeo parte della tradizione manoscritta registra la lezione lavino" “fatta di pietra”, come variante di cavlkeo"32 in riferimento alla soglia (2+5). Petrigna è anche la
30 Così anche West 1966, al v. 741.31 Vd. West 1966, ad 741 e 749. Per West sarebbero dunque quattro le porte nel Tartaro di cui
parla Esiodo.32 Sull’uso dei metalli nelle architetture vedi soprattutto Germain 1954, pp. 153179, che, nel
quadro di un’interessante panoramica sulla percezione dei metalli nelle culture “primitive”, spiega l’uso letterario facendo riferimento al valore rituale del bronzo attestato in Grecia ed in altri luoghi a partire dall’età del ferro (quando il bronzo non era più utilizzato per le incombenze della vita quotidiana perché sostituito dal ferro, e venne quindi circondato da un’aura di sacralità); vd. inoltre West 1966, ad v. 726.
estratto
79«Vicini sono i sentieri della Notte e del Giorno»: una proposta esegetica per Od. 10. 80-86
soglia della porta di Giorno e Notte in Parmenide33. Secondo West si tratta di antiche varianti testuali, per Cerri34 di varianti mitiche oltre che testuali, e le due formule farebbero riferimento alla stessa immagine mitica.
Se ammettiamo che la dimora di Notte è l’abisso cosmico in cui si trovano indistinti le radici e i limiti degli elementi della realtà fisica, le difficoltà esegetiche di Opp. 171935 potrebbero forse trovare una soluzione:
th;n d∆ eJtevrhn [scil. Eris] protevrhn me;n ejgeivnato Nu;x ejrebennhv,qh'ke dev min Kronivdh" uJyivzugo", aijqevri naivwn,gaivh" t∆ ejn rJivzh/si kai; ajndravsi pollo;n ajmeivnw:
L’altra [scil. Eris] la generò per prima Nyx oscura,e l’alto Cronide, che nell’etere ha dimora, la posealle radici della terra, e per gli uomini è molto migliore(trad. di G. Arrighetti).
La difficoltà che nasce dalla collocazione della buona Eris alle «radici della terra», luogo tremendo e odioso persino agli dei (Th. 743), potrebbe risolversi accettando il ragionamento fin qui svolto, per cui la casa della Notte coincide proprio con l’abisso in cui sono, e si confondono, le radici dell’universo. La formula Nu;x ejrebennhv, infatti, richiama per associazione di idee la formula gaivh" t∆ ejn rJivzh/si, perché entrambe sono parte della stessa immagine mitica; la collocazione di Eris alle radici della terra è strettamente connessa con l’immagine della dimora di Notte trasmessa dalla Teogonia36. Il ragionamento potrebbe forse spingersi ancora oltre: la buona Eris dimora nella casa di sua madre come altri figli di Notte, Sonno e Morte, ma anche Giorno luminoso (Th. 744761).
A completamento del quadro che si sta tracciando si debbono aggiungere altri due passi omerici:
33 lavino" oujdov" è formula epica, compare ad es. in Il. 9. 404, Od. 8. 80, h. Ap. 296, vd. West 1966, al v. 811, Cerri 1999, p. 177.
34 Cerri 1995, pp. 461462, e Cerri 1999, p. 177.35 Il verso è problematico anche dal punto di vista linguistico; vedi il commento ad. loc. di West
1978, Verdenius 1985, Arrighetti 2007, Ercolani 2010.36 L’interpretazione della formula gaivh" t∆ ejn rJivzh/si in senso locale ha suscitato delle per
plessità forse eccessive. Mazon, West ed Arrighetti, nei loro commenti ad loc., interpretano la formula metaforicamente, nel senso che “Eris rappresenta un principio fondamentale della vita umana” (Arrighetti) o che “elle est aussi vielle que le monde” (Mazon), benchè l’espressione non si trovi mai impiegata in senso metaforico. In senso locale, come una realtà cosmologica, la intende invece Verdenius (ad loc.) per il quale la presenza di Eris alle radici della terra si giustifica con l’idea che essa impregna di sé tutto l’esistente e la vita umana, attribuendo anche ad Esiodo l’immagine, abbastanza diffusa nel pensiero arcaico, della terra come un albero; egli dunque non lega la formula alla menzione della Notte al v. 17. Ercolani 2010, ad loc., seguendo Cerri 1995, vede nell’Ade il luogo in cui si trovano i principi generativi dell’esistente, e dunque nell’Ade sarebbe da collocare la buona Eris.
estratto
80 P. Argenziano
Il. 8. 1316h[ min eJlw;n rJivyw ej" Tavrtaron hjeroventath'le mavl∆, h|ci bavqiston uJpo; cqonov" ejsti bevreqron,e[nqa sidhvreiaiv te puvlai kai; cavlkeo" oujdov",tovsson e[nerq∆ ∆Aiv>dew o{son oujranov" ejst∆ ajpo; gaivh":
oppure l’afferro e lo scaglio fra le nebbie del Tartaro,lontanissimo, dove sotterra è più fondo l’abisso,dove sono le porte d’acciaio e la soglia di bronzo,tanto al di sotto dell’Ade, quanto il cielo è lontano dalla terra(trad. di G. Cerri).
I vv. 15 e 16 sono versi formulari che ricorrono quasi identici rispettivamente in Th. 721 e 811. Anche in questo nuovo accenno all’aldilà il testo non è del tutto chiaro: il Tartaro si trova nel punto più profondo dell’abisso sotterraneo, tanto lontano dall’Ade quanto il cielo lo è dalla terra (v. 16); anche in Esiodo il verso è utilizzato per indicare la distanza infinita del Tartaro, con la variante uJpo; gh'" in luogo di ∆Aiv>dew. La menzione della porta dalla soglia di bronzo al v. 15 è introdotta da e[nqa, avverbio di luogo che ricorre martellante nell’excursus esiodeo sull’aldilà (vv. 720814) a separare le varie sezioni del catalogo di entità oltremondane, senza mai implicare una chiara collocazione spaziale37. Kirk segnala il parallelismo con Th. 81138, ma sostiene che le porte di cui si parla in questo passo dell’Iliade si troverebbero al livello del Tartaro: si tratterebbe dunque di una nuova porta nell’aldilà, posta giù nel Tartaro, diversa da quella di cui parla Esiodo al v. 811 della Teogonia, nonostante l’identità della formula. L’interpretazione di Kirk mi pare motivata dal fatto che i versi nel complesso parlano del Tartaro, della sua spaventosa profondità oltre il baratro che si apre sotto la terra: il contesto di riferimento è il Tartaro e lì si dovrà intendere la porta menzionata. Ma se la chiave di interpretazione è quella dell’associazione di idee, processo compositivo comune nella poesia greca arcaica, bisogna segnalare che al v. 14, subito prima della menzione delle porte, è nominato il bevreqron che si spalanca sotto la superficie terrestre, per cui con buona sicurezza le puvlai vanno intese come il varco da cui si accede a questa voragine39. Si tratta quindi di una porta dalla soglia di bronzo, varcata
37 Vd. supra n. 12.38 Kirk 1990, p. 297, ad 1316. Anche qui c’è una piccola variante formulare: marmavreiai in luogo
di sidhvreiai; entrambi gli aggettivi evidenziano le stesse caratteristiche, splendore e durezza.39 I termini cavo"cavsma non compaiono mai in Omero. Il termine bevreqron è usato nei poemi
omerici solo due volte: nel brano appena analizzato ed in Od. 12. 94 in riferimento all’antro di Scilla; è interessante notare che il verbo caivnw, abbastanza raro in Omero, nelle forme dell’aoristo (cavne, cavnoi) fa riferimento esclusivamente alla terra che si spalanca, al cavsma gh'". L’associazione di bevre-qron omerico e cavo"cavsma esiodeo è giustificata anche da una considerazione di tipo semantico. Infatti i termini usati da Esiodo hanno la stessa radice di caivnw (IE *gheh2-), verbo che, abbiamo visto, è spesso usato in Omero in riferimento a fauci che si spalancano, mentre bevreqron deriva dalla radice *gwer- (con esito eolico della labiovelare), da cui tra l’altro bibrwvskw ed il lat. voro, vorago.
estratto
81«Vicini sono i sentieri della Notte e del Giorno»: una proposta esegetica per Od. 10. 80-86
la quale si piomba in un baratro profondo: nulla impedisce di identificarla con la porta di cui parla Esiodo (2+5+3), con cui ha in comune anche la descrizione formulare40.
Altro passo significativo è Od. 24. 1114:
pa;r d∆ i[san ∆Wkeanou' te rJoa;" kai; Leukavda pevtrhn,hjde; par∆ ÔHelivoio puvla" kai; dh'mon ∆Oneivrwnh[i>san: ai\ya d∆ i{konto kat∆ ajsfodelo;n leimw'na,e[nqa te naivousi yucaiv, ei[dwla kamovntwn.
Andarono oltre le correnti di Oceano e la Rupe Biancae oltre le porte del Sole e la regione dei Sogni;e presto giunsero al prato degli asfodeli,dove hanno sede le anime, immagini degli estinti(trad. di V. di Benedetto).
Hermes conduce nell’Ade le anime dei pretendenti; per giungervi esse oltrepassano la corrente di Oceano, la Pietra Bianca41, le Porte del Sole ed il popolo dei Sogni; al riguardo lo scoliasta avverte che il popolo dei Sogni sta per la notte. Nonostante qui si parli di Sole e non di Giorno, è verosimile ritenere che la porta in questione, collocata al di là di Oceano e connessa alla notte, sia la porta attraverso la quale si alternano Notte e Giorno sulla terra: il passo è omogeneo al gruppo di testimonianze finora prese in esame.
2. La terra dei LestrigoniRicapitoliamo tutte le informazioni sul mitema della porta della Notte e del
Giorno ricavabili dai passi presi in esame: essa si trova ai confini (occidentali)
40 Cerri 1995 interpreta la porta nominata in Il. 8. 1316 come porta dell’Ade per due ragioni fondamentali: 1) per la ricorrenza dell’avverbio e[nqa che nella tradizione epicotragica funziona come una sorta di «Schlagwort per l’evocazione del mondo infernale [...] Quasi che l’Ade fosse in qualche modo il luogo per eccellenza, la località per antonomasia» (p. 438); 2) perché sia in Omero sia nel resto della poesia arcaica «quando si parla dell’aldilà, la porta è la porta di Ade» (p. 439). Sulla base di questa identificazione Cerri considera ingresso dell’Ade anche le porte del Sole in Od. 24. 12 e le porte della Notte e del Giorno nominate in Th. 749750, le prime perché compaiono nel testo omerico subito prima della menzione del prato di asfodeli, le seconde essenzialmente per la menzione della soglia di bronzo in comune con Il. 8. 15. Allo stesso modo sono ingresso dell’Ade le porte nominate in Th. 741 (che sono le stesse di Th. 749750 perché vengono nominate subito prima) e quelle in Th. 811 (per il verso formulare comune con Il. 8. 15). Infine anche la porta menzionata nel proemio parmenideo è la porta che introduce al regno dei morti, coerentemente con la diffusa (ma non universalmente accettata) lettura del viaggio di Parmenide come catabasi nell’Ade. Tuttavia io credo che la presenza di e[nqa in Il. 8. 1316 non possa essere considerata, da sola, una prova che in quel passo si stia parlando di Ade; inoltre, se è vero che l’associazione delle porte con Ade è tradizionale (si pensi agli epiteti eujrupulhv" e pulavrth"), non è vero che essa è unica, anzi, per limitarci solo ad Omero, l’immagine delle porte compare spesso ad indicare la transizione da una dimensione ad un’altra (vd. supra n. 20).
41 Per le problematiche relative a questo toponimo mitico vedi Heubeck 2004, nota a Od. 24. 11 e Ballabriga 1986, p. 54.
estratto
82 P. Argenziano
del mondo, ben piantata sulle scaturigini della terra, del Tartaro, del mare e del cielo (Esiodo). Al di là di essa si apre una voragine immensa (Omero nell’Iliade, Esiodo, Parmenide), dove i principi primi della realtà fisica si confondono nel Chaos (Esiodo). Gli aggettivi che ad essa si riferiscono ne denotano la grandezza e lo splendore. Essa introduce alla dimora della Notte avvolta dall’oscurità (Esiodo e Parmenide; la menzione della notte compare anche in Od. 24. 12 secondo l’interpretazione dello scolio). Quando Giorno è fuori ad illuminare i mortali, Notte aspetta nella dimora, e così fa Giorno quando Notte attraversa la terra; mai la dimora racchiude insieme entrambe le divinità (Esiodo). Esse si salutano traversando la grande porta, l’unico momento in cui si trovano ad essere vicine (Esiodo, Omero), l’una per uscire tra i mortali, l’altra per rientrare (Esiodo, Omero – trasferendo però l’azione mitica ai pastori lestrigoni).
L’accostamento dei passi presi in esame nel precedente paragrafo non è nuovo nella critica moderna: per lo più si trae la conclusione che i versi alludano ad una piuttosto vaga collocazione cosmica del contesto originario dei Lestrigoni42; poi però la notizia, fornita nei vv. 8485, della possibilità per un pastore insonne di guadagnare doppio stipendio viene inevitabilmente interpretata come allusione a luce perpetua o a giornate di sole lunghissime, per cui l’ambientazione dell’episodio omerico sarà nell’estremo nord, o nell’estremo est, o a nord est43. Il v. 86 («vicini infatti sono i sentieri della Notte e del Giorno») viene quindi generalmente spiegato alla luce di queste straordinarie condizioni astronomiche.
Eppure il testo in nessun punto parla di luce perpetua, o giornate lunghissime. La mia interpretazione, anziché partire dai vv. 8485, si basa sull’unico
42 Vd. ad esempio Germain 1954, p. 520 ss., Hölscher 1991, p. 141 ss., West 1997, p. 407, che argomentano anche sulla base del confronto con altri racconti tradizionali, e Frame 1978, pp. 5963.
43 Mi riferisco ai tentativi di localizzazione topografica proposti già in età antica: dagli scoli al passo sappiamo che Cratete (fr. 50 Broggiato) interpretava i vv. 8485 come allusioni alle brevi notti estive al Polo nord, e quindi collocava l’avventura all’estremo nord del disco terrestre; tra i critici moderni che interpretano i vv. 8485, e quindi il v. 86, come riferimento alla luce solare nell’estremo nord ricordo Gisinger 1929, col. 534, Germain 1954, p. 524 (ma vd. infra n. 44), Stanford 1959, ad loc., Page 1983, p. 45 ss., Frame 1978, pp. 5963, Hölscher 1991, p. 141, Tsopanakis 1992, p. 8, Cerri 1995, p. 443, West 1997, p. 407, Ballabriga 1998, pp. 112139, danek 1998, p. 199, West 2005, pp. 4748. Pensano invece alle condizioni astronomiche di un estremo est sempre luminoso Vos 1963, Heubeck 2003, p. 266, che fornisce altra bibliografia, e Nakassis 2004. Riporto per completezza un’altra interpretazione, anch’essa rintracciabile negli scoli al passo, secondo la quale le condizioni astronomiche della terra dei Lestrigoni sarebbero normali, ma lì i pastori guadagnerebbero doppio stipendio pascolando le pecore di giorno e le mandrie di notte per evitare i tafani (ipotesi sostenuta in epoca moderna da Hennig 1934, pp. 7985, e da Pocock 1958, pp. 109111); tale ipotesi, oltre a fondarsi su prove esigue, non tiene conto del dato astronomico del v. 86 (vd. Meuli 1931, col. 539, Germain 1954, p. 517). Ulteriore bibliografia al riguardo è in Arrighetti 1975, p. 148 ss. Infine sul processo di “storicizzazione del mito” (l’espressione è di Alfonso Mele), rintracciabile almeno a partire da Esiodo (Th. 10111016 e fr. 150. 26 M.W.) in base al quale le avventure di Odisseo furono localizzate nel Mediterraneo occidentale, vd. Braccesi 1993, Mele 1997, Cerri 2006.
estratto
83«Vicini sono i sentieri della Notte e del Giorno»: una proposta esegetica per Od. 10. 80-86
dato sicuro presente nel testo, l’informazione del v. 86, che trova conferma, ed è spiegata, dai luoghi della poesia arcaica sopra discussi. Sulla base di quanto detto sin qui, infatti, si deve fornire per l’avventura dei Lestrigoni u n a l o c a l i z z a z i o n e c h i a r a e d e t t a g l i a t a , ma non sul piano geografico, quanto su quello della cosmologia mitica: la poesia omerica colloca i Lestrigoni nei pressi della porta della Notte e del Giorno, luogo mitico della poesia cosmologica44, dove appare immensa, dalla soglia di bronzo, accesso alla dimora di Notte avvolta dal-le nubi, che è il baratro in cui si confondono le radici ed i confini dell’universo. Con questo abbiamo risposto al terzo degli interrogativi iniziali (p. 72); a partire da questo dato possono sciogliersi anche le problematiche di ordine concettuale espresse al punto 2.
Che cosa significa che i sentieri della Notte e del Giorno sono vicini (2b)? Il senso dell’avverbio ejgguv" (Od. 10. 86) si chiarisce solo alla luce dell’espressione esiodea a\sson ijou'sai (Th. 748) e del mitema ivi descritto: esso fa riferimento al momento in cui le entità mitiche di Notte e Giorno si trovano vicine perché si incontrano traversando la porta di bronzo, l’una rientrando nella dimora comune, l’altra diretta verso il mondo degli uomini45; la porta, come abbiamo visto, è metafora del passaggio da una dimensione ad un’altra46; tutto il mitema è immagine dell’alternarsi sulla terra del giorno e della notte47.
44 Così anche Germain 1954, pp. 517525, che però elimina i vv. 8485 considerandoli tardi, «nés postérieurement, d’une réflexion de l’ancien texte, compris de façon matérialiste, dans un sens géographique, quand ce “bout du monde” aurait été assimilé aux extrémités réelles que représentaient les terres nordiques avec leurs longues journées d’été» (p. 524).
45 diversamente Vos 1963 che collega l’avverbio ejgguv" di v. 86 ai versi precedenti e intende dunque che presso i Lestrigoni si trova il luogo attraverso il quale Notte e Giorno si muovono; dello stesso parere anche Heubeck 2003, ad. loc., che tuttavia non argomenta la sua interpretazione. Secondo Vos il verso farebbe dunque riferimento a tutto il percorso degli astri attraverso la volta celeste (aijqhvr), zona sempre luminosa: i Lestrigoni godrebbero di luce perenne proprio perché posti in prossimità dell’aijqhvr; l’unico modo in cui si può essere vicini a questo percorso è all’estremità del disco terrestre, sul quale, secondo Vos, si pensava che l’aijqhvr fosse appoggiato come la sezione di una sfera; i Lestrigoni sono all’estremità orientale del disco terrestre perché fanno parte del gruppo delle avventure narrate negli Apologhi che, secondo Vos, sono chiaramente dislocate in oriente (Lestrigoni, Circe, Ade, Sirene, Scilla, Cariddi, Trinachia). Questa interpretazione, oltre a partire dal presupposto, indimostrato, che i Lestrigoni si trovino ad est e che godano di perpetua luce, non tiene conto del chiaro parallelo esiodeo e aggiunge così ulteriori problemi alla lettura del passo.
46 Vd. supra n. 20.47 L’idea che Notte e Giorno entrino ed escano dalla stessa porta, ad occidente, è parsa imba
razzante ad alcuni critici in quanto, sul piano logico, dovrebbe portare con sé quella che il sole sorga e tramonti ad occidente. Ma si tratta del tipico falso problema che si determina applicando categorie di interpretazione razionalistica alle immagini mitiche; «Esiodo non avrebbe nemmeno capito le nostre domande» (Hölscher 1991, p. 135). Eppure continuano i tentativi di conciliare l’immagine mitica con la nostra esigenza di razionalismo; tra i più recenti segnalo quello di Scodel 2003, in un articolo di difficile reperimento, che l’autrice mi ha gentilmente inviato e per questo la ringrazio: in esso la studiosa ricostruisce per il percorso del sole un circuito ad otto con la porta della Notte e del Giorno nel punto in cui la linea torna su se stessa, ipotesi che mi pare nasca solo dall’esigenza di avere un’unica porta dalla quale gli astri entrino ed escano. Interessante, benché discutibile, è l’ipotesi di Stokes 1962, il quale sostiene che, razionalmente, l’immagine
estratto
84 P. Argenziano
Rimane da trattare l’altro spinoso interrogativo di natura concettuale (2a): perché lì un pastore potrebbe guadagnare doppio stipendio (vv. 8485)? Quali sono le condizioni che in quella terra lo rendono possibile? L’interpretazione più diffusa, secondo la quale i versi in questione alluderebbero a giornate di luce perpetua, o quasi, non trova alcuna conferma nel testo omerico.
Al riguardo la mia ipotesi di interpretazione coincide in parte con quella proposta da Ruth Scodel (2003) ed è semplicemente una logica conseguenza della localizzazione proposta per i Lestrigoni.
I Lestrigoni si trovano nei pressi della porta della Notte e del Giorno: quando sulla terra c’è luce, al di là della porta c’è Notte; quando invece è Notte a stare tra i mortali, dall’altra parte della porta c’è Giorno; è quanto ci dice chiaramente il testo di Esiodo. dunque negli Apologhi i Lestrigoni, abitanti di questo luogo liminale, si trovano nella condizione di poter raggiungere sempre, facilmente, la zona illuminata da Giorno. Lì, mentre un pastore si ritira alla fine della sua giornata lavorativa, l’altro esce con il suo gregge, perché la luce lì è raggiungibile, seguendo Giorno al di qua o al di là della porta. Lì un uomo a[u>pno", evitando la Notte (che tiene ”Upno" tra le mani, cf. Th. 756), e portando le sue greggi alternativamente al di qua ed al di là della porta al seguito di Giorno, potrebbe guadagnare in ventiquattro ore lo stipendio di due giornate lavorative48.
Tuttavia, a mio avviso, questi dati negli Apologhi sono frutto di un’ulteriore, e autonoma, elaborazione del mitema rintracciabile chiaramente in Esiodo e Parmenide: a partire dall’immagine mitica di Notte e Giorno che si alternano sulla terra traversando contemporaneamente, in direzioni opposte, la grande porta dalla soglia di bronzo, l’Odissea ha elaborato la notizia di un popolo di orchi antropofagi, i Lestrigoni, che abita nei pressi di questa porta cosmica ai confini del mondo e, conseguentemente, l’idea che esso possa usufruire continuamente della luce solare traversando la soglia insieme a Giorno. Sono dati che non trovano riscontro nella tradizione poetica che fa riferimento alla
esiodea funziona solo se si colloca la porta in un punto equidistante da est ed ovest, e dunque sottoterra. Questo sembra in contrasto con il dato esiodeo che colloca la dimora di Notte alle estremità occidentali del mondo, ma la contraddizione si può anche superare considerando che una caratteristica del pensiero greco arcaico, che sembra un universale del pensiero ‘primitivo’, è il sovrapporsi di orientamenti spaziali contraddittori nell’immaginario mitico dell’aldilà ed in generale dei luoghi estremi al confine della terra (Ballabriga 1986 e 1998). Se si considera, inoltre, che al di là della soglia della porta cosmica il pensiero mitico collocava il caos indistinto dei principi della realtà (cf. supra pp. 7779), l’annullamento di orientamenti spaziali nel mitema dell’alternarsi degli astri sembra ancora più plausibile. Su un piano completamente diverso si pone Nakassis 2004 che, sulla base delle acquisizioni di Bergren 1975, riconosce nell’immagine di un unico luogo dove comincia e termina il ciclo solare l’espressione di un punto di vista “cosmico” (“outside in”) che concepisce i limiti terrestri come centro e fonte dell’esistente; mentre è solo da un punto di vista ellenocentrico (“inside out”) che il sole compie il suo ciclo sulla linea estrema dell’orizzonte tra l’oriente e l’occidente. Secondo Nakassis la fusione di questi due punti di vista spiegherebbe molte delle ambiguità astronomiche presenti negli Apologhi.
48 Così intende anche Scodel nell’articolo citato.
estratto
85«Vicini sono i sentieri della Notte e del Giorno»: una proposta esegetica per Od. 10. 80-86
porta della Notte e del Giorno: infatti sia Esiodo che Parmenide49 parlano di dimora oscura della Notte avvolta di tenebre nere, che si apre al di là della porta e che accoglie Giorno quando Notte è tra i mortali; come nota Cerri nel suo commento al passo, in Parmenide l’azione delle figlie del Sole che abbandonano la dimora della Notte dirigendosi verso la luce (eij" favo"), scostandosi dal capo il velo (kaluvptra", B 1. 10) sembra richiamare verbalmente l’immagine esiodea della dimora di Notte avvolta di tenebre (nefevlh/" kekalummevna kuanevh/si). Inoltre sia in Esiodo sia in Parmenide e sia nelle altre attestazioni omeriche tale porta compare sempre in un contesto di divinità primigenie, in luoghi odiosi persino agli dei dell’Olimpo; essa si trova ai confini del mondo, dove i principi primi di cui è composto l’universo progressivamente degradano. Sembrerebbe strana la presenza in questi luoghi di un popolo che, benché antropofago, vive secondo le leggi e le abitudini di una comunità greca, con basileus e agorà, come si evince dai vv. 110 e 114 del libro X. A mio avviso l’avventura presso i Lestrigoni presenta, nei versi che abbiamo esaminato, un caso di r i f u n z i o n a l i z z a z i o n e d i u n ’ i m m a g i n e m i t i c a t r a t t a d a l l a p o e s i a c o s m o l o g i c a 50: sappiamo che gli Apologhi rispondono alla volontà di dare alle avventure di Odisseo un carattere quanto mai esotico, come esperienza di un mondo sconosciuto, di terre dove scorreva impetuoso Oceano; di qui il ricorso a nuclei narrativi che rimandano al mondo lontano della fiaba, manipolati e spogliati degli elementi che meno potevano adattarsi al racconto omerico51; ma la fiaba non è l’unico contesto tradizionale a cui si poteva attingere per significare l’alterità delle terre toccate da Odisseo; non meno immediatamente poteva destare questa impressione un riferimento
49 Hes. Th. 744745; Parmen. B 1. 910 d.K.50 Su questo punto fondamentale la mia interpretazione si distanzia da quella della Scodel.
La studiosa, infatti, cerca di fornire una ulteriore giustificazione mitica all’immagine omerica descritta in Od. 10. 8086 utilizzando un frammento pindarico assai problematico (129. 12 Sn.M. = 58 Cannatà Fera toi'si lavmpei me;n mevno" ajelivou / ta;n ejnqavde nuvkta kavtw) che secondo alcuni farebbe riferimento alla credenza che la notte ed il giorno si alternino tra i beati in maniera opposta rispetto al regno dei vivi (così intendono anche Rohde 1989, p. 541 n. 1, Kerényi 1949, p. 33, LloydJones 1985, p. 86, West 1997, pp. 541542). Ma l’interpretazione del frammento è molto problematica ed è probabile che qui Pindaro stia solo alludendo alla luce perpetua di cui godono i beati (così Lehnus 1982, ad Ol. 2. 6167, Page 1983, p. 47, Cannatà Fera 1978 e Cannatà Fera 1990 ai frr. 58 e 65). Inoltre, a mio modo di vedere, esso non può essere accostato al passo omerico in questione; è bene ricordare che l’idea del Sole che si alterna tra vivi e morti, familiare nella mitologia egiziana, mesopotamica ed anatolica (Kérenyi 1949, p. 33, Hölscher 1991, pp. 145146, West 1997, pp. 541542, Marinatos 2001, p. 383, Watkins 2007, pp. 309311), non può considerarsi tradizionale nel mondo greco prima dell’introduzione delle dottrine orfiche ed eleusine (vd. ad. es. Kerényi 1949, p. 33). E, soprattutto, il background mitico di riferimento dei due passi non è lo stesso per il semplice fatto che nel frammento di Pindaro manca il dato essenziale che è emerso da tutte le testimonianze prese qui in esame: la menzione esplicita, e determinante per l’individuazione del mitema, dei sentieri della Notte e del Giorno intesi come entità divine. Il frammento di Pindaro citato dalla Scodel, quindi, non è una testimonianza omogenea con il passo omerico preso in esame.
51 Sull’argomento si veda soprattutto Page 1983.
estratto
86 P. Argenziano
ai luoghi estremi della terra spaventosa (pelwvrh" e[scata gaivh"), quelli di cui parla Esiodo nella sezione presa in esame (vv. 720819). La narrazione omerica rifunzionalizza temi cosmologici attingendo ad essi tanto quanto basta, per poi distaccarsene ed uniformare l’episodio al tono epicoeroico: l’utilizzo del mitema, cioè, è funzionale a suscitare nel pubblico l’impressione di lontananza estrema; a partire da esso il testo odissiaco, razionalmente ed autonomamente, trae la logica conseguenza della possibilità, in quei luoghi, di seguire il Giorno (riportando il mitema ad una dimensione quotidiana); ed infine se ne distacca completamente nella descrizione del popolo antropofago dei Lestrigoni e della loro ferocia52.
BiBLiografia
B. d’Agostino, Le sirene, il tuffatore e le porte dell’Ade, «AION(archeol)» 4, 1982, pp. 4350
G. Arrighetti, Cosmologia mitica di Omero e Esiodo, in G. Arrighetti (ed.), Esiodo. Letture critiche, Milano 1975, pp. 146213
G. Arrighetti, Esiodo. Opere, Milano 2007 (= Torino 1998)A. Ballabriga, Le Soleil et le Tartare. L’image mythique du monde en Grèce archaïque, Paris
1986A. Ballabriga, Les fictions d’Homère. L’invention mythologique et cosmographique dans
l’Odyssée, Paris 1998A. L. T. Bergren, The Etymology and Usage of PEIRAR in Early Greek Poetry, s. l. 1975L. Braccesi, Gli Eubei e la geografia dell’Odissea, «Hesperìa» 3, 1993, pp. 1123 (= Gli Eubei
e la geografia dell’Odissea: la rotta settentrionale, in Grecità di frontiera. I percorsi occi-dentali della leggenda, Padova 1994, pp. 321)
M. Cannatà Fera, L’aldilà nei frammenti di un treno pindarico, in E. Livrea G. A. Privitera (curr.), Studi in onore di Anthos Ardizzoni, Roma 1978, pp. 127155
M. Cannatà Fera, Pindarus. Threnorum Fragmenta, Roma 1990G. Cerri, Cosmologia dell’Ade in Omero, Esiodo e Parmenide, «PP» 50, 1995, pp. 437467G. Cerri, L’ideologia dei quattro elementi da Omero ai Presocratici, «AION(filol)» 20, 1998,
pp. 107118G. Cerri, Parmenide. Poema sulla natura, Milano 1999
52 Anche Ballabriga 1986, p. 129, che vede nella poesia cosmologica e teogonica una delle fonti di ispirazione dei viaggi di Odisseo, sostiene che l’Odissea non si attiene fedelmente ai principi della cosmologia primitiva, piuttosto si tratta di «di riattivazioni secondarie ed artificiali che donano un carattere atipico alla geografia mitica dell’Odissea»; l’utilizzo di motivi cosmologici è funzionale a conferire alla navigazione di Odisseo il carattere di gh'" perivodo". L’allusione geografica è strumento per «arricchire di significati l’azione drammatica», l’accenno a luoghi remoti è «un modo per tradurre in termini spaziali una separazione di tipo antropologico» come si è espresso Roberto Nicolai in un seminario tenuto a Berlino sulla tragedia ed i confini del mondo. Ringrazio Roberto Nicolai per avermi messo a disposizione la stesura scritta del suo intervento, in corso di stampa.
estratto
87«Vicini sono i sentieri della Notte e del Giorno»: una proposta esegetica per Od. 10. 80-86
G. Cerri, L’Oceano di Omero. Un’ipotesi nuova sul percorso di Ulisse, «IncidAntico» 4, 2006, pp. 2357
G. danek, Epos und Zitat. Studien zu den Quellen der Odyssee, Wien 1998H. Ebeling, Lexicon Homericum, III, Leipzig 18801885A. Ercolani, Esiodo. Opere e Giorni, Roma 2010d. Frame, The Myth of Return in Early Greek Poetry, New Haven London 1978H. Fränkel, Poesia e filosofia della Grecia arcaica: epica, lirica e prosa greca da Omero alla metà
del V secolo, Bologna 1997 (ed. or. München 19622)G. Germain, Genèse de L’Odyssée. Le fantastique et le sacré, Paris 1954F. Gisinger, Geographie, in RE, Supplb. IV, 1924, coll. 517685E. A. Havelock, Parmenides and Odysseus, «HSPh» 63, 1958, pp. 133143R. Hennig, Die Geographie des homerischen Epos. Eine Studie über die erdkundischen
Elemente der Odyssee, Leipzig Berlin 1934A. Heubeck, Omero. Odissea, III, nona edizione rinnovata con un’appendice a cura di
Mario Cantilena, Milano 2003A. Heubeck, Omero. Odissea, VI, settima edizione rinnovata con un’appendice a cura di
Mario Cantilena, Milano 2004U. Hölscher, L’Odissea. Epos tra fiaba e romanzo, Firenze 1991 (ed. or. München 1988)F. Jacoby, Hesiodi carmina, I, Theogonia, Berolini 1930d. M. Johnson, Hesiod’s Description of Tartarus (Theogony 721-819), «Phoenix» 53, 1999
pp. 828K. Kerényi, Figlie del Sole, Torino 1949 (ed. or. Zürich 1944)G. S. Kirk, The Iliad: A Commentary, II, Cambridge 1990L. Lehnus, Pindaro. Olimpiche, Milano 1982H. LloydJones, Pindar and the Afterlife, in A. Hurst (éd.), Pindare, «Entr. Hardt» XXXI,
Vandoeuvres Genève 1985, pp. 132 (= Greek Epic, Lyric and Tragedy, Oxford 1990, pp. 80105, da cui si cita)
N. Marinatos, The Cosmic Journey of Odysseus, «Numen» 48, 2001, pp. 381416P. Mazon, Hésiode. Théogonie, Les Travaux et les Jours, Le Bouclier, Paris 1951A. Mele, Il processo di storicizzazione dei miti, in AA. VV., Mito e storia in Magna Grecia.
Atti del XXXVI Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 47 ottobre 1996, Taranto 1997, pp. 151166
K. Meuli, Laistrygonen, in RE, Supplb. V, 1931, coll. 537540d. Nakassis, Gemination at the Horizons: East and West in the Mythical Geography of
Archaic Greek Epic, «TAPhA» 134, 2004, pp. 215233R. Nicolai, La tragedia e i confini del mondo: limiti geografici e limiti linguistici, in corso di
stampad. Page, Racconti popolari nell’Odissea, Napoli 1983 (ed. or. Cambridge 1972)E. Passa, L’epica, in A. C. Cassio (cur.), Storia delle lingue letterarie greche, Milano 2008,
pp. 99144L. P. Pocock, Gadflies and the Laestrigonians, «CR» n. s. 8, 1958, pp. 109111E. Rohde, Psiche, Roma Bari 1989 (ed. or. Freiburg 18901894)R. Scodel, The Path of Night and Day, «Ordia prima» 2, 2003, pp. 8386F. Solmsen, Chaos and Apeiron, «SIFC» n. s. 24, 1950, pp. 235248W. B. Stanford, The Odyssey of Homer, I, London 19592
M. C. Stokes, Hesiodic and Milesian Cosmogonies, «Phronesis» 7, 1962, pp. 137
estratto
88 P. Argenziano
A. Tsopanakis, Lestrigoni, «QUCC» 40, 1992, pp. 713W. J. Verdenius, A Commentary on Hesiod, Works and days, vv. 1-382, Leiden 1985H. Vos, Die Bahnen von Nacht und Tag, «Mnemosyne» IV s. 16, 1963, pp. 1834C. Watkins, The Golden Bowl: Thoughts on the New Sappho and its Asianic Background,
«CA» 26, 2007, pp. 305325M. L. West, Hesiod. Theogony, Oxford 1966M. L. West, Hesiod. Works and Days, Oxford 1978M. L. West, The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth,
Oxford 1997M. L. West, Odyssey and Argonautica, «CQ» n. s. 55, 2005, pp. 3964
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”dipartimento di Antichità e tradizione classicaemail: [email protected]
aBstraCt: In Od. 10. 8086 there is an image, which has always challenged scholars of Homer and early Greek thought: it is mentioned a place (the enigmatic Lavmou ptoliveqron, Thlevpulon Laistrugonivhn, vv. 8182), where a sleepless herdsman could earn a double salary (vv. 8285) because of the nearness of the paths of Night and day (v. 81). The Homeric passage is best understood through the comparison with Hesiod (Th. 744757) and Parmenides (B 1. 621 d. K.): the bard is here referring to a precise mythic image, that of the door crossing which Night and day alternate on the earth for humans. The usage of this cosmological image in the Odyssey is a mean to underline the extreme remoteness of the lands in which Odysseus’ wanderings take place. The odd and enigmatic information in vv. 8285 is the result of the bard’s reworking of the original, cosmological image of the door of Night and day.
estratto