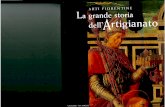Un ministero degli esteri sui generis: la Giunta dei Confini della Repubblica di Genova
Transcript of Un ministero degli esteri sui generis: la Giunta dei Confini della Repubblica di Genova
1
Giovanni Assereto
Un ministero degli esteri sui generis: la Giunta dei Confini della Repubblica di Genova1
Nel febbraio del 1587 ai Serenissimi Collegi – il massimo organo del governo
genovese – viene proposta l’approvazione di un decreto «per metter ordine e provedere alla
conservatione e territorio e confini della Repubblica»: un testo di 11 articoli che prevedono
di formare, in seno agli stessi Collegi, una deputazione di tre membri col compito di
istruire processi «sino alla sentenza exclusive» e di «fare qualonque altre diligenze
giudicheranno necessarie» riguardo a «tutte le liti e differenze di confine che la Repubblica
abbia con cui si voglia, ovvero in le quali la Repubblica in qualsivoglia modo possa avere
interesse». Il decreto specifica che – al fine di salvaguardarne la giurisdizione – la
deputazione dovrà catalogare tutti i titoli di possesso e sovranità della Repubblica, specie
quelli che riguardano le terre di confine: titoli di cui dovrà essere formato «un libro molto
distinto et ordinato affine che con facilità si possino ritrovare tutte le scritture pertinenti a
qualsivoglia luogo o feudo della Repubblica, procurando di raccogliere insieme dette
scritture non solo dall’Archivio publico della Città, ma da ogni altra parte, e spezialmente
dalli luoghi istessi del Dominio»2.
Approvato, sia pure parzialmente, il 18 del mese, il decreto segna la nascita della
Giunta dei Confini, il più antico tra gli organismi di questo tipo, che il governo genovese
istituisce di solito in via provvisoria, per rispondere a qualche emergenza, salvo poi
trasformarli in permanenti quando lo reputa opportuno. In questo caso, come si deduce dal
testo, l’intenzione è invece sin dall’inizio quella di avere un’istituzione stabile che affronti
compiti di lungo periodo, segno che i problemi cui si vuole rispondere non vengono affatto
ritenuti temporanei o passeggeri. D’altronde a quest’epoca altri Stati italiani – primo fra
tutti la Repubblica di Venezia – cercano di dotarsi di magistrature o di funzionari con
compiti analoghi3, e semmai va notato che Genova, spesso accusata dalla storiografia di
possedere forme statali arcaiche, in questo caso sembra invece molto precoce, tanto da
anticipare di quasi mezzo secolo quel «Conservatore o Sovraintendente generale dei
confini» che Vittorio Amedeo I, signore di uno Stato assai più solido, creerà solo nel
16344. Ma la precocità della Giunta genovese non deve trarre in inganno, visto che per
molti aspetti essa conferma la “debole statualità” della Repubblica: non siamo infatti di
fronte a una nuova istituzione, ma semplicemente a una serie di compiti appoggiati a
persone che già fanno parte dell’organo di governo – una «deputazione», appunto – alle
1 Questo saggio è un ampliamento della relazione presentata al convegno internazionale Per una
ricognizione degli “stati d’eccezione”. Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa (secc.
XVII-XX), Messina 15-17 luglio 2013. 2 C. Bitossi, «La Repubblica è vecchia». Patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento, Roma,
Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, 1995, pp. 28-29; Archivio di Stato di Genova
(d’ora in avanti: ASG), Archivio segreto (d’ora in avanti: AS), 1650 e 20. Il testo completo della proposta di
decreto è riportato in Appendice 1. 3 V. Adami, La magistratura dei confini negli antichi domini di casa Savoia, in «Miscellanea di storia
italiana», terza serie, t. XVII, 1915, pp. 181-230, in particolare p. 184; P. Cavalieri, L’Archivio della Camera
dei Confini di Bergamo e il confine occidentale della Repubblica di Venezia tra XVI e XVII secolo, in A.
Pastore (a cura di), Confini e frontiere nell’età moderna. Un confronto fra discipline, Milano, F. Angeli,
2007, pp. 219-246, in particolare pp. 220-221. 4 E. Mongiano, Delimitare e governare le frontiere: le istituzioni per i confini nello stato sabaudo del
secolo XVIII, in R. Comba e P. Sereno (a cura di), Rappresentare uno Stato. Carte e cartografi degli Stati
sabaudi dal XVI al XVIII secolo, Torino, U. Allemandi, 2002, pp. 165-178.
2
quali oltretutto si nega, per risparmiare sui costi, un minimo di personale subalterno5. Chi
abbia voglia di leggere il testo riportato nell’Appendice 1 vedrà che fra gli articoli non
approvati figurano quelli relativi all’assunzione, con relativo stipendio, di un notaio e di
«due giovani d’isperienza et fedeltà» al servizio della Giunta, e persino quello che
vorrebbe riservare per le sue riunioni un’apposita stanza a Palazzo Ducale. A conferma
però di un connotato tipico delle istituzioni genovesi – e cioè il fatto che l’esiguità del
personale di governo e ancor più del corpo burocratico non si traduce necessariamente in
inefficienza – possiamo rilevare che la Giunta, nonostante queste limitazioni risparmiose, è
destinata a operare con continuità sino alla caduta della Repubblica e a produrre un’enorme
massa di documenti tuttora presenti nell’Archivio di Stato di Genova. Una magistratura da
prendere sul serio, dunque, meritevole di essere analizzata sia per comprenderne l’origine,
sia ancor più per descrivere i campi in cui si è dispiegata la sua attività, anche perché in tal
modo è possibile – crediamo – mettere in luce alcuni tratti importanti della politica
genovese tra il tardo Cinquecento e la caduta della Repubblica. Nell’affrontare questo
compito non ci addentreremo – se non marginalmente – in quella complessa tematica
riguardante le definizioni di confini e frontiere nell’età moderna, contando sul fatto che
negli ultimi anni essa è stata ampiamente trattata, grazie soprattutto a una nutrita serie di
saggi scaturiti da un progetto di ricerca interuniversitario coordinato da Alessandro
Pastore6.
A spiegare la nascita della Giunta concorrono motivazioni di diversa natura, alcune
delle quali hanno particolare rilevanza nel processo di evoluzione dello Stato genovese,
altre hanno carattere più contingente. Tra le prime si può ricordare la maggiore attenzione
alla sovranità del proprio territorio, conseguenza sia di un assetto istituzionale più stabile
(nel 1576 sono state promulgate quelle Leges Novae che rappresentano il definitivo testo
costituzionale – se così possiamo chiamarlo – della Repubblica); sia anche, come avviene
5 «Non propriamente una magistratura, – ha scritto Carlo Bitossi a proposito della Giunta – ma una
specializzazione dell’attività dei Collegi» (C. Bitossi, Personale e strutture dell’amministrazione della
Terraferma genovese nel ‘700, in Cartografia e istituzioni in età moderna, Genova, Società ligure di storia
patria, 1987, pp. 203-224, in particolare p. 208). 6 Si vedano in proposito i numerosi volumi nati da quel progetto e raccolti nella collana «Confini e
frontiere nella storia. Spazi, società, culture nell’Italia dell’età moderna»: C. Donati (a cura di), Alle frontiere
della Lombardia. Politica, guerra e religione nell’età moderna, Milano, F. Angeli, 2006; A. Pastore (a cura
di), Confini e frontiere nell’età moderna cit.; M. Ambrosoli e F. Bianco (a cura di), Comunità e questioni di
confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.), Milano, F. Angeli, 2007; B. A. Raviola (a cura di), Lo spazio
sabaudo. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna, Milano, F. Angeli, 2007; M. Cavallera (a cura di),
Lungo le antiche strade. Vie d’acqua e di terra tra Stati, giurisdizioni e confini nella cartografia dell’età
moderna, Busto A. (VA), Nomos Edizioni, 2007; A. Torre (a cura di), Per vie di terra. Movimenti di uomini
e cose nelle società di antico regime, Milano, F. Angeli, 2007; E. Fasano Guarini e P. Volpini (a cura di),
Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo, Milano, F. Angeli,
2008. Per quanto riguarda l’età moderna, ha fatto il punto su questi studi e ha fornito preziose indicazioni
bibliografiche B. A. Raviola, Frontiere regionali, nazionali e storiografiche: bilancio di un progetto di
ricerca e ipotesi di un suo sviluppo, «Rivista storica italiana», CXXI, 2009, pp. 193- 202 (nello stesso
volume della rivista si veda anche l’articolo di L. Blanco, Confini e territori in età moderna: spunti di
riflessione, pp. 184-192). Tra i testi che in Italia hanno affrontato per tempo le tematiche in questione sono da
ricordare quantomeno: C. Ossola-C. Raffestin-M. Ricciardi, La frontiera da Stato a nazione. Il caso
Piemonte, Roma, Bulzoni, 1987; E. Grendi, La pratica dei confini fra comunità e Stati: il contesto politico
della cartografia, in Cartografia e istituzioni in età moderna cit., pp. 133-145; Id., La pratica dei confini:
Mioglia contro Sassello, 1715-1745, «Quaderni storici», XXI, 1986, n. 63, pp. 811-845; O. Raggio,
Costruzione delle fonti e prova: testimoniali, possesso e giurisdizione, «Quaderni storici», XXXI, 1996, n.
91, pp. 135-156. Un contributo recente e interessante in tema di confini – nato anch’esso dal progetto di
ricerca di cui s’è detto – è quello di D. Balani, Per terra e per mare. Traffici leciti e illeciti ai confini
occidentali dei domini sabaudi (XVIII secolo), Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2012.
3
per altre realtà italiane, di un generale consolidarsi degli Stati territoriali in seguito
all’affermazione della pax hispanica nella penisola. Tra le seconde ci sono «li molti
pregiuditij che da tempo in qua si sentono essere fatti alli confini della Repubblica dalli
circonvicini che per ogni via tentano di usurpare la giurisdizione et territorio di essa
Repubblica», come recita un testo del 25 settembre 15867. Emergenze temporanee,
dunque, che però s’inscrivono in una tendenza più generale, tale da configurare un vero
pericolo per l’integrità dello Stato: prova ne sia che proprio in questi anni sono frequenti le
proposte di potenziare l’apparato difensivo con l’acquisto di artiglierie, l’arruolamento di
truppe, l’adeguamento delle fortificazioni8. I tentativi di usurpazione avvengono su più
punti del Dominio, compresi alcuni molto vicini alla capitale, per esempio nella val
Polcevera, cioè in un’area in cui la cognizione dei reati spetta al tribunale della Rota
Criminale. Come in altri casi analoghi, il ceto dirigente genovese si rende però conto che,
in alcune materie di grande rilievo politico, l’amministrazione della giustizia è cosa troppo
seria per lasciarla in mano ai giudici – per di più forestieri, come sono appunto quelli della
Rota – ed è quindi necessario riservarla al massimo organo di governo o a una sua
emanazione9. Anche per rispondere a questa esigenza viene creata la Giunta
10.
A giudicare dalla documentazione di quegli anni, due sono soprattutto le minacce, o
quantomeno i contenziosi, che preoccupano Genova: quelli che hanno come controparti da
un lato il duca di Savoia Carlo Emanuele I, fautore di una politica espansionistica che ha
nel Ponente ligure uno dei suoi obiettivi, dopo che nel 1576 Emanuele Filiberto ha
acquistato da Gian Girolamo Doria il principato di Oneglia; d’altro lato la Spagna, che sin
dal 1571 si è impadronita del Marchesato di Finale, altra grossa enclave della quale nel
1618 otterrà formalmente l’investitura dall’imperatore Mattia. È vero che Filippo II è un
buon alleato di Genova, e che il Piemonte a quest’epoca gravita anch’esso nell’orbita
spagnola; ma questo in certo senso rende le dispute ancor più insidiose, perché se un
piccolo Stato si trova ad essere in contrasto con chi – almeno ufficialmente – gli è amico,
non ha speranza di trovare appoggio altrove. A parte questi due casi specifici, poi, è la
situazione complessiva del Genovesato a destare preoccupazione dal momento in cui –
come s’è detto – i nuovi equilibri dell’Italia costringono la Repubblica a dedicare maggiore
attenzione alla propria integrità territoriale. Se, infatti, è vero che a quest’epoca i confini
tra gli Stati sono dappertutto labili e incerti, per Genova lo sono in modo particolare, sia
7 ASG, AS, 1650.
8 ASG, AS, 1027.
9 R. Savelli, Potere e giustizia. Documenti per la storia della Rota criminale a Genova alla fine del ‘500,
«Materiali per una storia della cultura giuridica», V, 1975, pp. 29-172.. 10
Nel citato testo del 25 settembre 1586 si rileva infatti che i Serenissimi Collegi potrebbero non avere
l’autorità di procedere contro chi usurpa la giurisdizione della Repubblica, «allegandosi che per le nuove
leggi la cognitione de’ delitti commessi in la città et tre podestarie sia appoggiata alla Rota Criminale. Il che
quando fussi vero, et che non li fossi provisto di rimedio opportuno, sarebbe un lasciare libero adito
all’usurpatione di detta iurisditione, essendo pur troppo chiaro quanto inconveniente fusse che la cognitione
et provigione in simili cause si confidasse a’ giudici forastieri, onde conoscendo li Collegi Serenissimi per
isperienza quanto danno et pregiuditio sia venuto alla Repubblica dallo essersi per lo passato trascurato et
negligentato il mantenimento delle proprietà et confini del Dominio nostro», hanno chiesto al Minore e al
Maggior Consiglio che «se li conceda libera facoltà e bailia di procedere, punire et castigare tutti coloro che
in qual si voglia modo havessero pregiudicato o vero pregiudicheranno o tenteranno di pregiudicare alla
giurisditione, territorio et confini della Repubblica […], et di pigliare tutti quelli ispedienti et fare quelle
provigioni et essecutioni che giudicheranno necessarij et opportuni per la conservatione di detta giurisditione,
confini et patrimonio di essa Repubblica e per la reintegratione di esso» (ASG, AS, 1650). La proposta,
approvata dal Minor Consiglio il 22 ottobre e dal Maggior Consiglio il 18 novembre, rappresenta la premessa
della successiva nascita della Giunta dei Confini.
4
per l’alto numero dei suoi vicini (il Piemonte, il Monferrato, Milano, Parma, Modena, la
Toscana, Massa, Lucca), sia ancor più per la costellazione dei feudi – oltre un centinaio,
spesso estremamente minuscoli – che da ogni lato circondano il Dominio e quel che è
peggio in molti punti lo intersecano.
Quest’ultimo è problema di antica data, cui Genova ha cercato di ovviare stipulando
con alcuni piccoli signori accordi in base ai quali il Comune ha ottenuto l’alta sovranità
sulle loro terre e li ha quindi legati a sé con un vincolo vassallatico11
. Ben più numerosi,
tuttavia, sono i feudi imperiali sparsi intorno e dentro il territorio genovese: alcuni di essi
sono investiti a patrizi della Superba, ma questo non costituisce una garanzia, come prova
appunto la clamorosa cessione di Oneglia appena ricordata. E i feudi – la cui presenza
«non solo complica il quadro politico-amministrativo del territorio, già caratterizzato da
una forte discontinuità, ma moltiplica a dismisura le aree di confine» – sono elementi di
instabilità sia perché destano l’appetito dei principi confinanti, sia in quanto sono frequente
occasione di contenzioso su un terzo fronte, quello della corte di Vienna, specie da quando
Genova non può più contare su un Impero amico, come al tempo in cui la corona di Spagna
e quella imperiale stavano entrambe sulla testa di Carlo V, ferreo alleato della Repubblica.
Quel contenzioso è e resterà a lungo particolarmente sgradevole per un piccolo Stato cui
non solo sfugge il controllo su tanti piccoli lembi di territorio, ma la cui stessa
indipendenza viene frequentemente messa in discussione dalla cancelleria aulica, che non
cessa di considerare Genova «camera imperiale» e di attribuirle quindi una sovranità
subordinata e di rango inferiore.
Questo, a linee molto sommarie, il quadro entro il quale comincia a muovere i primi
passi la nuova magistratura. Se il termine confini che la connota sembra mettere al primo
posto fra i suoi compiti la salvaguardia del territorio e la tutela delle zone frontaliere,
vedremo più innanzi che non meno importante è un’altra finalità, cioè l’ampliamento di
quello stesso territorio, l’«acquisto di giurisdizione», che proprio ai feudi imperiali si
rivolge; e che, legata a questa, c’è necessariamente la rivendicazione di una piena
sovranità, culminata durante il Seicento nei tentativi – solo parzialmente riusciti – di
ottenere il rango di «testa coronata», cioè la dignità regia12
. Una sovranità contraddittoria,
come bene mostra uno tra i primi documenti prodotti dalla Giunta nel quale – in questo
caso per rivendicare nei confronti della Spagna la legittimità del «dominio sul mare
Ligustico» e dei relativi diritti fiscali – si cita una formula all’epoca ormai classica,
secondo cui la Repubblica lo avrebbe ottenuto «col sangue et per ricompensa degli aiuti e
serviggi fatti alla christianità et alla Chiesa nell’aquisto di Terra Santa, nell’espugnatione
delle città d’infideli, con havere scacciato di Corsica e di Sardegna li saracini, et purgato e
difeso il mare Mediterraneo da’ corsari […]. Il quale dominio ha sempre la Repubblica
mantenuto in tutt’i tempi, e n’è in pacifico possesso confermato da una consuetudine
immemorabile et antichissima, né mai ci ha avuto alcuna contraditione»13
. Ma si aggiunge
anche – con evidente incoerenza – che «il detto dominio le è stato conceduto per privilegio
da papi et imperatori», e confermato in particolare «da Massimiliano l’anno 1496 e dalla
11
V. Piergiovanni, I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio, «Atti della Società ligure di storia patria»
(d’ora in avanti: ASLSP), n. s., vol. XXIV/2, 1984, pp. 427-449 (qui p. 442); A. Zanini, Strategie politiche ed
economia feudale ai confini della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII), ASLSP, n. s., vol. XLV/3, 2005,
pp. 18-20). 12
M. Schnettger, Feudi, privilegi e onori. La Repubblica di Genova e la corte di Vienna negli anni trenta
e quaranta del ‘600, in C. Cremonini e R. Musso (a cura di), I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo,
Roma, Bulzoni, 2010, pp. 279-297. 13
ASG, AS, 20.
5
felice memoria di Carlo V l’anno 1529»: con ciò stesso riconoscendone la derivazione da
istanze superiori.
La sorveglianza e difesa dei confini si attua in forme che sono già piuttosto note alla
storiografia, e che non differiscono molto da quelle che si possono riscontrare presso altri
Stati dell’epoca. In particolare, come è stato messo bene in luce da Edoardo Grendi e
Osvaldo Raggio nelle opere già citate, l’azione della Giunta mostra un nesso forte tra
possesso e sovranità, con un conseguente dialogo fra il piano locale e quello statale. Ciò
significa che l’iniziativa della rivendicazione di una terra di confine parte quasi sempre
dalle comunità che cercano di affermare il loro diritto a sfruttare una risorsa agricola
(pascoli, boschi, seminativi, corsi d’acqua), coinvolgono nella disputa i giusdicenti mandati
da Genova a reggere le circoscrizioni periferiche, e questi a loro volta fanno riferimento al
governo centrale, il quale può portare la controversia sul piano diplomatico, entrando in
conflitto con altri principi o cercando con essi un accordo. D’altra parte anche su tale piano
è essenziale il riferimento alla realtà locale, cioè ai concreti atti di possesso: a definire la
giurisdizione, infatti, sono anzitutto «i gesti quotidiani e la memoria individuale e collettiva
dei contadini pastori dei villaggi di confine», dei mulattieri o dei mercanti, e di quanti –
notai, amministratori, esattori – esercitano o hanno esercitato diritti su un dato territorio14
.
Solo in seguito, e spesso in misura subordinata, si ricorre a strumenti d’altra natura, come
diplomi imperiali, investiture, atti di vendita e così via.
Ben presto, tuttavia, la Giunta non si limita a intervenire di volta in volta a sostegno
dei conflitti locali, ma mette in atto una serie di procedure utili sia a prevenirli, sia a
risolverli con successo. Questa sua opera finisce per rafforzare, all’interno del ceto di
governo, la consapevolezza di quanto sia importante la compattezza territoriale, come
dimostra ad esempio la legge del 24 novembre 1637, con cui si proibisce di vendere o
cedere a persone forestiere, senza espressa licenza del Senato, «alcuna casa, cassina,
possessione domestica o silvestre, o vero terra di qualsivogli sorte che sia vicina per lo
spatio di due miglia al territorio di qualsivogli prencipe straniero, signore o feudatario di
qualsivogli Stato, compresi anche li feudatari della Repubblica Serenissima, sotto pena
della confiscatione de i beni venduti»15
.
Si dispongono periodicamente visite ai confini: di carattere generale, come quella
decisa già nel 1590, o particolare, come quella concordata col duca di Parma nel 1600-
14
La Giunta e i suoi emissari fanno riferimento – come sostiene efficacemente Raggio – a «una gamma
amplissima di atti possessori», verificati con l’indagine presso coloro i quali «in virtù della professione,
possono fornire una gamma di testimonianze diverse, ma tutte focalizzate su aspetti peculiari del possesso e
della giurisdizione. Così i “lavoranti” e i boscaioli testimoniano sulla consuetudine di “pascere”, “roncare”,
“seminare”, “raccogliere fieni e biade”, “fogliacare” e “legnare” pacificamente e “senza contraddittione”; i
mulattieri e i mercanti sulle vie di transito e sulla presenza o meno di dazieri e “peageri”; i preti sulla
“raccolta” e sepoltura dei cadaveri; gli ufficiali e i bargelli sulla cattura e l’esecuzione dei banditi, o sulle
corti che in passato hanno accolto le denunce degli abitanti» (O. Raggio, Costruzione delle fonti cit., pp. 140-
147). 15
ASG, AS, 1021. La legge proibisce inoltre «a’ nostri sudditi di accettare alcuna terra che sia dentro il
detto limite di due miglia vicino alla giurisdittione nostra per via di nuova investitura da qualsivoglia
feudatario […], eccetto se si trattasse di rinovarla da padre in figlio, da avo in nipote o parente dentro al
secondo grado inclusive, sotto le istesse pene, eccettuando da questa prohibitione quei sudditi che habitano in
quelli feudi ne’ quali la Repubblica tiene partecipatione». La legge, che si rifà ad altra analoga datata 4 luglio
1570, non sempre verrà osservata: tanto è vero che il 30 settembre 1661 i Serenissimi Collegi, accennando
all’esistenza di ordini proibitivi circa la vendita degli immobili in vicinanza dei confini, incaricano la Giunta
di «far diligenza per ritrovare detti ordini, e trovatili li consideri e riffera il suo senso in ordine a farli
essequire nell’avvenire e rimediare all’inosservanze di essi che fossero state fatte per il passato».
6
160116
. Nel 1643 si commissiona un’accurata descrizione dei confini nell’Oltregiogo, che
produce un risultato di grande rilievo documentario tanto per i governanti di allora quanto
per gli storici, primo fra tutti lo splendido atlante dei territori genovesi situati al di là dello
spartiacque appenninico, redatto da Giovanni Battista Massarioti «per assicurarsi per
sempre dalle occupationi alle quali soggiace chi a tante diversità de prencipi e signori
confina»17
. Ed è inutile dire che dalle iniziative della Giunta deriva – analogamente a
quanto avviene altrove – lo sviluppo di un’attività cartografica che avrà il suo apice nel
Settecento, grazie soprattutto all’attività del maggiore ingegnere cartografo al servizio
della Repubblica, vale a dire Matteo Vinzoni.
Nel 1651 si delibera una nuova ispezione complessiva, con l’elezione – nella persona
di Giovanni Battista Raggio – di un Commissario generale nella Riviera di Ponente «per
visitare i confini che habbiamo con prencipi forastieri». Si ordina perciò «a tutti li nostri
capitani, commissari, podestà et altri ufficiali che detto Illustre Commissario riconoschino
per tale e che le diino per essercitio di detta carrica ogni aiuto e favore»; come pure si
comanda «a qualunque altro agente, reggitore o particolare del Dominio di aiutarlo e
obbedirgli sotto ogni grave pena a noi arbitraria»18
. Le istruzioni impartite a Raggio
esemplificano bene il modus operandi richiesto in simili affari: la visita ai confini
dev’essere fatta «unicamente con la delineazione d’essi in carta accompagnata dalle
annotazioni necessarie affinché in ogni tempo apparisca certamente della loro sussistenza».
Sua cura principale «sarà di riveder oculatamente tutti detti confini, fare ripiantare quelli
termini che o dall’ingiuria del tempo o per altro accidente trovasse amossi et alterati,
pigliando in questo caso esattissima cognizione in scritto del sito e luogo preciso nel quale
stavano posti». A tal fine porterà con sé «persone vecchie e pratiche del paese», e
confronterà tutte le scritture che potranno essergli comunicate dall’archivio della
Repubblica o dalle località cui la visita si riferisce, «procurando passar il tutto d’accordo
con li popoli forastieri confinanti». I termini vanno ripiantati «ben radicati et assodati,
acciò non così facilmente in l’avvenire possano esser spiantati et amossi». In caso di
contestazioni non deve toccar nulla, ma riferire ai Serenissimi Collegi, affinché decidano,
con giustizia e possibilmente reciproca soddisfazione, «quello sarà conveniente per
indennità della giurisditione della Repubblica e quiete de’ sudditi»19
.
Della visita, protratta a più riprese sino al 1654, ci è rimasta un’ampia
documentazione che attesta, come vedremo più avanti, la molteplicità di compiti
appoggiati sia alla Giunta sia ai suoi delegati; ma qui ci preme intanto porre l’accento su
alcuni caratteri peculiari della magistratura genovese riguardo proprio agli scopi primari
per cui è stata creata. Ciò che forse più colpisce è il numero altissimo delle questioni
pendenti: in tutto l’entroterra del Ponente (ma anche sulla costa: basti pensare ai casi di
Oneglia e di Finale) e del Levante, nelle valli immediatamente poste a settentrione della
capitale (Scrivia, Stura, Trebbia, Orba), nella Lunigiana, praticamente ovunque, il reticolo
quasi inestricabile delle frontiere con i principi esteri e ancor più con i feudatari pone
continuamente la Repubblica nelle condizioni di dover difendere quasi palmo a palmo il
16
ASG, AS, 22 e 26; ASG, Giunta dei Confini (d’ora in avanti: GC), 61. 17
ASG, Manoscritti (d’ora in avanti: Mss), 712: «Visita, descrittione et delineatione de’ confini del
Dominio della Serenissima Repubblica di Genova di là da Giogo». 18
ASG, AS, 284. 19
Ibidem. Il principale scopo della visita è «fare apparire per sempre designati e delineati in carte
destintamente li confini della Repubblica», perciò Raggio condurrà seco «persona perita e pratica che possa
levarne la pianta con le misure agiustate e chiare», così da «haver piena cognitione e certezza de detti confini
e de siti controversi, procurando riunire in uno stesso tempo tutte le scritture e prove per mezzo de quali
possano rimanere autenticate et assicurate maggiormente le ragioni della Repubblica».
7
proprio territorio. Nell’Archivio di Stato di Genova otto ponderosi registri di «pandette
confinium», ciascuno recante il sunto delle pratiche trattate dalla Giunta in un determinato
periodo e una rubrica delle località cui le pratiche stesse si riferiscono, sono forse la più
efficace testimonianza circa l’onnipresenza delle dispute confinarie20
. E se queste appaiono
numerosissime sull’arco di oltre due secoli, altrettanto lo sono quando si considerino
periodi più ristretti. Un Inventario de’ fogliazzi e tipi trasportati in archivio dal colonello
Vinzoni nel 1755 circa i confini, cioè una sorta di compendio delle questioni trattate in un
breve volgere di tempo da quel cartografo, ne comprende 25, distribuite su tutto l’arco
della Liguria21
; mentre un Indice delle vertenze de’ confini, all’incirca coevo, ne indica ben
5722
.
20
ASG, Mss., 160-163C. 21
ASG, Mss, 254. I contenziosi aperti sono i seguenti: «1. Per li confini di Beverino col Capitanato della
Spezzia, con Cavanella del marchese Malaspina di Villafranca del 1737; 2. per li confini di Brugnato del
Capitanato di Levanto con Stradomella del marchese Malaspina di Villafranca del 1711; 3. per li confini di
Suvero del marchese di Malaspina del 1692 sino al 1737; 4. per li confini di Godano e Zignago di Genova
con Zeri e Rossano di Pontremoli dall’anno 1700 sino al 1719; 5. idem del 1739, 1741 e 1743; 6. idem nel
congresso di Chiusola e Massa del 1744; 7. per li confini di Chiavari e Varese di Genova con Taro e
Compiano di Parma del 1688, 1699, 1717, 1718, 1723, 1738, 1739, 1742; 8. per li confini di Varese di
Genova con Compiano di Parma 1739; 9. per li confini di Rapallo con San Stefano del Prencipe Doria del
1725; 10. per li confini e feudo di Buzalla e Montoggio di Genova con Fraxinello; 11. per li molini di Novi
con Tortona […] e per li molini proposti di Gavi del 1738 e 1739; e per la strada di Carosio; e per il
riadattamento di detti molini di Novi del 1745; 12-14. per il Sassello di Genova con Mioglia e Ponte Invrea
del re di Sardegna del 1737, 1740, 1741; 15. per li confini di Bormida del Finale con le Mallare, 1737 e 1738;
16. per li confini di Loano del Principe Doria col Borghetto, Toirano, Quarzi, Giustenice, Pietra, Balestrino
del marchese Carretto, Castelvecchio e Bardineto del 1749; 17. per li confini di Triora di Genova con la
Briga del re di Sardegna del 1736; 18. per li confini di Triora di Genova con Pigna e Buggio del re di
Sardegna del 1729; 19. per li confini di Baiardo della podesteria di Triora et Apricale del re di Sardegna; 20.
per li confini di Almo del Capitanato della Pieve di Genova con Caprauna del conte Cepolini, uno dei feudi
occupati dalla Serenissima Repubblica del 1735, del 1737; 21. per Rezzo e le Prealbe del marchese Rainero
Grimaldi, uno dei feudi occupati come sopra, con Cenova e Lavina del Marchesato del Maro; 22. miscellaneo
per Rezzo e la Viozenna del 1732; 23. per le castellanie di Cosio, Mendatica di Genova e Montegrosso del re
di Sardegna; 25. per li confini di San Remo con la Seborca riguardo al sito nominato il Cuneo». Inutile dire
che alcuni di questi contenziosi (per esempio quello già considerato di Compiano, quello fra Triora e Briga, o
quello sull’altopiano delle Viozene) sono di lunghissima data. 22
Ibidem. L’Indice elenca le seguenti controversie, indicando con (S) quelle «stabilite», cioè concluse, e
con (I) quelle ancora indecise, che sono la maggioranza: «1. Di Vallebona altro dei Otto Luoghi del contado
di Ventimiglia con la Seborca feudo alias donato dal conte Guido di Ventimiglia a’ Padri di S. Onorato
dell’Isola d’Eres, ora del re di Sardegna (I). 2. Di Sanremo con la detta Seborca (I). 3. Dolceaqua del
marchese Doria con Camporosso di Ventimiglia (S). 4. Apricale del detto marchese con Baiardo della
podesteria di Triora (S). 5. Pigna del contado di Tenda con Castelfranco della podesteria di Triora (S). 6.
Pigna e Buggio del detto contado di Tenda con Triora e Castelfranco (S). 7. Glori della podesteria di Triora
con Carpasio del Marchesato del Maro (S). 8. S. Bartolomeo e Larzeno del detto Marchesato con Calderara
del capitanato della Pieve (S). 9. Calderara sudetta con Lavina del detto Marchesato del Maro (I). 10.
Massimino del Marchesato del Finale con Bagnasco del contado di Ceva (S). 11. Triora con la Briga del
contado di Tenda (S). 12. Rezzo feudo occupato del 1736 con Cenova del Marchesato del Maro (I). 13. Cosio
e Mendatica castellanie con Montegrosso castellania (I).14. Viozenna tenimento (I). 15. Pornassio castellania
(I). 16. Almo e Moano del capitanato della Pieve con Caprauna altro feudo occupato del 1736 (I). 17. Cisano
luogo del contado d’Albenga con Conscente feudo del marchese di Balestrino (I). 18. Detto Conscente con
Castelfranco, Erli, Castelvecchio e Zuccarello (I). 19. Zuccarello, Toirano con Ballestrino e Carpi del
marchese (I). 20. Toirano, Pietra e Borghetto con Loano del Principe Doria (I). 21. Bormida del Marchesato
del Finale con Mallare del conte Cattaneo (I). 22. Mallare et Altare con Quigliano e il bosco della Consevola
governo di SV (I). 23. Sassello con Mioglia e Ponte Invrea (I). 24. Ponzone e Pareto col Sassello e Stella (S).
25. Ponzone e Cassinelle con Sassello et abbazia del Tiglieto (S). 26. Molare con Ovada e Rossiglione (S).
27. Ovada con Belforte (S). 28. Belforte con Rossiglione (S). 29. Polcevera con Elma e Casaleggio (S). 30.
Nove con Pasturana (S). 31. Nove con Basaluzzo (S). 32. Nove con Bosco (S). 33. Nove con Possolo (I). 34.
8
Si tratta quasi sempre di dispute estremamente complesse, visto il numero dei
soggetti implicati – dai principi potenti come il duca di Savoia e il granduca di Toscana ai
signori di minuscoli feudi, alcuni appartenenti a illustri casate come i Malaspina, i Landi e
i Del Carretto, altri a più modeste famiglie di nobiltà locale come i Costa, i Cepollina, i
Cazulini, gli Scarampi, i Lascaris – e visti anche i frequenti trasferimenti di sovranità sulle
singole terre. Possiamo rendercene conto, ad esempio, considerando una delle più lunghe
fra queste controversie, quella riguardante i confini tra Varese Ligure e Compiano.
Quest’ultima località apparteneva «alla casa de’ signori Landi prencipi di Valdetaro, con
quali per raggion de’ confini la Serenissima Repubblica ebbe delle continue differenze e di
longa durata che apportarono delle gravi dissensioni tra’ popoli confinanti e delle liti assai
dispendiose a’ respettivi prencipi padroni. Si terminorono poi le differenze nel 1611 col
mezzo di un compromesso universale» fra due delegati delle parti che il 17 maggio di
quell’anno «stabilirono i confini dell’uno e dell’altro Stato, deliberando ancora la
piantatione de termini divisorij del territorio di Varese da quello di Compiano»23
. Ma
quest’ultima terra viene acquistata dal principe Doria, col quale nel 1632 si riapre una
piccola disputa per la rimozione di alcuni termini; poi dal duca di Massa, che «nel 1682 si
prese assonto di provare che la Repubblica Serenissima non habbia dominio di là del fiume
Taro per mezzo dell’essame di molti testimonij ». Infine Compiano passa al duca di Parma,
il quale rivendica il possesso della selva di Penna, luogo strategico per riscuotervi il dazio
delle merci che passano il Taro. A quel punto, la Giunta ha il non facile compito di
ricostruire la documentazione che comprovi i diritti della Repubblica, a partire almeno
dall’accordo del 1611, ben sapendo tra l’altro che anche dopo quella sentenza «sono seguiti
di tempo in tempo qualche dissensioni tra’ popoli confinanti, che penuria già mai non fu di
risse»: una frase, quest’ultima, che ci richiama a quell’intreccio tra controversie
diplomatiche e beghe di privati o di piccole comunità di cui dicevamo poc’anzi.
Un altro aspetto da mettere in evidenza, del quale troviamo traccia anche nelle
istruzioni al Commissario Raggio citate più sopra, è l’estrema cautela con cui la Giunta e i
suoi emissari sono costretti a operare. La Repubblica è piccola e militarmente debole, non
può fare il viso dell’armi con i suoi vicini maggiori, e talvolta neppure con i più modesti
signorotti, se questi riescono a trovare protezione in una potenza straniera, a cominciare
ovviamente dall’Impero, titolare dell’alto dominio sui loro feudi. Questa cautela richiede
che ci si fondi sul diritto ben più che sulla forza: quindi da un lato, s’è detto,
sull’accertamento quanto più possibile completo dei titoli di possesso derivanti dalle
consuetudini locali, dagli usi del territorio e dagli atti di giurisdizione; e d’altro lato sulla
raccolta e conservazione dei documenti di varia natura, compresi quelli di carattere privato
– per esempio i rogiti notarili – «riguardanti interessi de’ particolari, che possono alle volte
Nove col Tortonese per la Fraschetta (I). 35. Nove con Cassano per li Molini (I). 36. Nove con Tassarolo (I).
37. Nove con Serravalle (I). 38. Serravalle con Gavi (I). 39.Gavi con Carosio per la strada nuova (I). 40.
Buzalla con Fraxinello (I). 41. Montoggio con Torriglia (I). 42. Rappallo con S. Stefano (I). 43. Codorso
della podesteria di Varese con Strepeto del territorio di Compiano (I). 44. Orneto, Chiusola ed Antessio della
podesteria di Godano con Zeri del Pontremolese (I). 45. Zerri e Rossano del Pontremolese con Torpiana,
Valgioncata, Sasseta del comune di Zignago (I). 46. Rossano del Pontremolese con Suvero (I). 47. Vezola di
Zignago con Suvero (I). 48. Sero di Zignago con la Rocchetta (I). 49. Rocchetta con Brugnato e Stradonella
(I). 50. Beverino e Castiglioncello con Cavanella, Calice e Madrignano (I). 51. Montedevalli con Tivegna e
Bollano (I). 52. Bollano con Albiano e Stadano (I). 53. S. Stefano con Caprigiola (I). 54. Falcinello con
Ponzanello (I). 55. Falcinello e Sarzana con Giucano di Fosdinovo (I). 56. Carrara con Ortonovo, e Nicola
(I). 57. Sarzana, Ortonovo e Nicola con Massa e Carrara per la Parmignola (I). 23
ASG, GC, 98: «Notizie per il confine di Varese verso Compiano», senza data.
9
giovare a quelli del publico, particolarmente per l’enonciativa de’ confini»24
. «Raccogliere
e metter per ordine tutte le scritture che si potranno avere di qualsivoglia luogo spettante
alla Repubblica», si è visto, è tra i compiti originari della Giunta, e viene in effetti
assiduamente perseguito, anche mediante un’oculata sorveglianza sugli archivi delle
comunità, comprese le più piccole: quello di Ameglia, ad esempio, a proposito del quale
nel 1701 e nel 1707 si emanano ordini, prima «per la miglior custodia delle scritture» in
esso contenute, poi per lasciarvi solo «quelle che sono sopra interessi de’ particolari»,
trasportando invece a Sarzana, capoluogo della circoscrizione, «tutte l’altre che riguardano
matteria de’ confini»25
. Com’è ovvio, è però soprattutto sulle località maggiori, o di
maggior interesse strategico, che si appunta l’attenzione della Giunta, la quale funziona
spesso come una sorta di ufficio storico, con il compito di ricostruire anche per uno spazio
di molti secoli titoli e passaggi di sovranità26
. Così avviene per Gavi, terra incuneata tra
feudi e possedimenti stranieri che ospita una delle principali fortezze della Repubblica, e
sulla quale si raccolgono documenti risalenti al XII secolo; o per la val Polcevera, le cui
antiche carte servono a sostenere dispute con i vicini feudi delle valli Stura e Scrivia;
naturalmente per Finale, a sostegno delle ragioni della Repubblica su quel Marchesato e sul
diritto di vendervi il sale; per Sarzana, importante città di confine; per il feudo di Sassello,
di cui Genova è riuscita a impadronirsi all’inizio del Seicento; per Oneglia, la cui cessione
al Savoia la Repubblica non riesce a digerire27
; e in pratica per tutti quei luoghi che
rappresentano altrettanti “punti caldi” dello Stato genovese28
.
24
Ibidem: «Notulario di vari instrumenti rogati da non so qual notaro, la maggior parte nel luogo della
Pieve di Teco». 25
ASG, Mss, 160. 26
Alcune filze della Giunta (per esempio ASG, GC, 61) si configurano come una sorta di archivio in cui
si raccolgono, in originale o più spesso in copia, diplomi, investiture, convenzioni fra comunità e altri
documenti anche molto antichi, reperiti e conservati per sostenere le dispute. Ma soprattutto va considerato
che nelle oltre cento filze dell’Archivio segreto (ASG, AS, 191-294) dedicate a singole dispute di confine è
frequente la presenza di carte risalenti molto indietro nel tempo, sino al XIII secolo. D’altronde quando si
apre una vertenza, sia pur minima, riguardante particolari diritti, è consueto il ricorso da ambe le parti alla
documentazione più antica. Per fare un esempio, nel fascicolo «Giunta de’ Confini. Pratica per la pretenzione
del conte di Millesimo in riguardo a franchiggie daziarie, 1692-1720» si riferisce che costui ritiene «di non
esser soggetto al pagamento de’ datij, e particolarmente per la vena del ferro e ferraccione che serve per la
sua ferriera detta d’Acquafredda, come né meno per il ferro lavorato in essa, fondando questa sua pretensione
sopra un contratto che fece il marchese Bonifacio Del Carretto ascendente di esso conte nell’anno 1326 o
altro più vero tempo ad Emanuele ed Antonio fratelli marchesi del Finale tutti Del Carretto». Inevitabile,
quindi, che la Giunta obietti esibendo documenti altrettanto antichi (ASG, GC, 53). 27
«Il luogo di Oneglia ha in ogni tempo da molte centinaia d’anni in qua formato soggettione con la
Repubblica di Genova, la quale vi ha essercitato superiorità et dominio diretto, per ciò che sin l’anno 1199 gli
homini di Oneglia giurorno fideltà alla detta Repubblica et promissero concorrer ad hostem et cavalcata, et
osservare gli ordini et comandamenti di detta Repubblica». Si ricorda che ne restava proibita l’alienazione
senza il consenso «del superiore, onde havendo novamente l’anno 1576 il signor Gio Geronimo Doria fatto
alienatione del detto luogo di Oneglia et altre sue partecipationi che havea nella valle superiore di detto luogo
al duca di Savoia senza assenso et beneplacito di detta Repubblica, resta tale alienatione nulla, et oltre di ciò
il feudo devoluto et aperto alla detta Repubblica»; e si rileva che «essendo quel luogo posto nelle viscere del
Stato di detta Repubblica non può né potrà mai quietarsi che alcuno se ne impatronisca, meno de ogni altro il
duca di Savoia per la opportunità che se le apre alle cose ligustiche» (ASG, GC, 98). 28
Ibidem. In questa filza si trovano molti piccoli dossier contenenti documenti storici e cronistorie di
controversie riguardanti, oltre ai luoghi già menzionati, Porto Maurizio, Montegrosso e Borghetto di
Mendatica, Cosio, Maremo, Velago, Rezzo, Masone (per cui si indicano le investiture dal XIII secolo),
Pontremoli (con la relazione della Giunta circa «gl’attentati de’ sudditi del granduca nel Dominio della
Repubblica», la «controversia de’ confini tra la Serenissima Repubblica di Genova et il Serenissimo Gran
Duca di Firenze», cioè la pretesa del granduca che «il suo Stato di Pontremoli» si estenda sino a parte del
territorio di Godano e Zignago, e gli aggiustamenti col duca di Parma), la val Polcevera e le sue controversie
10
È però soprattutto su Savona, la maggiore e più problematica città del Dominio, che
la Giunta raccoglie o fa raccogliere una cospicua quantità di «notizie istoriche», «scritture
in carta pergamena con carattere gotico e poco intelligibile», altre «registrate ne’ Libri
Iurium», altre ancora «esistenti ne’ fogliazzi de’ confini»29
. Documenti che ne ripercorrono
le vicende «per lo spazio di ben cinque secoli, vale a dire dal decimo primo sino doppo del
decimo quinto, quando le cose della Repubblica non più soggette a fatali vicissitudini
rimasero stabilite su quella base di grandezza e di libertà sopra di cui tutta via si
mantengono»30
. L’incipit di una lunga relazione stesa sulla base di quei documenti recita:
«Il dominio della Serenissima Repubblica di Genova sopra Savona ha questo in sé di
singolare e di proprio, che non è limitato ad un atto solo di legitimo e legale acquisto, ma
in sé ne contiene una longhissima serie, dalla quale apponto ne deriva un dominio
veramente compito et innegabile»31
. Un’ancor più corposa memoria Sulla dipendenza della
città di Savona dal dominio genovese ricostruisce minuziosamente i rapporti tra le due città
sino alla metà del Seicento, contestando sia le pretese d’indipendenza – passate e presenti –
della comunità soggetta, sia quelle di alto dominio sulla stessa rivendicate dagli imperatori:
«Posto adunque così giusto e lungo dominio che la Repubblica ha di Savona – si dice in un
passo della memoria – resta a discorrere se verun principe, e segnatamente l’imperatore,
possa pretendere sopra di detta città alcuna anteriorità o ipoteca o altro gius turbativo del
possesso che ne ha la Repubblica»; e naturalmente la risposta è del tutto negativa32
.
La debolezza della Repubblica richiede anche che essa, nelle proprie rivendicazioni,
si appoggi – più ancora di quanto fanno altri principi – sull’iniziativa e direi quasi sul
protagonismo dei sudditi abitanti nelle comunità di confine. Questo finisce per essere un
efficace instrumentum regni, perché si traduce in una scrupolosa attenzione agli interessi
con Busalla, Pieve («la più antica memoria che si ricavi dall’Archivio segreto circa il possesso della Pieve, o
sia valle Arroscia è dell’anno 1204»), Pietra, Giustenice, Toirano, Bergeggi, Spotorno («notizia dell’acquisto
del luogo della Pietra et altri vicini fatto dalla Serenissima Repubblica l’anno 1385 dal pontefice Urbano
VI»), Masone e Ovada (con indicazione di titoli di possesso, cessioni, investiture), Gavi e Parodi («usque de
anno 1130 superioritas ianuensis orta videtur ex praecepto consulis Alberto de Gavi»), Stellanello, Carrosio,
Bardineto, Albenga (con un lungo elenco di passaggi di sovranità e possesso), Lingueglietta («questo feudo o
castellania o contado […] è antichissimo quanto al supremo e diretto dominio, et anco per la maggior parte
dell’utile, della Serenissima Repubblica di Genova et de’ signori Lengueglia, i quali sin al presente ne son
sempre stati infeudati dalla prefata Serenissima Repubblica», come risulta a partire da un documento del
1199), Vado, Segno, Quiliano (con vari «istromenti di vendita»), Noli, Campo (oggi Campo Ligure, di cui si
riportano varie notizie storiche e si citano le successive investiture), Cairo (con una relazione che ricorda
come il 25 luglio 1214 il marchese Otto Del Carretto e suo figlio Ugo abbiano fatto donazione del
Marchesato del Cairo al comune di Genova, il quale poi lo ha reinvestito allo stesso marchese: «deve
osservarsi che ne’ sudetti luoghi la Repubblica Serenissima vi ha al presente dell’interesse per li confini, e
che particolarmente ne’ boschi del Dego vi sono sovente delle differenze per la pretensione de’ pascoli con
sudditi della Repubblica, onde quando si dovesse concedere copia aotentica di sudetta donatione et
investitura non sarebbe se non accertato che la Gionta Eccellentissima de’ Confini ne fusse intesa, […] come
già è seguito in consimili occasioni»), Bollano, Castiglioncello, Brugnato, Ponzano, Falcinello, S. Stefano,
Ameglia, La Spezia (su cui esiste una lunga relazione in data 10 marzo 1710, commissionata dalla Giunta per
«essere intierata de’ fondamenti veri e legali delle ragioni che ha la Serenissima Repubblica sopra tali luoghi
[…] e loro vicarie e pertinenze»), Diano, Arnasco, Falcinello, Bardineto, Carrosio, Cisano, Zuccarello,
Conscente, Casanova e molti altri luoghi o di pertinenza della Repubblica, o su cui essa rivendica una
qualche sovranità, o dei quali – come feudi imperiali – è investita per qualche carato («tempo nel quale ha da
governare la Serenissima Repubblica nel feudo di Casanova per tre caratti»). 29
ASG, AS, 292-294. 30
ASG, GC, 98. 31
Ibidem. 32
ASG, AS, 361, n. 57.
11
locali, che rafforza l’intesa tra il governo e i suoi popoli, accrescendo la fedeltà di questi
ultimi. Ben consapevole di questo fatto, la Giunta rivolge una parte cospicua della propria
attività a una materia che apparentemente non dovrebbe competerle, vale a dire il controllo
dei confini interni, assai rilevanti in uno Stato che – in misura più marcata rispetto ad altri
corpi politici coevi – è un mosaico di comunità dotate spesso di notevole autonomia e
legate alla Dominante da patti e rapporti di sudditanza tra loro diversi. L’arbitrato fra
queste comunità, ogni qual volta si profili un dissidio fra esse, è un diritto-dovere
irrinunciabile del governo genovese, e in particolare della Giunta, che può disporre
apposite visite ai loro confini, come quella effettuata nel 1601per definire la ripartizione
esatta del territorio fra Varazze, Celle e Albisola33
.
Anche per questi temi, i già citati registri delle «pandette confinium» sono una
miniera d’informazioni. Scorrendo le pratiche ivi sommariamente elencate, si è colpiti
dall’enorme quantità di interventi che riguardano ogni tipo di contenzioso fra le comunità
del Dominio o all’interno di esse per l’uso di pascoli, boschi e corsi d’acqua, la
disponibilità delle comunaglie, i furti di bestiame, la ripartizione dei carichi fiscali, gli
insulti a persone, il mancato rispetto di statuti locali e in pratica per qualsiasi controversia o
dissapore di cui giunga notizia al potere centrale tramite l’invio di suppliche o la
segnalazione dei giusdicenti periferici: informazioni tutte che vengono trasmesse alla
Giunta perché consideri, riferisca, istruisca, provveda. In pratica il governo prende atto,
molto lucidamente, che quando due comunità – o due gruppi all’interno di una stessa
comunità – confliggono per l’uso o il riparto di qualche risorsa, dal loro punto di vista c’è
poca differenza se la controparte è situata all’interno o all’esterno del territorio dello Stato.
Per l’autorità centrale, viceversa, è ovvio che il secondo caso è più rilevante; ma essa non
può permettersi di ignorare il primo, anzi deve dedicargli pari attenzione, perché vi è
ugualmente in gioco la dignità, la giurisdizione e la stessa sovranità della Repubblica.
Prendiamo ad esempio la città di Albenga, che non è terra di confine e il cui legittimo
possesso non è contestato da alcun principe straniero, ma che occupa nondimeno uno
spazio rilevante nella documentazione della Giunta. Tra le questioni trattate possiamo
trovare la proibizione del pascolo delle pecore, decisa nel 1627 dal parlamento di quella
città e contestata dalla vicina comunità di Alassio; un’istanza dei borghi e delle ville
suburbane, nel 1668, «per li luoghi che spettano alle loro figlie» nel monastero cittadino di
S. Tomaso; un dissidio con la comunità di Borghetto, nel 1674, circa il pagamento delle
«avarie», cioè delle imposte locali; nel 1684, un problema legato all’acqua del fiume Centa
«che di notte con numero di gente, bovi et altri attrezzi si travaglia per divertirla dal suo
corso» a vantaggio di «padroni particolari che possiedono stabili in quelle parti» e con
«gravi danni alla città»; nel 1699, l’invio di un commissario per ovviare a disordini del
locale Ufficio di abbondanza e alla cattiva gestione di lasciti pii34
; e si potrebbe continuare
a lungo, per questa come per ogni altra località, essendo incredibile il numero e la varietà
degli affari su cui la Giunta è chiamata a pronunciarsi, perché ad essa viene «appoggiata»,
in pratica, qualunque vertenza che abbia anche la più debole attinenza con questioni di
giurisdizione territoriale35
.
33
ASG, GC, 53. 34
ASG, Mss, 160. 35
Nelle carte relative alla già citata visita generale dei confini condotta da Giovanni Battista Raggio, per
esempio, si riscontra che a costui vengono affidati anche incarichi apparentemente del tutto estranei al suo
compito, come quelli – attribuitigli dal Magistrato dei Censori – relativi al controllo delle mete, dei pesi, delle
misure e della qualità delle merci; o quelli riguardanti la repressione di delitti e atti di banditismo; o ancora la
sorveglianza sulle monete. Da un lato questa estensione di attribuzioni è dettata dal desiderio di risparmiare –
12
Molto spesso si tratta di faccende davvero insignificanti, come quella riferita dal
capitano della Pieve il 19 dicembre 1720 a proposito di quattro uomini del piccolo paese di
Caprauna, due dei quali, mentre si recavano al mercato, «son stati assaltati da soldati della
livrea di Savoia, quali con l’archibuggio teso alla loro vita gli hanno prima dimandata la
bolletta di qualche galline che portavano, et avendogli essi risposto che sono sul Dominio
di Vostre Signorie Serenissime e che non sogiacciono a veruna bolletta, gli son subito
andati intorno e gli hanno per forza prese tre galline, e poi li hanno lasciati continuare il
camino a questa volta con maltrattarli et ingiuriarli». Lo stesso è accaduto agli altri due, i
quali sono stati perquisiti a forza e, visto che portavano solo delle rape, gli è stato rubato
«qualche poco formaggio» che avevano in tasca36
. La lettera del capitano contenente questi
fatterelli, si badi bene, viene letta nientemeno che al Doge e «agli Eccellentissimi di
Palazzo», quindi rimessa alla Giunta «perché vi abbia cognizione e rifera». Si tratta, è vero,
di un sopruso perpetrato da soldati stranieri a danno di sudditi della Repubblica; ma non
può non stupire la capacità di considerare e di portare ai vertici dello Stato episodi così
minuti. Tanto più che ne esistono moltissimi altri esempi riguardanti la cattura di qualche
pecora, il furto di un asino, o il sequestro di un collo a un mulattiere. Senza contare che la
Giunta è chiamata a occuparsi di fatti altrettanto trascurabili anche quando non sia in gioco
il rapporto con un altro principe o signore37
: rendere giustizia ai sudditi e tutelarne i diritti è
infatti ritenuto lo strumento migliore per garantire – come appunto recitava il decreto
istitutivo della Giunta – la «conservazione del territorio e giurisdizione della Repubblica e
suoi confini». Il che suggerisce, tra l’altro, che il luogo comune secondo cui lo Stato
genovese sarebbe poco presente sul proprio Dominio va rifiutato, o almeno accolto con
riserve, vista la sua capacità di essere molto vicino alle esigenze quotidiane dei popoli.
Altri compiti ancora ricadono su questa magistratura, tali da configurarla per vari
aspetti quale un vero ministero degli esteri: anzitutto perché, quando le controversie locali
si trasferiscono sul piano diplomatico, è ad essa che spetta istruire e seguire le trattative, o
preparare la documentazione da presentare nel caso di una mediazione o di un arbitrato
internazionale, come avviene a più riprese per le lunghe dispute con lo Stato sabaudo38
.
Inoltre, anche di là dalle mere questioni confinarie, essa è chiamata a occuparsi di molti
affari concernenti le relazioni estere: il rispetto delle precedenze e del cerimoniale, perché
la Repubblica non sia umiliata nei rapporti con le altre potenze o non commetta sgarbi nei
loro confronti; le richieste di estradizione, le «concessioni de’ rei ottenute da principi
forastieri» o disposte da Genova; la cattura e restituzione dei disertori di altri eserciti; gli
atti di cortesia nei confronti di regnanti, le felicitazioni per le nascite, le condoglianze per i
lutti; i favori accordati a personaggi di rilievo in transito da Genova (ospitarli in un
palazzo, concedere loro una quarantena più breve, mettere a disposizione una galea per i
loro spostamenti); i passaggi di truppe sul territorio genovese o l’accoglienza nei porti
si utilizza cioè una persona che già si trova sul posto e si evita di inviarne altre – ma a ben vedere anche
questi sono «atti di sovranità» che servono a rafforzare la giurisdizione della Repubblica. 36
ASG, GC, 61. 37
L’11 luglio 1756, ad esempio, il Governatore di Savona riferisce circa una «bestia mulatina che Gio
Batta Rovere di Berzezzi pensò di trattenere avendola riconosciuta per una di quelle che furono manprese nel
bosco di Crivero», mentre un altro mulattiere di Vado sostiene che il mulo è suo. Anche questo insignificante
affare viene trasmesso alla Giunta, affinché «abbia facoltà di dare tutti quelli ulteriori ordini et instruzioni che
più stimerà» (ASG, GC, 62). 38
Non mi soffermo su queste dispute e sulle relative mediazioni internazionali, rimandando all’esauriente
volume di P. Palumbo, Un confine difficile. Controversie tra la Repubblica di Genova e il Regno di Sardegna
nel Settecento, Torino, Silvio Zamorani editore, 2010.
13
liguri di navi da guerra estere, cose che devono essere scrupolosamente disciplinate perché
non si possa accusare la Repubblica di aver violato quella neutralità su cui si fonda la sua
politica estera; l’attenzione alle strade aperte da Stati limitrofi, che possono configurare un
pericolo militare o una perdita d’introiti daziari; l’appoggio dato ai corrieri e ai mastri di
posta quando incontrino «pregiudicij e disturbi» nel transito per altri paesi; il controllo
sugli «artisti», per impedire «che l’arti radichate nel Dominio non si portassero ad
introdursi ne’ Stati forastieri». Ma è soprattutto su una materia particolare – cioè quella che
riguarda i possibili ingrandimenti territoriali – che la Giunta svolge con continuità e con
estremo impegno incombenze di portata davvero internazionale.
«I nostri antichi», recita un biglietto di calice letto nei Serenissimi Collegi il 30
ottobre 1705, ebbero grande «attenzione alle congionture di aumentare il Dominio, come si
scorge nei tanti aquisti fatti in diversi tempi, non trascurandone alcuno quantonque si fusse
di poca considerazione, fra’ quali vi sono Gavi, Voltaggio, Ovada, Sassello, una porzione
di Carrosio, metà di Campo, Serravalle, Zuccarello, e quest’ultimo anche a costo di una
guerra che fu così disastrosa col duca di Savoia nostro competitore in questa compra»39
.
L’anonimo estensore, inutile dirlo, deplora che in seguito la Repubblica si sia invece
lasciata sfuggire altre buone occasioni d’ingrandimento territoriale, ma suggerisce che
sarebbe ora possibile e opportuno riprendere l’iniziativa in questo campo. In realtà Genova,
come ha sempre avuto cura di difendere puntigliosamente i confini del proprio Stato con i
mezzi che abbiamo sommariamente indicato, così non ha mai trascurato le opportunità di
accrescerlo, naturalmente utilizzando gli unici strumenti a sua disposizione, vale a dire non
la forza militare, ma il denaro e la diplomazia. Come abbiamo anticipato più sopra, tra i
compiti primari della Giunta si colloca, infatti, quello di «acquistar territorio e
giurisdizione». Negli anni Settanta del Cinquecento Genova – lo abbiamo ricordato – ha
subito due colpi gravissimi perdendo Oneglia e lasciando il Marchesato del Finale in mano
agli spagnoli: ammaestrata anche da questi insuccessi, avvia nel decennio seguente una
politica di ricompra dei feudi confinanti con il suo Dominio o «inviscerati» in esso, che
riguarda le terre appena menzionate e altre ancora, come S. Stefano d’Aveto, Lingueglietta
e Savignone40
.
Così non si può aprire alcuna filza della Giunta dei Confini senza trovarci molte
pratiche riguardanti, appunto, il possibile acquisto di feudi, materia che peraltro impegna
tutti gli apparati dello Stato genovese, dai Serenissimi Collegi agli ambasciatori presso le
corti estere ai giusdicenti periferici, i quali ultimi sono sempre molto attenti a segnalare se
qualche vassallo dell’Impero – magari perché oberato di debiti – ha intenzione di vendere
in tutto o in parte la sua signoria41
. I successi non sono trascurabili, visto che alla fine di
questa vicenda i feudi imperiali acquistati dalla Repubblica copriranno una superficie pari
39
ASG, AS, 102. 40
G. Assereto, Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo,
Savona, Elio Ferraris Editore, 1999, p. 27. La Repubblica conta sul fatto che molti feudi posti ai confini o
all’interno del Dominio appartengono a patrizi genovesi; ma, memore anche del caso di Oneglia, nel 1583
emana una «additio statutis de pagis non vendendis» che inasprisce le pene contro chi, senza licenza del
Senato, aliena a principi forestieri feudi situati «nel distretto del Dominio di Genova o vicino ad esso per
venti miglia» (G. Giacchero, Il Seicento e le Compere di San Giorgio, Genova, Sagep, 1979, pp. 104-105).
Tale disposizione verrà mantenuta nonostante il palese disappunto espresso dalla cancelleria imperiale (S.
Pugliese, Le prime strette dell’Austria in Italia, Milano-Roma, Treves, 1932, p. 88). 41
Quanto ai diplomatici, com’è ovvio, ad occuparsi della materia sono soprattutto quelli accreditati
presso l’imperatore. Si veda ad esempio ASG, AS, 2719: Relazioni dei ministri all’estero, Vienna 1613-1775.
14
al 17,7% dell’intero Dominio42
. Ma tra Sei e Settecento, in questa materia, le sconfitte sono
certamente più numerose, a cominciare da alcuni casi particolarmente brucianti: in
particolare quelli di due località strategiche come Pontremoli – che a metà del XVII secolo,
conteso tra la Repubblica e il Granducato di Toscana, finisce a quest’ultimo43
– e Aulla,
già possedimento della famiglia genovese dei Centurione marchesi di Estepa, la cui
trattativa si trascina dal 1680 al 1720, senza che Genova riesca a impedirne, ancora una
volta, l’acquisto da parte del granduca44
.
La guerra di Successione spagnola, con il conseguente bisogno di denaro da parte
dell’Impero, offre alla Repubblica, sin dal 1704, «l’opportunità di acquistare una parte dei
feudi imperiali di maggior pubblica convenienza, ed anche di concerto col duca di Savoia».
Ma la trattativa si arresta sia per diffidenza verso la corte di Torino, sia ancor più perché si
teme che un esborso di denaro all’imperatore Leopoldo sia interpretato dalla Francia e
dalla Spagna come un’iniziativa «per sovenirlo nella guerra allora vegliante con le due
Corone» 45
. Tre anni dopo, con una missione diplomatica di Costantino Balbi a Vienna, si
riprendono le trattative, ma ancora con poco costrutto46
. Proprio sul finire della guerra, nel
1713, a Genova riesce però il colpo grosso dell’acquisto di Finale, la terra in assoluto più
appetita47
. Altre iniziative riguardanti feudi contesi tra Torino e Genova, condotte tra il
1720 e il 1724 dall’ambasciatore sabaudo a Vienna marchese di Breglio con il suo
omologo genovese Clemente Doria, non vanno invece a buon fine, anche perché la
Repubblica avvia contemporaneamente un progetto ambizioso per l’acquisto del Ducato di
Massa, fallendo su entrambi i fronti48
. Del 1728 è l’ultimo e non memorabile successo
genovese, con l’acquisto di parte del feudo di Busalla, di cui peraltro si ottiene l’investitura
solo dieci anni dopo49
. Da allora è Torino a farla da protagonista, ottenendo con la guerra
di Successione polacca la superiorità territoriale sui feudi delle Langhe – ben
cinquantasette località, buona parte delle quali confinanti con la Repubblica di Genova e
alcune situate su punti chiave della viabilità tra il territorio genovese e la pianura Padana50
– e successivamente, col trattato di Worms del 1743, puntando all’acquisto dello stesso
Marchesato del Finale. Una minaccia talmente grave per Genova da costringerla, per la
prima volta dopo secoli, ad abbandonare la neutralità e a partecipare alla guerra di
Successione austriaca a fianco dei «gallispani»51
.
42
A. Zanini, Strategie politiche ed economia feudale cit., p. 41. 43
M. Giuliani, La contesa tra Genova e Firenze per l’acquisto di Pontremoli (1647-1650), «Bollettino
ligustico per la storia e la cultura regionale», X, 1958, pp. 55-65. 44
Nelle filze della Giunta (ASG, AS, 86-114) sono documentati tutti i tentativi per perfezionare
l’acquisto, che si possono seguire anche in un bel dossier preparato nel 1721 dall’archivista Viceti per la
Giunta stessa (ASG, GC, 98). 45
ASG, GC, 62: relazione della Giunta dei Confini senza data (ma presumibilmente del 1757). 46
ASG, AS, 458. 47
Sull’importanza del Marchesato del Finale per Genova e sui ripetuti tentativi di acquistarlo si veda,
riassuntivamente, P. Calcagno, «La puerta a la mar» del Ducato di Milano. Il Marchesato del Finale nel
sistema imperiale spagnolo (1571-1713), Roma, Viella, 2011. 48
Corso per l’Italia e la Germania fatto dal Magnifico Clemente Doria incaricato de publici affari
dall’anno 1710 sino all’anno 1730, ASG, Mss, 715-715A, cc. 52v-53v. 49
A. Zanini, Strategie politiche ed economia feudale cit., p. 32; V. Tigrino, Giurisdizioni e transiti nel
Settecento. I feudi imperiali tra il Genovesato e la pianura padana, in M. Cavallera (a cura di), Lungo le
antiche strade cit., pp. 45-94, in particolare p. 51. 50
P. Palumbo, Un confine difficile cit., p. 73. 51
Nel trattato di Aranjuez che determina quell’alleanza sono contenuti, tra l’altro, alcuni «articulos
separados y secretos» con i quali le due Corone si impegnano a conquistare e cedere alla Repubblica
numerosi feudi del Ponente ligure: Dolceacqua, Perinaldo, Apricale, Seborga, Cosio, Testico, Stellanello,
15
La questione dei feudi, lo si è accennato all’inizio, implica quella assai complessa e
delicata dei rapporti con il Sacro Romano Impero, nei confronti del quale Genova è
costretta a subire una plurisecolare condizione di inferiorità e dipendenza: condizione che
diviene particolarmente drammatica da quando Sanremo, in contrasto e poi in aperta
rivolta contro la sua Dominante, rivendica la propria condizione di città imperiale e si
appella alla cancelleria aulica, provocando una “guerra di carte” in cui è messa in
discussione la stessa indipendenza della Repubblica52
. Proprio a questi temi si rivolge la
maggiore attività della Giunta a partire dalla metà del Settecento, e in particolare durante la
guerra dei Sette anni, da un lato con la ripresa delle iniziative per gli ingrandimenti
territoriali (il 24 novembre 1757 viene prorogata una legge del 1728 che consente «di fare
acquisto de feudi, luoghi, territori e giurisdizioni in tutto o in parte […], secondo che se ne
presentasse l’opportunità, con facoltà […] di spendere al detto acquisto tutte quelle somme
e prezzi che occorressero per tal conto»53
), e d’altro lato con un piano per liberarsi della
pretesa superiorità imperiale.
Al 7 marzo 1757 risale una «relazione dell’Eccellentissima Gionta de’ Confini
riguardo l’acquisto de feudi di tramontana e della Luniggiana» che fa il punto sulle
incombenze ad essa appoggiate «relativamente a diversi e tutti importantissimi interessi
della Repubblica alla corte di Vienna». Tra questi le vertenze su Campofreddo e Sanremo,
poi la necessità di «togliere qualunque dubbio circa la superiorità territoriale competente
alla Repubblica sopra i feudi che già da essa sono posseduti», e di ottenere «le investiture
dei sudetti feudi già posseduti e degli altri che riuscisse acquistare, senza che in essi
facciasi menzione né dei privileggi cesarei, né delle antiche difficoltà sulla corona regia,
sulla data del Real Palazzo e di altre simili cavillazioni che all'occorrenza di dette
investiture si oppongono, e senza il carico di ottenerle da ogni nuovo imperatore, ma solo
dopo il periodo di cinquanta in cinquanta anni; e procurando altresì che nella somma de'
laodemij da pagarsi all'occasione di dette investiture venga indirettamente compreso
qualonque eventuale carico di contribuzioni imperiali, onde per titoli di queste non possa
mai direttamente esiggersi dalla Repubblica qualsivoglia altro sborzo». Infine l’opportunità
di ottenere il vicariato imperiale, o per meglio dire una «delegazione di plenipotenza
cesarea perpetua […] così per i feudi che sono di antico possesso, come per quelli che
fossero di nuovo acquisto»54
. Si aggiunge che le suddette dispute su Campofreddo e
Garlenda, Arnasco, Nasino, Balestrino, Loano, Bardineto, Oneglia, Maro e altri ancora (una copia in ASG,
GC, 62). 52
N. Calvini, La rivoluzione del 1753 a Sanremo, Bordighera, Istituto internazionale di studi liguri,
1953; V. Tigrino, Castelli di carte. Giurisdizione e storia locale nel Settecento in una disputa fra Sanremo e
Genova (1729-35), «Quaderni storici», XXXIV, 1999, n. 101, pp. 475-506; e, soprattutto, Id., Sudditi e
confederati. Sanremo, Genova e una storia particolare del Settecento europeo, Alessandria, Edizioni
dell’Orso, 2009. Come vien detto nelle righe che seguono, un’altra lunga disputa con l’Impero, iniziata a fine
Seicento e protrattasi per buona parte del Settecento, riguarda il feudo di Campofreddo, oggi Campo Ligure,
di cui la Repubblica dal 1636 deteneva la metà in condominio con la famiglia Spinola (ASG, AS, 224, 245,
246; D. Leoncini, Storia del feudo imperiale di Campo Freddo a cura di M. Calissano, F. P. Oliveri e G.
Ponte, Campo Ligure, Comune di Campo Ligure, 1989, pp. 207-313).
Sul tema dei rapporti tra Genova e l’Impero esiste ormai una bibliografia molto ampia: F. Edelmeyer,
Genova e l’Impero nel Cinquecento, ASLSP, n. s., vol. XLI/2, 2001, pp. 123-134; M. Schnettger, Reichsstadt
oder souveräne Republik? Genua und das Reich in der Frühen Neuzeit, in M. Schnettger-M. Verga (a cura
di), L’Impero e l’Italia nella prima età moderna-Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit, Bologna-
Berlin, il Mulino-Duncker & Humblot, 2006, pp. 277-297; Id., Principe sovrano oder civitas imperialis? Die
Republik Genua und das Alte Reich in der Frühen Neuzeit (1556-1797), Mainz, von Zabern, 2006. 53
ASG, AS, 1061. 54
ASG, GC, 62. Nei passi sopra citati si riassumono i principali aspetti del contenzioso tra Genova e
Vienna a proposito di investiture.
16
Sanremo, «sebbene in apparenza sopite, devono però riguardarsi come tuttavia veglianti e
quasi un fuoco ricoperto di cenere», cosicché «ricominceranno alla prima congiuntura se
non riesce di terminarle deffinitivamente». Per non parlare dei «pretesi diritti imperiali
ampliati oramai senza riserva e senza limiti sopra ogni parte del Dominio Serenissimo»,
tanto che alcuni recenti scritti non lasciano alla Repubblica quasi un solo angolo di terreno
che sia immune dalla macchia dell'imperialità».
Approfittando della guerra in corso, del bisogno di denaro che ha la corte di Vienna,
dell’influenza esercitata su di essa da quella di Versailles, dell’apparente buona
disposizione del ministro cesareo Beltrame Cristiani – un genovese d’origine che vorrebbe
favorire insieme la sua patria e l’imperatrice Maria Teresa – si potrebbe risolvere il
problema in modo definitivo. A tale scopo la Giunta «ha fatto formare un tipo esatto ed un
altro non geometrico da valersene alla opportunità, nei quali si descrive la situazione del
Dominio Serenissimo, l'ubicazione de' feudi imperiali e l'estensione degli acquistati dal re
di Sardegna»; e ha preparato un prospetto dei fondi che si potrebbero utilizzare per gli
«sborzi» necessari, prevedendo che ci vorranno almeno tre milioni: «né la detta partita
dovrà sembrare eccedente se si rifletta all’uso che deve farsene e all’inestimabile vantaggio
a cui sarebbe destinata», perché «niuna somma si sarà mai o più giustamente raccolta, o
più utilmente spesa quanto quella che servirà quasi per mettere l’ultima mano alla
sicurezza e alla indipendenza della Repubblica».
Un’altra minuziosa relazione della Giunta, non datata ma coeva alla precedente, rifà
la storia della politica feudale e dei rapporti con Vienna dalla fine del Seicento, elencando i
principali problemi sul tappeto: «I feudi riguardevoli che la Repubblica già possiede, quelli
che sarebbe desiderabile di acquistare tanto per il publico vantaggio quanto per la indennità
dei particolari possessori, le incessanti pretensioni imperiali ampliate ormai senza limite e
col fatto e con i volumi dati alle stampe; le notorie inquietudini tante volte sofferte per i
raccorsi [ricorsi] de’ sudditi sempre bene accolti dal Consiglio Aulico; le dispendiose liti
sostenute sovente in Vienna; i grandiosi sborzi a cui per tanti diversi titoli si è dovuto
soccombere; e la continua apprensione in cui il governo serenissimo si è sempre ritrovato
per gli effetti della temuta imperialità», cioè per la pretesa che la stessa Genova sia
«Camera imperiale». Tutto ciò fa sì che – se anche altre corti sono in grado di nuocere alla
Repubblica – nessuna può farlo quanto quella di Vienna, «che sola può colorire le sue
sinistre intenzioni colla plausibile apparenza delle giuridiche formalità». Quindi bisogna
una buona volta definire le pendenze con essa, per «mettersi al coperto, se sia possibile, da
ogni ulteriore disturbo dei tribunali cesarei, e tentare finalmente i mezzi opportuni rispetto
a quei feudi, che essendo o inviscerati o limitrofi al Dominio Serenissimo, ne risulterebbe
infinito danno al publico ed ai privati se […] passassero in mano ad altro principe, e
nominatamente in quelle del re di Sardegna», essendo ancora bruciante il ricordo
dell’acquisto da lui fatto «delle ben note terre imperiali nei preliminari del 1735». Una
materia tanto più grave, questa, se si riflette che alcuni feudi «s‘inoltrano con i loro confini
dentro le due valli vicine a questa Capitale, altri vengono a cadere sopra i siti più gelosi
della Riviera di Levante, altri intersecano il libero commercio con li Stati adiacenti, e tutti
vengono a circondare da ogni lato le più importanti situazioni del Dominio Serenissimo»55
.
Nonostante questa insistenza, e la persuasione che si possano ottenere molti
risultati56
, ancora una volta la Repubblica resta a mani vuote. Anzi, nel 1766 la Giunta
55
Ibidem. 56
E precisamente: «1. L’ultimazione delle pendenze di Campofreddo con rimettere quei sudditi al
tribunale del Condominio; 2. l’adeguamento della pratica di San Remo, almeno col mezzo termine di una
dichiarazione cesarea che v’imponga perpetuo silenzio; 3. la superiorità territoriale sopra i feudi che già sono
17
deve commissionare al Segretario di Stato Domenico Maria Tatis una corposa memoria
Sopra le investiture imperiali e dimanda de privileggi per consegnarla a Luca De Fornaris,
in partenza per la legazione di Vienna, affinché se ne serva nelle trattative con quella
corte57
. Si tratta infatti di evitare quelle richieste di rinnovo e conferma dei privilegi
concessi a Genova dagli imperatori del passato, che la Repubblica considera un’indebita
umiliazione – tanto che dal 1638 si cerca di evitarle – ma che il Consiglio Aulico continua
a pretendere, minacciando di non rinnovare le investiture dei feudi acquistati dalla
Repubblica stessa. Riportiamo integralmente in Appendice 2 la relazione, corredata di
un’aggiunta redatta anni dopo dallo stesso Tatis, perché vi si ripercorrono con estrema
precisione tutte le materie del contendere tra Vienna e Genova, e le varie forme in cui la
prima ha sempre cercato di affermare la propria superiorità sulla seconda; ma soprattutto
perché il testo, specie nella seconda parte, è uno splendido saggio di critica storica. Dopo
aver elencato con estrema precisione tutti i privilegi concessi a Genova dagli imperatori, a
partire da Corrado II sino a Giuseppe I, l’estensore dimostra quanto essi siano fittizi: lungi
dal concedere qualcosa, essi ogni volta non hanno fatto che prendere atto di una realtà già
esistente: «In fatti al udire che la Republica fu dalli imperatori privilegiata di sue maggiori
prerogative si potrebbe facilmente entrare in sospetto che ella ne fosse debitrice alla
liberalità de’ medesimi imperatori. Sarebbe questo un ben raro essempio di più che regia
munificenza. Ma il fatto sta che la nostra Republica anteriormente a tutte le concessioni
imperiali era in diritto e in possesso di sua libertà e dominio, come anche di tutte le altre
reali prerogative delle quali si fa menzione ne’ privileggi imperiali», come «il gius
privativo del traficar sale nel mare Ligustico», «il privileggio di coniar monete» concesso
da Corrado nel 1138 quando già da tempo il Comune ne batteva, il diritto di eleggersi i
propri consoli, e così via. Cosicché i formali atti di sottomissione di Genova all’Impero
sono stati sempre dettati o da un rispetto delle consuetudini, o da opportunità del tutto
contingenti: «Generalmente parlando, se si badi alle circonstanze de’ tempi ne’ quali si
ottennero i privileggi imperiali si vedrà che furono impetrati o nell’occasione dell’essersi i
genovesi rimessi in libertà con sottrarsi dalla suggezione de’ prencipi stranieri a’ quali per
sedare l’impeto delle insorte civili discordie erano stati obligati di sottomettersi, o per
dileguare le speranze de’ confinanti intenzionati di frastornare i possessi della Republica,
onde giovava venissero raffermati con il consenso e la ricognizione fattane da soggetti di
tanta autorità quali erano l’imperatori».
Documento di estrema precisione e lucidità, ma tutto impostato sulla difensiva,
questa relazione simboleggia bene l’attività della Giunta: la sua abilità nel trattare gli affari
più delicati e insieme la consapevolezza di agire all’interno di un organismo politico
debole, vaso di coccio fra vasi di ferro, con una sovranità sempre precaria, che va quasi
quotidianamente protetta e riaffermata con mezzi sottili e senza poter mai fare conto sulla
forza delle armi.
posseduti dalla Repubblica; 4. l’acquisto delli altri feudi imperiali situati nelle valli de’ Ratti, Bormida,
Aveto, Scrivia, Magra e Borbejra, o almeno di tutti quelli fra essi che sono di maggior gelosia ed importanza
per la Repubblica, nel modo espresso nel trattato di Aranjuez, ed aggiuntovi pure sopra di essi il diritto della
territoriale superiorità; 5. le investiture di questi e degli altri già posseduti dalla Repubblica senza che in esse
si faccia menzione o dei privileggi cesarei, o di tutte le altre difficoltà che in occasione di dette investiture si
oppongono dai tribunali di Vienna, e senza il carico di ottenerle da ogni nuovo imperatore, ma solo dopo un
certo periodo d’anni; 6. finalmente il vicariato imperiale perpetuo così nei feudi di antico possesso, come in
quelli di nuovo acquisto; ed acciò questo vicariato sia rivestito di quelle prerogative che lo esentino dalli
ulteriori disturbi, accompagnarlo col distintivo delle regie onoranze». 57
ASG, Mss, 715-715A, cc. 104-110.
18
Appendice 1
Proposta di decreto per l’istituzione della Giunta dei Confini58
Per metter ordine e provedere alla conservatione e territorio e confini della Repubblica si
loderìa che si facessero le proviggioni infrascritte.
1. E prima, che li Serenissimi Collegi facessero deputazione di tre delli Serenissimi Collegi,
a’ quali restasse appoggiata la cura di formar processi in nome dei Serenissimi Collegi sino alla
sentenza exclusive, et in appresso rifferirli alli detti Serenissimi Collegi, i quali dovranno fare la
sentenza, et abbino anche aotorità in fare qualonque altre diligenze giudicheranno necessarie usque
ad sententiam exclusive come si è detto sopra, l’ellezioni de’ quali duri per un anno, in fine del
quale, cioè del mese di decembre, possino di nuovo essere eletti li medesimi o altri come parrà a
essi Serenissimi Collegi. [approvato]
2. Che si deputino doi dottori di coleggio per consultori, li quali doveranno ancora essere
avocati della Repubblica in le liti che si movessero per caosa de confini, et l’ellezione di essi per
l’istesso tempo di un anno, et possano di nuovo esser elletti. [approvato]
3. Che si elegesse di più un sindico notaro di coleggio, che fusse uomo d’isperienza et
intelligenza tale che meritatamente fosse riputato sufficiente per il carico e cura di quanto in
appresso si anderà similmente distinguendo, al quale si assegni salario competente in maniera che
senza speranza di altri emolumenti straordinari possa in esso convenientemente trattenersi, con
obligo ancora di servire alla Repubblica in quelle occorrenze che si presentassero, et in quelle cure
che le fussero appoggiate, con dichiarazione che per quanto l’ellezione di esso fosse di persona
nobile, non s’intenda ricevere alcun pregiudizio alla sua nobiltà per l’esercitazione di detta cura.
Che il salario non ecceda lire doi mille l’anno. [non approvato]
4. Che li siano assegnati due giovani d’isperienza et fedeltà, li quali li servano in detta cura,
et particolarmente in andar fuori della città per ricercar scritture et far altre diligenze a beneficio
publico, a’ quali similmente si statueria conveniente salario, che tutti due non ecceda lire mille
l’anno. [non approvato]
5. Si deputi una stanza nel Palazzo nella quale li detti Signori Deputati possino congregarsi
per consultare e provedere alle cose concernenti alla loro cura, nella quale si debbano congregare
ogni volta che l’occasione e bisogno ricercherà, et almeno due volte la settimana per l’ordinario, in
quelli giorni massime che li doi Serenissimi Collegi non si congregano, et affine che più facilmente
possano attendere a detta cura restino esenti li detti Illustrissimi Deputati dall’assistere ad altri
Magistrati della città. [non approvato]
6. Avranno finalmente cura di tutte le liti e differenze di confine che la Repubblica abbia con
cui si voglia, ovvero in le quali la Repubblica in qualsivoglia modo possa avere interesse, usque
tamen ad sententiam exclusive. [approvato]
7. Averanno anco pensiero d’invigilare in tutte quelle provigioni, ordini e diligenze che
possano esser utili alla conservazione del territorio e giurisdizione della Repubblica e suoi confini.
Riconosceranno di più le ragioni che la Repubblica ha in tutto lo Stato, e particolarmente nelle terre
de’ confini e con li feudatari di essa Repubblica, le investiture loro, procurando che quelli di essi
che fussero stati negligenti in pigliare le debite investiture, che le piglino, ovvero che siano dalli
due Serenissimi Collegi dichiarati incorsi in le pene dalle leggi statuite, de quali ragioni doverà il
sindico farne un libro molto distinto et ordinato affine che con facilità si possino ritrovare tutte le
scritture pertinenti a qualsivoglia luogo o feudo della Repubblica, procurando di raccogliere
insieme dette scritture non solo dall’Archivio publico della Città, ma da ogni altra parte, e
spezialmente dalli luoghi stessi del Dominio. [approvato]
8. Si doveranno anco raccogliere e metter per ordine tutte le scritture che si potranno avere di
qualsivoglia luogo spettante alla Repubblica, quantonque al presente fusse da altri possesso, e
quelle riddurre similmente in un libro. [approvato]
58
ASG, AS, 1650.
19
9. Et oltre l’aotorità che in generale sarà conferta a detti signori deputati intorno alle suddette
cose dalli Serenissimi Collegi, potranno, in le occasioni che si presenteranno, ricercare quelle
aotorità più particolari che giudicheranno ispediente per essecuzione di dette cose e di quelle che
inoltre le fussero appoggiate dalli Serenissimi Collegi, li quali con facilità dovranno concedergliele.
[approvato]
10. Si potria ancora dar cura a detto sindico dell’Archivio del Palazzo affine che con più
facilità potesse pigliar informazione delle ragioni della Repubblica e quelle custodire per servirsene
in le occorrenze. [non approvato]
11. Doverà ancora aver carico e cura di diffendere sotto nome di Sindico della Repubblica le
liti e controversie che vertiscono e vertiranno per caosa di confini o giurisdizioni nelle quali la
Repubblica abbia interesse. [non approvato]
20
Appendice 2
Sopra le investiture imperiali e dimanda de privileggi59
Da che mancò al mondo la potenza e dominio dell’antico Imperio Romano, quei prencipi a’
quali ne fu trasferito il titolo senza più il possesso della corrispondente proporzionata giurisdizione
pretesero di mantenerne vivo in certa maniera ancor l’essercizio nella concessione de’ privileggi
imperiali, quali benché graziosi ed onorevoli, sempre però portano seco almeno arguisivamente una
qualonque siasi dipendenza di chi gli riceve da quello che viene a concedergli. Per lo che
quantonque ne’ tempi antichi in attestato delle opere grandi e gloriosamente operate da Genovesi in
vantaggio dell’Impero e di tutto il mondo cattolico si ottenessero molti di tali diplomatici privileggi
dalli imperadori Federico primo, Enrico sesto, Frederico 2°, Enrico 7°, Carlo 4° e Sigismondo
primo, stati poi confermati da Massimiliano e da Carlo 5°, passati però quei primi secoli e rozzi, la
Repubblica cominciò nel 1638 a far riparo in più chiederne la conferma o sia rinovazione per
motivo apponto de’ gelosissimi dovuti riguardi alla sovranità del suo principato, tanto anteriore di
tempo e superiore di origine a tutti i sopracennati privileggi imperiali.
Che però in detto anno 1638 si scrisse da’ Serenissimi Collegi al gentilhuomo Rodino
ressidente all’ora in Vienna per la Repubblica, che quanto alla conferma de’ privileggi si schivasse
l’occasione di domandarla e di riceverla, e che in ogni caso ciò solamente seguisse rispetto a’ due
di Carlo quinto, l’uno de’ 29 giugno 1529 che conteneva la conferma de’ privileggi conceduti da’
precedenti imperadori, con l’approvazione della libertà e stato che all’ora nelle due Riviere la
Repubblica possedeva, e l’altro del primo novembre 1536 in cui parimente restò approvato lo stato
della Repubblica e sua libertà, in segno della quale e per freggio di sua grandezza potesse la stessa
usare diversi ornamenti espressivi il suo principato. Ma se poi vedesse che i ministri di Vienna
insistessero per modo che non si potesse a meno di prendere la conferma degli altri, non mancasse
di farlo, per che quindi un’altra volta si eviterebbe di dimandarla, o almeno farebbe sopra di ciò
nuova considerazione.
Il fatto andò che il Magnifico Rodino così astretto da’ ministri di Vienna, doppo haver fatto
la dimanda per la conferma di sudetti due privileggi di Carlo quinto, presentò memoriale
all’imperadore che era Ferdinando terzo per la conferma ancora di altri due, il primo di
Massimiliano primo in data de 4 aprile 1513 che importava la proibizione di non potere alcuno,
eccetto i soli Genovesi, condurre né trafficar sali tra Marsiglia e Monte Argentino [sic, ma
Argentario], del che per altro la Repubblica già da trecento anni avanti ne era in possesso, tutto che
per qualche spatio di tempo interrotto dalle agitazioni di quei secoli, e l’altro di Carlo quinto in data
de ... 1536 nel quale quest’umperadore haveva anche confermato alla Repubblica il possesso e
dominio de’ luoghi che la stessa possedeva di là da Giovi.
Hor questa è stata l’ultima volta che siasi presa per parte della Repubblica da alcun
imperadore la conferma de privileggi, mentre in appresso nelle deliberazioni de’ Serenissimi
Collegi e Minor Consiglio si è sempre più fissata la massima che per decoro di questo governo non
sia conveniente né dimandare né ricevere una tale già per se stessa non necessaria conferma. Del
che instruiti i gentilhuomini che doppo il sudetto Magnifico Rodino sono stati successivamente
inviati alla corte di Vienna, si adoperorono essi in maniera che sempre loro è riuscito declinare da
una tale dimanda, non ostante i forti impegni in contrario de’ ministri cesarei, che più volte
indussero l’imperadori a negare la solita conferma delle investiture de’ feudi, se non si richiedeva
quella de’ privileggi, quando per altro questi nulla hanno che fare, e sono materia del tutto distinta
e separata dalle investiture de’ feudi acquistati dalla Repubblica per titoli legali, e quasi tutti per
mezzo di compra.
Prosseguendo la serie del fatto, essendo succeduto al sopra Riferito Ferdinando 3° il di lui
figlio Leopoldo primo, sortirono dal di lui Consiglio Aulico due voti, uno del 1661 e l’altro del
1663, co’ quali si voleva obligata la Repubblica a chiedere la conferma de’ privileggi in occasione
che si faceva instanza al nuovo imperadore per la solita rinovazione delle investiture de’ feudi. Per
59
ASG, Mss, 715-715A, cc. 104-110.
21
l’opposto i Serenissimi Collegi ordinorono al Magnifico Gio. Battista Pallavicino inviato al prefato
Leopoldo primo di astenersi di dare alcuna intenzione di voler prendere la conferma di quei
privileggi che non hanno conexione alcuna con detti feudi, quando bene gli venisse proposto di
farlo, come per il passato, separatamente dalla dimanda delle investiture, et etiamdio doppo che
dette investiture fussero state concesse, essendogli anche stata conferita la facoltà di spendere sino
a mille ducento talari in regali a’ ministri per ottenere la rinovazione delle investiture in detta
conformità libera dalla rinovazione de’ privileggi, e tale alla fine effettivamente si ottenne nel
1663, come da i transonti originali delle medesime investiture esistenti nell’armario delle
investiture.
Anzi per che il memoriale presentato all’imperadore dal detto gentilhuomo Pallavicino erasi
trovato, non si sa come, adulterato con la gionta dimanda della conferma di tutti i privileggi,
ottenne il detto gentilhuomo non solo che gli fusse restituito il memoriale sudetto, ma che venisse
anche anullato il decreto imperiale fatto sotto di esso, e presentato quindi altro memoriale seguito
dal decreto cesareo della libera concessione delle investiture, il tutto a tenore del contenuto nella
seguente scrittura:
“Lune 3 7bris 1663. Ser.mae Reip.cae Genuensis ablegatus sub p.so hodierno dicit, in
nuopero suo memoriali de 30 aug.ti pro renovatione et confirmatione investiture supra feudis
imperialibus exhibito, inserta fuisse clausula cum omnibus privilegiis ante habitis; tametsi igitur
hoc aliter intelligi non debeat qua de privilegiis ipsis feudis connexis; cum idem memoriale se
referat ad precedentia, in quibus haec restrictio reperitur. Attamen cum ea clausula contra tenorem
procuratoris et suam intentionem per errorem scriptoris irrepserit, petit illud memoriale sibi restitui,
ne quids ipsi sinistri imputatur, substituendo aliud, et de supra decreta pro nullis haberi.
Restituatur dicto supplicanti suum memoriale, et habeatur pro non exhibito, et consequenter
conclusum de supra factum habeatur pro non facto, et acceptetur alterum memoriale.
Idem in altero memoriale de p.so hodierno exhibet sub A mandatum suum procuratorium, et
inherendo prioribus congruis supplicationibus et petitionibus humillime petit renovationem et
confirmationem investiturarum aliquorum feudorum imperialium quae dicta Respublica longe ab
hinc tempore iuste et legitime tenet in confinibus Ligurie, v. g. Locorum et castrorum Montobii,
Varisii, Roccatagliate et Ponzoni, Marchionatus Zuccarelli, Saxelli, pro qua dicta investitura est
obtinenda participationis, Savignoni, Carosii et dimidis Campi, ut ex ultimis investituris quae in
authentica forma cum suis privilegiis in iis contentis producuntur, offerens se ad solitum fidelitatis
iuramentum et alia omnia de consuetudine vel de iure prestanda.
Vigore cesarei decreti die vigesima prima augusti nuperi admittatur dictus mandatarius ad
iuramentum fidelitatis et pro hac vice, citra tamen consequentiam quoad claosolam finalem. Dati in
mandato”.
La claosola finale di cui si parla in questo decreto e che incontrò molte difficoltà fu quella
del datis in Regali Palatio posta nel mandato di procura fatto dalla Repubblica al gentilhuomo
Pallavicino.
A Leopoldo successe il di lui figlio Giuseppe primo, cui fu spedito nel 1708 con titolo
d’inviato straordinario il Magnifico Constantino Balbi per congratularsi della di lui assonzione al
trono imperiale, con ordine di prendere in questa occasione l’investitura de’ feudi già di sopra
enonciati, con l’avvertenza però che quantonque in tempo de i due antecedenti imperadori
Ferdinando terzo e Leopoldo fusse stato ad essi prestato il giuramento di fedeltà dalle persone
immediate de’ Magnifici Rodino e Pallavicino, non doveva però esso Magnifico Balbi regolarsi in
questo sul loro essempio, mentre quelli havevano il solo titolo di gentilhuomini, ed egli lo haveva
d’inviato straordinario.
Incontrò il detto Magnifico Balbi molte difficoltà nel maneggio de’ ricevuti incarichi, ma
tutte felicemente le superò con la sua singolare destrezza e valore. La prima principale opposizione
fu quella della pretensione rinnovata dalla corte di Vienna di non dare la conferma delle investiture
senza la dimanda de’ privileggi, sopra di che furono fatti dal Consiglio Aulico più voti relativi a’
già rifferiti del 1661 e 1662, in coerenza de’ quali l’imperadore fece intendere al detto Magnifico
Balbi che Sua Maestà metteva in avvertenza la Repubblica di prendere la conferma de’ privileggi,
mentre secondo il costume se ne perde il vantaggio quando non si addimandi fra un anno ed un
22
giorno. Ma ciò non ostante doppo longhi trattati riuscì al sudetto inviato Balbi di ottenere la
conferma delle investiture senza che più si parlasse de’ privileggi.
Vi fu ancora molto contrasto da superare sulle circonstanze della procura, ma poi finalmente
l’imperadore venne alla seguente deliberazione stata communicata al sudetto Magnifico Balbi dal
vice Cancelliere dell’Impero, cioè “che Sua Maestà in considerazione della qualità e de’ meriti
della Serenissima Repubblica, e massime di quelli fattisi presso dell’Augustissima Casa in ogni
tempo e particolarmente in quello della guerra (all’hora presente) permetteva che per quella volta si
prendesse la rinovazione delle investiture per mezzo di agente aulico e sul mandato di procura già
presentato, cioè quello che conteneva la claosola datis in Regali Palatio ed il sigillo con la corona
reale, con che però dovesse la Repubblica Serenissima in avvenire astenersi dall’uno e l’altro,
quando fra tanto non ne ottenessero da Sua Maestà la permissione o privilegio, che massime per la
corona reale ne sarebbe stato accordato ogni qual volta ne facessero conoscere a Sua Maestà il
desiderio.
Sopra di quest’ultima offerta fu scritto da Serenissimi Collegi al detto Magnifico Balbi che
rappresentasse in forma di discorso non già di positiva instanza e mai né anche in scritto la
supposizione nella Repubblica di avere sempre fra le altre cose a seguitare di praticare in dette
procure ed in ogni altra cosa il sigillo con la corona reale e la data in Regali Palatio.
La sopra rifferita cesarea deliberazione in riguardo alla ammissione della procura e formalità
della data e sigillo fu fatta del 1709 9 maggio, e quindi a 3 settembre dello stesso anno il detto
Magnifico Balbi ottenne il diploma de’ regii onori per la Serenissima Repubblica con espressioni di
maggiore ampiezza di altro simile concesso nel 1713 [sic, ma 1613] dall’imperadore Mattia,
essendo in questo secondo dell’imperadore Giuseppe confermato anche il primo con la condizione
stata espressa a voce che di dette regie onoranze se ne risservasse il possesso doppo che fusse
conchiusa la pace tra le potenze di Europa. E a 29 di ottobre dello stesso anno furono
dall’imperadore firmati i transonti originali delle ottenutesi investiture de’ feudi.
La spesa fattasi per ottenere il diploma delle regie onoranze fu di fiorini 90.085, e per
ricevere le investiture dei feudi libera dalla dimanda de’ privileggi e con le altre sopra espresse
formalità si spesero fiorini 1.469:2, compresi in questi fiorini 1.039:30 pagati per la tassa a tenore
di un decreto di riduzione fatto dallo stesso imperadore Giuseppe del 1708, e col quale rimase per
l’avvenire ristretta e moderata la tassa delle investiture che per l’addietro si era andata
straordinariamente accrescendo.
Morto nel 1711 l’imperadore Giuseppe e assonto all’Impero Carlo sexto di lui fratello, la
Repubblica mandò al suo gentilhuomo di Vienna, che era il Magnifico Domenico Maria Spinola, la
copia della procura fatta nella persona di Adamo Ignatio Heunisch per la rinovazione delle solite
investiture uniforme a quella mandata al gentilhuomo Balbi nel 1709.
Parimente fu proveduto il Magnifico Domenico Maria Spinola di altra simile procura nella
persona dello procuratore sudetto per ricevere le investiture del Finale acquistato dalla Repubblica
per mezzo di compra fattane nel 1713.
Nel farsi però la dimanda delle investiture tanto per i feudi antichi come per quello del Finale
volse questo Serenissimo Governo che sempre si declinasse dalla dimanda de’ privileggi, come era
felicemente riuscito a’ tempi de’ due precedenti imperadori Mattia e Giuseppe, secondo il già
rifferito, e per ottenere ciò più facilmente fu data facoltà al gentilhuomo Spinola di spendere ungari
1.500 per il buon essito delle seguenti tre pratiche, cioè l’investitura del Finale, quella de feudi
antichi, sopita intieramente la dimanda de’ privileggi e il datio delle Carcare, altra pratica all’ora
agitata alla corte di Vienna.
Furono per molti anni gagliarde e continue le insistenze di quei ministri acciò si dimandasse
dalla Repubblica la conferma delle investiture assieme con quella de’ privileggi, e quantonque il
gentilhuomo Spinola molto si adoperasse per far conoscere che non poteva la conferma de’
privileggi ostare alla libera concessione delle investiture de’ feudi, che nulla hanno che fare co’
privileggi, ciò non ostante il Consiglio Aulico con suoi voti resi all’imperadore continuava ad
insistere in che non fusse da ammettersi il procuratore della Repubblica al giuramento di fedeltà per
le investiture de’ feudi, se prima non si richiedeva la conferma de’ privileggi, e che però dovesse
essere ammonita la Repubblica a farne far la dimanda, sotto pena di perdere il beneficio de’
23
privileggi medesimi. E per l’opposto il gentilhuomo Spinola, in essecuzione degli ordini de’
Serenissimi Collegi, diede nel 1718 in iscritto la sua protesta, mediante la quale la Repubblica non
doveva più soggiacere a positivi pregiudicij in ragione delle investiture per esserne la dimanda stata
fatta in tempo opportuno, e nella stessa conformità il detto gentilhuomo Spinola si espresse a voce
nel 1722 col vice Cancelliere del Impero.
Rimase sospesa in questa maniera la pratica delle antiche investiture, e solo si pensò a
ricevere la nuova investitura del Finale, che alla fine doppo il longo trattato fattone si ottenne nel
1718 con l’inserzione in essa del vicariato imperiale, come in riguardo di altri feudi haveva
ottenuto il sovrano di Savoia. In riguardo adonque alla ottenuta investitura del Finale fu proceduto
con quest’ordine e nella seguente maniera.
A’ 20 di aprile del 1717 il sopranominato procuratore aulico fece instanza allo imperadore di
essere ammesso al giuramento di fedeltà per il feudo del Finale a nome della Repubblica, secondo
il mandato di procura fatto, come già si è detto, in sua persona nel 1716, e a’ 30 dello stesso mese
di aprile fu pagato il laodemio per le investiture del Finale nella somma di fiorini 600. A’ 12
maggio furono pagati all’ufficio della tassa di Vienna fiorini 200, e a’ 27 maggio dello stesso anno
lo stesso procuratore fu ammesso al giuramento di fedeltà, come dalla copia dell’atto mandato dal
gentilhuomo Spinola con sua lettera delli otto giugno 1718, e per fine si ebbe l’aotentico della
investitura del Finale, che presentemente sta rachiusa nel cassone di ferro.
Venne doppo alcuni anni il caso di richiedere dall’imperadore altra investitura di nuovo
feudo, acquistato che fu quello di Buzalla; ed in questa occasione il prencipe di Bamberga ministro
imperiale espose un progetto al Magnifico Clemente Doria subentrato al ministero di Vienna in
luogo del Magnifico Domenico Maria Spinola, e il progetto fu che la Repubblica mediante lo
sborso di grandiosa somma ottenesse dall’imperadore il consenso sopra l’acquisto di Buzalla e con
la nuova investitura di questo feudo e la rinovazione delle investiture degli altri che già possedeva,
con il possesso ancora delle regie onoranze concesse già come si è detto sopra dalli imperadori
Mattia e Giuseppe. Si tenne per alcun tempo vivo il trattato del rifferito progetto, non tanto per il
maggior decoro che arrecare dovevasi alla Repubblica dall’essercizio delle regie onoranze, quanto
perché il possesso delle medesime doveva importare il disimpegno della domanda de’ privileggi,
secondo che haveva fatto credere la corte di Vienna al detto Magnifico Clemente Doria. Ma i
torbidi sopragionti in Corsica furono motivo che la Repubblica rissolvesse di declinare intieramente
da un così dispendioso progetto, come fu ordinato ai Magnifici Gio. Luca Pallavicino q. Josephi e
Cesare Cattaneo, che l’un doppo l’altro subentrorono al ministero di Vienna doppo del Magnifico
Clemente Doria, entrambi incarricati d’interromperne intieramente il trattato, e solo eccitati a
procurare dall’imperadore l’assenso e l’investitura per il feudo di Buzalla. L’uno e l’altro si ottenne
alla fine, ma con quali spese e formalità convien ricavarlo dalle scritture dell’acquisto medesimo, le
quali non sono ancora state consegnate in archivio.
Tornando a’ privileggi imperiali, resta ad aggiongere per ultimo che, oltre gli a principio
accennati gelosi motivi per i quali la Repubblica da più d’un secolo si è mantenuta in possesso di
non più chiederne la conferma, vi sono ancora le seguenti raggioni per le quali non può
l’imperadore aggravare la solita concessione delle investiture de’ feudi con la condizione del
doversi prendere ancora la conferma de’ privileggi.
Primo perché le investiture sono materia diversa da i privileggi, e che nulla han di commune.
2° perché non può negarsi al vassallo l’investitura, ove non concorrono quelle caose che,
secondo le leggi e consuetudini feudali, danno raggione di negarle.
3° perché il padrone diretto ed il vassallo non devono essere con imparità giudicati, onde
come non sarebbe scusa sufficiente al vassallo per non chiedere la conferma delle investiture
l’essergli stata negata dal padrone diretto quella de’ privileggi, così non deve il patron diretto
negare l’investiture sul pretesto della ommessa dimanda de’ privileggi.
4° perché essendo i privileggi stessi perpetui conferiti ob benemerita e per le caose espresse
ne’ rispettivi diplomi de’ privileggi medesimi, però la loro perpetuità non è sogetta a nuova
conferma, massime anche perché si intende che la concessione sia stata fatta non tanto dalla
persona, quanto dalla dignità imperiale, che sempre rimane.
24
E finalmente perché una tale pretensione sarebbe espressamente del tutto contraria alle
constituzioni imperiali, et in specie al cap. 11 della Carolina, in cui Carlo sexto ultimamente
defonto dichiarò che la concessione delle investiture non doveva restare aggravata in alcuna
maniera.
Notizie più particolari circa la natura de’ privileggi imperiali da aggiongersi alla mia prima
relazione sopra le investiture imperiali e dimanda de’ privileggi 60
Acciò conoscasi meglio la natura de’ privileggi concessi dalli imperadori alla Serenissima
Republica gioverà in primo luogo indicarne alquanto più precisamente l’enonciativa, con fare un
breve elenco di ciò che contengono, e quindi accennando i fatti istorici e i documenti i quali
sembrano opportuni a fissare il senso più giusto e insieme meno pregiudiciale che deve darsi alla
enonciativa o sia contenuto de’ medesimi privileggi.
Elenco del contenuto ne’ privileggi imperiali.
L’imperatore Conrado 2° intitolato re de’ Romani in decembre del 1138 che fu il primo anno
del suo regno in Italia concesse un suo privileggio alla città di Genova nel quale altro non si
contiene se non la facoltà accordata a’ genovesi di fabricar moneta, la quale nel privileggio dicesi
che prima non l’avessero, e che loro veniva concessa in seguito della dimanda da essi fattane e in
considerazione e premio della fedeltà da essi mostrata verso dello stesso Conrado e suoi
predecessori, e del loro valore in terra e in mare impiegato a l’accrescimento e gloria del Impero
Romano.
Federico primo in giugno del 1162 ritrovandosi nella città di Pavia poco dopo aver distrutta
quella di Milano e soggiogate quelle di Piacenza e di Brescia concesse a genovesi un privileggio di
molto diffusa enonciativa nel quale dopo aver molto lodata la loro fedeltà e le grandi e magnanime
opere diede a medesimi in feudo la città di Genova con la facoltà di far essercito per le loro
spedizioni nelle due Riviere da Porto Venere per sino a Monaco, salva però la fedeltà al Impero e
non diminuita nel rimanente la giustizia de’ marchesi e de’ conti. In oltre concesse pure a’ genovesi
la facoltà di ellegersi i proprij consoli per l’amministrazione della giustizia tanto nel civile come
nel criminale secondo i costumi e consuetudini della città, promettendo di non mandarvi alcun suo
giudice o presidente e disobbligandoli dal fare essercito per l’imperatore se non per la guerra allora
accesa nella Sicilia e nelle provincie di Calabria e di Capua. Confermò li acquisti fatti da genovesi
in varie parti del mondo ed in ispecie quello della città di Siracusa, di più accordando loro varie
regalie nelle terre soggette al Impero. Ma sempre il tutto accordasi a titolo di concessione feudale
mediante la clausola sempre aggionta: concedimus vobis in feudum. Dopo l’estensiva del
privileggio, che non si sa fosse concesso alle instanze de genovesi, siegue la formola del
giuramento di fedeltà verso li imperatori e re de’ Romani da farsi da’ consoli pro tempore della
città di Genova; ma non si sa che in effetto ciò siasi mai pratticato.
Enrico 6° imperatore e re de’ Romani concesse due privileggi al Commune di Genova, il
primo in data di Napoli del 1191 che fu il primo anno del suo impero in cui confermò il sopra
riferito privileggio di Federico primo in termini tanto corrispondenti che ne sembra quasi una
copia. L’altro dattato in Pavia del 1194 e porta una nuova conferma del privileggio delle monete
concesso come si è detto da Conrado secondo.
Federico 2° imperatore e re de’ Romani trovandosi in ottobre del 1220 vicino a Bologna
riconcesse con le stesse formole al Commune di Genova quanto già era stato accordato da’
precedenti imperatori, e specialmente il contenuto de’ privileggi di Federico primo del 1162 e di
Enrico 6° del 1191, con la sola gionta di una riserva favorevole alle anteriori raggioni della
Republica, cioè che il privileggio non debba pregiudicare a i gius del Commune di Genova. Quindi
in giugno del 1226 lo stesso imperatore Federico 2° riconfermò le medesime concessioni vallendosi
60
Ibidem, cc. 204-215.
25
sempre delle stesse formole state usate da sé e da suoi predecessori ne’ precedenti diplomi, con la
spiegazione annessa alla facoltà accordata a’ consoli di Genova di render giustizia che niuno
potesse riconvenire in giudizio, né il Commune di Genova né alcuno de’ genovesi se non dinanzi i
loro proprij giudici e mai dinanzi l’imperatore, salvo che quando i consoli ricusassero di
amministrar giustizia anche dopo del ordine avutone dal imperatore.
Enrico settimo imperatore in marzo del 1313 trovandosi nella città di Pisa concesse un suo
privileggio in cui ramemorando con quanta costanza di fede e perseveranza di continuata affezione
il Commune di Genova si fosse diportato verso l’Impero Romano non solo ne’ tranquilli, ma
ancora ne’ tempi più torbidi, confermò tutte le compre e acquisti fatti per qualonque altro titolo dal
detto Commune, quand’anche si trattasse di territorij e luoghi acquistati senza il consenso del
prencipe a cui si potesse supporre appartenere il supremo dominio, purché in avvenire il Commune
di Genova resti obligato di chiederne e riceverne speciale investitura dal prencipe, che si sarà inteso
dovere essere l’imperatore, e fargli gli omaggi di fedeltà, e quanto altro erano tenuti coloro da’
quali il detto Commune aveva fatti suddetti acquisti. Egli è però da avertirsi che la Republica si è
sempre mantenuta nel possesso di non prendere alcuna particolare investitura se non di pochi feudi
da essa posteriormente acquistati, e de’ quali pur tuttavia seguita a prenderla, segno assai manifesto
che tutte le città e luoghi del antico Dominio di Genova nel incorporarsi al suo principato avevano
perduta la natura e qualità di feudo imperiale per il motivo da accennarsi in appresso.
Carlo quarto imperatore e re di Boemia in settembre del 1358 su le instanze di Pietro Leoni
procuratore e sindico del Commune di Genova le confermò e nuovamente concesse generalmente
tutti i privileggi, libertà, onori, consuetudini dominij e proprietà statele concesse da’ precedenti
imperatori o sia re d’Italia. Nella estensiva del presente privileggio restano osservabili le
espressioni con le quali viene indicata la dignità e preminenza di Genova, dicendosi per
confessione dello stesso imperatore fondata più nobilmente delle altre città d’Italia e sopra di tutte
multiplicemente di varij onori e libertà freggiata.
Sigismondo imperatore in genaro del 1414 su la instanza di Giorgio Adorno Duca di Genova
concesse la semplice generale conferma de’ precedenti privileggi imperiali.
Massimiliano primo con suo diploma dato in Vigevano in settembre del 1496, chiamando al
solito la città e Commune di Genova fedele a sé e al Sacro Romano Impero in considerazione di
essersi ella sopra le altre città mantenuta divota ed ossequiosa al medesimo Impero, le confermò i
privileggi statile accordati da precedenti imperatori, e il possesso de’ luoghi che ella aveva di più
acquistati nel fiume Magra e sue vicinanze, con insieme il privileggio di potere crear dottori in
medicina e nelle altre facoltà liberali come facevasi in altre città d’Italia.
Lo stesso imperatore con altro suo privileggio rogato pure in settembre del 1496, premessa la
buona volontà del suo animo in volere rendere illustri con singolari privileggi e preminenze quelli
che si erano distinti sopra delli altri nella divozione sincera di fedeltà ed ossequiosa volontà verso i
re de’ Romani e li imperatori suoi predecessori, e dopo una molto onorevole confessione del avere i
genovesi con le valorose imprese loro assicurato il Mare Ligustico dalle continue depredazioni de’
Barbari in tempo che nessuno ardiva prendere le armi in diffesa del popol cristiano, conferma a’
genovesi su le loro instanze il gius privativo di trafficar sali per il Mediterraneo dal Monte
Argentaro sino a Marsilia, e di punire essi stessi con la confisca de bastimenti chionque ardisse
dentro a’ riferiti termini di trasportarlo. Nel estensione del presente privileggio si confessa che il
gius privativo del trafficar sali il Commune di Genova ne era già in possesso da 300 anni avanti; si
aggionge però che dicevasi averlo ottenuto in privileggio dalli imperatori, ma questo detto mancava
di fondamento non solo perché fra’ privileggi imperiali concessi alla Republica anteriormente a
quelli di Massimiliano primo non ritrovasi quello del sale, ma perché ancora quando si fosse
smarito se ne dovrebbe ritrovare la memoria e la conferma nella serie delli riferiti privileggi ne’
quali tutte le altre concessioni de’ precedenti imperatori si vedono ripigliare benché siano meno
essenziali e non considerabili in paragone di questo del sale, regalia di sua natura riserbata et
annessa alla persona del principe, o de’ Stati che ne hanno l’autorità e i diritti.
Carlo Quinto con suo primo privileggio rogato in Barcelona in giugno del 1529, premessa
una molto onorata memoria delle grandi e valorose opere fatte da’ genovesi, concede loro di moto
proprio tutti i privileggi, libertà, prerogative e possessi territoriali, dazij, tributi e ogni altra
26
giurisdizione stata loro accordata da’ precedenti imperatori e re de’ Rom,ani, salvi però sempre i
gius dell’imperatore con chiamarsi Genova camera e città imperiale; ma però viene anche chiamata
Republica, titolo che ne’ precedenti privileggi non erasi ancora adoprato.
Lo stesso imperatore Carlo V con altro suo privileggio del primo novembre 1533, dichiarato
l’animo suo che era non solo di mantenere ma anche di accrescere i gius, i privileggi e le libertà de
i fedeli al Impero, e considerando come la Republica e città imperiale di Genova era stata un ottimo
presidio ed un fedel propugnacolo contro i nemici della fede cristiana, ed erasi con suo grave
incommodo e danno mostrata sempre fedele al imperatore e al Sacro Romano Impero, e di più
riflettendosi come questa città e Republica già da molti anni anzi oltre la memoria delli uomini era
stata in una quasi possessione di sua libertà nuovamente ricuperata pochi anni avanti, cioè dal 1528
quando si liberò dalla suggezione del re di Francia, perciò il detto imperatore Carlo V ritrovandosi
in Genova aprovò e confermò di moto proprio il suo presente stato e libertà.
Lo stesso imperatore Carlo V nove giorni dopo, cioè alli 10 novembre dello stesso anno
1536 [sic], nella stessa occasione del ritrovarsi egli in Genova, concesse alla Republica un terzo
privileggio nel quale, asserendo di rivolgere nella memoria i grati ossequij di fedeltà e li ufficij di
sincera divozione usati dalla Republica e città imperiale di Genova verso i precedenti imperatori e
re de’ Romani, e quanto ella avesse servito allo stesso imperatore Carlo V nella ricuperazione e
diffesa dello Stato di Milano e nella spedizione affricana, in considerazione di tutto ciò di moto
proprio con il sano e maturo consiglio de’ suoi baroni approva e conferma generalmente tutti i
privileggi e concessioni ottenute per l’innanzi dalla Republica, ed in ispecie li acquisti da essa fatti
de’ luoghi di Nove, Gavi, Parodi e Ovada, de’ due Rossiglioni, di Voltaggio e di Fiacone spettanti e
appartenenti alla stessa Republica, dichiarandosi che non sarebbero tolti e smembrati dal suo
Dominio quantonque il Ducato di Milano passasse in qualonque altro possessore.
Ferdinando primo a cui Carlo V di lui fratello aveva ceduto l’Impero, su le instanze fatteli
per parte della Republica, a 12 aprile del 1559 confermò ne’ consueti termini i tre riferiti privileggi
di Carlo Quinto, e a 9 maggio dello stesso anno confermò parimente ambidue i privileggi di
Massimiliano primo, i quali si vedono inseriti entrambi nella presente loro confermazione di
Ferdinando primo su le instanze del ambasciar [sic] della Republica con un solo diploma confermò
similmente in aprile del 1565 i tre privileggi di Carlo V ed uno di Massimiliano primo, cioè quello
del sale, tutti quattro inseriti nel presente diploma.
Rodolfo 2° imperatore con unico suo diploma fatto in aprile del 1577 confermò i privileggi
di Massimiliano primo del 1513, quello di Carlo V del 1529 e i due dello stesso imperatore Carlo V
del 1536, con quello di Massimiliano 2° del 1565, e ciò come dicesi nel presente diploma attesa la
richiesta fattane dalli Illustri Magnifici e Fedeli al Sacro Romano Impero il Doge e Magistrato della
Camera e città imperiale di Genova.
Mattias fratello e successore al Impero di Rodolfo 2° ad instanza del ambasciatore della
Republica in genaro del 1613, usando le stesse formole adoprate dal detto Rodolfo confermò i
medesimi privileggi di Massimiliano primo, Carlo V e Massimiliano 2° in quattro separati rescritti,
attese le insistenze in ciò de’ ministri imperiali, quando per altro erasi dalla Republica ordinato al
suo ambasciatore di prenderne la conferma in un solo rescritto, e vedesi in ciascheduno di questi
quattro inseriti i rispettivi corrispondenti anteriori diplomi.
Lo stesso imperatore Mattias il dì 4 marzo 1613 fece un decreto favorevole alla Republica
nel quale, ramemorati i singolari di lei meriti sì antichi che nuovi verso tutta la cristianità, Sacro
Romano Impero e Casa d’Austria, e ramemorata anche la celebrità del nome della stessa Republica
distintasi fra le altre repubbliche e principati d’Italia per le tante sue grandi opere e di terra e di
mare e per la sua potenza accresciuta con il dominio della isola di Corsica, in considerazione di
tutto ciò e delli varij generi di privileggi con li quali era stata onorata da’ precedenti imperatori,
attesa la fede di essa Republica e li aiuti prestati in varij tempi e di pace e di guerra, e in fine
considerata la propensione del divoto animo mostrato dalla Republica nel mandare un suo legato a
rallegrarsi con lo stesso imperatore Mattias per la sua assunzione al Impero, egli di moto proprio
concede luogo e sede alli oratori della Republica nella Capella Imperiale come alli altri ordinarij
oratori e con le medesime prerogative. Evvi anche l’attestato autentico del possesso a cui era stato
27
ammesso nel 1620 il Magnifico Constantino Pinello, oratore ossia ambasciatore della Republica,
del posto assegnato nella Capella Imperiale in essecuzione del riferito decreto.
Ferdinando 2° imperatore successore di Mattias, anche egli sopra le instanze del
ambasciatore o sia inviato della Republica confermò in agosto del 1620 in un solo rescritto con le
stesse formole i medesimi privileggi quatenus opus sit pure inseriti nel diploma della loro presente
conferma; e perché in questa occasione seguì l’irregolarità che nel memoriale presentato dal
ambasciatore della Republica per ottenere la presente confermazione de’ privileggi imperiali si
trovò inserita la clausola a nome del detto ambasciatore del offerens se prestare iuramentum
fidelitatis, clausola non mai per l’addietro usata almeno da più secoli avanti; però i Serenissimi
Colleggi andando al riparo del pregiudizio che ne potesse nascere fecero ciò saputo una inmediata
protesta e dichiarazione firmata da i tre secretarij contro di detta offerta come invalida e fatta dal
detto ambasciatore senza alcun precedente mandato della Republica, e anzi contro della sua
intenzione. Ma il corriere spedito espressamente a tal fine non ritrovò più in Vienna l’ambasciatore
della Republica già postosi in viaggio per il suo ritorno a Genova. Ad ogni modo non si sa che il
promesso giuramento siasi effettivamente prestato, né di esso fassi alcuna menzione nel rescritto
della ottenuta conferma de’ privileggi.
Ferdinando 3° figlio e successor nel Impero del detto Ferdinando 2° non concesse più la
conferma de’ privileggi imperiali perché, come è stato nella prima relazione esposto, dal tempo di
questo imperatore si è sempre sino al presente declinato da più prendere una tale conferma come
non necessaria e pregiudiciale al decoro della Republica. Bensì il detto imperatore Federico [sic,
ma ovviamente Ferdinando] 3° con suo decreto de 2 settembre 1641 preceduto da un preambolo
corrispondente al già esposto dal decreto del imperatore Mattias per il posto del ambasciatore della
Republica nella Capella Imperiale, dichiarò che nel avvenire sarebbe da esso Ferdinando 3° e da
suoi successori dato alla Republica, suo Duce e Governatori in iscritto ed in voce il seguente titolo:
Serenissimo Duci Principi nostro carissimo ac Illustribus Gubernatoribus Reipublicae Genuensis
nostris dilectis. Con questo decreto dovrebbero essere rimaste abollite le antiche poco decorose
formole di Camera imperiale ed altre indicate nel presente elenco de’ privileggi imperiali con le
quali li imperatori erano soliti di spiegarsi verso della Republica.
Finalmente l’imperatore Giuseppe figlio del detto Ferdinando terzo con suo decreto de 3
settembre del 1709 accordò egli pure al legato della Republica la facoltà di aver luogo nella sua
Imperiale Capella in questi termini: In Capella sua Cesarea una cum oratoribus ordinarijs locum
et sessionem obtineat atque occupet eideque [?] qualis inde dependet, honor habeatur. Un tale
privileggio del avere li legati o sia ambasciatori di Genova luogo nella Capella Imperiale porta seco
il possesso di quelli che diconsi onori regij; al proposito de quali, oltre i già riferiti decreti delli
imperatori Mattias e Giuseppe, non è da tralasciarsi una sentenza data da Carlo V a 12 agosto 1526
su la precedenza delli oratori di Genova in riguardo a quelli di Firenze e di Ferrara. Per metter fine
alla controversia insorta sopra di ciò l’imperatore dichiara che in avvenire nella Curia Imperiale si
osservi e mantengasi l’ordine praticato nella Curia Romana, cioè che li oratori di Genova senza
contradizione e impedimento alcuno precedano a quelli di Ferrara e di Firenze a tenore di un
attestato inserito in questa stessa sentenza e fatto dal maestro delle cerimonie del papa, in cui dicesi
che anticamente e da tempo immemorabile li oratori della Republica avevano sempre preceduto a i
suddetti di Firenze e di Ferrara, e che quantonque al tempo del papa Giulio 2° fosse stata
contrastata una tal precedenza per motivo del trovarsi allora questa città soggetta al re di Francia,
pure essendosi ricconosciuto come i genovesi nel sottomettersi al detto re si erano riserbata la
facoltà essi come se fossero in istato di intiera libertà i proprij oratori alla corte Romana; però non
ostante l’addotta eccezione li oratori genovesi avevano seguitato a precedere a quelli de’ fiorentini
e de’ ferraresi con l’assegnazione del posto conveniente a una tal precedenza, la quale era stata poi
confermata da Leon decimo e pratticata sotto li altri susseguenti pontefici.
Inteso il contenuto de’ riferiti privileggi, conviene fissare anche quale per riguardo ad essi
fosse la situazione della Republica prima di averli ottenuti, altrimente si corre il rischio di formarne
concetto non convenevole alla loro natura e di valutarli assai più di quello che importano. In fatti al
udire che la Republica fu dalli imperatori privilegiata di sue maggiori prerogative si potrebbe
facilmente entrare in sospetto che ella ne fosse debitrice alla liberalità de’ medesimi imperatori.
28
Sarebbe questo un ben raro essempio di più che regia munificenza. Ma il fatto sta che la nostra
Republica anteriormente a tutte le concessioni imperiali era in diritto e in possesso di sua libertà e
dominio, come anche di tutte le altre reali prerogative delle quali si fa menzione ne’ privileggi
imperiali.
E primieramente quanto al possesso e diritto della libertà non è necessario per la presente
intenzione impegnarsi nella ardua impresa di dimostrare i genovesi essere sempre stati popolo
libero anche nel tempo quando quasi tutto il rimanente del noto mondo era soggetto al antico e ora
distrutto Imperio Romano. E nemeno è necessario di entrare nel altro pur difficile assonto di
provare come i goti e li altri popoli del settentrione, da’ quali fu distrutta Roma e la sua monarchia,
non giongessero a impadronirsi di Genova né che il suo territorio rimanesse inserito in alcuna delle
provincie del Regno d’Italia fondato da’ longobardi e ristabilito da Carlo Magno.
L’epoca della libertà di Genova sarà sempre più certa e di più facile dimostrazione se invece
di riferirla alle invasioni de’ goti e de’ longobardi si riferisca a quella de’ saraceni non meno delle
precedenti luttuosa e funesta, avendo quei barbari occupata e per più secoli ritenuta quasi tutta la
Spagna e le parti meridionali di Francia e d’Italia con le isole adiacenti, con esservi altresì de’
fondati riscontri che nel principio del decimo secolo Genova sia stata saccheggiata da’ medesimi
saraceni.
Or in questa così funesta e pericolosa occasione, non ritrovandosi chi contro le agressioni de’
barbari ardisse di essere il primo a muoversi in diffesa della causa commune, i soli genovesi, come
confessò pur anche lo stesso Massimiliano primo nel di lui secondo riferito diploma del anno 1496,
unicamente sostenuti dal proprio valore risorgendo i primi dal totale abbandonamento e
dessolazione in cui si giacevano e cominciando con le loro galee a battere e a mettere in fuga le
squadre marittime de’ communi nemici, quindi passando a discacciarli dalle isole di Corsica e di
Sardegna ove si erano già da due secoli stabiliti e finalmente conquistando varie isole e porti più
considerabili del oriente, in breve spazio di tempo si apersero un fiorito comercio nell’Asia e in
Europa e divennero una delle potenze più rispettabili.
Sicché quand’anche Genova da prima fosse stata soggetta al antico Impero Romano e quindi
ancora incorporata nel Regno d’Italia, ad ogni modo ella sarrebbesi posta in istato di intiera
indipendenza per un titolo forse il più nobile e il più legitimo che possa esservi per riaquistare la
libertà, quale aponto si è quello che non trovandosi il prencipe dominante più in caso di provedere e
di diffendere le soggette provincie da inminente e fatale invasione di barbara e feroce nazione come
al certo fu quella de’ saraceni, accada che una di cotali provincie fatta nel commune avilimento
ardita e prodiga del proprio sangue liberi se stessa e i popoli circonvicini dalla inminente schiavitù,
e quindi senza interompimento di fraposto intervallo seguiti a mantenersi, in guerra e in pace,
l’arbitra di se medesima e anche delli altrui principati e regni. Acciò la libertà e grandezza della
Republica potesse credersi effetto de’ privileggi imperiali, converebbe che prima di ottenerli non ne
fosse ella stata al possesso, e fosse venuta aquistandoli solamente a proporzione che i privileggi si
andavano multiplicando ed estendendo a concessioni sempre più decorose. Ma la cosa è andata al
contrario, mentre la presente signoria e grandezza della Republica, per quanto in se stessa siasi
pregevole e rispettabile, non è però se non parte di quella molto maggiore che acquistò un tempo a
forza di magnanimità e di valore indipendentemente dalle concessioni imperiali ed anche prima di
averle ottenute.
L’epoca a cui si riferisce la libertà della Republica riaquistata indipendentemente da’
privileggi imperiali serve del pari a giustificare il suo possesso e superiorità nelle due Riviere
indipendentemente da’ medesimi privileggi; impercioché quantonque possa sembrare che ne’
luoghi delle Riviere ora posseduti dalla Republica stati una volta soggetti al Impero come
argumentasi dal essere stati tali luoghi anticamente denominati marchesati e contee, nomi che si
davano alle terre del Impero situate a’ suoi confini, non potesse la Republica aquistarvi
giurisdizione senza il consenso delli imperatori, né bastasse quello della respettiva communità, pure
dal riferito fatto dell’invasione de’ saraceni a cui fece un così possente riparo il valore de’ genovesi
vedesi manifesto come i popoli delle Riviere per trovare scampo al imminente pericolo, essendo
vano aspettarlo dalle troppo lontane e troppo indebolite forze del Impero del occidente, dovettero
necessariamente riccorrere invece alla protezione della Republica e soggettarsi ad essa, in modo
29
che ella aquistasse il dominio diretto e la suprema autorità, e venisse per conseguenza a perderla
l’imperatore anche senza il di lui consenso. Così aponto successe mentre particolarmente fra
l’undecimo e il duodecimo secolo, anteriormente a’ riferiti privileggi imperiali, si stipularono fra il
Commune di Genova e le communità delle due Riviere le disugualissime convenzioni per le quali
rimase fondata nella Republica quella suprema giurisdizione che tuttavia mantiene ed essercita in
ambedue le Riviere.
Fra le varie autorità e diritti che nelle accennate convenzioni si attribuiscono alla Republica
vi è sempre quello dell’esercito e della cavalcata da farsi a suo ordine e piacimento, sicché anche
questo contrasegno di autorità competeva alla Republica sopra i luoghi delle due Riviere
anteriormente a i privileggi imperiali.
Lo stesso è avvenuto per il gius privativo del traficar sale nel mare Ligustico, poiché la prima
volta che se ne faccesse memoria ne’ privileggi imperiali di Massimiliano primo del 1496 e là dove
molto prima di tal privileggio, cioè dalli anni 1159, 1166, 1224, 1235, 1288 i trattati e convenzioni
passate fra la Republica di Genova con quelle di Firenze, di Pisa e di Lucca e con la communità di
Oneglia portano che un tale diritto debba appartenere ai genovesi. Onde è che poi nelli antichi
autentici decreti fatti in materia del sale si vede che sin dal 1441 era in Genova stabilito l’Ufficio o
sia Magistrato del Sale, incaricato fra le altre cose ad impedire efficacemente e con tutta l’austerità
delle pene che niuno ardisse traficare o scarricar sale dal Monte Argentaro sino alla città di
Marseglia senza espressa licenza del Commune di Genova. Siché anche questa regalia del sale non
può essere stata effetto delle concessioni imperiali, ma bensì, attesa la coincidenza de’ tempi e la
natura di un tale diritto, egli va rapportato come a sua vera origine al dominio sopra del mare
Ligustico essercitato dalle vittoriose squadre de’ genovesi ne’ primi secoli della loro accresciuta
potenza.
Il privileggio di coniar monete fu, come si è veduto, la prima volta concesso dal imperadore
Conrado 2° nel 1138, e pure è certo che Genova prima di detto anno aveva la sua propria moneta e
che ne fu coniata della nuova nel 1102 e 1114 come riferisce il Varagine nella Vita di S. Siro
vescovo e quindi il ciprio Giustiniani e il Foglietta nelle loro respettive opere. Ciò che Genova ebbe
in privileggio da Conrado 2° non è il gius di fabricarsi la sua moneta, che già di questo come si è
detto era in possesso e le conveniva come alle altre città libere dell’Italia, ma bensì le accordò
quella facoltà che niun prencipe deve arrogarsi ne’ proprij Stati, cioè il coniar le monete con la
inscrizione e l’effigie di un altro prencipe, il che per riguardo al nome e all’effigie di Conrado 2° si
fece in Genova solamente dopo che se ne ebbe ottenuta la facoltà dallo stesso Cesare; e ciò perché
in quei tempi non si poteva usare moneta spendibile universalmente per tutti Stati se non la moneta
imperiale, come afferma Vincenzo Borghesi cittato dal Federici ne’ suoi collettanei sotto di questa
parola Moneta.
Il privileggio di crear notari e di addottorare in legge e in medicina veramente non so siasi
usato in Genova anteriormente alle concessioni imperiali ne’ quali si accordava una tal facoltà.
Dovette questa essere una di quelle prerogative che per gran tempo non si ebbe riparo di lasciare
aderenti alla dignità imperiale, giaché il valersi soltanto di notari, di medici e di dottori creati nelle
curie e università del Impero non è cosa che per se stessa pregiudichi alla libertà e indipendenza de’
principati, come non lo è il seguitare a valersi nella amministrazione della giustizia e nel ordine de’
giudizij del gius romano al quale una volta tutto il mondo fu obligato di uniformarsi; e dall’altra
parte la legazione delle publiche e private scritture fatta da notari autorizati dalli imperatori si
rendeva per ciò più ammissibile per tutti i Stati della cristianità, come si è detto per riguardo alle
monete coniate con l’impronto imperiale.
Ma quanto al gius di elegersi i proprij consoli e li altri giudici per il proprio governo,
siccome questo è un diritto inseparabile dal essere di stato libero, così Genova ne godette assai
prima che li imperadori passassero ad accordarglielo, il che seguì la prima volta nel 1162 mediante
il privileggio di Federico primo, quando già da più di sessanta anni avanti si sa che la nostra
Republica era in possesso di elegersi i proprij consoli, i nomi de’ quali cominciando dal 1100 si
vedono registrati nelli annali di Caffaro primo scrittore delle cose di Genova.
Or se per cotal modo la Republica di Genova, nel riaquistare fra l’undecimo e il duodecimo
secolo una autorità e potenza superiore di molto a quella che tuttavia conserva, si vide al possesso
30
delle prerogative che molto tempo dopo le vennero dalli imperadori a poco a poco accordate, non
vi dovrebbe esser più luogo di prendere pregiudiciali equivochi su la natura de’ privileggi
imperiali, rendendosi manifesto che non furono in sostanza quali rassembrano in apparenza gratuite
concessioni di nuovi diritti, ma bensì mere ricognizioni de i già aquistati.
Pure a togliere anche ogni ombra di difficoltà che potesse aportare l’incongruenza del nome
di privileggi datosi alle semplici ricognizioni de i già fondati e legitimi diritti della Republica, e dal
vederle espresse e accompagnate con formole indicanti soggezione e dipendenza per la Republica,
e per l’imperatori superiorità e dominio, a togliere dico ogni sospetto che potesse nascere dal uso di
tali espressioni e formole state da me fedelmente trascritte nel precedente elenco de’ privileggi
imperiali, sarà ben fatto accenare le circonstanze de’ tempi che diedero occasione a’ medesimi
privileggi.
Vedendo l’imperatori dell’occidente riuscir vani tutti i loro tentativi fatti per mantenere in
Europa il dominio e la signoria delle provincie una volta sottoposte al loro Impero, dalla di cui
soggezione si andavano vie più staccando con ridursi in principati e republiche libere e
indipendenti, per dare a divedere come mantenevano almeno con l’animo il perduto dominio sopra
di tali separate provincie, seguitorono per gran tempo a usare ne’ loro cesarei rescritti le antiche
formole indicanti la primiera autorità. Il nome istesso d’imperatore che tuttavia conservano al certo
suona molto più di quello che in effetto presentemente importi e vaglia. Dall’altra parte le
republiche e li altri indipendenti principati di Europa, doppo di essersi sottratti dall’effettiva
suggezione del imperatore, a principio non fecero il dovuto riparo al uso delle autorevoli formole
delle cancellerie imperiali; anzi più tosto chi più e chi meno tutti lo secondavano per una specie di
connivenza e di rispettoso riguardo tutto proprio di quei rozzi secoli e che ora sarebbe di
ammirazione e di scandalo, dopo che tutti i Stati liberi e indipendenti si sono alla fine intieramente
emancipati anche da questa soggezione apparente e di mere parole.
Non è però meraviglia se i genovesi risorti quasi dal nulla, fatti d’improvviso liberi e
prepotenti senza quasi sapere di esserlo divenuti e soliti avere un religioso rispetto alla dignità
imperiale abbiano tardato a riflettere sopra l’incongruenza delle espressioni e de’ formularij nel
reciproco trattamento tra di essi e li imperatori. L’aver però li stessi imperatori prima modificato e
quindi intieramente abbollito l’uso di tali formole, ciò dà chiaramente a conoscere come anche essi
le hanno considerate per una specie di cerimoniali, e come tali soggette a continue riforme. Dal che
si può anche dedurre quanto siano deboli le raggioni addotte dalli autori che vanno scrivendo in
favore dei pretesi diritti del Impero su la città di Genova, mentre si fondano quasi intieramente
sopra l’uso di tali espressioni; le quali, se non fossero state vane e prive del corrispondente effetto, i
genovesi avrebbero solamente cominciato a vivere in libero principato dopo che l’imperadori
avessero lasciato di chiamare Genova Camera imperiale, e feudo il suo territorio. E pure, come si è
detto parlando del essenziale de’ privileggi, Genova era libera e indipendente non meno prima che
poi, con questo di più che prima era assai più rispettata e potente.
E ben tale ella mostrossi anche a fronte de i più temuti imperatori che tentorono di ripassare
da i ritenuti titoli al riaquisto della perduta autorità. Così quando Federico primo, intraprendendo di
riaquistare l’Italia dopo avere saccheggiata e distrutta la città di Milano e impadronitosi di Pavia e
di molte altre città della Lombardia, voleva obbligare ancora i genovesi ad essergli tributarij, essi
spedirono loro ambasciatori al imperatore accampatosi con il suo vittorioso esercito nelle vicinanze
di Alessandria a fargli intendere la ingiustizia della di lui pretenzione e a dirgli con tutta franchezza
come essi non possedevano né terre né altro che si appartenesse al Impero, tutto che sin d’allora
estendessero il loro dominio nelle due Riviere dal Corvo per sino a Monaco. Il che uditosi dal
imperatore assieme con la nuova dello strepitoso apparecchio di genti e di armi fatto da’ genovesi
in diffesa della propria libertà e dominio, ebbe per bene di non più inquietarli e di lasciarli in
possesso di quanto per qualonque titolo avevano di già aquistato. Imperator (sono le parole con le
quali il Caffaro riferisce il fatto) gratiam et suam bonam voluntatem ianuensibus dedit, eosque in
sua tutela et deffensione recepit, addens quod nullam super eos lamentationem audiet (al contrario
di quanto aveva stabilito per le altre città) nec eos modo aliquo inquietaret de aliquo quod tenerent
vel possiderent. Ecco come il riferito privileggio di Federico primo per cui consentì a’ genovesi le
cose medesime non fu altro che una mera e forzata ricognizione di quei gius de i quali erano già in
31
possesso e pronti a diffenderli con le armi alla mano quando l’imperatore avesse insistito nelle sue
pretensioni.
Lo stesso accadde per riguardo al imperatore Federico 2° con cui i genovesi vennero più
d’una volta a dichiarata guerra, e punirono come nemici e rebelli i savonesi ed altri popoli della
Riviera per avere aderito al partito del imperatore a fine di sottrarsi dalla dovuta e già contratta
suggezione verso il Commune di Genova. Sicché i privileggi accordati da questo imperatore furono
anche essi forzate ricognizioni.
E generalmente parlando, se si badi alle circonstanze de’ tempi ne’ quali si ottennero i
privileggi imperiali si vedrà che furono impetrati o nell’occasione dell’essersi i genovesi rimessi in
libertà con sottrarsi dalla suggezione de’ prencipi stranieri a’ quali per sedare l’impeto delle insorte
civili discordie erano stati obligati di sottomettersi, o per dileguare le speranze de’ confinanti
intenzionati di frastornare i possessi della Republica, onde giovava venissero raffermati con il
consenso e la ricognizione fattane da soggetti di tanta autorità quali erano l’imperatori.
Così il privileggio di Massimiliano primo, nel quale con la rinovazione delle precedenti
concessioni imperiali si contiene la espressa conferma della giurisdizione spettante alla Republica
nelle vicinanze del fiume Magra, fu ottenuto nelle occasioni del essersi Genova liberata dalla
soggezione de i re di Francia, e del avere contemporaneamente la Republica di Firenze promosse
delle prettensioni sopra la città di Sarzana e luoghi adiacenti. E l’altro privileggio dello stesso
Massimiliano concernente il diritto del sale si vede ottenuto per impedire che a forza di
contravenzioni non passasse il disuso.
Similmente al privileggio di Carlo quinto del 1529 diede luogo la libertà nuovamente
riaquistata da’ genovesi con il discacciamento del Governatore e guarniggione francesi dalle
fortezze della città e delle Riviere mediante l’aiuto di Andrea Doria, ammiraglio in quel tempo di
detto imperatore allora nemico del re di Francia. L’altro privileggio dello stesso Carlo quinto del
1536 in cui si conferma il possesso della Republica ne’ luoghi situati di là da Gioghi fu fatto in
tempo che il Ducato di Milano, per la morte del suo ultimo duca essendo ricaduto sotto il dominio
del imperatore, e di un imperatore così potente qual fu Carlo quinto, vi era luogo a temere che egli
facesse valere qualche sua pretensione sopra i luoghi aquistati dalla Republica di là da Gioghi che
anticamente potevano avere avuta qualche aderenza con il Ducato di Milano.
Ma giaché dopo di Carlo quinto la Republica ha sempre goduto il vantaggio di una libertà
non più interotta né amaregiata da alcuna delle passate vicende, sarebbe altresì desiderabile che sin
dal tempo di Ferdinando primo fratello di Carlo quinto il Serenissimo Governo avesse pensato a
interompere la consuetudine non più giovevole per conto alcuno di prendere da’ susseguenti
imperatori la conferma de’ privileggi imperiali, come in fatti dopo di Ferdinando 2° si è declinato
dal più richiederla per quei gelosi e ben giusti riguardi a’ quali diedero luogo le soverchie sospette
insistenze della corte di Vienna acciò si seguitasse a prendere una tale conferma. Così invece di più
di un secolo ne sarebbero già compiti più di due da che si è in possesso di questa ommissione in cui
consiste un privileggio negativo più preggievole di tutti li altri di mantenere la propria libertà senza
bisogno di alcun privileggio, prerogativa che incontestabilmente compete alla nostra Republica.