Generalizations of Swierczkowski's lemma and the arity gap of finite functions
Tra lemma e voce: ruolo della preredazione nel Tesoro della Lingua Italiana delle Origini
Transcript of Tra lemma e voce: ruolo della preredazione nel Tesoro della Lingua Italiana delle Origini
OPERA DEL VOCABOLARIO ITALIANO
ISTITUTODEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
PRESSO L’ACCADEMIA DELLA CRUSCA
Bol le t t ino
DIZIONARI E RICERCA FILOLOGICA
GIORNATA DI STUDI IN MEMORIA DI VALENTINA POLLIDORI FIRENZE, VILLA REALE DI CASTELLO
26 OTTOBRE 2010
SUPPLEMENTO III 2012
Atti della Giornata di Studi
in memoria di Valentina Pollidori
Firenze, Villa Reale di Castello26 ottobre 2010
© 2012
Copyright by Edizioni dell’Orso s.r.l.
15121 Alessandria, via Rattazzi 47
Tel. 0131.252349 - Fax 0131.257567
E-mail: [email protected]
http: //www.ediorso.it
È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, com-presa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L’illecito sarà penalmente perseguibile anorma dell’art. 171 della Legge n. 633 del 22.04.1941
ISBN 978-88-6274-370-9
Dizionari e ricerca filologica. Atti della Giornata di studi in memoria di Valentina Pollidori, Firenze, 26 ottobre 2010 (Supplemento III al Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano), Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012.
Rossella Mosti (Opera del Vocabolario Italiano)
Tra lemma e voce: ruolo della preredazione nel Tesoro della Lingua Italiana delle Origini
Il processo di redazione del TLIO si è andato evolvendo negli anni, dalle pri-me voci sperimentali del 1996 in poi, ed è oggi abbastanza complesso, come è stato descritto da Paolo Squillacioti1. L’evoluzione ha progressivamente riguardato tutte le fasi, dal modo di utilizzare la banca dati come fonte fino al sistema di revisione delle voci redatte, prima della pubblicazione in rete. Dall’ottobre del 2005 si è inserita in questo processo, e me ne è stata data la responsabilità, una funzione alla quale diamo il nome di preredazione, inter-media fra la gestione e lemmatizzazione della banca dati e la redazione delle voci, e svolta, come le altre funzioni che riguardano il TLIO, rispondendo di-rettamente al direttore dell’Istituto. In sintesi, la preredazione consiste da un lato nell’esaminare la lemmatizzazione, redigendo note con eventuali propo-ste di modifiche che potranno entrare nella successiva revisione quadrime-strale del corpus; dall’altro nel preparare liste di voci da redigere, corredate di precise indicazioni redazionali e note di sussidio, necessarie soprattutto per i redattori ‘esterni’2; questo compito si estende, al di là del processo di redazione effettivamente in corso (che dipende dalle forze impegnate), al- 1 Cfr. Paolo Squillacioti, Uno sguardo al Tesoro della Lingua Italiana delle Origi-ni:procedure e prospettive del vocabolario storico dell’italiano antico, in questi stessi Atti. 2 Con tale espressione si intendono specificamente coloro che usufruiscono di un incarico di collaborazione occasionale con l’Opera del Vocabolario Italiano, prevalentemente del-la durata di sei mesi, per la redazione di circa 120 voci del TLIO (ogni anno l’OVI confe-risce da un minimo di tre ad un massimo di sette collaborazioni a seconda delle disponi-bilità finanziarie). Si avvalgono dell’ausilio della preredazione anche gli aspiranti redat-tori dell’OVI, la cui attività è subordinata ad una prova di redazione, gli studenti delle università di Notre Dame (USA) e di Zurigo, con cui il nostro istituto collabora da oltre una decina d’anni, e i dottorandi delle Università per Stranieri di Siena e della Basilicata che compiono all’OVI un periodo di stage di formazione alla lessicografia, redigendo tra l’altro uno svariato numero di voci del TLIO. Per una sintesi dettagliata dei vari contratti di collaborazione con l’OVI nel corso del 2010 cfr. la relazione di Paolo Squillacioti in questi stessi Atti.
86 Rossella Mosti
l’aggiornamento e all’incremento del database della redazione (consultabile online all’indirizzo http://reddyweb.ovi.cnr.it/)3, con l’obiettivo di costituire un lemmario completo del TLIO, che ancora manca, perché è un compito complesso che finora è stato posposto a quello della redazione nell’ordine delle priorità, dettato, come sempre, dalle forze a disposizione.
Come esempio di preredazione scelgo ghella s.f., vocabolo del linguaggio tessile che designa una qualità di seta proveniente da Ghilan, località a sud-ovest del mar Caspio, per cui il Corpus TLIO fornisce attualmente tre lemmi:
gella a.g. (?), cui corrisponde un es. negli Ordinamenti aggiunti nel 1322 al Breve dell’ordine del mare di Pisa4 che, non essendo stato identificato, è riportato nell’unica forma attestata, con la categoria grammaticale a.g. (che sta per ‘ambiguità grammaticale’) e con la formula dubitativa espressa dal punto interrogativo nel disambiguatore;
ghele s.f., attestato unicamente nella versione toscana del Milione di Mar-co Polo5;
3 Vi si accede dal link Tutto sul TLIO della pagina principale, cliccando il link database della redazione. 4 Breve dell’ordine del mare di Pisa e Ordinamenti aggiunti, in Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, a cura di Francesco Bonaini, vol. III, Firenze, Vieusseux, 1857, pp. 455-612. 5 Marco Polo, Milione. Versione toscana del Trecento, a cura di Valeria Bertolucci Piz-zorusso, Milano, Adelphi, 1975.
Tra lemma e voce: ruolo della preredazione nel TLIO 87
ghella agg., cui è associato un es. della Pratica della mercatura del Pego-lotti6, nella locuzione seta ghella (ma a cui vanno ricondotte altre due occor-renze dello stesso testo lemmatizzate erroneamente ghele s.f.).
La preredazione accerta prima l’entrata lessicale7, che, nel caso specifico, non essendo registrata dai lessici, viene decisa dalla forma più comunemente attestata, ghella, per la quale si afferma la derivazione da Ghilan proposta da Evans, e a cui si associa la categoria grammaticale s.f.8; il lemma ghele s.f. diventa conseguentemente una voce di rimando a ghella, mentre gella a.g. verrà ricondotto al lemma corretto ghella s.f.
Entrata lessicale
Preredazione Note per reddy9 Note per la lemmatizzazione
ghella s.f.
OK Attuale lemma GHELLA agg. Considerare anche il lemma GELLA a.g. (?). Considerare anche il lemma GHELE s.f. Inserire nel file la seguente voce di rinvio: GHELE s.f. > GHELLA s.f.
Eliminare il lemma GELLA a.g. Correggere la cat. gr. di ghella. Inserire la seguente voce di rinvio: GHELE s.f. > GHELLA s.f.
Disambiguatori inutili a ghele (= cfr. Indice pag. 631) e a ghella (= cfr. seta) Correggere il lemma gella a.g. (?) in ghella s.f. Correggere il lemma ghella agg. in ghella s.f. Correggere le 2 occ. di ghella lemmatizzate ghele s.f.
Scheda di preredazione della voce ghella.
6 Francesco Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura, ed. Allan Evans, The Mediaeval Academy of America, Cambridge [Mass.] 1936. 7 Confermata dalla sigla convenzionale OK. 8 Nonostante che ghella sia propriamente un aggettivo, si preferisce tuttavia considerare la forma in funzione appositiva a seta, e definire pertanto la voce con la sola categoria grammaticale s.f. 9 ‘Reddy’ è il nome convenzionale del database della redazione.
88 Rossella Mosti
È in fase di preredazione che si decide come accentare graficamente l’en-
trata lessicale (in base alle Norme di redazione10 che impongono l’accento per le parole ossitone, per i lemmi sdruccioli, per quelli uscenti in parola to-nica più atona e per i lemmi che differiscono nel timbro della vocale tonica). Eventuali dubbi relativi all’accento vengono segnalati qui con una nota spe-cifica nel punto 0.5 dell’intestazione della voce del tipo ‘Accento non det.’, come nel caso della voce farfala s.f., attestata unicamente dal volgarizza-mento sabino della Mascalcia di Rusio11, nella forma plurale farfale, che, trattandosi probabilmente di una corruzione del termine forfora, potrebbe forse pronunciarsi fàrfala, oppure del tipo ‘Accento incerto’ come si legge nella voce gazzola s.f. ‘gazza’, attestazione unica nella Composizione del mondo di Restoro d’Arezzo12, che potrebbe dirsi anche gàzzola.
Obiettivo fondamentale della preredazione, come già accennato, è la co-stituzione del lemmario integrale del corpus, operazione fino ad oggi impen-sabile senza presupporre un lungo lavoro di analisi della banca dati finalizza-to alla redazione. È in preredazione che si stabilisce, per es., se più lemmi di-versi per funzione grammaticale, come tali distinti opportunamente in lem-matizzazione, vanno riuniti sotto un’unica entrata lessicale: è classico il caso degli aggettivi sostantivati che sono caratterizzati dalla doppia marca agg./ s.m. e che talvolta si presentano come avverbi13 (come si vede per es. nella voce fervente agg./s.m./avv., al punto 2.1.2, dove l’aggettivo è documentato nel toscano del Reggimento e costumi di donna di Francesco da Barberino14 e nel volgarizzamento fiorentino della Leggenda Aurea15 col valore avver-
10 Leggibili online in una versione dell’aprile 2006 a partire dal link Tutto sul TLIO della pagina principale. 11 Luisa Aurigemma, La "Mascalcia" di Lorenzo Rusio nel volgarizzamento del codice Angelicano V.3.14, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1998. 12 Restoro d’Arezzo, La composizione del mondo colle sue cascioni, a cura di Alberto Morino, Firenze, Accademia della Crusca, 1976. 13 Più raro invece è il caso dei nomi con doppio genere grammaticale, maschile e femmi-nile, che si lessicalizzano come avverbi: cfr. per es. il sostantivo fiore, che si trova atte-stato, specie nel linguaggio lirico, come femminile, per probabile influsso del galloro-manzo, e che già nel Duecento viene usato in funzione avverbiale col significato di ‘poco’, ‘niente’ per lo più in frasi negative. 14 Del reggimento e costumi di donna di messer Francesco Barberino secondo la lezione dell’antico testo a penna barberiniano, a cura di Carlo Baudi di Vesme, Commissione per i testi di lingua, Bologna, Romagnoli, 1875. 15 Beato Iacopo da Varagine, Leggenda Aurea, Volgarizzamento toscano del Trecento a cura di Arrigo Levasti, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1924-1926, voll. 3.
Tra lemma e voce: ruolo della preredazione nel TLIO 89
biale di ‘con fervore religioso’), ma si può avere anche il caso particolare di sostantivi che si classificano anche come aggettivi o soltanto come aggettivi nell’entrata, perché tali sono nell’unica attestazione considerata, come per es. nel caso della voce esasperatrice agg., documentata dal TLIO unicamente dall’esempio fuori corpus del volgarizzamento dei Moralia di S. Gregorio di Zanobi da Strada16 col significato di ‘che provoca sdegno e collera’. In pre-redazione si segnala il fatto con la nota specifica da registrare nel paragrafo 0.5 «S.f. att. solo come agg.».
Il TLIO mantiene generalmente voci separate per i femminili distinti mor-fologicamente dal maschile (ad es. fermana s.f. ‘donna della città marchigia-na di Fermo’ è voce distinta da fermano s.m. ‘abitante di Fermo’), ma diver-samente da altri dizionari storici (Battaglia in primis 17) raccoglie sotto una sola entrata i due generi quando sono varianti di una parola con unico refe-rente: per es. la voce finestrato s.m. che si intende ‘l’ordine di ampie apertu-re praticate sulle pareti di edifici di culto’ ingloba nel punto 0.1 dell’intesta-zione della voce anche l’occorrenza del femminile finestrata, presente nello stesso testo, i Documenti fiorentini degli anni 1353-5818, in una ‘ricordanza’ del 1353, mentre quella che attesta finestrato è del 1357. Nonostante la cro-nologia, si è deciso di mettere a lemma la forma del maschile, perché è quel-la che risulta lessicalizzata, mentre quella femminile diventa solo voce di rinvio. In finestrato s.m. si dà conto del fatto mediante la formula espressa nel punto 0.5 «Anche s.f.», seguìto tra parentesi dalla forma linguisticamente più prossima al lemma, in questo caso dall’unica attestata.
Capita che in preredazione ci si imbatta in voci di attestazione unica o di bassissima frequenza tali da richiedere un intervento di tipo filologico, che talvolta (in presenza di un codice unico, a disposizione dell’Istituto) si spin-ge fino alla collazione con il ms.: in questi casi è certo più economico redi-gere personalmente la voce che non affidarla ad un altro redattore corredan-dola di svariate note esplicative. Cito l’esempio della voce gaianiti s.m.pl. ‘seguaci della setta eretica di Gaiano’, attestati unicamente nella forma gaianici dell’Ottimo Commento alla Commedia dantesca, nell’edizione otto-
16 I Morali di San Gregorio Magno papa volgarizzati nel secolo XIV da Zanobi da Strata [...], alla sua vera lezione ridotti [...] da Bartolomeo Sorio, 3 voll., Verona, Moroni, 1852. 17 Salvatore Battaglia [poi Giorgio Barberi Squarotti], Grande dizionario della lingua italiana, Torino, UTET, 1961-2002. 18 Si tratta delle Ricordanze del Provveditore Filippo Marsili, in Cesare Guasti, Santa Maria del Fiore. La costruzione della chiesa e del campanile secondo i documenti tratti dall’Archivio dell’Opera secolare e da quello di Stato, Firenze, Ricci, 1887.
90 Rossella Mosti
centesca di Alessandro Torri19. Si tratta in realtà di una voce che la sotto-scritta avrebbe comunque trattato e redatto nel corso di una revisione filolo-gica dell’edizione Torri, limitatamente al proemio del canto X dell’Inferno, che contiene un lunghissimo elenco di sette eretiche che ha come fonte le Etymologiae di Isidoro di Siviglia20. La forma gaianici è quasi certamente un errore per gaianiti per un banale scambio di t con c. Si è scelto pertanto di assumere in entrata la forma gaianiti non solo perché la fonte citata riporta Gaianitae, ma anche perché ciò risponde alla precisa scelta di non promuo-vere a lemma un errore di un copista. È inclusa nella voce anche la forma gianiti perché ritenuta un probabile errore per Gaianiti, con caduta di -ni-. Qualora il ricorso al ms. accerti un evidente errore di lettura si provvede ad avvertire il responsabile della banca dati che procederà a correggere diretta-mente il file di testo, mentre si avrà cura di annotare nel paragrafo 0.6 N la lettura dell’edizione (come nel caso della voce priscillianisti s.m.pl. ‘seguaci della setta eretica di Prisciliano’, attestati dalla stessa edizione dell’Ottimo nella forma presicilianisti, frutto di un banalissimo errore di lettura del ms. per priscilianisti, con cattiva interpretazione di p con i sovrascritta (si noti che l’errore si ripete anche per Prisciliano, letto invece Presiciliano).
È decisamente un compito troppo ambizioso per la preredazione stimare un calcolo preciso delle reali dimensioni dell’impresa: talvolta essa stessa suggerisce l’accorpamento di due o più lemmi di diversa base etimologica che presentano evidenti problemi di forme variamente incrociate (come per es. nel caso della voce elefante s.m., che raccoglie sotto un’unica entrata le forme elefante e leofante e quelle intermedie, con eventuale tipologizzazione degli incroci), ma è spesso a voce ultimata, e nel caso di lemmi di particolare complessità semantica, che si decide, in fase di revisione o anche di messa a norma, un eventuale accorpamento (come è avvenuto per la voce cervogia s.f., che raccoglie sotto di sé i lemmi cervese e cervisia). Capita poi che in fase di revisione si colga un aspetto linguistico determinante, non rilevato dalla lemmatizzazione e sfuggito alla preredazione, tale da giustificare una voce a sé, com’è successo per es. nel caso di famiglia s.f., da cui è stato scor-porato il preciso significato di ‘serva, domestica’, attestato rispettivamente nel cremonese delle Rime di Ugo di Perso dei primi decenni del Duecento, negli Statuti senesi del 1305 e nell’aquilano della Leggenda di S. Caterina
19 L’Ottimo Commento della Commedia, t. I Inferno, a cura di Alessandro Torri, Pisa, Capurro, 1827. 20 Isidori Hispalensis Episcopi, Etymologiarum sive Originum libri XX, ed. Wallace Martin Lindsay, Oxford, 1911.
Tra lemma e voce: ruolo della preredazione nel TLIO 91
da Siena di Buccio di Ranallo del 133021, perché riconosciuto giustamente come femminile del corrispettivo maschile famiglio s.m., ‘servo, domestico’, che, stante l’opposizione di genere non può essere accolto all’interno della voce famiglio e merita perciò un’entrata distinta: appunto famiglia (2).
Resta il fatto che un’analisi preventiva condotta sul corpus ed estesa ai lessici, riesce quanto meno a dare un panorama più che verosimile delle ef-fettive dimensioni del TLIO. È per questo motivo che la preredazione volge uno sguardo anche ai lessici di riferimento, nell’eventualità di integrare voci mancanti nel corpus testuale22. Si tratta delle cosiddette citazioni fuori cor-pus, annotate sempre con l’indicazione esplicita della fonte lessicografica che le attesta, o, se si tratta di citazioni di prima mano, con l’abbreviazione titolo opportunamente codificata, contenente la provenienza linguistica e la data assegnata al testo23. In preredazione si registrano anche le voci pro-venienti da edizioni che non sono ancora comprese nel corpus, ma che vi en-treranno. Mi riferisco al Corpus aggiuntivo24, interrogabile solo attraverso una ricerca per forme, fucina di molte voci di attestazione minima, non pre-senti nel corpus maggiore: si vedano per es. lo zoonimo gallione s.m.25, atte-stato nei Documenti fiorentini degli anni 1359-6326, nell’edizione aggiornata di Roberta Zazzeri del 2003:
21 Ugo di Perso, Rime, in Poeti del Duecento, a cura di Gianfranco Contini, Milano-Na-poli, Ricciardi, 1960, t. I, pp. 589-95; Statuti volgari de lo Spedale di Santa Maria Ver-gine di Siena scritti l’anno MCCCV, a cura di Luciano Banchi, Siena, Gati, 1864; Adolfo Mussafia, Mittheilungen aus romanischen Handschriften. II. Zur Katharinenlegende, «Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien», CX, 1885. 22 Sarà invece compito del redattore rinvenire possibili significati negli ess. tratti dai les-sici, altrimenti non documentati nel corpus. 23 Lo scioglimento delle abbreviazioni bibliografiche si trova nella Bibliografia dei citati (cui si accede dal link Tutto sul TLIO della pagina principale). 24 Su cui informano anche le relazioni di Elena Artale e Pâr Larson in questi stessi Atti. Indirizzo diretto http://aggweb.ovi.cnr.it. (ma si accede anche da www.vocabolario.org cliccando il link INTERROGA LE BANCHE DATI e quindi l’icona relativa alla banca dati “Aggiuntivo”. 25 Ora (settembre 2011) visibile nella versione di rete s.v. gallione s.m. 26 Si tratta del Libro di spese del monastero di Santa Trinita di Firenze, in Ci desinò l’abate. Ospiti e cucina nel monastero di Santa Trinita (Firenze, 1360-1363), a cura di Roberta Zazzeri, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2003.
92 Rossella Mosti
gallione s.m. OK
0.4 Non att. nel corpus. Corpus aggiuntivo. [1] a Doc. fior., 1359-63, pag. 123.14: per una pollastra per l’abate di Spugna che era infermo s. iiij.o d. iiij.o; per un gallione per mettere nela sopradetta gelatina s. viij d. vj...
Scheda di preredazione della voce gallione. il sostantivo galileano ‘uomo di Galilea’, documentato nelle forme galileani e galeliani del Volgarizzamento veneziano dei Vangeli, secondo il codice it. I 3 della Marciana edito da Francesca Gambino nel 200727: galileano s.m. OK
‘uomo di Galilea’ 0.4 Non att. nel corpus. Corpus aggiuntivo: forme galileani e galeliani di a Vang. venez., XIV pm. [1] a Vang. venez., XIV pm., Luc., cap. 13, pag. 256.15: et medemamentre li galeliani erano plu contra Pilato de ço oltra la soa volontade che tuti li oltri. [2] a Vang. venez., XIV pm., Luc., cap. 13, pag. 256.20: Et perçò disse qua sen Lucha che Pilato mesclà lo sangue de galileani con li soi sacreficii).
Scheda di preredazione della voce galileano. e l’aggettivo gètico ‘proprio dei Geti’, citato unicamente dal volgarizzamento pratese della Farsaglia di Lucano, nella recentissima edizione di Laura Allegri del 200828:
27 I Vangeli in antico veneziano. Ms. Marciano it. I 3 (4889), a cura di Francesca Gambino, Roma-Padova, Editrice Antenore, 2007. 28 Volgarizzamento pratese della Farsaglia di Lucano, a cura di Laura Allegri, Firenze, Accademia della Crusca - Gruppo Bibliofili Pratesi “Aldo Petri”, 2008.
Tra lemma e voce: ruolo della preredazione nel TLIO 93
gètico agg. OK
0.4 Non att. nel corpus. Corpus aggiuntivo: forma getiche di a Lucano volg., 1330/1340 (prat.). [1] a Lucano volg., 1330/1340 (prat.), L. VIII [Phars., VIII, 202-262], pag. 146.17: «Se ' patti di prima stanno a noi fermi, iurati a me per Iove Italiano, fermati per li vostri maghi, empiete i turcassi, e gli archi d'Ermenia tendete con le corde getiche...
Scheda di preredazione della voce gètico. Il corpus aggiuntivo è anche fonte preziosa di retrodatazioni rispetto al
corpus maggiore: per es. il volgarizzamento fiorentino dell’Antidotarium Ni-colai della fine del XIII secolo29 fornisce la prima attestazione del lemma galluzza, nella forma galuçça, col valore specifico di ‘galla quercina’,30 altri-menti documentato dal TLIO solo negli Statuti della colletta del comune di Orvieto del 131231 e da due esempi provenienti da edizioni non comprese nel corpus32, il Libro delle segrete cose delle donne, dei primi decenni del Tre-cento, nell’edizione ottocentesca del Manuzzi33, e le Prediche di Giordano da Pisa, degli anni 1304-05, nell’edizione settecentesca del Manni34:
29 Lucia Fontanella, Un volgarizzamento tardo duecentesco fiorentino dell’Antidotarium Nicolai, Montréal, McGill University, Osler Library 7628, Alessandria, Edizioni del-l’Orso, 2000. 30 Tale testo ha permesso di aggiornare nel TLIO la prima attestazione di parecchi fitoni-mi (quali per es. abròstino s.m., abròtano s.m., anacardo s.m., avornio s.m., càppero s.m., èbulo s.m., édera s.f., éllera s.f., èmblico s.m., genziana s.f.), di varie voci mediche (come artética s.f., asmàtico s.m., cardìaco agg./s.m., epàtico agg./s.m., epilèntico agg./s.m.) e della farmacopea (tra cui benedetta (2) s.f., elaterio s.m., gerapigra s.f.), nonché di qualche voce appartenente al lessico della chimica (come aghetta s.f., àlcali agg.). Senza l’Antidotarium Nicolai volgarizzato non ci sarebbero nel TLIO voci come per es. anacardino agg. ‘a base di anacardi’, antera (2) s.f. ‘seme della rosa’, antìdoto s.m. ‘preparato medicinale specifico usato contro una malattia, un veleno, un disturbo’, catàrtico s.m., ‘preparato medicamentoso con effetto purgante’, dendrolìbano s.m. ‘lo stesso che rosmarino’, o non si avrebbero accezioni come per es. quella botanica di ‘mil-lefoglie’ presente nella voce ambrosia s.f. o come quella di ‘cicoria’ relativamente alla voce elitropia (1) s.f. 31 Giuseppe Pardi, Gli Statuti della colletta del comune di Orvieto. Parte II. Codice N. 1, «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria», IV, 1898. 32 Ciò essenzialmente per una questione di inaffidabilità filologica. 33 Giuseppe Manuzzi, Il Libro delle segrete cose delle donne, Firenze, Tip. del Vocabo-
94 Rossella Mosti
galluzza s.f. OK
0.4 Att. unica nel corpus. Considerare nel corpus aggiuntivo la forma galuçça di a Antidotarium Nicolai volg., XIII ex. (fior.), glossata ‘galla quercina’, che è anche la prima attestazione: [1] a Antidotarium Nicolai volg., XIII ex. (fior.), 15, pag. 10.33: [III.] Quando tu voli sapere s’egl’è cotto, poni una gocciola in sul marmo e diclina il marmo e se si tiene a modo di mele, si è cotto. Dassi gargariçando colla decotione dela galuçça. Citare inoltre due ess. fuori corpus: [] ^083 F Libro delle segrete cose delle donne, XIV pi.di. (fior.): R. scorze di melograno, balaustie, cioè le meluzze che caggiono del detto melo, galluzza, galle d’arcipresso... || Manuzzi, Segrete cose, p. 6. [] ^072 F Giordano da Pisa, Prediche, 1304-1305 (pis.>fior.): Il corpo nostro sta ora in macero, in galluzza e in concia. || Manni, p. 313.
Scheda di preredazione della voce galluzza. Spetta alla preredazione il compito di registrare tali voci utili al completa-
mento alfabetico e informare della presenza qui di testi di particolare rilievo per la distribuzione geolinguistica da raccogliere nel punto 0.4 dell’intesta-zione della voce (come per es. il volgarizzamento laziale dei Disticha Cato-nis ad opera di Catenaccio di Anagni35, a cavallo dei secoli XIII e XIV, che fornisce un’ulteriore attestazione della voce garzonezza s.f. ‘fanciullezza’36, oltre a quella unica fornita dal corpus nel volgarizzamento degli Ammaestra-menti degli antichi latini e toscani ad opera di Fra Bartolomeo da San Con-
lario della Crusca, 1863. 34 Domenico Maria Manni, Prediche del Beato frate Giordano da Rivalto dell’ordine dei predicatori al canonico marchese Gabriello Riccardi, nella stamperia di Pietro Gaetano Viviani, Firenze 1739. 35 Paola Paradisi, I Disticha Catonis di Catenaccio da Anagni. Testo in volgare laziale (secc. XIII ex.-XIV in.), Utrecht, LOT, 2005. 36 Adesso (settembre 2011), leggibile online s.v. garzonezza s.f.
Tra lemma e voce: ruolo della preredazione nel TLIO 95
cordio degli anni 1302-0837): garzonezza s.f. OK
0.4 Att. unica nel corpus. Considerare il seguente es. del corpus aggiuntivo: [] a Catenacci, Disticha Catonis, XIII/XIV (anagn.), IV, 18.6, pag. 404: Om(n)e homo, poy che i(n) vetraneza scende, / de garzoneza la manera prende.
Scheda di preredazione della voce garzonezza. o come Le Aggiunte agli Statuti dei merciai, edite da Nello Bertoletti nel
2005 nei Testi veronesi dell’età scaligera38, che fanno acquisire alla voce garbellatura s.f.39 l’unica attestazione settentrionale, nella forma garbelaura. garbellatura s.f. OK
Considerare anche il seguente es. del corpus aggiuntivo: forma garbelaura di a Stat. ver., 1366 glossata «prodotto della setac-ciatura», che fornisce l’unica attestazione settentrionale del lem-ma. [] a Stat. ver., 1366, pag. 327.1: Primo che alguna p(er)sona terera o folestera, de que (con)dition voia sì sia, no onso né debia da qui ena(n)ci (con)duro o far (con)duro en la cità o êl destreto de Verona pevrelo né garbelaura de pevro né de zençevro menua né de alguna altra (con)dition... Inserire nel file la seguente voce di rinvio: GHERBEL-LATURA s.f > GARBELLATURA s.f.
Scheda di preredazione della voce garbellatura.
37 Ammaestramenti degli antichi latini e toscani raccolti e volgarizzati per Fra Bartolommeo da San Concordio, a cura di Vincenzo Nannucci, Firenze, Ricordi, 1840. 38 In Nello Bertoletti, Testi veronesi dell’età scaligera. Edizione, commento linguistico e glossario, Padova, Esedra, 2005, pp. 326-328. 39 Ora (settembre 2011) leggibile nella versione pubblicata in rete s.v. garbellatura.
96 Rossella Mosti
Appartengono alla categoria dei fuori corpus anche i cosiddetti ‘falsi del Redi’ che vengono registrati in quanto tali dal TLIO con una nota specifica nello 0.6 N. Se la scelta di redigere tali voci che in realtà pertengono al Sei-cento (allorché l’accademico della Crusca Francesco Redi le inserì a partire dalla terza impressione del Vocabolario «per appoggiare con l’autorità del-l’attestazione trecentesca, necessaria nel contesto del Vocabolario degli Ac-cademici, l’inserimento di lessico più moderno» 40) può anche essere opina-bile, ciò serve per lo più a richiamare l’attenzione, segnalandole, su attesta-zioni accettate senza riserva dai lessici come trecentesche: cito per es. solo il caso della voce botanica fiorrancio s.m., denominazione volgare della calen-dula, attestata a partire dalla terza impressione della Crusca da una tipica fonte fantasma, denominata Libro della cura delle malattie e datata concor-demente dalla lessicografia storica (le Crusche41, Tommaseo-Bellini42 e Bat-taglia) ed etimologica (intendo il DEI di Battisti-Alessio43 e L’Etimologico di Nocentini44, mentre è assente nella seconda edizione del Cortelazzo-Zol-li45) al XIV secolo. Ciò che induce a dichiarare spurio tale esempio non è so-lo il fatto che il fitonimo non risulti mai attestato nell’edizione ottocentesca di riferimento curata da Giuseppe Manuzzi46, ma è soprattutto la presenza nel contesto di mestruo, vocabolo che se è vero che circola già alla fine del Duecento47 è del tutto assente nei libelli medici primo-trecenteschi editi dal
40 Maurizio Vitale, L’oro nella lingua. Contributi per una storia del tradizionalismo e del purismo italiano, Milano-Napoli, Ricciardi, 1986, pp. 329-30. 41 Vocabolario degli Accademici della Crusca, prima ed., Venezia, Giovanni Alberti, 1612; seconda ed., Venezia, I. Sarzina, 1623; terza ed., Firenze, Accademia della Crusca, 1691; quarta ed., Firenze, Domenico Maria Manni, 1729-38; quinta ed. (A-O), Firenze, Tipogr. Galileiana, 1863-1923. 42 Niccolò Tommaseo-Bernardo Bellini, Dizionario della lingua italiana, Torino, UTET, 1861-1879. 43 Carlo Battisti - Giovanni Alessio, Dizionario Etimologico Italiano, Firenze, Barbèra, 1950-57. 44 Alberto Nocentini, L’etimologico. Vocabolario della lingua italiana con CD-Rom e online, Firenze, Le Monnier, 2010. 45 Manlio Cortelazzo - Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, seconda ed. a cura di M. Cortelazzo e M. A. Cortelazzo, Bologna, Zanichelli, 1999 (d’ora in poi DELI 2). 46 Libro degli adornamenti delle donne, Libro della cura delle febbri, Libro della cura delle malattie, Libro delle segrete cose delle donne [pubblicati separatamente dalla Tip. del Vocabolario della Crusca nel 1863 e riuniti insieme ad altri libelli in una stampa anastatica], in Testi di lingua citati nel Vocabolario della Crusca, raccolti e pubblicati dall’abate Giuseppe Manuzzi, Bologna, Forni, 1979. 47 Attestato dal TLIO a partire da un testo compreso attualmente nel Corpus aggiuntivo,
Tra lemma e voce: ruolo della preredazione nel TLIO 97
Manuzzi, che registrano unicamente ragione e il plurale fiori per intendere il flusso mestruale48. In presenza di un presunto apocrifo rediano la preredazio-ne avrà cura di segnalare la fonte fantasma unitamente al lessico che l’attesta per primo, ricavato dalla banca dati online dell’Accademia della Crusca La lessicografia della Crusca in rete49, e imposterà di conseguenza la specifica nota da citare sotto lo 0.6 N, col rimando alle pagine relative del noto studio di Guglielmo Volpi pubblicato negli anni 1915-1750.
Tale scelta operativa è una peculiarità del TLIO che come tale merita senz’altro che nel prossimo futuro le venga riservato un apposito link nella
il già citato volgarizzamento fiorentino dell’Antidotarium Nicolai, nelle forme menstrue (1 occ.), mestrua (3 occ.), mestrue (6 occ.). 48 Cfr. Manuzzi, Libro delle segrete cose delle donne, dove si registrano 1 occ. di fiori («assegnò la natura una purgazione spezialmente nelle femmine per lo tempo loro, la quale purgazione è appellata dalle genti fiori», p. 2) e 7 occ. di ragione («Quando la femmina non puote avere sua ragione», p. 4; «Se la femmina non hae la sua ragione, e sia disvenuta del corpo suo, dee fare questo rimedio», p. 4; «Galieno ne pone uno esemplo d’una femmina, che era stata per spazio di dieci mesi, che non avea avuto sua ragione», p. 4; «E tutte cose somiglianti a queste, e queste erbe, ciascuna per sè, o tutte mescolate in vino, fanno molto a quella ragione», p. 5; «Medicamento d’Avicenna a questa medesima ragione», p. 5; «Abbonda tale fiata alla femmina la sua ragione sanza modo», p. 6; «sente la femmina grande dolore nello stomaco, e hacci difetto di sua ragione», p. 7), cui se ne aggiunge un’altra nella rubrica, non compresa nell’edizione Manuzzi: «iij Capitolo quando la femina no(n) puote avere sua ragione» (ms. Redi 1721, c. 38r.9). 49 Indirizzo diretto http://www.lessicografia.it/index.jsp (ma vi si accede anche dalla home page dell’OVI, cliccando il link Accademia della Crusca, e procedendo attraverso il link Biblioteca virtuale, quindi Le cinque edizioni del vocabolario (1612-1923). 50 Guglielmo Volpi, Le falsificazioni di Francesco Redi nel Vocabolario della Crusca, «Atti della R. Accademia della Crusca per la lingua d’Italia», a.a. 1915-1916, 1917, pp. 33-136. Per un approfondimento sul tema cfr. Bielfeld, Methoden der Belegsammlung für das Vocabolario della Crusca, Tübingen, Niemeyer, 1996. Informano inoltre gli in-terventi di Pär Larson, Il Tesoro della Lingua Italiana delle Origini: gli inserti estranei al corpus, in La lessicografia storica e i grandi dizionari delle lingue europee, «Bolletti-no dell’Opera del Vocabolario Italiano», Supplemento I, 2001, pp. 71-72; Rossella Mo-sti, I falsi del Redi visti dal cantiere del «Tesoro della Lingua Italiana delle Origini», «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» XIII, 2008, p. 381-397; Pietro G. Bel-trami, La nuova lessicografia dell’italiano antico: Il Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, «Bollettino dell’Atlante Lessicale degli Antichi Volgari Italiani», I, 2008, Pisa-Roma, pp. 33-52; Sandra Covino, Giacomo e Monaldo Leopardi falsari trecenteschi, Fi-renze, Olschki, 2009, I, p. 41; Pietro G. Beltrami, Lessicografia e filologia in un diziona-rio storico dell’italiano antico, in Storia della lingua italiana e filologia. Atti del VII Convegno ASLI 2008, Firenze-Pisa, 18-20 dicembre 2008, Firenze 2010, pp. 236-37.
98 Rossella Mosti
pagina Tutto sul TLIO, che si denominerà Falsi del Redi51. La ricerca auto-matica degli apocrifi raccolti dal TLIO contribuirà non solo a fare maggiore chiarezza sulla reale portata dell’opera mistificatoria dello studioso nella les-sicografia trecentesca, ma favorirà certo un’analisi più capillare e puntuale dei cosiddetti «stilemi rediani», primo fra tutti il mancato rispetto della legge Tobler-Mussafia determinato dalla presenza ad inizio assoluto di frase del pronome personale atono in posizione proclitica52.
Se per il TLIO ciò costituisce una prospettiva immediata, occorreranno tempi più lunghi e maggiori risorse di quelle attuali per sviluppare parti del-l’intestazione della voce che sono state sospese momentaneamente per non moltiplicare i tempi dell’impresa: mi riferisco in primis alle costruzioni sin-tattiche raccolte nel paragrafo 0.5, che meritano certamente di essere consi-derate in un vocabolario come il TLIO che, stante l’impostazione schietta-mente semantica nella suddivisione delle definizioni, deve accogliere in un punto preciso anche le informazioni di tipo grammaticale. Parimenti si po-tranno curare alcuni punti del paragrafo 0.6, come la scheda onomasiologica dei sinonimi e degli antonimi e quella sui rapporti di derivazione, attualmen-te rinviate ad una fase successiva del lavoro. Inoltre si potrebbe elaborare un’opportuna informazione bibliografica, come è sempre più nell’uso della lessicografia etimologica, segnalando sistematicamente gli studi sulla parola in entrata che oggi si citano solo saltuariamente nel paragrafo 0.6 N, prece-duti dalla sigla Cfr.: come per es. nella voce buffone s.m./agg., per cui è inte-ressante citare la recensione di Lucia Bertolini al libro di Giancarlo Schizze-rotto, Gonnella il mito del buffone, uscita nella rivista «Belfagor» nel 200153, o come nella voce pinocchio s.m., per la quale si cita l’ultima lezione di Gianfranco Folena, Antroponimia letteraria, tenuta a Padova il 23 maggio del 1990, dedicata tra l’altro al nome del celebre personaggio, pubblicata sei anni più tardi nella «Rivista Italiana di Onomastica»54.
Rimane per ora un’utopia lo spoglio sistematico dei lessici che dichiarano 51 La ricerca automatica degli apocrifi raccolti dal TLIO ammetterà due diverse modalità di interrogazione: la prima, intitolata Solo Falsi del Redi, consentirà di trovare le voci attestate unicamente da una o più fonti fantasma; la seconda, denominata Anche Falsi del Redi, consentirà di trovare le voci in cui è presente almeno un esempio spurio insieme con altre attestazioni. 52 Per una prima, breve analisi dei tratti tipici di Redi ‘falsificatore’, cfr. Rossella Mosti, I falsi del Redi cit., pp. 387-90. 53 Lucia Bertolini, Rec. a Giancarlo Schizzerotto, Gonnella il mito del buffone, Pisa, ETS, 2000, «Belfagor», LVI, 2001, pp. 743-48. 54 Gianfranco Folena, Antroponimia letteraria, «Rivista Italiana di Onomastica», II, 1996, pp. 356-68.
Tra lemma e voce: ruolo della preredazione nel TLIO 99
una prima attestazione esplicita, allo scopo di segnalare i casi in cui il TLIO offre una retrodatazione55. Sappiamo bene che il Corpus TLIO, per il fatto che si fonda su materiali di prima mano editi in tutti i dialetti italiani, è fonte inesauribile di retrodatazioni, e auspichiamo fin da oggi che il TLIO e la ban-ca dati dell’italiano antico dell’OVI diventino ben presto il punto di riferi-mento per tutti i dizionari, cui potranno attingere liberamente come sta fa-cendo lo Zingarelli56, a partire dall’edizione 2007, e come ha fatto per alcune sezioni alfabetiche L’etimologico, il neonato vocabolario di Alberto Nocenti-ni, cui il ricorso al TLIO ha permesso per es. di retrodatare ulteriormente al 1128 la prima attestazione di abate nella Frase volgare in una charta libelli edita da Renzo Fantappiè nelle Carte della propositura di S. Stefano di Pra-to57 (rispetto alla data del 1252 fornita da DELI 2 e a quella del 1278 dichia-rata dal GRADIT di De Mauro58).
55 Su questo aspetto informa Rossella Mosti, Italiano antico e moderno, relazione alla Giornata di studi Lo stato della lingua. Il CNR e l’italiano nel terzo millennio, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 8 marzo 2010, in corso di stampa negli Atti. 56 Lo Zingarelli 2010. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli (con CD-ROM), Bologna, Zanichelli, 2009. 57 Le carte della propositura di S. Stefano di Prato, I, 1006-1200, a cura di Renzo Fantappiè, Firenze, Leo S. Olschki editore, 1997, pp. 246-47. 58 Grande Dizionario Italiano dell’Uso, ideato e diretto da Tullio De Mauro, Torino, UTET, 2000, 6 voll., con l’aggiunta del vol. VII, Nuove parole italiane dell’uso, 2003 (con CD-ROM).
INDICE
Pietro G. Beltrami, Presentazione p. 3 Edgar Radtke, La valutazione degli indicatori discorsivi
nella lessicografia dell’italiano antico 7 Pär Larson – Elena Artale, Il punto sui corpora dell’Ope-
ra del Vocabolario Italiano 25 Domenico Iorio-Fili, Il lemmatizzatore semiautomatico di
GATTO4 41 Andrea Boccellari, Il sistema di redazione e pubblicazio-
ne web del TLIO 57 Alessandro Pancheri, I testi editi sugli «Studi di Filologia
Italiana nel TLIO 65 Paolo Squillacioti, Uno sguardo al Tesoro della Lingua
Italiana delle Origini: procedure e prospettive del vocabolario storico dell’italiano antico 73
Rossella Mosti, Tra lemma e voce: ruolo della prereda-
zione nel Tesoro della Lingua Italiana delle Ori-gini 85
Lino Leonardi, Testo e tradizione manoscritta: un pro-
getto per il corpus TLIO 101 Roberta Cella, I gruppi di clitici nel fiorentino del Tre-
cento 113 José A. Pascual, Filología y lexicografía. La marcación
diatópica en los corpus históricos 199
Nella stessa Collana:
1. La lessicografia storica e i grandi dizionari delle lingue europee, Atti della Giornatadi studi (Firenze, Villa Reale di Castello, 10 luglio 2000), 2001, pp. 128, €12,91. 978-88-7694-531-8
2. Sondaggi sul lessico della poesia medievale, 2007, pp. 184, € 18,00.978-88-7694-984-5



































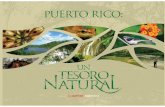

![Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334f93ea1ced1126c0a92f1/il-tesoro-dei-pirati-la-fotografia-a-inchiostro-fra-rotocalchi-e-riviste-fotografiche.jpg)







