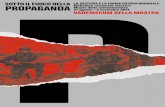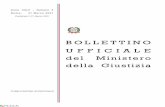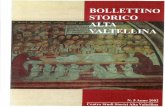Tombe romane a Muggio, in Bollettino Storico della Svizzera Italiana, 108, 1, 2005, pp. 131-163
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Tombe romane a Muggio, in Bollettino Storico della Svizzera Italiana, 108, 1, 2005, pp. 131-163
FULVIA BUTII RONCHETII
Tombe romane a MuggioIn appendice un excursus sulle olle di «tipo comasco»nel Canton Ticino, con contributi di Moira Morininie Gianluca Vietti
Il rinvenimento
Nel 1972, in occasione dello scavo per una costruzione, a Muggio vennerodistrutte delle tombe a cremazione, il cui materiale di corredo fu in gran parterecuperato ed appare inventariato tra gli sporadici. Successivamente interven-ne Pierangelo Donati, responsabile dell' allora Ufficio monumenti storici, cheindividuò e scavò altre due sepolture. Dalla sua relazione emerge che «lacaratteristica principale di queste tombe è la costruzione della cassetta ottenu-ta scavando direttamente negli strati di calcare selcioso emergenti ea inclinatiquasi a facilitarne lo scavo; due esplorazioni a regola ci hanno permesso diosservare l'esistenza di una copertura piana sulla prima tomba e lo sconvolgi-mento della seconda, dovuto alle radicidi un grosso castagno.
Il corredo della prima tomba comprende: l'olpe, un'umetta, un coltello, lamolla di una fibula in ferro e le o~te disperse nelloculo; quello del-la tomba 2, totalmente frammentato, permette di riconoscere la presenza del-l'olpe e dell'umetta»l; una valutazione approssimativa del materiale recupera-to precedentemente all'intervento dei funzionari, permette di stimare laperdita di due corredi.
Il materiale è in parte esposto al Castello di Montebello; il restante è con-servato nel magazzino dell'Ufficio cantonale dei beni culturali di Bellinzona.
Ringrazio il responsabile dell'Ufficio cantonale dei beni culturali Giuseppe Chiesi, per lasempre cortese disponibilità Rossana Cardani Vergani, per i preziosi suggerimenti, GiorgioLuraschi e Simonetta Biaggio Simona, e per l'utilissima collaborazione Moira Morinini, Luisa Mosetti, Gianni Toffetti e Gianluca Vietti.
I P. A. DONATI, NOlI/lll1i/() Il sut! di'i Ccrcst« 11/'/11' 1I/111111itn n: ttclnrst, in AA, VV" I NOII/IIIIIII'"
"omosct), COl1l0 II)!!(), p, 66,
FULVIA BUTII RONCHETTI
CATALOGOd = diametroh = altezzalu = lunghezzaric = ricostruibileLe misure sono espresse in cm; i disegni, salvo diversa indicazione, sono in scala 1:3.
Tomba 1I - Olpe con alto bordo a fascia ed orlo piatto, collo troncoconico ornato da
collarino, corpo globulare schiacciato, basso piede, fondo pressochè pia-no. Ansa a nastro costolata con margini rilevati; una depressione per l'ap-poggio del dito pollice presso il collo.Ceramica rossastra con chiazze beige, inclusi frequenti nella parte infe-riore, anche neri.Frammentata e ricomposta.d orlo 5 h 23,1 d base 5,6175.72.1 Castello di Montebello (il1. 1)
2 - Olletta con brevissimo bordo verticale, spalla obliqua, corpo troncoconi-co e fondo convesso; fattura grossolana.Ceramica grezza rossastra a chiazze nerastre.Frammentata e ricomposta; sul fondo esterno tracce di ossa cremate.d orlo 7,6 h 8,8 d base 8 circa175.72.3 Castello di Montebello (il1. 2 e 22)
3 Frammento di fibula in ferro; sopravvivono parte della molla e dell' ardi-glione.Corroso.lu massima 2,6175.72.2 (il1. 3)
oltello in ferro con lama arcuata a sezione triangolare, a serramanico.Molto corroso, mancante dell' impugnatura.lu massima 11,6175.72.4 Castello di Montebello (ill. 3)
5 Ossa cornbustc175.72.5
Tombe romane a Muggio
Tomba 2l - Olpe con piede ad anello e fondo piano.
Ceramica a chiazze, rossiccia, arancio, nocciola, abbastanza depuratacon inclusi anche neri.Sopravvive solo la parte inferiore del corpo.d piede ric lO circa175.72.6 (il1.4)
2 - Frammenti ceramici vari fra cui si distinguono alcuni frammenti di olpein ceramica beige abbastanza depurata (5x3,6), un frammento di olia for-se di tipo «comasco» (ceramica rossiccia con anima nera, abbastanzadepurata; 6x3).175.72.6.1
3 - Frustuli di carboni e frammenti ossei.175.72.7
Sporadicil - Fibula in bronzo variante del tipo Aucissa, con arco semicircolare in ver-
ghetta a sezione quadrangolare, che si allarga sulla testa in una piastrinarettangolare; staffa piena rilevata ed ingrossata alla sommità; ardiglionea sezione circolare che si aggancia con un settore circolare al perno del-la cerniera; arco percorso da un motivo ad «S» inciso.Integra, ma corrosa.lu 8,1175.72.23 Castello di Montebello (i11.5)
2 - Anello in bronzo a sezione ovale.Corroso.d 4,7175.72.24 Castello di Montebello (il1. 6)
3 - Patera di forma Drag. 31; una serie di linee incise sia all'interno cheall'esterno.Ceramica rosa-arancio depurata, vernice rosso-arancio con chiazze nera-stre, opaca, in parte evanida.Frammentata, ricomposta ed incompleta.d orlo 14,4 h 4 d piede 5175.72.1 'i Castello di Montebello (ill.
FULVIA BUTTI RONCHEITI
4 - Olpe con collo troncoconico, corpo globulare schiacciato, fondo piano;una linea incisa non continua alla base del collo, parte superiore del cor-po non uniforme, ma quasi costolata; ansa a nastro tricostolata, con mar-gine solo a destra, depressione all'attacco del collo per alloggiamento delpollice.Ceramica mediamente depurata, con inclusi anche di grosse dimensioni(anche neri), rossiccia con chiazze rosso mattone, beige e nerastre.Frammentata e ricomposta, mancante del bordo.h max 26,3 d piede Il,5175.72.9 Castello di Montebello (ill. 8)
5 - Olpe con alto bordo a fascia, collo troncoconico ornato da collarino, cor-po globulare schiacciato, piede ad anello, fondo piano; ansa a nastro conquattro costolature, con due piccole depressioni laterali all' attacco con ilcollarino.Ceramica arancio e beige mediamente depurata, con inclusi anche neri.Frammentata e ricomposta.d orlo 4,2 h 31,5 d base 10,8175.72.8 Castello di Montebello (ill. 9)
6 - Olpe con orlo piatto e bordo ingrossato, collo troncoconico, corpo ovoi-dale, fondo piano, piede ad anello; ansa costolata; due linee incise, sottoil collo ed a metà del corpo.Ceramica arancio e beige, abbastanza depurata con inclusi anche neri equalche incluso di grosse dimensioni.Mancante di parte dell'orlo e di un frammento del corpo.Ricostruita graficamente al bordo.d orlo 4 h 23,5 d base 9175.72.17 (ill. lO)
7 - alla con bordo esoverso, spalla curva, corpo globulare schiacciato, fon-do piano con segno dello stacco dal piano del tornio. Una linea incisa sot-to la spalla.Ceramica a chiazze rossicce, beige e nerastre, abbastanza depurata coninclusi anche neri.Frammentata, ricomposta ed incompleta.d orlo 13,8 h 8,8 d base 6175.72.10 (ill. 11)
Tombe romane a Muggio
8 - alla con bordo esoverso, spalla curva, corpo globulare schiacciato, fon-do leggermente incavato con segno dello stacco dal piano del tornio. Unalinea incisa sotto la spalla.Ceramica arancio con chiazza beige, abbastanza depurata, con inclusianche neri.d orlo 14 h 8,3 d 6,4175.72.11 (ill. 12)
9 - alla con corpo globulare schiacciato e fondo piano, con segno dello stac-co dal piano del tornio.Ceramica con inclusi abbastanza frequenti, anche neri, di colore non uni-forme, arancio con chiazze beige e nerastre.Mancante di tutto il bordo e di parte del corpo.d base 6,2 h massima 7,7175.72.18 (ill. 13)
lO - alletta con bordo esoverso, spalla curva, corpo ovoidale, fondo pianocon segni dello stacco dal piano del tornio; una scanalatura sotto la spalla.Ceramica abbastanza depurata con degrassanti anche neri, di colore arancio e beige, con fiammata marrone.Mancante di un frammento del bordo ed incrinata.d orlo 10,8 h Il,8 d base 4,7175.72.12 (ill. 14)
11 - alla con bordo esoverso con scanalatura all'interno, corpo globulareschiacciato, fondo piano.Ceramica arancio e rossastra mediamente depurata con inclusi ancheneri.Mancante di un grosso frammento.d orlo 16 h Il,1 d base 9175.72.13 Castello di Montebello (ill. 16)
12 - alla con bordo ingrossato, collo obliquo modanato, spalla curva, corpotroncoconico; striature di lisciatura sotto la spalla.Ceramica con frequenti inclusi marrone e nerastra in superficie, rossicciuall'interno; impasto analogo alle «olle cornasche».Mancante del fondo.d orlo ric 24 h massima 10,7175.72.16 (ill. 17)
FULVIABUTrI RONCHElTI
13 - Base piana di olla, con segno dello stacco dal piano del tornio.Ceramica arancio abbastanza depurata, con inclusi anche neri.d base 6,5175.72.19 (il!. 15)
14 - Tegame troncoconico con orlo arrotondato, bordo inflesso e fondo con-vesso; probabili resti di cibo all'interno.Ceramica a chiazze nocciola e nerastre con frequenti piccoli inclusi.Incompleto.d orlo 14,4 h 3,8 d base 11,4175.72.14 Castello di Montebello (il!. 18)
15 - Recipiente in pietra ollare, cilindrico, con presette orizzontali; sopra unapresetta XlIX inciso.Pietra ollare beige-biancastra,Mancante del fondo.d bordo 27,2175.72.21 Castello di Montebello (ill, 19)
16 - Recipiente in pietra ollare, cilindrico, con fondo appena concavo.Pietra olIare biancastra, beige e grigia.Frammentato ed incompleto.h ric 9,8 d base 12l75.72.20 Castello di Montebello (ill. 20)
17 - Coltello in ferro con lama triangolare a sezione triangolare; imrnanicatu-ra circolare con chiodo di fissaggio.Incompleto, corroso, restaurato con integrazioni.lu massima 15,3175.72.22 Castello di Montebello (ill. 21)
Tombe romane a Muggio
La struttura tombale ed il rito
Come appare consueto nel Sottoceneri il rito attestato è quello crernatorio-,, _ ..
E invece particolare la struttura, a parallelepipedo, ma scavata direttamente nel«calcare selcioso», e successivamente coperta. La dispersione delle ossaall'interno delloculo (e non contenute nell'urna cineraria) è rituale riscontra-bile altrove già in contesti della romanizzazione, come ad Appiano Genti le"Arsago Seprio", Oleggio" ed attestata ad esempio a Melano". Scavi recentihanno però appurato che i resti della cremazione sono talvolta conservati incontenitori di materiale deperibile, stoffa, legno o forse cuoio, di cui non sonostate nel passato riconosciute le tracce? (e che neppure oggi sono sempre individuabili), ma che possono essere arguiti nel caso l'assembramento dei restidella cremazione abbia limiti ben definiti.
2 F. BUTTI RONCHETII, Necropoli romane del Canton Ticino: osservazioni su alcuni aspetti l'
caratteristiche, in Archeologia della Regio Lnsubrica, Dalla Preistoria all'Alto Medioevo, Alli (11:1Convegno, Chiasso 5-6 ottobre 1996, Como 1998, pp. 267-282.
3 C. NICCOL!, La necropoli di Appiano Gentile (CO). Problemi della romanizratione del Comusco, tesi di laurea discussa all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, (reI.: prof. M. p,Rossignani), a.a, 199L-92, pp. 195-197.
4 M. A. BINAGlil LEVA, La necropoli, in Arsago, Nullus in lnsubria pagus vctustior, Suul! /1/memoria di Silvio Pozzi, Varese 1990, p. 30; dove, peraltro, sono attestati anche casi in cui le CCI1\'
ri sono raggruppate in modo da far supporre l'esistenza di un contenitore in materiale dcperibile5 G. SPAGNOLOGARZOL!, Gli scavi, la topografia e i riti, in G. SPAGNOLOGARZOII (li CUlli di),
Conubia gentium, La necropoli di Oleggio e lo romanizzazione dei venamocori, Torino 11)')'), p5 L, dove sono presenti anche ceneri ammucchiate.
6 S. BIAGGIOSIMONA,Leponti e Romani: l'incontro di due culture, in R. C. J)H MARINIS, S. IIIACIGIOSIMONA (a cura di), I Leponti tra mito l' mllte), 2, Locurno 2000, pp. 2612trl, tìg. 4.
7 F. BUTII RONC'IIE'IìI, C. NIC'col.I SI'RIO, I. NOli Il l' ))1' AOOSIINI, ta nrcropoli di ViII 'Iim1/1I/11OI rossi, in Stori« di Marlano (',11I11'111'(', nlll/o "ll'lIt/llio 1III'IIIto Medtoeva. MIIIIIIIHl ('(\I I li'lI M'
1999, )lll I) I lJ2
1'\'/
FULVIABUTII RONCHETfI
I materiali
Lafibula, una variante tarda della Aucissa", reca una decorazione che ricor-da quella impressa su alcune fibule di tipo Mesocco? ed è analoga a quella dialcune fibule a tenaglia da Arcegno, dal Locarnese e da Ca'4,gliano'O, daMadrano!', dei Grigioni 12, da Zugo!' e forse del Vallese!", confronti che si col-locano fino al III secolo. È probabile sia un prodotto del territorio, sia per lapresenza di pezzi pressochè identici 15, sia per la decorazione attestata su fibu-le locali e di lunga persistenza".
La classe della Terra Sigillata è rappresentata da un solo esemplare moltoscadente di Drag. 31 (E. ETILINGER ET AL., Conspectus formarum Terrae Sigil-latae italico modo confectae, Bonn 1990, Form 3) (spor. 3) che asseconda lanormale evoluzione qualitativa e morfologica della forma, presentando vernicedi scarsa consistenza, il piede basso e di diametro inferiore, e linee incise".
8 E. ETILINGER, Die romischen Fibeln in der Schweir, Bern 1973, tipo 28; E. R1HA, Die romi-schen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst, Forschungen in Augst, 3, Augst 1979, tipo 5.5.
9 Cfr. F. BUTII RONCHETII, La necropoli di Airolo-Madrano, Una comunità alpina in epocaromana, Bellinzona 2000, tav. 25, n. 3/57/97, tomba datata 150-180 d.C.
io Informazioni gentilmente fornite da Sabina Mazzi ed Emanuela Guerra.11 BUTII RONCHETII, La necropoli di Airolo-Madrano, p. 117, tomba 1/1957, datata fine del 11-
inizi del IIIsecolo.12 I. R. METZGER,Roveredo GR-Tre Pilastri. Ausgrabungen des Riitischen Museums von 1965, in
«Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft fur Ur- und Fruhgeschichte», 87, 2004, tomba 25, n.2; A. GREDlG, Maladers-Tummihiigel: Merkur; von Rom nach Maladers, in Archdologie in Grau-bùnden, Funde und Befunde, Chur s.d., p. 147, fig. 4; S. MARTINKILCHER,A. SCHAER,l Grigioni inepoca romana, in Storia dei Grigioni, I,Dalle origini al Medioevo, Coira 2000, p. 93, n. 7 da Bivio.
13 E. ETILINGER, Die riimischen Fibeln, tav. 15, n. 18 da Hagendorn.14 Sono ornate con una decorazione similare le fibule a tenaglia in V. REv VODOZ,Les fibules gal-
lo-romaines de Martigny VS, in «Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft fur Ur- und Fruhge-schichte», 69, 1986, pp. 169 e 186, nn. 216-218, che per la loro omogeneità sono ritenute prove-nienti dallo stesso atelier, probabilmente localizzabile a Martigny, infatti questo tipo di fibula ètipicamente alpino; uno di questi esemplari potrebbe già essere di fine I secolo.
15 A. SIEGFRJEDWEISS, Funde aus Bronze, Bein, Ton, Stein und anderen Materialien, in A. HOCHU-LIGVSEL,A. SIEGFRIEDWEISS, E. RUOFF,V. SCHALTENBRANDOBRECHT,Chur in romischer Zeit, 2, A.Ausgrabungen Areal Markthallenplatz, B. Historischer Uberblick, Base11991, tav. 53, n. 2, però ina-dorno; una fibula strutturalmente identica, con decorazione ad S incisa sul lato e sulla testa in M. FOR-TUNATIZUCCALA, Lovere (BG): considerazioni preliminari sulla necropoli romana, in La ValleCamonica in età romana, Collana di storia carnuna, Storia e testi, 7, Brescia 1986, tav. 48, n. 3.
16 Una fibula antesignana della Mesocco, di età protoimperiale, reca una decorazione a tremoli inA. SIEGFRlEDWEISS, Funde aus Bronze, Bein, Ton, Stein und anderen Materialien, tav. 51, n. 3(cfr. anche BUTII RONCHETII, La necropoli di Airolo-Madrano, tav. 6).
17 M. P. LAVlZZARI PEDRAZZINI,Terra Sigillata, in G. SENA CHIESA (a cura di), con la collabora-zione di M. P. LAVIZZARIPEDRAZZINI,Angera romana. Scavi nella necropoli 1970-79, Roma 1985,p. 346. Per confronti molto simili al nostro: SENA CHIESA,Angera romana, tav. 44, n. 10, associa-ta a moneta di Adriano, e C. FERRARESI,N. RONCHI,G. TASSINARI,La necropoli romana di Via Bel-trami ad Arsago Seprio (VA), in «Rassegna di studi del Civico Museo Archeologico e del Civico
abineuc Numisrnatico di Milano», «Notizie dal Chiostro del Monastero Maggiore», 39-40,19H7, fig. 72, c, in tomba compresa Ira In seconda metà del I e la prima metà dd Il secolo.
Tombe romane a Muggio
Prevalentemente concentrata nella seconda metà del I secolo, persiste finoad età traianeo-adrianea con attestazioni anche successive".
Tre le olpai con collarino e corpo globulare schiacciato; le due complete sipresentano con alto bordo a fascia (che si allarga rispetto al collo, pur nonmutando lo spessore), caratteristica che non trova confronti nelle altre olpai acollari no dal Sopraceneri'", ma è atte stata più a sud.
Confronti piuttosto precisi a Mariano Comense sia per il n. inv. 175.72.8(spor. 5)2°, sia per la 175.72.1 (t. 1, n. 1)21. Contemporaneo a quest'ultimo edaffine nel corpo, lo spor. 4 (175.72.9), paragonabile ad un esemplare da Sta-bi022, anch'esso con inclusi neri nell'impasto ceramico. Questi ultimi due recipienti da Muggio (175.72.1 e 9) e l'olpe (234.37.342) da Stabio (forse anchela n. 422) dovrebbero provenire dalla medesima fabbrica, se non, addirittura,essere stati plasmati dallo stesso artigiano, poiché presentano la caratteristicadi una depressione sull'ansa, presso l'attacco con il collarino, per appoggiareil pollice nell'atto del versare il contenuto.
L' olpe a coIlarino è notoriamente un manufatto caratteristico deIla zonacompresa tra il sistema Verbano-Ticino ed il Milanese>, dove era verosimilmente fabbricata.
Per l'altra olpe (spor. 6) dal corpo ovoidale, confronti sirnilari a Muralto(Liverpool basso tomba 3)24.
18 C. DELLA PORTA, Patera Drag. 31, in G. OLCESE (a cura di), Ceramiche in Lombardia tra /Isecolo a.c. e Vll secolo d.C; Raccolta dei dati editi, Documenti di archeologia, 16, Mozzecane1998, pp. 101-102; per il Canton Ticino: BUTII RONCHETII, La necropoli di Airolo-Madrano, pp.79-80.
19 C. DE MICHELI SCHULTHESS,Aspects of Roman Pottery in Canton Ticino (Switzertand), HARIntern. Series, 1129, tavv. 83-95.
20 M. SAPELLl,1moteriali della necropoli di Mariano Comense, in AA.VV., I Romani nel Comasco, Como 1980, pp. 85-176, tav. 16, n. 2, tomba 22, datata 90-120 d.C.
21 Ibidem, tav. 24, n. 3, tomba 19, datata 141-150 d.C.22 C. SIMONETI, Necropoli romane nelle terre dell'attuale Canton Ticino (traduzione italiana IIl'l
l'originale in tedesco del 1941), Bellinzona 1967-1971, Stabio, n. inv. 234.37.342, l. 31, tlU11l11l115-140 d.C.; analogie anche con F. BUTII RONCHETII, Lo necropoli roma/la della «Coscinu 1//'/1('
della» di Lurate Caccivio, in «Rivista Archeologica dell'antica provincia e diocesi di Corno», I()7,1985, pp. 5-111, tomba 3, n. 13.23 A. MARENSI, La ceramica comune come indice di acculturazione? Alcuni esempi 1111I<1 italu),
in Le popolazioni dell'Italia antica e la 10m rontinuitù (,/III/1mll' e istituzionalo .1'0110 il dotnlnlo /1/
Roma, Alli del seminario, Biassono 20 settembre 20m. Macherio 2004, pp. 47 ·5H.2·1 SIMONill r. Nerrnpoli /YIIIIIIIII'.fig. ~(); l'h. 1)1' MI( 1111l, A.II/I'I'I.I'o/ U/IIIIOIi1'1111/'/y. fouuu 111H.
IIiV.71, il. 767, lomhll dllltllU I()() L~()d.t ', SI Vl'dll llil' 1\1't '. 1)1'1I.A POIHA, 01,1/' Il. 27, in ()I ( I \Il,
Crnnntrlu: in t omtmnlln, pp. l')? 1')\,IIlV liti, Il I
FULVlABUITI RONCHETrI
Le ollette (spor. 7, 8 e 9) trovano paralleli identici nelle tombe l e 31 di Sta-bi02
5, ma comunque la forma globulare schiacciata è molto frequente in Lom-bardia per tutta l'età imperiale-e; nelle sue numerose varianti di dimensioni,proporzioni, orlo e vasca.
Nella medesima forma, globulare schiacciata, rientrano anche le due alle(spor. 11 e 12), sostanzialmente analoghe morfologicamente, pur nella incom-pletezza della seconda, ma molto differenti nell'impasto, molto più grossola-no nella spor. 12. Mentre per la prima non è delimitabile più precisamente unadatazione riferita genericamente alla prima età imperiale, la seconda rientra inun tipo attestato a partire dal 111 secolo" e trova paralleli stringenti ancora unavolta con un esemplare da Stabio-" associato ad un'olpe invetriata-". L'impastodella spor. 12 è molto grossolano, analogo a quello dell' alletta (n. 2) dallatomba l, che appare ad un esame autoptico del «tipo comasco», su cui ci sof-fermeremo nell' appendice.
L'alletta ovoidale (spor. 10) fa parte di quei prodotti in ceramica comune,ma piuttosto raffinati, dallo spessore non elevato ed abbastanza depurati, e tro-va infatti confronti pertinenti con manufatti a pareti sottili o ad imitazione diesse, analogamente decorati con la linea orizzontale incisa, con una buona dif-fusione nel Comprensorio del Ticino fino al Milanese". La forma è comunquepresente anche nella ceramica comune" con una lunga persistenza.
Il tegame (spor. 14) è una forma molto comune che diventa particolarmentefrequente nei corredi medio-tardoimperiali; l'esemplare di Muggio è del tipopiuttosto frequente con bordo rientrante", sebbene presenti il fondo convesso,caratteristica poco attestata in ambito ticinese.
2.5SIMONEIT, Necropoli romane; DE MICHELI SCHULTHESS,Aspects of Roman Pottery, p. 82, tipoB3.26C. DELLA PORTA,alla/alletta n. 50, in OLCESE,Ceramiche in Lombardia, pp. 148-149; evi-
denziamo la particolare frequenza nei corredi di FERRARESI,RONcHI, TASSINARI,La necropoliromana, passim.27C. DELLA PORTA,alla/alletta n. 77, in OLCESE,Ceramiche in Lombardia, pp. 157-158, tav. 73,
n.2.28SIMONEIT, Necropoli romane, tomba 9; questo esemplare, completo, ha il fondo convesso.29C. MACCABRUNI, Ceramica invetriata nelle necropoli romane del Canton Ticino, in AA. Vv.,
Reperti romani da scavi nelle attuali terre del Canton Ticino, in «Quaderni ticinesi di Numisma-tica e Antichità Classiche», 198\, p. 96, n. 25.30DE MICHELI SCHULTHESS,Aspects oJ Roman Pottery, forma BK9, in particolare n. 168 da
Muralto; G. TASSINARI,alletta Angera 13, in OLCESE,Ceramiche in Lombardia, p. 59, tav. 17, n.2; segnaliamo per le analogie stringenti BVITI RONCHEITI, La necropoli romana della "CascinaBenedetta», tav. 4, n. Il; A. M. VOLONTE', Le ricerche e le scoperte a Parabiago prima degli anni'90, in M. A. BINAGHI LEVA ETAL., Antichi silenzi, La necropoli romana di San Lorenzo di Para-biago, Cassano Magnago 1996, tav. 8, n. 2 (esemplare decorato anche a strisce incise).31Per il Ticino DE MICHELI SCHULTHESS,Aspects of Roman Pottery, forma J 1.2, in particolare n.
484.12DE MICIIELI SC'IIULTIIF~~S,Aspects of Roman Potterv, forma D l, pp. 75 76.
Tombe romane a Muggio
Due i recipienti in pietra ollare (spor. 15 e 16), ambedue incompleti, c gi11contemplati nell' inventario dei materiali ticinesi'". Il primo è il tipico vasocilindrico a presette orizzontali (sopra una delle quali appare un'Incisionenumerale), l'altro è un bicchiere. È notorio che nelle valli a nord del Verbanoesistevano filoni sfruttati dalla popolazione locale per la produzione di rccipienti molto apprezzati sia in pianura che in ambito transalpino, come crncrg«dai censimenti riguardanti i reperti archeologici>', ed ancora documenti dl'VIiultimi decenni del 1700 testimoniano che i prodotti erano portati a dorso dimulo al mercato di Locarno e da lì imbarcati su battelli diretti nel Milanese l'ti
in Piemonte".
Il coltello (spor. 17), di grandi dimensioni a lama triangolare>, trova 1111
confronto pressoché identico a San Lorenzo di Parabiago" e, per quanto i'li plill
dedurre dallo stato frammentario, ad Inveruno>, e, con un altro tipo di impugnatura, a Mariano Cornense'". A serramanico il coltello dalla tomba I (Il I) 111
Considerazioni conclusive sui materiali
Il contesto nella sua globalità può essere collocabile, granon essendo state reperite monete, principalmente nel II sec.
Ben poco si può osservare a proposito dei corredi, che ci sono pl'1 VI'III1II
integri solo in un caso, ma consentono di rilevare la presenza degli «cleuu IIII
base» della «dotazione» funeraria, cioè olpe ed olletta, associate talvoltu 111111
telli o altro vasellame.La composizione dei corredi non presenta pezzi di pregio e pare di 1I111i1\1
dere, dalla reiterata presenza delle olpai e delle olle, una omogcnciv/u/uuuassestata su un'associazione standardizzata ed essenziale.
33P. A. DONATI, Archeologia e pietra oliare nell'area ticinese Iinvelltario di'i riunvunnnnarcheologici noti, in AA. Vv., 2000 anni di pietra oliare, Bellinzona 1986, pp. 71 142, 111111/ IIH
34 M. BOLLA, Recipienti in pietra oliare, in D. CAPORUSSO(a cura di), Scavi MMI, UH t't, Il, tlIarcheologia urbana a Milano durante la costruzione della linea 3 della Metropolitano 1()8.' l'NO3.2, Milano 1991, pp. 21-28.
15 DONATI,Archeologia e pietra ollare, p. 93.36Per quanto si può dedurre, nonostante l'incompletezza del pezzo, appartiene al tipo ,I di W Il
MANNING, Catalogue of the Romano-britisn iron tools.fiuing and weapons in the I//it/III M,tlt"IIII,
London 1985, fig. 30.17BINAGHI LEVA ETAL., Antichi silemi, tav, 13, n. 6.18 D. TONINI, I metalli, in M. A. BINAGIH LEVA, P. CAl"rANEO, R. VOWNII\' (a cura di), /I,,,.1/I1I,t
anni fa a Inveruno, La necropoli romana ritrovata, Mesero 2000, pp. 63 M, liA.1~M. SAPRIIl, I materiali della ncrropoti di Marinno Comense, tombe 17 c 22411 Cfr. ad esempio M. DAllO', lo //I,(·ltIllllft tli MII1/h"1/I/II, Studu) tI,'t nuttr» Il/li l' tlttttt 't'"
Mcmoire d'mdH.<ologÌl' provincinlc 111111111111'11I11\l'IlIl' il Ili FUl'IIII(' lk~ I ('lIIl'~ (Il' l'Ulllvl'''llr tll
I 1111"I Ilne, (1\'1 pllIl J) 1',1111111'1).Il Il 1'11111iuv \ l, Il IIiV. 111'11)·1Il)
1,1.1
FULVlABUTIIRONCHEITI
Il quadro collima con quanto emerge dai coevi contesti ticinesi, in cui sonostati notati, dopo i primi decenni del II secolo, un impoverimento dei corredi ela contrazione, a vantaggio della çomune, delle attestazioni in terra sigillata,che va di concerto con uno scadimento qualitativo dei prodotti di quest'ulti-ma+', come rilevabile nell'unico pezzo (Drag. 31) da Muggio.
Se da una parte questi fenomeni comuni all'area sono interpretati comeconseguenza del ristagno dei traffici commerciali e del ripiegamento su pro-duzioni locali, poiché l'Italia settentrionale non svolge più funzione di «centronodale» per il transito delle legioni, e di approvvigionamento delle province,che hanno autonomamente organizzato proprie produzionr", non bisognadimenticare che in questo periodo nella vicina città di Como si assiste al fiori-re di iniziative edilizie di grande impegno".
Da sottolineare la presenza di due fibule, una integra ed un frammento, ele-mento dell'abbigliamento che in Canton Ticino cade progressivamente in di-suso con l'affermarsi della romanità, durante la quale si adottano vestiti chenon necessitano di fermagli; infatti i sepolcreti del Locarnese, caposaldo dellaromanizzazione nel Canton Ticino, hanno restituito poche fibule+. Ad esem-pio indossava ancora l'abito tradizionale locale la defunta sepolta nella tombal dello scavo Realini di Stabio, in fase di rornanizzazione", mentre le fibule diMuggio, di circa 200 anni dopo, indossate singolarmente, dovevano con ogniprobabilità bloccare un mantello.
Tra gli oggetti rinvenuti è individuabile un dualismo di influenze, mentre lafibula è rapportabile per la decorazione all'ambito alpino, in altri manufatti(ceramiche e ferri) sono riscontrabili strette analogie con il materiale di centripiù meridionali, oltre agli ovvi rapporti con località limitrofe. Ma non costi-tuisce un caso isolato la fibula di Muggio, infatti a Stabio è stata reperita un' al-tra fibula" di provenienza transalpina, smaltata e databile al III secolo, analo-
41S. BlAGGIOSIMONA,Regione H: Ticino, in C. SCHUCANY,S. MARTIN-KILCHER,L. BERGER,D.PAUNIER,Romische Keramik in der Schweiz; Céramique romaine en Suisse, Ceramica romana inSvizzera, Antiqua, 31, Basel 1999, p. 232.42Sul problema M. P. LAVIZZARIPEDRAZZlNl,Il quadro produttivo nel vicus di Angera, in G. SENA
CHIESA,M. P. LAVIZZARIPEDRAZZINI(a cura di), Angera romana. Scavi nell'abitato i980-86, 2,Roma 1995, p. 604.43D. CAPORUSSO(a cura di), Ritrovare iComenses, Como 2002.44BUTTIRONCHETTI,La necropoli di Airolo-Madrano, p. 103; S. MARTINKlLCHER,Airolo passa
alla storia, La vita di un paese di i800 annifa e dei suoi abitanti attraverso la lettura delle tombe,in BUTTIRONCHETTI,La necropoli di Airolo-Madrano, pp. 23-47.45S. MARTINKILCHER,Die Romanisierung der Lepontier im Spiegel der Kleidung, in DE MARI-
NIS,BiAGGIOSIMONA,i Leponti tra mito e realtà, 2, p. 313, fig. 8, l.46A. CRIVELLI,Atlante preistorico e storico della Svizzera italiana, Bellinzona 1990 (ristampa
anastatica con un contributo di P.A. Donati; ed. or. 1943), pp. 108-109; per il tipo M. FEUGERE,Lesfibules en Caule Méridionale de la conquéte à la fin du V' s. ap. J.-c., in «Revue Archéologi-que de Narbonnaise», suppl. 12, Paris 1985, tipo 27d l, n. 1942.
Tomberomanea Muggio
ga ad una da Airolo-Madrano'". La rarità in Transpadana delle fibule smaltate48 rende ancora più evidente il rapporto tra la spilla da Inveruno" ed alcunerinvenute ai piedi del Gottardo'", tutte recanti una protome identica di volatile,che fanno concludere come sia sempre vitale la funzione di raccordo tra norde sud svolto dall'asse del Ticino. Forse la presenza di fibule settentrionali IIl'IComasco e nel Lecchese", più verosimilmente indossate che commerciate, iIlparticolare quelle a coppia, indicano il trasferimento di donne dal noni ali"zona subalpina o alla pianura, secondo una tradizione di strategie matrimoumli di cui abbiamo tracce già in epoca protostorica". A questa prassi fanno pi'1Isare anche gli aneJli da caviglia tipici delle donne seduni, rinvenuti li ('''VIII(Varese) ed a Ornavasso, ma anche le fibule leponzie di «tipo Mesocco» illh!·state a Verdello (Bergamo)" ed a Golasecca (sud Verbano)".
D'altro canto strettissime sono le analogie con olpai da Mariano COIlWII •.•e l
un coltello da Parabiago. Ancora, l'olletta grezza della tomba n.1 uppuic di 1111tipo di accertata produzione comasca e diffusissimo negli scavi cittadini, 11111smerciata per un raggio piuttosto ampio (vedi excursus).
Un'altra conclamata usanza comasca è quella delle urnette (uncnu ie 111pIItra, sia in grezzo serizzo che nel raffinato marmo di Musso", che IIOVIiIlIIlIanche a Lugano ed Agno"; quest'ultima'? è riconoscibile per il laCl'llo di l"gio «a parentesi graffa» tipico appunto della produzione dei lapicidt 111I111111
47BUTTIRONCHETTI,La necropoli di Airolo-Madrano, p. 121, dalla t. 2/1966.48Una fibula di I secolo da Bellagio (A. GIUSSANI,Tombe preistoriche e tomb« 111I11/111/'.111_Hiv
sta Archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como», 111-113, 1936, p. 9Cl,lip Il)49BINAGHILEVA,CATTANEO,VOLONTE',Duemila annifa a Inveruno, tav, 3. Il.2 l, 1111111111111./111111
tomorfa nella tav. 7, n. 39.50BUTTIRONCHETTI,La necropoli di Airolo-Madrano, tombe 7/1957 ed 1/1911\ PII I .1.1"I~1,, '"1
bibliografia, databili alla metà del II - prima metà del 11I secolo.51Sul problema F. BUTTIRONCHETTI,l rapporti tra Lario e zona alpina 11/'/111 ti/li 11/11/'/110/'fI'l/
archeologica, in «RivistaArcheologica dell'antica provincia e diocesi di Corno», 111\'111,Il di q.III1I',152S. CASINI,11 ruolo delle donne golasecchiane nei commerci del Vi- V seco a (' , 111l'' M ~I"
NIS,BIAGGIOSIMONA,l Leponti tra mito e realtà, 2, pp. 75-100.53G. PERANI,Icorredi delle tombe i, 3, i5, in M. FORTUNATI,L. PAGANI,R. PO(iCIIANI1\11111'1'/
cura di), Verdello dalle origini all'Altomedioevo, Ricerche archcologlchc l' .\'IlIIitl"" VIIdI'I1112003, p. 186, nn. 25-26 (l'autrice è in dubbio sull'attribuzione della sepoltura lId '111111111111Il 111111donna).~4F. BUTTIRONCIIETTI,F. RONCORONI,Una fibula di tipo «Mesocco» da GII/nl'I'ITI/, 111111111•.111no dell' Associazione Archeologica Ticinese», 16, 2004, pp. 12·14.~~Reperti in marmo di Musso rinvenuti in Canton Ticino, in M. A"J<NAS("ONIRI'IJII\IIl, t ' 1(1I
sr'R, D. DECROUEZcon la collaborazione di J. SCIIMII),Analisi di marmi hlunchi //11I1'1'/111"/111dll/ "'ltesti a/'cltl'%fiici del Canton Ticino, in «Jahrbuch der Schwcizci ivchen (kSl'II"llllli 1111'Il IIlIdFrllhgcschichte», 87, 20()4, pp. 125 126.'I, ('({IVI'III,AIIWIf(' prcistoriro l' .II0riCII, p 79Il G WAI0,1'11,Romisrh« "m·ltnl"'II;1I di'I SellIl'I'I:., '\l'I Il 1')!lO, Il \O'i'M M 1IIIINAS(,()NI,/I'1I1111'./il/ll'IWII'tli ('011I11111//1/1111'l' 1'11/111'11I1// tll'/III/'IIIIIIIIIIII'/'llIltI/l,/1.111I(IV"'" i\"1Il"IIlllplill,kll' .11111\"IIIIIVIII\111\' ,lIlIn'" ,li ('1111111'"Ih'l, l'IH l, IIIV,I. "P" Il 1 Il I
FULVIABtrrn RONCHEITI
Certamente non stupiscono i rapporti commerciali con il Comasco per la con-tiguità geografica, mentre non è certa la dipendenza amministrativa della zonada Milano o Com059, poiché ambedue le città appartenevano alla tribù Oufen-tina, ed anche nelle epigrafi rinvenute compaiono personaggi sia comaschi chemilanesi.
Altre testimonianze di rapporti di gravitazione del Sottoceneri verso il sud,anche se più generiche, sono lo stesso rito funerario della cremazione, o l'usodelle lucerne, quasi inesistenti nel Sopraceneri, o ceramiche di grande diffu-sione come il bicchierino con strozzatura mediana, tipico prodotto della pia-nura in età augustea".
Se certamente Mendrisio doveva essere un naturale punto di riferimento perla valle di Muggio, non si può pensare al centro di Stabio se non come ad unodei fulcri della vita sottocenerinav', una località attraverso le cui purtroppodisiecta membra possiamo solo intuire l'esistenza sia di attività produttive=,sia di un ceto ad alto tenore di vita, a giudicare dall'eleganza dei rinvenimen-ti63.
Sono infatti con ogni probabilità provenienti dalla medesima fabbrica, senon addirittura plasmate dal medesimo artigiano, le olpai che presentano nel-l'ansa una depressione più o meno pronunciata, per appoggiare il pollice nel-l'atto di versare, una caratteristica che troviamo in due olpai da Muggio(175.72.1,175.72.9) e, meno evidente, in una da Stabio (234.37.342) ed iden-tità significative sono state riscontrate anche nelle ollette. Del resto inclusi neriben evidenti, individuati nell'impasto cerarnico dei materiali di Muggio,appaiono anche nel vasellame da Stabio='.
Nel territorio era insediata una consolidata comunità che nel Il-I sec. a.C.recepisce influssi romani adottando ad esempio comportamenti ed abitudinipeninsulari, come l'uso di unguenti e profurni=, e riesce ad imitare i modelli
59 S. BIAGGIOSIMONA,L'epoca romana, in G. CHIESI,P. OSTINELLI(a cura di), Storia del Ticino,in corso di stampa.
60 Si vedano i reperti da Mendrisio in CRIVELLI,Atlante preistorico e storico, figg. alle pp. 103-104; per la diffusione del bicchierino S. BIAGGIOSIMONA,F. BUTTI RONCHETII,Céramiques fineset céramiques communes au Sud des Alpes: quelques formes à diffusion regionale du Canton duTessin et des régions limitrophes, in Actes du Colloque de Fribourg, 13-16 mai 1999 de la SFE-CAG, 1999, pp. 143-144.
61 G. BASERGA,Scoperte romane di Ligornetto e Stabio nel Canton Ticino, in «Rivista Archeolo-gica dell'antica provincia e diocesi di Como», 115-116, 1938, pp. 47-63, p. 54, si cita una via«romana» proveniente da Varese e diretta a Leggiuno.
62 C. SIMONETI, Costruzioni romane recentemente scavate nel Mendrisiotto (Ticino), in Munera,Como 1944, p. 183; due bacini rettangolari sono forse da connettere alla lavorazione di filati.
63 CRJVELLI,Atlante preistorico e storico, pp. 79-82; BASERGA,Scoperte romane, pp. 50, 53.64 Gentile informazione di Mariadele Zanetti che si sta occupando dello studio dei materiali di
Stabio.~, Balsarnari in CRIVIiI.II, Atlante preistorico /' storico, figg. 261 e 267.
Tombe romane a Muggio
romani, pur restando ancorata alle sue tradizioni: infatti, conformemente almos romanus segnala le tombe dei propri membri con lapidi, però grezze edancora con alfabeto encorio, secondo schemi non latini che affiancano il nomeproprio al patronimico. Una comunità che era presumibilmente unita da fortilegami di clan=, oltre che al proprio passato, le cui origini celtiche trapelanoancora nelle epigrafi posteriori, con tracce di onomastica gallica'". All'internodella popolazione indigena sono le élites le prime a romanizzarsi ed acquisireil nuovo modus vivendi , a garantire la fedeltà agli accordi con i dorninatori ead assumere le cariche amministrative locali, veicolo per ottenere l'ambita cittadinanza romana.
La zona era appetibile e famiglie di rilievo dovevano essere proprietarie dIappezzamenti terrieri, come presumibilmente i Petroni di Como attorno li
Ligornetto (dove furono reperite due epigrafi relative alla gens)68;un mcmhrudella famiglia ha una madre dal nome chiaramente celtico'" e sposa una donundella famiglia dei Virii?", a cui apparteneva anche il Caio Virio Vero, notabilemilanese, sepolto a Stabio'". Sono quattuorviri a Como sia un Caio Roma/ioC[---] di Riva San Vitale'? (membro di un'altra famiglia eminente, la quale ~in rapporti di amicizia addirittura con Plinio)", sia un Calpurnio di un'cpigrufe da Sonvico?", appartenente ad un'altra gens di spicco (basti pensare al CHI
purnio Fabato, prosuocero di Plinio, che donò alla città di Como un portico)Questo breve squarcio epigrafico ci ragguaglia sulla rete di rapporti di amicizia e parentela, di interessi politici ed economici intercorrenti con i nourhi Ilindigeni e tra i maggiorenti della tribù Oufentina, che detenevano il POll'Il'
66 Si constatano reiterazioni onomastiche nelle tre stele di San Pietro di Stabio: A. MORANDI,Il'1grafia e linguistica, in P. PIANAAGOSTINETII(a cura di), Celti d'Italia, 2, Roma 2004, nn. ~XI(), 111stele n. 38 contiene il patronimico «Askoneti. (corrispondente al latinizzato «Asconius»), du' ~Iritrova a Brisino, sulla sponda occidentale del Verbano, nelle altre due si ripete il medesimo plllilinirnico «Komoneos». Sulla sponda occidentale del Lago Maggiore si suppone fosse loculll'"IIiuna bottega di lapicidi (P. PIANAAGOSTINETII,Le stele, in Celti d'Italia, I, pp. 293-294 l.
67 WALSER,Romische Inschriften, n. 295 con il nome «Samrnonia», n. 303, con il nome «OCl'lHI..,sulle epigrafi ticinesi si veda da ultimo il contributo di C. REUSSERin G. CHIESI, P. Os IINI'I I I elicura di), Storia del Ticino, in corso di stampa.
611 CIL V 5443, 5444. Il Caius Petronius Crescens di CIL V, 5443 è quattuorviro; un / l Pcuuntu»Crescens dedica un altare a Giove (chiesa di Solbiate Olona; ClL V 5250; A. SARTORI,/A' II'II/i/lni romane. Guida all'esposizione, Como 1994, Su04).
69 CIL V 5444; WALSER,n. 295, la madre è la «Sammonia» citata sopra.70 Alla gens Viria sono attribuibili molte attestazioni a Como e nell'ager (M. REAli, /./' ;,\1'/1 '/1111I
latine del territorio comense settentrionale, in «Rivista Archeologica dell'antica provincrn l' diOcesi di Como», 171, 1989, pp. 207-297, n. 43, p. 232); Baserga (BASERGA,Scoperte /TJl/III11/', il '1.1)
aggiunge anche Monza, Milano, Gallarate e Carate Brianza.71 CIL V 5445; WALSER1980, n. 296.72 WAL.SFR,Romische lnschriften, n. 302, noto per aver lasciato unti somma di danuro PI'I l'~M'II
commemorato con rose ed arnarami.7l Plinio, Ep. I, 19; 4, 29./,1 R Flll'l S 101HA, Il. 1.I1'H,1,';11 11/'/1/'/ (11//111//11/ "/1 "(1/1 COl/lo: drr 1'1/11I/ \'011 SII/I"//'/I 'J l, 111
..l\nlll'oI01'111 SVII/l'Il''', 12,4, 1')XIJ,l'I' Il K l' \
l,t
FULVlABUITI RONCHEITI
locale, occupando le più alte cariche cittadine, ed economico, essendo pro-prietari terrieri". A questo ceto dovevano appartenevano anche le ville di Men-drisio"; Ligometto", Stabio", Morbio"? e, nel Luganese, Bioggio"; struttureche dobbiamo ipotizzare «ville rurali», coniuganti aspetti di raffinatezza «cit-tadina» (ambienti mosaicati, impianti di riscaldamento, piscina, ecc.) destina-ti all' otium dei possessores, ad impianti produttivi a cui facevano capo gli abi-tanti deifundi e la manovalanza che vi operava".
La villa di Stabio appare particolarmente sontuosa per la presenza anche diuna piscina di 13x7 metri quadrati, rivestita di marmi di vari colori, corredatadi statue e vasi marrnorei", che istintivamente si è portati a connettere allosfruttamento delle acque terapeutiche'", di cui però non abbiamo nessuna noti-zia certa per l'età romana.
Donati ha evidenziato come la posizione di alcune di queste ville denun-ciasse un rapporto di relazione con Como: quella di Morbio Inferiore, «situa-ta su un terrazzo della valle del Breggia, dominante lo sbocco verso Cernob-bio», e quella di Stabio «situata nello spartiacque tra Gaggiolo ed una dellesorgenti dell'Olona»!', Accanto alle ville produttive, insediamenti sparsi di
15Sul problema dell'osmosi tra autoctoni e Romani si veda A.T. SARTORJ,I rapporti tra ciuà ecampagna: l'osmosi demografica, in Milano tra l'età repubblicana e l'età augustea, Atti del con-vegno di studi, Milano 26-27 marzo 1999, Milano 2000, pp. 58-60.76Sono stati recentemente ripresi gli scavi di una villa che si sviluppa a partire dal I sec. d.C, e
presenta segni di crollo nel V (R. CARDANIVERGANI,Mendrisio TI, Villa presso la chiesa di SantaMaria in Borgo, in «Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft fììr Ur- und Fruhgeschichte», 86,2003, p. 240); per i reperti da Mendrisio oltre a CRJVELLI,Atlante preistorico e storico, pp. 103-104, si veda la scheda relativa alla villa nell' e.xcursus sulle olle.77SlMONEIT, Costruzioni romane, p. 183: alcuni lacerti murari davano adito alla supposizione
dell'esistenza di una villa.78Ibidem, pp.183-184; forse le ville sono due, poiché oltre a San Pietro, frammenti murari furo-
no rinvenuti «nel terreno Cadei»; per le altre scoperte BASERGA,Scoperte romane, pp. 48-54 e perla necropoli SIMONETI, Necropoli romane, pp. 260-295.79SIMONETI, Costruzioni romane, p. 184; una revisione della villa in C. AGUSTONI,La villa roma-
na di Morbio Inferiore, in «Bollettino dell' Associazione Archeologica Ticinese», 17, 2005, pp. 26-31.
80 Una presentazione in P. A. DONATI,Tra Franchi e Longobardi: una villa romana, in «Quaderniticinesi di Numismatica e Antichità Classiche», 22, 1993, pp. 201-220; R. CARDANIVERGANI,Bioggio: un esempio di continuità civile e cultuale dalla romanità al Medioevo, in «ArcheologiaSvizzera», 21, 4, 1998, pp. 155-162; P. A. DONATI,Bioggio. Lo villa romana, Relazione prelimina-re in G. FOLETII (a cura di), Pierangelo Donati, venticinque anni alla direzione dell'Ufficio canto-nale dei monumenti storici, Bellinzona 1999, pp. 177-187; per completezza d'informazione varicordato che le strutture sono da alcuni ritenute riferibili ad una mansio.81Sull'argomento G. SENACHIESA,Il territorio di Comum: insediamenti, necropoli, popolamen-
to, in Novum Comum 2050, Como 1993, pp. 200-212.82SLMONETT,Costruzioni romane; BASERGA,Scoperte romane, p. 48 e ss.83G. LURASCHI,Le terme romane di Como e dell'Insubria, in «Rivista Archeologica dell'antica
provincia e diocesi di Como», 184,2002, p. 86.84 P. A. DONATI,Il Ticino romano, in Novum Comum 2050, Auì del Convegno celebrativo della
fondazione di Como romana, Como 1993, p. 226.
Tombe romane a Muggio
piccola entità, a vocazione agro-pastorale, la cui economia era integrata anchedallo sfruttamento delle risorse ittiche del Ceresio (aghi da rete rinvenuti aMelano), ma non era investita dai profitti delle attività commerciali, così evi-dentemente ostentati nelle ricche sepolture del Locarnese. La povertà dei cor-redi ed il prepotente contrasto con il benessere del vicus verbanese avevano giàcolpito il Baserga che aveva liquidato i rinvenimenti archeologici con unasemplice ed incisiva definizione: «vasellame ordinario, carnpagnuolox'". 11Donati ha poi ironicamente sottolineato lo stretto rapporto con il Comasco (edoggi potremmo dire la pianura meridionale in generale) applicando tacitamcnte alla realtà sottocenerina la definizione di «gente di campagna, modesta (...)>>che Mirabella Roberti aveva usato a proposito del Comasco e che appuntoappariva estremamente calzante anche per il lembo meridionale del CantonTicino86.
Excursus sulle olle di «tipo comasco»
L'alta frequenza in territorio comasco di un'olia con brevissimo orlo vcrticale, spalla obliqua (spesso con linee incise) ed impasto ricchissimo di inclusi, aveva fatto ipotizzare una sua produzione locale, sospetto che le analisi chimiche hanno confermato, trovando corrispondenza tra la composizioucmineralogica dei frammenti e la composizione geologica del territorio attornoa Com087• La forma è risultata attestata dalla seconda metà del I secolo 01111prima metà del Il, sia in contesti abitativi che funerari, dove frequentementecostituiva l'urna cineraria. Alcuni esemplari tombali conservavano tracce dicibo bruciato, denunciandone lo scopo di recipiente da cucina'" per la prcparazione della puls, la bollita di cereali costituente il cibo comune degli untichi89.
Le olle sono ben riconoscibili per le caratteristiche morfologiche sopra CIH"l
ciate, che ritroviamo nell'esemplare da Muggio (ill. 22). Se questo fatto non l'probante con assoluta certezza poiché, ovviamente, contenitori di tipo similepotevano essere prodotti anche altrove, è comunque molto probabile che questasia stata importata dal Comasco e comunque ne denuncia l'influenza; non
85 BASERGA,Scoperte romane, p. 51.86 DONATI,Il Ticino romano, p. 226.R7G. PREDIERI,S. SFRECOLA,Analisi dei materiali ceramici, in l. NOBILE!OEAGOSTINI (li l 11111Ih),
Indagini archeologiche a Como, Lo scavo nei pressi di Porta Pretoria, Como 2(Xl5, r. 244, Il.IIIPpo lIa.
HH F. Burri RONC'IIE'rrI, I. NOBilE DI! Aoos'l INI, II/dizi di lino produzione di 0111' 11/'1 ('111//1/.\1'11, ìllG. P. BIHXlIClL(l, G. OLC'ESE (a CUrti di), t'mdu.ion» rrratnira in area puduua trn ll ll srrolu Il (' I
il VI/ .\'/'('//111 ti.C'.: nuovi dati l' f)/OI/Il'ttll'I' di 1111'/1'11, ('OIlVCI!1l0inter nll/iollult' di I )("l'IlI\\lIO Ih'l(l IlI du, Il I () uplll(' Il)1)9, Muniovn ")()()().l'I' .1\ I .11
., M WAlIlll'.N, (' SI liNI 11111{,Oli' plll\, AllI' ,In MII'I'llIlIh('(f(', (-I, Am"1 (1/11
1.1
FULVIA BUTII RONCHETII
sarebbe sicuramente molto verosimile l'imitazione di una produzione di scarsopregio, ed una distribuzione su ampio raggio (cfr. ill. 23), ma numericamentepoco rilevante al di là del nucleo cittadino, calza bene con un commercio piut-tosto che con una produzione parcellizzata nel territorio.
Questa forma risulta ulteriormente diffusa in Canton Ticino, nella villa diMendrisio, a Stabio, a Tremona, a Bioggio ed a Giubiasco. È facilmente con-statabile dai disegni l'omogeneità morfologica dei pezzi ticinesi, nonostantesiano distinguibili alcune varianti nel corpo ceramico, infatti, pur essendo tut-ti particolarmente ricchi di inclusi, hanno superficie nera, uniforme i primi treframmenti da Mendrisio, meno compatta è l'olletta da Muggio, mentre l'ulti-mo pezzo da Mendrisio è di colore diverso, grigiastro, affiancabile forse aduno da Coira?",
Mendrisio (sito n. 16) (ill. 24)Era già nota da tempo l'esistenza a Mendrisio di una villa famosa a causa delrinvenimento di un mosaico; gli scavi ripresi recentemente?' hanno individua-to l'esistenza di varie fasi di utilizzazione dal I al IV secolo d.C.
I - Frammento di olla con brevissimo bordo verticale, orlo arrotondato,spalla obliqua; probabili resti di cibo all'interno.Ceramica nerastra con inclusi frequenti.d orlo ric 12 caReperto 25
II - Frammento di olla con bordo quasi inesistente, orlo arrotondato, spallaobliqua percorsa da due linee incise. Probabili resti di cibo all'interno.Ceramica rossiccia, con superficie nerastra, con inclusi frequenti.d orlo ric 18 caReperto 36
111 - Frammento di olla con brevissimo bordo verticale ed orlo arrotondato,spalla obliqua con linea incisa non continua, spalmatura di argilla sotto laspalla.Ceramica rossiccia e nerastra con inclusi frequenti.d orlo ric 24 caReperto 28
'IO La presenza in questa località delle olle «comasche» mi sembrava, ad un semplice esame visi-vo. corretta, ma per scrupolo è stata indicata dubitativamente nell'articolo citato alla nota 88.'" ('AIUlANI VI·RClANI.Mt'//Ihi.l'io TI.
Tombe romane a Muggio
IV - Frammento di olla con brevissimo bordo verticale, spalla obliqua.Ceramica grigiastra e beige con inclusi, più compatta dei precedenti.d orlo ric 20 caReperto 28
Stabio (sito n. 22)Nel magazzino dell'UBC di Bellinzona sono conservati due frammenti dagliscavi del 1937 effettuati dal Simonett.
Da S. Pietro, scavo Realini-Rusconi:V - Frammento di olla con orlo arrotondato, spalla obliqua con due linee
incise, corpo troncoconico.Ceramica ricca di inclusi, arancio-rossiccia con chiazze nere all'esterno,bruna all'interno.d orlo ric 17,6300.37.199 (ill. 25)
Da Segeno, «sotto la fabbrica Realini»:VI - Frammento di olIa con brevissimo bordo verticale, spalla obliqua percor-
sa da linee incise.Ceramica ricca di inclusi nerastra, rossiccia all'interno.d orlo ric 16300.37.107 (ill. 25)
Tremona (sito n. 23)La necropoli è stata scavata dall'UBC in vari interventi; lo scavo dell'anno1983 ha restituito la seguente olIa:
VII - Frammento di olIa con brevissimo bordo verticale, spalla obliqua conspigolo marcato; segni di lisciatura al di sotto della spalla. All' internoprobabili resti di cibo.Ceramica rossiccia e nerastra per esposizione al fuoco, con moltissimiinclusi.d orlo ric lO240.83.67 (ill. 26)
1,111
FULVIABlJITl RONCHETrI
Bioggio (sito n. 18) Scheda di M. MorininiIl frammento di oUa di «tipo comasco» è sporadico, recuperato durante i lavo-ri di chiusura dello scavo, nella zona antistante il podium di un tempietto pro-stilo di ordine corinzio eretto nella seconda metà del II secolo d.C.92;l'area inquestione, delimitata da quattro basi (in relazione a una struttura o spazio ret-tangolare non definibili), era occupata da due fosse circolari (diametro 110-120 cm) destinate alla deposizione di offerte rituali.Sullo stesso pianoro, a un centinaio di metri di distanza dal!' area sacra, già inprecedenza erano state indagate altre strutture di epoca romana: quella che fudefinita parte di una villa rustica sviluppatasi nel II e III secolo d.C. (scavocentro scolastico - 1992) e un complesso in muratura, non determinato, attri-buito anch'esso al medesimo arco cronologico (ampliamento cimitero -1962).
VIII - Frammento di olIa con brevissimo bordo verticale e spalla obliqua, per-corsa da una linea incisa.Ceramica nera rossiccia con numerosi inclusi.Annerito dal fuoco su entrambe le superfici.d ric. 21,51.79/27.96.53 (il!. 25)
Giubiasco (sito n. 19) Scheda di G. ViettiLa necropoli di Giubiasco comprende quasi 600 sepolture databili dall'età delbronzo all'epoca romana (XII sec. a.C. - II sec. d.C.). La maggior parte dellesepolture furono scavate agli inizi del Novecento ed i loro corredi sono attual-mente conservati presso il Museo nazionale svizzero. Quest'ultimo, in colla-borazione con l'Università di Zurigo, ne ha recentemente promosso uno studiopluridisciplinare finalizzato alla pubblicazione critica del contesto".
92 Indagine archeologica UBC (1996/1998) - mappaJi 925/I073A11126. Il tempietto è statooggetto della tesi di laurea di M. MORININI, Bioggio (TI), découverte d'un petit tempie d'époqueromaine. Présentation des fouilles et des trouvailles archéologiques, presentata all'Università diGinevra, (reI.: prof. Descoeudres), Ginevra 2002 (inedita). Una prima sintesi inerente le differentifasi di occupazione dell'area è discussa in M. MORININI, Bioggio, lo studio di uno scavo archeolo-gico e dei suoi reperti, in «Bollettino dell' Associazione Archeologica Ticinese», 15,2003, pp. J4-21; in corso di stampa M. MORININI, L'area sacra di Bioggio, Complesso cultuale o parte di unimpianto produttivo-residenziale di Il e 11I secolo d.C.?, in «Quaderni ticinesi di Numismatica eAntichità Classiche», 35, 2005.
93 L. TORI, E. CARLEVARO,PH. DELLA CASA, L. PERNET,B. SCHMID SIKIMIç, G. VIETII, La necro-poli di Giubiasco (TI), l, Storia degli scavi, documentazione, inventario critico, Zurigo 2004. Ilvolume Il, Tombes et mobilier de la fili de l'ARe du Fer et d'époque romaine, è di prossima pub-blicu/ìonc. Il volume 111,ancora in corso di prepara/Ione, sarà dedicato alle sepolturc dell'età delhlllllll1 l' dl'll'lIIll1o dl'II'I'I~ ,klll'1I0
Tombe romane a Muggio
Hanno restituito due olle di «tipo comasco» due sepolture d'epoca romana(tombe 528 e 538) appartenenti a un lotto scavato nel 1905 dall'archeologo D.Viollier, al quale il Museo nazionale aveva affidato la responsabilità scientifi-ca dello scavo.
Tomba 528Sepoltura ad inumazione, con orientamento NNE-SSa, costituita damuretti di pietre a secco, a pianta rettangolare (cm 140x75), con copertu-ra formata da lastre di pietra.Il corredo comprende anche un'olpe a collarino ed un'olIa con bordoestroflesso; è ascrivibile genericamente al I-Il sec. d.C.
IX - alla con breve bordo verticale, spalla obliqua, corpo troncoconico, fondo piatto; annerita dall'uso sul fuoco; fattura poco curata.Ceramica con frequenti inclusi bruno scuro.d orIo 9A-16884 (ill. 27)
Tomba 538Sepoltura a cremazione, costituita da una fossa circolare (cm ISO di diametro) con tracce del rogo. Il corredo comprende anche una coppetta li
pareti sottili decorata a rotella, un'olpe a collarino ed una con imboccatura a beccuccio, un'ella con bordo estroflesso; è databile al I sec. d.inizio II sec. d.C.
X - alla con piccolo bordo verticale, spalla obliqua, corpo troncoconico,fondo convesso.Ceramica con frequenti inclusi, di colore non uniforme dal rossastro algrigio nero, grossolana.d orIo 10,5A-16926 (ill. 28)
Tutti i disegni sono dell'autrice, tranne le olle di Giubiasco di G. Vieui, ed il recipiente spt». 15 diN. Quadri. I disegni sono in scala J :3, tranne le fibule, in scala I :2. L'illustrazione 22 ~ di D. '1'l'1I1perii.
--~----------~- I.C;I
FULVIA BIJITI RONCHETTI
~
III. 1 - Olpe (tomba I; n. I). I disegni sono in scala I :3, tranne le fibule, in scala 1:2
III. 2 - Olletta (tomba I; n. 2)
~I
~
i-" c '. Q I - . ;' r .
Tombe romane a Muggio
J11I.3 - Frammento di fibula (n. 3; scala 1:2) e lama di coltello (n. 4) della tomba 1.
11I.4 - Olpe (tomba 2; n. I)
o
I ~
&~, ~/ ~L:) E
oc:;.-~~~/"'.~.1I1!.!1!~,)ml!"tl'nll)llll'tIUtmHIIWI/II~- ~
11I.5- Fihllili (S/lIII: I; sculu 1:2)
o~
11I.() - i\1ll'II0 di hlol1l.O (,\/1/1/
FULVIA BUTII RONCHETTI
11I. 7 - Patera (spor. 3)
{l~
A,I
r~'r
I
-~
11I. 8 - Olpe (spor. 4)
Tombe romane a Muggio
---.,'
-~
11I. 9 - Olpe (spor. 5)
FULVIA BUITI RONCHETrI I Tombe romane a Muggio
\1ll~
11I. lO - Olpe (spor. 6)
11I. 11 - Olia (spor. 7)
11I. IJ 01111 ispo). 9)
11I. 12 - Olla (spor. 8)
11I.14 - Olletta (spor. lO)
.~ r-~?~ ..
11I. 15 - Base di olla (spor. 13)
11I. 16 - Olia (spor. J 1)
----------- -'1 ..•/('1
111. 17 01111 (lfllII I l)
"
~
FULVIA BUTII RONCHETrI
~vJ11I.18 - Tegame (spor. 14)
XlXt·-:-_- .---=::g
• ~t.I•.;.,,:..... '-.~~.I•.. ' •.~
11I. 19 - Recipiente in pietra oliare (spor. 15)
ICU
Tombe romane a Muggio
11I. 21 - Coltello in ferro (spor. 17)
11I.20 - Recipiente in pietra oliare (spor. 16)
,./ - _/
j "I
'" -.J r > \\..' \-. ( ~I_)" \ {'-' -c, -
.__.._..--------------- --- ..== ------------=-_.=="
A
! rFULVIA BUITI RONCHETrI
IIl. 22 - Olla da Muggio (tomba I; n. 2)
Tombe romane a Muggio
~
LegendaI. Lurate Caccivio2. Como città3. Carnerlata e Ca' Morta4. Mariano Comense5. Ponte Lambro6. Cassago Brianza7. ValmadreraR. Oliveto Lario
~
t 21 ?
181Jr:•• 16
22•23.
9. ChiavennalO. BellagioIl. Guanzate12. Breccia13. Prestino14. Rovello Porrol'i. E~illnICI. MI'll(hl,in
1.6•
4•11·• 14
20•
11I.23 - Cartina sulla diffusione dell'olla di «tipo comasco»
17. Muggio18. Bioggio19. Giubiasco20. Vimercate21. Coira22. Stabio23. Trcmona
t I: I
FULVIA BUTII RONCHElTI
»::~,
~-I-- ---~II
il' ~
III
N( I .~
DI. 24 - Olle da Mendrisio (I-IV)
V
VI j~---=;->r=+r=:': ~
[~
VIII:~ ! E0:
Tombe romane a Muggio
VII
( I u11I.26 - Olia da Tremona (VII)
IX
11I.27 - Olia da Giubiasco (IX; tomba 528)
X (1-~---·I~l I )III. 28 - Olia da Giubiasco (X; tomba 538)