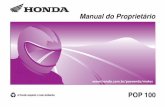This Is It. The King of Pop (in italiano)
Transcript of This Is It. The King of Pop (in italiano)
6.This Is It(The King of Pop)di Peter Szendy
This is it: è così, sì, proprio così, è la Cosa stessa.Si sta producendo, qui e ora, arriva, si annuncia. Ecco, di-
ce, eccomi, proclama parlando di sé, eccomi come la Cosa inpersona, come la Cosa in effetti, effettivamente.
This is it, canta Michael Jackson nella sua ultima canzone,che è anche il primo di una lunga serie di titoli postumi proba-bilmente a venire. Vi si sente la voce del King of Pop1, che chie-de se tutti sono pronti, ready?, che conta fino a quattro, one twothree four, e poi ecco, attacca il piano: This is it, here I stand…
È così, eccolo, il Re del pop.È così, eccola, la Cosa.Ecce homo, ecce res. La Cosa è dunque la canzone che è appena cominciata di-
cendo che è così, this is it, che lei è proprio questa canzone che
Pop filosofia!"#
1. Questo Re del pop, come noto, ha sposato nel 1994 la figlia del King ofrock’n’roll, Lisa Marie Presley, per poi divorziare nel 1996. Bisognerebbe analizzare larappresentazione della sovranità nella musica cosiddetta popolare. Durante i funerali diJames Brown, soprannominato The Godfather of Soul, Michael Jackson baciò il corpodefunto dell’uomo che incarnò il suo modello (cfr. C. NEWKEY-BURDEN, Michael Jack-son. Legend 1958-2009, p. 129). Ci si ricorderà anche del concerto del 1983 in cui JamesBrown invitò successivamente sul palco Michael Jackson e… Prince. D’altra parte, co-me ricorda Pascal Bertin nel numero speciale consacrato dalla rivista “Les Inrockupti-bles” nel 2009 a Michael Jackson, in 2 Bad, nel 1995, il King of pop utilizzava un sampledi “alcune parole e [de]la base ritmica di King of Rock, estratto del secondo album, conquesto stesso titolo, del gruppo Run-DMC uscito dieci anni prima. All’epoca, nel vi-deoclip, il duo hip-hop gettava a terra e calpestava il guanto argentato di Michael Jack-son per ottenere il suo titolo di Re del rock” (p. 25).
è. Ma così, l’evento della Cosa è anche, immediatamente, l’ere-zione di qualcuno, di un Io sovrano, che sta in piedi, here Istand, davanti a noi, davanti ai nostri occhi. E subito restiamoabbagliati, sbattiamo le palpebre nella luce splendente che ciinonda, strizziamo gli occhi per tentare di vedere su questa sce-na, nell’alone di un’aura accecante, che cosa o chi, res o homo,si erige crescendo fino a confondersi con un amore infinito: iosono la luce del mondo, annuncia lui, annuncia lei, I’m the lightof the world, dice la Cosa, mi sento immenso, dice il Re, gran-dioso o glorioso, I feel grand, e questa grandezza, questa gloriache sento è quella dell’amore, it is love I can feel.
Certo Michael Jackson sarà stato il primo a protestare inanticipo: dopo aver confidato a Oprah Winfrey, nel corso diun’intervista televisiva del febbraio 1993, che adorava aiutare ibambini e che cercava di imitare Gesù, I try to imitate Jesus, ave-va ritenuto di dover rassicurare la sua interlocutrice insieme agliinnumerevoli telespettatori. Non sto dicendo di essere Gesù,aveva insistito, I am not saying I am Jesus, non dico questo, I’mnot saying that. Allo stesso modo, in una dichiarazione televisi-va del 22 dicembre 1993, nel bel mezzo del suo primo processoper pedofilia, si era riferito (in modo a dir poco maldestro) alleparole di Gesù contenute nel Vangelo di Luca: “Lasciate che ifanciulli vengano a me”, per precisare subito dopo: Non pensoin alcun modo di essere Dio, in no way do I think that I am God,ma cerco di essere a immagine di Dio nel mio cuore, but I do tryto be God-like in my heart.
Che si tratti di denegazione poco importa, in fondo. Perchéciò che deve attirare la nostra attenzione non è quel che MichaelJackson in persona ha potuto pensare o voler dire, sinceramen-te o no. È piuttosto quel che si sarà inscritto in e come un gran-de testo musicale, visuale e multimediale. Noi prestiamo ascol-to a questa favola chiamata Michael, come sono soliti chiamar-lo i suoi fans, e non a Michael Jackson. Ne auscultiamo, fino neidettagli più kitsch o più pop, la figura cristica, la cui morte pa-
Pop Music !"$
re sia stata commentata su Internet molto più di quella del pa-pa Giovanni Paolo II2.
Michael J., dunque, come Jesus. Ma una simile cristologia, sì, è così, this is it, una passione
pop esemplare come la sua sarà stata l’inno planetario nascosto,benché ovunque esibito sotto i nostri occhi, di un’altra religio-ne: quella del capitale e del suo culto mondializzato.
*
Ai Brit Awards del 1996, prima di ricevere un premio spe-ciale in qualità di “Artista di una generazione”, Michael avevainterpretato la canzone Earth Song, dal suo album HIStory ap-parso l’anno precedente. Si vedeva la Terra girare lentamente infondo al palco, poi l’ombra di Michael profilarsi sullo sfondodel nostro pianeta blu. Poco a poco, al ritmo di una musicaneoevangelica colorata di gospel, dei bambini, come chiamatidall’apocalittica parola ecologica delle lyrics che evocano la ter-ra in lacrime, the crying Earth, un gran numero di bambini, al-cuni tenuti in braccio, uscivano dal globo per circondare il can-tante in mezzo a fumo artificiale e macchine per il vento. Alla fi-ne, Michael si spogliava dei propri abiti scuri per apparire ve-stito di bianco, in una purezza immacolata che attirava le mani
Pop filosofia!""
2. Cfr. C. NEWKEY-BURDEN, Michael Jackson, p. 189. Il numero speciale già ci-tato di “Inrockuptibles” consacrato a Michael Jackson si apriva con un dossier intitola-to: “Più celebre di Gesù Cristo”. È noto che Michael Jackson nel 1985 aveva acquista-to i diritti sul catalogo che comprendeva la maggior parte delle canzoni dei Beatles. Ora,more popular than Jesus Christ era una frase di John Lennon, che fece scandalo quando,in piena Beatlemania, Lennon dichiarò nel marzo 1966, a un giornalista britannico delquotidiano “Evening Standard”: “Il cristianesimo passerà. Scomparirà e si ritirerà. Nonho bisogno di dimostrarlo: ne sono sicuro e i fatti mi daranno ragione. Siamo più po-polari di Gesù Cristo ora; non so che cosa passerà prima – rock’n’roll o il cristinesimo”(cfr. anche “Rock’n’roll: According to John”, Time, 12 agosto 1966, www.time.com). Il22 novembre 2008, il giornale del Vaticano, “L’Osservatore romano”, aveva “perdona-to” l’ex Beatle assassinato nel 1980.
degli innocenti riuniti al suo fianco. E tutti e tutte lo toccavano,lo abbracciavano, lo stringevano. Lui, con voce rotta dall’emo-zione, ricordava le sofferenze di questo mondo, tutti i bambiniche, ogni minuto, muoiono di fame, per concludere con un mes-saggio di speranza e amore: I love you all, credo in tutti voi, I be-lieve in all of you, vi amo, I love you.
Ancora più sorprendente, per la sua fede in un universalemiracolo pop, il video clip che aveva accompagnato nel 1995l’uscita di questo stesso canto della Terra mostrava un Michaelteso ad arco tra due alberi carbonizzati, quasi crocifisso, che conla sola forza del suo verbo cantato o gridato faceva risorgere glianimali cacciati e mutilati, gli uomini fucilati, gli alberi abbattu-ti. In questo video si assisteva, con gli occhi sgranati, alla reden-zione di un mondo distrutto che occorreva dunque curare oguarire, come diceva già, nel 1991, la canzone Heal the World, ilcui videoclip metteva ugualmente in scena migliaia di bambinicon le candele, intenti ad ascoltare il vangelo michaeliano: fra-telli, diceva loro, my brothers, noi dobbiamo guarire il mondocon il nostro amore che è così forte, love is strong.
Si potrebbero riesumare molti altri momenti cristici, nellafavola di Michael. Le immagini per Billie Jean (girate da SteveBarron nel 1983) mostrano la star che illumina letteralmentetutto quello che tocca: i suoi passi sul marciapiede di un quar-tiere povero trasformano ogni lastra di pietra in un quadrato diluce; e il povero clochard addormentato vicino a un bidone del-l’immondizia si sveglia all’improvviso e si scopre, dopo il pas-saggio dell’angelo, è vestito di bianco immacolato. Michael do-na: nella scodella del povero, lancia una moneta che sprigiona laluce.
Cos’è dunque questa universale carità all’opera, la stessache spinse Michael a scrivere, in collaborazione con Lionel Ri-chie, la canzone filantropica We Are the World, nel 1985?
Questa carità universale modellata sull’amore cristiano ocristico è, come dice letteralmente This is it, la carità dell’indif-
Pop Music !"%
ferenza. Sì, è così, è proprio questo che canta il ritornello dellasua canzone postuma: Non ho mai sentito parlare di te, I neverheard a single word about you, ma ho l’impressione di conoscer-ti da mille anni, and I feel as though I’ve know you since a thou-sand years. È così: questa Cosa che dice Io riesce nel miracolo dirivolgersi a un Tu, you, di cui confessa di non sapere nulla, e acui è tuttavia destinata. Non avevo mai pensato, canta lui, dicelei, che sarei stato il tuo amante, che ti avrei amato, I never thou-ght that I would be your lover, ma è così, proprio così, this is it,la forza debole, la passione passiva di questa carità che Io sonoè più forte di tutto, non si può che sottomettersi ad essa, non sipuò che acconsentire.
Michael, la Cosa chiamata Michael, sarebbe dunque unaspecie di plasticità infinita, capace di sposare la forma di cia-scuno di noi, di cambiare o di scambiarsi all’infinito, come unamoneta universale, per prendere su di sé tutti i nostri tratti piùsingolari, per farsene carico nello scambio, proprio come si facarico dei mali del mondo. Non ha importanza che tu sia bian-co o nero, Black or White, canta nel 1991 nell’album Dangerous.E nello stupefacente finale del videoclip realizzato da John Lan-dis per questo tormentone, Michael sembrava prestarsi in anti-cipo a infinite trasformazioni in una sorta di assoluta passivitàche lo rendeva ora uomo, ora donna, ora cinese o giapponese,ora wasp americano, ora russo, ora rasta: in breve, un volto ca-maleontico che riveste tutti i tratti di tutte le razze, nazioni oclassi di questo mondo. In questa scena, che contribuì a rende-re popolare il procedimento del morphing, Michael, attraversola chirurgia plastica dell’immagine digitale, si presta caritatevol-mente a un’incessante deformazione a profitto di un’umanità lacui diversità è solo apparente: in lui, che si cancella così per labuona causa, l’umanità è una, danza e canta e gesticola come unsolo uomo.
In Michael, in questa Cosa che fu e continua ad essere, lacarità è lo scambio. È l’indifferenza dello scambio generale –
Pop filosofia!"&
tutti uguali, tutti equivalenti – che riguarda tutti noi, ognuno dinoi, in particolare. In Michael, con Michael, quel che si compiee si accelera è la sabbiatura dell’umanità che Nietzsche annun-ciava in un frammento postumo del 1880:
Quanto più cresce tra gli uomini il sentimento di unità con i loro simili,tanto più essi si uniformano e percepiscono ogni differenza come immo-rale. È così che appare necessariamente la sabbia dell’umanità: tutti mol-to simili, piccoli, rotondi… Fino ad oggi sono stati il cristianesimo e lademocrazia ad aver condotto più lontano l’umanità sulla via della meta-morfosi in sabbia.
Non sono mancate delle proteste, come quella del cantan-te inglese Jarvis Cocker che, esasperato, tentò addirittura di sa-lire sul palco nel corso dell’insopportabile show cristologico deiBrit Awards. Ma invano, naturalmente. Non solo a causa delservizio d’ordine e delle guardie del corpo che impedivano l’ac-cesso a questo corpus caritatevole che si autodesigna come tale– this is it, è così, hoc est corpus meum, questo è il mio corpo. Maanche e soprattutto perché si dimentica, quando ci si esasperacosì, che la forza innica di Michael, la sua potenza di assembra-mento attinge a tutt’altra profondità e ha le sue radici in una sto-ria che non si riduce alla superficie brillante e sgargiante dellasocietà dello spettacolo, dello show business.
Da dove viene dunque questa forza? Da dove trae la sua lin-fa?
*
La passione passiva della carità, scriveva Paolo nella primalettera ai Corinti (13, 7), “Crede ogni cosa”, spera “ogni cosa”,sopporta “ogni cosa”. Questo è l’amore infinito (agape, nel gre-co di Paolo) che è in primo luogo il supporto di tutto ciò che ac-cadrà, che si mantiene, in anticipo, al di sotto (hupomenei) di tut-to ciò che può accadere. La carità è come questo archiangelico
Pop Music !"'
volto michaeliano (Michele è il solo, nella Bibbia, a essere defi-nito arcangelo), come questo volto che è sfondo portante e sup-portante per tutti i volti e che, per questa stessa ragione, è pron-to a riapparire dappertutto, ad affiorare o a trasparire a ogniistante: i fans di Michael, come si è saputo lo scorso agosto, fan-no a gara per andare a contemplare, dopo la sua morte, i suoitratti reincarnati in un busto egizio di tremila anni fa conservatoal Field Museum di Chicago3; ma già nel 2005 si vendevano nel-le aste su eBay dei toast, sì sì, dei pezzi di pane tostato, sì sì, la cuiparte abbrustolita aveva miracolosamente disegnato l’effigie diMichael, vi giuro, come quella del Cristo che sarebbe rimasta im-pressa sul velo di Veronica4. È così, this is it, ecce homo.
Ora, questo spettrogramma del volto archi angelico è anchequello dell’interscambiabilità infinita. Come se il morphing del-la faccia veronicomichaeliana facesse di essa l’equivalente gene-rale di tutte le visaggità [visagéités] umane, come se fosse la lo-ro monetazione, il caro e caritatevole volto che rivela così il pro-prio essere caro, il proprio prezzo.
Che Michael sia dunque l’arcangelo dello scambio, lo dice ilsuo divenir effigie, certo; ma anche e soprattutto lo cantano lesue canzoni: sono queste infatti a trasportare, meglio di qualsia-si immagine, il suo messaggio senza messaggio.
This is it, a questo titolo, è esemplare. Perché This is it è co-sì, non dice nulla, non veicola nessun altro contenuto al di fuo-ri del suo proprio evento: sì, è così, questo evento, this is it, nonè esso stesso nient’altro, lo ascolteremo, che l’avvento dello
Pop filosofia!"(
3. Cfr. il dispaccio apparso su “Libération” il 9 agosto 2009: “Il direttore delmuseo Jim Phillips ha dichiarato all’ AFP [Agence France-Presse] che la sua istituzio-ne era stata “sommersa” di telefonate e email di fans, curiosi di sapere se il recente arti-colo di un quotidiano che aveva rivelato la rassomiglianza fosse vero. ‘Alcuni entranonel museo chiedendoci: Dov’è Michael Jackson? Noi spieghiamo loro che non c’è, chepossediamo solo un busto che gli assomiglia’”.
4. Cfr. “Jackson’s face ‘appears on toast’”, sul sito della BBC News(news.bbc.co.uk), il 21 giugno 2005.
scambio. This is it sarebbe in tal senso la formula della posteritàdi Michael, la formula della sua infinita resurrezione e transu-stanziazione in un cambio senza fine.
Non solo, in primo luogo, perché queste parole, this is it,furono onnipresenti nel corso della conferenza stampa del 5marzo 2009, in cui Michael annunciò che i suoi concerti londi-nesi sarebbero stati gli ultimi: This is it, dichiarò Michael men-tre i suoi fans scandivano queste tre parole, voglio solo dire chequesti saranno i miei ultimi spettacoli a Londra, I just want tosay these will be my final show performances in London, e que-sta fu così una scena, una sorta di Cena, anche, più che mai au-totestamentaria, in cui Michael afferma che this will be it, saràcosì, this is it, è così, and when I say this is it, e quando dico cheè così, it really means this is it, vuol dire che è davvero così.
Non solo, inoltre, perché This is it è il titolo del film postu-mo che avrà fatto rivivere Michael sugli schermi del mondo in-tero in una tourné post mortem grandiosa e spettralmente trion-fale come quelle fatte in vita.
Ma anche, infine, e soprattutto perché this is it era la for-mula dell’apparente evidenza con cui nascono le canzoni, que-sti miracoli cristomichaeliani. Lo aveva scritto nella sua auto-biografia del 1988 intitolata Moonwalk: in fin dei conti, in theend, molte canzoni si creano in qualche modo da sole, manysongs kind of create themselves, e voi vi dite semplicemente cheè così, you just say: this is it…5.
Sembra dunque evidente: sì, è così, this is it, ecco la canzo-ne, ecce cantus. Ma questo canto, annunciandosi, si scambia su-bito con un Io, here I stand, è così, ecco un Io, ecce ego, ecce Mi-chael. E questo Io della canzone si dona a ciascuno nell’amore,si dona a tutti. Se è la luce del mondo, I’m the light of the world,se si sente immenso e grandioso, I feel grand, è perché è in anti-
Pop Music !")
5. M. JACKSON, Moonwalk, p. 264.
cipo riempito di un amore infinito, it is love I can feel, un amo-re per un Tu, chiunque, per noi tutti, i suoi fedeli, che questo Ioha l’impressione di conoscere da sempre: ed è come se io avessivisto il tuo volto mille volte, dice Michael, and it feels as thoughI’ve seen your face a thousand times, canta, e ci fa confessare inanticipo che anche noi lo conosciamo, and you said you reallyknow me yourself.
La canzone, così facendo, si comporta come un vasto di-spositivo di scambio o di conversione: essa stessa, this is it, di-venta Io, here I stand, e questo Io diventa la luce cristica di Mi-chael e del suo amore che ci conosce e che noi conosciamo dasempre, che si presta a noi come noi ci prestiamo a lui.
L’evidenza di questi scambi della Cosa e nella Cosa, Michaell’ha cantata fin dai tempi dei Jackson Five. Una canzone come(You Were Made) Especially For Me, che fa parte dell’album re-trospettivo Soulsation nel 1995, diceva che ciascuno di noi, cia-scun uditore, ciascun fedele o fan è fatto per essere tale, in bre-ve, che noi siamo e siamo sempre, tutti quanti noi, specialmentee specificamente fatti così, sì, è così, this is it, fatti per questa Co-sa che si rivolge a noi dicendo Io, here I stand, e cantandoci checi ama, you’re definitely my kind of loving. Tra i commenti deifans quello che preferisco è questo, letto su youtube, a proposi-to di una interpretazione di (You Were Made) Especially For Medurante il Jacksons Variety Show del 1977: I was made especiallyfor Mike, dichiara qualcuno sotto lo pseudonimo di becau-se0011. E anche se non saprò mai chi è because0011, lei o luiavrà risposto in anticipo, per tutti noi, alla causalità indotta dal-la canzone nel suo rapporto a sé: sono stato fatto, rispondiamoogni volta, sono stato costruito specialmente per Michael, perquesta Cosa chiamata Michael che può dire Io a partire dall’evi-denza del this is it che accompagna l’autopresentazione del Sécosale inscritto nell’interscambiabilità generale.
Nel 1987, I Just Can’t Stop Loving You, questo arcinoto sin-gle estratto dall’album Bad e cantato insieme a Siedah Garrett,
Pop filosofia!%*
rende ancora più evidente la dimensione cristologica di questoamore della canzone per colui o colei cui si rivolge in se stessa.Questa volta, la Cosa cantata, non contenta di dire Io per rivol-gersi a un Tu qualunque, si sdoppia in un Io-Tu, diventa essastessa una scena di indirizzo all’altro in sé per celebrare il carat-tere celeste dello scambio: Our love is dawning, è l’alba del no-stro amore, canta Michael, e il cielo gioisce della tua venuta,Heaven’s glad you came, mentre l’altra voce, la voce dell’altro inlui, quella di Siedah Garrett, risponde che lo sente, che sente lasua voce, I hear your voice now, assicurando che il cielo è nel suocuore, Heaven’s in my heart, nel corso di questo incontro glori-ficato dal suono dell’arpa e dei canti angelici, I hear harps, andangels sing.
È così che la Cosa cantata si sente. È questa la sua eviden-za, this is it, il suo modo di andare da sé e di comprendersi, sì, ècosì, questa è la sua comprensione di sé in sé. Questa è l’auto-referenza del tormentone chiuso su di sé, la sua chiusura taute-gorica su di sé, che condiziona, come ho tentato di mostrare al-trove, la sua interscambiabilità infinita, la generosità o la caritàsenza limiti con cui si presta a tutto6.
Prestiamo orecchio a Man In The Mirror, uno dei grandisuccessi michaeliani, composto da Siedah Garret per l’albumBad: I’m starting with me, canta questa canzone umanitaria, iocomincio da me, dice, certo per ricordare a ciascuno di cambia-re se stesso prima di pretendere di cambiare il mondo; ma an-che, al di là delle buone intenzioni dichiarate, come se il tor-mentone confessasse che, per scambiarsi, per darsi il cambio,deve in primo luogo dire se stesso, cominciare rapportandosi ase stesso facendosi specchio di sé. I’m starting with the man inthe mirror, afferma, io comincio con l’uomo nello specchio, per-ché questo riflesso attraverso cui ciascuno di noi è inscritto in
Pop Music !%!
6. Cfr. P. SZENDY, Tormentoni! La filosofia nel juke-box, 2009.
anticipo nel narcisismo della Cosa è ciò che le permette di desi-gnare se stessa come luogo per eccellenza dello scambio7.
*
Il paradigma compiuto della Cosa scambiabile è il denaro.E il denaro ha sempre avuto qualcosa di sacro e di sacrifi-
cale, a immagine delle ostie che, come ha ricordato Marc Shell8,erano la moneta di Cristo, ostie che erano battute e pressate co-me monete, che dovevano rappresentare il corpo di Gesù e va-lere per Lui, affermando al contempo la fede nella possibilitàstessa di questo scambio. Alcuni arrivano fino a far derivare ilsegno del dollaro, $, dall’inscrizione IHS, in hoc signo, “attra-verso questo segno”, che è raffigurata sulle ostie cristiane9.
In ogni caso, il denaro, per essere l’oggetto di scambio cheè, per incarnare lo scambio stesso, deve designarsi come tale,deve sempre, in un modo o in un altro, portare il segno autode-signante del segno monetario che è.
In hoc signo, this is it. Sì, è così, una tale marca si inscrive in ciò che Giorgio
Agamben ha descritto come il paradigma di una “teologia eco-
Pop filosofia!%#
7. È Gil Anjdjar che, nella sua bella postfazione al mio Prophecies of Leviathan.Reading Past Melville (Fordham University Press, 2009), parla di un “narcisismo del-l’altra cosa” (narcissism of the other thing). Ma soprattutto, le pagine che seguono de-vono molto al lavoro di Gil Anidjar sulla “critica del cristianesimo”. Si veda per esem-pio “Blutgewalt” (Oxford Literary Review, vol. 31, 2009, pp. 153-174) e “The Idea of anAnthropology of Christianity” (interventions, vol. 11 (3), 2009, pp. 367-393).
8. Cfr. M. SHELL, Art and Money, p. 15: “l’ostia eucaristica è concettualmentenumismatica”, afferma l’autore dopo aver ricordato che “l’ostia era espressamente fat-ta come una moneta: veniva pressata tra dischi di ferro e impressa con segni come quel-li delle monete”.
9. È quel che sostiene Mark C. Taylor in Confidence Games. Money and Marketsin a World Without Redemption, p. 68. Taylor rinvia a Shell, anche se questo dice sem-plicemente “il simbolo del nuvo dollaro ha una forma visibilmente simile al […] IHS”(cit., nota 59, p. 147).
nomica”10, di cui rintraccia le fonti nella patristica cristiana.Senza poter ricostituire qui le pazienti analisi di Agamben, dirò,nella loro scia, che se la Trinità e l’Incarnazione del Figlio sonolegate a una oikonomia e anche a un “mistero dell’economia”, latransustanziazione dell’eucaristia prosegue questo scambio pri-mo, ne monetizza la vicarianza originale in quelle che vengonochiamate le specie eucaristiche, vale a dire il vino o il pane, l’o-stia. E quando l’ostia diviene una moneta – un gettone come fuil caso delle méreaux ai tempi di Calvino, monete di scambio chepermettevano di essere ammessi a partecipare all’Eucaristia –,essa porta generalmente il segno di questo segno che è: in hoc si-gno.
Queste sono senza dubbio le ragioni per cui Walter Benja-min, ne Il capitalismo come religione, un frammento postumodel 1921 di cui non è stata ancora ben misurata la portata, siproponeva di procedere a una “comparazione tra le immaginidei santi delle differenti religioni e i biglietti di banca dei diffe-renti Stati”, al fine di cogliere “lo spirito che parla nell’orna-mentazione” delle monete cartacee11. Uno spirito (Geist) chesoffia, ma nascosto, nella fede, nella fiducia o nel credito impli-cati in ogni operazione di scambio.
Quello che in fondo Michael ha cantato è proprio la gloriadi questo spirito fiduciario. Non solo in Money, nell’album HI-Story del 1995, quando il ritornello martella: Anything,anything, anything for money, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa per isoldi. Ma anche e forse soprattutto quando intona, con Keep theFaith, nell’album Dangerous del 1991, un inno alla fede e al ren-
Pop Music !%$
10. Cfr. G. AGAMBEN, Il Regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell’eco-nomia e del governo, p. 17.
11. W. BENAJMIN, Fragmente, in Gesammelte Schriften, p. 102. Chiunque vogliaabbordare questo enigmatico testo di Benjamin non può evitare di passare attraverso lalettura delle analisi che ad esso ha dedicato Samuel Weber in “Closing the Net”, Benja-min’s -abilities, p. 250 ss.
dimento fiduciario: the power’s in believing, dice, il potere stanel credere, dunque conserva la fede, so keep the faith, sì, baby,yeah, conserva la fede perché è solo questione di tempo, it’s ju-st a matter of time, la tua fiducia o il tuo credito vinceranno,before your confidence will win out, sì, vai, go and keep it brother,conservala fratello, e tieni i tuoi occhi sul compenso, sulla ri-compensa, just keep your eyes on the prize.
Quello che ascoltiamo qui, tra le parole di Michael, tra le ri-ghe dell’inno alla fede cantato dall’arcangelo dello scambio, è ilbuon vecchio adagio secondo cui time is money, il tempo è de-naro. Benjamin Franklin lo ricordava nel suo celebre Advice toa Young Tradesman nel 1784, in questo documento fondatoreche Max Weber considerava come un’illustrazione dello spiritodel capitalismo “nella sua purezza quasi classica”12. Al suo gio-vane amico, Franklin diceva: ricordati che il tempo è denaro, re-member that time is money. E ancora: ricordati che il denaro è,per natura, generatore e prolifico, of the prolific, generative na-ture, perché il denaro può generare denaro, money can begetmoney, e i suoi frutti possono generarne ancora, e così via, andits offspring can beget more, and so on.
Più di tutte le reliquie di Michael che vengono scambiate apeso d’oro (il 21 novembre 2009, nel corso di un’asta new-yorkese, il suo guanto fu aggiudicato per 350.000 dollari, e ilgiubbotto nero della tourné Bad per 225.000 dollari), più dellasua immagine declinata in inestimabili opere di pop art (la piùcelebre è Michael Jackson and Bubbles di Jeff Koons, una scul-tura di porcellana ricoperta d’oro e venduta per sei milioni didollari nel 2001), sono evidentemente le canzoni del King of popche avranno realizzato il miracolo di cui Franklin si vanta di po-ter insegnare il segreto: The Way to Make Money Plenty… E seesse hanno generato profitti mai eguagliati nella storia dell’in-
Pop filosofia!%"
12. M. WEBER, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, p. 99.
dustria discografica, battendo tutti i record di rendimento, è an-che perché, prima di arrivare sul mercato dell’hit parade, hannomesso in scena la questua infinita dello scambio redditizio inuna autoaffermazione di se stesse, nella loro autoingiunzione amonetizzarsi, a moltiplicarsi in innumerevoli esemplari di sé.
Keep the Faith ne è la pura illustrazione: la fede che si trat-ta di conservare, questa fede che aprirà l’accesso a tutte le ri-compense e a tutti i premi, è la fede in questo stesso imperativo,Keep the Faith, vale a dire, in fin dei conti, al termine di un con-to senza fine, il credito dato a questo inno allo scambio che è lacanzone stessa che lo canta. Keep the Faith vuol dire Keep theFaith, sì, è così, this is it, custodiamo e cantiamo questo canto,Keep the Faith, abbiamo fede in lui, nel suo carattere fiduciario,per generare con lui, in noi e sul mercato, i suoi infiniti e assil-lanti rampolli.
Molte altre canzoni dell’arcangelo Michael, con il pretestodi cantare l’amore di qualcuno o di qualcuna, cantano in realtàil proprio credito. I Just Can’t Stop Loving You è così prima ditutto un rivolgersi, una dichiarazione d’amore della canzone ase stessa, secondo il raddoppiamento circolare di questo Io-Tuche fa dire alla canzone, da sé e di sé: non posso smettere diamarmi e di cantarmi – I just can’t stop loving I Just Can’t StopLoving You… E così via, fino alla vertigine.
Allo stesso modo, in I Can’t Help It, nel mitico album Offthe Wall del 1979, la canzone si guarda allo specchio, looking inmy mirror, finge di essere sorpresa, took me by surprise, non puòevitare di riconoscersi, I can’t help but see you, di amarsi nel suonarcisismo di Cosa che comincia a moltiplicarsi, I can’t help butlove you, e di amarsi sempre più ogni volta che si ripete, it’s get-ting better all the time, secondo un’autoaffezione irresistibileche non ci lascia alcuna possibilità, I can’t help it, che ci ha in an-ticipo conquistato promettendoci una ricompensa celeste, Hea-ven is the prize.
Ma è Don’t Stop ’til You Get Enough, uno dei più grandi
Pop Music !%%
successi di tutti i tempi fin dalla sua uscita nel 1979, che enun-cia in modo cristallino e irresistibilmente trascinante la struttu-ra al contempo chiusa e proliferante del tormentone michaelia-no (Michael stesso, nel videoclip, sembra d’altronde moltipli-carsi); il tormentone qui dice il suo proprio potere, power, la suaforza e il suo voto, the force the vow, ciò che fa sì che accada,that makes it happen, senza sapere perché né come, it asks noquestions why, ciò che semplicemente fa sì che la canzone, que-sta canzone, non cessi ne cesserà mai, don’t stop, don’t stop ’tilyou get enough.
Ecco l’ingenuità, il potente candore narcisistico del tor-mentone michaeliano. Ecco il suo scambiangelismo [échangéli-sme], il messaggio portato da questo messaggero angelico: la suabuona novella, il suo vangelo non dice nient’altro che se stessoe la fede in se stesso. In se stesso come teatro del primo cambioche proseguirà infinitamente nello scambio.
Keep the Faith, this is it, sì, è così, don’t stop, keep on, youwere made especially for me.
*
Nel suo frammento del 1921, ne Il capitalismo come religio-ne, Walter Benjamin scriveva:
Bisogna vedere nel capitalismo una religione, vale a dire che il capitali-smo serve essenzialmente a dare sollievo alle stesse preoccupazioni, glistessi tormenti e le stesse inquietudini cui un tempo dava riposta ciò chechiamiamo religioni. Dimostrare la struttura religiosa del capitalismo –vale a dire dimostrare che è non solo una formazione condizionata dallareligione come pensa [Max] Weber, ma un fenomeno essenzialmente re-ligioso – ci condurrebbe ancora oggi nei meandri di una polemica uni-versale smisurata. Noi non possiamo stringere la rete in cui siamo presi.
Niente ci assicura di poter decifrare questo breve testo, cor-to, queste pagine così dense che confessano fin da subito unacerta impossibilità: “stringere la rete in cui siamo presi”, das
Pop filosofia!%&
Netz in dem wir stehen zuziehen. Nulla garantisce che si possacomprendere il racconto di ciò che ci tiene, che ci costituisce eci stringe. E tuttavia, è a queste pagine che, per finire, ci rivol-geremo, per provare a comprendere meglio la favola di Michael,per prestare orecchio a ciò che annuncia, alla novella del suonuovo Nuovo Testamento13.
Pop Music !%'
13. Ciò significa forse che, prendendo il King of pop come oggetto di un discor-so filosofico, citando Benjamin e altri filosofi per pensare la sua passione dello e nelloscambio, stiamo facendo della pop filosofia? – Sono Gilles Deleuze e Félix Guattari che,per primi, hanno parlato di pop filosofia. Per esempio in Kafka. Per una letteratura mi-nore, “Ciò che si chiama Pop – Pop music, Pop filosofia, Pop scrittura […]. Servirsi delpolilinguismo nella propria lingua, farne un uso minore o intensivo, opporre il caratte-re oppresso di questa lingua al suo carattere oppressivo…”. Se un discorso pop filosofi-co sul Re del pop deve necessariamente lasciarsi contaminare dal proprio oggetto – chenon è dunque un semplice oggetto, precisamente –, non è detto, non è detto in alcunmodo che questa contaminazione possa essere colta nei termini dell’opposizione op-presso vs. oppressore (quando si parla di una passione pop come quella di Michael, que-ste posizioni si scambiano in modo vertiginoso, perdono la testa nello scambio). – L’e-spressione, la parola d’ordine deleuziana di pop filosofia è stata ripresa poi da altri, adesempio, in Francia, da Élie During e Patrice Maniglier in riferimento all’opera collet-tiva che hanno consacrato a Matrix, machine philosophique (in particolare con la colla-borazione di Alain Badiou). Nella raccolta Fresch Theorie (Léo Scheer, 2005), During eManiglier ritornano sul loro lavoro nel corso di un’intervista intitolata “Che cosa restadella pop filosofia?”. Affermano che il “problema che sta dietro la pop filosofia” è“quello degli agganci e degli innesti impuri che la filosofia si dà per cominciare”. Vale adire che la pratica della filosofia sceglie il suo punto di partenza, il suo punto di anco-raggio in qualcosa di non filosofico: “Con tutta una linea di pensatori (Nietzsche, Marx,Freud, Deleuze…), crediamo che, dal punto di vista filosofico, l’impegno filosofico siasempre impuro. Detto altrimenti, malgrado tutto quello che si può dire in merito, sonosempre delle cattive ragioni che ci portano alla filosofia. C’è una necessaria eterogeneitàdelle condizioni della filosofia: è sempre per delle cattive ragioni che si fa filosofia, perragioni ben poco ‘filosofiche’”. – Da qualche anno, l’espressione si è diffusa, e i mediapossono definire un filosofo come Slavoj !i"ek “star della pop filosofia” (cfr. in parti-colare “Philosophie Magazine”, n. 8, aprile 2007). Alcune case editrici come OpenCourt Publishing negli Stati Uniti, lanciano collane intitolate Popular Culture and Phi-losophy (il primo volume è apparso nel 2009), con innumerevoli titoli del tipo Star Warsand Philosophy, James Bond and Philosophy, Monty Python and Philosophy… Qualsiasicosa and Philosophy dunque? Una filosofia applicata a tutti gli oggetti che si presenta-no sul mercato? Una filosofia che si applica piuttosto che inventarsi? Ad ascoltare conattenzione During e Maniglier, si tratterebbe esattamente del contrario: la pop filosofianon è un pensiero costituito applicato a differenti oggetti della cosiddetta popular cul-
Il pensiero di Benjamin è stato attento come nessun altro alkitsch, alla pubblicità, alla moda, alla fotografia, al cinema e al-le sue star, ai grandi magazzini, in breve, a un buon numero dielementi appartenenti a ciò che oggi verrebbe chiamato, senzasapere bene che cosa si intende con ciò, cultura pop. Ma, quan-do rivolge la sua attenzione, in questo frammento, alla naturareligiosa del capitalismo, Benjamin tiene un discorso per lo me-no lapidario ed enigmatico. Senza giustificarli né propriamenteargomentarli, identifica, enumera “tre tratti della struttura reli-giosa del capitalismo” (in realtà ce ne saranno quattro).
Primo, scrive Benjamin, “il capitalismo è una religione pu-ramente cultuale”, eine reine Kultreligion: nel capitalismo, valea dire, c’è solo culto, “non c’è né dogma specifico né teologia”.E secondo, aggiunge, “la durata del culto è permanente”, il ca-pitalismo non conosce “giorni ordinari”, Wochentag.
Questi due prime caratteristiche, in realtà, sono un’unicacosa. Se il culto capitalista non è la celebrazione di un dogma odi un principio, se non è al servizio di nulla, se non coltiva un
Pop filosofia!%(
ture; è, all’opposto, un pensiero che si cerca, filosoficamente, a partire della sua esposi-zione all’impuro. E lasciandosi profondamente, appassionatamente affettare. O infetta-re, come dice Laura Odello nel presente volume, per essene trasformata, per mutare, co-me suggerisce Simone Regazzoni nel suo prologo. Lasciandosi invadere dall’impuro,dunque, fin nella sua lingua, ma secondo un polilinguismo intralinguistico in cui l’op-pressione, lo ripetiamo, è difficilmente localizzabile. – Resta il termine stesso di “popo-lare”, di cui Jacques Derrida ha analizzato i pesanti presupposti metafisici, in particola-re nella sua lettura di Kant (cfr. “Popularité”, in Du Droit à la philosophie, p. 525 ss). Sa-rebbe possibile, con o a partire da Benjamin, immaginare qualcosa come degli oggettipop che non siano né dei semplici oggetti, né determinati dal rinvio, anche implicito, alconcetto così problematico di “popolo”? Bisognerebbe, per rispondere, riprendere cer-ti passaggi benjaminiani che ho già evocato in Tormentoni (p. 21), in particolare il fram-mento postumo del 1929 intitolato Alcune idee sull’arte popolare, che si conclude conquesta annotazione: “L’arte popolare e il kitsch ci permettono di vedere a partire dallecose”. A partire da qui, bisognerebbe forse reinterrogare la Cosa rileggendo Heidegger.E questa rilettura dovrebbe incrociare, in modo critico, i lavori di Graham Harman e dialtri autori, che rivendicano una filosofia “oggetto-orientata” (objected oriented philo-sophy). Questioni aperte, che eccedono il quadro di una nota a piè di pagina già troppolunga…
messaggio, è perché vale di per sé, come culto del culto che è.E, in questo senso, deve essere permanente, bisogna praticarlogiorno e notte, Working Day and Night, come canta Michael nel-l’album Off The Wall. Questo culto che rinvia solo a sé14, que-sto culto immanente a se stesso, è dunque la celebrazione delmistero del this is it. È così, sì, quello che celebriamo nel capi-talismo non è nient’altro che ciò che celebriamo, this is it, è co-sì, and when I say this is it, e quando dico che è così, it reallymeans this is it, vuole dire che è davvero così.
Culto del culto, dunque, che perciò non può smettere di ce-lebrarsi, ancora e ancora, sempre più, don’t stop, keep the faith,don’t stop ’til you get enough.
Tuttavia, per questo culto, Benjamin sembra indicare unafine, un termine. Fine senza fine o termine senza termine, che èla sua terza caratteristica: il culto capitalista del culto capitalista,nella sua autocelebrazione permanente, mirerebbe all’universa-lizzazione di quel che Benjamin, in tedesco, chiama Schuld. Dif-ficile da tradurre in una parola questa parola che dice al con-tempo, indissociabilmente, la colpa e il debito, in senso econo-mico:
In terzo luogo questo culto è indebitante [verschuldend]. Il capitalismoè probabilmente il primo esempio di un culto che non è espiatorio ma in-debitante. […] Una coscienza mostruosamente indebitata [ein ungeheu-res Schuldbewusstsein], che non sa espiare, si appropria del culto, nonper espiare attraverso di esso questo debito, ma per renderlo universale[…] e, infine e soprattutto, per implicare Dio in questo debito… È nel-l’essenza di questo movimento religioso che è il capitalismo perseverarefino alla fine, fino al completo indebitamento finale di Dio [die endlichevöllige Verschuldung Gottes].
Pop Music !%)
14. Come scrive Sam Weber in Benjamin’s –abilities (p. 254): “Il capitalismo por-ta il culto all’estremo […] lasciando che diventi la propria fotte di signifcato, cioè do-tandolo di una certa autoomia”.
Il dio di cui il capitalismo celebra il culto è così, in fin deiconti, l’indebitamento stesso. Dio, completamente indebitato,diventa il Debito – viceversa. Quanto a Michael, sarà stato, senon proprio questo Dio-Debito, almeno il suo arcangelo, l’ar-cangelo dello scambio che, multimilionario, ammucchiandoprofitti come nessuno, ha tuttavia accumulato un debito abissa-le, che sembrava crescere di pari passo con la sua ricchezza15.Tra i processi che l’hanno visto sotto accusa e il suo indebita-mento smisurato, i due valori del Schuld benjaminiano sono in-distinguibili nella passione pop di Michael, al contempo colpe-vole e debitore.
Ciò che occorre forse comprendere, nell’enigmatico fram-mento di Benjamin, è che la fine del culto capitalista è il divenir-debito della divinità stessa. L’orizzonte o lo scopo di questo cul-to, che non è il culto di nient’altro che se stesso, sarebbe così lapura struttura differita, fiduciaria, del credito infinito e del de-bito infinito.
Ed è per questo che il dio di questo culto, dice Benjamin ag-giungendo una quarta caratteristica alle tre che aveva annuncia-to, “deve essere nascosto”, conservato in segreto (verheimlicht).Non si deve sapere, non ci si deve poter rivolgere a un dio di-ventato debito, indebitato da parte a parte. Non ci si deve poterrivolgere a lui, votargli un culto in quanto tale, in quanto debi-to. Perché un Dio-Debito non può stabilizzarsi, porsi come tale– può solo essere rimesso a più tardi, indefinitamente, può solo
Pop filosofia!&*
15. Uno dei suoi biografi (C. NEWKEY-BURDEN, Michael Jackson, p. 183) scrive:“Una delle maggiori sorprese degli ultimi anni di Michael fu come lo show man con piùsuccesso di sempre, che ha venduto 750 milioni di dischi, poté ritrovarsi con un debitocolossale. Come è potuto succedere? La storia comincò a chairirsi durante il suo pro-cesso del 2005, in cui i suoi accusatori lo descrissero come uno drogato delle spese conabitudini da miliardario ma con un budget milionario. Per decenni, le sue spese hannosuperato le entrate, e un conto rese evidente che il suo deficit annuale superava i 30 mi-lioni di dollari”.
essere debitore nei confronti di se stesso. Ha bisogno, all’infini-to, di altri volti, come il Re del pop.
Se Michael sia stato l’incarnazione cristica di un tale dio,non lo si può sapere. Tutt’al più si può pensare che ne sia statol’arcangelo, l’angelo o un qualche ministro celeste.
Quel che è sicuro è che gli dobbiamo molto.Il nostro debito è infinito, come lo fu il suo – un debito ca-
pitale.
*
A una domanda imbarazzante che gli rivolgeva Oprah Win-frey nell’intervista televisiva del 1993, Michael aveva risposto:Ask the music.
E quello che abbiamo fatto.E lei ci ha risposto: keep the faith, don’t stop, this is it.
Pop Music !&!
#%* Pop filosofia
Bibliografia
AA. VV., Matrix, machine philosophique, Paris, Ellipses, 2003.AA. VV., Fresch Théorie, Paris, Léo Scheer, 2005.ADORNO, T.W., HORKHEIMER, M., Dialettica dell’illuminismo, trad. it., Torino, Einaudi,
2008.AGAMBEN, G., Mezzi senza fine. Note sulla politica, Torino, Bollati Boringhieri, 1996.AGAMBEN, G., Il Regno e la gloria, Milano, Neri Pozza, 2007. AGAMBEN G., Nudità, Nottetempo, Roma 2009. AGOSTINO D’IPPONA, Confessioni, trad. it., Milano, Mondadori, 1989.BADIOU, A., Le Siècle, Paris, Seuil, 2005. BARTHES, R., Miti d’oggi, Torino, Einaudi, 2007.BARTHES R., Frammenti di un discorso amoroso, trad. it., Torino, Einaudi, 1979.BATAILLE G., L’erotismo, trad. it., Milano, Mondadori, 1969.BAUDRILLARD J., La società dei consumi, trad. it., Bologna, il Mulino, 1976.BAUDRILLARD J., Della seduzione, trad. it., Milano, SE, 1997. BAUMAN, Z., La solitudine del cittadino globale, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2000.BAUMAN Z., Amore Liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi, trad. it., Roma-Bari, La-
terza, 2004.BENAJMIN, W., Fragmente, in Gesammelte Schriften, VI, Frankfurt am Main, Suhrkamp,
1985.BENJAMIN, W., Angelus Novus, trad. it., Torino, Einaudi, 1995.BENJAMIN, W., Opere complete. Vol. VII. Scritti 1938-1940, trad. it., Torino, Einaudi,
2006. BLANQUI, L.A., L’eternità attraverso gli astri, trad. it., Roma-Napoli, Theoria, 1983.BORGES J.L., Storia dell’eternità, trad. it., Milano, Adelphi, 1997.CACCIARI, M., L’Angelo necessario, Milano, Adelphi, 1992.CAMILLERI, A., La presa di Macallè, Palermo, Sellerio, 2003.CAMPBELL, J., Erotic Irony and Mythic Forms in the Art of Thomas Mann, Mill Valley,
Robert Briggs Associates, 1991.CAMPBELL, J., Il potere del mito, trad. it., Milano, TEA, 1994.CAMUS, A., Il mito di Sisifo, trad. it., Milano, Bompiani, 2001.CAMUS, A., L’Uomo in rivolta, trad. it., Milano, Bompiani, 2005.CAMUS, A., Mi rivolto dunque siamo, trad. it., Milano, Eleuthera, 2008.CARACO, A., Breviario del caos, trad. it., Milano, Adelphi, 1998.
#%!Bibliografia
CARANDINI, A., Archeologia del mito. Emozione e ragione fra primitivi e moderni, Tori-no, Einaudi, 2002
CERONETTI, G. (a cura di), Qohélet o l’Ecclesiaste, Torino, Einaudi, 1998.CESARANO, G., COPPO, P., FALLISI, J., “Cronaca di un ballo mascherato”, in Antasofia 4.
Lampi di critica radicale, a cura di Antasofia, Milano, Mimesis, 2005.CHANDLER, D. GRIFFITHS, M. Who is the Fairest of Them All? Gendered Readings of Big
Brother UK, in E. MATHIJS, J. JONES (eds.) Big Brother International: Formats, Cri-tics and Publics, London-New York, Wallflower, 2004.
CIORAN, E.M., Il funesto demiurgo, trad. it., Milano, Adelphi, 1986. CIORAN, E.M., La caduta nel tempo, trad. it., Milano, Adelphi, 1999.CIORAN, E.M., L’inconveniente di essere nati, trad. it., Milano, Adelphi, 1999.DAGERMAN, S., Il nostro bisogno di consolazione, trad. it., Milano, Iperborea, 1991.DE CATALDO, G., Romanzo criminale, Torino, Einaudi, 2002. DELEUZE, G., Pourparler, trad. it., Macerata, Quodlibet, 2000.DELEUZE, G., L’île déserte et autres textes, Paris, Minuit, 2002.DELEUZE, G. Che cos’è l’atto di creazione?, trad. it., Napoli, Cronopio, 2003. DELEUZE, G., GUATTARI, F., Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, trad. it., Roma, Ca-
stelvecchi, 1997.DELEUZE G., PARNET, C., Conversazioni, trad. it., Verona, ombre corte, 2006.DE PASCALE, G., Wu Ming. Non soltanto una band di scrittori, Genova, il melangolo,
2009. DERRIDA, J. Della Grammatologia, trad. it., Milano, Jaca Book, 1969.DERRIDA, J., Politiche dell’amicizia, trad. it., Milano, Cortina, 1995.DERIDDA J., Ciò che resta del fuoco, trad. it., Milano, SE, 2000.DERRIDA, J., Adesso l’architettura, trad. it., Milano, Scheiwiller, 2008.ECO, U., Postille a Il nome della rosa, Bompiani, Milano, 2000. EISNER, W. / MILLER F., Conversazione sul fumetto, trad. it., Bologna, Kappa Edizioni,
2005. ENSLER E., Monologhi della vagina, trad. it., Milano, il Saggiatore, 2008.ERODOTO, Le storie, trad. it., Torino, UTET, 2006, 2. voll. ESCHILO, Persiani – Sette contro Tebe – Supplici, Milano, Rizzoli Bur, 1987. FARASSINO, A., Scritti strabici. Cinema 1975-1988, Milano, Baldini e Castoldi, 1984. FOUCAULT, M., Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello...
Un caso di parricidio del XIX secolo, Torino, Einaudi, 1978.FOUCAULT, M., Sorvegliare e punire. La nascita della prigione, trad. it., Torino, Einaudi,
1993.FOUCAULT, M., Storia della sessualità. Vol. 1. La volontà di sapere, trad. it., Milano, Fel-
trinelli, 2001.FOUCAULT M., Storia della sessualità. Vol. 2. L’uso dei piaceri, trad. it. Milano, Feltrinel-
li, 2002.FOUCAULT M., Storia della sessualità. Vol. 3. La cura di sé, trad. it. Milano, Feltrinelli,
2002.FOUCAULT, M., Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), trad. it.,
Milano, Feltrinelli, 2005. GENETTE, G., Soglie. I dintorni del testo, trad. it., Torino, Einaudi, 1989.
GOODY, J., Jade. My Autobiography, London, HarperCollins, 2006.GOODY, J., Jade. Catch a Falling Star, London, John Blake, 2008.GOODY, J., Jade. Forever in My Heart – The Story of My Battle Against Cancer, London,
HarperCollins, 2009.GOODY, J., Jade. How It All Began, London, John Blake, 2009.GOODY, J., Jade. Fighting to the End. My Autobiography 1981-2009, London, John
Blake, 2009.GRASSO A., Buona maestra. Perché i telefilm sono diventati più importanti dei libri e del
cinema, Milano, Mondadori 2007.HARDT, M., NEGRI, T., Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, trad. it., Milano,
Rizzoli, 2002.HEIDEGGER, M., Essere e Tempo, trad. it., Milano, Longanesi, 1976.HEIDEGGER, M., Chi è lo Zarathustra di Nietzsche, in Saggi e discorsi, trad. it., Milano,
Mursia, 1991. HEIDEGGER, M., Che cosa significa pensare? trad. it., Milano, Sugarco, 1996.HUME, D., Dialoghi sulla religione naturale, trad. it., Torino, Einaudi, 1997.HUXLEY, A., Il mondo nuovo. Ritorno al mondo nuovo, trad. it., Milano, Mondadori, 1991.JACKSON, M., Moonwalk, William Heinemann, 2009.JAMESON, F., Firme del visibile. Hitchcock, Kubrick, Antonioni, Roma, Donzelli, 2003. KANT, I., Critica della ragion pratica, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 1997.KIERKEGAARD, S., Il diario del seduttore, trad. it., Milano, Rizzoli, 1990.KIPNIS J., LEESER, TH. (eds.), Derrida Eisenman. Chora L Works, New York, Monacelli
Press, 1997LACAN, J. Il seminario, libro VII. L’etica della psicoanalisi (1959-1960), trad. it., Torino,
Einaudi, 1994. LA POLLA, F. Sam Peckinpah. Il ritmo della violenza, Genova, Le Mani, 2006.LÉVI-STRAUSS, C., Tristi tropici, trad. it, Milano, Il Saggiatore, 1996.MAINES, R.P., Tecnologia dell’orgasmo. Isteria, vibratori e soddisfazione sessuale delle
donne, trad. it., Venezia, Marsilio, 2001.MOSSE, G.L., La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di mas-
sa in Germania (1815-1933), trad. it., Bologna, Il Mulino, 1975.MOSSE, G.L., Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, trad. it., Roma-Bari,
Laterza, 1990.MOSSE, G.L., L’uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste, trad. it., Roma-Bari, Later-
za, 1999.MARCO AURELIO, Pensieri, trad. it., Milano, Mondadori, 1996.MARCUSE, H., Eros e civiltà, Torino, Einaudi, 2001.MARX, K., Il Capitale. Vol 1, trad. it., Roma, Editori Riuniti, 2006. NANCY J.-L., Il “c’è” del rapporto sessuale, trad. it., SE, Milano 2000.NEWKEY-BURDEN, C., Michael Jackson. Legend 1958-2009, London, Michael O’Mara
Books Limited, 2009,NIETZSCHE, F., Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, trad. it., Milano,
Adelphi, 1992.NIETZSCHE, F., Sull’utilità e il danno della storia per la vita, trad. it., Milano, Adelphi,
1974.
Pop filosofia#%#
ONFRAY, M., Teoria del corpo amoroso, trad. it., Roma, Fazi, 2006.PACKARD, V., I persuasori occulti, trad. it., Torino, Einaudi, 2008.PASOLINI, P.P., Il caos, Roma, l’Unità/Editori Riuniti, 1991.PASOLINI, P.P., Petrolio, Torino, Einaudi, 1992.PLUTARCO, Le vite di Licurgo e di Numa, trad. it., Milano, Mondadori, 1980. PLATONE, Opere complete. Vol. 5. Protagora, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2003.PLATONE, Opere complete. Vol. 6. Timeo, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2003.QUINTILIANO, Istituzioni oratorie, trad. it., Torino, Einaudi, 2001. RABBANO MAURO (780?- 865), In honorem sanctae Crvcis, PL 107, Coll. 133-293, ed. M.
Perrin, Turnhout 1997.RITZER G., Il mondo alla McDonald’s, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1997.RONELL A., Giornale di una tossicofilomaniaca, trad. it., Genova, il melangolo, 2008. RUSSELL, B., An inquiry into meaning and truth, London, G. Allen and Unwin LTD,
1951.SARTRE, J-P., L’Essere e il Nulla, trad. it., Milano, Il Saggiatore, 1967.SAVTER, F., Cioran, un angelo sterminatore, trad. it., Piacenza, Frassinelli, 1998.SHELL, M., Art and Money, Chicago, University of Chicago Press, 1995SCHOPENHAUER, A., Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. it., Milano, Mursia,
1969.SCHOPENHAUER, A., Parerga e paralipomena, trad. it., Milano, Adelphi, 1999.SLOTKIN, R., Gunfighter Nation. The Myth of the Frontier in Twentieth-Century Ameri-
ca, Norman, University of Oklahoma Press, 1998. TAYLOR, M. C., Confidence Games. Money and Markets in a World Without Redemption,
Chicago, University of Chicago Press, 2004,SLOTERDIJK, P. Sfere I. Bolle, trad. it., Meltemi, Roma 2009.SLOTKIN, R. Gunfighter Nation. The Myth of the Frontier in Twentieth-Century Ameri-
ca, Norman, Univerity of Oklahoma Press, 1998.SZENDY, P., Tormentoni! La filosofia nel juke-box, trad. it., Milano, Isbn, 2009.TAYLOR, M.C., Il momento della complessità. L’emergere di una cultura a rete, trad. it.,
Torino, Codice, 2005. VICO, G.B., La scienza nuova, Milano, Rizzoli BUR, 1996.VIRNO, P., Grammatica della moltitudine. Per un’analisi delle forme di vita contempora-
nee, Roma, DeriveApprodi, 2002.WEBER, M., L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, trad. it., Firenze, Sansoni,
1970.WEBER, S., Benjamin’s -abilities, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2008.WITTGENSTEIN, L., Tractatus logico-philosophicus, trad. it., Torino, Einaudi, 1995.WOLFE, T., Il falò delle vanità, trad. it., Milano, Mondadori, 1988.WU MING, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Torino, Ei-
naudi, 2009.!I!EK, S., Il Grande Altro. Nazionalismo, godimento, cultura di massa, trad. it., Milano,
Feltrinelli, 1999.
Bibliografia #%$
Indice
Prologo
0. Crossover(Per una filosofia popular)Simone Regazzoni
Anime
1. Neon Genesis Evangelion(Un anime per tutti e per nessuno)Jadel Andreetto
Cinema
2. 300(Allegoria e guerra)Wu Ming 1
3. Il mucchio selvaggio(Viaggio al termine dell’eroismo western)Simone Regazzoni
Graphic novel
4. Watchmen(Il triste tropico del dottor Manhattan)Girolamo De Michele
5. Asterios Polyp(Mitografie della decostruzione)Francesco Vitale
Pop Music
6. This is it (The King of Pop)Peter Szendy
Romanzo
7. Romanzo Criminale(La produzione di storia e l’esistenza dell’Italia)Lorenzo Fabbri
Televisione
8. Mad man (L’esposizione del pensiero)Tommaso Ariemma
9. Grande Fratello(Le due morti di Jade Goody)Giulio Itzcovich
10. The King(Il regno ® è infetto)Laura Odello
11. Sex and the City(Indizi per un’erotica contemporanea) Francesca R. Recchia Luciani
Autoritratti d’autore
Bibliografia