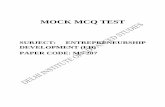THEOG. 207-210: UN CASO DI PROLESSI NARRATIVA
Transcript of THEOG. 207-210: UN CASO DI PROLESSI NARRATIVA
THEOG. 207-210: tIN CASO DI PROLESSI NARRATIVA
Terminata la lunga e particolareggiata narrazione della nascita di Afrodite daigenitali di Urano, recisi e gettati in mare da Crono, esecutore del òo),og orditoda Gaia (Theog. 159-L82), Esiodo completa il racconto concernente le vicende delprimo nreu degli dei, IJrano, chiudendo 'ad anello' la sezione teogonica in questione(Theog. 154-210) con la menzione di Urano medesimo, perso di vista nel corso della
descrizione della nascita di Afrodite, e dell'ultima 'azione' da lui compiuta autono-mamente (t), cioè l'attribuzione di una epiclesi ai figli che egli stesso a'veva generato:
Touq Eà naclp Trtflvoq ènírl,qorv Kc,}.ésoKtnoîòaq verKeíov péyaq Oúpovoq oùq térev aótog'qúore òè trtoívovroq &tooOal"íq péyo ité\utépyov, roîo ò' énerru ríorv perónro0ev éoeo0ar.
Di questi versi, in generale, ciò che ha maggiormente attirato I'interesse dellacritica, e che è tuttora oggetto di discussione, è la possibile connessione etimologicatra il participio rtrCI,ívovîeg e il nome Trtflveg (z), nonché il significato di tale
connessione. La ben nota tendenza esiodea a riflettere sulla capacità degli strumentiespressivi, a disposizione del poeta, di dare forma esattamente alla realtà delle cose,
1t; Da quesro momento in poi, infatd, lJrano non compie personalmente alcuna azione, ma affianca
Gaia nell'importante funzione di dare consigli al fine della realizzazione di quanto stabilito dal fato: cfr. a ri-guardo Theog. 463-465 e 470-476 (su cui infra pp.2Ù-22), e ancora w.888-893.
1z) Tra i tanti studiosi che si sono occupati del problema ricordiamo in particolare: H.J. Linghor, Die
Bedeunng der etymologischen Namenserhkrungen in dzn bedichten Homers und Hesiods und in den homerischen
Hymnm, Berlin (Diss.) 1954, pp.lÙ7 e 133-134; M.L.'$7est, Hesiod. Theogony, Edited with Prolegomena
and Commentary by M.L.\?., Oxford 1966, spec. pp. 225-226; Y. Duhoux, Le caractère dzs Titans. A propos
dune oEtyrnologie, Hésiodiqur- in oRecherches de Philologie et de Linguistique,,,I (1967), pp.35-46; P. Chan-
traine, Dictionnaire Etymologique de k hnguz grecque,Il,Parigi 1968 (s. a. Trtdveq); A. Colonna (a cura di),
Opere di Esiodo, Torino 1977, pp.72-73 n. t6; J. M. Duban, Hesiod.\ Titain Etymologt Reuiew ed. IL Theo-
goryt, 207-21Q in uAevum,52 (1978) pp.43-44; G. furigheni, Poeti, eruditi e biograf. Momenti delk ifles'sione dei Greci sullz lztteraturq Biblioteca di Srudi Antichi 52, Pisa L987, p.27; Id., Esiodo. Opere (testi in-trodotti, tradotti e commentati da G. Arrighetti), Torino 1998, pp.332-333. A questi ed altri saggi critici si
farà riferimento in maniera più specifica nel corso della discussione. Per il momento va sottolineato che alcuni
degli studiosi citati, sulla falsariga della interpretazione degli antichi testimoniata dallo scolio a Theog.2O9,
coinvolgono nell'analisi etimologica del nome Trtflveg anche il termine tíotq, menzionato al v.210; così
infatti leggiamo in L. Di Gregorio (rec.), Scholia aetera in Hesiodi Theogoniarn Milano 1975, p.43: r;'caívov-
roq' dorv roì opopíov î,apBúvovto.q; siffatta interpretazione attribuisce al verbo ntcíverv il significato
di vendicare-punire, e ai Titani il ruolo di vendicatori, specificatamente, di Gaia per le colpe commesse nei
suoi confronti da Urano (cfr. anche Hesych., s. z. Trtfiveg: nporpoí, &nò toú trtcíverv; e I'inno orfico
citato in Athenagoras, IIepì Xpwrtavúv 18 (p.21, 1.7 Schwaru) in cui I'epiclesi Trtfrveq è così giustificata:
oúvera reroúoOqv pÉyav Oúpavov &otepóevta). Nell'ambito della presente ricerca si osserverà che di
fatto il termine tíorq ha un suo spazio ben preciso nella etimologia del nome Trtflvtq, ma in modo e
per ragioni differenti rispetto a quanto si può desumere dallo scolio.
-16-
la conseguente tendenza a rendere etimologicamente perspicui i significanti, sì da
raggiungere una perfetta, o quasi perfetta, identificazione con i significati (a), tuttoquesro ha indotto gli studiosi ad individuare nel verbo Ttrc,ívco una intenziondeetimologia per Trtfrveq. Superata, in qualche modo, la difficoltà prosodica che sif-
fatta connessione comporta(<), l'attenzione si è focalizzata sulla relazione semantica
tra i due termini allo scopo di stabilire a quale realtà, a qude aspetto del mondo
descritto da Esiodo, o a quale fase della complessa storia teogonica e cosmogonica,
che sta prendendo forma nel poema esiodeo, alluda significativamente il nome dato
da Urano'ai suoi figli (5).
Il verbo TtîCI,íVo, da cui si fa derivare il nome Trt{veq (u), h", fondamental-
menre, il significato di ntendere, stendereo (z); in quanto transitivo, inevitabilmente
(3) Ricca la bibliografia relativa a questa caratteristica dell'opera esiodea: ricordiamo, in particolare,
Linghor, op. cit.,p. 103 ss.; D. Gambarara, Alle fonti dtllaflosofa dcl lingudggio. 'Lingua'e 'Nomi'nelh cubura
greca arcaic4 Roma 1984, spec. pp. 130-135; Arrighetti, Poeti cít., pp.22-36 (con relativa bibliografia); furi-ghetti, Esioda cir., pp. )O(I-)CfiII. Del resto, anto le etimologie dei nomi nella Teogonit qtanro il gusto di
spiegare il significato delle parole o di creare nuove parole motivandone il significato, rispondono pienamente
a quell'impegno di poesia veritiera che Esiodo assume in occasione della sua consacrazione a Poeta nell'incon-
tro con le Muse sull'Elicona (cfr. Theog.,20-35; ma cfr. anche Er.9-10): I'esigenza di verità, infatti, induce
Esiodo alla scelta di un linguaggio (nomi compresi) che esprima effettivamente la redtà indicata sì da renderla
rrasparenre all'ascoltatore (su tale aspetto della poesia esiodea, cfr. anche G. furighetti, Esioda e h Muse: il dpno
dzth uqità e k conqaista delk parola" in oAthenaeum, 80 (1992), sPec. PP. 52-59)-
1+) Ladifficoltà prosodica che rende, in qualche modo, arbitrario I'accostamento Tttfrveq-trtoívar è
costituita dalla diversa quantià della sillaba iniziale di ciascun termine: nell'epiclesi tr è di quantità lunga,
menrre nel verbo, come in tutri i verbi raddoppiati al presente, tr è di quantità breve. Esiodo -
[a11qe s5-
servaro quanti si sono occupati della question e (cfr. supra n.2) -
pare non abbia awertito alcuna difficoltà nel
considerare lunga anche la sillaba rr del verbo, onde istituire la connessione tra epiclesi e verbo, di cui qui si
discute. Trattasi, quesro, di uno dei numerosi interventi che il poeta ha compiuto sulle forme espressive rra-
dizionali a vantaggio di contenuti nuovi, interventi che si collocano in quella operazione di riflessione lingui-
stica, cui si è già acc€nnaro. Un intervento simile che concerne la struttura prosodica della parola si può os-
servare, ad esempio, in Theog. 15, su cui cfr. G.P. Edwards, The Langaage of Hesiod in its Traditional Context,
Publications of the Philologicd Society )O(I, Oxford 1971, pp.101-102.(5) Come puntualizzeremo nel seguito dell'esposizione, è caratteristica riconosciuta di Esiodo procede-
re alla descrizione del mondo divino e fisico attraverso costruzioni genealogiche costituite da endtà il cui nome
trova la sua motivazione nelle realtà e negli aspetti che di quel mondo esso esprime. Per questa ragione, gli
elenchi di nomi che costituiscono l'impalcatura dell'opera testimoniano della riflessione esiodea linguistico-
concettuale, cui si è sopra accennato (cfr. supran.3) e su cui torneremo a parlare (cfr. infann.6 e l7).(6) Ma contrq Duhoux, art. cit., spec. pp. 43-45: diversamente questo studioso ritiene che sia il verbo a
derivare dal nome, secondo un processo paretimologico che definisce ad.norninatio.Il verbo îltoívo, dunque,
si formerebbe dal nome trróv con l'aggiunta di un sufisso in jod: trtÓvjco > tttcívro. Il significato del verbo
così formatosi, secondo lo studioso, sarebbe di per sé incomprensibile se non messo in raPPorto al sostantivo
da cui è derivato, per cui orcívco significherà ufare il Titanou (proprio come - aggiunge lo studioso -
ttol-poívco < norprlv + j significa nfare il pastoreu). Da qui una diversa interpretazione dei w. 207'210 Per una
diversa soluzione delle problematiche ad essi annesse: nMais le grand Ouranos, leur père, les injuriant, donnait
arx enfants qu'il avait engendrés le surnom de Titans; et il leur disait qu'en faisant le Titan ils avaient commis
avec un fol orgueil un crime grave dont I'avenir saurait les punir, (cfr. Duhoux , art. cit., P. 43). Duhoux am-
_17_
si awerte il bisogno di un complemento che lo precisi e la mancanza di quest'ultimo
è stata in qualche modo superata con varie soluzioni (0. Cosicché, alcuni intendo-
no: ntendeie le braccia> (r); altri (ro); (tendere le mani>; altri ancora, con valore ri'flessivo (rr): <sforzarsi, tendersi,r. Sulla base di tali proposte la traduzione dei versi
sopra citati è, per la maggior Parte degli studiosi, la seguente:
Costoro dunque, suoi figli, il padre li chiamò Titani,per odio, il grande (Jrano, loro che, Pure, generò lui stesso;
e diceva che tendendo con tÍacotanza le braccia avevano
commesso un grande
misfatto, del quale avrebbero dopo scontata la pena(tz).
mette che non si può comprendere pienamente cosa si intendesse per ufare il Titanoo, e quale realtà, dunque,
fosse implicita nel nome stesso di nTitanou, ma ritiene che doveva essere chiaramente wocativo per i Greci del
rempo sì da permettere ad Esiodo di trdasciare ulteriori spiegazioni. Proprio per questo, come soPra detto, lo
studioso ritiene che ciò che lega ntcívo e Trtfrveq non sia una vera etimologia, bensì un procedimento ap-
parent€mente etimologico ma sostanzidmente diverso (Ia ad.nominatz'o), consistente in un accostamento di
due o più parole tra loro unite dalla coscienza del soggetto parlante, il quale rendendosi conto di trovarsi da-
vanti a termini del tutto perspicui nel loro significato e nella loro relazione, rePuta inudle insistere con spie-
gazioni. Per quel che concerne Esiodo, è evidente che tale interpretazione è in netto contrasto con il modo di
operare del poeta cui sopra si è accennato (cfr. supra nn.3 e 5): nomi, aggettivazioni, connessioni etimologi-
che, neologismi erc. sono frutto di una intenzionale attività di riflessione sulla redtà e sui modi di esprimerla
in maniera veritiera (rispetro ai casi cosiddetti di paretimologia, considerati da Duhoux, art. cit. pp.44-46, ma
da noi reputati come esempio di 'vera' riflessione linguistica; oltre la bibliografia sopra citata, cfr. ancora P.
Friedliinder Das Proiirnium uon Hesiods Theogonie, in nHermes> 49 (1914), pp. 1-16, rist. in E' Heitsch, .É/r-
siod, Darmstadt 1966, pp.277-294; E. Risch, Namensdeutungen und Vorterhlnrungen bei dcn àbesten griechi'
schm Dichtern, in EUMUSIA. Festgabe ftir E. Howald, Zurich 1947, pp.72-91; in panicolare per ciò che
concerne le Opere e Giorni '$7. J. Verdenius, A Commentar! on Hesiod V(orhs and Dalts, au. I-382, uMnemo-
syneo Suppl. 86, kiden 1985, Index of subjects, s.v. etymologizing.; in generale, sulla questione delle etimo-
logie, ancora: I. Sellschopp, Stilistische (Jntersucbungen zu Hesiod, Diss. HamburgL934, Nachdruck Darm-
stadt 1966, pp.18-41 e passim.
(z) Cfr. LSJ, s. u. rttaívto: (stretch, stretch outn.
(a) Per una buona esemplificazione della varie soluzioni proposte a riguardo, cfr. Dohoux, art. cit.,
spec. pp.4I-42.(9) Così, ad esempio, P. Mazon, Hésiodz. Théogonie, Les Trdaauc et les Jours, Le Bouclien Paris i 928,
p.39;D. Ferranre, Irnmagini etimobgiche nei poeti greci dett'eù ionico-atticu in nRendiconti dell'Ist. Lombardo
di Scienze e Lefiere, Classe di Lettere e Scienze Morali e Storicheo 99 (1965), p.456; G. Auighetti, Esiodn,
Teogonia Milano 1984, p.77 ma diversamente in Arrighetti, Esioda cit., p.ta (cfr' anche cornm. ad loc.'
pp.lZZ-llZ), il verbo è stato reso in senso assoluto con nosandou e inteso come reggente l'infinito péfcr
.he, g.rr.ol*enre, viene fatto dipendere dal verbo góore; qui di seguito la nuova traduzione suggerita da
furighetti: oCosroro, dunque, suoi figli, il padre li chiamò Titani I per odio, il grande LJrano, loro che, pure,
gene.ò lui stesso I e diceva che osando, con tracotanza, commettere un grande I misfatto, di questo, dopo,
avrebbero sconraro la penao; cfr, ancoraColonna, op. cit., p.73, che rende trto,ívovroq ncol tendere troPPo).
1to) Così, ad esempio, West, 42. cit., p.226.(rl) Tra gli altri, H.G. Evelvn \7hite, Hesiod. The Homeric Hymns and Homerict (with an English
translation) London and Cambridge, 1936 (2 ed.), p.85.(r2) Diversamente, come sopra deffo, intende Duhoux (cÎr. supra n-6)'
_18-
A questo punro, si è, naturalmente, presentato il problema del significato di
quesra azione dei figli di Urano - 66p5istente nel ntendere le braccio (ta) - e
del nome che, di conseguenza, essi hanno ricevuto.
La critica è pressoché concorde nel rinvenire nel gesto dei Titani una allusione
all'affronto perperrato ai danni di Urano, su ispirazione di Gaia, di cui si narra poco
prima: cioè, I'evirazione del dio e la conseguente detronizzazione (cfr. Theog., L60'
l82a)(r+). Traffasi di una vicenda che si connota come útoo0ol"í0, cioè come
usciocca presunzione, (tt), quale è quella che ha portato le divinità in questione
ad assumere aneggiamenti di intollerabile arcoganza, a macchiarsi, quindi, di
tipprq 1re). Il loro nome, pertanto, recherebbe in sé traccia dell'azione che più par-
ticolarmente risulta condizionare ed incidere sulla loro esistenza (tz). Dati questi
presupposti, da un punto di vista puramente narrativo, è evidenrc che la connessio-
ne Tl1c,ívoweq-Trrfrveq implica una sorta di analessi narrativa, cioè uno (sPosta-
mento all'indieuo> (re; rispetto al tempo del racconto primario.
1rr; Onde scaturirebbe il péyo Épyov accennato in Theog.209-210a (cfr. anche infa n'I5).(14) La detronizz=*:rone di Urano
- che awiene in realtà per opera di Crono, effettivo esecutore del
6ói,o6 @fr. infa n. 16) -,
non è esplicitamente espressa nella narrazione esiodea, ma l'atto di evirazione si
lascia chiaramente intendere anche come atto di deposizione di Urano dalla sua dignità regale (cfr., inoltre,
infa n. LG).
1rl) Nel brano esiodeo, il termine &taoOol"ío @fr. Theog.209), precisa, significativamente, il ngrande
misfattoo (péya épyov) compiuto dai Titani, con il loro tttoívovteq, assolvendo ad una funzione logica
oscillante, pare, rra il complemento di modo e quello di causa, entrambi esprimibili, nella lingua greca, nel
caso dativo.
1re) È pur vero che di fatto l'azione (tracotante) è compiuta solo da Crono, ma -
a Parere dei più -I'acquiescenza degli altri figli di Gaia, manifestatasi attraverso il silenzio, li renderebbe altrettanto colpwoli e
meritevoli del titolo Trrfrveq: cfr. a riguardo, in particolare, J.-U. Schmidt, Die Aufrichung der Zeashenrchaft
ak Modett - {Jberlegungen zur Theogonie dts Hesiod, I, in n'\ù(/ùrzburger Jahrbùcher frir die Altertumswissen-
schafto Neue Folge 14 (1988), spec. PP' 54-69.(rf Quesra è una caratteristica propria dei nomi e delle epiclesi esiodei, caratteristica che tradisce una
sorvegliata volontà del poeta nell'adattare, il più possibile, la lingua alle realtà da essa designate (cfr- supra
nn.3,5,6 e la bibliografia ivi citata). La Teogoni4 nel suo complesso articolato di nomi ed epiclesi, è uno
d.ei frutti, forse il più grande, di un simile sforzo. Spesso i nomi e le epiclesi risultano invenzione esiodea anche
se fondati su una tradizione che riconosceva, alle entità da denominare di volta in volta, caratteristiche che
Esiodo concretizzain nomi o da cui prende spunto per motivare i suoi nomi: tde, ad esempio, è il caso delle
Muse (Theog.,77-79), costituente una delle prove più vistose dell'attenta riflessione linguistica esiodea (su cui
cfr. Linghor, op. cit., pp. 125-130; più recentemente, H. Podbielski, Der Dichter and die Musen im Prooimion
drr hes;idz;schen Tbeogonie, in uEoso 82 (1994) pp. 173-188, spec. pp. I85-I87, con reladva bibliografia); e,
come vedremo, in maniera simile Esiodo si è comportato nel caso dei Titani (cfr. infran.44).In generale,
circa I'imponanza ed il significato dell'atto dell'imposizione del nome, cfr. G.R Cardona, Introduzione allbt'
nolinguistica Bologna 1976, p.133 ss. e Intoduzione allz sociolingaisticqToríno L987, p.79 ss.
(1s) Per una simile definizione, cfr. Massimo Fusillo, Il tempo fullt Argonautiche. Un'analisi del racconto
in Apollanio Rodio, Roma 1985, p. 24. Alquanto numerosi risultano gli studi di tecnica narrativa delle com-
posizioni poetiche antiche, specificatamente del genere epico, in cui termini e concetti come 'analessi' o 'pro-
l.rri' ,orro, ormai, di uso comune: per indicazioni bibliografiche in generale e in riferimento ad Esiodo, cfr.
_19_
Ma c'è ancora dell'altro. Urano non si limiterebbe a fornire una epiclesi ai suoi
figli, quasi a ricordo dell'azione che li oha macchiati, per semPre, in confor-
-ità " quella che sarà, da questo momento in poi, Ia sua funzione essenziale - for-
nisce una ulteriore informazione; toîo E' 'énemu tíorv lrtrofilo0ev éoeCI'0ur. ITitani, dunque, non impunemente hanno compiuto il loro ugrande misfattoo,
ma di esso (otoîoo) pagheranno in seguito il fio (ocíorqr). E stato osservato (tr)
che il termine che designa la futura punizione prevista per i Titani, cioè tíorq, e
il verbo da cui deriverebbe il nome delle divinità in questione, cioè rtro,ívcù, risul-
tano in qualche modo connessi da un punto di vista sia fonico che grafico, € -
tenuro conro dell'operazione esiodea di riflessione sulla lingua - tale connessione
non è casuale ma volutamente ricercata dal poeta per esprimere con i due termini in
discussione (trtoívrrl-ríorq) concetti che, in questo particolare contesto, appaiono
semanricamente legati tra loro nel fornire un nome significante, cioè Tttfrveq. Cer-
chiamo di chiarire meglio:
a) con il verbo îlîCI,ívcrr, si è detto, si allude all'atto da cui scaturisce un péyo
épyov compiuto con (o, per) eo) étoo0al"ío, di cui vittima è urano e colpevoli
sarebbero, appunto, i Titani;b) poiche nel regno dí Zeus -
di cui, in questa fase, si delineano i prodromi
- ogni
"olp" riceverà la sua pena (tíotq) (rt), anche i Titani saranno puniti. La rí-
org iarà, cósì pare, I'incatenamento nel Tartaro, quale si verificherà più tardi per
mano di Zeus, in seguito alla lotta che Zeus stesso sosterrà contro i Titani per ilconseguimento definitivo del potere regale, lotta nota con il nome, aPpunto, di Ti-tanomachia(221.
Esiodo, perranro, troverebbe una legittimazione per I'epiclesi uTrrflvtqD non
solo nella colpa (il trtotverv) commessa da quelle divinità nei riguardi di Urano, di
infa n. 35 . Per ciò che concerne i versi della Teogoni4 qui in discussione, i più - come soPra accennato -
vl
"olgo.ro un 'richiamo all'indietro': così, in particolare, Linghor, op. cit., p. 134; Ferrante, art. cit., p.456; Du'
b^i, art. cit.,; Arrighetú, Poeticit., p.27 (ma diversamente in Esiodo cit., su cui cfr. suPran.9), etc.
1u) In p"rti.ol"r. Risch, op. cit., spec. p.77;West, op. cit., p.226; furighetti, Poeti cit', P.27 ( ma cfr.
^nche tilpra n.2).
1zo; Cfr. a riguardo supran.l5.(zr) Inf*ti, è stato osservaro che il regno di Zeus non è solo un regno di serenità e armonia; esso è
anche necessità e obbligo di sottostare al desdno che spetta ad ognuno, di rispetnre le regole che tale regno
impone, di comminare punizioni a chi queste regole non rispetta (cfr., a riguardo, furighetti, Esiodo cit.,
p.iSZ 5.1. Il rispetto della giustizia per cui ogni colpa dovrà ricevere la sua pena è uno dei caratteri fonda-
mentali del regno di Zeus, a tal punto importante dafarela sua comparsa quando ancora questo regno di Zeus
è in fieri: I'intera vicenda della successione lJrano-Ctono-Zeus, una delle sffutture ponanti della Teogonia, è
infatti dominata da questo principio di giustizia, giacché la colpa di Urano è punita da Crono, e quella di
Crono àaZeus.Tornando dunque ai'Tirani', risulta comprensibile in qud senso i concetti espressi dalle pa-
role trtsívo (colpa) e ríorg (punizione), attraverso una loro inscindibile complementarietà, forniscono pie-
nezza di significato al nome Tttflveg.(22) Di quesra si narra successivamente nell'ambito del poema teogonico, cioè ai vv.6l7-720.
-20-
cui ha narrato in precedenza(zt), ma anche nella conseguenre punizione (la tío'rq),di cui parlerà successivamente. Nel dare, quindi, un nome che individui delle enritàin maniera significativa per la storia teogonica 1za), rl poeta non solo si attiene ad unevento passato, ma, contemporaneamente, pensa anche al futuro destino di quelleentità, trovando così un secondo collegamenro per il loro nome. È ,t"to, del iesto,osservato che la prigionia dei Titani nel Tanaro non è solo conseguenza della lororibellione aZeus, ma è anche la punizione per l'attentato al loro padre (z:): cosicché,attraverso questa possibile seconda spiegazione dell'epiclesi nTrtfrveqo da utíorqr,la storia del loro attentato ad Urano diventerebbe motivazione della loro prigionianel Tartaro (zo). Tutto ciò significa, tradotto in termini di tecnica narrativa, cheTrrfrveq implica contemporaneamente una analessi ed una prolessi: analessi dellacolpa e prolessi della punizione, due vicende che, insieme e nella sressa misura, dan-no ragione dell'epiclesi qui in discussione.
In entrambe queste vicende, inoltre - si sente I'esigenza di precisarell
-IJrano risulta coinvolto, sì da poter legittimamente procedere ranro alla denomina-zione dei suoi figli quanto alla scelta di siffatto nome: egli non solo è vittima del-I'attentato, cioè di uno degli eventi che giustifica il nome Trtfrveg, bensì è anchepartecipe della punzione, il cui esecutore materiale
- come detto
- è Zeus. È,
questo, un aspetto della figura di Urano che, rivalutata alla luce di una analisipiù attenta, può fornire nuovi ed ulteriori dati per una lettura alternativa del nosrro
Passo. Intanto va sottolineato che (Jrano, insieme a Gaia, collabora all'instaurazionedel regno diZeus mediante informazioni e consigli che risultano vitali per tale even-to: si può ricordare in proposito che furono Urano e Gaia a dare consiglio a Rea, laqualel prossima a partorire Zeus, chiese loro aiuto perché potesse nascondere il suo
Parto al genitore, Crono, il quale divorava tutti i suoi figli (cfr. Theog. 468-478a).Va osservato che su questo obiettivo della richiesta di aiuto da parte di Rea (vv.468-472a)
- la rcalizzazione del quale è presupposto fondamentale nella sroria teogo-
nica esiodea -
si è generalmente focùizzata I'attenzione della critica al punto ditrascurare un secondo ben preciso scopo, altrettanto importante ed esplicitamenteespresso nella preghiera di Rea, cioè che Zeus, una volta nato e sfuggito a Crono,rsíoolîo E' 'Eprvùq Trorpòq éoio I noíErrlv 0' oùq rCI,rénrve péyuq Kpóvoq
1zz1 Cfr. vv.167-181(ma cfr. enche supra n. 16).
1za) Sull'importanza dell'imposizione dei nomi, in generale, nell'economia dell'opera esiodea, cfr. supran.17,ei"fnp.10en.33.
(25) Cosi Linghor, op. cit., p.133.(26) Cosi Linghor, op. cit., p.133; tra gli altri, anche 'West,
op. cit., p.226; in panicolare, invece, se-
condo Arrighetti, (cfr. Poeti cit., p.27) nella menzione della ríorg (v.210) è da cogliere una allusione all'esitodella Titanomachia, dunque all'incatenamento nel Tanaro: a riguardo, cfr. anche Arrighetti, Esiodo cit.,p.333.
1zz; Così, in panicolare West, op. cit., p.226.
I
-2r -&yrul,oprlrrlg -
uplacasse le Erinni del padre di quello I e dei figli che divorava ilgrande Crono dai torti pensieri> (cfr. Theog., 472b-473). D" questi versi parrebbe,
d,rrq,r., che la parteirpazione di lJrano alla punizione (tíotq) dei Titani consista,
più specificaramente, nell'aver aiutato Zeus avendicare (teívco / tívro: cft. Theog.,
47Zb) le sue Erinni 1za) ('Eprvùq natpoq Èoîo) - quelle, eventualmente, scatena-
te al momento delle evirazione (cfr. vú. 176- I82a). Si tratterebbe di una vendetta
non del rurto immediata; ad essa urano partecipa'indirettamente', per così dire,
cioè favorendo I'ascesa al trono di Zeus il quale poi, dal canto suo, Provvederà a
punire innanzitutto Crono, e, in seguito, anche i Titani (zr).
A ben considerare, questi versi 472b-473, relativi allo scopo immediato del-
I'aiuto fornito da Urano e Gaia alla nascita di Zeus (to), e testimonianti una Parte-
cipazione di Urano ad una tío'rq che colpirà, infine, anche i Titani - onde la le-
giitimità del suo atto di denominazione -, consentono una diversa interpretazione
Ae[a colpa dei Titani medesimi, cioè del loro îtîCI,ív€lv (cfr. Theog.207-210), da
cui purelcaturisce il nome stesso di queste divinità. Riesaminando le posizioni della
critùa esiodea, sopra discusse, a proposito della possibile interpretazione dell'azione
del trruívtlv come allusione all'affronto eseguito ai danni di Urano, si awerte, a
mio awiso, una difficoltà non di poco conto nel fatto che dell'affronto in questione
unico esecurore è Crono. Il silenzio e I'acquiescenza delle altre divinità come segno
di parteci pazione, sia pur passiva, a quell'azione, mi sembra un'argomentazione
piuitosto debole, ranro più che nel momento in cui Zeus è chiamato esplicitamente,
1za; Le Erinni sono le dee vendicatrici delle offese e dei torti subiti: dal passo esiodeo risulta che Crono
abbia scatenato sia le Erinni di Urano che quelle dei suoi figli, per due distinte offese, rispettivamente: evi-
razione (del padre) e divoramento (dei figli). A placarle in entrambi i casi sarà Zeus (cfr' anche infian-29).
1zl) Per quanro concerne la punizione di Crono - quella a cui lJrano partecipa indirettamente in
maniera più evidente di quanto lascerebbe suppoffe il semplice e più generale atto di denominazione (cfr.
su?ra, p.7) - ti può notare che enffano in gioco entità nate in conseguenza' e come esito ultimo, dell'atto
dievirazione eseguito da Crono: le Erinni. In Theog.l82b-185 si narra della nascita delle Erinni (insieme ai
Giganti e alle Ninfe Melie: cfr. w.185-187) ddle gocce di sangue sprnzate dai genitali tagliati' non invano
zuggiri dalle mani di Crono (cfr. v. 182). La presenza di queste divinità vendicatrici dei delitti o torti subiti è
cerrarnenre funzionale a dare compl etezza aI regno di Z,eus che si va delineando nei suoi prodromi: si è sopra
detto, infatti (cfr. supra n.2l), che il regno di Zeus, in quanto regno di giustizia (idea che sarà approfondita
nelle Opere e Giom), si compone di ogni sorta di entità, positiva e negativa, che garantisca il mantenimento
dell'equilibrio, dell' armonia, quindi della giustizia, che saranno appunto de Zeus instaurati. In quest'ottica,
risulta parricolarmente significativo, a mio parere, che le Erinni, una volta nate, facciano la loro prima com-
p"rs" ir, funzione del loro genitore (Jrano, come strumento di cui si serve Zeus, loro legislatore, per così dire,
proprio nei confronti di chi per primo le ha scatenate e di chi è stato responsabile della loro nascita: Crono
i.fi. f6tog.4GB-473). Dunque, tutto lascerebbe supporre che fin dall'inizio unico responsabile dell'atto di
úpptq coÀmesso nei confronti di Urano sia Crono (cfr. pure, infa n.31), sul quale solo cadrà la punizione
di tale colpa, specificatamenre per mano di Zeus; quindi altra sarà la colpa propriamente commessa dai Tttfr-
urgr q,r.ri" una delle conclusioni cui si perverrà nel corso di questa trattazione (cfr. oltre, Pp.2Z-23).(30) Cioè: uperché potesse placare/vendicare le Erinni del padre di quello I e dei figli che divorava il
grande Crono dai toni pensieri,': cft. Theog. 472b-473.
-22-
Per così dire, ad un'opera di vendetta nei confronti sia di Urano che dei suoi proprifratelli, qu€sta vendetta specificatamente ed espressamente colpisce unicamenteCrono, colui, cioè, che ha offeso direttamente ranto LJrano
- per il traminte del-l'evkazione
- quanto i suoi stessi figli, fratelli quindi di Zeus -
che egli divoravaper evitare che qualcuno lo spodestasse (cfr. Theog. 459-462).In altre parole, daiversi 472b-473, sopra citati, risulterebbe che LJrano, collaborando alla nascita delsuo vendicatore Zeus, partecipi indirettamente alla tíorq di Crono, l'unico vero,effettivo responsabile dell'affronto da lui subito in passato. Proprio perché nel regnodi Zeus, come detto, ogni colpa riceve la sua punizione, come la colpa di Urano-molto simile a quella di Crono, dal momento che impediva ai figli di venire alla luce
Per timore di perdere il potere (cfr. Theog. 156-159) -
è srara, in qualche modo,punita da Crono, così la colpa di Crono
- duplice, in quanto diretta al genitore (:r)
e ai figli -
viene punita da Zeus.A questo punto viene spontaneo chiedersi quale sia, allora, la colpa, cioè il pé-
To épYov, commessa dai Titani con il loro trtuívrlv, che giustifichi, insieme conla menzione della tíorq, la loro denominazione da parte di Urano. La risposta è
nella vicenda che più significativamente per il decorso della storia teogonica vedeprotagonisti i Titani: la Titanomachia, cioè l'atto di insubordinazione nei confrontidi Zeus. Questo, a mio awiso, il ogrande misfattor, la colpa adombrata nel nomeTrt{veq, per cui quei figli generati da Urano che hanno osato sfidare (ntaívovteq... útaoOol"í1: v.209) colui che era destinato ad essere sovrano degli dei e de$luomini (:z) riceveranno la loro giusta giusta punizione (tíorq), cioè I'incatenamenronel Tartaro. Tutto ciò significa che la denominazione Trrfrveq implica, nel suo ar-ticolato e complesso significato, un richiamo prolettico non solo
- come già sopra
accennato -
alla punizione, bensì anche alla colpa. Questa possibile conclusionetrova conforto nelle seguenti considerazioni: 1) i nomi delle entità teogoniche, è
stato detto (::), sono significativamente allusivi all'essenza di chi li porta e, proprioPer tale ragione, recano in sé, generalmente, tracce delle azioni o vicende che più
1lt; Cfr. su?ra n.29. D'alva parte, di un particolare astio di Crono nei riguardi di Urano -
astio chesfocerà nell'atto finale dell'evirazione
- si ha già un qualche accenno in Theog. 138b: a conclusione dell'e-
Ienco dei figli generati da Gaia e lJrano, a proposito di Crono, ultimo menzionato, vien detto che opresein odio il gagliardo suo genitoren. In maniera simile, a conclusione della breve presentazione generale di tuttii figli di Gaia e lJrano, di essi vien demo che: nfurono presi in odio dal padreo (&. Thng.l55b: per unadiversa interpretazione del passo, cfr. Arrighetti, Esiodo.ir., pp.328-329), un odio
- qr.r..ro di Urano
-che poi si rivelerà anche nell'atto di denominazione dei Titani (cfr. spec. Theog. 20Ba: nci6og verreíolv).In entrambi i casi si può inravedere un fenomeno di prolessi, cioè di anticipazione allusiva ad eventi dicui si suscita I'atresa (sul fenomeno della prolessi cfr. infa n.35).
1sz7 Tra le diverse attestazioni, esplicite o allusive che siano, di siftàtta realtà, ricordiamo in particolare iw.464-465 (in cui parola chiave, designante il vincolo obbligante del 'destino' è il verbo nénpara); w.490-491 (épeî"}"e...&vó(etv); v.506 (in cui Zeus è detto: ... 0vntoîor ruì &govúcororv óvúoosr).
(33) Cfr. supra nn.3, 5, 6 e 17.
_23_
hanno inciso sulla loro esistenza: è innegabile, credo, che l'evento che più partico-
larmente ha condizionato Io status dei Titani nella storia teogonica esiodea sia ap-
punto la Titanomachia, con la conseguente punizio ne 2) la Teogonia esiodea, è sta-
lo *.or" detto 1:a), è vna narrazione della formazione del mondo che ha il suo focus
nella instaurazione del regno definitivo di Zeus: infttti, in quest'opera esiodea molte
vicende e realtà narrate trovano una giustificazione, sia dei loro contenuti che della
forma in cui il poeta le presenta, in funzione dell'esaltazione della potenza di Zeus;
siffatto intento risulta a tal punto importante che spesso condiziona le modalità tec-
nico-compositive in cui il racconto procede (::). Tenuto conto di ciò, è plausibile
pensare che, proprio in funzione dell'esaltazione del regno di Zeus, Esiodo abbia
voluto dare enfasi, attraverso un atto di denominazione dell'entità interessate -con tu6o ciò che una denominazione esiodea comporta - ad uno degli episodi-
chiave per I'instaurazione definitiva del regno medesimo: ricordiamo, infatti, che
la Titanomachia è una delle prove ineludibili per Zeus, da cui dipende veramente
(i4) A riguardo, in particolare cfr. F. Solmsen, Hesiod andAescltylus, New York 1949, pp.7-8, 50; Lin-
ghor, op. cit.,pp.l35-136 e 182-185; G.S. Kirk, The Stnr.cwre andAim of the Theogony,in Hésiode et son
lrfuororr, uEntretiens sur I'Antiquité Classique, VIII (1960), 63-107 , sPec. P. 97; I -U .Schmidt, Die Aufrich-
nng dcr Zeushenschafi ab Modclt - Úberttgongm zur Theogonic des Hesiod,Il, in o'Slùrzburger Jahrbúcher ftir
die Altenumswissenschaft, Neue Folge 15 (1989) pp.17'37, sPec. PP.22'28.pi) In proposito pensiamo in particolare dla rccnica narrativa della prolessi (su cui, in generale, cfr. E.
Lammerr, Baufornen dzs Erzàhlens, Stuttgart 1955, spec. pp. 139-1S9); di essa si tratterà nel seguito della di-
scussione. Qui ci limiteremo ad accennare in cosa consiste siffatta tecnica e in quale misura può rinvenirsi in
Esiodo. Come sopra accennaro per I'analessi (cft. supran. 18), la prolessi è 'uno spostamento in avanti' rispet-
to alla naturale successione cronologica in cui si susseguono gli eventi narrati; è, cioè, un criterio di organiz-
zazione narrativa che incide specificatamente sulla dimensione temporale del racconto. Nella Teogonia diEsio'
do, I'applicazione di siffatta tecnica risulta particolarmente funzionale alla realizzazione del tema narrativo ba-
sil"r., i'"rruento del regno di Z,eus. Quanto ad Esiodo, però, mancano studi specifici di carattere narratologico
che analizzino fenomeni di analessi e prolessi pur presenti nell'opera esiodea' Disponiamo di accenni, rispet-
tivamente in C. Robert, Zu Hesiods Theogonie,in Mélanges Nicole, Gen&e 1905,461-487 (rist. in Heitsch,
op. cit., pp. 154-174); P. Friedlànder, Recensione aHesiodi Carmina, recensuit F. Jacoby, Pars It Theogonia,
Berlin 1930, in nGóttingische Gelehrte Anzeigenu 93 (1931) 241-266 (rist. in Heitsch, op. cit., pp. 100-130);
Sellschopp, op. cit., p.Iil, passirn Un'analisi più particolareggiata di alcuni fenomemi di prolessi presenti nel-
l^ Trogiilaesiodea, con particolare riferimento aJla Grundidee del poema, cui sopra accennato, sono in RLaurio-ia, Ilyévog di lapeto: considzrazioni sull'ordinamento genealngico drlh Teogonia esiod,ea in G' Arrighetti
(ed..), Poesia grec4 Ncerche di filologia classica IV, Biblioteca di studi antichi 72, Pisa 1995' 73-L00. Per ciò
.h. .on..6. I'epica greca, i più studiati, secondo questa prospettiva narratologica, risultano Omero e Apol-
lonio Rodio: cfr. infatii, tra i saggi più rappresentativi, C. Kraut, Die epischen Prolzpsis nacltgewiesen in der llias,
Túbingen 1863 (il primo lavoro che ci risulta eseguito in quest'ottica su Omero); G. E. Duckworth, Fore-
thada*;"g and Suspinse in the Epics of Homen Apollonius and Vergil, Princeton 1933; 'S7. Schadewaldt, Ilias-
studien, ó"r-rt"di 1966; Fusillo , op. cit, L De Jong, Nanaton and Focaliztrs. The Presentation of the Story in
the ltia{Amsterdam 1989 (repr.). Più in generale, sulle modalità compositive dell'epos antico, con riferimen-
to anche ad Esiodo, cfr. Van Groningen, La composition lixéraire archaiQue grecqae. Procédés et Réalisations,
Amsterdam 1958, pp.3-108 (su Esiodo, in particolare , pp.256-303); \7.G. Thalmann, Conuentions of Form
and. Thought in Early Greeh Epic Poary, Baltimore and London 1984 (su Esiodo, spec. pp.l-64).
-24-la possibilità di un regno stabile e definitivo (rr). E tale intento il poeta parc aver rag-giunto combinando il gioco etimologico che sottostà alla denomi n ziine dei Titanicon una tecnica narrativa, sPesso finalizzataa dare risalto all'evento centrale della sto-ria teogonica, cioè la prolessi (r4. tt nome Trrfrveg, dunque, come è proprio del si-stema di denominazione esiodeo (ta), riflette l'essenza delle entità che là pon"no;questa essenza è significativamente definita, in funzione della vicenda portante del-I'intera narrazione
- cioè il regno di Zeus-, p€r il tramite di un richiamo prolet-tico a ciò che la determina nelle cause, per così dire, (utoívovteq...&roo0aì,íq,Titanomachia), e nelle conseguenze (ríctq:incatenamento nel Tartaro) (rr. il dupli-
(36) Infatti, nella narrazione esiodea Zeus risulta aver preso di fatto il trono e il comando dopo averconcluso
- coadiuvato dagli altri dei (i Centimani, in particolare, ma anche i Ciclopi, i figli di Siig., ,,,cui infra n. 37 , etc-)
- la disputa con i Titani. Così infatti leggiamo in Theog 88 t -s85: oùtù! èneí ití nó-
vov póxopeq 0eoi é(erél,eooov, I Trt{veo'or òè trpúolu *pívovto Fít'1q1, I Sú óa rót'ótpuvov paor-l"euépev r]òè óvóooerv lfcír1q gpo8pooúvrlorv'Ol.úpriov eùpuonaZfiv lógavúrrov.é òè roîorvéu òreòóo'ocro :.:"paq. Da tener presente che, oltre la lotta contro i Titani (Theog.6l7-7zo),Zeus dovetteaftontare, prima del regno' una nuova dura prova: quella conrro il mostro frfeo\Theog.82l-880).
(37) Cfr. saPra n. 35 ' Per ciò che concerne I'episodio in sé della Titanomachia, un richiamo proletticoalquanto evidente può rinvenirsi nel noto episodio di Stige: Theog. vv,383-403. eui Zeus
- di cui, peraltro,
non si è ancora narrata la nascita - invita gli dei a schierarsi dalla sua parte per Ia lotta contro i Titani .h. p"r.
imminente per la conquista del regno: su questo specifico caso di prol.ssi, c&. Lauriola, art. cit,spec. pp. g6-88e 88-95. A proposito di questo episodio di Stige, che culmina nella pronta risposta di tale entità all'invito diZeus con il dono dei suoi figli
- Zfiìuoq, Nírr1, Kpótoq, Bírl
-, e ancora a proposito delle realizzairone
dell'intento narradvo principale dell'opera esiodea, mediante la combinazione ragioco etimologico e tecnicadella prolessi, cui sopra accennato, si può osservare che spesso i nomi delle varie enriù, che enrrano in gioconella storia teogonica, risultano proletticamente significativi attraverso la loro collocazione all'interno dell'o-pera: essi infani, risultano in uldma analisi
- cioè alla luce dei fatti successivi -
giustificare e simboleggiareaspetti e carafferi di ciò che sarà la figura ed il regno di Zeus. Tale, ad esempio, è il caso dei figli di Stige] cuinomi simboleggiano le qualità su cui Zeus impronterà il suo regno e grazie a cui trionferà 1.*. flrrog. +O3111;490;495b-496;647' e ancora Lauriola, art. cit.); tale, in qualche modo, il caso delle Erinni cui sopra accen-nato (cfr- suPrdn.28); tale
- vedremo -
sarà, a nosro awiso, il caso anche dell'epiclesi Trrfrveq. per con-siderazioni analoghe sui nomi ed il loro significato in relazione aZeus, cfr. Linghor, op. cit., spec. p. lg2.
(38) Cfr. sa?ra nn. j, 5, 6, 17 e 37.
139) Una difficoltà, a mio awiso apparente, cui può andare incontro I'inrerpretazione d.ei versi 207-210come allusione proletdca anche alla colpa dei Titani (trraívovr€q ... ótao0al,ín)
- urro degli elementi chedarebbe giustificazione dell'epiclesi
-, oltre che alla loro punizione (ríorq), po,r.bb. essere rappresentata d.al
temPo in cui è esPresso il verbo pé(ro, che ha il significato di ocompiere,, (cfr. L. S. J. r. z. óé(ro) e nel contestoesiodeo ha come oggeffo diretto il péya épyov, cioè il grande misfatto in cui si concretizzercbbe la colpa deiTitani' Il tempo in questione è I'aoristo e il modo è I'infinito. La presenza dell'aoristo piurtosto che, ad esem-pio, di un futuro, parrebbe limitare la possibilità di una inrerpreiazione in termini di prolessi. In proposito,una prima considerazione da fare, forse anche banale, è che la presenza di prolessi ,r"rr"ri.,n" non si valuta sullabase della forma temporale dei verbi eventualmente presenti nella pomion. di t.rro che è oggetto di analisi: siconsidera un'anticipazione, infatti, un aggettivo, un epireto o una inrera frase o u. gr,rppJ-di versi che allu-dano a vicende che, nell'ambito del tempo interno alla narrazione, si collocano ir, ,rrr" f"r.ìuccessiva rispetto aquella in cui ne ricorre il primo accenno allusivo, che, appunto per quesro, si connora come prolettico. Alcuniesempi di questo genere I'abbiamo nello stesso poema teogonico: per fare solo qualche es.Àpio, al v.506, a
_25_
ce richiamo riflesso nel nome si concilia, peralffo, con una maniera tipica del pensie-
ro arcaico di concepire e descrivere la redtà, una maniera che pervade I'intera îaurfa'
zione esiodea e che convenzionalmente può definirsi come oapproccio molteplice alla
realtà (multiple approaches)> (ao); essa consiste nel considerare e raPPresentare una
realtà nella sua completezza osservandola da rutti i punti di vista possibili. Questa
molteplicità dei punti di vista che compongono una stessa realtà può trovare esPres-
sione sia nel singolo nome di una data entità (ar;, che nelle sue diverse attribuzio-
conclusione della succinta narrazione della detronizzazíone di Crono, compiuta con un atto di forza da parte
di Zeus (cfr. anche vv.490; 496), di quest'ultimo vien detto che otoîq (sr. tuono, fulmine e baleno) nío'uvoqgvqtoîor roì ó0avótororv óvóootlD nonosrante che, di f*to, in questo momento della storia teogonica
non abbia ancora affrontato le prove inevitabili (titanomachia e tifonomachia: cfr. vv.6l7-820;821-880; in
entrambe le prove le armi di cui si serviÈ Zeus sono quelle indicate appunto, di già, al v. 506) per il definitivo
dominio sugli uomini e sugli immortdi; sono, questi, eventi che si collocano in una fase successiva e a cui, nel
v.506, si prelude nonostante la presenza di un tempo verbale presente (ma per questo e alui casi, cfr. anche le
indicazioni bibliografiche sul fenomeno della prolessi in n. 35). Oltre questa considerazione generale sui tempi
verbali nei brani interpretabili come 'prolessi', specificatalnente in relazione ai versi in questa sede discussi,
cioè 207-210, per ciò che concerne la presenza dell'aoristo, nel modo infinito, è doveroso ricordare che
nel sistema dei tempi del verbo greco, I'aoristo non designa una dimensione temporale ben determinata, piut-
rosto privilegia I'aspetto dell'azione: esso, infatti, qualifica I'azione in sé, allo stato Puro' senza riferimento alla
sua durata (che, nel sistema verbale greco, è proprio del presente) o alla sua compiutezza (che è proprio del
perfetto), ma esprime l'azione come un fatto momentaneo - indeterminato - puntuale, al di là di ogni
precisa valutazione di tipo temporale. Questo valore prettamente 'aspettuale' dell'aoristo impronta tutti i mo-
di, fatta eccezione dell'indicativo: infatti, mentre quest'ultimo tende ad esprimere un'azione puntuale speci-
ficatamente nel passaro, gli altri modi -
tra cui dunque I'infinito -
gsplirneno costantemente I'aspetto (su
tutto ciò, cfr. E. Schwyzer, Griechische Grarnmatih, Múnchen 1950, II, spec. PP. 248'269). A ciò si aggiunga
che nel sistema dei modi verbdi della lingua greca I'infinito è propriament€ uno dei modi che manca di una
temporalità precisa (fatta eccezione per I'infinito futuro) ed esprime costantemente I'aspetto verbale: su queste
osservazioni, con relativi esempi del valore 'aspettuale' e non temporale dell'infinito, specificatarnente aoristo,
cfr. Y. Duho nx, Le uerbe grec ancien. Eléments dz morphobgie et de syntaxe histori.ques, Louvain, 1992, spec.
pp.161-163;272-273. A tutto ciò, a favore di una lettura in chiave prolettica del verso 209, nonostante la
presenza di un infinito aoristo, si può aggiungere un passo ancora esiodeo: Theog., 478, in cui di Rea vien
detto che fu inviata a Licto: énnót' 6"p' én7'6"carov roíòcov iipel,î"e reKéoeot (oquando il suo ulcimo fi-
glio stava per panorirer). Si può notare qui I'uso di un infinito aoristo, per designare un'azione awenire, in
dipendenza di un verbo - pél,l,ro
- che implica una idea di futuro e che, per questo, si costruisce gene-
ralmente con I'infinito futuro. Ma pur designando una idea di futuro il verbo pél,l"rrl può facilmente regger€
I'infinito presente, aoristo e perfetto: la scelta dipende non da ragioni temporali, bensì 'aspettuali' (cfr. a ri-
guardo e con relativi esempi, Duhoux, op. cit., p. 163). A conclusione di queste considerazioni, si può infine
"orrr,"r"r. che la presenza di un infinito aoristo non rappresenta una vera difficoltà aI tipo di lettura che in
questa sede proponiamo.(40) A riguardo cfr. in particolare CJ. Rowe, Archaic Thought'in Huiod in nThe Journal of Hellenic
Studies, 103 (1983) pp.l24-135 (trad. it. in furigheni, Esiodn cit., pp.539-558); furighetti, Esiodo cit.,
pp.)OCflII-)OOilV.(41) In proposito si pensi ai nomi delle divinità della più antica generazione come faia, Oúpovóq,
'Clrecvóg, Ilówoq etc., nonché ad alcuni nomi dei loro discendenti - ad esempio: OÚpec poKpú, gene-
rati da Gaia per partenogesi (v.129), o Bpóvt46, }repónqq,'Apyng (w'139'140) e tanti altri -:
tutti
_26_
ni (az;. In considerazione di ciò, dunque, il nome Trtfrveq designa la personalità de-gli dei così chiamati da due punti di vista: quello della colpa.oÀ*.rr" e quello dellapunizione conseguenremenre subita (ar;.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si può osseryare che il significato,da sempre discusso, del nome Ttt{veq coinvolge ben più che una protlematicaconnessione etimologica: subentrano, infatti, elementi che concetnonó il modo difue-poesia, da Parte di Esiodo, e gli intenti che in quel modo il poeta si propone.Analizzati, dunque, in questa più articolata e .o-pl.rr" prorp.ttirr", i verci 207-210 della Teogoniapossono assurgere ad uno dei passi emblèmalici dell'operare poe-tico esiodeo (aa1.
Rosanna Lauriola
indicano al tempo stesso tanto le entità divine quanto gli elementi fisico-naturali che impersonano. Infattisono costantemente menzionati e resi protagonisti delle varie vicende teogoniche nel loro duplice aspettodi cui, di vola in volta, a seconda delle esigenze del conresro, ne è îocalizzato ora I'uno ora l'altro. euestaduplicità e molteplicità di aspetti costituenti tutti, parimend imponanti, una medesima realtà, considerara ap-punto da più punti di vista, rende conto, infine, della varietà di endtà discendenti da uno sresso progenirore,che ha sue definite caratteristiche: su ciò cfr. ancora Arrighetti, Esiodo cit., pp.29l-295.
(42) Tra gli esempi più eclatanti vi è quello di Eris, in Er. 11-26, e di Pandora, in Er,59-105: cfr.furighetti, Esiodo cit., pp.)OCOV, 410..412 e, sulla figura in generale della donna uambiguar, pp.452-467.Ancora, in particolare su Pandora, cfr. M.R Calabrese De Feo, La duplice fsionomia di pandnìa in Esiodp,in Arrighetd, Poesia greca cít., pp.10l-122.
(43) Per ciò che concerne la colpa, sulla base del principio dei 'multiple approaches', si può anche am-mettere' oltre il richiamo prolettico alla Titanomachia, che è
- a mio awiso
- di gran lunga più determi-
nante' un implicito richiamo analettico a quella pane di responsabilità, e quindi di colpa, che i figli di Uranopossono aver commesso non opponendosi all'atto scellerato che Crono personalmente compie nei confrontidel padre. Turto ciò, del resto, ben si addice alla anicolata tecnica narrativa di Esiodo ,r', .,.ri, per una felicesintesi, cfr. Sellschopp, op. cit., spec. p. 121.
144) D'altra parte, si può ancora notare che, operando in quesro modo, il poeta risemantizza un nomeche trova già nella tradizione poetica: Trtfrveg sono chiamati in Omero gli dei ùzoruprúplou così leggiamoin 1i. XIV 278b-279
- ove abbiamo I'unica attestazione in Omero del nome Trrfrveq.-: .... (rc. Era)ieouq6' óvóprlvev ftnavrag I toùq ézotaprapíouq, oí Trrfrveg rul,éovrar -
(( ... nominò tutti gli dei I quellidi sotto il Tartaro, che si dicono Titani,,. Questa è la collocazione ultima che i Tirani hanno nella storia esio-dea (cfr. vv.7l7-720), una collocazione tradizionale a cui Esiodo, come già similmente in altri casi (il caso piùvistoso è quello delle Muse, su cui: Linghor, op. cit., pp.125-130; cfr. anche sapra n. l7), e inossequio al suoimpegno di verità (cfr. supra n' 3), dà una spiegazione e legittimazione condensandole in un ro*. o epiclesi.