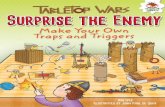The Traps of flexible work
Transcript of The Traps of flexible work
Pubblicato in A. Giglia e A. Miranda (a curadi), PRECARIEDAD URBANA Y LAZOS SOCIALES. UNA MIRADA COMPARATIVA ENTRE MEXICO Y ITALIA,Ed. Juan Pablos & Universidad AutonomaMetropolitana-Iztapalapa.
THE TRAPS OF FLEXIBLE JOBS
mirella gianninidipartimento di sociologia
università "federico II" di napolie-mail: [email protected]
Summary
In the current labor market, flexiblejobs are rising as the main shape ofapplications in private and public sectors.Most of the sociological analyses have foundthat, as inflecting for age, gender and socialstanding, fixed-term jobs are unlikely to leadto stability, and rather, they turn out to anever-ending traps, especially for youngpeople lacking of social and culturalresources. Despite all evidence of increasinguncertainty in life and work, State, Union andCorporate actions delay building systems offlexsecurity. Especially in contexts ofcrisis, social responses seem to contrast neo-liberalism in the labor market by adapting
1
individual behavior and familiar relations tothe precarious jobs and life. The“precarisation” as internalisation of socialtraps play an important role for the youngpeople who fill with the private virtues thegaps of public regulation.
Key words: Flexible job, young people, social traps,precarisation
LE TRAPPOLE DEI LAVORI FLESSIBILI
mirella gianninidipartimento di sociologia
università "federico II" di napolie-mail: [email protected]
INTRODUZIONE
2
In questo saggio ci concentriamo sullaflessibilità del lavoro, che appare come laconseguenza dell’assetto neo-liberale delloStato e del mercato. Mettiamo in evidenza comei lavori flessibili difficilmente tendono adiventare stabili, piuttosto finiscono permantenere moltissimi giovani intrappolati insituazioni di prolungata precarietà. Rileviamouna relazione tra i lavori flessibili e i modidi organizzare la vita quotidiana, inparticolare quelli della nuova generazione.
Dai dati statistici ufficiali, abbiamovisto che, in Italia, il lavoro flessibile ètipico dei giovani, anche se si declina inmodo differente a seconda del genere o deltitolo di studio. Ma, esso appare piùincidente nelle aree meridionali, che sonodefinite da scarse opportunità occupazionali eda una crisi strutturale che allunga laprecarietà lavorativa e moltiplica le suetrappole.
Da recenti ricerche, condotte a Napoli,su giovani disagiati e su giovani coppie chesvolgono lavori flessibili, abbiamo potutoconstatare che le trappole sociali sono resepiù incisive dallo scenario istituzionale chenon provvede a sostenere la continuità dellavita quotidiana a fronte della discontinuitàdella vita lavorativa. E poi, non abbiamopotuto fare a meno di rilevare un tipo dirisposta sociale che, in alcuni casi, si è
3
presentata come un “adattamento” allaprolungata precarietà del lavoro e della vita,e in altri, come una logica di “contrasto” alneo-liberalismo dello Stato e del mercato dellavoro.
Abbiamo letto i risultati delle ricercheutilizzando il concetto di “precarizzazione”,nel senso di Bourdieu e Goffman1. Abbiamointeso la precarizzazione comeinteriorizzazione delle trappole sociali,
1 La “precarizzazione” è una categoria che parafrasa untermine di Bourdieu (1984/2002, 1993), e che riprendeda Goffman il modo di analizzare i percorsi degliinternati psichiatrici e i loro adattamenti allacultura istituzionale, quasi come una “lotta diresistenza” per mantenere spazi di dignità. Bourdieuha utilizzato il termine ouvriérisation o usinisation, inQuestions de sociologie, Les éditions de Minuit, 1984-2002, p.252-253, dichiarando esplicitamente che essoricalca il concetto di asilisation di Goffman (Asylum1961). Tale termine indica un processo diappropriazione di spazi organizzati e logiche dicondotta, di assimilazione di culture istituzionali.L’allargamento operativo del concetto di“precarizzazione” al mercato dei lavori flessibili,inteso come campo istituzionalizzato, è stato possibileriferendosi alle analisi dello stesso Bourdieu e dimolti dei suoi collaboratori (La misère du monde,Editions du Seuil, 1993), in particolare ai commentialle interviste ai lavoratori precari. Ci riferiamoalle pp. 339 e ss (sulla conversione collettiva dellavisione neo-liberale), p. 125-126 (sull’ordine dellecose), p. 745-748, p.547 e ss. (sulla vita e sul sognodei lavoratori precari)
4
perché ci è sembrato che i giovani si“adattassero” alla flessibilità come culturaistituzionale mettendo così in atto una speciedi “resistenza dignitosa” alla moltiplicazionedi spazi di precarietà prolungata.
Abbiamo infine notato che a questa“precarizzazione” le giovani donne partecipanoin quanto coinvolte nei lavori flessibili e inquanto protagoniste di relazioni familiari chesi muovono verso la parità di genere. Quindi,come si sostiene nelle analisi sulleprospettive del genere femminile nelletrasformazioni del mercato del lavoro2,abbiamo potuto supporre che proprioriformulando in questa direzione i ruoli e leresponsabilità domestiche, molte giovanicoppie napoletane sembrano “resistere” allaprecarietà.
Potremmo dire di più. Lo sviluppoparitario delle relazioni di genere e lemodalità cooperative dell’organizzazione dellavita quotidiana emergono con una logica di2 Rilevando in una prospettiva di genere le ristrutturazioni nel mercato del lavoro e le conseguenze sulla vita familiare, già la Crompton (2002) individuava che se questo non aveva portato a cambiamenti radicali lo sviluppo della parità di genere avrebbe potuto contrastare , in parallelo con altre forme di lotta, gli effetti del neo-liberalismo economico. Recentemente questo tema è entrato nell’agenda della sociologia femminista europea (Walby 2012).
5
“contrasto” alle trappole dei lavoriflessibili e ai rischi di precarietàprolungata. Insomma la nuova generazione, adifferenza delle lotte collettive dei lorogenitori, fanno “lotte di resistenza e dicontrasto”, riempiendo con virtù private ivuoti delle istituzioni neo-liberali.
1. LA FLESSIBILITA’ NELLO SCENARIO NEO-LIBERALE
1.1. L’istituzionalizzazione dellaflessibilità lavorativa
Attualmente, in Italia, come in tutti ipaesi europei, il neo-liberalismo dominantedisegna uno scenario socio-economicocaratterizzato dalla crescita costante dilavori flessibili. Abbiamo assistito aldeclino costante della forma di lavoroindustriale, che, fino ad alcuni decenni fa,si è presentata stabile nelle prospettivetemporali e spaziali.
Svolgendosi in spazi contigui e in tempilunghi, nella grande organizzazione, privata opubblica, dai grandi numeri di assunti a tempoindeterminato e dai rapporti di lavorodisciplinati, il lavoro industriale hafavorito legami di prossimità e di solidarietàtra i lavoratori. La solidarietà, inparticolare, si è espressa attraverso canali
6
informali o formali, ed è stata rilevata nelleazioni collettive tese a migliorare lecondizioni del lavoro e della vita fuori dellavoro.
Come è noto, il Welfare State è statostrettamente connesso a questa formalavorativa, mentre il posto di lavoro, a suavolta, ha svolto un ruolo centrale epermanente nella vita familiare e sociale deilavoratori. La stabilità del lavoro ha resoprevedibili i percorsi biografici e il postodi lavoro, la sua temporalità e la suaspazialità, ha segnato i modelli e i movimentifamiliari.3
Il passaggio alle istituzioni dello Statoneo-liberale ci appare consonante alcambiamento del lavoro, non solo ai suoi moditemporali e spaziali, ma anche ai contenuti diconoscenza e alle competenze idonee adaffrontare le trasformazioni tecnologiche.Oggi, va delineandosi sempre più chiaramenteun modello di diffusi rapporti di lavoro
3 Questi modelli e storie familiari sono statidominanti, come verrà detto anche in seguito, ecomunque abbiamo nel nostro immaginario il padre bread-winner che convoglia le strategie cooperativeall’interno della famiglia, un po’ come la catena dimontaggio della fabbrica metalmeccanica. Per le storiefamiliari, a sostegno della memoria rimane il raccontodella famiglia Savo, protagonista del “romanzoantropologico” di Pitkin (1992).
7
individualizzati e soprattutto caratterizzatida tempi e spazi flessibili. La flessibilitàsi definisce per lo più come flessibilitànumerica piuttosto che funzionaleall’evoluzione delle imprese, e comeflessibilità a rischio precarietà piuttostoche flessibilità semplicemente allocativa trale opportunità occupazionali (Dore, 2005).
In realtà, per definire un lavoroflessibile, il parametro più usuale è iltempo. Il lavoro a tempo parziale, il lavoro atempo determinato, o il lavoro a chiamata,tutti presuppongono la totale disponibilità daparte del lavoratore e ne permettonol’utilizzo intermittente e discontinuo. Unaltro parametro, recentemente moltoconsiderato (Hollister 2012), per definire unlavoro flessibile è quello relativoall’unicità o alla pluralità del datore dilavoro oppure del tipo di occupazione. Lapluralità spesso implica la applicazione dicompetenze eterogenee e perciò la svalutazionedella competenza con cui il lavoratore siidentifica.
La flessibilità del mercato del lavoronon ci appare un fatto congiunturale, anzidalle statistiche più recenti (Istat 2012) siha l’impressione che si stiaistituzionalizzando.
8
1.2. Notizie recenti dallestatistiche ufficiali
Sulla istituzionalizzazione dellaflessibilità nel mercato del lavoro italiano,il dato sugli occupati con contratto a tempodeterminato ci dà ragione. Questi cresconocostantemente dal 1993 al 2011, e riguardanoi giovani tra i 18 e i 30 anni.4 Per questistessi giovani già si rileva un alto tasso didisoccupazione 5 ma il rischio dell’esclusionesociale si traduce anche nella alta quota diNeet, giovani della fascia 15-29 anni che nonstudia e non lavora, maggiormente presenti nelMezzogiorno.
Altri indicatori ci segnalano che illavoro flessibile può intrappolare i giovaniper lungo tempo. Un indicatore rilevante è iltasso di permanenza nel lavoro dipendente atermine. Misurato a distanza di un anno, eosservato in relazione ai giovani 18-29enni,lo vediamo aumentare in modo costante e4 In questo arco di tempo il lavoro temporaneo aumenta a tal punto da incidere per il 13,4% sul complesso del lavoro dipendente, mentre la percentuale sale al 35% fra i giovani della fascia 18-29 anni.5 Nel 2011 è pari al 20,2%, ma va crescendo. Anche laquota di Neet, che l’ultimo dato disponibile dà a 2,1milioni in Italia, aumenta e si caratterizza per esseremeridionale, dove troviamo il 31,9%, un valore quasidoppio di quello del Centro-nord, e con punte massimein Sicilia (35,7 per cento) e in Campania (35,2 percento)
9
rapidamente negli ultimi anni, fino a chetocca il 56,3%, più della metà dei giovani. 6
Inoltre, non possiamo non rilevare chel’aumento del lavoro temporaneo si accompagnaad un abbassamento di qualificazione nellagenerale lieve crescita occupazionale. Questoci segnala una flessibilità occupazionale, nelsenso di contratti temporanei con unapluralità di datori di lavoro. E’ un tipo diflessibilità che, come abbiamo detto, portaalla svalutazione delle competenze deilavoratori. Tale situazione è tipica delsettore terziario, dove abbondano figure dibasso livello e esecutive, e, soprattutto digenere femminile.
Per le donne, che partecipano sempre piùal mercato del lavoro, la dequalificazione siaccompagna al tempo parziale, al tempodeterminato e poi alla disoccupazione, specieal Sud.7 Notiamo che a lasciare o perdere il
6 Il tasso di permanenza nel lavoro temporaneo se trail 1993 e il 2000 rimane sostanzialmente stabile,intorno al 40%, dopo il 2000 cresce fino al 50% nelperiodo 2005-2006, e si porta fino al 56,3% per centonel periodo 2010-20117 Fra il 1993 e il 2011 due terzi dell’aumentodell’occupazione femminile sono riconducibili agliimpieghi a orario ridotto. Fra i 2,3 milioni dilavoratori a tempo determinato, quasi uno su due èdonna (circa 1,1 milioni). Attualmente il 30 per centodelle occupate lavora a tempo ridotto, ma per circa lametà di queste si tratta di part-time involontario.
10
lavoro sono prevalentemente le neo-madriresidenti nel Mezzogiorno, le più giovani,quelle che hanno avuto il primo figlio equelle che vivono in coppia.
Da indagini attendibili (Ocse 2012),possiamo rilevare facilmente che i giovaniitaliani occupati con contratti a termine oaltre forme di lavoro, intermittente e condiversi datori di lavoro, sono i primi aperdere il lavoro quando le condizionieconomiche peggiorano. Per una donna, poi, ilrischio di perdere il lavoro in fasi recessivenon è dovuto solo alla presenza in alcunisettori economici o posizioni lavorative oalla dimensione d’impresa e nemmeno allapresenza di figli. Eliminando l’influenza diquesti fattori il rischio per una donna diperdere il lavoro è superiore del 40% rispettoa un uomo, solo perché è donna (Giannini2009).
Oltre il rischio di precarietà e diesclusione sociale, il lavoro flessibile haacquisito un aspetto molto importante che lestatistiche mettono in luce solo in parte. E’la individualizzazione del tempo e laframmentazione dei posti, fattori cheindeboliscono qualsiasi azione collettiva. Inogni caso, sia nell’ottica del tempointermittente, sia in quella del salto tradiverse occupazioni, il lavoro flessibilesembra impedire la formazione dei legami di
11
prossimità, e quindi, di solidarietà, che sonostati alla base delle lotte collettive nellafase del lavoro stabile.
1.3. La flessibilità del lavoro e laflessibilità della vita quotidiana
Nei modelli familiari della nuovagenerazione di lavoratori, le strategiecooperative, a cui partecipano sempre più inmodo paritario giovani donne e uomini,sembrano incorporare la flessibilità dellavita lavorativa nella vita quotidiana.
Molte ricerche mostrano le difficoltàdella vita delle nuove generazioni, dei loroprogetti di formazione di una famiglia configli (Barbagli, Castiglioni, Dalla Zuanna,2003; Piccone Stella, 2007; Salmieri, 2006).Se consideriamo il rapporto tra generazioni,vediamo come per la prima volta non solo ifigli vivono peggio dei genitori persituazione di lavoro e per il modo con cui sifronteggia il presente e il futuro, ma sono igenitori a sostenere i figli nella loro vitaquotidiana e nella conciliazione con la vitalavorativa.
Vediamo quindi che, per i giovani d’oggi,il percorso di vita dipende dalle possibilitàeconomiche della famiglia d’origine e dal cetosociale di appartenenza più che dal tipo dilavoro svolto. Di sicuro il lavoro flessibilenon offre stabilità al loro percorso, e quando
12
non soccorre l’aiuto dei genitori le giovanigenerazioni finiscono per vivere in modoprecario. Il termine precarietà ci appareadatto a definire le situazioni di vita deigiovani d’oggi, perché non riescono a pensareautonomamente al loro presente e non riesconoa progettare il loro futuro.
Nonostante l’evidente precarietà, loStato tarda a costruire un efficace sistema diflexsecurity mentre i Sindacati, bloccati nelvecchio ruolo della rappresentanza collettiva,manifestano una forte miopia nell’affrontarequesto problema. Una spiegazione è che il neo-liberalismo è dominante e pervasivo, ed ènella sua natura scorporare il lavoro dai suoiriferimenti sociali. Perciò, gli interventisul lavoro operano come neutrali eindifferenti di fronte alla disuguaglianzasociale, nei suoi termini di distribuzione eattribuzione di risorse economiche eculturali.
Invece, sono le risorse che costituisconoil capitale accumulato e trasmesso attraversole generazioni, a intervenire nellaformulazione dei progetti di lavoro e di vitadei giovani, e a condizionare la stessapercezione delle probabilità occupazionali.Intervengono, poi, nel momento in cui le loroaspettative si scontrano con la struttura delmercato del lavoro, dove le modalitàistituzionali finiscono per moltiplicare,
13
piuttosto che ridurre, le trappole dellavoro flessibile.
In quest’ottica, la scarsità di risorseeconomiche e culturali appare una trappolaconsiderevole per imprigionare i giovani neglispazi della precarietà e spessodell’esclusione dal mercato del lavoro.Tuttavia, a questa si aggiungono altretrappole, persino meno evidenti, come quellelegate al genere femminile. Poiché al generefemminile è strettamente correlata ladimensione sociale e familiare, le giovanidonne sembrano subire, un po’ più degliuomini, quella logica economica, puramenteneutrale, del mercato del lavoro flessibile edello Stato neo-liberale (Giannini 2004).
2. LA “PRECARIZZAZIONE” DEI GIOVANI: EVIDENZEEMPIRICHE DA NAPOLI
2.1. L’ipotesi della “precarizzazione”come categoria analitica dei giovani
Nello scenario che abbiamo delineato, èuna questione di senso comune quella cheriguarda l“adattamento” delle giovani donne edei giovani uomini alla flessibilità e alrischio precarietà nel mercato del lavoro. Equesto “adattamento” che riguarda i giovanidalle risorse scarse, che vivono laflessibilità del lavoro e della vita
14
quotidiana come un destino di precarietà, oggisembra allargarsi a quelli con una discretadose di capitale economico, sociale eculturale.
Nonostante ciò, notiamo che in paesioccidentali come l’Italia, i giovani nonmettono in atto azioni collettive di protestae di rivendicazione di lavori stabili. Adifferenza della precedente, questa nuovagenerazione non ha avuto esperienza dellacondizione di stabilità lavorativa e non hasviluppato una disposizione alla lottacollettiva mediata dalle organizzazioni dirappresentanza dei lavoratori. Inoltre,questi giovani non hanno vissuto, se nonattraverso genitori e parenti, le condizionidi vita, familiare e esistenziale, chefacevano riferimento al lavoro stabile, epossono aver sviluppato un adattamento allaprecarietà che coinvolge la loro vitaquotidiana e persino la loro strutturamentale.
Noi proponiamo perciò l’ipotesi della“precarizzazione”, come “interiorizzazionedella precarietà”, per cui in un certo sensopossiamo dire che i giovani d’oggi sembrano“precarizzati”. Una sorta di “precarizzazione”totale, termine che, come si è dettoall’inizio, ricalca quello di “operaizzazione”usato da Bourdieu (1984/2002, 1993), che ha, asua volta, parafrasato “asilizzazione”,
15
termine che Goffman utilizza in Asylums:Essays on the Social Situation of MentalPatients and Other Inmates Anchor Books NewYork (1961). In quest’ottica8 l’adattamentoalla cultura istituzionale, diventa quasi una“lotta di resistenza” per mantenere spazi didignità.
Diciamo ancora che la “precarizzazione”comporta non solo forme di “resistenza” maanche di “contrasto” alle forme neo-liberaliin cui si è istituzionalizzato il lavoro. Unelemento di contrasto è lo sviluppo dellerelazioni di genere, che può coniugarsi astrategie cooperative e solidali nei modellidi vita quotidiana delle giovani coppie.
Recentemente si è affermato che ildilagante liberalismo nel mondo globalediventa una sfida per le lotte e le politiche
8 Ripetiamo che è’ vero che Bourdieu e Goffman fannoriferimento a spazi organizzati e istituzionalizzatima non riteniamo di forzare troppo il concetto se loriferiamo a spazi sociali istituzionalizzati, comefacciamo per il mercato del lavoro flessibilemeridionale, e in particolare la città di Napoli comecampo delle ricerche. Per il concetto di lotta di“resistenza”, abbiamo attinto alle considerazioni diDal Lago il quale introduce la traduzione di Asylums initaliano (Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismidell’esclusione e della violenza. ed. Comunità, Torino2001), ed evidenzia una sorta di esercizio moralecompiuto da Goffman, il quale fa “parlare”la dimensionetipicamente umana della resistenza all’oppressione.
16
per il riequilibrio di genere (Walby, 2011,pp.11-13). In particolare, se nel mercato dellavoro è ancora fittizio il cambiamento nellerelazioni di genere, questo avviene perché ledonne hanno il carico maggiore delleresponsabilità domestiche. Perciò, si èdetto, proprio la famiglia potrebbe essere lafonte di “contro-movimenti” contro gli effettidel neo-liberalismo economico (Crompton 2002,pp. 538).
Nello specifico delle relazioni di generee dei modelli familiari, è vero che nell’epocadella stabilità lavorativa il modellofamiliare del padre breadwinner dominavaperché assumeva che il ruolo maschile è il piùimportante nell’ambito della coppiafamiliare9. Di più, la stabilità nel campoeconomico poggiava sui due pilastriistituzionali dell’economia e del sociale, daun lato, il lavoro a tempo indeterminato,generalmente, come si è detto, sottol’ombrello della grande organizzazione dellavoro, dall’altro, una famiglia integra e
9 Qui avremmo dovuto fare un approfondimento perdistinguere modelli familiari e comportamenti di generea seconda dell’appartenenza di classe sociale o aseconda del lavoro stabile, quello delle grandifabbriche manifatturiere o quello dell’impiegopubblico. Rimandiamo alle analisi che hanno affrontatoin parte questo tema, e che sono contenute in alcuniarticoli più o meno recenti (Giannini 1995 e 2004)
17
solidale, al suo interno e rispettoall’esterno, con ruoli di genere predefiniti.
Ma ora, nell’attuale fase di passaggiodalla stabilità alla flessibilità del lavoro,possiamo vedere la separazione tra economico esociale, anzi lo stretto legame tra forme dilavoro flessibili e marginalizzanti e ruoloprocreativo nella famiglia, un ruolo che, comeabbiamo visto dalle statistiche, gioca comefattore di esclusione delle donne dal mercatodel lavoro.
Allora, possiamo fare un sempliceparallelismo tra relazioni di genere e tipo diStato. Lo Stato del Welfare, nella sua fasematura, ha favorito il declino del padrebreadwinner con l’ingresso massiccio delledonne nel mercato del lavoro, specie neilavori detti femminili perché legati allasfera del sociale (Giannini 1995), e ha, nellostesso tempo, avviato la ridistribuzione tra ipartner dei carichi domestici.Differentemente, lo Stato neo-liberale sembradimenticare proprio le condizioni sociali e ledonne, che fanno binomio con sociale, in nomedi una neutralità economica.
Appare, invece, evidente quanto siastretto il legame tra lavoro e vitaquotidiana, quando notiamo che le risorseeconomiche, sociali e culturali della famigliahanno buon gioco ad articolare la stessaprecarizzazione, lo stesso modo di
18
interiorizzare la precarietà e quindi le lottedi resistenza e le lotte di contrasto al neo-liberalismo dominante nell’attuale mercato dellavoro e nella attuale forma di Stato.
L’ipotesi della precarizzazione, come finqui formulata, funzionerà come lente perrileggere i risultati di alcune ricerchecondotte a Napoli.
2.2. La precarizzazione di giovaninapoletani a bassa scolarizzazione.
La prima ricerca, che permette diriferire sull’ipotesi della precarizzazione edella “lotta di resistenza”, è stata condottasu un campione di giovani disagiati. Si eraintorno all’anno 2000, un periodo in cui gliinterventi dello Stato italiano avevano messoin moto la deregolamentazione neo-liberale delmercato del lavoro. Si cominciava ad assistereagli esiti di misure pubbliche che assegnavanoalla formazione professionale e all’impiegotemporaneo il compito di preparare i giovaniad entrare nel mondo del lavoro.
In quanto residenti in un’area di crisioccupazionale, un discreto numero di giovaninapoletani, per lo più a bassascolarizzazione, avevano avuto accesso aquelle misure. E’ importante dire chealeggiava una sorta di premonizione in alcuniricercatori, per cui non ci si aspettava cheper quei giovani le occasioni formative elavorative potessero costituire fonti di
19
riduzione delle disuguaglianze sociali, né chepotessero far acquisire competenze tali darenderli occupabili.10.
Il campione da intervistare è statoformato coinvolgendo destinatari e nondestinatari delle misure pubbliche, e glistessi sono stati intervistati ad un anno didistanza, per verificarne l’esito nel mercatodel lavoro11. Dalle interviste è apparso subitoche gli elementi cognitivi e esperienziali,acquisiti con il coinvolgimento nelleoccasioni formative, avevano avuto delleconseguenze. E se queste si sono rivelatequasi nulle sul piano degli sbocchioccupazionali, sono sembrate efficaci sulpiano della costituzione di un capitalesociale, che ha finito però per essere
10 In realtà, l’obiettivo della ricerca era quello dicapire quale sbocco lavorativo i giovani .andavanoprefigurando e in che modo il loro progetto e il loropercorso potessero essere influenzati da quelleoccasioni formative e lavorative di brevissimo periodo.La ricerca era coordinata a Napoli da Spanò (2001),mentre il coordinamento nazionale delle diverse unitàlocali della ricerca era stato affidato a Luciano(2002).11 In molti casi, i giovani, specie quelli intervistatiper la seconda volta, a distanza di tempo dallaconclusione del corso di formazione, apparivanovincolati alla percezione espressa sin dal principiosulla propria posizione nel contesto sociale eoccupazionale.
20
percepito più come supplemento di amicizia checome rete di sostegno sociale per trovarelavoro.
L’approccio dei percorsi biografici(Spanò 2001, pp.30-34) ha permesso dapprima dicostruire delle tipologie fondate sullarappresentazione del lavoro, precisandonedimensioni, quali il significato,l’atteggiamento e l’importanza del lavoronella vita quotidiana. (Clarizia, Maddaloni)12, tipologie che hanno messo in risalto lacostruzione identitaria dei giovaninapoletani. Quella che è stata definita la“generazione bloccata” (Giannini 2001a, p.40)mostrava, attraverso i racconti, la varietàdelle risposte individuali alle trappolesociali e, insieme, la varietà dei modi perresistere dignitosamente alla precarietà e airischi ravvicinati di esclusione dal mercatodel lavoro.
Innanzitutto, emergeva una percezionedelle trappole sociali che sembrava rendere laprecarietà lavorativa più una conseguenza di12 Le tipologie costruite sono numerose e definivanogli intervistati confusi, risvegliati, predestinati,consacrati, intrappolati, sbandati, defilati. Lanumerosità registrava non solo le diverse logiche diazione dei giovani ma il diverso grado di esposizione aquel rischio di esclusione dal mercato del lavoro chedefiniva l’orizzonte esistenziale della generazionenapoletana accomunata da poche e spesso scarsissimerisorse materiali e culturali.
21
limiti personali che dell’assettoistituzionale neo-liberale.
- La precarietà da trappola sociale a limitipersonali
Come possiamo avvertire facilmente dalleparole dei giovani napoletani intervistati, ilimiti personali incominciavano a rendersimanifesti già a scuola. In altri termini, lascuola era stata la prima istituzionerivelatrice del carattere della persona e,quindi, del destino di precarizzazione dellavoro e della vita.
Alcune interviste ci sembranoparadigmatiche. Come quella di Biagio, un uomodi 28 anni, che ha parlato del suo percorsocome di un fallimento dovuto alla debolezzadelle sue risorse personali: “A scuola poinon mi sono trovato bene non sapevo nemmeno iocosa volevo in realtà fare.. ho cambiatoistituto, ho perso tempo per prendermi unaqualifica di tre anni ci ho messo 5 poi ..non mi è andato bene, poi ho fatto un’attivitàautonoma ma anche qui non è andata bene civolevano capitali ho preferito nonavventurarmi sono psicologicamente moltoforte.. penso poi.. chi dice così è in realtàmolto debole “.
Alcune interviste hanno, poi, assunto unsignificato paradigmatico in relazione alcarattere di genere della percezione deilimiti sociali, laddove hanno avuto buon gioco
22
la rassegnazione e l’accettazione disegregazioni lavorative e sociali. Il raccontodi Rosalba, di 23 anni, ha riferito di una suapropria incapacità ad entrare in un mondo perlei troppo complicato, che è cominciatodall’apprendimento scolastico: “La maestra ospiegava molto in fretta o spiegava in modoche non capivo, con me ci voleva piùsemplicità … io avevo il terrore quellapersona mi ha dato sempre timore “
E poi, Gelsomina, giunta all’età di 30anni senza lavoro, ha pensato che “l’unicaalternativa che rimane è fare la cooperazionedomestica”, perché, come lei ha detto: “è unarealtà che devi affrontare, non ho diploma,non ho niente”. Ma anche Olimpia è sembratarassegnata a collocare le donne in un ruolotradizionale, quando ha ricordato: “Mia mammami ha tolto dalla scuola perché dovevo starein casa”.
Riflettendo sul genere, ci è sembrato cheper le donne fossero sempre in agguato “letrappole delle aspettative”, una definizionepresa in prestito da un’altra ricerca, in unaltro territorio, sull’inserimentooccupazionale dei giovani (Zurla, 1999).
Tuttavia, ci sono stati tentativi diesplicita “resistenza dignitosa” allaprecarizzazione totale e ci è sembrato fosserorappresentati dal modo con cui moltiintervistati davano meno importanza
23
all’occupazione e molto più all’affettività,spesso in modelli relazionali definiti,talvolta in alcune relazioni fluide, nonchiaramente definite. Questa “resistenza” puòessere notata in molte interviste13.
Interviste come questa di Rocco, undisoccupato di 24 anni, che non aveva trovatomai un lavoro fisso, che si arrangiava mastava cadendo in una situazione molto criticae che ha detto : “Sono sposato, ho una bambinadi tre anni, mi arrangio faccio un po’ ditutto”. Oppure Ignazio, che di fronteall’alternativa prospettata di andare lontanoa lavorare ha sostenuto: “ Sto con la miafamiglia.. e sto bene.. problemi con la miafamiglia non ne tengo ..sto fidanzato, mitrovo molto bene… con il lavoro mi arrangio…prima ero un po’ sbandato, però cerco sempredi trovare un lavoro meglio… di andare fuorinon me ne vado, perché sto bene qua”.
Inoltre, se tra questi giovani,generalmente, rassegnazione e recriminazioni13 Per dare conto dei casi paradigmatici delle tipologiecostruite nell’ambito della ricerca, questoatteggiamento si trova tra i confusi, e in parte tragli intrappolati e gli sbandati, ma anche tra idefilati, che pure, a differenza dei primi, sembravanogodere di risorse familiari in grado di tutelarli dalrischio dell’esclusione sociale, e persino ipredestinati, che mostravano di avere un capitalesociale familiare, pure se accumulato per la suaspecializzazione in lavori umili.
24
sembravano alternarsi, pure alcuni mostravanouna disponibilità alla flessibilità lavorativache scaturiva da una precisa intenzione diaccumulare risorse morali e relazionali, piùche abilità professionali, in vista di uninserimento nel mercato del lavoro. Abbiamonotato una reazione finalizzata a mantenere la“dignità” di “persona”, in modo da reagirealla precarietà che può “corrodere ilcarattere”, quello di cui parla Sennett(1999)14.
In verità, i giovani napoletani, che almomento dell’intervista avevano un’età intornoai 30 anni, presentavano diversi modi diintendere la dignità personale, non tanto comeesito di un progetto quanto di una speranza,una dignità sorretta talvolta dallatradizionale immagine sociale del breadwinner.Gli stralci di interviste riportati ci sembrache possano dimostrare quanto stiamoaffermando.
Infatti, Tonino ha detto: “Tra 2 o 3 annicon la qualifica che c’ho, se vado fuori lotrovo un posto di lavoro, so’ sicuro ditrovarlo”, mentre Alessandro ha confessato
14 Il titolo originale del libro di Sennett è Thecorrosion of character (1999) e al suo internoriferisce dell’espressione “capitalismo flessibile” edi come la flessibilità sta cambiando tutti i percorsidi lavoro e di vita fino ad avere impatto sul caratteredelle persone.
25
che il suo non è un progetto ma una speranzadi dignità: “…perché la speranza è dura amorire, di trovare qualcosa che mi fa sentirenon dico una persona normale perché io sononormale, ma una persona che c’ha un guadagno,c’ha da vivere e quindi che posso andareavanti”.
Una dignità di persona a cui ancheMassimo ha mostrato di non voler rinunciare,collegandola implicitamente al ruolo maschilenella società e nella famiglia: “Finora pureho guadagnato però sempre al nero e si vedevasubito in partenza che non era un lavoroserio, ma io non posso fare come gli altri chealla fine si sposano e si fanno mettere ilpiatto avanti, non esiste proprio , cioè unminimo di dignità, cioè un minimo di dignitàognuno lo dovrebbe avere …”.
- La flessibilità soggettiva nei percorsi”bricolage”A conclusione della ricerca, si è notato
che le biografie di questi giovani che stavanoaffrontando la precarietà e i rischi diesclusione dal mercato flessibile meridionale,avevano disegnato una mappa di “percorsibricolage” (Giannini 2001b). Questirappresentavano caratteristiche differenti,invero non molto differenti, per condizionisociali e culturali e modalità con cui si eraincorporata la precarietà del lavoro. Tuttaviasi potevano distinguere in percorsi “apatchwork” e “a scrittoio”.
26
I primi, quelli che avevamo definito “apatchwork” si presentavano nello snodarsi deivari lavoretti come un attraversamento tracompetenze di basso livello, eterogenee,acquisite in esperienze lavorative brevi e condiversi datori di lavoro. Questi tipi di“giovane bricoleur napoletano”, maggiormentediffusi nella realtà indagata, avevanomostrato una rassegnata disposizione allaflessibilità lavorativa e davano un sensoriflessivo del sé alla precarizzazione dellavoro e della vita.
Davvero raramente i “percorsi bricolage”si presentavano con competenzesufficientemente coerenti, di livello medio,acquisite in esperienze lavorative coerenticon la base culturale e professionale, quasicome se fossero state ordinate “a scrittoio”.Qui si avvertiva una disposizione ad un lavoroi cui caratteri potevano essere conciliabilicon le dinamiche della flessibilitàistituzionalizzata, ma non necessariamente conderive nella precarietà.
Comunque, molto spesso, come si è visto,la costruzione del percorso rimaneva vincolataalla percezione delle probabilitàoccupazionali così come il mercato le offriva.Soprattutto, si vedeva bene come il più bassolivello di capitale sociale e culturale e, diconseguenza, la percezione dei limiti socialialla progettazione formativa e lavorativa
27
portava il giovane ad interiorizzare laprecarietà del lavoro, così come gli apparivanello spazio sociale in cui si muoveva.
Di tutti i giovani conosciuti attraversole interviste, è sembrato che la visione delmondo rimanesse limitata dai confini dellospazio sociale in cui si muovevano e in cui,spessissimo, finivano per rimanereintrappolati. E’ sembrato evidente che nonsono riusciti ad uscire dalle trappole, eanche che erano consapevoli di non poterneuscire. Senza strumenti di lotta collettiva esolidale, e senza aiuti istituzionali come puòapprontare lo Stato del Welfare, strumenti chepure avevano sperimentato i loro padri, lasolitudine di questi giovani si stempera nellerelazioni affettive.
Alla fine della ricerca a Napoli, è stataforte la nostra convinzione che il concetto dilavoro flessibile stava riferendo di unaflessibilità soggettiva, personale, nonproprio alla maniera di Rico, “l’uomoflessibile” di Sennett (1999), ambizioso e incarriera, ma alla maniera di “Ciro”,anagramma di Rico, “l’uomo flessibile” diSpanò (2001, pp.18-24). Il ritratto emersoera quello di un giovane napoletano che avevafatto del bricolage l’arte dell’arrangiarsitra i lavori e della precarizzazione unarassegnata modalità del sé.
28
2.3. La precarizzazione tra lavoro e vitaquotidiana di giovani coppie napoletane
La seconda ricerca è stata realizzataanch’essa a Napoli, ed è collegata idealmentea quella precedente, perché riguarda illavoro flessibile e le conseguenze sullarelazione di coppia e sul modo di gestire lavita quotidiana. Rispetto alla prima ricercasembra rappresentare una sorta di “secondotempo”, proiettato a distanza di circa unquinquennio.
Siamo nel 2005, ormai si è compiuta deltutto la istituzionalizzazione dellaflessibilità nel mercato del lavoro neo-liberale. E’ diventata cruciale la questionedei giovani, della loro ritardata entratanella vita adulta e nel mercato del lavoro. Igiovani coinvolti nel lavoro flessibile enelle sue trappole non sono più solo quellisocialmente disagiati.
Per questo, a differenza del campionedella precedente ricerca, i giovani oraintervistati hanno un livello discolarizzazione prevalentemente medio-alto,ma, ugualmente, essi posseggono contratti dilavoro talmente diversi da rappresentare benel’arcipelago di possibilità che il mercato dellavoro flessibile offre. Per l’indagine sono
29
state campionate 21 giovani coppie, in cuinessuno dei partner lavora stabilmente15.
Usando la questione abitativa come unalente per “disvelare”16 la complessità delrapporto tra lavori flessibili e vitaquotidiana, l’obiettivo della ricerca si èfocalizzato sulle modalità con cui sigestiscono i problemi che sorgono nel momentoin cui i giovani non possono fare affidamentosulla continuità del lavoro, in termini,ovviamente, di retribuzione, ma anche diorganizzazione dei compiti domestici 17.
Anche in questa ricerca l’approccio èqualitativo e anche qui le biografie ci hannorivelato una pluralità di modi di affrontarela precarietà (Madonia 2011). Questa sembraaccettata quando si collega all’idea di essereimprenditori di se stessi e al rifiuto di
15 Le coppie intervistate sono residenti per la maggior parte in quartieri del centro storico di Napoli, la durata della loro convivenza nella stessa casa va da unanno a otto anni.16 Termine che avrebbe usato Bourdieu17 Come la precedente, la ricerca si è svoltanell’ambito di un programma nazionale, coordinato da S.Piccone Stella (2007), mentre a livello locale lacoordinatrice è stata G. Orientale Caputo (Giannini,Orientale Caputo 2007, 2011). L’obiettivo generaledella ricerca è stato quello di capire in che modo legiovani coppie rispondono alla flessibilità del mercatodel lavoro e in che modo reagiscono sfruttandone leopportunità o pagando i prezzi della precarietà.
30
lavorare in modo monotono e ripetitivo, marisulta più fortemente vissuta da quantisentono di subire più che scegliere lavariabilità delle condizioni dell’occupazione.
Si ha l’impressione di rivedere all’operaquei percorsi bricolage, che già emergevanonella ricerca sui giovani disagiati degli anniduemila, “a patchwork” e “a scrittoio”. Soloche, in questa indagine si vede come ilriferimento per distinguerli è meno legato alcapitale culturale e più alla situazione didepauperamento.
I risultati di questa ricerca aggiungono,quindi, un altro tassello all’analisi dellaprecarizzazione del lavoro e della vita deigiovani nel quadro del neo-liberalismo cheallarga la flessibilità del mercato del lavoroe spazza via il sostegno sociale dello Stato achi non ha capitale materiale e culturale. E’il racconto della vita quotidiana che, pur coni limiti propri del racconto di sé e dellecondizioni in cui si realizza il vissuto dicoppia, ha permesso di capire qual è illivello di sviluppo delle relazioni di generee che importanza ha nel modo in cui i giovaniaffrontano la flessibilità lavorativa.
Abbiamo la convinzione che questo tipo diindagine possa andare oltre le ipotesi dellaprecarizzazione e delle lotte di resistenza, acui si è già trovato il riferimento empirico,e così riferire dell’ipotesi, prima avanzata,
31
che il riequilibrio di genere diventi unaformula di contrasto alle derive del neo-liberalismo18. In particolare, abbiamo rilevatouna forma di contrasto alla precarizzazioneche consiste nel modo solidale in cui siorganizza la vita quotidiana e si configura larelazione di genere nelle “coppieflessibili”19.
Infatti, oltre ai modi diversi diinteriorizzazione della precarietà a secondadelle risorse sociali e culturali, assistiamoalla realizzazione di modelli complessi dicomportamento con cui si affrontano i problemidel lavoro e della vita quotidiana. In altritermini, quando la flessibilità lavorativa èrappresentata da un patchwork di diversilavori, svolti a intermittenza ma anchecontemporaneamente, si delineano strategie di“adattamento” 20, che si traducono in una
18 Abbiamo già detto che questa ipotesi riprende untema entrato ormai nell’agenda della sociologiafemminista europea (Walby 2011). 19 Questo è il titolo del libro di Salmieri (2006), che ha partecipato alla ricerca.20 Hochschild (1983) sostiene, nel suo libro sulrapporto tra sentimenti di coppia e mondo economico,che “Ad ogni strategia d’azione corrisponde un percorsoemotivo differente ma anche un insieme differente diconseguenze emotive” ( la citazione è nella traduzioneitaliana 2006, p. 129)
32
pluralità di sentimenti, ansia, apprensione maanche di solidarietà all’interno della coppia,e oltre la coppia visto che finisce percoinvolgere le famiglie d’origine.
- Sentimenti di coppia di fronte alla precarietàInnanzitutto, diciamo che tra i giovani
appare netta la consapevolezza che laflessibilità del lavoro finisca per essereprecarietà. Mario, un diplomato di 34 anni, hadefinito bene la situazione: “La precarietànon è solo nella durata ma anche nel reddito,poiché dipende dalle ore ,… le ore possonoanche dipendere da te … Comunque io credo diessere lo specchio di una generazione quelladei trentenni che vive in pieno il disagiodato dal passaggio da un certo tipo di mercatodel lavoro ad un altro, appunto quellocaratterizzato dalla flessibilità come diconoquesti signori, ma che in realtà si tratta diprecarietà come sanno tutti”.
Infatti, anche il sentimento diconsapevolezza delle proprie risorse culturaliche porta all’accettazione della flessibilitàdel lavoro è umiliato dal fatto che si scopredi non avere più il controllo della gestionedei propri tempi, né la possibilità di esserecreativi e autonomi, né la possibilità diaffrontare serenamente la nascita di unfiglio, come è successo a Bruno e Concetta,lui diplomato di 29 anni, lei laureata di 26anni. Concetta dice: “ tutti dicono che questi
33
lavori ti danno molto più tempo… io preferireiavere meno tempo, ma meno angosce.. non hainemmeno una vera autonomia perché in realtàdevi sottostare alle regole come tutti ilavoratori dipendenti”.
Ed è forse la consapevolezza di vivereuna situazione in bilico, non solo rispetto alfuturo ma anche al presente, che produceansia, persino per chi, come Maria e Marco,lei 35 anni, lui 32, entrambi laureati especializzati, con capitale economico eculturale molto elevato, con un lavoro chepercepiscono da libero professionista, ma“senza i margini del guadagno enorme dellibero professionista”.
Maria manifesta così l’apprensione:“chiaramente noi dobbiamo tendere ad unasituazione di stabilità. E stiamo costruendo,nella nostra precarietà un minimo.. unastabilità nella precarietà, non so come dire,per ora non c’è la stabilità dei soldi. .. E’questo il problema, l’ansia. Sì, possiamoavere una stabilità di contratti a mediotermine, ma ci manca i pagamenti: o ci paganoin ritardo o..”. Lo stato apprensivo diventauna modalità emotiva interiorizzata, come diceRuggero, che ha 31 anni e un master, e chevive con Maddalena, una laureata di 37 anni:“Mah, a livello psicologico, sinceramentel’instabilità certo non ti fa stare bene, però
34
è come se ci fossi abituato, diciamo … perchéormai non c’è un’alternativa”.
Comunque, è comune la convinzione che illavoro non sarà mai stabile, e da un certopunto di vista neanche lo si vuole. Raffaella,artista restauratrice di 39 anni, dice:“Innanzitutto non cambierei mai, se perstabilità si intende un impiego pubblico, ogginon è questo che cerco, non so… se un giornomi venisse fatta la proposta forse accetterei.Sicuramente la stabilità economica è legataanche ad un lavoro…”.
C’è chi come Marco, il regista di 29anni, marito di Nives se ne fa un vanto diaver rinunciato ad un posto nell’industriadell’auto dove, a suo dire, “i dirittivenivano spesso ignorati”, ma anche chidenuncia il disagio della libertà edell’autonomia. Glauco, operatoremulticulturale, 34 anni, sposato con Alida, 31anni, assegnista di ricerca, rinuncerebbe ai“vantaggi legati alla libertà e al fatto chefaccio ciò che mi piace” e ammette: “se mioffrissero un lavoro di 6 o 7 ore al giorno,per 1000 euro al mese, ma stabile, forsel’accetterei”.
In tutti i casi, non viene mai meno lasperanza di “una regolarità” che lasci spazioalla vita. Ciro, 30 anni, laureato ededucatore a progetto, marito di Melissa di 28anni, con una situazione certamente non da
35
benestanti, dice: “ Gli impegni lavorativi econtrattuali devono essere un po’ più regolariin modo che le persone hanno un tempo perlavorare e un tempo per vivere. Invece questacosa, ecco, di auto-organizzarsi ti invadeproprio le sfere, non c’è più distinzione dispazi, tempi, luoghi, tra lavoro e privato. E’rischiosa come cosa… almeno io così la sento”.
Insomma, ad eccezione di due o trecoppie, tutte soffrono della precarietàeconomica, derivante dalla limitatezza dellerisorse economiche, vuoi per la pocaremunerazione dei lavori svolti, vuoi per lemodalità irregolari di pagamento, in ogni casomai prevedibili. Certo, se chi ha risorseeconomiche e culturali denuncia il disagio diquella che potrebbe essere vista comeoccasione di libertà e di autonomia, chi ne hapoche di risorse mostra ansia epreoccupazione, avverte la precarietà comepericolosa, sente fortemente a rischio unapropria vita futura, anche di coppia.
- Integrazione delle discontinuità nella solidarietàdi coppia e tra generazioni
Nel presente, quello che è grave sono leconseguenze della discontinuità nel lavorosulla gestione quotidiana delle coppienapoletane. La discontinuità dei redditi dalavoro contrasta, poi, con i ritmi e lescadenze dei pagamenti dell’affitto, dellebollette della luce o del telefono. Da molte
36
interviste sembra che la formazione di unacoppia finisca per rinforzare una strategia disuperamento di questa discontinuità, unastrategia di “integrazione delle discontinuitàdei redditi” che assicura la continuità dellespese per le esigenze quotidiane.
Questo avviene in molte coppie. Ilcompagno di Chiara, 32 anni, educatrice aprogetto si chiama Dario, e a 27 anni e conuna laurea in ingegneria elettronica, èufficialmente istruttore in una palestra. Suiredditi lui dice “se finisce il mio finisce ilmio, se finisce il suo finisce il suo, perciòvengono gestititi separatamente, però è ovvioche se sta finendo il mio c’è quello suo eviceversa”. E anche Concetta, 26 anni con unalaurea, compagna di Bruno, di 29anni,cameriere diplomato, dice: “il denaro logestiamo entrambi, quello è, lo organizziamoin base alle spese che abbiamo”.
Come per le discontinuità di reddito,anche rispetto alla pluralità di orari dilavoro, le strategie di coppia sembranooperare una sorta di “integrazione degli orarie delle disponibilità di tempo” per gestire lefaccende domestiche e le attività di cura. Igenitori sono inclusi, quando è possibile, senon lavorano o se non abitano troppo lontano,o se possono pagare un aiuto domestico.
Talvolta, però, lo stress insopportabile.Una coppia sposata, Marianna e Rodolfo,
37
laureati, rispettivamente di 38 e 44 anni, siorganizzano “a turni” per stare con ilbambino, ma “se non è possibile e se a Rodolfonon serve la macchina”, lei lo porta “a casadi mamma che è più vicina al posto di lavoro”,se invece “la macchina serve a Rodolfo” e selei fa tardi “lo passa a prendere lui”,altrimenti, se Rodolfo non può, è il padre“che accompagna lei e il bambino a casa”.
Non c’è dubbio, come si vede, che questesituazioni di discontinuità lavorativa e diflessibilità oraria possano costituire unaspinta a non allentare i legami fra legenerazioni21. Solo che lo scivolamento dallaflessibilità del lavoro alla precarizzazionedella vita dipende non solo dalla situazionedei giovani ma anche da quella delle famiglied’origine. Fondandosi sulla solidarietà,talvolta sull’annullamento dei confini tra legenerazioni, se le famiglie d’origine nonpossono costituirsi in sostegno continuo allenuove coppie, possiamo dire che la trappoladel lavoro flessibile finisce per accomunare
21 Barbagli, Castiglioni, Dalla Zuanna (2003, pp.39-198)) parlano in termini di convenienza. La nostraipotesi intende valorizzare i sentimenti di solidarietàdei genitori, così come quelli di cooperazioneaffettiva che accompagnano i nuovi equilibri nellerelazioni di genere, permettendo la conciliazione tralavoro e vita quotidiana.
38
nella precarizzazione coppie vecchie e coppienuove.
Dario, l’ingegnere elettronico che fal’istruttore in palestra, confessa: “lasituazione economica è buona ma non per meritomio, nel senso che le mie entrate sonoregolarmente quel paio di centinaia di eurodei corsi e basta. Tutto il resto sono entrateestemporanee. Quindi non sarebbe per nientebuona. Considerando, comunque, che ci sono imiei che ci danno una mano… e considerando chenon solo i genitori di lei le danno una mano,ma che lei sta iniziando a lavorare piùregolarmente, è una situazione ottima. Setogliamo invece tutti i regali che mi vengonofatti la situazione è disperata, cioè nelsenso che si riesce sempre a campare ma èdifficile”.
Mentre Mario, diplomato di 34 anni,compagno di Claudia, 37 anni e laureata, conuna famiglia abbastanza povera, dice: “Guardaci siamo basati fondamentalmente sulle nostreforze economiche, almeno ti parlo della miafamiglia, che non poteva aiutarmi più di tantovivendo in una situazione di precarietà più omeno come la mia nonostante una vita dilavoro, pertanto, più di tanto, non gli si puòchiedere”
E ancora Gianni, di 36 anni, con licenzamedia, imbianchino, sposato con Federica, 31anni laureata, che lavora al call center,
39
racconta di come hanno arredato la casa:“Qualcosa l’ho trovato nella spazzatura Questacucina me l’ha data mia zia, il frigoriferol’ho pagato 50 euro seminuovo, il materassoera di un parente che è deceduto”. E Rodolfo eMarianna, una coppia con bambino, che abbiamogià incontrato: “le nostre famiglie non cidanno un aiuto economico, piuttosto quando ilfine settimana andiamo a pranzo una volta daisuoi una volta dai miei, a turno, se mia madreo sua madre preparano qualcosa, ne fanno inpiù .. ed effettivamente è anche un risparmio,questo”.
- Relazioni di genere nella vita quotidiana dellecoppie
A questo punto, sorge spontanea ladomanda sul perché questi giovani hannoavviato una relazione di coppia e sono andatia vivere da soli con una situazione diprecarietà senza prospettive di stabilitàlavorativa e spesso non autosufficienzaeconomica. La motivazione dichiarata riguardail desiderio quasi sempre di rendere stabileun legame affettivo, talvolta per rispetto diquelle convenzioni sociali e culturali chevogliono che si viva da adulti ad una certaetà o in presenza di figli, talvolta con laconvinzione della sua reversibilità.
“E’ un passo un po’ irresponsabile cheabbiamo fatto. Ma se uno guarda ai prossimianni che saranno di possibile precarietà
40
diveniva troppo frustante trasportare questadecisione fra altri dieci o quindici anni”,dice Raffaella, la restauratrice.“Fondamentalmente la convinzione e ildesiderio di farlo, abbiamo messo insieme iredditi che avevamo e che derivano appunto dailavoretti precari che svolgiamo”, rispondeAntonio, il suo compagno, docente a progetto.
Dalle interviste alle coppie campionateemerge anche un modello relazionale che ci èsembrato nuovo rispetto a quello dellaprecedente generazione e certamente non vi èdubbio che la tendenza al cambiamento nellerelazioni di genere sia intrecciata con lesituazioni del lavoro flessibile.
Non è solo il declino del maschiobreadwinner nel mercato del lavoro (Crompton1999), ma è la continua ristrutturazione dellavita quotidiana che porta allaristrutturazione delle relazioni di genere. Equesto avviene quando si devono prenderedecisioni e si cercano soluzioni e compromessisui modi di organizzare il tempo, il denaro elo spazio, influenzati e spesso costretti daimodi organizzativi e temporali del lavoroflessibile.
Questa ristrutturazione della vitadomestica porta a modalità relazionali tra leie lui, che solo in parte sono rappresentate daquelle di Rico e Rose, la coppia di Sennett(1999), o da quelle delle giovani coppie di
41
Kaufmann (1995). In realtà, le coppienapoletane, prevalentemente coppie di fatto espesso con combinazioni fino a poco tempo fadavvero rare22, rivelano mutamenti relazionalitalvolta negoziati talvolta spontanei, e,certo, anche permanenze della tradizionaledivisione dei ruoli, spesso inconsapevoli.
Il caso estremo è quello di Alberto,laureato e con un contratto di livellodirigenziale, compagno di Annalisa, 30 anni,laureata educatrice, ora incinta, chedichiara: “Faccio davvero tutto io”. All’altroestremo c’è Obed, 39 anni laureato etraduttore, che “ fa tutto”, perché il suocompagno Alessandro, laureato e speakerradiofonico “non c’è quasi mai in casa”.Quest’ultima è una coppia gay che ripropone latradizionale fissità dei ruoli forse perché suquesti si fonda la costruzione delle identitàdi genere.
Comunque, nel complesso delle coppiecampionate, abbiamo potuto individuare tremodalità che definiscono le relazioni digenere. La prima riguarda sei coppie ed èstata definita ad appannaggio femminile. Inqueste coppie le incombenze domestiche gravanoesclusivamente su di lei, come nel caso22 Si sarà notato che nelle coppie esistono asimmetriedi età e di livello di scolarizzazione, e spesso l’etàdella donna è maggiore di quella dell’uomo ed anche iltitolo di studio è superiore.
42
conosciuto di Ciro e Melissa, e Ciro dice: “Lei ad esempio nei servizi è normale, hamaggiore dimestichezza, io nello sporcare hopiù dimestichezza di lei”.
La seconda modalità, la meno diffusa,riguarda quattro coppie, ed è quella cheabbiamo definito di parità apparente. Sebbeneentrambi nella coppia dichiarino una certaequa suddivisione dei compiti, alla fine, leicomunque risulta essere la referenteprincipale per quanto riguarda le faccendedomestiche. Tale gruppo comprende una grandevarietà di casi che vanno da quella in cui “sucerte cose lei ha maggiore dimestichezza”, aquella di Antonio e Raffaella, che abbiamoprima citato, in cui lui “non sa usarel’oggetto lavatrice” pur essendo un esperto diinformatica (!). Insomma, lui può anchepartecipare attivamente alla gestione dellacasa ma si limita a fare quel che può.
In queste coppie rientrano anche alcunicasi in cui “l’incompetenza” o piuttostol’indolenza di lui si infrangono sulle fortipretese di parità di coppia accampate da lei,per cui certi compiti (di solito lavare estirare i panni, indicatore della modalitàrelazionale di coppia secondo Kaufmann 1995)vengono prese in carico piuttosto dalla madredi lui.
La terza modalità di relazioni genere èquella che riguarda la metà delle nostre
43
coppie e che abbiamo definito di vera paritànella distribuzione delle mansioni. Sia leiche lui svolgono tutto quello che riguarda lacasa e le faccende domestiche nel finesettimana, non presentano una distribuzionesessuata dei compiti domestici anche se questonon significa che non vi siano divisionistandardizzate delle responsabilità,l’atteggiamento prevalente è quellocollaborativo fra i due.
Rientrano in questa modalità anche quellecoppie che sono giunte ad una miglioredivisione dopo una contrattazione (voluta dalei) più o meno dura, come quella coppia conbambina, già incontrata, in cui Maddalena, lasociologa, dice a suo marito Ruggero, ilprogettista sociale: “Considera di coabitarecon un tuo collega, non mi considerare lamoglie, quella che ti leva il piatto da tavolacome tua mamma, non ti aspetteresti mai che untuo collega di lavoro ti levi il piattodavanti “ e dopo questo discorso lui èdiventato molto collaborativo.
3. SENTIMENTI E VIRTU’ PRIVATE IN PROSPETTIVA
44
In chiusura, vogliamo sottolineare alcunirisultati delle ricerche, in particolare dellapiù recente ricerca sulle coppie napoletane.Abbiamo potuto vedere come i giovani mettanoin atto strategie di “adattamento” allaprecarietà della vita lavorativa e della vitaquotidiana. In questa ottica, due percorsisembrano emergere, rispetto al futuro erispetto al presente.
Rispetto al futuro, la precarizzazione sirappresenta come una sorta di rimozionecollettiva del futuro non solo lavorativo maanche sentimentale. Rispetto al presente, laformazione della coppia e la divisione deiruoli di genere nella gestione della vitaquotidiana, finiscono per rinforzare unastrategia di superamento della discontinuitàlavorativa, una strategia di integrazionedelle discontinuità dei redditi che assicurala continuità nella gestione delle esigenzequotidiane.
In conclusione, appare che nel quadrodella precarizzazione totale emergano percorsidi sentimenti, di solidarietà di coppia, dicooperazione affettiva che accompagnano inuovi equilibri nelle relazioni di genere. E,come si è visto, a questa solidarietà sembranopartecipare attivamente le famiglie diorigine.
Perciò appare che nella attuale societàdove tutto è flessibile, anzi precario, il
45
tutto sembra tenersi insieme grazie asentimenti e virtù private. Certamente questevirtù, che comprendono anche più equilibraterelazioni di genere, finiscono per risponderealle lacune di uno Stato neo-liberale chescorpora problemi sociali dalle logicheeconomiche, trasferendo sulle risorseindividuali i costi quotidiani dellaflessibilità lavorativa.
Secondo l’ipotesi avanzata nei paragrafidi apertura, e come si è notato dallericerche, in particolare dalla più recente, lasolidarietà da collante dell’azione collettivae rivendicativa di tutele legate al lavorostabile, si trasforma in solidarietà“familiare”23, per resistere alle trappole deilavori flessibili.
Di più, sembra proprio che queste virtùprivate, in particolare la più equilibrataridistribuzione delle responsabilità tra donnee uomini, nel lavoro ma soprattutto nella vitadomestica, finiscono per porsi in una logicadi contrasto al neo-liberalismo, dal momentoche oppongono il sociale all’economico, o, cheè quasi lo stesso, il genere alla neutralità.
23 Ovviamente per famiglia si intende la coppia di giovani, i loro genitori e spesso anche i parenti o gli amici più intimi.
46
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Barbagli, Castiglioni, Dalla Zuanna(2003), Fare famiglia in Italia. Un secolo di cambiamenti,Il Mulino Bologna
Bourdieu P, (1993), sous la direction de,La misère du monde, Editions du Seuil, Paris.
Clarizia P. e Maddaloni D. (2001),“Biografie, costruzioni identitarie erappresentazioni del lavoro e delladisoccupazione nei giovani inoccupati a bassascolarità”, in Spanò, cit pp. 157-212
Crompton R., (1999), Restructuring GenderRelations and Employment. The decline of the MaleBreadwinner, University Press, Oxford
Crompton R., (2002), “Employment,flexible working and the family”, in BritishJournal of Sociology, Vol. 53, N. 4, pp. 537, 558.
47
Dore R., (2005), Il lavoro nel mondo che cambia,Il Mulino, Bologna
Giannini M, Orientale Caputo G., (2011),Casa lavoro Futuro, Liguori , Napoli
Giannini M, Orientale Caputo G.,(2007),“La casa senza radici”, in Piccone Stella,cit.
Giannini M. (2001 b), “Formazionecompetenze e flessibilità del lavoro”,Intervento al 2° Workshop di OrganizzazioneAziendale Flessibilità & Performance Padova 1-2 febbraio 2001
Giannini M., (1995) “Le don au féminin” inRevue du MAUSS, n. 6 (trad. de S. Latouche dellaversione italiana "Il dono femminile", in ITInterpretazioni Tendenziose, n.1,1994)
Giannini M., (2001 a), “Mercato de lavorolocale e politiche per l’occupabilità”, inSpanò, cit. pp.37-76
Giannini M., (2004) “Questioni di generenel mercato del lavoro”, Economia & Lavoro,n.2/3, pp. 225-49
Giannini M., (2009), a cura di, Ugualesalario per uguale lavoro? Ricerca sui differenziali retributivitra donne e uomini in Toscana, (Introduzione pp.17-28), Franco Angeli, Milano
Hochschild, A. R. (1983), The Managed Heart:Commercialization of Human Feeling. Berkeley, CA:University of California Press. trad. it. Peramore o per denaro: La commercializzazione della vitaintima, Il Mulino, Bologna, 2006
48
Hollister N.M., (2012), “Employer andOccupational Instability in Two Cohorts of theNational Longitudinal Surveys”, The SociologicalQuarterly 53, pp.238-263
ISTAT, Rapporto annuale sul mercato dellavoro, 2012, www.istat.it
Kauffmann J.C., 1995, Trame coniugali.Panni sporchi e rapporto di coppia, Dedalo,Bari
Luciano A., (2002) a cura di, Politiche dellavoro. Linee di ricerca e prove di valutazione, Intro pp7-22., FrancoAngeli 2002
Madonia E., (2011) “Una chiave di letturadella complessità: le cinque dimensioni dellaprecarietà”, in Giannini M., Orientale CaputoG., cit , pp.13-34
OECD, Employment Outlook 2012,www.oecd.org
Palmieri R. e Perone S., (2001), “I corsidi formazione professionale e i Piani diinserimento professionale a Napoli. Ritrattodei giovani intervistati”, in Spanò, cit. pp.132-156
Piccone Stella S. (2007), a cura di, Traun lavoro e l’altro. Vita di coppia nell’Italia postfordista,Carocci, Roma
Pitkin D., (1992), La casa che Giacomo costruì.Romanzo antropologico, Dedalo Bari
Salmieri L., (2006), Coppie flessibili. Progetti evita quotidiana dei lavoratori atipici, Il Mulino, Bologna
49
Sennett R. (1999), The Corrosion of Character.The Personal Consequences of Work in the New Capitalism,Norton & Company, New York- London
Spanò A. (2001), a cura di, Tra esclusione einserimento. Giovani inoccupati a bassa scolarità e politichedel lavoro a Napoli, Franco Angeli, 2001; Intropp.9-36 sul metodo narrativo p.30-34
Walby S., (2011), The Future of Feminism,Polity Press, Cambridge
Zurla P., (1999), Giovani elavoro:rappresentazioni e percorsi: Scelte formative edopportunità occupazionali al femminile e al maschile nelcomprensorio lughese, FrancoAngeli, Milano 1999
50