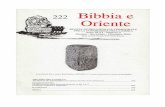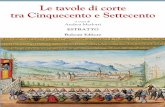Telve 2002 - Prescrizione e descrizione nelle grammatiche del Settecento (II parte)
Transcript of Telve 2002 - Prescrizione e descrizione nelle grammatiche del Settecento (II parte)
STUDI LINGUISTICI ITALIANIDIRETTI DA ARRIGO CASTELLANI
E LUCA SERIANNI
VOLUME XXVIII(VII DELLA III SERIE)
FASCICOLO II
SALERNO EDITRICE • ROMA
MMII
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 229 del 9.5.1996
Il volume viene stampato con un contributo del CNR
Tutti i diritti riservati - All rights reserved
Copyright © 2002 by Salerno Editrice S.r.l., Roma. Sono rigorosamente vietati lariproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsia-si uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, lamemorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della
Salerno Editrice S.r.l. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
Direttore responsabileLuca Serianni
RedazionePaola Manni, Nicoletta Maraschio, Giuseppe Patota,
Pietro Trifone
Segretario di RedazioneLuigi Matt
Comitato scientificoAldo Menichetti (Friburgo), Michael Metzeltin (Vienna),
Max Pfister (Saarbrücken), Edgar Radtke (Heidelberg),Serge Vanvolsem (Lovanio)
Gli articoli e le note più impegnativi proposti per la pubblicazione negliSLI sono sottoposti di norma al parere vincolante di almeno due degli studiosiinternazionali che fanno parte del Comitato.
197
PRESCRIZIONE E DESCRIZIONENELLE GRAMMATICHE DEL SETTECENTO
(seguito)
5. Fattori linguistici
Confrontando il Corticelli e il Soave su alcuni fatti di sintassi, s’è accen-nato a un certo impressionismo del primo rispetto al secondo, che nell’os-servare (e interpretare) il fenomeno grammaticale tenta invece di rimane-re all’interno dei fatti linguistici. A ben vedere, la venatura impressionisticaravvisata nel Corticelli non è circoscritta solo a quel luogo della gramma-tica né è soltanto sua; ma si tratta di una tendenza di molti grammatici, daascrivere a un atteggiamento di portata generale.
Una delle acquisizioni della riflessione grammaticale post-cinquecente-sca è la constatazione, ineludibile per ogni grammatico, che la mutevolezzae la varietà di usi sono caratteri intrinseci di ogni lingua.72 Più forte chenon nelle grammatiche del passato (innanzitutto cinquecentesche) è l’aspi-razione a guardare alla lingua come a un oggetto da descrivere osservando-ne non solo la relativa fissità (e con intenti perlopiù normativi), ma anchele oscillazioni.
Una buona parte del materiale linguistico col quale i grammatici si tro-vano ad avere che fare è per loro facilmente analizzabile solo là dove èancora ben saldo il discrimine segnato dalla tradizione grammaticale:innanzitutto, quindi, tra ciò che è della prosa e ciò che è della poesia. Piùincerto è invece il confine degli altri àmbiti d’uso, che l’egida della normanon può proteggere altrettanto efficacemente: antico, moderno, popolare,regionale/dialettale, familiare; àmbiti non sempre nettamente distinti. Ilmateriale di sfrido, se così si può dire, giacente dopo questa sgrossatura,cioè quello che sfugge alle classificazioni e che nel corso del tempo, mutandola sua sfera d’uso, si è sottratto al giudizio espresso dai grammatici prece-denti situandosi in uno stato di incertezza, viene comunque raccolto eclassificato e, nell’impossibilità di esprimersi in termini di registro, si ricor-re a volte a giudizi impressionistici e a criteri genericamente eufonici; unabito mentale che sconfina facilmente (anche se non troppo di frequente)in speculazioni sofistiche e logicizzanti. Parte di questo materiale è infineordinato in liste di allotropi che i grammatici allineano senza riguardo per
72. Cfr. Simone, Seicento e Settecento, cit., pp. 321-22, e Patota, Percorsi, cit., pp. 111 e sgg.
stefano telve
198
la diversità delle connotazioni, testimoniando limpidamente la tendenzaad osservare il mero fatto linguistico.
Si tratta insomma di quattro momenti principali, nei quali s’avverte com-plessivamente la pressione dell’atteggiamento descrittivo a scapito di quelloprescrittivo (e, di conseguenza, un certo riassestamento della nozione di “nor-ma” e del suo ruolo all’interno della grammatica): constatazione della varietào variabilità linguistica (§ 5.1), resistenza dell’impressionismo (§ 5.2) e di de-rive logicizzanti (§ 5.3), tendenza al descrittivismo puro: le allotropie (§ 5.4).
5.1. La varietà linguistica
«La varietà, ancor nella lingua, è bellezza» è massima del Bartoli (Torto,p. 402) e motto che potrebbe essere assegnato come un ideale cartiglio allospirito grammaticale del suo tempo. L’allargamento della nozione di uso inuso parlato e l’accettazione nella lessicografia fra Cinque e Seicento dellalingua popolare e degl’idiotismi (di conserva con «l’accoglimento della de-nominazione di ‘lingua toscana’, con la quale si indica, secondo il Buom-mattei, “quella lingua toscana che si parla ne’ miglior paesi della provin-cia”»)73 sensibilizza i grammatici anche nella prassi normativa concreta;tuttavia la soglia che separa il rilievo descrittivo dal rilievo prescrittivo nonappare sempre ben distinguibile.
In generale, quale che sia l’asse di variazione lungo il quale si trovano adessere disposte le forme in opposizione citate dai grammatici, può essererischioso ritenere immediatamente dotata di valore anche normativo lasemplice menzione di una forma, che potrebbe figurare allo scopo princi-pale di illustrare la varietà della lingua. Così, in tema di variazione diatopica(tema che peraltro ai nostri grammatici interessa poco), non basta sem-plicemente trovare citato un dialettismo non fiorentino o non toscano per-ché questa voce possa ritenersi legittimata accanto alla corrispettiva voce(fiorentina) solitamente promossa dalla grammaticografia.
Quando il Manni annota che pesce «in alcun luogo di Toscana» si dice pescio(Lezioni i, p. 88) e che «le voci nostre Grano, e Andiamo, gli Aretini le pro-nunziano Greno, e Andiemo» (Lezioni i, p. 34, Lezioni ev, p. 28, Lezioni iv, p. 31;sul fenomeno anche il Gigli, Regole, pp. 581-87, e Lezioni, pp. 19-20) vuolecertificare la varietà e la mutevolezza della lingua (nella fattispecie la prossi-mità fonetico-articolatoria delle vocali), non promuovere la forma citata.74
73. Glynn Faithfull, Teorie filologiche, cit., p. 298.74. Su pescio cfr. Arrigo Castellani, Grammatica storica della lingua italiana, i. Introduzione,
Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 312 e 417.
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
199
Solo occasionalmente si forniscono informazioni utili sull’uso coevo e geo-linguisticamente circoscritto (sebbene ‘benché’/sibbene, «avverbio conferma-tivo» usato «dagli antichi, e da’ moderni Fiorentinamente», Lezioni i, p. 196).75
Scarso è l’interesse per le variabili diatopiche nella Gramatica del Soave,dove si citano forme spiccatamente dialettali (si noti, senza presentarletali), al solo scopo di distogliere dal loro uso. Si osservi la secchezza di pre-scrizioni come: «amerò, e non amarò, amerei, e non amarei» (Gramatica, p. 117;cfr. anche Gramatica 1816, p. 72), «questa terminazione in ajo, e non già inaro, aver debbono i nomi degli Artisti, come Librajo, Ferrajo, ec., e i due mesiGennajo; e Febbrajo» (Gramatica, p. 296; il Nelli, come detto precedente-mente, aveva invece attribuito il passaggio -aro > -aio all’esigenza di evitarela durezza del suono: Grammatica, p. 226). Solo in un caso si dà conto di una«maniera usatissima dai Toscani», andare/mandare per una persona/cosa (sott.per chiamarla, per prenderla, ivi, p. 240).
È un atteggiamento comune, nella sostanza, anche al Rogacci, che nonqualificando mai esplicitamente le numerose forme citate come dialettali,fossero anche toscane, proscrive oltre alle voci già commentate (oglio,nevigoso, fatiga, cfr. più avanti § 5.4) e ad altre,76 forme come vinti (Prattica, p.81), catarina (ivi, p. 95), saccio («come da alcuni dicesi», ivi, p. 166), cucchiara(da preferire cucchiaio, ivi, p. 132), cuscire e sdruscire (ivi, p. 229; cfr. anche p.134),77 basciare o bagiare (e ancora: bacio non bagio, ivi, p. 131),78 brascia e bragia(«avvegnache quest’ultimo si trovi in Dante per uso della rima», megliobracia o brace, ivi, p. 132) e camiscia,79 anco, nè meno/nè manco (da preferire nè
75. Estremi che talora si toccano: a proposito delle « locuzioni raddoppiate, che traggonfuori con maggior forza il sentimento», si cita ad es. mo mo, «che venendo insieme col mo de’Lombardi (usato alcuna fiata a maniera di scherzo da’ nostri) dal Latino modo, vale Or ora»(Lezioni i, p. 216).
76. Si consigliano ancora cinghiale (di contro a cignale, Prattica, p. 132), artigiano e cortigiano(rispetto ad arte-, corte-), dicembre (citato anche dal Bartoli in alternanza a decembre insieme adaltre voci: cfr. Ortografia, pp. 247-48) e le forme in u ulivo, singulare, facultà, mulino, ecc. (Prattica,p. 135).
77. Di queste forme cfr. la difesa del Bartoli e la critica dell’Amenta («E vero che ’nqualche Antico si truova […] ma molto di rado, come avvisò il Salviati […]» secondo il qualegli antichi « il fecero talora per vezzo»), in Bartoli, Torto, pp. 140-43 (p. 143).
78. Su bagio cfr. Rohlfs, Grammatica, cit., vol. i § 286, e A. Castellani, Saggi di linguistica efilologia italiana e romanza (1946-1976), 3 voll., Roma, Salerno Editrice, 1980, vol. i p. 222 n. 7(entrambi ricordano gli esempi di bagio che Clemente Merlo trasse dal glossario annesso allav impressione della Crusca).
79. Invece di camicia, ivi, p. 132; e chissà che su queste prescrizioni, e in particolare susdruscito, bagio e camiscia, il Rogacci non risenta dell’autorità del Pallavicino, Avvertimenti, p. 36.Camiscia figura anche in un esempio del Voc. Cat. s.v. pronunzia, p. 217.
stefano telve
200
pure) e assieme (da preferire anche, nè pure, insieme, Prattica, p. 288),80 benchéin altri luoghi della grammatica menzioni dialettismi (o forme in regresso:oltre alle voci precedentemente osservate si menzionano vuova, ivi, p. 83,81
megliore, ivi, p. 94, e a testo, ivi, p. 99,82 dimane, domane, modo «più usato» didimani, domani, ivi, p. 272)83 e arrivi persino ad accogliere l’uscita in -emo perla iv persona dell’indicativo presente.84
Quanto è di dialettale nella Prattica del Rogacci non filtra al setaccio delNelli. Un’eccezione potrebbe essere vadia (accanto a vada e vadi, e vadiano,vadano: Grammatica, p. 143), ma si tratta di una forma non spiccatamentesenese (e assente dal prospetto riassuntivo del verbo: ivi, pp. 144-45; citatadal Rogacci, Prattica, p. 162), come precisa il Gigli («e pur Fiorentino, evolgare anche del Contado Sanese», Regole, p. 110).85 Del tutto episodici,
80. Su anco/anche cfr. Castellani, Saggi, cit., vol. i pp. 37, 523, vol. ii 281-83, e Id., Grammatica,cit., pp. 317, 349-50, 359, 365, 429. Su assieme cfr. Id., Saggi, cit., vol. i pp. 361-62, e Id., Gramma-tica, cit., pp. 367, 429.
81. Forma del toscano occidentale che penetra anche a Firenze sul finire del XIV secolo:cfr. Castellani, Saggi, cit., vol. ii p. 297 n. 43, Id., Grammatica, cit., p. 310.
82. Cfr. Castellani, Saggi, cit., vol. ii p. 217. Gli esempi di megliore documentati dalla LIZ 3 siarrestano al XVII secolo.
83. Su dimane cfr. Castellani, Saggi, cit., vol. i pp. 27, 35, 181-82, e Id., Grammatica, cit., p. 294, eL. Serianni, Introduzione alla lingua poetica italiana, Roma, Carocci, 2001, § 36: « la vocale finale siassesta nel fiorentino dopo il Quattrocento […] dalla fine del Settecento gli esempi della formacon -e finale sono frequentissimi in poesia». Nella prosa del Settecento prevale nettamente laforma labializzata con -i finale: cfr. G. Patota, L’ ‘Ortis’ e la prosa del secondo Settecento, Firenze,Accademia della Crusca, 1987, p. 47, Giuseppe Antonelli, Alle radici della letteratura di consumo. Lalingua dei romanzi di Pietro Chiari e Antonio Piazza, Milano, Istituto di Propaganda Libraria, 1996,pp. 103-4, e Id., Lingua e stile di Aurelio Bertola viaggiatore, SLI, xxv 1999, pp. 186-233 (p. 199).
84. Non sarebbe da condannarsi chi « in luogo della terminazione più ordinaria in Iamo:si servisse dell’altra in Emo, meno bensì ora corrente, ma usata nondimeno dal Crescenzi, eVillani, e famigliarissima a Dante» nel Convivio (Prattica, p. 137; segue rinvio a Bartoli, Torto,Osservazione 87: p. 137; il Pallavicino respinge semo: cfr. Avvertimenti, p. 30). Per una panora-mica del tratto nelle grammatiche del Cinquecento cfr. Giada Mattarucco, Alcuni punti criticinelle grammatiche italiane da Fortunio a Buonmattei, «Studi di grammatica italiana», xix 2000, pp.93-139 (pp. 118-19).
85. Cfr. Rohlfs, Grammatica, cit., vol. ii § 556, e Strambi, La lingua in Girolamo Gigli, cit., p.307. Il Nelli non è tuttavia particolarmente sensibile agli scarti diatopici tra le varietà toscane,come confermerebbe l’aver omesso di rilevare (come fa invece il Bargagli) l’opposizionefiorentino/senese tra le forme piene comperare, adoperare, sgomberare, temperare, « secondo alcu-ni» (Grammatica, p. 228) da preferire, e quelle sincopate (comprare, secondo il Bargagli, è«propio comunemente del dir sanese […] comperare si è del parlar fiorentino»: ScipioneBargagli, Il Turamino, ovvero Del parlare e dello scriver sanese, edizione critica a cura di L. Serianni,Roma, Salerno Editrice, 1976, p. 96), e tra le uscite -iere/-o/-i (p. 102), sebbene il Gigli avesseindicato cavaliere e alfiere come voci proprie del senese di contro a cavalieri, alfieri tipiche invecedel fiorentino (Voc. Cat., s.v. pronunzia, p. 217).
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
201
ancora a conferma di una generale tendenza all’oscuramento delle marca-tezze geolinguistiche, un paio di rilievi dialettali non toscani, il primo la-sciato implicito (sui nomi in -aio che «da altre nazioni si terminano perlopiùin -aro», Grammatica, p. 226), il secondo esplicitato e censurato (l’uso lom-bardo di si per ci, ivi, p. 52; già nel Pallavicino, Avvertimenti, p. 17).
Smorza i toni anche il Corticelli, che pone l’accento solo su usi generi-camente toscani senza mai aggiungere specificazioni ulteriori, rendendopalese che i suoi rilievi diatopici, peraltro alquanto blandi e generici, inte-ressano solo in quanto servano a illustrare una certa peculiarità grammati-cale, senza implicare promozione di modelli regionali o dialettali, che nonsiano ovviamente il toscano.86
Oltre a quanto si dirà circa certe proprietà del linguaggio (cfr. § 5.2), ilCorticelli nota l’uso «presso ai Toscani» di per conto «col genitivo in sensodi per cagione» (Regole i, p. 285), di sopracciò con valore di «nome, e significail soprantendente all’uficio, di cui si parla» (ivi, p. 343), e per il verbo, ditrarre per ‘accorrere, concorrere’ (ivi, p. 227), del tipo veddi («benchè negliAntichi si truovi vidi» ecc., ivi, p. 118), dell’uscita del passato remoto in -etti,-ette, -ettero (invece di -ei, -é, -erono), che sembra «la più famigliare a’ Tosca-ni» (ivi, p. 118), di essere seguito da a con infinito (come in «Io mi credo, chele Suore sien tutte a dormire», ivi, p. 291) e infine, come «cosa affatto pro-pria della lingua nostra», dell’infinito sostantivato al plurale (ivi, p. 296;tace invece della toscanità di sur, citato a p. 365).87
86. Si tenga conto di quanto asserito nei discorsi Della toscana eloquenza: «quando i toscania significare una cosa, oltre al vocabolo fiorentino, ammettono ancora il vocabolo comune-mente inteso in Italia, conviene usare questo comune, per essere facilmente inteso: benchèquando a significare una cosa ci ha diversità di vocaboli fra i Toscani, e gli Italiani, convengausare il Toscano vocabolo, il quale suol’essere più gentile, e di miglior suono» (p. 33). Unesempio di applicazione di questo principio si ha nelle Regole a proposito delle voci del verbodi iv persona dell’imperfetto, che «da non pochi Italiani si pronunziano colla penultimabreve, amàvamo, udìvamo &c., ma ciò non dee ammettersi, non solamente perchè i Toscani lepronunziano con la penultima lunga, amavàmo, udivàmo & c., ma ancora perchè così le pro-nunziavano gli Autori del buon secolo» (Regole i, pp. 513-14). Cfr. anche Nelli: la iv e la vpersona dell’imperfetto « suol pronunziarsi colla penultima lunga; ma non già la terza, comeamava \mo, amava \te, amavano; sentiva\mo, sentiva \te, sentivano» (Grammatica, p. 126).
87. Su sur cfr. Rohlfs, Grammatica, cit., vol. i § 308. Ancora a proposito del verbo, il Corticellinota che «Ci sono de’ verbi di quest’ordine [scil. attivi], de’ quali fanno i toscani un’uso [sic]diverso da quello, che se ne fa volgarmente» come domandare ‘interrogare’ e ‘richiedere dialcuna persona’, ricordare ‘nominare’, crescere ‘allevare’, rubare ‘ispogliare’, fuggire ‘trafugare’, sen-tire ‘conoscere’, sostenere ‘comportare’ e ‘permettere’ e si usa anche, «più singolarmente, perarrestare un reo in corte, senza incarcerarlo», usare ‘frequentare’, tenere ‘pigliare’ (solo nelpresente dell’imperativo), lasciare stare «vale il Latino praeterire», togliere, torre per ‘prendere’
stefano telve
202
Prevedibilmente diverso è invece il caso di grammatici che contrastano,più o meno fortemente, il modello linguistico fiorentinocentrico. Nel casodel Gigli, il tentativo di legittimare forme senesi è evidente. Se nel testodelle Regole si informa ad esempio il lettore, con apparente distacco, che «ISanesi dicon giognere, e gionto» (come anche per altri verbi, p. 170), alcunepagine più avanti, nella prassi linguistica dell’esercizio, il Gigli dichiara che«ponto si dice bene quanto punto» (ivi, p. 256), forma data invece comeidiotismo pisano nel Voc. Cat.88 e sconsigliata nelle Lezioni.89 Il Gigli usainfatti citare forme senesi (eventualmente accostate a forme fiorentine)specificandone la connotazione diatopica oppure no: quando questo acca-de, la forma senese figura spesso accanto a quella fiorentina e il sempliceaccostamento suggerisce l’equiparazione tra le due voci e il ridimensiona-mento del fiorentino al livello degli altri dialetti («Denari alla Sanese, danarialla Fiorentina», «Vinti alla Sanese, e Veneziana, venti alla Fiorentina», Re-gole, p. 256); quando la connotazione diatopica è sottaciuta, il Gigli dichiaraesplicitamente l’equivalenza delle due forme (oltre all’esempio precedente-mente citato di punto/ponto, si veda anche: « lassate, e lasciate può dirsi», Re-gole, p. 256).90 Si consideri del resto che proprio la costatazione della con-cordanza di più dialetti contro il fiorentino è una delle argomentazioni piùforti a disposizione del Gigli e dei filosenesi per tentare di promuovere ilproprio modello di lingua (oltre a quanto già detto a proposito di amarò, siveda ancora: «Sabbato alla Sanese, e secondo la pronunzia universale; Saba-to, alla Fiorentina», Regole, p. 224).91
(«molto familiare a’ Toscani»), togliere e torre via ‘levare’, toccare ‘commuovere’, morire ‘uccide-re’ (del quale si specifica: «ne’ preteriti »; Regole i, pp. 188-90).
88. Cfr. Castellani, Saggi, cit., vol. i p. 82.89. Pur ricordando che secondo il Cittadini si alternano longo/lungo, ponto/punto, ecc., «Egli
è però vero, che le sopradette voci meglio alla Fiorentina si pronunziano, e si scrivono, cioè colV lungo punto, giunto, &c.» (Lezioni, p. 20). Su queste forme cfr. anche T. Poggi Salani, Motivi elingua della poesia rusticale toscana. Appunti, «Acme», xx 1967, pp. 233-86 (pp. 250-51).
90. Benché lassare non sia inconsueto nell’antico fiorentino (cfr. Rohlfs, Grammatica, cit.,vol. i § 225), è tipico di molti dialetti non fiorentini (cfr. Castellani, Grammatica, cit., pp. 304,350, 357, 398-99). Gigli dà spazio anche al lucchese (ivi, pp. 62, 73-74) e al romano (ivi, pp. 25,28, 62, 64, 114, 218), ma il senese rimane prevalente (pp. 64, 66, 73, 86, 92, 100, 133, 156, 159, 165,170, 174, 178, 182, 194, 214).
91. In quanto «questo Sanesismo è parlato da più Nazioni Italiane, non che toscane sole,come da molti di Lombardia; perciò non debbe imputarsi a errore; ed ugualmente stavabene nella colonna prima del corretto parlare» (Regole, p. 86). Una presa di distanza dal mo-dello di Firenze si avverte ad esempio quando il Gigli indica che «quella Nazione nonproferisce l’V consonante» (Regole, p. 72; di qui le forme ate, aete, aemmo, aranno, poste nellacolonna dell’uso corrotto: p. 66, e altre forme: cfr. p. 99; ate è invece inaspettatamente accolta
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
203
Se su alcune alternanze fonetiche i grammatici si esprimono con relativasicurezza, il giudizio si fa più incerto là dove sono in gioco usi oscillanti nonsull’asse diatopico ma su quello diacronico, in particolare per quelle formecon statuto sociale e stilistico meno sicuro, circolanti in differenti livelli dilingua e di stile, e dunque tendenzialmente in bilico: popolare e popolare/contadinesco, anticheggiante ovvero affettato o raro, e, viceversa, familiaree colloquiale.92 Gruppi non nettamente separabili (specie i primi due), sui
dal Corticelli in Regole iii, p. 128) e in altre indicazioni specifiche sul fiorentino: arrò «pervezzo di lor proferenza» (ivi, p. 73), dichiamo («è rifiutato dal Cinonio, e da tutti i Gramma-tici; e pure alcuni de’ loro freschi buoni Scrittori l’hanno usato», ivi, p. 186), giucare (ivi, p.197), «Quattordici dicono i Fiorentini con o chiuso» (ivi, p. 578). Oltre ad altre forme ricorda-te nel corso del presente lavoro: finischiamo, abbi i e iii pers., e abbino vi pers., vadia, i temi inponghiamo/pognamo; nonché nel giudizio espresso sulla grammatica del Salviati (cfr. n. 58).
92. Si prescinde qui dai tanti tratti rilegati sicuramente ora all’antico ora al moderno. Diseguito un breve saggio di forme e costrutti ritenuti dell’uso moderno (vale a dire cinque-centesco e successivo) e dell’uso antico: alla volta di invece di verso (Corticelli, Regole i, p. 278),di presente, presentemente che «per Al presente» (Rogacci, Prattica, p. 270), conciosia che («comepiù amano, e usano dire i Moderni» invece di conciosiacosa che: Rogacci, Prattica, p. 289; secon-do il Soave conciofosseché, conciofossecosaché «or son maniere affettate», Gramatica, p. 184), se bene«per Benche» (Rogacci, Prattica, p. 294; cfr. anche Manni, Lezioni i, p. 196, e Amenta inBartoli, Torto, p. 349), succedere « I Moderni l’usano anche per avvenire» («dagli Antichi nonsi usa, che per venir dietro […] ò per cedere e toccare», Rogacci, Prattica, p. 250). Per l’usoantico (si ordina secondo le parti del discorso). Nome: i mangiari (Manni, Lezioni i, p. 56),chericherìa-chericìa e forestierìa (ivi, p. 66), uscia ‘usci’ (ivi, p. 79), le alternanze domanda/-o, pastu-ra/-o, Batista/-o (ivi, p. 88). Pronome: sing. ello, plur. elli («maniere antiquate»: Soave, Gramatica,p. 63), queglino sogg. (Rogacci, Prattica, p. 35), quai/qua’ ‘quali’ («ora in prosa affettato», Rogacci,Prattica, p. 50), que’ sing. (apocope che «or più non si usa, fuorche nel plurale Quelli», Rogacci,Prattica, p. 305), nosco, vosco («già andate in disuso», Rogacci, Prattica, pp. 33-34), chente, chenti(Gigli, Regole, p. 43). Aggettivo: i tipi fratelmo, Signorso («che oggi non si userebber giammai»,Manni, Lezioni i, p. 112; ma l’Amenta ne constata l’uso in «bassi componimenti», in Bartoli,Torto, pp. 454-55), il tipo molto ricchissimo (« Il che però non è ora da usarsi, se non rarissimevolte, quando, e dove paresse entrar bene», Rogacci, Prattica, p. 94). Verbo: l’uscita in -ono peril congiuntivo imperfetto (amassono: Manni, Lezioni i, p. 179; accettata dal Rogacci, Prattica, p.145), -onno per -arono (Manni, Lezioni i, p. 179), essente, essuto o issuto («oggi niente» in uso:Corticelli, Regole i, p. 100, cfr. anche Manni, Lezioni i, p. 173), abbo (Manni, Lezioni i, p. 173),semo (in prosa e in verso, ma «non è oggi in uso», Regole i, p. 98), cresi ‘credetti’ («che alcunoantico disse», Regole i, p. 128), discernei (che Cinonio trova in Dante, «non è però in uso»;manca però il perfetto di questo verbo, Regole i, p. 128), il perfetto e il participio sigmatici divolere (Rogacci, Prattica, pp. 170-71, Gigli, Regole: volsemo e vollemo ‘volemmo’ « scrivono, edicono i più civili, con inciviltà grammaticale», p. 156; cfr. anche p. 72; Corticelli, Regole i, p.117 volsero per vollero «è di lega ancora peggiore», ivi, p. 122; già il Buonmattei disse volsero «dipeggior condizione», come ricorda l’Amenta in Bartoli, Torto, p. 277; così già il Pallavicino,Avvertimenti, pp. 34 e 58, il Bartoli e l’Amenta, in Bartoli, Torto, pp. 108-10) e di altri verbi, adesempio morse ‘morì’ (Gigli, Regole: « io lo sento pur mal voltentieri negli uomini civili», p. 188;cfr. anche Pallavicino, Avvertimenti, p. 34), l’imperfetto congiuntivo per il trapassato (fosse per
stefano telve
204
quali non tutti gli autori si esprimono in modo omogeneo (specie quelli delprimo gruppo). Osserviamo per ognuno di essi alcuni tratti significativi.
1) Popolare
Le mane. Il plurale le mane, caratteristico dell’antico toscano, parlato e popolare93
e respinto già dal Buonmattei («chi dice le Madre, le Botte, le Mane, fa error manife-sto», Della lingua toscana, p. 137), è eccezionalmente accolto dal Manni sulla scortadegli scrittori del secolo d’argento («quali son quelli dopo il 1500») come il DellaCasa (ma si cita anche il Pulci), benché per il resto egli ritenga che «mal fa chipronunzia le Madre, le Botte, e somiglianti in questa guisa dal volgo storpiati» (Le-zioni i, p. 82, Lezioni ev, p. 67, Lezioni iv, p. 76). Il Nelli si limita a dichiarare che«alcuni qualche volta l’hanno fatto terminare in E, dicendo le mane, che viene damana singolare» (Grammatica, p. 10), là dove il Rogacci e il Corticelli citano solo laforma regolare in -i (Prattica, p. 13, Regole i, p. 36) e il Gigli oppone mane, in quantofiorentina, al senese mano.94
Indefiniti al plurale. Il Rogacci e il Nelli specificano la rarità dell’uso al pluraledi ogni (cfr. Prattica, p. 75, e Grammatica, p. 22, Gigli, Voc. Cat., s.v. ogni, p. 95, e Regole,p. 49: «Oggi abbiamo nella lingua Ognissanti», Soave, Gramatica 1816, p. 49), ciascunoe ognuno («rarissime volte» al plurale, Grammatica p. 22; cfr. anche Rogacci, Prattica,p. 77, che nota: «è meglio usarlo in singolare, anche quando si parla di molti,posponendolo però in tal caso al verbo Plurale, e. g. Cominciarono ciascuno à partire»,segnalando peraltro che ciascuno è anche aggettivo e ognuno no, ivi, p. 75; gli esempi
fosse stato, «maniera molto usata dagli antichi»: Regole i, p. 422), il presente condizionale per ilpassato (vorrei per avrei voluto: Regole i, p. 423). Avverbi, congiunzioni e preposizioni: avaccio (inuso solo nell’espressione «O tardi, o avaccio», Manni, Lezioni i, p. 199; già marcata nel Cinque-cento: sulle testimonianze di Bembo, Gelli e Muzio cfr. Poggi Salani, Poesia rusticale, p. 251),costigiù e costisu (Rogacci, Prattica, p. 264), sanza (Manni, Lezioni i, p. 34, Lezioni ev, p. 28, Lezioniiv, p. 31; Corticelli, Regole i, p. 359), sed, ched (Soave, Gramatica, p. 296), benched, sed, ned («ogginon sono in uso»: Corticelli, Regole i, p. 444; in ched, sed, mad, od, ned «affine di ottenere ilnecessario suono si fa l’aggiunta del D […] praticata eziandìo da’ nostri antichi eleganti Scrit-tori», Manni, Lezioni i, p. 254). Singole voci: piatoso (Manni, Lezioni i, p. 34, Lezioni ev, p. 28,Lezioni iv, p. 31), «antiquate» sono vitiperio, lalda ‘lauda’ («rimaso ora in contado»), svembrare esvemorato, boce ecc. (Manni, Lezioni i, p. 247, Lezioni ev, pp. 198-99, Lezioni iv, p. 224), l’uso dianteporre Messere, Monsignor, Madonna ai nomi di dignità («Solo è rimaso all’antica foggia iltitolo di Madama, e si dice: Madama la Reina, la Contessa &c.», Corticelli Regole i, pp. 310-11).
93. Cfr. Benedetto Varchi, L’Hercolano, ed. critica a cura di Antonio Sorella, 2 tomi, Pescara,Libreria dell’Università Editrice, 1995, to. i p. 114, Rohlfs, Grammatica, cit., vol. ii § 389, PaolaManni, Ricerche sui tratti fonetici e morfologici del fiorentino quattrocentesco, «Studi di grammaticaitaliana», viii 1979, pp. 126-27, e C. Marazzini, Il secondo Cinquecento e il Seicento, Bologna, IlMulino, 1993, p. 116. LIZ 3 [’700]: mane plurale è solo nei versi di Goldoni e Parini.
94. Cfr. Serianni in Bargagli Turamino, cit., p. 147 e n. 1, e Voc. Cat., s.v. piei: «membro delcorpo umano Sanese, come la Mana, e le Mane sono membri del corpo umano Fiorentino»(p. 119).
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
205
antichi di uso al plurale di ciascuno «non bastano oggi per farne l’uso approvato»secondo il Gigli, Regole, p. 48), qualunque («assai di rado», Grammatica p. 23; Rogacci,Prattica, p. 78 «di rado»; Gigli, Regole, p. 51: «oggidì […] non si loderebbe usato, senon parcamente»), nessuno e niuno («di radissimo», Grammatica p. 23; Rogacci, Prattica,p. 78 «molto di rado»; Gigli, Regole, p. 49: «non già»). Diversamente il Manniavvisa dell’uso popolare: «mancano poi del plurale Niuno, Nessuno, Veruno, Ciascu-no, Ciascheduno, Qualcuno, comecché il volgo in questo vada errando, Ognuno, Qua-lunque, Qualsivoglia ed Ogni […] Quello, che da i nostri Regolatori si prescrive, è,che oggigiorno deesi l’uom guardare di far che l’Ogni al plurale vada servendo»(Lezioni i, pp. 91-92, Lezioni ev, p. 75, Lezioni iv, p. 83; esempi di qualcuno al plurale«rarissimi sono, ma si trovano», Gigli, Regole, p. 49). Solo eccezionali gli esempi diognuno, ciascuno e qualche plurale (Manni, Lezioni i, p. 140).95 A questo riguardo leRegole del Corticelli mostrano qualche differenza tra i e iii edizione: laddove nellai si dichiara che ogni «si addatta [sic] malvolentieri al plurale, col quale tuttociòl’accordarono talvolta gli antichi» (Regole i, p. 71) e che ciascuno «non ha plurale,benchè gliel dessero alcuni Antichi» (ivi, p. 77; mancano inoltre del plurale: niuno,nessuno, veruno, ciascuno, ciascheduno, qualcuno, ognuno, qualunque, qualsivoglia, uno e una«numerali addiettivi», ivi, pp. 43-44); nella iii, accanto a queste considerazioni(appena diversamente formulate),96 si menziona senza specificazioni l’uso al plura-le anche per qualunque («serve ad amendue i numeri col segnacaso», Regole iii, p.106) e nessuno («si trova usato nel numero del più dal Cresc[enzi] […] i frutti di taliarbori o sono nessuni, o sono sconvenevoli, e non maturi», Regole iii, p. 99).97 Il Soave, purricordandone l’uso in Boccaccio, avvisa che qualche al plurale è «da non seguirsi»(Gramatica, p. 31 n.; commento che non figura in Gramatica 1816, p. 24), come giàprescrisse il Gigli (« in qualche antico, ma senza approvazione, come qualche verdiboschi, qualche meluzze», Regole, p. 49: il primo esempio è petrarchesco e citato giàdal Rogacci: Prattica, p. 72).
Il tipo ponghiamo. Registrando l’alternanza poniamo/pogn(i)amo/ponghiamo e altre,il Nelli avverte che «molte di queste voci non sono comunemente ricevute per
95. Da un sondaggio nel corpus settecentesco della LIZ 3 emerge un solo esempio perciascune (Caffè) e quattro per nessuni (Alfieri, Vita).
96. «Ogni malvolentieri s’adatta al plurale, ancorchè dinoti pluralità, ed universalità. Pureve l’accordarono talvolta gli Antichi» (esempi da Boccaccio e G. Villani, Regole iii, p. 93);ciascuno «nel comune uso non ha plurale, benchè alcuni Antichi gliel dessero» (ivi, p. 107).
97. Bisognerà notare che anche il Nelli, pur senza menzionare l’autore (com’è sua normanella grammatica), cita lo stesso passo del Crescenzi (con qualche divergenza: « i frutti di talialberi o sono nessuni, o non maturi», p. 23), passo menzionato in precedenza anche dal Bartoli,anche se per altre ragioni e in forma più sintetica («nel Cresc. lib. 2. c. 16 I frutti, ò sonoNessuni, &c.», Torto, p. 499) e dal Rogacci (Prattica, p. 78); il che indicherebbe un canone diautori già piuttosto allargato rispetto a quello selezionato dal Corticelli nella i edizione delleRegole, dove il Crescenzi non figura (si veda l’indice degli autori moderni e degli autori del buonsecolo in Regole i, pp. 476-77, al confronto con quello della terza edizione, Regole iii, p. 519: tragli autori del buon secolo compare il Volgarizzamento del Trattato dell’Agricoltura di Piero de’ CrescenziCittadino Bolognese, Napoli, s.c., 1724).
stefano telve
206
ottime» (Grammatica, p. 163; cfr. anche ivi, p. 227):98 se infatti il Rogacci mostra unalieve preferenza per poniamo99 e il Corticelli tace (e anzi registra per tenere il solotenghiamo, Regole i, p. 120, accettando le tre uscite per porre, ivi, p. 130, e per venire,ivi, p. 137) come pure il Soave (tenghiamo, Gramatica, p. 125, e Gramatica 1816, p. 87;ma: poniamo o ponghiamo, Gramatica, p. 127, e Gramatica 1816, p. 88), il Gigli specificache ponghiamo, tenghiamo, pognamo, tegnamo «sono rancidumi restati in gran partenel Fiorentino Idioma» (Regole, p. 174).100 Parallelamente, se il Nelli ritiene «arbi-trario» (cioè ‘liberamente alternativo’) dire sciolghiamo e sciogliamo, sciolghiate e scio-gliate, ma anche che «questa libertà arbitraria dee prendersi con giudizio» (Gram-matica, p. 164),101 sarà forse significativo che delle tre forme codificate per venire,veniamo, venghiamo e vegnamo (ivi, p. 168), quest’ultima non figuri nel prospetto rias-suntivo.102 Da notare che nella iii edizione delle Regole il Corticelli inserirà accanto
98. Ponghiamo e tenghiamo «non sono arcaismi, bensì forme di dubbio prestigio per unoscrittore purgato» (L. Serianni, Annotazioni sulla lingua di Pietro Giordani, in Giordani Leopardi1998, Convegno nazionale di studi, Piacenza, Palazzo Farnese, 2-4 aprile 1998, a cura di Ro-berto Tissoni, Piacenza, Tip.Le.Co, 2000, pp. 239-69, a p. 262; a p. 263 n. 69 si segnala chenell’Ottocento il Mastrofini riterrà ponghiamo un « idiotismo» e tenghiamo da «scansarsi affat-to come sregolato»); cfr. anche Maurizio Vitale, La lingua della prosa di G. Leopardi: le ‘Operettemorali’, Firenze, La Nuova Italia, 1992, p. 56 e n. 31. Da un sondaggio nella LIZ 3 [’700] emergeil predominio di poniamo (10 occorrenze: Vico 6, Goldoni 2, Il Caffè 2), rispetto a pogniamo(Baretti 3) e ponghiamo (Goldoni).
99. Si annoverano ora tutte e tre le possibilità (per tenere, Prattica, pp. 168-69, porre e spegne-re, p. 177, venire, p. 180; e salire, p. 179), ora si citano veniamo, teniamo, poniamo tra le forme di«maniera più usata » rispetto alle corrispondenti forme palatalizzate (p. 344), ora, a proposi-to delle iv e v persone del presente indicativo di dolere, tenere e porre si suggeriscono i tipi po-niamo e pogniamo « senza che sia necessario il dire» ponghiamo (p. 191), che pure è forma accet-tata sulla scorta del Buonmattei (p. 192).
100. Cfr. anche Strambi, La lingua in Girolamo Gigli, cit., p. 303. Così ancora il Gigli: «Que-sta lettera [scil. g] fu volentieri tralasciata da’ Sanesi negl’indicativi, e desiderativi di alcuniverbi nel numero del più, come veniamo, veniate, che i Fiorentini dissero venghiamo, venghiate,ponghiamo» (Voc. Cat., s.v. g, p. 40; sulla scorta del Cinonio che respinge forme quali tegnendo,pognendo, rimagnendo, si esprimono anche riserve su pospognendo: cfr. Voc. Cat., s.v. sanese, p.271). Ponghiamo si direbbe «con poca lode» secondo il Cinonio: cfr. M. Vitale, L’oro nellalingua. Contributi per una storia del tradizionalismo e del purismo italiano, Milano-Napoli, Ricciardi,1986, p. 204 n. 89.
101. Il tema in -gl- appare limitato nell’uso (da quanto si ricava dall’interrogazione dellaLIZ 3 [’700]), per i verbi citati, ai soli accoglio (Vico, Poesie), scioglio (Metastasio, Nitteti), toglio(Parini, Odi) e togliono (Baretti, La frusta letteraria 2, e toglion in Gravina, Della ragion poetica). Siha scioglion (ma: tolgonsi) in Sc. Bargagli.
102. Vegnamo, menzionata accanto alle altre forme anche dal Corticelli (Regole i, p. 137), sitrova in Sc. Bargagli (con due esempi; e vegna, vegno, vegnente: dati LIZ 3 [’700]). Per il tema in-gn- la LIZ 3 [’700] registra (non sarà superfluo, in questo caso, riportare oltre all’autore ancheil titolo dell’opera): avvegna (Baretti, La frusta letteraria), convegna (Parini, Giorno ii red. 2 ess.,Casti, Gli animali parlanti), convegno (Casti, Gli animali parlanti), vegna (Vico, Poesie, Goldoni,Enrico, Parini, Giorno ii red., Baretti, La frusta letteraria [versi], Cesarotti-Ossian), vegnente (Gol-
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
207
alle regolari forme con palatale anche legghiamo (p. 152), dichiamo (p. 158) e volghiamo(p. 161), in quanto attestate nel Salvini.103
Foste/fuste. Ammettono entrambe le forme il Rogacci (anche se si dichiara che«più volentieri ammette l’O che l’U», Prattica, p. 160), il Gigli (Regole, p. 59; vice-versa, sono dell’uso corrotto fosti e fusti) e il Nelli (nel prospetto verbale di essere,Grammatica p. 27), su probabile influsso del Bartoli (Torto, p. 181). Apertamente con-trari l’Amenta («noi diciamo Fosti, e Foste: e non Fusti, e Foste» [sic: ma sarà Fuste],in Bartoli, Torto, pp. 181-82; sulla scorta del Castelvetro e del Buommattei) e ilCorticelli (fusti e fuste per fosti e foste «sono manifesti errori», Regole i, pp. 98-99;nelle Regole iii, p. 123, si dice: «sono condannati dal Buommattei»).104
Vidi/veddi. Concorde con la norma grammaticale e con l’uso settecentesco, è lapreferenza assegnata dal Nelli (Grammatica, p. 149) a vidi di contro a veddi, toscanismoancora «abbastanza tollerato nel corso del XVIII secolo» (Serianni, La prosa, in Storiadella lingua italiana, cit., vol. i pp. 451-577, p. 540 n. 110), ma poco gradito ai gramma-tici: l’Amenta, contro il giudizio del Buommattei, respinge veddi, vedde, veddero, chepure «leggonsi in qualche Testo», perché «oggi son voci dell’infima plebe» (in Barto-li, Torto, p. 277; consiglia vidi già il Pallavicino, Avvertimenti, p. 34), il Gigli collocaveddi/viddi/vedei nella colonna del corrotto (Regole, p. 87; veddi/viddi, e veddemmo/viddem-mo, difesi dal Buommattei, si sentono in Toscana, a Roma e altrove, ivi, p. 92; vedderoper videro è indicata nel Voc. Cat. tra i «cambiamenti del Volgo da non imitarsi, o permeglio dire da totalmente sfuggirsi», s.v. verbi, p. 319) e similmente fa il Manni (èannoverato tra i «solecismi» veddamo in luogo del corretto vedemmo, Lezioni i, p. 174,Lezioni ev, p. 141, Lezioni iv, p. 158). Si distinguono il Rogacci e il Soave, che allineanole due forme (Prattica, p. 165, e Gramatica, p. 125, e Gramatica 1816, p. 87), e il Corticelli,che assegna vedd- all’uso toscano e vid- all’uso degli antichi (Regole i, p. 118).105
doni, L’impostore, Cesarotti-Ossian), vegnenti (Vico, Poesie e Principi di Scienza nova 2, Alfieri,Rime), vegniamo (Baretti, La frusta letteraria 6), vegno (Parini, Giorno ii red., Baretti, La frustaletteraria [versi], Alfieri, Rime 2, Cesarotti-Ossian). Su vegnente cfr. Patota, Ortis, cit., p. 63.
103. Su dichiamo cfr. il giudizio del Gigli riportato alla n. 91.104. Fuste, forma originariamente lucchese, pisana e senese, è vitale fino al Seicento: cfr.
Nuovi testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento, a cura di A. Castellani, Firenze, Sansoni,1952, p. 44, Manni, Ricerche, cit., pp. 115-71 (pp. 143-44 n. 10), e Castellani, Grammatica, cit., p.332. La LIZ 3 [’700] non fornisce esempi di fuste.
105. Le forme veddi/viddi, veddemmo/viddemmo, «benchè il Buommattei con scandalo ditutti i Grammatici gli difenda», osserva il Gigli nelle Regole, si sentono in Toscana, a Romae altrove (Regole, p. 92). Troviamo viddi in Scipione Bargagli (accanto ai più frequenti vidi,vide con 13 esempi, e videro; cfr. Bargagli, Turamino, cit., p. 25) e in Tolomei (cfr. ClaudioTolomei, Il Cesano de la lingua toscana, ed. critica riveduta e ampliata, a cura di Ornella CastellaniPollidori, Firenze, Accademia della Crusca, 1996, p. cxiv). Forme del genere, «molto diffusein Toscana e fuori fino al Seicento, sono sempre state d’uso occasionale in poesia» e hannopropaggini settecentesche (nel lirico Camilli: cfr. L. Serianni, Per una caratterizzazione linguisti-ca della poesia neoclassica, in Neoclassicismo linguistico, a cura di Roberto Cardini e MariangelaRegoliosi, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 27-64; si cita dalle pp. 46-47; per la prosa del Settecentocfr. Patota, Ortis, cit., p. 56, e Antonelli, Alle radici, cit., pp. 162-63) e successive (dati LIZ 3).
stefano telve
208
Misi/messi. L’Amenta riprende il Bartoli che incoerentemente, dopo aver re-spinto messi («non è da usarsi», Torto, p. 103; così già il Pallavicino, Avvertimenti, p.34), dedica un paragrafo del trattato per informare dell’esistenza di questa forma(«Vaglia almeno il sapere […]», Torto, p. 534), che l’Amenta reputa non usabile «nemeno a mio giudizio da’ Poeti: se non se per forza di rima, e in bassi componimen-ti» (ivi, p. 534). Riscontratane la presenza in molti autori, il Gigli assegna promessi/promesse «al poetico, che meglio al corrotto si arrolavano; è bene però ch’altri, piùche può, se ne astenga» (Regole, p. 171) e anche il Nelli, pur menzionando entram-be le forme (anche nei composti), ritiene che «il migliore però sarà servirsene conuna [scil. s] solamente» (p. 128). «Misi ò Messi: Permisi, ò Permessi» (Rogacci, Prattica,p. 140; cfr. anche p. 195). Solo misi e promisi annotano invece il Corticelli (Regole i, p.127) e il Soave (Gramatica, p. 116, e Gramatica 1816, pp. 74 e 78).106
Abbi ii persona.107 Menziona solo l’uscita in -i per la ii persona il Corticelli (neglischemi verbali: Regole i, pp. 97, 101, 130), ma accettano entrambe le uscite in -i e in-a il Rogacci (Prattica, p. 145: «Vero è che la seconda persona può sempre, & in tuttele Coniugazioni finire anche in I», cfr. anche p. 174), il Gigli (Regole, p. 69), il Nelli(Grammatica, p. 161; cfr. anche pp. 26, 28, 162; e già il Pallavicino, Avvertimenti, p. 29,e il Bartoli, Torto, p. 146) e il Soave («tu abbia, o abbi», Gramatica, p. 102; cfr. anche p.118; nell’edizione del 1816 figura solo abbi nello schema verbale di p. 61, ma altrovesi specifica che «Il miglior uso» vuole la terminazione in -a: cfr. pp. 72-73).108
Abbi (i e iii persona) e abbino (forme nettamente respinte dal Pallavicino, Avver-timenti, p. 29) è secondo il Gigli «mal detto da quasi tutti i Toscani più rozzi» e «avernon dee tolleranza per quanto se ne trovino sparsi grandi esempi ne’ Prosatorimoderni, e Poeti più degni di tutti i Secoli» (Regole, p. 73): forme come scrivino,venghino, diffuse «Per tutta la Toscana, e per tutta l’Italia» sono da ritenere un«Sollecismo che ha per mallevadori tutti i buoni Scrittori, che non se n’astennero,
106. Forme come messi, «ben radicate nel toscano popolare, cadono presto dall’uso lette-rario», con occasionali riprese nella poesia settecentesca (Serianni, Poesia neoclassica, cit., p. 47,dove si segnala messe in Parini, dove è forse «un intenzionale popolarismo “comico”», escommessêr in Lamberti; cfr. anche Serianni, Lingua poetica, cit., § 37.1.9.12). Il tipo messe èfrequentemente attestato in Scipione Bargagli accanto al tema in mis- (cfr. Bargagli, Turamino,cit., p. 20 e n. 2; per i Trattenimenti la LIZ 3 fornisce la seguente documentazione: messe 7,missesi, messero, messegli, intromesse, rimesse, promisse; mise 7, miseli, misero, commise, commisero, pro-mise, promisero). Adottato dall’Ariosto nell’edizione del 1532 del Furioso e da altri prosatori delCinquecento, il tipo messi è censurato dal Ruscelli e stigmatizzato come idiotismo fiorentinodal Muzio (cfr. P. Trovato, Il primo Cinquecento, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 296).
107. Originariamente forma extrafiorentina poi entrata come demotismo, attestata di radonel Settecento (cfr. Nuovi testi fiorentini, cit., pp. 71 sgg., Rohlfs, Grammatica, cit., vol. ii § 537),ma presente nella commedia La moglie in calzoni di Nelli (cfr. Strambi, La lingua in GirolamoGigli, cit., p. 282).
108. L’Amenta appronta una regola di carattere funzionale «non letta da me fin’ora inGramatico alcuno»: se il pronome tu è inespresso l’uscita va in -i, viceversa in -a (in Bartoli,Torto, p. 149). Sporadica la presenza di uscite in -i in Bargagli (abbi 3, sii; fonte: LIZ2). Il tipotu abbi è ancora usato dal Leopardi delle Operette morali: cfr. Vitale, Operette, cit., p. 60.
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
209
ma che pure dai Grammatici non fu mai scusato» (ivi, p. 100; dove si cita Bartoli [cfr.Torto, pp. 105-6], Borghesi, Cinonio, Rogacci [cfr. Prattica, p. 145]; cfr. anche Voc. Cat.,s.v. verbi, p. 311). Si allinea su questa posizione il resto dei grammatici: Corticelli (cheannovera abbi, abbino tra gli «errori popolareschi», Regole i, p. 103; «si fugga l’erroredi chi dice faccino per facciano», ivi, p. 112), il Manni (il quale annota che FrancescoRedi «volle più per ischerzo, e per usar familiarità grande coll’amico» Carlo de’Dottori scrivere vadino per vadano, Lezioni i, p. 184, Lezioni ev, pp. 148-49, Lezioni iv,pp. 166-67) e il Soave (io abbi e abbino sono tra le «voci pur da guardarsene», Gramatica,p. 104; nella Gramatica 1816, p. 64, solo abbino, tra altre, è «da doversi fuggire»; ingenerale, per la sesta persona dei verbi di ii e iii coniugazione, si consiglia come«miglior uso» l’uscita in -ano, benché «da alcuni» si usi l’altra in -ino, ivi, p. 72).109
Acciò per acciocché. Benché se ne riconosca l’uso negli scrittori dei primi secoli,acciò per acciocché è respinto dal Rogacci (con rinvio al Bartoli: Prattica, p. 288; cosìgià il Pallavicino, Avvertimenti, p. 39; il Rogacci ritiene inoltre che «per maggioreleganza» (ac)ciò e che vadano disgiunti, ivi, p. 64); il Corticelli nota che acciò, «assaiusato volgarmente, non è di troppo buona lega» (Regole i, p. 402), mentre il Manni,diversamente, che fu degli «Antichi, sebbene di buoni Rimatori piuttosto, che diAutori in Prosa» (Lezioni i, p. 199).
Popolare-contadinesco
Le prescrizioni dei grammatici riguardano in primo luogo la morfologia verba-le: i tipi siàno per siamo e siate per siete,110 abbiàno,111 enno,112 io amavo, io amarò,113 ifuturi non sincopati di sapere e potere,114 e di avere,115 i passati remoti amorono,116 funno
109. Il plurale in -ino è respinto anche dal Buommattei (faccino: cfr. Marazzini, Il secondoCinquecento, cit., p. 191).
110. Questi i giudizi: «costume della plebe» (Manni, Lezioni i, p. 179), così «dicono ma-lamente i popolari di Firenze» (Gigli, Regole, p. 62), « in Toscana voce del popolo» (Corticelli,Regole i, p. 98).
111. Tra gli «errori popolareschi» in Corticelli, Regole i, p. 103; come proprio del fiorenti-no in Gigli, Regole, p. 72.
112. Voce che, secondo il Corticelli, «non è più in uso in Toscana, se non se in alcuniluoghi tra i Contadini» (Regole i, p. 98) e che, secondo il Gigli, è del lucchese e del pisano(Regole, p. 62). Su enno e altre forme di vi persona non fiorentine cfr. Ignazio Baldelli, Linguae poesia in Dante: il caso delle terze plurali non fiorentine, SLI, xx 1994, pp. 157-60.
113. Sull’imperfetto in -o cfr. più avanti. Su amarò cfr. anche Bartoli, Torto, pp. 100-1, eAmenta, ivi, p. 101.
114. Modi «contadineschi»: cfr. Corticelli, Regole i, pp. 119 e 121 (su questo tratto cfr. § 5.1);«non è di uso buono» vederò, vederei, ivi, p. 122.
115. Annoverato insieme a averei, io avevo, che io abbi, che coloro abbino, tra gli «errori popo-lareschi, da schifarsi »: cfr. Corticelli, Regole i, p. 103.
116. Mentre il Gigli osserva che « il comune favellare poi non ha per lo più altrimenti, checosì» (Regole, p. 85), gli altri grammatici ne parlano soprattutto in termini di diastratia: così«dice il volgo», Corticelli, Regole i, pp. 109-10 (amorono è anzi ritenuto «errore ben grande»);amorono e amorno sono della «vil nostra gente» secondo il Manni (Lezioni i, p. 179) e «manie-
stefano telve
210
‘furono’,117 avessimo o ebbimo o ebbemo ‘avemmo’,118 il condizionale presente ameressimo‘ameremmo’,119 i congiuntivi fosti e avesti di ii persona.120 Il Gigli ricorda ancora iofosse/fusse invece di fossi/fussi,121 e il Manni mette in guardia «dal dire io fosse in vecedi io fossi» (Lezioni i, p. 175), e respinge amassino (della «vil nostra gente», ivi, p. 179),voi amasti (della plebe: ivi, p. 174; voi amavi è «error manifesto», Soave, Gramatica, p.114), egli avessi (del volgo: ivi, p. 175, e Manni, Lezioni i, p. 175; cfr. anche Gigli122) eun gruppo di solecismi (io andiedi, io stiedi, ei puole, colui vegghi, noi ebbamo, noi veddamo,noi feciamo, noi andavassimo, noi vorressimo: Lezioni i, p. 174).
Ancora il Manni avverte che « la bassa nostra plebe pronunzia Gódere, e nonGodére, e che in qualche luogo d’Italia Sédere dicono, e Védere, e non Sedére, e Vedére»(Lezioni i, p. 167), che oramai è «solamente […] del volgo» (ivi, p. 198)123 e che sono«oggi solamente da’ Contadini» gli avverbi quiritta, qui(n)ciritta, qui(n)centro, iventro,quinamonte, quinavalle, quindavalle (Lezioni i, pp. 216-17).124 Il Nelli ricorda che l’epitesidi -ne, benché usata anticamente, non è «da imitarsi al presente», forse perché siritiene il -ne tipicamente aggiunto anche «dalla plebe Toscana, e da’ contadini»(farone, chene, tene, mene, piune, fane, Grammatica, p. 227; cfr. Gigli, Voc. Cat., s.v. ine, pp.57-58, e quine, p. 245, e Soave, Gramatica 1816, p. 173). Così anche il Corticelli, Regoleiii, p. 122 (non in Regole i, p. 98): «In Firenze s’ode talvolta ène per è; singolarmentequando altri tarda a rispondere ad interrogazion fattagli, e replica la terza personasuddetta, dicendo ène così per istrascico, e riposo di pronunzia. Si trova anchepresso gli Antichi […]».125 Del «volgo Fiorentino» (e anche del senese: cfr. Lezioni,
ra bassa, e viziosa» secondo il Soave, Gramatica, p. 114 (l’uscita -arono per la i coniugazione siusa «più elegantemente» che -orono già secondo il Pallavicino, Avvertimenti, p. 28).
117. Detta « sciocca sincope di Plebei Toscani, e Romani» dal Gigli, Regole, p. 63.118. Cfr. Gigli, Regole, p. 72, Corticelli, Regole i, pp. 98-99 e 103, Soave, Gramatica, pp. 103 e
114. Noi andassimo e noi fussimo sono tra i solecismi in Manni, Lezioni i, p. 174, e fussimo ‘fum-mo’ è per il Gigli «Romanesco vizio particolare, da cui non s’astengono i più nobili, e i piùsaputi» (Regole, p. 63; così anche avessimo, ivi, p. 72).
119. «Dove molti sogliono errare» (Rogacci, Prattica, p. 145); cfr. anche Bartoli, Torto, pp.96-97, Amenta, ivi, p. 97, e Soave, Grammatica, p. 109.
120. Cfr. Soave, Gramatica, p. 103.121. Queste voci « stan pur troppo male in bocca de’ popolari di tutte le Città ben parlanti,
e ne sono esempj innumerabili in Dante, in S. Caterina, nei Villani, e frai moderni n’è pienol’Ariosto, Pietro Aretino, ed assai più» (Regole, p. 64).
122. Così nelle Regole: « fossi per fosse […] è usato malamente da più autori, e resta appressoi Fiorentini oggidì, più che altri. Così pure fossino coloro […] per fosseno […]» (p. 64).
123. Nell’esercizio posto in fondo al volume il Gigli corregge ormai in omai (Regole, pp.239, 242).
124. Così anche l’Amenta in Bartoli, Torto, p. 350.125. Rispetto all’epitesi di -e/-o, quella di -ne appare in disuso nel Settecento e maggior-
mente marcata diafasicamente e diastraticamente, tant’è che in poesia è diffusa « fino al pri-mo Cinquecento, ma sempre in poeti di registro colloquiale (cantari ecc.) o in area cortigia-na» (Serianni, Lingua poetica, cit., § 25.4). Si veda anche il giudizio del Bargagli (Turamino, cit.,p. 154 e n. 4, e p. 177). Sull’epitesi di -ne del toscano antico cfr. Castellani, Grammatica, cit., pp.357, 412-13 e n., e per la poesia rusticale, Poggi Salani, Poesia rusticale, cit., p. 245.
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
211
p. 52) sono anche secondo il Gigli, i possessivi me ‘mio’ e to ‘tuo’ (fatti derivare dameio, toio che, con soio, «anticamente usavano», Regole, p. 38),126 i neutri plurali «delVolgo Fiorentino» mia, tua (Lezioni, p. 52), e alternanze come Pagolo/Pavolo, volpe/golpe («per uso antico restato oggi tra i nostri Villani […], delle quali voci non scarsiesempi tra gli Autori del buon secolo si averebbono», Lezioni, p. 20). Il Corticelligiudica barbare le voci abbenché («barbara, non trovandosi in alcuno Scrittore auto-revole», Regole i, p. 399; è respinta anche dal Rogacci, Prattica, p. 294, e già dalBartoli, Torto, p. 348) e potiamo (ivi, p. 121; «non puoti, puote, puotero» dice il Soave,Gramatica, p. 124). Il Soave, oltre ad annotare che medemo è «termine del volgo»(Gramatica, p. 73; mentre secondo il Rogacci è di coloro che parlano «affettatamen-te», Prattica, p. 39, e secondo l’Amenta non è «ne della Prosa, ne del Verso, ma vocede’ Segretari Romaneschi», in Bartoli, Torto, p. 239),127 si sofferma su questioni dideissi sociale, avvisando che costui, costei, colui, colei «non si debbono usare parlandodi una persona, a cui s’abbia rispetto» (ivi, p. 72) e che «Quando si parla, o si scrivead uno in terza persona, siccome si parla alla Signoria di quel tale, così bisognausare il pronome femminile, onde si deve dire le raccomando, o la prego, e non gliraccomando, o lo prego. Molto di più poi si dee fuggire l’error volgare di dir ci offero[…] invece di le offero» (ivi, p. 63).128
2) Anticheggiante (affettato, raro)
Uscite -iere/-o/-i. Sulla scorta del Buommattei, che non specifica gradi diversi diuso,129 ammettono le tre uscite il Nelli (Grammatica, p. 102) e, per i soli mestiere eleggiere, il Rogacci (Prattica, p. 84) e il Corticelli (Regole i, p. 40). Il Gigli ammettepensiere e cavaliere ma non anche cimiere (e impere), consigliando che per queste alter-nanze «bisogna attender l’uso colla lettura de’ libri» (Regole, p. 32). L’Amenta, ci-tando le quattro forme menzionate già dal Buommattei (leggiere, mestiere, destriere,mulattiere e rispettive forme in -o/-i), giudica «poco, o niente in uso» le uscite in-ieri (in Bartoli, Torto, p. 417; ampio il corredo di voci in -iere/-iero nell’Ortografia, pp.249-50), già del tutto omesse dal Manni (Lezioni i, p. 88). Il Soave si limita invece asegnalare come forme «poco in uso» barbieri, destrieri (Gramatica, p. 25; si omettedestrieri in Gramatica 1816, p. 20).130
126. Me (masch. e femm. sing.) e to (masch. sing. e femm. sing. e plur.) figurano nellapoesia rusticale: cfr. Poggi Salani, Poesia rusticale, cit., p. 248.
127. Medemo «è errore» già secondo il Pallavicino, Avvertimenti, p. 40.128. Si ricordi che ancora per tutto l’Ottocento « i confini tra le sfere d’uso dei singoli
allocutivi erano meno rigidi e potevano essere varcati senza particolari implicazioni affetti-ve»: L. Serianni, Sulla “lingua degli autori”: divagazioni di uno storico della lingua, in Id., Saggi distoria linguistica italiana, Napoli, Morano, 1989, pp. 9-26 (p. 20).
129. Cfr. Vitale, Oro, cit., p. 462 n. 46.130. Spese qualche parola in più il Bembo: «Ma tornando alle voci del maschio, egli
termina nella E ancora molto toscanamente in molti di que’ nomi, li quali comunementeparlandosi nella O finiscono, Pensiere Sentiere Destriere Cavaliere Cinghiare Scolare e somiglian-
stefano telve
212
Il tipo lo ’ncanto. Il tipo lo ’ncanto, già riprovato dal Lombardelli come plebeo,131 èinvece accolto dal Rogacci (esattamente: descritto senza giudizio) e dal Corticelli,concordi anche nel respingere l’aferesi se alla nasale segue una vocale (come in la’mitazione, lo ’more: cfr. Prattica, pp. 302-3, Regole i, p. 445, e Regole iii, pp. 489-91), nelrispetto delle prescrizioni che furono già del Bartoli (addirittura favorevole al co-strutto lo ’ncanto: «bene, e ottimamente», Ortografia, p. 74) e del Buommattei (conqualche regola in più: cfr. Della lingua toscana, pp. 95-96). Il Corticelli è l’ultimobaluardo di un uso in forte recessione. Il costrutto è ricordato dal Nelli (Gramma-tica, pp. 215-16), rifiutato come antico dal Manni («Più modernamente peròl’Imperadore si dice, ed All’incontro», Lezioni i, p. 260, Lezioni ev, p. 209, Lezioni iv, p.236) e dal Soave («Gli Antichi usaron talvolta», Gramatica, p. 292; «Gli Antichiusarono spesso […] da’ Moderni ciò si usa assai di rado», Gramatica 1816, p. 187).Contrario anche il Gigli: «questa vocale [scil. i] ella ne va a capo rotto solo in in[sic] Firenze in alcune voci comincianti per in o im […]. Per queste povere vocidecapitate ha gran compassione l’intendentissimo P. Mambelli, o sia ’l Cinonio, enella seconda parte delle sue Osservationi sopra la Lingua cap. 146. consiglia ad aste-nersi da questo Lettericidio praticato per lo più con affettazione da taluni […]»(Voc. Cat., s.v. i, p. 50); nelle Regole il Gigli avverte che per evitare la sequenza ditroppe vocali (con effetto di cacofonia: cfr. § 7.1) si tronca l’ultima della prima voceo la prima della seconda voce, «ma pure oggidì tal troncamento poco s’adopera, eper lo più si tronca sempre l’ultima vocale della prima voce, e si dice dell’Imperio,dall’Invidia &c.» (p. 15; il tema è ripreso anche nelle Lezioni).132
Istimare/estimare. Enunciando le regole della prostesi (Grammatica, p. 117), il Nelliindica che «si trov’ancora il detto accrescimento fatto colla e», precisando però, adifferenza del Corticelli che si limita ad indicarne l’uso più raro (Regole i, p. 443),che «non costumasi al presente, come: non estarà, non estima, che noi diremmo: nonistarà, non istima» (Grammatica, p. 225), disautorando così il modello latino che inprecedenza aveva motivato il Gigli a sostenere, «come ben avverte il Salviati» (Voc.Cat., s.v. cone, p. 19), che davanti a stimare, stima (e sperienza), «vuol pronunziarsi laE» (Voc. Cat., s.v. I, p. 49; cfr. anche Lezioni, p. 14).133
ti » (Prose, cit., iii 3, p. 188). L’uscita -iere è in origine fiorentina e senese, -ieri del resto dellaToscana, -iero dell’Italia settentrionale (anche se già petrarchesca e diffusa nel parlato corren-te almeno già nel Cinquecento; cfr. Castellani, Saggi, cit., ii p. 122, Castellani, Grammatica, cit.,pp. 418-19, Patota, Percorsi, cit., p. 122, Trovato, Il primo Cinquecento, cit., pp. 56 e 294, e Vitale,Oro, cit., pp. 461-63).
131. Cfr. Trattati di fonetica, cit., p. 88.132. Così nelle Lezioni: «Dove pure troncasi l’articolo, e l’apostrofo serve in luogo della
vocale della parola seguente, e così pare dovrebbe dirsi Maria andò ’n Egitto, Giuda cascò allo’nferno: il che da i Cruscanti viene puntualmente eseguito, ma pure la maggior parte degliScrittori non và sù queste tracce, e quando altri della sopraddetta regola non voglia servirsinon può esserne rigorosamente corretto, bastando, che per lo più ciò si avverta nello scontrodegl’Articoli » (p. 23).
133. Il Nelli segue il Rogacci (Prattica, p. 120) e prima di lui, il Bartoli (Ortografia, pp. 151-
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
213
Il tipo arò, arei. Forme originariamente occidentali divenute poi «molto comuninella prosa toscana e non toscana cinque-secentesca» (Serianni, Poesia neoclassica,cit., p. 46), sono ricordate dal Rogacci (avere «si contenta di rimanerne senza [scil.v], e che, in luogo del consueto Havrà, & Havrebbe, si dica Harà, & Harebbe», Prattica,p. 343; cfr. anche p. 186, dove si rinvia a Bartoli, Ortografia), parzialmente accettatedal Nelli (che accoglie arei ma non arò, ritenuto non «molto in uso» per ragionifunzionali, «potendo portar equivoco con arò di arare», Grammatica, p. 228), taciutedal Corticelli (Regole i, pp. 100-4) e finalmente respinte dal Soave come «affetta-zioni» (Gramatica, p. 104, Gramatica 1816, p. 64).134 Il Gigli ricorderà aranno in quan-to voce caratterizzata dalla caduta, diffusa nel fiorentino, della labiodentale (Rego-le, p. 72).
Forme sincopate del futuro e del condizionale. Se il Gigli colloca collettiva-mente vederò, anderò, caderò, poterò nella colonna dell’antico (Regole, pp. 88, 108, 120,135) e saperò in quella del corrotto (p. 140), più analitici sono gli altri grammatici. IlRogacci osserva che vivere, cadere, sedere «più volentieri ritengono l’E», mentre an-dare, avere, vedere «guadagnan col perderla» (Prattica, p. 343); necessariamente sin-copate per «chiunque ama parlar colto» sono invece potere e sapere (p. 344; poterò «òmeglio» potrò, p. 170).135 Analogamente, il Nelli ritiene la sincope obbligatoria nei
53), nel menzionare la possibilità di una prostesi “superflua”, fenomeno non segnalato daglialtri grammatici (Gigli, Corticelli, Manni, Soave), che « si sente usata frequentemente inparlando, e tal volta in iscrivendo ancora senza necessità, come: mi ha fatto ispaventare: tu se’un’ismemorato: oh che iscompiglio è mai questo! La mia spada è più della tua ismisurata» (Grammatica,p. 225). La prostesi superflua non è apertamente respinta e anzi, a proposito delle parole chepossono essere «accresciute» della s ad inizio di parola, si nota che «possono avere l’altroaccrescimento dell’i senza distinzione, se preceda loro, o no parola terminata per consonan-te, o per vocale, come isfolgorante, potendosi dire: con isfolgorante luce, e con luce molto isfolgorante»(ivi, p. 117; questo esempio è anche nel Rogacci, Prattica, p. 120); uso effettivamente praticatoall’epoca nelle scritture più letterarie (si vedano i frequenti esempi in Baretti, scrittore facilea ipertoscaneggiare). Su un campione di circa 150 voci prostetiche ricavate da LIZ 3 [’700],sono emersi esempi di prostesi di questo tipo in Cesarotti (anche se sempre ad inizio diverso: «annosa pianta / isbarbicata», «da due balze opposte / iscatenati », « il cor gli balza: /iscolorossi »), Baretti («da voi iscambiate», « fai iscaturire») e Alfieri («ma ischeletrito»),accanto ad esempi di prostesi condizionata dall’elisione o dall’apocope dell’ultima vocalenella parola che precede («difficile d’ischivare», Il Caffè, « far iscoppiare», « far iscortare»,Baretti) e ad altri privi di condizionamento («viva maniera dello iscrivere di questo autore»,Baretti, «vengo ad iscoprire», Goldoni).
134. Il tipo arò, arei (cfr. Manni, Ricerche, cit., pp. 141-42, e Castellani, Grammatica, cit., pp.304, 332), corrente nella poesia e nella prosa cinque-secentesca (con occorrenze anche inBargagli accanto alle forme con labiodentale: Bargagli, Turamino, cit., p. 70 n. 2), sopravvivesolo episodicamente in seguito (ad es. in Vico e in Bossi: cfr. Serianni, Lingua poetica, cit., §37.1.9.2).
135. Il Rogacci consiglia genericamente le forme sincopate (avere, dovere, potere e sapere«nel Futuro parimente, e ne’ tempi da esso nascenti amano di essere abbreviati […] lascian-dovi per maggiore, e quasi necessaria eleganza l’E dinanzi alla R, senza però raddoppiarquesta […]. Il quale accorciamento può usarsi anche ne’ Verbi Vivere, Andare, Cadere, & altri
stefano telve
214
futuri di potere, sapere (Grammatica, p. 131) e, almeno secondo certi, di andare (p. 145),e libera in viv(e)rò e cad(e)rò, benché la forma piena appaia «più usata, e migliore»(p. 228). Il Corticelli accetta le forme piene per cadere (Regole i, pp. 118-19) ma lerespinge per andare e vedere perché d’uso non sorvegliato («Anderò &c. e anderemo&c. non sono voci troppo buone», Regole i, p. 113, il dire «vederò &c., vederei &c. nonè di uso buono», ivi, p. 122) e per sapere e potere perché modi «contadineschi» (ivi,pp. 119 e 121; si espresse in questi termini già il Buommattei: Della lingua toscana, p.287 e p. 289). Proprio su caderò, caderei esprime riserve il Soave, che rifiutandorecisamente le forme piene degli altri verbi, ritiene cadrò, cadrei «meglio usato»(Gramatica, p. 123; e andrò «non anderò», ivi p. 121).136 Come notato in apertura,nell’edizione del 1816 della Gramatica si danno come possibili per il verbo andareanche le forme non sincopate del futuro e del condizionale presente (anderò, anderaie anderei, anderesti).
Il tipo dotta ed accortamente. Il costrutto avverbiale, in voga soprattutto nel Tre-cento (anche se perlopiù evitato dai maggiori), tornato alla ribalta tra Cinque eSeicento per probabile analogia con l’uso spagnolo, e infine scaduto, nel secolosuccessivo, a «vezzo letterario, sentito come classicheggiante» (B. Migliorini, Cop-pie avverbiali con un solo ‘-mente’, in Id., Saggi linguistici, Firenze, Le Monnier, pp. 148-55, p. 155), è ritenuto dal Rogacci un «troncamento affettato», che non è «solitousarsi dagli scrittori di miglior penna» (Prattica, p. 263, con rinvio al Bartoli: cfr.Torto, p. 35): così anche il Gigli («di tale spezzamento guardatevi, che che ne scri-vano alcuni», Regole, p. 214), il Nelli (Grammatica, pp. 199-200) e il Manni (di certi« forestieri»: Lezioni i, pp. 211-12). Più cauto il Corticelli, che si limita a ricordare,senza giudicare, questi «stroncamenti, che udiamo talvolta» (Regole i, pp. 427-28),137
mentre il Soave segnala che si tratta di un uso non seguito «dai buoni Scrittori»,«se non quando l’avverbio troncato ha senso avverbiale da sè medesimo, comeprima, e principalmente […]» (Gramatica, p. 159, Gramatica 1816, p. 111).
Avverbi in -e. Sulla scorta dell’Ortografia del Bartoli (p. 251), il Rogacci ritienel’uscita in -e degli avverbi in espressioni come giacer boccone, star ginocchione, andar
finiti in Do: quando non venga (come viene in alcuni) a risultar quindi durezza di suono»;Prattica, p. 186). Andrò non anderò consiglia anche il Bartoli, Ortografia, p. 280.
136. Ma nell’edizione del 1816 si legge, oltre a «Cadrò, Cadrei è meglio detto che Caderò,Caderei» (p. 85), «da doversi fuggire» averò (p. 64), e soprattutto «Andrò, o Anderò» (p. 82). Daun sondaggio nel corpus della LIZ 3 emerge che nel Settecento le forme piene del futuro divivere e cadere sono nettamente minoritarie. La tradizione grammaticale prescrive da Bemboin avanti la forma sincopata andrò classificando quella piena come non buona (Pallavicino-Facciolati, Corticelli) o antica (Gigli, Mastrofini): cfr. L. Serianni, Norma dei puristi e linguad’uso nell’Ottocento nella testimonianza del lessicografo romano Tommaso Azzocchi, Firenze, Accade-mia della Crusca, 1981, pp. 28-29.
137. Cfr. anche Rohlfs, Grammatica, cit., vol. iii § 888, Serianni, Saggi, cit., p. 60 n. 14, e (perImbriani) ivi, pp. 234-35. La LIZ 3 [’700] registra un solo esempio del costrutto segnalato inVico («della quale troppo oscura e confusamente hanno scritto i filologi», Principi di Scienzanova) a fronte di numerosi esempi del tipo -mente e -mente.
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
215
tastone, «più conforme all’uso degli antichi» (Prattica, p. 267; cfr. anche pp. 106-7),seguito dal Nelli, che ne consiglia l’uso («benchè tali voci possano avere la loroterminazione in i, e dirsi bocconi, ginocchioni, tastoni &c, è meglio però terminarle ine per uniformarsi all’uso fattone da’ migliori antichi scrittori», Grammatica, p. 72), inlinea con le posizioni della Crusca («nella Crusca notansi terminati in E», notal’Amenta in Bartoli, Torto, p. 421). Il Manni affianca senza distinguere le due seriedi avverbi (Lezioni i, p. 195, Lezioni, pp. 176-77, Lezioni ev, pp. 157-58).138 Taceinvece a questo riguardo il Soave (cfr. la sezione dedicata agli avverbi, Gramatica,pp. 147-59).
Gliele indeclinabile. Se il Corticelli ne cita gli usi senza commentare (Regole i, p.432) e ancora il Soave lo ritiene adoperato dai «buoni Autori» (Gramatica, p. 66, eGramatica 1816, p. 41 n.), il Rogacci ne parla come di una «strana libertà» e «abuso»degli antichi e specie del Boccaccio, « introdotto senza niuna ragione, anzi contrarioalle regole communi del parlare» e abbandonato dai successivi scrittori (Prattica,pp. 44-45); così ribadisce il Nelli.139 Il Gigli si limita a precisare che «tale uso fuordel Boccaccio non si trova» (e scrive Gliel’ e gliel: Regole, p. 27), mentre il Manni neparla in termini di registro, consigliandolo «a chi il ben comporre sta a cuore»(contro il volere dello Strozzi, e proprio sulla scorta degli stessi scrittori e gramma-tici citati dal Nelli: Boccaccio, Salvini e Bembo: Lezioni i, p. 142; Lezioni ev, p. 115,Lezioni iv, pp. 128-29).140
Accusativo con infinito. Ne sconsiglia l’uso il Rogacci, che, costatato quanto«Duramente sonassero» costrutti siffatti, suggerisce in sostituzione la costruzioneesplicita con che: «Anzi questa è la costruzzione, di cui quasi di sua propria, e più
138. Dalla LIZ 3 [’700] si ricavano occorrenze per ginocchioni (5) e ginocchione (un es.), e perboccone (3) e tastoni (2); nessuno invece per bocconi e tastone.
139. Sebbene «presso il Boccaccio, e per sentimento del Bembo anche ne’ buoni scrittoridi prosa sia usato indeclinabile, nulladimeno non vedesi da gran tempo chi adoperi una talformula, a cagione di non potersi discernere di che numero, e genere, sieno le cose, che sifanno, o delle quali si parla» (Grammatica, p. 98). Giudicò gliele una «pazza bestia» lo Strozzi,come ricorda l’Amenta, non contrario a questa forma anche se loderebbe «molto chi usassesempre Gliel, dove si puo, non Glie’l come scrive il Bartoli […] Ne biasimerei chi scrivesseGlielo, Gliela, Glieli», attestati in «molti de’ buoni Scrittori» (in Bartoli, Torto, pp. 202-6, spec.pp. 204-5).
140. D’altro canto il Nelli afferma che « in vece di dirsi gliene, pare sia meglio, e più re-golare il dire le ne, come: le ne verrà gran danno» (Grammatica, p. 187; così anche il Rogacci cheesemplifica con «Lene verrà gran giovamento», rinviando al Cinonio: Prattica, p. 45; viceversa,prescrivono gliene il Gigli, Regole, p. 27, e il Corticelli, Regole i, p. 432; dall’interrogazione del-la LIZ 3 [’700] si ricavano alcuni esempi della sequenza le ne (nelle commedie goldoniane euno in Casti). Gliele è considerato corretto da altri grammatici (Salviati, Varchi) ma non dalRuscelli, che ne rimprovera l’uso in Boccaccio; il Bargagli lo annovera tra le «grossolaggini»e « sciapitezze del parlare»: cfr. Bargagli, Turamino, cit., p. 157 e n. 3, Nuovi testi fiorentini, cit.,pp. 88-90 e 94-98, Manni, Ricerche, cit., p. 129 n. 9, Castellani, Saggi, cit., vol. i pp. 28-29, eRohlfs, Grammatica, cit., vol. ii § 467. Segue la linea bembiana il Muzio (cfr. Girolamo Muzio,Battaglie per diffesa dell’italica lingua, a cura di Carmelo Scavuzzo, Messina, Sicania, 1995, p. 260).
stefano telve
216
grata ad udirsi, ordinariamente si serve la nostra lingua, tanto nel parlar cotidiano,quanto nel volgarizzamento delle scritture Latine […]» (Prattica, p. 238). Ricordan-do che «Alcuni stimano che una tal costruzione sia alquanto spiacevole, e pocoamica della lingua Toscana»,141 il Corticelli riconosce che i costrutti con me e te coninfinito, frequenti negli scrittori del buon secolo «oggi non s’adoperano, e senton delduro, e del troppo antico»; viceversa, « tornano bene anche in oggi, e hanno gra-zia», con la stessa funzione, i pronomi se, lui, lei (Regole i, p. 288).
3) Familiare-colloquiale
Numerali sincopati. È genericamente ammessa la sincope sillabica (quella vocalicaè ritenuta generalmente possibile in alcune voci verbali e altri vocaboli di largouso, anche letterario)142 nei numerali, laddove, nel primo Ottocento, queste formesaranno percepite come «vistosi idiotismi» (L. Serianni, Il primo Ottocento, Bolo-gna, Il Mulino, 1989, p. 94). Dopo il Bartoli (che nell’Ortografia cita venzei, venzette,p. 304) e l’Amenta (cencinquanta, duecencinquanta, trecencinquanta, cenquaranta, venzei,venzette; in Bartoli, Torto, p. 571), il Rogacci e il Nelli ricordano vensei, cenquaranta(Prattica, p. 122, Grammatica, pp. 118-19), cendue, cendieci (Prattica, p. 81), vensette,trecencinquanta (ivi, p. 122) e cenquaransei (Grammatica, p. 119). I numerali sincopatisono ancora accettati dal Gigli (con qualche riserva: «Direste: quaransei, quaransette,cinquansei, cinquansette così troncati? – Sì; e solo vuole il Salviati, che non possa dirsitrensei per trentasei, nè trensette», Regole, p. 31; il Salviati è ricordato anche nel Voc.Cat., s.v. numeri, p. 90) e dal Manni, che nel dare esempio di vocaboli univerbaticita quaranzette e venzei (Lezioni i, p. 250).
Per il/per lo, con il/con lo. I grammatici settecenteschi non riprendono la conno-tazione familiare di per il evidenziata dal Pallavicino (benché si dica per lo passato o pelpassato, la soluzione con il «tuttavia si trova in buoni Autori, specialmente nello stilfamiliare», Avvertimenti, p. 9), né la discrezione nell’uso dell’una e dell’altra formaconsigliata dal Bartoli (Torto, p. 302).143 Il Rogacci (e dopo di lui l’Amenta, in Bar-toli, Torto, pp. 303-4) accoglie infatti pel e per lo («con tutto che sia lecito anche ivi diadoperare l’articolo Il, dicendo, Per il passato», Prattica, p. 12), considerato che lo«dopo la preposizione Per è più in uso, che l’articolo Il» (p. 322); analogamente, siconsiglia col, collo, colla (pp. 13-14). Il Nelli preferisce le forme assimilate pel («sem-
141. Si ricordi qui il giudizio polemico del Beni: «Non può non offender l’orecchie» (cit.in B. Migliorini, Storia della lingua italiana, Firenze, Sansoni, 199110, cap. ix § 16).
142. Il Nelli segue il Rogacci (Prattica, p. 122) nel ricordare opra, tempra, cetra, scevro, spronee dritto, citati insieme ad altri “accorciamenti”: sotterrano, subitano, impero (Grammatica, p. 118).Cetra e opra sono voci possibili anche in prosa secondo il Bartoli, ma solo poetiche secondol’Amenta (Bartoli, Torto, pp. 405 e 416). Il Pallavicino prescrive per la prosa opera, operare,comperare, dirizzare (Avvertimenti, p. 40), mentre il Rogacci menziona adoprare, comprare, sgom-brare, temprare senza alcun commento (Prattica, p. 343).
143. Il Pallavicino osserva inoltre che « Il in cambio di lo non si pone mai avanti al verboquando precede la particella non» (Avvertimenti, p. 15).
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
217
pre pel, essendovene pochi esempi ne’ migliori autori», Grammatica, p. 220) e col(«non bene però si dice con il, ma solo col, collo, o con lo […]», ivi, p. 62),144 una regolache «si stima necessaria, non volendo, che possa dirsi per il, con il» (p. 97), comeritengono anche il Manni (Lezioni i, p. 249), il Gigli (per lo/pe ’l e collo/co ’l, Regole, p.25; cfr. anche Lezioni, p. 35), il Corticelli (dopo per sempre lo: Regole i, pp. 32-33),145 eil Soave («per il rigorosamente non può dirsi», ma per lo o pel ).
Al plurale, il Manni indica le forme assimilate (Lezioni i, p. 249), il Nelli pe’ ecogli (ma per con è inoltre ammesso che preposizione e articolo rimangano disgiun-ti, come vorranno di volta in volta « l’orecchio e ’l giudizio», Grammatica, pp. 98-99), il Gigli prescrive per li, pei («non già per i») e cogli, colli, coi («di rado trovasi conli», Regole, p. 25) e così fa il Soave («per i è riguardato come errore; per li si truovausato da molti, ma da’ Migliori gli si preferisce pe’, o pei o per gli, e per le»; anche con«ama anch’essa d’incorporarsi coll’articolo, e far col, collo, e colla nel singolare, e co’,coi, cogli, e colle nel plurale piuttosto che andarne staccata facendo con lo, con la, congli, e con le; molto meno poi con il, con i, e con li», Gramatica, p. 35), osservando che«gli Antichi usarono anche pella, e pelle, ma non sono seguiti» (ivi, p. 35). Anchesecondo il Rogacci è meglio «Pe’, in luogo dell’Antico Pelli, e Co’ in luogo di Colli»(Prattica, p. 304), mentre si ammettono colle e cogli (p. 14).
Il tipo il di lui amico.146 Il Gigli ne respinge l’uso (Regole, p. 42), ammettendo ilcostrutto senza inversione in sostituzione di suo «dove potesse cadere equivoco nelsenso» (ivi, p. 38, con rinvio al Bartoli; cfr. anche Lezioni, pp. 52-53). Il Nelli siallinea alla tradizione grammaticale che da Ruscelli a Bartoli, a Facciolati, si espri-me contro il costrutto con inversione, «all’esempio de’ più corretti scrittori» (Gram-matica, p. 93), seguito dal Corticelli, che nella iii edizione delle Regole nota che di lui«si ode bensì volgarmente posto avanti il nome» («ma l’uso migliore del Boccaccioè di posporlo», ivi, p. 62; mancano osservazioni su questo fenomeno nel corrispettivoparagrafo delle Regole i, pp. 57-58, e l’esempio che esce dalla penna del Corticelli ap. 312 della prima edizione, « l’articolo […] debba darsi ancora al genitivo da lui
144. Anche per il plurale: «pelli in vece di per li, che non si usa, e colli in cambio di con li»,Grammatica, p. 223; «Lo stesso si dice di con i, con li, e coi, le quali maniere sono in disuso,benchè se ne trovino molti esempi nelle scritture degli antichi; ma in quel cambio si dice congli, o co’, come co’ padri, con gli uomini», ivi, p. 62.
145. Il Corticelli osserva a p. 339 che « con s’incorpora coll’articolo della voce seguente,come più distesamente si vedrà nel terzo libro»; qui si specifica che « sovente, o per toglierealcuna asprezza di suono, o per rendere più concatenata, e robusta l’orazione, si troncano»i monosillabi con finale consonantica (Regole i, p. 447).
146. Si alloga qui, tra forme più schiettamente “familiari”, un costrutto che nel Settecentoconquista «piena cittadinanza nel panorama letterario» facendo ingresso nel parlato dellecommedie di Goldoni (e di Fagiuoli); cosa che induce a ipotizzare che esso « sia stato con-sapevolmente usato dal commediografo come tassello di quella lingua italiana comune adat-ta alla conversazione che egli andava faticosamente cercando di costruire»: Massimo Paler-mo, Il tipo ‘il di lui amico’ nella storia dell’italiano, SLI, xxiv 1998, pp. 12-50 (pp. 27 e 30). Per ladiffusione del costrutto nel Settecento cfr. ivi, spec. pp. 27-34, e Antonelli, Alle radici, cit., pp.153-56.
stefano telve
218
dipendente, e che accenna la di lui materia», scompare nel passo corrispondentedella terza edizione, p. 336: « l’articolo […] dee darsi ancora al genitivo dipendenteda esso, e che gli segue dopo») e dal Soave («maniera viziosa», Gramatica, p. 75,«da schifarsi», p. 63; di lui «rigorosamente dovrebbesi usar» per nomi non sogget-to, «ma ove non possa nascere ambiguità si adopera indifferentemente anche ilsuo», pp. 68-69). Meno netta la posizione del Rogacci, che ricorda le obiezioni conle quali il Pallavicino respinge il costrutto147 ma conclude diversamente: «È benvero, che, quanto a questi due ultimi genitivi [scil. di lui, di lei], l’uso delle moderneSegreterie ha renduta già famigliare all’orecchio, nè perciò così cruda ed innaturalea sentirsi la trasposizion sopradetta. Laonde non biasimerei, chi talora, o per darealla costruzzione suono più numeroso, e più pieno, o per altro acconcio del parla-re, l’usasse: dicendo e.g. Il di lei merito, La di lui cortesia» (Prattica, pp. 3-4).
Io avevo/io aveva.148 Il giudizio di grammatici cinque-secenteschi (Muzio, Cinonio,Bartoli e Dati: cfr. Serianni La lingua del Seicento, cit., p. 575) che riconoscono ladesinenza in -o come propria del registro familiare e volgare è ripreso nel Settecentodalla gran parte dei grammatici, che adducono spesso ragioni funzionali (la distin-zione tra i e iii persona). Così Rogacci (seguendo esplicitamente il Buommattei),Gigli (che ricorda il Cinonio e il Rogacci), Manni, Nelli (che di norma allinea ledue uscite nei prospetti dei verbi: cfr. Grammatica, pp. 143-64) e Corticelli.149 Sulla
147. «Onde è grande affettazione, troppo remota dal parlar naturale, ed anche dall’usopiù frequente degli approvati Scrittori antichi, ciò che s’è introdotto nelle moderne Segrete-rie, dicendosi, la di lei bontà […]. Mà in ogni caso potrebbe dirsi naturalmente la bontà di lei[…] senza quella dura trasposizione» (Avvertimenti, p. 13).
148. Per una panoramica del tratto nella grammaticografia italiana dall’Alberti al Petrocchicfr. T. Poggi Salani, Storia delle grammatiche, in Lexikon der Romanistischen Linguistik, heraus-gegeben von Günther Holtus, Michael Metzeltin, Christian Schmitt, vol. iv, Tubinga,Niemeyer, 1988, pp. 774-86 (p. 783).
149. Cfr. Rogacci, Prattica, p. 138 («quando la prima Persona con la sua terminatione, nonpunto diversa da quella della terza, rendesse il senso del parlare oscuro & ambiguo; saràbene farla terminare in Vo»; ma nel prospetto verbale si ha solo -a, ivi, p. 156), Gigli, Regole,p. 63 (« si dice per tutti; nè mancano scrittori insigni, che l’abbiano praticato, parendo checosì distinguasi la prima persona dall’imperfetto della terza […]. Perciò quì ponesi l’ero,l’amavo, nell’usuale scrivere, e parlare quanto che tanti Autorevoli Grammatici nol consenta-no, come il Cinonio, il Padre Rogacci, e molti più; ma però è da consigliarsi ogni delicato dilingua, a scriver più tosto io era»), Manni, Lezioni i, p. 179 («non per altra ragione vanno imoderni concedendo, che nel ragionar familiare dir si possa Amavo, Avevo, in vece di quel,che è più regolato, Io amava, Io aveva, se non perchè la voce del Verbo, senza quel pronomesi confonde sovente con la terza persona»; cfr. anche Lezioni ev, pp. 144-45, Lezioni iv, p. 162),Nelli, Grammatica, p. 126 (la prima persona dell’imperfetto « termina in -va, e volgarmente in-vo»; nei prospetti verbali il Nelli scrive ora io aveva, p. 27, e io era, p. 25, ora io andava, e andavo,p. 144, e faceva, facea, facevo, ivi, p. 147), Corticelli, Regole i, p. 98 («Volgarmente si dice io ero,e quest’uso tornerebbe forse bene per distinguer la prima dalla terza persona, e si ammettenel parlar famigliare, ma non già nello scrivere, e nel parlare in pubblico, perchè di troppopeso è l’autorità in contrario»; altrove è annoverato tra gli «errori popolareschi», ivi, p. 103;
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
219
differenza di registro insiste il Gigli anche nel Vocabolario Cateriniano: sebbene eglidefinisca in un primo momento la terminazione dell’imperfetto in -o «Uso, pernon dire abuso del Volgo, o del parlar famigliare», il contrasto tra grammaticiavversi alla forma e l’uso è tale che egli conclude ritenendo di «poter dire, che ladiversità dello stile o in parlando, o in scrivendo, dovesse determinar chi parla, oscrive, a servirsi dell’una, o dell’altra terminazione» (s.v. verbi, p. 313). Va meno peril sottile il Soave: «Ero, e avevo nella prima persona dell’imperfetto, sebbene piùregolari, perciocchè distinguono la prima persona dalla terza, pure dai Migliorinon s’usano», Gramatica, pp. 103-4 (e ancora: «non è di buon uso», ivi p. 114; si pre-scrive l’imperfetto in -a anche in Gramatica 1816, pp. 64 e 72). Da notare invece chenon è raccolta da nessun grammatico, nemmeno dai senesi Gigli e Nelli, l’osserva-zione del Cittadini che rilevava uno scarto diatopico tra le due uscite (-o, diffusaparticolarmente a Siena; -a, più frequente invece a Firenze).150
Lui soggetto. Analogamente all’alternanza dell’imperfetto in -o/-a, i grammaticiammettono l’uso di lui soggetto nel parlato familiare (così Gigli, Manni, Nelli,Corticelli).151 Si distinguono il Rogacci, il quale ritiene che gli esempi antichi di lui
ma in generale: «La prima persona singulare del preterito imperfetto dell’indicativo non ègià: io amavo, come dice il volgo, ma io amava, e questa terminazione in a in tal tempo, senzach’io l’abbia a replicar di vantaggio, è comune a tutti i Verbi, ed è stabilita con fermissimaregola», ivi, p. 109).
150. Così il Cittadini: « Io leggevo usato per lo più dagli scrittori sanesi e da’ moderni fio-rentini anchora, ed io leggeva usato per lo più da’ Fiorentini ed alcuna volta da’ Sanesi ancora»(cit. in Alessandra Cappagli, Diomede Borghesi e Celso Cittadini lettori di toscana favella, in TraRinascimento e strutture attuali, cit., pp. 23-33, a p. 33). Si alternano uscite in -a e in -o nelBargagli, le prime delle opere letterarie le seconde del Turamino (cfr. Bargagli, Turamino, cit.,p. 228 e pp. 54-55 e n. 3). Il tipo in -o era minoritario nella prosa dell’epoca (cfr. Serianni,Norma dei puristi, cit., pp. 25-26 e nn.; Patota, Ortis, cit., pp. 101-4; Id., Percorsi, cit., p. 119;Gabriella Cartago, La lingua dei ‘Dei delitti e delle pene’, nel vol. Cesare Beccaria tra Milano el’Europa, Milano, Cariplo - Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 138-67, a p. 150; Antonelli, Alle radi-ci, cit., pp. 158-161; Vitale, Oro, cit., pp. 205, 469 e sgg.; Id., Operette, cit., p. 59).
151. Secondo il Gigli non possono dirsi lui e loro soggetti «benchè tutto il Mondo Toscanonel famigliar discorso parli così» (Regole, p. 28) e non ne manchino esempi « in tutti i modipresso i migliori Scrittori del secolo buono, come nella nostra Grammatica avvertimmo: Macon tutti questi oggidì non se ne loderebbe l’uso, nè meno per licenza poetica» (ivi, p. 40;nel Voc. Cat., s.v. lei, p. 65, il Gigli nota il frequente uso dei pronomi lui, lei soggetto presso gliscrittori antichi, appoggiandosi alle autorità del Tassoni e del Bartoli). Non suonano diver-samente le parole del Manni (lui, lei soggetti sono un « fallo […] da concedersi soltanto,perch’egli è invalso, nel parlar famigliare; nelle scritture non già, nelle quali non primaincominciò del 1400», Lezioni i, p. 114, cfr. anche p. 136 e Lezioni ev, p. 93, Lezioni iv, p. 103),del Nelli (che precisa l’accettabilità anche per lui, lei, loro pronomi soggetti, i quali «nonhanno luogo ne’ casi retti, benchè sene trovino degli esempi, e si usino famigliarmente nelparlar Toscano», Grammatica, p. 185) e del Corticelli (lui soggetto «è errore di gramatica […]benchè si oda tuttodì ne’ discorsi famigliari», Regole i, p. 58). Anche nella prosa letteraria lui,lei soggetto sono alquanto rari; meno invece, come ci si può aspettare, nella lingua di perso-naggi “medi” delle commedie di Gigli e Nelli (cfr., per la prosa, Patota, Ortis, cit., p. 69, e
stefano telve
220
pronome soggetto siano da «tenersi per errori di stampa; ò, come già riprovatidall’uso, ne’ loro libri lasciarsi», rinviando al Pergamini e al Bartoli (Prattica, p. 41;s’appellava agli errori di stampa già il Fortunio: cfr. Poggiogalli, Sintassi, cit., p. 118)e il Soave, che prescrive seccamente: «se ve n’ha qualche esempio non è da seguir-si» (Gramatica, p. 60; si ricorda la ricorrenza di lui lei, loro soggetti presso gli autoriantichi considerando questo un uso che «da’ buoni Scrittori non è più seguito»nella Gramatica del 1816, p. 40). Meno compattamente si esprimono i grammaticisulle eccezioni alla regola.152
Gli ‘a loro’. Osserva il Nelli: «Sempre si usa loro» invece di gli dativo plurale(Grammatica, pp. 99-100), d’accordo con Pallavicino (che giudica l’uso di gli e ledativi plurali un «solecismo»: Avvertimenti, p. 19), Manni, Gigli, Corticelli, e Soave(il Rogacci parla solo del «Dativo singolare Gli», Prattica, p. 44).153
La, le pronomi soggetto. È tratto dell’uso familiare secondo il Gigli, il Nelli, ilCorticelli, il Soave (dello stile famigliare e burlesco).154 Secondo il Manni si tratta di
Antonelli, Alle radici, cit., pp. 138-41; per le commedie cfr. Matarrese, Il Settecento, cit., pp. 104-5, e P. Trifone, L’italiano a teatro. Dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa-Roma, IstitutiEditoriali e Poligrafici Internazionali, 2000, pp. 138-39. Sulle posizioni dei grammatici cfr.anche Serianni, Norma, cit., pp. 29-30, e Paolo D’Achille, Sintassi del parlato e tradizione scrittadella lingua italiana, Roma, Bonacci, 1990, p. 316).
152. Il Rogacci accetta lui in quattro circostanze particolari (già in Bartoli, Torto, pp. 110-20,pp. 124-26): in frasi gerundiali e in frasi participiali assolute, dopo come comparativo (questetre regole sono ricordate anche dal Nelli, Grammatica, pp. 185-86) e «dopo il verbo sustantivo,con relazione d’identità al nome antecedente, e. g. L’amico dell’uomo è un altro egli e Disprezzatutto ciò, che non è lei» (Prattica, p. 41; si noti che quest’ultimo esempio sembrerebbe ricalcatosul parte finale del verso petrarchesco «e ciò che non è lei », RVF, cxvi 7-8, tanto dibattuto daparte dei grammatici del Cinquecento e oltre: cfr. Poggiogalli, Sintassi, cit., spec. pp. 119-23).I grammatici successivi al Rogacci ricorderanno solo alcune di queste regole: il Gigli am-mette indifferentemente egli e lui nelle frasi gerundiali (scartando la citata distinzione delPergamini che prevedrebbe egli in caso di coreferenza di soggetti tra gerundiale e principalee lui in caso contrario) e in presenza di credere ed essere, mentre dopo come consiglia «per piùsicurezza» di replicare il verbo (Regole, pp. 40-41); il Manni ricorda solo l’eccezione concredere ed essere (Lezioni i, p. 134); il Corticelli cita solo alcuni esempi particolari, tra i quali luifigura ora dopo siccome comparativo, ora con credere (che fosse creduto lui), Regole i, p. 58. NelleRegole iii l’argomento è trattato più distesamente specificando tre eccezioni: col verbo essere,dopo come e siccome, e nelle esclamazioni (pp. 63-64), che si ritrovano anche in Soave (il qualeavverte tuttavia che nell’ultimo caso « il lui è accusativo come lo è me beatum, me miserum!nelle esclamazioni Latine», Gramatica, p. 61).
153. Gli per loro è secondo il Gigli uno degli « sbagli » nell’uso del pronome (Regole, p. 27)e secondo il Corticelli «modo usitato del volgo, ma è poco regolato» (Regole i, p. 59). «Fuggasi»,prescrive il Manni, gli per ‘a lei’ e ‘a loro’ (Lezioni i, p. 142, Lezioni ev, p. 114, Lezioni iv, p. 128).Secondo il Soave «Gli in dativo non si può mai usare invece del plurale a loro» (Gramatica, p.62). Gli ‘loro’ è considerato corretto dal Buommattei (e dal Cinonio: cfr. Marazzini, Il secondoCinquecento, cit., p. 277 n. 28) che viceversa respinge gli ‘a loro’. Cfr. Varchi, L’Hercolano, ed. cit.,to. i p. 135, Serianni, Il primo Ottocento, cit., pp. 193-95, Antonelli, Alle radici, cit., p. 46 e n. 46.
154. Cfr. Gigli, Voc. Cat., s.v. la («proprio del Fiorentino Idiotismo», con rinvio al Cinonio,
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
221
un accorciamento «malgrazioso, e sregolato», che fu chiamato «per lo minor biasi-mo, da un ben chiaro Scrittore nostro, fretta segretariesca» (Lezioni i, pp. 141-42,Lezioni ev, p. 114, Lezioni iv, p. 128). Il Manni si riferisce molto probabilmente alloStrozzi, ricordato anche dall’Amenta (in Bartoli, Torto, p. 452). A proposito dellalingua delle proprie commedie, l’Amenta giudicò tra l’altro «più naturale, spedi-to, e forse più leggiadro, e di chi parla» la per ella, considerato che quest’ultimo«par tuttavia un parlar troppo studiato, artificiale, scolpito, e di chi scrive» (corsivimiei; in Bartoli, Torto, p. 453); così anche il Nelli nel concreto della scrittura per ilteatro.155
Che subordinante generico.156 Ammettono gli usi di che con valore temporale ecausale, menzionandone perlopiù esempi antichi, il Rogacci, il Corticelli e il Soave(il quale ricorda come poco in uso anche altri possibili impieghi).157 Solo il Nelliannota che costrutti come «Dite tutte le novelle, che vi ricordate; Con quella voce, chesoleva: La notte, che seguì l’orribil caso: Il dì, ch’io nacqui &.» si ritrovano «frequentemen-te anche nell’uso famigliare», oltre che nell’uso dei «buoni Autori» (Grammatica,p. 19; cfr. anche che ‘perché’ in non dubitare, che io ci rimedierò: ivi, p. 202).
Oltre ai tratti appena osservati, ne rimangono altri, di minore interesse, segnalatiepisodicamente da questo o da quel grammatico. Il Corticelli ritiene ad esempiodell’uso «più dimestico» l’anteposizione degli articoli ai nomi propri femminili(Regole i, p. 310; tratto connotato invece solo come fiorentino dal Gigli, Regole, p.26) e anche le forme eramo ed eri («si usano, dice il Buommattei, solo in parlando,
p. 62); nelle Regole, pp. 27-28, si richiama la restrizione suggerita dal Bartoli, cioè che la è statod’uso dopo voce terminante in e, «Sicchè non si può dire la segga, la venga assolutamente» esimili (cfr. Bartoli, Torto, pp. 450-51, e la relativa osservazione dell’Amenta, ivi, pp. 451-55). Cfr.Nelli, Grammatica, p. 186 (la, le in luogo di ella, elle, « sogliono esser molto in uso nel Dialettofamigliar Fiorentino, il qual uso non viene disapprovato da alcuni grammatici, che ne dannodegli esempi, come: la si fece avanti […]. Ma vien totalmente disapprovato da Gio. BattistaStrozzi nelle sue osservazioni intorno al parlare, e scriver Toscano»), Corticelli, Regole i, p. 60(«benchè nel parlare famigliare molto da’ Toscani si dica, e se ne trovi esempi di scrittori, nonpare, dicesi nel Vocabolario, assolutamente da usarsi»), Soave, Gramatica, p. 64 («Nello stilfamigliare, e nel burlesco in vece di egli si usa anche gli, e di ella, la»).
155. Sull’uso di la nel «codice medio» delle commedie del Nelli cfr. Strambi, La lingua inGirolamo Gigli, cit., p. 281. Su la per ella nella prosa del Settecento e successiva cfr. Patota,Ortis, cit., pp. 72-76, Matarrese, Il Settecento, cit., p. 181, Vitale, Operette, cit., p. 66.
156. Per una ricognizione diacronica del tratto basti qui rinviare a D’Achille, Sintassi, cit.,spec. pp. 208-12.
157. Cfr. Rogacci, Prattica, p. 269 (che «per Quando, e. g. Maledetta l’ora, che ’l vidi»), pp. 290-91 (che per perché), Corticelli, Regole i, p. 69 («Che talvolta si usa per nel quale», non temporalema di luogo, nelle fattispecie figurato: «Bocc. In quel medesimo appetito cadde, che cadute eranole sue Monacelle»), Soave Gramatica, p. 240 (che per perché e per in cui temporale), p. 75 (che perin cui temporale; anticamente anche che per di cui e per con cui, «ma da’ migliori Moderniquest’uso non è troppo seguito»; nella Gramatica del 1816 si ha: «ma da’ migliori Moderni ciòsi usa più parcamente», p. 43).
stefano telve
222
o scrivendo famigliarmente, e alla dimestica», ivi, p. 98), laddove il Rogacci respin-ge nettamente la prima («Eravamo, non Eramo», Prattica, p. 160) e il Gigli considerala prima dell’uso poetico (Regole, p. 57) e la seconda «fallo di tutta la Toscana, e tuttaRoma: o per dir meglio di tutta Italia» (ivi, p. 63). Il Manni (oltre ad alcune scelteavverbiali, l’uso di lui soggetto e l’uscita del congiuntivo in -ino: cfr. rispettivamente§ 5d e per gli ultimi due tratti § 5a) segnala l’oscillazione di registro che intercorretra le locuzioni verbali tirare le cuoia e render l’anima al creator suo (Lezioni i, p. 224);non fa altrettanto il Rogacci, che nel paragrafo dedicato all’uso e alla costruzione«di alcuni Verbi Speciali» ricorda espressioni come bere a ciantelini (Prattica, p. 240)e mangiare/parlare a spilluzzico (ivi, pp. 246-47) senza specificarne l’àmbito d’uso.
Più sicuro è il discrimine tra prosa e poesia, di là da rari sedimentiimpressionistici: a proposito degli accorciamenti, ad esempio, il Nelli (tenen-do presente il Rogacci)158 indica accanto agli usi poetici degli apocopati scio’‘sciogli’ e sare’ ‘sarebbe’, che «non son troppo della prosa» (Grammatica, p.224), quello di qua’ (e quai), ritenuto normale «In poesia, o in alcune co-struzioni, ove faccia buon suono anche in prosa» (ivi, p. 188).159 Similmen-te, il Gigli annota che i plurali fedeli, rivali, angioli si accorciano «di radissimodai Poeti per la durezza» (Regole, pp. 8-9).160
In generale però le numerose indicazioni riguardanti la fonetica e lamorfologia sono sgombre da rilievi di questo tipo. Osserviamo le posizionidei grammatici (anche in questo caso non sempre sovrapponibili) per alcu-ni usi significativi.
I plurali membre, osse. Il Nelli osserva che «buoni Autori hanno scritto membre, eosse» ma avvisa che «non è da servirsene troppo, particolarmente in prosa» (Gram-
158. Secondo il quale ta’, qua’, ma’, lacciuo’ sono « talora» gli «Antichi […] avvegnache noncorra oggi fuor del verso un tal troncamento», il pronome ei è « solito» del verso, mentre e’si trova «spesso eziandio da’ Prosatori » fe’ ‘feci’, die’ ‘diedi’, scio’ ‘sciogli’, sare’ ‘sarebbe’ «nonben si usano in prosa», me’ vale ‘meglio’ « alla Poetica» e po’ ‘poco’ «massimamente appres-so [sic] i Poeti» (Prattica, pp. 304-5; su ta’, qua’ cfr. anche p. 74; si tace su ver ‘verso’, p. 304); ealtrettanto vale per le forme con riduzione del dittongo discendente (po’, lu’, tuo’, puo’, mi’, tu’,ecc.) con l’avvertenza che « la maggior parte degli accorciamenti qui commemorati è solpropria del verso, nè perciò senza biasimo, e taccia di affettazione userebbesi in prosa»(Prattica, p. 312). Per gli accorciamenti della poesia cfr. anche Bartoli, Ortografia, pp. 46-48.
159. Anche se di norma ma’ e le voci in -li decurtate della laterale ed eventualmente dellasillaba finale, come ta’, qua’ e lacciuo’, in prosa «non si direbbero felicemente» (p. 224; lacciuoiè già in Bembo, Prose, cit., iii 4, p. 189, Buommattei, Della lingua toscana, p. 66, e senza com-mento nel Corticelli, Regole i, p. 14).
160. I poeti «più tosto dicono Tai, e Quai. Così troncansi ancora le terminanti in due L,Fanciullo, Fratello: e nel plurale dissero i Poeti Fanciui, Fratei» (Regole, pp. 8-9; lacciuoi è citatocome esempio di quadrittongo: Regole, p. 18). Sulla diffusione di queste forme nella poesiatra Sette e Ottocento cfr. Serianni, Lingua poetica, cit., § 29.4.
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
223
matica, p. 10). Anche il Manni, accanto a ossi, ossa prescrive «bisognando, Osse, e cosìil disse il Petrarca» (Lezioni i, p. 81, Lezioni ev, p. 66, Lezioni iv, p. 73; sono inveceallineati membri, membre, membra, Lezioni i, p. 81), mentre appaia indistintamenteossi, osse e ossa e i soli membri e membra il Corticelli (Regole i, p. 41; ma in Regole iii, p.42, come fece il Manni, aggiunge membre, come forma usata eccezionalmente daDante in rima; e forse ancora sulla scorta del Manni, Lezioni i, p. 163, Lezioni ev, p.132, Lezioni iv, p. 148, usa pendente, «come i Toscani con una sola voce esprimono»,Regole iii, p. 113, accanto a preterito imperfetto; alternativa che non figura nel passocorrispondente delle Regole i, pp. 89-90). Osse è infine ricordata, insieme ad altreforme in -e, dal Soave (Gramatica, p. 29, e Gramatica 1816, p. 23), che inoltre consiglial’uscita in -a per labbra, ciglia, dita, membra e altre voci (Gramatica, p. 29, e Gramatica1816, p. 23).161
Nosco, vosco. Voci «già andate in disuso» secondo il Rogacci e da sostituire concon noi, con voi «ò meglio» con esso noi, con esso voi (Prattica, p. 34), nosco e vosco sarannoregistrate dai grammatici successivi come specificamente poetiche (« in poesia, eben di rado in prosa»: Nelli, Grammatica, p. 62; «oggi non si direbbe, se non se nelverso», Corticelli, Regole i, p. 339; «si può […] dire, meco, teco, seco, nosco, vosco (ben-ché i due ultimi sono piuttosto del verso)»: Soave, Gramatica, p. 164, che annoveratra l’altro il tipo esso noi tra le sillessi, figura «non molto in uso», ivi, p. 247).162
‘Entrambi’, ‘due’. L’alternanza sull’asse poesia/prosa riguarda anche le espres-sioni di ‘entrambi’ e ‘due’. Il Nelli concorda col Rogacci (Prattica, p. 80) nel ritene-re migliore in prosa l’uso di amendue e ambidue (rispetto a ambedue, ambodue, ambidui,ambedui; Grammatica, p. 24; il Gigli segnala l’uso di ambidue presso gli «ultimibuoni Scrittori Sanesi», Voc. Cat., s.v. ambidue, p. 7),163 e nel consigliare due («nè
161. Nel Settecento osse è infatti usato (dati LIZ 3) solo in poesia (e sempre in fine di verso:6 occorrenze), mentre la documentazione relativa a membre, oltre a quattro esempi cinque-centeschi in Ariosto (sempre in rima), s’arresterebbe al secolo XVII con un esempio in poesia(Marino) e uno in prosa (Boccalini). Entrambe le forme sembrerebbero avere avuto in pre-cedenza una circolazione soprattutto in poesia (osse: Petrarca, Boccaccio, Pulci, Boiardo 6;membre: Guittone, Dante 2, Pulci, Boiardo 8), meno in prosa, dove possono aver agito influssidialettali (osse ricorre in Giordano da Pisa, Malermi, Ramusio, Aretino, Grazzini; membre nelMilione oltre che nell’Hypnerotomachia). Tra le voci citate dal Nelli con uscite in -a/-i si rilevaun divario d’uso nel Settecento tra cigli (dati LIZ 3: due esempi in poesia) e ciglia (quasi ottantaesempi) e tra diti (un esempio nel Caffè) e dita (oltre cento esempi), forme menzionate tra lealtre anche dal Manni (Lezioni i, pp. 76-77, Lezioni ev, p. 62, Lezioni iv, p. 68).
162. Con meco/teco/seco e nosco/vosco sono infatti diffusi più in poesia (risp. 14 e 5 esempi)che in prosa (4 e 2 esempi; dati LIZ 3 [’700]). Non stupirà il silenzio generale sul tipo seco lui:cfr. Lorenzo Tomasin, Il tipo ‘seco lui’, ‘seco lei’, ‘seco loro’, SLI, xxvii 2001, pp. 228-32.
163. Su ambidue cfr. anche Gigli, Voc. Cat., s.v., p. 7. LIZ 3 [’700]: le soluzioni della prosaappaiono effettivamente ristrette, ancora nell’uso settecentesco, alla coppia ambidue (25 esempi)e amendue (8); in poesia, oltre alle due forme citate (rispettivamente 14 e 2 esempi), troviamoanche ambidui (Parini, Poesie di Ripano Eupilino). Ambidue è forma stabile in Goldoni (versi eprosa) ed alternabile solo con ambedue. Per il resto si hanno 20 occorrenze di ambedue in prosa(privi di attestazioni ambodue e ambedui), 13 ambedue e 1 ambedui in poesia (nessun ambodue).
stefano telve
224
può dirsi dua, o duoi», Grammatica, p. 24, « In Poesia però si dice anche bene: Duo,come duo erano stretti insieme, e duo disciolti», ivi, p. 24; tace il Rogacci); prescrizioniche, oltre ad avere corrispondenza nell’uso coevo,164 saranno accolte anche dalCorticelli non nella i edizione delle Regole (dove per il numerale ‘due’ si nota solol’uso in rima di dui, citato dal Vocabolario della Crusca: Regole i, p. 43) ma nella iii,dove si analizzano nel dettaglio le diverse forme possibili: due è assegnato allaprosa e al verso, duo è « frequente in verso, e presso il Petrarca, non solamentemascolino, ma anche, contra il parer del Ruscelli, in femminino» (Regole iii, p. 21),seguendo in ciò il Cinonio, la Crusca e il Gigli contro il Ruscelli e l’Amenta (cfr.il giudizio dell’Amenta in Bartoli, Torto, p. 479), duoi è «disapprovato dal Caro […]ma trovasi in Villani» (ivi, p. 21), dua è respinto perché «sembra troppo fiorentino,ma pur se ne trova esempj negli Antichi» (ivi, p. 22), e infine «Poteva dubitarsi sefosse lecito usar dui nel numero del più, perchè il Vocabolario lo dice usato da’Poeti per la rima: ma ora sembra tolta via la difficultà, avendolo usato LorenzoBellini nelle sue Lezioni Anatomiche dette nell’Accademia della Crusca […]»(ivi, p. 45). Anche il Gigli nel Voc. Cat. ricorda dua come fiorentinismo in opposi-zione al senese due (s.v. numeri, p. 89), ma non ne parla nelle Regole, dove trattasolo due e duo (quest’ultimo da usare nei versi ma possibile per entrambi i generi:Regole, pp. 221 e 30).
Avea, aveano, udìa, udiano. Il Rogacci e il Nelli osservano che la desinenza senzalabiodentale nell’imperfetto della i, iii e vi persona è possibile per i verbi dellaseconda classe e che per quelli della terza avviene « in prosa più di rado» (Prattica,p. 138; cfr. anche ivi, p. 343, Grammatica, p. 126); così anche il Gigli, che colloca leforme senza labiodentale dei verbi di seconda coniugazione nella colonna del cor-retto e quelle dei verbi di terza coniugazione in quella del poetico (Regole, pp. 66, 75,87, 93, 100-1). Il Corticelli ritiene avea, aveano usati «non solamente in verso, maanche frequentemente in prosa» (Regole i, p. 102; si hanno sempre le forme pienenei prospetti dei verbi, pp. 114, 123, 134).165 Il Soave accorpa i verbi di ii e iii classeaccogliendo, senza alcuna distinzione di registro, avea, temea, sentia e aveano, temeano,sentiano (Gramatica, p. 114; cfr. anche p. 101).
Veduto/visto, faccio/fo. Il Nelli passa sotto silenzio la tradizionale distinzione poe-sia/prosa per le coppie veduto/visto (nel paradigma del verbo compare solo veduto,Grammatica, pp. 150-52) e faccio/fo (nel prospetto verbale si ha solo fo, ivi, pp. 147-48)registrate invece dal Rogacci («Meglio poi dicesi […] in prosa» veduto e fo, Prattica,
164. Cfr. il Bartoli, che consiglia due (non dua) e nel verso duo (secondo quanto dice ilVocabolario); duoi, « sì sovente alla lingua, e alla pena d’alcuni», ha un paio d’esempi antichi(cfr. Ortografia, pp. 299-300). Ma cfr. anche Bartoli, Torto, pp. 478-79, e le osservazioni del-l’Amenta. Sulla fortuna poetica di duo (in uso fino a metà Ottocento) e delle altre formedel numerale cfr. Serianni, Lingua poetica, cit., § 30. LIZ 3 [’700]: nessun esempio di dua, unosolo di duoi (in una poesia contenuta nella Frusta letteraria del Baretti) e 53 di duo, solo inpoesia.
165. Poggi Salani, Poesia rusticale, cit., p. 257 n. 13, rileva due esempi di facea nel parlato dellapopolana Geva nella commedia La serva padrona del Nelli.
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
225
pp. 229-30, e prima di lui dal Pallavicino, Avvertimenti, p. 58, per veduto e altri parti-cipi deboli), dal Gigli (che colloca visto nella colonna del poetico, Regole, pp. 87, 91-92), dal Corticelli (su faccio/fo: Regole i, p. 111). Il Soave osserva genericamente:« faccio, o fo che è migliore» (Gramatica, p. 122).166
Veggio. Per le alternanze tematiche del presente di vedere e sedere segnala il di-scrimine prosa/poesia solo il Rogacci («Meglio poi dicesi […] Fo e veggo, che Faccio,e Vedo, in prosa», Prattica, pp. 229-30), ma non il Nelli (che giustifica l’alternanzacon ragioni d’economia, non di registro: «Irregolare ad arbitrio sarebbe il verbovedere nelle voci veggio, e veggo, potendosi a queste sostituire l’altra regolare vedo», p.143), il Corticelli (Regole i, pp. 119-20, per sedere, p. 122, per vedere), il Manni (Lezionii, p. 172), il Soave (vedo, veggo, veggio, e solo seggo, ma sediamo o seggiamo, seggono oseggiono, Gramatica, p. 125).167
Amaro. L’uscita in -ro, per la vi persona del passato remoto di tutte le coniuga-zioni è riconosciuta come poetica ma ammessa anche in prosa dal Rogacci, dalNelli e dal Corticelli.168 Diversamente, il Manni colloca la forma tra « le voci de’Poeti, che mal sonerebbero in una prosa» (Lezioni i, p. 181, Lezioni ev, p. 147, Lezioniiv, p. 165). La forma è solo della poesia anche secondo il Soave (Gramatica, p. 114;per furo cfr. ivi, p. 104).169
Molte altre sono le forme ritenute poetiche dai singoli grammatici.Nomi, aggettivi, pronomi, avverbi, preposizioni. Anco (Corticelli, Regole i, p.
405), biasmo e biasmevole (Rogacci, Prattica, p. 131, e biasmare, ivi, p. 229), figlio (anchein prosa ma più familiare al verso: Rogacci, Prattica, p. 133), esto (Rogacci, Prattica, p.36; Nelli, Grammatica, p. 183, e Soave, Gramatica, p. 72),170 (in)ver per (in)verso (Corticelli,
166. Su veduto/visto cfr. Serianni, Lingua poetica, cit., § 37.1.7. Nella prosa del Settecento l’usodi veduto è largamante predominante (cfr. Patota, Ortis, cit., pp. 122-24, e Antonelli, Alle radici,cit., pp. 169-70). Su faccio/fo cfr. Serianni, Norma, cit., pp. 26-28, Patota, Ortis, cit., p. 119,Antonelli, Alle radici, cit., pp. 71-72.
167. L’uso coevo alterna indifferentemente i tipi vedo e veggo (non veggio; cfr. Patota, Ortis,cit., pp. 121 sgg., Antonelli, Alle radici, cit., pp. 173-74). Nel prospetto verbale il Nelli dà insie-me vediamo e veggiamo (Grammatica, pp. 150-52; ma anche le voci con tema in vegg-), seguendoin questo le Regole del Gigli (più che le grammatiche del Buommattei, del Pallavicino e delCorticelli, che registrano il solo veggiamo): cfr. Serianni, Saggi, cit., p. 15 n. 10. Veggio e veggosono entrambe largamente attestate in Bargagli (dati LIZ 3). Sui tipi veggio e veggo in poesiacfr. Serianni, Lingua poetica, cit., §§ 37.1.1.1 e 37.1.1.2.
168. Così il Rogacci: «non solamente in Verso, ma anche in Prosa» (Prattica, p. 143; per ferocfr. ivi, p. 163); l’uscita in -rono «può lasciare tanto in versi, che in prosa, la sua desinenza no»(Nelli, Grammatica, pp. 129-30); furo « si adopera il più da’ Poeti: non ne mancano però esempjdi prosa» (Corticelli, Regole i, p. 99).
169. Delle tre forme citate dal Nelli, amaro, temoro [sic; recte : temero] e furo, il corpus sette-centesco in prosa della LIZ 3 documenta un solo esempio di furo in Gravina.
170. Nelli, Soave e Rogacci ricordano tra l’altro l’uso corrente di sta davanti a notte, sera,mane, osservazione già del Bembo (Prose, cit., iii 23, p. 223: «Et è oltre acciò alcuna volta, chein luogo di Questo si dice Esto da’ poeti; e ultimamente nella voce di femina, Sta in vece di
stefano telve
226
Regole i, p. 278), lunge (Corticelli, Regole i, p. 349), labbia (Soave, Gramatica, p. 28),medesmo (Corticelli, Regole i, p. 64, Soave, Gramatica, p. 73), taciuta quest’ultima dalresto dei grammatici ma ricordata dall’Amenta come propria del verso (in Bartoli,Torto, p. 239), oltra (rispetto a oltre «è più del verso, che della prosa», Corticelli,Regole i, p. 352), i nomi derivati dal nominativo latino (Dido, Cartago, immago, testudo:Soave, Gramatica, p. 23). Il Rogacci dedica ampio spazio alle coppie di voci (perlopiùallotropi) distinte sull’asse prosa/poesia, segnalando in particolare per la prosa (traparentesi la corrispettiva forma corrente in poesia): ancella (ancilla, p. 131), avolo (avo,p. 131), esilio (esiglio, p. 132), fantasima (fantasma, p. 133), ignudo (più frequente chenudo, p. 133), maraviglia («più usata» che meraviglia, p. 133), mutolo (più frequente chemuto, p. 133), sparso e sparto (p. 134), re (più che regi, p. 134).171 È invece della prosa edel verso natio (p. 133).
Verbi. Avere: aggio (e aggiate: Corticelli, Regole i, p. 103, e aggia, aggiate, aggiano:Soave, Gramatica, p. 104), ave (Manni, Lezioni i, p. 182, Corticelli, Regole i, p. 193,Soave, Gramatica, p. 104), avei, avia (Soave, Gramatica, p. 104), avemo (tra le voci che«mal sonerebbero in una Prosa», Manni, Lezioni i, pp. 181-82, «è stato detto inverso, e in prosa», Corticelli, Regole i, pp. 102-3). Fare: fea (Rogacci, Prattica, p. 163,Corticelli, Regole i, p. 112, Soave, Gramatica, p. 122), fei ‘feci’ (Rogacci, Prattica, p. 163),feo (Corticelli, Regole i, p. 112), ferono (all’antica, Corticelli, Regole i, p. 112), fessi ‘faces-si’ (Rogacci, Prattica, p. 163), fesse (Soave, Gramatica, p. 122), fenno ‘fecero’ (Rogacci,Prattica, p. 163; fero ‘fecero’ è invece «usato anche in prosa», Prattica, p. 163). Altreforme: deggio («ha del Poetico», Rogacci, Prattica, p. 166), moro (Soave, Gramatica, p.130),172 le iii persone del presente indicativo dei verbi in -isco langue, fere, pere (Rogacci,Prattica, p. 183) e fero (Soave, Gramatica, p. 132), fora e forano (solo fora in Manni,Lezioni i, p. 182; Corticelli, Regole i, p. 99, fora e forano, che «Dicesi anche nel Voca-bolario, essersi usato»; Rogacci, Prattica, p. 160, Soave, Gramatica, p. 104), sendo («nonsia ora così usato, almeno in prosa», Rogacci, Prattica, p. 160), cangiare e meravigliare(Rogacci, Prattica, p. 230), ponno (Manni, Lezioni i, p. 182; e puonno: Rogacci, Prattica,
Questa, non solo da’ poeti, ma ancora da’ prosatori, giunto tuttavia e posto con queste trevoci e non con altre: Stanotte, Stamane, Stasera. Perciò che quando si dice, Ista notte, Ista mane,Ista sera, ciò si fa per aggiunta della I, che a queste cotali voci suole dare […]»). Su esto cfr.Serianni, Lingua poetica, cit., § 35.1. Da quanto emerso dall’interrogazione della LIZ 3 [’700] leforme sto, sta, ecc., risultano perlopiù evitate nella poesia alta. Stanotte è solo nella prosa diGoldoni (12 occorrenze) e di Baretti e conta nei componimenti in versi solo quattro occor-renze (in Goldoni); questa notte si ritrova, oltre che nella prosa di Goldoni (27), nelle suecommedie in versi (4), nei melodrammi di Metastasio (1), in Da Ponte (1), nelle tragedied’Alfieri (5) e in Cesarotti-Ossian (2; tuttavia bisogna notare che alcuni esempi di questa nottesono preceduti da in o per, con i quali difficilmente avremmo potuto avere stanotte). In verso,si preferisce questa sera (Goldoni 45, Parini i e ii red., Da Ponte 6) a stasera (Goldoni 3, DaPonte), e, viceversa, stamane (Goldoni 31, Parini 2, Da Ponte 5, Alfieri 5) a questa mane (Goldoni22, Alfieri).
171. Su nudo, muto, regi e sparto cfr. Bartoli, Torto, pp. 345-46.172. Ricorda il Bartoli che « tutte il verso usa di scrivere schiette, e senza V. ma nella prosa,
quanto più piene, e sonanti, tanto riescono migliori» (Ortografia, p. 161).
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
227
p. 230), concessi, concesso (antico e poetico, «ma ne’ migliori scrittori, e nel miglioruso» si hanno concedetti e conceduto: Corticelli, Regole i, p. 126; «quantunque i Mi-gliori in prosa usan piuttosto cedetti, e concedetti» invece di cessi e concessi: Soave,Gramatica, p. 115; « in prosa più frequentemente» già secondo il Pallavicino, Avver-timenti, p. 58), persi, perso (sconsigliate già dal Pallavicino, Avvertimenti, pp. 34 e 58,quindi dal Rogacci, ma non perché ritenute proprie della poesia: Rogacci, Prattica,p. 229; dei poeti, «ma l’uso migliore» è perdei, perduto: Corticelli, Regole i, p. 128, deipoeti talvolta «persi, ma è meglio perdei, o perdetti», Soave, Gramatica, p. 116), riedere(Nelli, Grammatica, p. 170),173 gire (Nelli, Grammatica, p. 170; cfr. Rogacci, Prattica, p.183-84, e Corticelli, Regole i: gire è «più del verso, che della prosa», p. 112, «pressoqualche antico» si ha gendo, p. 114).174
Fenomeni generali. Si segnalano: alcune forme sincopate (cfr. n. 142), l’omissio-ne dell’i prostetica (Corticelli, Regole i, p. 444), l’apocope vocalica nei plurali (Soa-ve, Gramatica, p. 294), l’epitesi di -e e di -o,175 l’omissione dell’articolo davanti alpossessivo (in prosa e in verso secondo il Corticelli, Regole i, p. 51, ma «nella prosaè da schivarsi» secondo il Soave, Gramatica, p. 48),176 le preposizioni articolate dis-giunte (a lo Rogacci, Prattica, p. 15; in la, Soave, Gramatica, p. 35),177 ella, elle al caso
173. Sullo statuto poetico di riedere cfr. L. Serianni, ‘Fiedere’ e ‘riedere’, SLI, xx 1994, pp. 161-65.174. Hanno invece una «diffusione ampia e stilisticamente non marcata fino a tutto il
Settecento» (Chiara Agostinelli, Sull’origine degli infiniti sincopati ‘corre’, ‘scerre’, ‘sciorre’, ‘sverre’, ‘tor-re’, SLI, xxii 1996, pp. 65-73, a p. 71) gl’infiniti apocopati, allineati senza distinzione con lerispettive forme piene dal Nelli: «Corre, sciorre, torre, accorciati da cogliere, sciogliere, togliere, chepure sono di buon uso» (Grammatica, p. 161). Il Gigli ricorda che cor ‘cogliere’ è «nostro»secondo il Borghesi, anche se «Non è troppo da fidarsi di quanto il Borghesi asserisce»(Regole, p. 178). Tutte poetiche le occorrenze del participio gito estratte dal corpus settecente-sco della LIZ 3. Su gire, similmente il Corticelli, Regole i, p. 112.
175. È riconosciuta dal Nelli come poetica e popolare l’epitesi di -e dopo monosillabi evoci ossitone, e solo come poetica quella di -o nella iii persona ossitona del passato remotodi iii coniugazione («L’e viene cresciuta talvolta da’ Poeti, e dal volgo, particolarmente To-scano nel fine di alcuni monosillabi terminati in a, u, o, i, e di alcune voci tronche, e gravated’accento, come: tu; su; più; sì; sta; udì, partì, finì; andò; portò […] ed a queste voci del preterito,terminante in i, si accresce anche l’o poeticamente, e bene, come: uscìo: finìo: partìo; ec. »:Grammatica, p. 227). Segnalano gli usi poetici il Corticelli, che ritiene l’epitesi di e/o usata daipoeti «per far più sonoro il verso» (Regole i, p. 444), il Manni, che cita le forme epitetichechiedeo, feo, udìo, morìo tra le voci poetiche «che mal sonerebbero in una prosa» (Lezioni i, p.181, Lezioni ev, p. 147, Lezioni iv, p. 165) e il Soave (morìo, batteo, fue e die: Gramatica, p. 297).Sull’origine fiorentino-popolare e non necessariamente meridionale dei tipi verbali in -eo/-io cfr. Serianni, Poesia neoclassica, cit., pp. 44-45; sull’epitesi di -e in poesia cfr. Serianni, Linguapoetica, cit., § 25.1 e, per i perfetti, ivi § 37.1.4.3.
176. Il Corticelli ricorda inoltre l’uso di mercè sostantivo preceduto da possessivo senz’arti-colo in poesia e con articolo in prosa: Regole i, p. 370.
177. Tratto che il Gigli ricorda in quanto senese: « […] i Sanesi nel pronunziare dicono delo, a la, a lo, de le, e così scrissero il Dante, il Petrarca, ed altri, e così pronunziano altre CittàToscane; il che in altro luogo abbiamo noi osservato» (Regole, p. 24).
stefano telve
228
obliquo (Rogacci, Prattica, p. 46; già in Bartoli, Torto, pp. 112-13),178 quei singolare(Soave, Gramatica, p. 71), lui/lei ora in funzione di dativo («qualche volta in poesia,ma parcamente», ivi, p. 62),179 ora in luogo di quello o colui («massimamente inverso, e quando sono seguiti dal pronome relativo che», ivi, p. 62). Varrà e contrario,per la poesia, l’annotazione del Corticelli che segnala l’accordo con il nome, «al-meno in prosa», da parte dei participi di verbi con ausiliare essere (Regole i, p. 307).Per l’ortografia: l’uso della maiuscola ad inizio di verso (Manni, Lezioni i, p. 269,Soave, Gramatica, p. 287), l’uso dell’accento in presenza di diastole (Soave, Gramatica,p. 288), il valore monosillabico di -ajo, -oja (Corticelli, Regole i, p. 457, Soave, Gramatica,pp. 287-88 e p. 295, nei «Poeti antichi»). Singolare è invece un’osservazione fattadal Soave a proposito di un costrutto non certo connotabile come poetico: «Quel-le espressioni de’ Poeti dalle bionde chiome, dagli occhi neri, ec. significan avente lechiome bionde, e gli occhi neri» (ivi, p. 170; anche in Gramatica 1816, p. 98; non nefa menzione il Corticelli nel paragrafo dedicato agli usi di da: Regole i, pp. 332-24).180
A chiusura di questa ricognizione su registri diversi, è da notare che ilCorticelli, nel passaggio dalla i alla iii edizione delle Regole, incrementa iriferimenti relativi agli àmbiti d’uso. Da un sondaggio sulla morfologiaverbale si ricavano le seguenti prescrizioni aggiunte alla i edizione, ordi-nate secondo la quadripartizione precedente (con l’aggiunta di tratti mo-derni).
Popolaresco (errore). Tra gli «errori popolareschi» è «voi avevi», p. 130; «errore»serò, serai, serà invece di sarà, sarai, sarà, p. 123; escire, escisse, escissero «presso i Poeti
178. Il Gigli e il Rogacci non ne ricordano la specificità poetica ma semmai l’antichità(«oggidì non se ne loderebbe l’uso, nè meno per licenza poetica»: Regole, p. 40; per elli, egli,cfr. Corticelli, Regole i, p. 60, e Regole iii, pp. 62-63).
179. Il costrutto disse lui ‘a lui’ è accolto, senza connotazioni, dal Buommattei, Della linguatoscana, p. 163, dal Gigli (Regole, p. 41) e dal Soave nella Gramatica 1816, p. 41, che tuttavia nellaGramatica, p. 62, ne aveva limitato l’uso alla poesia («qualche volta in poesia, ma parcamen-te»); è tratto respinto dal Pallavicino («ora nondimeno sarebbe affettato», Avvertimenti, p. 15)e dal Bartoli (benché sia detto della poesia e anche della prosa, Torto, p. 492).
180. Tacciono sulla presunta poeticità del costrutto Tullio De Mauro, Da, in Enciclopediadantesca, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1970-1978, ii ed. riv. 1984, vol. i pp. 297-98,Ugo Vignuzzi, Preposizioni, ivi, vol. iv pp. 344-65, Rohlfs, Grammatica, cit., vol. iii § 833, e L.Serianni, Grammatica italiana, Torino, Utet, 1989, § viii 64. Il costrutto è anzi molto raro inpoesia (qui di séguito un paio di esempi ricavati dall’interrogazione dei testi informatizzatidella LIZ 3 e dell’Archivio della tradizione lirica da Petrarca a Marino, a cura di A. Quondam,Roma, Lexis, 1997: «Mea mia dolce, dai capei de l’oro / o saporita dal viso rosato», L.B.Alberti, Rime, e «E Menelao dai capei biondi», Pindemonte, Traduzione, dove si hanno an-che altre occorrenze del costrutto) e appare ben diffuso nella prosa di secondo Ottocento eprimo Novecento (Nievo, Verga, Praga, Fogazzaro, Oriani, Tozzi, Svevo, Pirandello, D’An-nunzio: dati LIZ 3). C’è dunque da chiedersi se il Soave non volesse invece riferirsi all’anticocostrutto gallicizzante con a.
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
229
antichi, e con giudicio adoperar si possono, ma le accennate terminazioni con l’usono più regolate. Così escito si dice, ma è meglio uscito», p. 168. Rubrico qui, ben-ché non classificato come errore né come uso popolaresco, l’epitesi sillabica: «InFirenze s’ode talvolta ène per è; singolarmente quando altri tarda a rispondere adinterrogazion fattagli, e replica la terza persona suddetta, dicendo ène così peristrascico, e riposo di pronunzia. Si trova anche presso gli Antichi […]», p. 122.
Antico. «Gli Antichi per eravamo, eravate dicevano savamo, savate […]» p. 123;abbo, abbiendo, abbiente «oggi non sono più in uso», p. 128; «antiche maniere»:avavamo, avavate, avieno, in «Boccaccio, ma oggi sono dismesse», p. 130; di usoantico devere, «voce approvata dal Vocabolario; e quindi nasce la varietà, che in essosi vede nella prima vocale», p. 149; si citano: potero ‘poterono’ (Brunetto), poria i eiii pers. (Petrarca e Boccaccio), possendo e possuto (come non in uso), potavate evolavate (di entrambe: «ma oggi non s’userebbe»), p. 150; veggi (in Boccaccio) ac-canto a tu vegghi, p. 151; io sentì (in Dante), p. 163; io uscì (in Boccaccio), p. 168.
Moderno. Siano ‘sieno’ «è riprovato dal Buommattei […]. Io però ora nol ri-prenderei sì di leggieri, trovandosi in Autori moderni approvati, singolarmente nelSegneri […]», p. 124; «devo, devi, deve, sono da ammettersi, trovandosi più volteusati dal Salvini, e dal Segneri», p. 149; il Salvini «usa devè per dovette […] debbiamoper dobbiamo», p. 149; le voci di bere con mantenimento della labiodentale (accantoa quelle con caduta), poiché si riconosce l’infinito bevere, «come ammette il Voca-bolario», pp. 162-3 (in Regole i, p. 133: Bere «che da alcuni sì dice, bevere, e si coniugaregolarmente»), e come concordano il resto dei grammatici.181
Familiare. «S’ode in Firenze nel discorso famigliare ate per avete […] la qualvoce dal Buommattei è riputata barbara. Io non ho alcuna difficoltà d’ammetterla,avendola usata il gran lume della nostra Accademia, e dell’Italia, il Galileo, e piùvolte», p. 128.
Poetico. Ponno ‘possono’ «è poetico» benché in Salvini, p. 150; morìo, p. 167.
Residuano altre osservazioni sulle perifrasi avere a + infinito e andare + participiopassato ‘dovere’, pp. 133-34 e 138, su un imperativo d’uso familiare (tieni tu, «o purte, pronunziata con l’e larga. Bocc. g.7.n.2 Te questo lume, buon uomo», p. 148), esulle diverse coniugazioni di riandare e trasandare (si ricordano il Bartoli e l’Amenta:p. 142; sull’argomento anche il Rogacci, Prattica, p. 162, e il Nelli, che abbina l’oscil-lazione morfologica a una distinzione semantica: cfr. Grammatica, pp. 145-46).182
181. Il Nelli ritiene possibile «escludere l’u consonante» per tutte le voci di bere (tranne lai, la iii e la vi del passato remoto; Grammatica, pp. 162-63): un’eventualità che il Rogacci,ricordando l’approvazione in tal senso del Buommattei, riconosce anzi come «più conformeall’uso moderno del parlar Toscano, almeno in Prosa» (Prattica, p. 176). Il Gigli (Regole, pp.157-59) e il Soave (Gramatica, pp. 126-27) affiancano entrambe le forme. Alcune occorrenzetratte dalla LIZ 3 [’700]: bee (Goldoni 2, Baretti, Alfieri, Casti 5, Pindemonte), beon(o) (Goldoni,Casti), beeno (Giannone), beete (Parini 2, Bettinelli), beendo (Parini), beer (Il Caffè).
182. Bartoli dice che i verbi possono usarsi «colle voci antiquate, e non più in uso del suocomponente ando, andi, anda, andano, andino, e potersi ancora usare colle altre de’ verbi vo, e
stefano telve
230
Dell’apertura dello spettro linguistico avvenuta nel passaggio dalla i allaiii edizione colpisce soprattutto, di là dall’infoltimento, l’ampiezza dellavisuale complessiva della grammatica, che abbraccia, a un estremo, l’arcaismodea (si badi, non dichiarato tale), che già figurava nella i edizione, e, all’altroestremo, tratti moderni (i citati siano, devo e le voci di bere con conservazio-ne della v), accogliendo persino il franco demotismo ate: il Gigli, si noti,più di vent’anni prima, incasellava dea nella colonna del poetico (Regole, p.111) e ate in quella dell’uso corrotto (ivi, p. 66; forma «pur de’ Sanesi, e di altripopoli Toscani», p. 72).
5.2. Impressionismo
Il lessico tecnico dei grammatici è spesso inframmezzato da terminiquali vaghezza, dolcezza, vezzo, durezza e simili, termini che, pur non essen-do tecnici, sono destinati alla classificazione di scelte linguistiche.
Il Nelli, ad esempio, raccoglie alcune voci che subiscono «per dolcezza»(Grammatica, p. 225) un «accrescimento volontario» della i: perlopiù formedittongate come gli arcaismi priego, brieve e niego e, d’affermazione letterariapiù recente, tiepido; ma tra queste si cita anche veggio.183 L’accrescimento è
vadi, e dirsi: io trasando, e trasvo, o trasvado, ec. riando, e rivo, o rivado; ed il Rogacci, non disap-provando il sentimento del Bartoli, dice esser meglio seguire l’inflessione irregolare, e ser-virsi delle voci de’ verbi vo, vado, che delle antiquate dette di sopra, dicendo: trasvanno, trasvada,rivada ec. ad esempio di Dante, che di tali voci si è servito. A me parrebbe, che la riflessionesul significato di tali verbi possa dar regola al modo di usarli. Il primo di essi trasandare,quando significa trapassare molto avanti, o trascorrere oltre i limiti, debba usarsi colle vocidel verbo vo, o vado, e togliere in quei soli casi alla preposizione da che si compone, la s,dicendosi per esempio: tu travai dalla parte di là: i soldati di questa compagnia travanno gli altri nellamarcia. Quando poi significa trascurare, o dismettere, debba seguirsi la regolarità del verboandare anche nelle sue voci disusate, e dirsi: trasando, trasandi ec. per esempio: il negligenteagricoltore trasanda anche le migliori piante, e i diligenti non ne trasandono alcune. Il verbo riandare poi,quando è in significato di esaminare, o considerare di nuovo una cosa già fatta; direi, che sidovesse usare, come il verbo andare senza irregolarità, ma colle dette voci disusate ando, andi,ec., e dirsi: gli scolari riandano le loro composizioni: io riando la lezione ec. Nel significato poi diandare nuovamente doversi usare colla irregolarità del suo semplice andare, dicendosi: io nonci rivado più: tu ci rivai ogni giorno» (Nelli, Grammatica, pp. 145-46).
183. Sul topos della dolcezza del toscano cfr. N. Maraschio, Il parlato nella speculazione lingui-stica del Cinquecento, «Studi di grammatica italiana», vi 1977, pp. 215-18. Nell’errata corrige alla iedizione delle Regole del Corticelli (ma non anche in un altro esemplare della stessa edizioneda me consultata), stampate un anno dopo la grammatica del Nelli, si annota che « trovan-dosi per entro l’opera siegue, siegua, sieguono, sono parole scorse per inavvertenza, dovendosiin buona lingua dire segue, segua, seguono. E lo stesso dico di truovare, truovato ecc.» (in questiultimi casi forse perché il dittongo si trova in sede atona; Regole i, p. 533). Tant’è che nel
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
231
viceversa ritenuto «necessario» per le forme dittongate vuoi, vuole, puoi,tiene e viene (ivi, p. 172),184 ma per il resto «L’u parimente spesso togliesi»quando «compone il dittongo uo, come pruova, tuonare, che dicesi prova,tonare ec.» (e ancora in scuopro, truova, vuoto, tremuoto: Grammatica, p. 119),riflettendo la tendenza al monottongamento in atto nell’uso non letterariosettecentesco (per tonare conterà la regola del dittongo mobile), là dove ilRogacci, trent’anni prima, si era espresso in termini leggermente diversi:«suonan meglio» se accresciute le voci muoio, nuoto, scuoto, suono, scuopro, pos-siedo (Prattica, p. 189) e anche se pruova, vuoto, tuono, nuoto «meglio, e piùcommunemente si usin con essa [scil. u]; possono tuttavia starne senza»(ivi, pp. 124-25).185 Il Soave, nell’edizione del 1816, dirà finalmente che vocidi questo tipo «si pronunziano, e si scrivono indifferentemente, e coll’u, esenza» (Gramatica 1816, p. 184).186
passaggio dalla i alla iii edizione -ie- è eliminato: sieguono p. 309 > seguono p. 333, siegue p. 365> segue p. 396.
184. La regola del dittongo mobile è accennata dal Nelli a proposito del gerundio: «ne’verbi tiene e puote ed alcuni pochi altri, leva la prima vocale, e si dice tenendo, e non tienendo,potendo e non puotendo» (Grammatica, pp. 48-49). Si veda anche Pallavicino, Avvertimenti,spec. p. 45, Manni, Lezioni i, pp. 256-57, Lezioni ev, p. 206, Lezioni iv, p. 233, Corticelli, Rego-le i, pp. 440-41 (che distingue un dittongo mobile in infocato, tonare e tonerà; e un dittongo fermoin piego/piegare, piano/pianissimo, pieno/pienissimo, piovere/pioverà, fiato/fiatare, fiero/fierezza, mie-tere/mietitore, pietà/pietoso, lieto/lietissimo, ma non lietizia) e Soave, Gramatica, p. 285, Gramatica1816, p. 184. Anche il Rogacci testimonia che il dittongo in sede atona aveva ormai acquisitouna sua marcatezza: « […] i mentovati, e altri simili verbi, non possono così accrescersi,fuorche nelle voci che han l’accento sopra le vocali O, & E. Onde possiamo bensì direMuoro, Muori […] ma non ancora Muorrò, Muoriva […]. Sì come pur ben diciamo, Niega, eNiegano &c. ma non altresì Niegava, Niegherò &c.» (p. 188, sola eccezione: intiepidire). Laregola del dittongo mobile è espressa più avanti: il dittongo «dura intiero in tutte quellevoci, dove seguita a stargli sopra l’accento: ma in quelle, dove l’accento da lui passa a pre-mere alcun altra delle sillabe susseguenti, si scempia» (ivi, pp. 323-24). Sui dittonghi ie e uonel Settecento cfr. Patota, Ortis, cit., pp. 27-30, Serianni, Saggi, cit., pp. 68-69, Antonelli, Alleradici, cit., pp. 79-84, 87-89, Id., Bertola, cit., p. 200. A tiepido rinviano i vocabolari dell’epocache lemmatizzano la forma monottongata, di maggiore uso in prosa, ma minoritaria già nelSettecento: cfr. Patota, Ortis, cit., p. 30, Vitale, Operette, cit., pp. 20 sgg., Antonelli, Alle radici,cit., p. 85.
185. Non tutte le forme con dittongo -uo- citate dal Nelli sono alla stessa stregua: è nor-male tremuoto, che sopravvive ancora nei giornali milanesi di primo Ottocento e in Leopar-di (cfr. Vitale, Operette, cit., p. 16 n. 3, e Vitale, Oro, cit., p. 195); è interessante la presenza divuoto, i cui «più antichi esempi toscani […] noti al Castellani sono del 1751» (Aldo Ventigenovi,Il monottongamento di ‘uo’ a Firenze, SLI, xix 1993, pp. 170-212, a p. 212).
186. Cfr. Bartoli, Ortografia: « tutte il verso usa di scrivere schiette, e senza V. ma nellaprosa, quanto più piene, e sonanti, tanto riescono migliori», ma sono da lasciarsi «per lo darche fanno troppo nel duro» rispuose, puosero, puosonsi (p. 161); constatata l’oscillazione del
stefano telve
232
Il giudizio del Nelli è espresso in termini analoghi già dal Pallavicino187
e dal Bartoli («La vocale I in molte voci s’aggiunge, o per dilicatezza, o pervezzo», Torto, p. 404; cfr. anche Ortografia, pp. 157-60), che proprio per que-sto venne rimbeccato dall’Amenta, il quale, pur indicando come discrimi-nante una condizione prettamente grammaticale: la regola del dittongomobile («L’I non s’aggiugne per dilicatezza, e per vezzo, ma dove bisognail dittongo: come in Niego […] Brieve»), ammette un uso per “vezzo” invoci come milia e nieve che «oggi non diconsi, che Mila, Neve» (in Bartoli,Torto, p. 414).188
Si tratta di un vezzo che è forse tale perché sa d’antico (anche se una delleautorità consultate dall’Amenta, il Rogacci, accosta seccamente la formaquattro-cinquecentesca milia a quella più antica mila: Prattica, p. 85, e «Due-mila, ò Milia, Tremila, ò Milia», ivi, p. 81),189 come potrebbe suggerire ilNelli, a proposito di nieve, forse proprio sulla scorta della citata osservazio-ne dell’Amenta: la i figura infatti anche «in alcune parole, che più graziaavrieno, se ne fossero senza, come: nieve, triemo190 […] ec., con tutto che», sispecifica, «sieno stati usati talvolta da’ buoni autori antichi; ma il buon usopresente è al contrario; siccome non lo ammette nelle voci miele per mele:chierico per cherico» (Grammatica, p. 225), giudizio che gode questa volta an-che dell’avallo del Rogacci (« cherico, e non chierico», Prattica, p. 132, «mele,non miele», ivi, p. 133; nieve, brieve, tiepido e, tra queste, anche gielo, «possonoscriversi e pronunziarsi senza dittongo», ivi, p. 124), citato dal Gigli qualeproscrittore della forma chierico, «sotto pena di sospensione da tutti gli ono-ri della Crusca. Ma il Vocabolario vi è incorso» (Voc. Cat., s.v. chericato, p. 17).191
dittongo negli scrittori, l’autore dichiara di non scrivere «altrime[n]ti Truovo, e Truova, Pruovo,e Pruova, Vuoto, e Vuota, Nuoto, e Nuota &c. di quel che mi scriva Muore, Tuona, Cuopre […]che è il consueto scrivere delle prose» (ivi, pp. 239-40).
187. Si dice «elegantemente […] siegue, brieve, niega; ma non sieguire, brievità, niegare. Ed inciò la migliore regola è l’uso» (Avvertimenti, p. 45).
188. Nieve è forma toscana occidentale (anche pratese) e senese «che giunge fin quasi alleporte di Firenze» (Castellani, Grammatica, cit., p. 289).
189. Su milia cfr. Castellani, Saggi, cit., vol. i pp. 26-27.190. Per la prima (propria dell’antico senese, lucchese e pistoiese) cfr. anche Rohlfs, Gram-
matica, cit., vol. i § 51, Castellani, Saggi, cit., vol. i p. 164, Id., Grammatica, cit., pp. 289, 356; perla seconda Castellani, Saggi, cit., vol. i p. 123. Sulla minore diffusione delle forme in -ie-rispetto a quelle in -uo- nella prosa del Settecento cfr. Patota, Ortis, p. 28, Antonelli, Alle radici,cit., pp. 79-88, e Vitale, Operette, cit., pp. 16-18.
191. Si ha oscillazione «en Toscane, entre mèl, fèl, qui conservaient leur voyelle intacte, etmèle, fèle, qui tendaient à se diphtonguer (on pourrait songer aussi à une influence des formesde l’oblique avec deux l )»: Castellani, Saggi, cit., vol. i p. 125; cfr. anche i rinvii degl’Indici, s.v.mele/miele. L’oscillazione sarà stata collocata ancora nel Settecento sull’asse +/- toscano-lette-
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
233
I grammatici impiegano tuttavia il sostantivo vezzo anche per altri tratti,accomunati sotto l’accezione più ampia e generica di ‘proprio, caratteristi-co’ di una lingua o di un certo livello di lingua ed equivalente sostanzial-mente a ‘dialettale’ (e da questo punto di vista più che da quella dell’anti-chità saranno stati giudicati i fenomeni appena citati). Il Corticelli ricordache si usano «per un certo vezzo toscano» l’infinito con la preposizione a(piuttosto che con l’articolo: «Che cosa è a favellare […]», Regole i, p. 296)e le corrispettive voci apocopate di meglio, voglio, mali, quali, mezzo, egli (ivi,p. 457);192 il Soave, egli, ei, e’, ella, come ripieni «per puro vezzo di lingua»(Gramatica, pp. 63-64); il Manni, l’omissione «per vezzo» del che in tuttochè,perchè, poichè, acciocchè negli antichi (Lezioni i, p. 199); il Gigli, la caduta dellalabiodentale in tante voci verbali nel fiorentino (Regole, p. 99, cfr. anche pp.66 e 72),193 l’Amenta, forme come la per ella, vello vello (‘vedilo, vedilo’), fostùe fratelmo, d’uso nei bassi componimenti (in Bartoli, Torto, p. 455).
In casi come questi, l’ingrediente prettamente toscano (o fiorentino)non vuole essere né incluso senz’altro tra quanto è prescrivibile né esclusodel tutto, ma introdotto nella trattazione con un espediente linguistico,un’etichettatura non tecnica, ma certamente non casuale né spregiativa,che avverta soltanto della marginalità dell’uso rispetto alla norma o, vice-versa, della sua non completa esclusione.
Rimanda più alla sostenutezza dello stile che alla coloritura locale ecolloquiale la nozione di vaghezza. In questo termine il Corticelli accomu-na le cinque costruzioni figurate (ellissi, pleonasmo, sillessi, ennallage, iperbato,che si fanno «per maggior brevità del parlare, o un certo non so che divaghezza, e di grazia», Regole i, p. 413), un uso arcaizzante come la sequen-za accusativo + dativo dei pronomi («I moderni soglion dire: io ve lo dirò»:Regole i, p. 430; anteposizione che secondo il Rogacci «non è sempre tantonaturale, nè da usarsi perciò, senza moderazione e riserbo», a meno chenon si abbia la combinazione di gli/le con si/ne: Prattica, p. 48),194 e un co-
rario: largheggiano infatti tra Quattro e Cinquecento numerosi esempi di mèle nella lettera-tura alta (Lorenzo de’ Medici, Sannazaro, Ariosto, Aretino, Caro, Gambara, Guarini, ecc.), afronte di occorrenze di miele in un corpus di testi distante dal modello tosco-letterario (Ruzante,Ramusio, Sarpi, Boccalini, Pona e il Marino delle Dicerie sacre). Il fiorentino dugentesco hacherco (cfr. Castellani, Saggi, cit., vol. ii p. 502, e Id., Nuovi testi fiorentini, cit., p. 665).
192. «Me’ per meglio è ben detto» secondo il Gigli, Regole, p. 238 (nell’esercizio).193. Forme come scrio, scrie, scriàno, scriete, e molte voci di avere e dovere: «Ma pure i Nobili,
e Letterati s’astengono da questo vezzo, ed io ho stimato quì porre gli errori, che alla termi-nazione generale si appartengono, così tanto a scrivere, che a leggere, rendere &c.» (Regole,p. 99).
194. Il Corticelli si esprime in termini simili a quelli del Bembo («Ma regola o legge che
stefano telve
234
strutto di tono tutt’al più sostenuto, ma non certo arcaico, come il gerundiopreceduto da in (mentre non è «oggi troppo in uso» posporre il gerundioad altre preposizioni: cfr. Regole i, p. 302), accettato anche dal Rogacci (Prattica,pp. 146-47), il quale, d’altra parte, ritiene aggiunto «senza niun bisogno, maper mera vaghezza» (ivi, p. 4) il di con i nomi preceduti da aggettivi diquantità o numero (tanta di superbia) e coi nomi propri in senso di lode obiasimo (il tipo il cattivello d’Andreuccio).195
Così è anche per altre etichette impressionistiche, come la dolcezza, l’ele-ganza, la grazia e la leggiadria, che indicano un tono letterario o generica-mente sostenuto.196
Questo risultato si può ottenere, secondo il Nelli, anche grazie agli «ac-corciamenti»: ad esempio, quando il segue o, e, se, ne, che, chi, tra, non («cuisi tolga la n ultima») «può togliersi per eleganza al detto articolo la vocalei, ponendo l’apostrofo avanti la l» (Grammatica, p. 97)197 e, analogamente, ilRogacci ritiene possibile «per sola maggior eleganza» rendere l’articolo icol solo apostrofo (Prattica, p. 15).
Altrettanto vale per fenomeni non specificamente poetici come il parti-cipio tronco,198 usato secondo il Nelli «o per eleganza» (cfr., similmente,già il Bartoli: «con maggior gratia, che se fossero interi», Torto, p. 364, ilRogacci: «per maggiore eleganza», Prattica, pp. 150-51,199 e il Gigli, Voc. Cat.,s.v. verbi, p. 319) «o perchè torna comodo alla rotondità, e consonanza delperiodo» (lacerato/lacero, dimenticato/dimentico, troncato/tronco, gonfiato/gonfio,
porre vi si possa, altra che il giudicio degli orecchi, io recare non vi saprei, se non questa: cheil dire Tal la mi trovo al petto, è propriamente uso della patria mia; là dove, Tal me la trovo,italiano sarebbe piuttosto che toscano, e in ogni modo meno di piacevolezza pare che abbiain sé il nostro», Prose, cit., iii 19); il Rogacci a quelli del Pallavicino (« il che non è moltonaturale», Avvertimenti, pp. 11-12). Anche il Gigli respinge i tipi il vi e lo vi a favore di ve lo(Regole, p. 37: «Non passò tal uso nei Moderni, ed il Chiabrera ne fu tacciato d’affettazio-ne»), mentre per il Soave l’anteposizione dell’accusativo al dativo si usa « tal volta per graziadi lingua» (Gramatica, p. 66).
195. Il secondo costrutto è già osservato dal Buommattei, Della lingua toscana, p. 163.196. Sull’uso di termini di questo tipo (leggiadria, dolcezza, ecc.) nel Manni cfr. Trabalza,
Storia, cit., pp. 384-85.197. Nel secolo successivo la forma ridotta ’l assumerà piena connotazione poetica (cfr.
Serianni, Lingua poetica, cit., § 27.1).198. Toscanismo diffuso anche in prosa (anche se « i Prosatori, debbon sempre ricordarsi,
essere una licenza poetica», ammonisce l’Amenta, in Bartoli, Torto, p. 368), attestato ancoranel Di Capua (cfr. Vitale, Oro, cit., p. 207); nel primo Ottocento il participio tronco appar-terrà alla schiera dei «vistosi idiotismi» (Serianni, Il primo Ottocento, cit., p. 94).
199. Dove si citano: lacero, ritto (da rizzato), diritto (da dirizzato), dimestico, dimentico, valico,oso, guasto, tronco, ecc.
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
235
ivi, p. 138), e per la v talvolta omessa «liberamente, ed alcune volte conleggiadria» (ivi, p. 228) nelle iii persone dell’imperfetto dei verbi di coniu-gazione diversa dalla prima.200
In accordo con «gli usi letterari moderni e la prescrizione dei gramma-tici meno tradizionalistici», come osserva Maurizio Vitale,201 è l’articolo glidavanti ai plurali di Dio e a parola cominciante per z, consigliato dal Rogacci«per maggior eleganza» (Prattica, p. 12) e quindi dal Nelli («per più elegan-za, e dolcezza di favella», Grammatica, p. 98; prescrive gli davanti a z e condei, oltre che in altre condizioni, il Soave, Gramatica, pp. 33-34, Gramatica1816, p. 26) – un tratto a lungo oscillante nelle prescrizioni grammaticalima non nell’uso settecentesco.202
La validità di un giudizio di questo tipo è messa in dubbio dal Manni aproposito del costrutto umana e benignamente, diffuso tra alcuni «forestieri[…] per leggadrìa [sic], direbbe lo Strozzi, e a me sembra per isfuggir lareplica (che leggiadrìa non torrebbe)» (Lezioni i, p. 212; sul tratto cfr. § 5.1),benché altrove egli affermi: «Omai, è più dolce, e come tale più frequen-tato dagli Antichi» (ivi, p. 198).
L’eleganza caratterizza anche altri tratti di lunga tradizione grammatica-le: oltre ad alcune voci verbali sincopate «per purità della nostra lingua»,come vedrò (e in generale quelle che nella iii persona hanno d/t/v «avantiall’ultima loro vocale», Grammatica, p. 131),203 voci che il Rogacci ritenevada sincopare «per maggiore, e quasi necessaria eleganza» (Prattica, p. 186),il Nelli concorda col Rogacci nel ritenere eleganti (e simili) la posposizionedi assai al nome («con molta grazia»: Prattica, pp. 65-66, Grammatica, p. 194),il costrutto formato da articolo + cui + nome invece che da nome + di cui(Prattica, p. 2; Grammatica, p. 93),204 l’omissione di a in frasi come cui piace,
200. Le voci dell’imperfetto senza labiodentale (tranne quelle di largo uso come avea,dicea, facea) erano nel secondo Settecento se non esclusive «certo più caratteristiche dellalingua poetica» (Patota, Ortis, cit., p. 113; cfr. anche Antonelli, Bertola, cit., p. 202, e Serianni,Pietro Giordani, cit., p. 264). Cfr. § 5.1 (e n. 165).
201. In Vitale, Operette, cit., pp. 46-47, dove si segnala la presenza del costrutto in Leo-pardi.
202. Cfr. Antonelli, Alle radici, cit., p. 134. Sull’uso dell’articolo lo davanti a z cfr. C. Marazzini,Grammatica ragionata e ragionare con la grammatica: Francesco Soave e le regole dell’articolo ‘lo’, in Laparola al testo. Scritti per Bice Mortara Garavelli, a cura di Gian Luigi Beccaria e Carla Marello,Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001, pp. 593-604. Nel corpus settecentesco della LIZ 3 gli + z-conta 4 occorrenze (Goldoni 3, Alfieri) di contro alle 37 di i + z (Vico, Goldoni 24, Baretti 6,Bettinelli 2, Alfieri, Casti 2, Cesarotti).
203. Su questo tratto cfr. § 5.1.204. L’articolo si tralascia «con eleganza» davanti a cui, loro, altrui, «quando però la detta
stefano telve
236
disse loro (secondo il Rogacci cui, loro, altrui «possono, e ’l secondo anchemeglio» non essere preceduti da a, Prattica, p. 3; Grammatica, p. 94).205
Analogo è l’uso in Corticelli, che ricorda costrutti usati «elegantemen-te» (a per in in complementi di tempo, come in Boccaccio «a queste not-ti»: Regole i, p. 331, e più in generale, ivi, p. 266; e sopra o allato invece diaddosso, «e s’intende delle cose, che altri ha in tasca, o intorno alla perso-na», con esempi in Boccaccio: ivi, p. 363), «con grazia» (certe omissioni dicosì: come nel Novellino «uomini, come donne»; ivi, p. 379, e amerò, amerei,voce «portata dall’uso della lingua» e «maniera più graziosa, e gentile»,«checchè ne dica il Bembo», di amarò, ivi, p. 110) e «leggiadramente» (laripetizione di e congiunzione «a ciascuna delle parole, che sono da essacongiunte», ivi, p. 405).206
Il Corticelli estende l’applicazione del termine anche all’uso dei verbi,segnalando «molti modi di dire eleganti, e proprj della lingua Toscana»,come contendere una cosa ‘impedirne il conseguimento’, far vedere ‘dare adintendere’, tenere ‘vietare l’ingresso’, tener favella ‘restar di parlare ad alcunoper isdegno’, tener credenza ‘tener segreto’, cogliere, porre cagione ‘accusare, in-colpare’, torre il capo, la testa a uno ‘infastidirlo’, rendere la grazia ‘perdonare’(ivi, pp. 195-96); una classificazione che ritroviamo simile nella grammaticadel Rogacci, dove si gradua per giunta l’intensità: si usano «elegantemen-
particella è retta da qualche nome sustantivo espresso, come: Pietro è assai dotto, la dottrina di cuiè assai utile al Pubblico, potendosi anche dire la cui dottrina ec. […]» (lo stesso costrutto èpossibile con i pronomi costui, costei, colui, colei, costoro: Grammatica, p. 93); così già il Rogacci:solo quando di «è retta da qualche nome sustantivo» (dopo cui, loro, altrui, costui, costei, colei,costoro, coloro: Prattica, p. 2). Cfr. Bembo, Prose, cit., iii 11 (dove si afferma che l’omissione èmolto più frequente «con quest’altre due, Cui e Loro, che con alcuna altra: Il cui valore, I cuiamori, Onde fosti e cui figliuolo, Del padre loro, Alle lor donne, Co’ loro amici», p. 202). Aderisconoalla prescrizione bembiana sconsigliando il costrutto formato da di cui posposto al nomeanche il Bartoli («dove più spacciatamente, e meglio, direbbono, Il Cui Nome, La cui bontà»,in Torto, p. 58), il Gigli (che negli esercizi corregge la frase «un certo libro, di cui non misovviene l’autore» in «del cui autore non mi sovviene», Regole, p. 230) e il Manni («Si diceancora Nella cui famiglia, Nel cui seno, ec. Nei quali casi si suol frapporre leggiadramente ilPronome tra la preposizione, e ’l sustantivo», Lezioni i, p. 161).
205. Il corpus settecentesco della LIZ 3 documenta per l’alternanza a cui/cui una distribu-zione disomogenea. Predomina il costrutto senza preposizione davanti a piacere ed è vicever-sa esclusivo quello preposizionale davanti a dire: a cui + piacere conta un solo esempio (Parini,Odi) contro sei di cui + piacere; per a cui + dire si registrano solo tre occorrenze (Gravina, Dellaragion poetica, Goldoni, Le donne di buon umore, didascalia, Vico, Vita). Si ha sempre loro senzapreposizione in presenza di dire e piacere (rispettivamente 11 e 5 occorrenze).
206. Leggiadramente non allude all’uso poetico, se altrove (a proposito dell’ellissi della con-giunzione) si specifica che « In verso si tace la copula e, e alcuna volta l’avversativa ma»(Regole i, p. 418).
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
237
te» amar meglio e tor più tosto ‘preferir nella elezione’, avvisare (-arsi) ‘pensare,ò Imaginare’, cessare ‘cansare’ e ‘impedire’, e la locuzione venire/avere + destro;e «con molta eleganza» essere impersonale (e «leggiadramente» avere peressere),207 la locuzione rendere/avere/seguire + merito, e punto in alcune espres-sioni (Prattica, pp. 240-48).208 Elegante è persino la costruzione che si haquando «gli Accusativi di amendue i generi, e numeri sogliono aggiunger-si talvolta nella Costruzzione, senza niun bisogno, ma per sola maggiorchiarezza, ò eleganza: e. g. Le quali forze io confesso che non le ho» (ivi, pp. 48-49), esempio tratto dall’autorevole penna del Boccaccio (cfr. Decameron,giorn. iv, introd.).209
Al polo opposto rispetto alla vaghezza e all’eleganza, si ha la durezza. Se-condo il Corticelli, «benchè alcuni stabiliscano regola che col dativo sem-pre debba dirsi contro, e non mai contra» (il riferimento potrebbe essere agliAvvertimenti del Pallavicino) tanto che «un non so che di durezza si sentenel dare a contra il dativo, per l’incontro di quell’ultimo a col segnacaso»,tuttavia «non dee per tutto ciò chi l’usasse condennarsi d’errore» (Regole i,p. 356; e cfr. più avanti a proposito del costrutto accusativo con infinito).210
Assegnabili alla durezza, nota inoltre il Manni, sono anche il concorso dipiù consonanti non inframmezzate dall’i prostetica (Lezioni i, p. 253) e lacaduta di e finale in insieme (ivi, p. 260).
207. Su avere per essere il Corticelli afferma di non trovare «presso a’ Gramatici regolaalcuna ben ferma. Dice contuttociò il Bembo, che una tal maniera la presero gli antichiToscani dalla lingua Provenzale: e in fatti i Franzesi medesimi usano molto avere per essere. Eio osservo appunto, che i Toscani, secondo la maniera Franzese, usano avere per essere sola-mente nelle terze persone, ponendo ancora il singulare di avere per lo plurale di essere, comeda’ seguenti esempj si farà chiaro» (seguono esempi di ha ‘è’, ‘sono’, aveva ‘erano’, ebbe ‘furo-no’, avere plur. per essere plur., avere plur. per essere sing., essere per avere, Regole i, pp. 105-7; unpaio di esempi boccacciani sono già nel paragrafo dedicato all’argomento [Avere posto taloraper essere] dal Buommattei, Della lingua toscana, pp. 275-76).
208. Quattro gli usi “eleganti” di punto: «Primieramente in senso di Termine: e. g. Vedi ache punto siam ridotti, […] 2. in senso di occasione: e. g. Preser lor punto […] 3. in senso diOrdine e assetto: e. g. Mettere in punto, ciò che bisogna […] 4. per procinto. Stavano in punto dicombattere» (uso, quest’ultimo attestato a partire dal XVII secolo: cfr. GDLI, s.v. punto, § 38e LIZ3).
209. Cfr. G. Boccaccio, Decameron, testo critico curato da Giuseppe Petronio, Torino,Einaudi, 1966, p. 246: « le quali forze io confesso che io non l’ho né d’averle disidero inquesto».
210. Il Pallavicino assegna a contro il dativo e a contra il genitivo o l’accusativo: Avvertimenti,p. 48. Dopo contro e contra prescrivono indifferentemente il dativo, il genitivo e l’accusativo ilRogacci, Prattica, p. 258; cfr. anche Bartoli, Ortografia, p. 286, e Torto, dove si osserva che contraseguito dal dativo «sarà peccato più contro alla musica, che alla grammatica» (p. 50) e cosìsimilmente l’Amenta (ivi, p. 51).
stefano telve
238
Analogamente, il Nelli precisa che la i in luogo di r è usata «particolar-mente da’ Toscani con lode, per isfuggire la durezza della pronunzia, ne’nomi, che da altre nazioni si terminano perlopiù in -aro» (ivi, p. 226) e chequelli va apocopato «per isfuggir la durezza, che si ha nel profferirlo, dicen-dosi: quei Santi, o que’ santi» (Grammatica, p. 184), pronome che si alternacon quegli a giudizio dell’orecchio: «Nel numero del più si usa dire quelli, enon quegli, eccetto che in alcune costruzioni, ove all’orecchio torni meglio,come: quegli strumenti, quegli amanti ec.» (ivi, p. 183) come ritiene anche ilCorticelli, che segnala un «mancamento di lettera […] per isfuggire alcuntristo suono, o per maggiore speditezza», come in que’ Signori, l’arte (Regolei, p. 441).
Il giudizio impressionistico dato dal Nelli e dal Corticelli a propositodell’uso di quelli/quegli denuncia uno spirito d’osservazione sensibilmentediverso da quello del Soave, che si esprime sulla stessa alternanza in termi-ni alquanto differenti: «se il sostantivo comincia per vocale, o per s impura,o per z nel singolare si dice quello, e nel plurale quegli […]; se il sostantivocomincia per tutt’altra consonante nel singolare si usa quel; e nel pluralequei, o que’» (Gramatica, pp. 71-72).
Termini di natura estetica quali armonia ed eleganza sono in Soave decisa-mente più rari ed hanno, ad ogni modo, accezioni più blande e generiche:il secondo figura in relazione alle figure grammaticali del discorso (ellissi,pleonasmo, sillessi, enallage, iperbato, pp. 237-38), che anche il Corticellireputava usate «per maggior brevità del parlare, o un certo non so che divaghezza, e di grazia» (Regole i, p. 413), il primo in riferimento a un dettatoperfettamente equilibrato nella distribuzione degli elementi fonico-acusti-ci interni alla parola e degli elementi ritmici della frase e del periodo;211
secondo il Manni, quella «giudiciosa scelta di voci» che danno al discorsoora leggiadria, ora vaghezza, ora durezza è altrimenti, e «meglio», chiamataparoleggiamento (Lezioni i, p. 239; cfr. pp. 226 sgg.).212
211. Cfr. per i primi: « le vocali di suono più grave, e più aperto […] con quelle di suonopiù debole, e più ristretto»; « le consonanti di spirito forte […] con quelle di spirito tenue»;« la gravità delle parole, che han molte consonanti, colla piacevolezza di quelle, che ne hanpoche» (pp. 234-35); per i secondi: «ben disporre, e distribuire gli accenti […]»; «variar lacostruzione acconciamente […] tenersi una via di mezzo fra la costante uniformità de’ Fran-cesi, e le molte trasposizioni de’ Latini […]» (p. 235).
212. Considerato che « il Periodo riceve la sua bellezza altresì dalle parole bellamenteacconce ad esprimere il concetto nostro», avremo profili linguistici diversi a seconda dellostile ricercato: se si ricerca grandezza e magnificenza useremo «cominciar da’ casi obliquj […]replicar le parole con giudicio […] parlare alquanto oscuro, e tardo […]» con «parole, che
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
239
Solo molto di rado affiora nel Soave un certo impressionismo, e si direb-be ancora correlato alla connotazione genericamente marcata del costrut-to. Si hanno infatti talvolta «per grazia di lingua» la sequenza dei cliticiaccusativo + dativo (Gramatica, p. 66; già contrassegnata dalla vaghezza se-condo il Corticelli: cfr. sopra), il clitico personale aggiunto ai verbi (transi-tivi e intransitivi, eventualmente anche «per ripieno»: come in non sa quelch’ei si dica, ivi, p. 106; i clitici sono «elegantemente» posposti al verbo se-condo il Rogacci, non solo come «meri affissi, o empiture» ma anchecome dativi e accusativi: Prattica, p. 32). Nota a questo proposito il Corticelliche «gli Autori del buon secolo» si servirono di verbi neutri passivi anchesenza pronome riflessivo, ciò che «sembra essere una proprietà, e, per cosìdire, un vezzo della lingua Toscana» (Regole i, p. 235; cfr. anche Soave,Gramatica, pp. 241-42), ricordata già dal Rogacci (che distingue tra uso libero(es. partire) e uso necessario (pentirsi): Prattica, p. 30; «ad arbitrio» ovvero «permera eleganza» (ivi, p. 152).213
Eccettua solo quanto osservato dal Soave a proposito dei plurali di requie,specie, progenie, ecc., che conserverebbero la stessa terminazione del singola-re «per ischifare la cacofonìa, o sia il cattivo suono, che nascerebbe dai duei, se si dicesse requii, specii ecc.» (Gramatica, p. 30),214 ma è un giudizio chesuona analogo a quello già fornito dal Buommattei e formulato dal «dot-tissimo» Albertino Barisoni (Della lingua toscana, p. 138). Del resto il timoredella cacofonia è comune a molti grammatici, di là dal fatto che nel dettaglioquesta sia intesa in modo leggermente diverso da autore ad autore: il Giglila definisce «scontro delle sillabe, che siano medesime nella voce, che ter-mina, ed in quella, che comincia» (come Bianco colore, Roma Madre dellaFede: Regole, p. 14), e così anche il Manni, che in nome dell’armonia arriva
hanno adunate molte vocali insieme» (Lezioni i, p. 238); se si ricerca evidenza sono da prefe-rire quelle «parole spieganti col suono stesso ciò, che vogliamo dimostrare, come per esemploRimbombo, Susurro, Fischio», ecc. (ibid.); se vaghezza e leggiadria, parole come snello, gentile, aura,grazioso e « sì fatte. E vi ha chi vuole, che tali riescano queste a cagione della bella collocazio-ne, e scompartimento di vocali, e consonanti» (ivi, p. 239); se dolcezza, parole come luce, desìo,gioire «e simili altre»; se languidezza, e bassezza, « le parole lunghe, e sdrucciole»; se asprezza,durezza, e severità, parole come stordimento, discoraggiare, stranezza, ecc., fatte «dall’unione diconsonanti dure e difficili alla pronunzia» (ibid.).
213. Per il tipo lo mi, che nella poesia dopo il Cinquecento ha rare propaggini, cfr. Serianni,Lingua poetica, cit., § 32.3.3. Sui verbi riflessivi pronominali cfr. Id., Grammatica, cit., § xi 27.
214. Il Rogacci dà seccamente come indeclinabili alcuni nomi femminili con uscita -ie trai quali specie, requie, superficie (Prattica, p. 86); idem il Gigli (Regole, p. 33: spezie, superficie, ecc.),e il Corticelli (Regole i, p. 38: per requie e specie, non usati nel plurale prole, progenie e stirpe: ivi,p. 45).
stefano telve
240
persino ad accettare l’uso al plurale di egli ed elle (usati a volte dagli scrittori– in luogo di eglino, elleno vicino a parole contenenti no – per evitare lacacofonia e «in rima per far comodo al verso»), pronomi che «si può fran-camente usare ancor noi […] quando all’orecchio fa bene» (Lezioni i, p.140; come accade in alcuni brani di Dante, Boccaccio, Della Casa), nono-stante l’Amenta avesse ritenuto quest’uso disusato e il Gigli lo ricordassetra gli usi «rancidi, e ridicoli a’ nostri giorni» (Regole, p. 41).215
Anche il Rogacci adotta più volte il parametro della durezza. A volte inopposizione all’eleganza: «per maggiore, e quasi necessaria eleganza» sonoinfatti da preferire oltre ad avrò, avrei, dovrò, dovrei, potrò, potrei, saprò, sapreianche i rispettivi futuri e condizionali sincopati di vivere, andare, cadere «quan-do non venga (come viene in alcuni) a risultar quindi durezza di suono»(Prattica, p. 186; cfr. § 5.1). Mentre decisamente duri sono fenomeni qualil’inversione nel tipo il di lui amico («quasi trasposizion dura, e affettata»,Prattica, p. 3; probabilmente il Rogacci ebbe presente il Pallavicino, cheparla di «dura trasposizione», Avvertimenti, p. 13) e la sequenza dei pronomiin portollasene («non senza durezza», ivi, p. 33), in impollomi ‘imponlomi’ ein menarollo ‘menaronlo’ (forme che presentano «durezza, e oscurità» eche «non imiterei mai, ò consiglierei altri ad imitar quegli Antichi» checosì scrissero, ivi, pp. 46-47; così si esprimeva anche il Bartoli, Ortografia,pp. 198-99). Del resto, in alternanze quali menossela/menollasi, dirottelo/dirol(lo)ti, mandoccene/mandonneci pare che «meglio suoni» quando lo e nesiano posposti all’altro pronome (ivi, p. 33), e se si accettano le assimilazioniin sommi e viemmi si respingono d’altra parte soluzioni simili, «massima-mente i plurali» come davammi e dicommi, perché l’esito non è «ugualmen-te chiaro, e soave ad udirsi» (ivi, p. 33). Sono invece «men dure, e di cuipossan le persone intendenti col dovuto riguardo servirsi» le costruzionicon tutto non seguito da articolo («e. g. A tutti altri il cela […] e simili, doveal sustantivo seguente preceda alcun pronome possessivo», ivi, p. 76).
Del resto il Rogacci si appella spesso a criteri eufonici per decidere aproposito di quesiti e dubbi grammaticali anche non banali, come l’usouniverbato delle preposizioni articolate,216 la presenza dell’articolo davan-
215. Cfr. Amenta, in Bartoli, Torto, pp. 113 e 241. È degli antichi secondo il Corticelli,Regole i, p. 58.
216. Fornite le regole sulle preposizoni articolate, il Rogacci conclude che «Del resto,dove sì queste due [scil. su e con], sì le altre nove particelle annoverate più avanti suoninmeglio, composte con gli articoli, con cui è libero l’accoppiarle in una voce; e dove meglio,da essi disgiunte; tocca al buon giudizio, e orecchio di ciascuno il determinarlo» (Prattica,p. 14).
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
241
ti al genitivo (è il tipo il masso del ferro),217 gli in luogo di le nella sequenzadi più pronomi atoni,218 gli invece di li,219 le prime persone dei verbi in-isco.220
Talvolta l’impiego di criteri eufonici come strumento d’indagine deimeccanismi linguistici sembra quasi travalicare, o ignorare, la variabilitàdella lingua, e astrarre il dato osservato dalla sua dimensione storica (nonsolo, come visto, in Rogacci); è quanto avviene ad esempio là dove il Rogacciannota che il prefisso verbale a o ad «il più delle volte non serve, che ò peraccrescimento della primiera significazione, ò per dar miglior suono allevoci: come in Abbaiare, per baiare, e abbendare per bendare: e così pure attem-pare, attenuare, annunziare, astringere, assicurare &c.» (Prattica, p. 213), osserva-zione che postulerebbe l’esistenza dei verbi (puramente virtuali) tempare etenuare.
5.3. Derive logicizzanti
L’impressionismo usato dai grammatici per giudicare forme e usi lingui-stici ha il suo rovescio in alcune elaborazioni iperraziocinanti della regolagrammaticale. Si tratta appunto di facce della stessa medaglia.
Per i verbi in -isco testé citati, ad esempio, i grammatici del Settecentoriprendono quanto già osservato dal Buommattei (Della lingua toscana, pp.303-5), che distingue due gruppi a seconda che i verbi ammettano anchel’uscita in -o alla prima persona (come da ferire è possibile fero) oppure no(così per ambire, colpire e altri verbi): per questi secondi, non potendo ammet-
217. Sebbene non si specifichi che si tratta del complemento di materia: «Vogliono di piùalcuni, (& è regola communemente osservata)» che l’articolo, omesso davanti al nome, siometta anche davanti al complemento; altrimenti, se il nome è preceduto da articolo eseguito dal genitivo, l’articolo del genitivo può o no esserci « secondo che in questa, ò quellaparticolar Costruzzione parrà suonar meglio» (ivi, p. 26). Su questo tratto cfr. n. 64.
218. Gli accorpato con altri pronomi va bene sia per il maschile sia per il femminile per«ovviare al mal suono» di lelo, lela, leli, e lele; d’altra parte però, con ne, il Rogacci stima«meglio l’attenersi alla maniera più regolare» distinguendo lene e gliene (ivi, p. 45; cfr. anchen. 140).
219. In determinate circostanze: nelle parole comincianti per vocale o s + cons. che «han-no nella seconda sillaba Gli, e. g. Scoglio» «par meglio (e lo prescrive il Ruscelli nel quintolibro de’ suoi Commentarj) usar dinanzi ad esse nel plurale, in riguardo del mal suono chealtrimenti seguirebbe, il primo articolo» cioè li e non gli (Prattica, p. 12).
220. Le quali « formano più elegantemente» le altre voci dalla desinenza in -o «parendosuonar meglio, Inghiotto, Inghiotti, Inghiottono: Pato, Pati, Pate, Patono &c.; che Inghiottisco, In-ghiottisci, Inghiottisce, Inghiottiscono: Patisco, Patisci, Patisce, Patiscono, &c.» (Prattica, pp. 182-83).Così anche il Nelli, Grammatica, p. 163.
stefano telve
242
tere per le iv e v persone né ambischiamo, ambischiate né ambiamo, ambiate,«bisognerà, o trovar’ altro Verbo, a quello equivalente: come per Inghiot-tire, Ingoiare […] o vero descrivergli con più parole: come in Ambire,Abbiamo Ambizione […]» (ivi, p. 305).221
La regola ritorna anche nel Nelli (Grammatica, p. 163), nel Corticelli(Regole i, p. 139),222 che sembrerebbe riprenderla in modo quasi letterale, enel Rogacci che, ricordando espressamente il Buommattei, afferma di nontrovare questa regola «accennata da verun altro autore; né veggo che si usinel parlare, e scriver commune. Vero è bensì, che alcuni verbi, a’ quali,oltre la desinenza in Isco, ne compete qualche altra, formano più elegante-mente da questa seconda tutte le loro voci: parendo suonar meglio» in-ghiotto e pato (-i/-e/-ono) che inghiottisco e patisco (-i/-e/-ono), ma langue, fere epere avrebbero del poetico (Prattica, p. 182).223 Ben più sbrigativo è il Gigli,che prescrive di norma la sola uscita in -sco (tra questi figura anche languire),avvertendo che non appartengono a questo gruppo i “falsi” verbi in -scoesco, nasco, pasco, pesco, tresco (Regole, pp. 202-5).
Anche il Manni sembra alludere proprio al Buommattei (grammatico,come s’è detto, da lui poco amato) là dove dichiara che «l’assegnare diquesta desinenza in ISCO una regola, che serva a tutti i Verbi della terza,si è renduto fin’ora impossibile, giacchè di essi alcuni soffrono questo au-mento, come Colpisco, altri come Cucio, nol soffrono; laonde l’autorità, el’uso saranno di ciò i maestri» (Lezioni i, p. 171).
Ancora dal Buommattei i grammatici ricevono la regola circa l’uso diqui e di qua, menzionata dal Rogacci («Quì suol significare luogo più de-terminato e particolare, che Qua», Prattica, p. 265), dal Nelli (Grammatica,p. 71) e dal Corticelli (che pure ricorda la difficoltà di distinguere usi spe-
221. Con un’eccezione: «Solo Finiamo par che alcuna volta si lasci sentire: almeno dallebocche del popolo, e in particolare in quell’Affisso Finianla, o Finiamola […]» (p. 305).
222. A tale proposito, il Gigli nota che «I Fiorentini dicono Finischiamo, il che da’ loroAutori non fu mai detto» (Regole, p. 187).
223. Uno sguardo ai testi letterari del Settecento contenuti nella LIZ 3 ci permette diosservare che l’idiosincrasia dei grammatici non trova riscontro nell’uso coevo. Non si han-no voci di patire se non con desinenza in -isc- (oltre sessanta). Ricorrono spesso in Metastasio,Goldoni e Alfieri, con occorrenze occasionali nei fratelli Verri e in Da Ponte, le voci langui-sco, languisce, languiscono e languisca (assente languiscano); non sono invece attestate le concor-renti languo, languono, langua, languano mentre langue conta oltre cinquanta esempi (solo duedi queste sono in prosa). Per nutrire le forme in -isc- appaiono complessivamente menofrequenti: nutrisco, nutrisce, nutriscon(o), nutrisca, nutriscano hanno più di venti occorrenze con-tro le oltre ottanta di nutro, nutre, nutrono, nutra (non attestata nutrano). Per inghiottire si regi-strano un paio di esempi di inghiottisca(si) (contro tre di inghiotta) e tre di inghiotte.
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
243
cifici per l’una per l’altra forma e le «gravi difficultà» patite in merito dallegrammatiche).224
Accanto a queste prescrizioni, persistono nelle grammatiche indicazionidi tenore simile: ad esempio la distinzione tra ci e vi, indicanti rispettiva-mente luogo vicino e luogo lontano, citata dal Rogacci (Prattica, p. 31 capov.39, ricordato dall’Amenta, p. 387), dal Gigli (Regole, pp. 252-53,225 Lezioni, p.65), dal Nelli (Grammatica, pp. 70-71), dal Corticelli (Regole i, p. 274),226 e dalSoave (il quale, pur osservando che «rigorosamente» ci vale ‘qui’ e vi ‘lì’, fapresente che «spesso si pongono indifferentemente l’uno per l’altro»,Gramatica, p. 67); e l’uso di appo, che secondo il Corticelli «significa talvoltaprossimità morale a una persona, cioè nel giudicio, concetto, o confidenza,talvolta vale in comparazione; e talvolta accenna alla Latina puro stato inluogo» (Regole i, p. 347). Ancora il Rogacci, sull’orma di certi schematismiespositivi logicizzanti (cfr. § 1), si slancia talvolta in considerazioni pret-tamente speculative, del tutto astratte dal dato linguistico reale. Un esem-pio. A proposito di sapere si nota che
Questo verbo parimente [scil. rispetto a Ho, Havere] si compone di due [scil. capi],l’uno reale, ma ristretto a quattro sole voci del Presente Dimostrativo, cioè So;l’altro mentalmente supposto, e che, per corrispondere al resto delle sue voci,dovrebbe esser Sapo, ò Savo, ò, come da alcuni si dice, Saccio. Fra’ quali tutto sidivide, appunto come il Verbo precedente fra’ suoi: senza vedersi altra differenzadelle voci di uno da quelle dell’altro; se non che quelle per H, e queste comincianper S: e, dove ivi la lettera V; quì si ritrova in suo luogo la P ; e, dove quelle hannoB doppio; queste raddoppian la P: havendo fuori di questa discrepanza tutto ilrestante medesimo, medesima la terminazione, medesimo il numero delle sillabe,e medesime tutte le altre lettere: e. g. Hò, Sò: Hai, Sai: Hà, Sà: Habbiamo, Sappiamo[…] (Prattica, pp. 165-66).227
224. Ritenendo tuttavia «verisimile l’opinione del Buommattei tratt. 16 cap. 7, purchè siamessa in buon lume» (Regole i, pp. 267-68; benché nella sostanza il Corticelli non dica più omeglio di quanto non abbia già detto il Buommattei: cfr. Della lingua toscana, pp. 342-45 espec. p. 343); stessa ripartizione di funzioni è assegnata anche alla coppia costì e costà (cfr.Regole i, p. 269).
225. Sia pure nell’esercizio, dove si corregge «qui non vi è più aria» in «ci è».226. Talvolta il vi « rileva il caso del moto per luogo», come in «Per ogni volta, che passar vi
solea […]» detto così da «quella donna, perchè era lontana da casa sua; che se fosse stata incasa sua, si sarebbe servita della particella ci, la quale può aver la medesima forza» (Regole i,p. 274).
227. Un campo d’applicazione più consono alla razionalizzazione e alla serialità che nonla fono-morfologia è semmai, di là dalla velleitarietà ed estemporaneità di alcune proposte,la formazione delle parole. A proposito dei verbi incoativi, frequentativi e composti il gram-
stefano telve
244
5.4. Il descrittivismo: le allotropie
L’esigenza di dar conto al lettore della varietà della lingua viene soddi-sfatta soprattutto attraverso l’ampia esibizione di alternanze, in particolaredi allotropi nominali e verbali. Là dove la singola forma non è riconduci-bile a un registro ben identificato, né a un altro parametro, foss’anche im-pressionistico, come per le voci già osservate caratterizzate dalla presenzalibera di i e o (un’eccezione, giacché giudizi di questo tipo sono di normaapplicati, come s’è visto, soprattutto a fatti di sintassi),228 i due allotropisono accostati il più delle volte senza alcun commento, con rischi – tantomaggiori nel caso di grammatiche compilate a fini didattici – di scarsaperspicuità nell’indirizzo normativo. Del resto, in queste sezioni delle gram-
matico ragusano ritiene « lecito essere, a chi sappia ben farlo, l’andar, sul modello de’ Com-posti, Frequentativi, e Inchoativi già usati, fabricando di suo ingegno e lavoro altri nuovi:massimamente quando non si habbia voce ricevuta e corrente, la quali basti sola a spiegarequegli oggetti, che, mediante una tal formazione, verrebbero con una sola voce ad esprimer-si». Perché dunque, sulla base di invelenire, «non sarà ben detto Inviperire?» e ancora, suallentare, assottigliare, migliorare e peggiorare (Prattica, p. 221) i verbi abbuiare, affiocare, arrocare, am-moscire, imbiondire, irruvidire, arroventire, invizzire, inanimare (ivi, p. 222), e ancora: canticchiare,scrivicchiare, salticchiare, spendicchiare, mangicchiare, disputacchiare, sermoneggiare, buffoneggiare (ivi, p.222). Si tratta di un’operazione che ad ogni modo, suggerisce il Rogacci, non dovrebbe, onon potrebbe, nascere per iniziativa del singolo ma dall’accordo di più intellettuali (ivi, p.223). Quanto detto per i verbi può valere anche per i nomi (ivi, pp. 113-20): in virtù delmedesimo principio analogico, si propongono alcune formazioni, tra le quali, oltre a quelled’attestazione recente (secentesca), si notano infiammatorio e dolciume (ivi, p. 115; DELI eGDLI assegnano la prima al 1714, L.A. Muratori, e la seconda al 1733, G. Del Papa), insiemead altre puramente virtuali come vendicaggine e abbandonanza (ivi, p. 114). Il problema dellaformazione di nuove parole era stato già affrontato, anche se in termini diversi, dal Bartoli,che raccolse numerose voci non lemmatizzate dal Vocabolario della Crusca, sia traendole datesti antichi sia ricavandole dallo stesso Vocabolario sotto altri lemmi. L’Amenta ricorda conil Bartoli, e soprattutto con il Rogacci, la possibilità di creare per analogia nuovi alterati,accogliendo nella sostanza le argomentazioni del secondo, con qualche glossa (cfr. Bartoli,Torto, pp. 548-58, e, per l’Amenta, ivi, pp. 558-77; sul Rogacci cfr. spec. pp. 563 e 568-70).Questo tema, perlopiù taciuto dal resto delle grammatiche, è ripreso dal Nelli (che ripetenella sostanza quanto detto dal Rogacci: Grammatica, pp. vii-viii) e, con accenni, dal Gigliche, rinviando di fatto a quanto detto dal Pallavicino, limita l’ingresso di nuove parole nellalingua ai tecnicismi eventualmente anche forestieri (Regole, pp. 34-35). Per un’opinione di ungrammatico sui forestierismi bisognerà peraltro ricorrere al trattato Della toscana eloquenza delCorticelli, dove ci si esprime in termini alquanto netti: « sofferir non posso quelle feccioseespressioni: si porta ella bene? […] ecco il dettaglio di tutto l’affare […] io le domando perdono» (p. 34;cfr. anche p. 33). Sulla formazione delle parole nelle grammatiche tra Sette e Ottocento cfr.Claudio Giovanardi, Linguaggi scientifici e lingua comune nel Settecento, Roma, Bulzoni, 1987, pp.17-27.
228. Cfr. Patota, Percorsi, cit., p. 115, e Bartoli, Torto, spec. pp. 402-11.
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
245
matiche ciò che si osserva sono i meccanismi interni e, per così dire,immanenti della lingua (prescindendo, come è stato già detto per i criterieufonici del Rogacci, dalla loro storicità), e cioè propri della lingua qua talis:significativamente, il Gigli e il Manni osservano l’allotropia e la varietà deltoscano comparandola a quella del latino: «Faciendum, e Faciundum, Arbos,ed Arbor, e simili» (Regole, p. 13), «Si dolse di questa incostanza tra’ LatiniFesto Gramatico, dicendo che alcuni non pronunziavano come gli altri idittonghi; e Varrone il simile fece, notando il dirsi da taluno Vea, per Via; esì Vella, per Villa» (Lezioni i, p. 244).
Nelle Regole del Corticelli (nella iii edizione, pp. 473-81, e già nella iiedizione del 1754, pp. 473-82, nei paragrafi intitolati Del valore, e della pronun-zia delle vocali e Del valore, e della pronunzia delle consonanti, derivati in formaampliata dall’unico paragrafo dedicato alle lettere della i edizione, pp. 434-39), nelle Lezioni i del Manni (pp. 76-109, Lezioni ev, pp. 197-200, Lezioni iv,pp. 223-26) e, continuando a risalire indietro nel tempo, nelle Regole delGigli, s’incontrano a tratti sequele di allotropi allogate soprattutto al fine diesemplificare la mutevolezza e la varietà della lingua (quale che sia l’asse divariazione) e dunque perlopiù senza necessità di commento (del resto,sostiene il Manni, dare regole stabili e durature «sarà sempre, come delfermare altre cose, un puro universal desiderio, senza che ne segua l’effet-to», Lezioni i, p. 245). Il risultato, da un punto di vista generale, può sem-brare quello di un momentaneo “obnubilamento normativo”.
Le coppie di voci citate per esemplificare l’alternanza sono spesso co-muni a più grammatiche. Il Gigli, ad esempio, afferma che «si dice ugual-mente bene Marinaro, e Marinaio, Desio, e Disio, Auro, e Oro» (Regole, p. 13)e accosta forme a vario titolo divergenti come amarò e amerò, lungo e longo,devoto e divoto (Lezioni, p. 19, pur avvertendo: «Egli è però vero, che lesopradette voci meglio alla Fiorentina si pronunziano, e si scrivono, cioècol V lungo, punto, giunto, &c.», ivi, p. 20) in un paragrafo dedicato allaillustrazione della «parentela delle lettere» cioè della «variazione delle let-tere stesse in alcune voci» (fenomeno già osservato da altri, ai quali sirinvia: Salviati iii cap. 3 part. 19, Pergamini, Fortunio, Bartoli, Lezioni, p.19), laddove nelle Regole e nel Vocabolario cateriniano decreta apertamente ladesuetudine delle voci con -ar-.229 Il Gigli ritiene del tutto legittima questa
229. Nelle Regole amarò è classificata (come del resto altre forme con -ar- amarei, scrivarò,essare) nella colonna dell’antico (p. 80; cfr. per le altre voci, pp. 81, 94-95 e 61); nel Voc. Cat. sifa presente che il futuro con -ar- dei verbi di ii e iii classe «non è al presente molto usato,almen nello scrivere, dalla Gente studiosa» (Voc. Cat., s.v. verbi, p. 321). Devoto e divoto sono
stefano telve
246
parentela, perché «essendo sino a sei diverse Nazioni in Toscana, che condiverse scritture di buoni Autori loro, hanno formato il testo della Linguaè convenuto ricevere diverse voci in quà, e in là secondo l’uso diverso dellepredette Nazioni, così per esempio i Fiorentini dicono amerò, ed amerei, iSanesi amarò, ed amarei» (Regole, p. 14). La variazione linguistica, osservatadal Gigli come dagli altri grammatici, finisce coll’occupare, all’interno del-le grammatiche, uno spazio extra-normativo, svincolato per sua natura alleclassificazioni; tant’è che il Gigli riconosce che per le varietà del toscanonon si ha «alcuna regola particolare de i Grammatici» (Lezioni, p. 19),230
benché talvolta sia il Gigli stesso ad ipotizzare ragioni linguistiche dell’al-ternanza.231
Ritenendo che «gran pregio di nostra Favella è il poter variar vocaboloa suo piacere» (Lezioni i, p. 55), anche il Manni s’adopera di testimoniarecon abbondanza di esempi questa proprietà della lingua, soprattutto a pro-posito delle voci passibili di due o più uscite e delle voci che si differenzia-no per un cambio vocalico o consonantico, prestando particolare attenzio-ne, rispetto al resto dei grammatici, a tesaurizzare anche forme arcaicheattestate occasionalmente (delle quali si fornisce la fonte).
Le esigenze descrittive (nella fattispecie della varietà morfologica dell’ita-liano) si direbbero far premio su quelle prescrittive e contenere il commen-to dell’autore entro il limite della glossa breve, che specifichi l’accezione(«Grani, e Grana, parlando di pesi», ivi, p. 77) e avverta dell’eventuale arcai-cità («Capi, e capita, nel Boezio antico», ivi, p. 76, «Elmi, e nell’antico Vege-zio Tosc. Elmora», ivi, p. 77): indice di un punto di vista che guarda, sinteti-camente, al fenomeno più che, analiticamente, a discriminare i livelli d’usodelle singole forme («l’ultimo plurale [scil. in -a] è molte volte andato indisuso per la sua gran vetustà», ivi, p. 79), come del resto appare confermatoda quanto detto dal Manni a proposito dei nomi d’animali di genere promiscuo
accostate anche dal Pallavicino (Avvertimenti, p. 39), che però non accetta amarò né amarei (ivi,p. 28).
230. Per divoto quale forma senese e insieme latineggiante cfr. Amenta in Bartoli, Torto, p.411. Oltretutto la lista, avverte il Gigli, potrebbe essere anche più nutrita: « se all’altre ItalianeNazioni dovesse aversi rispetto, molte più larghe parentele quì potrebbono annumerarsi.Perciò quando talora qualche dubbio accada potrà altri col Vocabulario consigliarsi » (Lezio-ni, p. 21).
231. Nel Voc. Cat., s.v. oncenso, riscontrata l’alternanza con incenso e altri allotropi con cam-bio di fonema tra i ed o (divizia/dovizia, dimandare/domandare), conclude: «questa voce credosia rimasta coll’O attaccatole dall’Articolo, il quale (levandosi l’I alle voci comincianti per im,e in, e dicendosi lo ’mperadore, lo ’ncenso, & essendo questa voce appiccicosa, e viscosa) se gli èappiccicato, e non si è potuto poi staccare se non mezzo» (p. 97).
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
247
(cioè nella fattispecie i femminili agnella, (l)usignuola, passera, porcella, rondina,scimia, tigra, e elefantessa, granchiessa, leonessa, corrispettivi dei maschili in -ooppure -e) e cioè che «l’usarli tutti con indifferenza non fosse per essere inogni occorrenza plausibile» (Lezioni i, p. 102).
Privo di commento (con poche eccezioni), e oltretutto ben nutrito, èinvece il drappello delle forme citate per esemplificare l’uscita in -ora (trat-tata marginalmente già nelle grammatiche del ’500)232 accanto a quella re-golare in -i (agora, borgora, cantora, corpora, latora, litora, nerbora, nomora, pianora,ramora, tettora, ivi, pp. 76-79), laddove il Soave, circa trent’anni dopo, liquidaseccamente l’argomento dichiarando che «Gli Antichi usaron’anche fruttora,campora, pratora, e simili: ma queste parole or sono affatto antiquate» (Gra-matica, p. 29, e Gramatica 1816, p. 23).233 Anche la precisazione fatta dal Mannia proposito di quei nomi che «vogliono, o per dir meglio, nel prisco tempodella Lingua ne volevano [scil. di desinenze] tre, o quattro» varrà per laprima voce della lista (budello/-i/-a/-e), non anche per tutte le altre (sivedano ad esempio legno/-i/-a/-e e labbro/-a/-i; Lezioni i, pp. 80-81).
Molte delle numerose voci caratterizzate da una o più uscite citate dalManni (Lezioni i, pp. 76-83) e prima di lui dal Rogacci (Prattica, p. 85)234 e,ancora più indietro, dal Bartoli,235 sono menzionate anche dal Soave, che lesottopone a una scrematura più severa giudicando «poco in uso» i singola-
232. Ad es. dal Giambullari, sia pure con preterizione: «non ragiono di pratora, luogora, etcorpora; perchè oggi non sono in uso; dicendosi comunemente per la maggior parte prati,luoghi, et corpi» (Giambullari, Regole, cit., p. 21). E si tenga conto che, come osserva IlariaBonomi, la trattazione della morfologia nominale «mira più ad evidenziare l’aspettoclassificatorio che non quello morfologico, ed è del tutto priva di considerazioni sulla diffe-renziazione semantica e sul diverso livello linguistico di forme concorrenti» (ivi, p. 21 n. 2).
233. È antico anche per il Manni fruttora (p. 80), non pratora (p. 81); campora è invece « rimasoper nome proprio d’una Contrada fuori della nostra Porta Romana» (p. 76).
234. Escono in -a o in -e e hanno i plurali rispettivamente in -e o -i: ala, fronda, loda, dota,sorta, froda, scura, vesta, greggia, arma, tossa, beffa, leggiera, silvestra, alpestra (p. 84), in -o/-a conplurali rispettivamente in -i, -e: orecchio, bisogno, costume, frutto, cestello, ombrello, briciolo, nuvolo,pineto, gocciolo, strettoio (pp. 84-85); per le voci di entrambi i generi: fonte, serpe, fine, carcere,folgore, pianeta, tema (p. 85); hanno singolare in -o e plurale in -a/-i: dita, ossa, membra, corna,migliaia, labra, ginocchia, cervella, ciglia, calcagna, interiora, castella, mura, legna, frutta, risa, grida,lenzuola, fila, vuova (ibid.).
235. Nell’Ortografia: «Usate dal nostro tempo, e da ben potersi usare sono» ossa, membra,tempia, braccia, ginocchia, dita, calcagna, anella, fila, fondamenta, mura, corna, grida, uova, p. 259; «piutosto in prosa Frutti, e Vestigi, che Frutta, e Vestigia», ibid., e pure le legne, più che le legna, p. 260;e nel Torto, per il singolare: arme, dota, macine, scura, ecc., p. 406. A proposito dei plurali frutta,legna e vestigia il Bartoli dice che « l’ordinario a trovarsi nelle buone scritture, è Frutti, Frutte,Legne, Vestigi, e Vestigie, in prosa» (Torto, p. 631); ma cfr. l’Amenta, ivi, pp. 631-32.
stefano telve
248
ri ale, arme, canzona, dota, macine, scura, tossa (Gramatica, p. 25, e Gramatica1816, p. 20, che omette macine), «da lasciarsi a chi ama di singolarizzare» iplurali coltella, comandamenta, demonia, letta, mulina, peccata, tina (Gramatica, p.29; e Gramatica 1816, p. 23),236 non «del miglior uso» i plurali canzone, dote,frode, macini, scure, tosse, veste (Gramatica, p. 30), e «meglio usati» delle rispet-tive forme in -i i plurali in -a «braccia, calcagna, ciglia, dita, gesta in significatod’imprese, ginocchia, labbra, membra, ossa, quadrella, risa» (ivi, p. 29; cfr. Gramatica1816, p. 23; solo per braccia il Rogacci specifica che è «più usato» dellarispettiva forma in -i, Prattica, p. 132, uscita che secondo il Pallavicino «nonsi troverà molto spesso nelle scritture eleganti», Avvertimenti, p. 21).237
È una selezione più rigida che non quella fatta da una delle sue fonti, ilCorticelli, il quale rifacendosi a Salviati, Buommattei e Manni avverte chelascerà «molti di tali nomi, che anticamente avevano doppia uscita, e oranon l’hanno più» e che farà «alcune osservazioni sopra l’uso modernointorno a’ nomi di tal sorta, tratte dagli Autori citati di sopra, e dal Vocabo-lario della Crusca» (Regole i, pp. 38-39). Si menzionano dunque per le vociche hanno singolare in -a e in -e e corrispettivi plurali in -e e in -i (antici-pando nella lista ora l’una ora l’altra forma, forse a seconda dell’uso): ala (ealia), arma, canzona, dote, frode, fronde, lode, macina, redine, scure, tosse, veste; men-tre molti nomi con più uscite al plurale, benché attestati «negli Antichi»,non sono «ricevuti dal buon uso vegliante degli odierni Toscani. Ecco i piùusitati»: hanno uscita in -i e -a: anelli, bracci, budelli, calcagni, carri, castelli, cigli,corni, diti (ditelle e ditella), fili, fondamenti, frutti (-a, -e), fusi, gesti (-a, -e), gi-nocchi, granelli, interiori, legni, lenzuoli, muri, ossi (-a, -e), quadrelli, risi, membri,sacchi, tempi (e tempora, con accezione ristretta: «onde diciamo: le quattrotempora»), vestimenti (Regole i, pp. 40-41; anche il Gigli ricorda le alternan-ze armi/arme e lode/lodi, i plurali in -a/-i per ciglio e dito e anche, «moderna-mente» il rifiuto di borgora, peccata, ma non di tempora nell’espressione citatadal Corticelli: Regole, p. 33).
Anche a proposito di «quella scambievolezza di lettere» che «parentela,od amistade da’ Gramatici vien detta» (trattata nella lezione sull’ortografia),in analogia alla cognatio litterarum dei latini (Manni, Lezioni i, p. 246, Lezioniev, p. 198, Lezioni iv, p. 223), l’autore accompagna alcune forme con il com-mento, altre no. Si qualificano come antiche (si ritiene qui sufficiente an-
236. Peccata, coltella (e castella) sono forme rifiutate dall’uso già secondo l’Amenta, in Bartoli,Torto, p. 632.
237. Identiche prescrizioni si hanno nell’edizione del 1816 (pp. 22-23) con le eccezioni difusi/-a, letti/-a, omessi, e pomi/-a, aggiunti.
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
249
che un solo «scrissero» o «dissero») le voci piggiore e pilliccia, filosafo e prolago,vitiperio, lalda («rimaso ora in contado»); svembrare, svemorato e menovare;boce, boto238 e forvici, civorio; chiovo; olore (‘odore’);239 Cicilia e vicitare (entrambidei «buoni antichi»), e, tra le «posposizioni», mosterrei, filosomìa (fisonomìa),prieta (pietra), foraino (foraneo), mandrola (mandorla), accanto alle quali si ricor-dano per il «moderno tempo» interpretazione/interpetrazione, fracido/fradicio,capresto/capestro, pianere/paniere, palude/padule, indivia/invidia («nel volgo»),fornuolo/frugnuolo, cofaccia/focaccia (ivi, pp. 248-49).240
Tante altre forme rimangono invece prive di qualche parola di accom-pagnamento: tra queste figurano accanto a coppie di termini non partico-larmente marcate (reverenza/ri-,241 ripugnanza/re-, primaziale/primiziale e an-che riformagione/riformazione e con accostamento estrinseco zara/gara242) al-tre più marcate, dove compaiono latinismi (auro/oro, amplo/ampio), formed’opposizione senese (e a volte latino)/fiorentino (ambasciata/imbasciata, de-naro/danaro, seguestro/sequestro, devoto/divoto),243 forme del toscano antico(albitrio/arbitrio, albore/arbore, piova/pioggia, vivore/vigore, savere/sapere, savore/sapore, contrario/contradio)244 e forme del fiorentino quattrocentesco ( fosse/fusse, stiaffo, stiena e mastio, ghiaccio/diaccio; cfr. Lezioni i, pp. 246-49; cfr. inol-tre schiamazzo e stiamazzo, ivi, p. 55).
Sono considerazioni che troveremmo in minima parte nella i edizionedelle Regole del Corticelli, non invece nella iii, dove nei due paragrafi citatisul valore e sulla pronunzia delle vocali e delle consonanti sono dedicate all’ar-gomento alcune pagine; esempi di somiglianze vocaliche sono: desiderio/disiderio, peggiore/piggiore, tra o e u in sorge/surge, coltivare/cultivare, agricoltura/
238. Secondo il Bartoli boce, boto e le rispettive forme in v- sono usate «da gli antichi, etuttavia, da chi vuol de’ moderni» (Ortografia, p. 261).
239. Su l/d cfr. Castellani, Grammatica, cit., p. 9.240. Si ritiene invece usato due volte «per baia», « in persona d’uomini idioti», fisofolo nel
Decameron (p. 249).241. Voci « indifferenti a scriversi nell’un modo, e nell’altro» secondo il Bartoli (Ortografia,
p. 247) insieme a semplicità/simplicità, devotione/divotione, ecc. (p. 248)242. O meglio suggerito dalla convergenza tra i significanti (di cui forse si sarà percepita
l’esoticità; anche gara potrebbe essere tra l’altro un arabismo: cfr. DELI, s.v.) e, almeno par-zialmente, dei significati.
243. Imbasciata è ricordata quale forma senese dall’Amenta (in Bartoli, Torto, p. 517); perdenaro (senese e toscano)/danaro (fiorentino) cfr. Bargagli, Turamino, cit., p. 225; per le altredue coppie cfr. n. 230 e n. 259.
244. Su albitrio cfr. Castellani, Saggi, cit., vol. ii pp. 224, 363, 369. Su piova cfr. ErnestoGiacomo Parodi, Lingua e letteratura, a cura di Gianfranco Folena, 2 voll., Venezia, Neri Poz-za, 1957, vol. ii p. 227. Su sapere/savere, sapore/savore e altre voci con alternanza p/v cfr. ancheBartoli, Ortografia, p. 261. Contradio è «antico» secondo il Gigli (Lezioni, p. 21).
stefano telve
250
agricultura, fosse/fusse (p. 474); per le somiglianze consonantiche: serbare/servare,nerbo/nervo, boce/voce, pubblico/piuvico, tempio/templo, esempio/esemplo, coper-ta/coverta, soprano/sovrano, peregrino/pellegrino, vedello/vederlo, muoja/muora,rado/raro, etate/etade, potere/podere, lito/lido. L’estraneità di quanto detto inquesto paragrafo a qualsiasi norma è resa evidente sia dalla marcatezza dicerti accostamenti, come fosse/fusse (già nel Manni), sia dalla natura delleconsiderazioni che accompagnano gli abbinamenti citati: «molte voci sipronunziano scambievolmente» con p o con b/v (ivi, p. 480), t si usa «scam-bievolmente» con d (ibid.), la r è mutata, per via del suono aspro, « in altralettera di più moderato suono» (ivi, p. 481), dopo la b può seguire l e r«benchè con la L di rado si trovi appresso i Toscani, nè mai in principio diparola, come pronunzia a loro più strana: salvo alcune voci latine, comeblando, blandimento &c.» (ivi, p. 475). Considerazioni insomma che guarda-no all’aspetto prettamente fonetico ed eventualmente, come a propositodel nesso bl-, anche geolinguistico.
Più spazio (nella mole degli esempi) è dato all’argomento nelle gram-matiche del Rogacci e del Nelli, dove, per dar conto di voci caratterizzateda alternanze consonantiche, si allineano insieme coppie di allotropi (nellaquasi totalità comuni, benché molto più ricca sia l’esemplificazione delRogacci) con marcatezza variabile (cfr. Prattica, pp. 120-31 e 224-30, e Gram-matica, spec. pp. 120-22).
Omettendo qui gli esempi più banali di allotropia dotto/popolare,245
troviamo accanto a forme caratterizzate all’epoca da una debole opposizio-ne (riguardo/risguardo,246 famigliare/familiare,247 scilocco/scirocco,248 corvo/corbo,249
245. Ad esempio: reverenza/ri-, desìo/di-, decembre/di-, questione/qui-, leone/li-, commessione/commi-, nemico/ni-, ecc. (Prattica, p. 120).
246. Riguardo è «più com[une]» (TB, s.v. risguardo) di risguardo, che ha una diffusione limi-tata (LIZ 3 [’700]: Baretti, Il Caffè, Alfieri 2, Cesarotti-Ossian).
247. Secondo il Bartoli «può ugualmente bene scriversi» familiare e famigliare (Ortografia, p.168); così anche il Rogacci, Prattica, p. 344. Sull’alternanza delle forme nella prosa del Set-tecento cfr. Antonelli, Alle radici, cit., p. 126 n. 141.
248. Le due forme convivono per lungo tempo. Scilocco, con l etimologica, è voce moltodiffusa «nei testi italiani antichi anche toscani» (Giovan Battista Pellegrini, Gli arabismi nellelingue neolatine, Brescia, Paideia, 1972, p. 479) ed attestata in Dante, Villani, Boccaccio, Pulci,Ramusio (accanto a sciloc, prediletta nel Milione) e, nel secolo XVIII, in Goldoni (dati LIZ 3).Scirocco è in Folgore, Pulci (8 ess.), Ramusio (numerosi esempi accanto a 3 di sciroco), Goldoni(4) e nel Caffè.
249. Secondo l’Amenta « si può nondimen dire […] Corbo, e Corvo, Serbare, e Servare» (inBartoli, Torto, p. 413; serbare è a lemma nella prima edizione del Vocabolario della Crusca).Ricorda la toscanità di voci quali corbo e serbo il Rhys: cfr. Trattati di fonetica, cit., p. 231. Nel ’700corbo è ancora presente in Baretti (2 esempi) e Casti (6; dati LIZ 3).
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
251
galea/galera,250 dispregio/disprezzo e palagio/palazzo 251) altre attinte al tosca-no antico o popolare maggiormente marcate (Grammatica, pp. 118-21),molte delle quali sono anche in Bartoli (Torto, spec. p. 405): virtù/vertù(quest’ultima «all’antica» già secondo il Bartoli, Torto, p. 403), calzolaro/calzolaio,252 benevoglienza/benevolenza,253 bogliente/bollente,254 le coppie vegghia/veglia e tegghia/teglia,255 propio/proprio,256 doppo/dopo,257 e le sonorizzate
250. Secondo l’Amenta «Galea è Toscanamente detto, più che Galera» (in Bartoli, Torto,p. 419). Anche se stando ai dati della LIZ 3 [’700] galea conta minori attestazioni (Goldoni,Baretti 5) rispetto a galera (Giannone, Goldoni 16, Baretti, Il Caffè 2, Alfieri, Casti 2).
251. Già il Rhys notò la libertà dell’alternanza («Aeque enim & sine discrimine») tra leforme di queste due coppie di allotropi (cfr. Trattati di fonetica, cit., p. 134). Nel Settecentosono numerosi gli esempi per tutte le forme citate, benché dispregio e palagio appaiano inminoranza e sopravvivano nell’Ottocento (il primo anche nella prosa, il secondo soprattuttoin poesia; cfr. Vitale, Operette, cit., pp. 39-40). Nella Quarantana Manzoni mutò palagi edispregio in palazzi e disprezzo (cfr. M. Vitale, La lingua di Alessandro Manzoni. Giudizi nella criticaottocentesca sulla prima e seconda edizione dei ‘Promessi Sposi’ e le tendenze della prassi correttoriamanzoniana, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1986, p. 28).
252. Cfr. anche Gigli, Lezioni, p. 20 (fornaio/fornaro), e Rhys in Trattati di fonetica, cit., pp.158-59. Il Nelli osserva che i per r è usata «particolarmente da’ Toscani con lode, per isfuggirela durezza della pronunzia, ne’ nomi, che da altre nazioni si terminano perlopiù in -aro […]»(Grammatica, p. 226). Quella in -aro è per il Bartoli « terminatione poco gentile, per non dirtroppo rustica» (Ortografia, p. 253).
253. Secondo il Rogacci è «maniera più usata» benivolente (e benivolenza) rispetto alle cor-rispettive forme palatalizzate, pure ammesse (Prattica, p. 344). Va rilevato che il Bargagliassegna benevolenza al senese (di contro al fiorentino benivolenza), ma la forma non sarà statadel tutto estranea a Firenze (cfr. Bargagli, Turamino, cit., p. 125 e n. 2). Nel corpus settecentescodella LIZ 3 troviamo benevoglienza solo in Goldoni e un più largo ricorso a benevolenza(Giannone, Goldoni 3, Baretti 8, Il Caffè 17, P. Verri 3, A. Verri 13, Beccaria).
254. Date come alternative dal Rogacci, Prattica, p. 344. Nelle Regole del Gigli alla doman-da del Maestro «ma quel Boglirò, e Bogliente, e Bogliendo, non s’odono oggimai nella pronun-zia?» lo Scolare risponde che «Alla lingua viva si permette quell’uso, che s’accomoda al-l’orecchio» (p. 183). Bogliente, forma di tradizione toscana (cfr. Vitale, Oro, cit., p. 196), èattestato oltre che in Boiardo (cfr. Pier Vincenzo Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, Firen-ze, Olschki, 1963, p. 91) in Dante (4 esempi), Sacchetti (boglientissimi), Passavanti, Villani (2),Boccaccio (2), Malermi, Ramusio (3), Bruno (2), Bartoli (2; dati LIZ 3).
255. L’esito regolarmente toscano -gghi- da -gl- (in vegghia e tegghia; cfr. Castellani, Saggi,cit., vol. i pp. 213-21) è nel Settecento tratto «antico e toscaneggiante» (Vitale, Oro, cit., p.199; vegghia nel Settecento figura solo in Goldoni con 2 esempi e in Vico nel contesto « sem-pre vegghiante (cioè sempre folta)»; dati LIZ 3). L’alternanza veghia/veglia, in virtù di unasomiglianza col greco, è ammessa eccezionalmente anche dal Lombardelli che d’altra parteesclude i rusticismi consigghio e migghiore (cfr. Trattati di fonetica, cit., p. xxxix).
256. Propio, normale nell’italiano antico (cfr. L. Serianni, Ricerche sul dialetto aretino nei secoliXIII e XIV, «Studi di filologia italiana», xxx 1972, pp. 59-191, a p. 69 n. 5), è pressochécostante nel Turamino del Bargagli e considerato « il vero vocabolo toscano» dal Tolomei (cfr.Bargagli, Turamino, cit., p. 3 e n. 4) che lo usa correntemente nelle Lettere (cfr. Tolomei, Il
stefano telve
252
savore,258 seguela,259 miga260 (cfr. anche Grammatica, p. 76, e, per miga, Prattica,
Cesano, cit., pp. cxx e cxxv; propio è anche citata nel Della pronunzia toscana del Lombardelliinsieme alle forme vinti, nissuna, prencipe, ambasciadore che, « sebbene non esclusive di Siena,erano dai senesisti ritenute proprie della loro lingua»: N. Maraschio, in Trattati di fonetica, cit.,p. 90). Proprio e propio secondo il Pallavicino, Avvertimenti, p. 38; ricorda l’uso di propio inBoccaccio il Bartoli, Ortografia, p. 254. Dalla LIZ 3 [’700] si ricavano 50 esempi in Vico (propiosostituisce proprio nella revisione «arcaistica e toscaneggiante» della Scienza nuova, favoritoforse da convergenze dialettali: cfr. Serianni, La prosa, cit., p. 536, e Giovanni Nencioni, Corsoe ricorso linguistico nella ‘Scienza Nuova’, in Id., La lingua dei ‘Malavoglia’ e altri scritti di prosa, poesiae memoria, Napoli, Morano, 1988, pp. 283-314, a p. 297) e altri in Parini (8) e Baretti (65).
257. Doppo è originariamente forma della Toscana centrale penetrata a Firenze dopo ilXIV secolo (cfr. Serianni, La prosa, cit., p. 493 e n. 35), «ma la scuola senese ne farà quasi unblasone» (Trovato, Il primo Cinquecento, cit., p. 57). Doppo/dopo, oscillazione frequente nellestampe cinquecentesche, è coppia assegnata alla distinzione prosa/poesia dal Dolce («Doposi doppia da Prosatori; ma nel verso non si pone altrimenti che con sola P», Osservationi, cit.in Migliorini, Storia, cit., § viii 22 n. 277; per il commento di Ruscelli, che pure approvandotale regola ne rileva l’incoerenza d’uso, cfr. N. Maraschio, Grafia e ortografia: evoluzione ecodificazione, in Storia della lingua italiana, cit., vol. i pp. 139-227, a p. 190; ancora sull’incertezzagrafica cfr. ivi p. 194 n. 88, e Trattati di fonetica, cit., spec. pp. 72-73); solo successivamente laforma assumerà connotati senesi municipali (cfr. Maraschio, Grafia e ortografia, cit., p. 190).L’oscillazione perdura ancora nelle grammatiche secentesche (cfr. Migliorini, Storia, cit., § ix12), ma nel Settecento doppo appare pressoché uscito dall’uso letterario (le 4 occorrenzeattestate dalla LIZ 3 [’700] in Vico risentiranno probabilmente della convergenza col napole-tano) e sarà stato probabilmente sentito «come più popolare, almeno fuori di Siena» (L.Serianni in Bargagli, Turamino, cit., p. 14 n. 1) dove appare ancora ben vivo (così il Gigli:«Così pure alla Sanese dicono […] doppo […] sempre mai secondo l’antico buon maestro, ebuon padrone Idiotismo Sanese», Voc. Cat., s.v. pronunzia, p. 221; cfr. anche s.v. doppo, p. 27;cfr. anche Tolomei, Cesano, cit., p. cxiv, e Bargagli, Turamino, cit., p. 14 n. 1; il Bargagli, usacostantemente doppo nel Turamino e nei Trattenimenti: 67 occorrenze di doppo contro una didopo: dati LIZ 3). Doppo è tra i pochi senesismi accolti dal Gigli nelle Regole (cfr. prefazione),forma «che a tutti gl’Italiani meglio si accomoda che il proferimento di Fiorenza» (cit. inBargagli, Turamino, cit., p. 226), e anche dal Manni («Dopo, vuolsi dire, anzichè doppo; ma chianche del secondo si valesse, avrebbe dalla sua Fazio Uberti nel Dittamondo, e il Davanzatinella versione di Tacito», Lezioni i, pp. 198-99, Lezioni ev, p. 161, Lezioni iv, p. 180). Tra dopo,dopò, doppo e doppò « solo il primo è giudicato il migliore, e da usare: benche doppo, si leggaparecchie volte nel Barberino» (Bartoli, Ortografia, p. 286).
258. Savore è menzionata dal Rohlfs tra le «poche parole, che accanto alla forma popolarecon p ne hanno un’altra un po’ meno popolare con v» (Grammatica, cit., vol. i § 205). Giàsecondo il Rhys «Verum P in frequentiore usu est [scil. che non v]: veluti coperto, sopra, scopro»(cfr. Trattati di fonetica, cit., p. 156). Sulle voci con alternanza p/v nella prosa del Settecento cfr.Vitale, Oro, cit., p. 198, Patota, Ortis, cit., pp. 59-60, Antonelli, Alle radici, cit., pp. 122-23, Id.,Bertola, cit., p. 202.
259. Nel Voc. Cat. si annotano forme sonorizzate come seguestro nel Villani (s.v. q, p. 240).Sulla diffusione di forme sonorizzate nella poesia rusticale cfr. Poggi Salani, Poesia rusticale,cit., p. 246 e p. 273 n. 73.
260. Nelli deve aver optato per la forma sonorizzata, d’origine occidentale (cfr. Nuovi testi
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
253
p. 286), e neviga;261 infine, citata insieme a quest’ultima, fatiga262 (Grammati-ca, p. 228; entrambe sconsigliate dal Rogacci, Prattica, p. 229).
Alcuni elementi della rassegna – si noti, tra i più marcati – sono com-mentati e sconsigliati in altri luoghi della Grammatica: doppo, osserva il Nelli,«meglio si scrive con uno che con due p» (p. 63), neviga e fatiga, insieme aoglio e bugo, sono parimenti da respingere: «Non istà bene [scil. la g] nelverbo aumentare, e suoi derivati, ma molto meno nelle voci olio [sic], bugio,neviga, fatiga, dicendosi: olio, buco ec.» (p. 228). Un atteggiamento che seguele prescrizioni del Rogacci nel respingere dialettismi spiccati.263
fiorentini, cit., p. 48, Castellani, Saggi, cit., vol. i pp. 300 e 303, Id., Grammatica, cit., pp. 274, 295,320), ma attestata anche in Scipione Bargagli (è costante nel Turamino, cit., p. 28 n. 1, contadue esempi contro uno di mica nei Trattenimenti: dati LIZ 3), grazie all’avallo del Bembo chenelle Prose cita miga («Neente anticamente si disse, e Né mica o pure Non mica, e Nulla quellostesso; come che Non mica si sia eziandio separatamente detta, Elli non hanno mica buonasperanza; e Miga altresì, e Niente alle volte si ponga in vece d’Alcuna cosa […]», Prose, cit., iii 67,p. 289; nel Decameron si contano 2 occorrenze di mica contro 7 di miga; dati LIZ3).
261. Rari (stando ai dati forniti dalla LIZ 3 per il corpus tra Due e Settecento) gli esempi dinevigare, presenti solo in Caro (Traduzione dell’Eneide, 2 ess.) e Ramusio (3).
262. Fatiga (attestata frequentemente nella letteratura tra XIV e XVI secolo quale allotropo,con sonora etimologica) è forma corrente, accanto alla più marcata fadiga, nel lucchese anti-co e moderno ed è « frequente nei Senesi (A. Piccolomini, ecc.)» (Migliorini, Storia, cit., §§viii 22 n. e ix 12; cfr. anche Trovato, Senese letterario, cit., spec. p. 101, e Castellani, Grammatica,cit., p. 396; fadiga, fatigoso in Tolomei, Cesano, cit., pp. cxxi e cxxiii; fadiga è di norma nelBargagli, Turamino, cit., p. 125 e n. 2; cfr. anche N. Maraschio-T. Poggi Salani, L’insegnamentodi lingua di Diomede Borghesi e Celso Cittadini: idea di norma e idea di storia, SLI, xvii 1991, pp. 204-32, a p. 219) e perdura ancora nel XVIII secolo arrivando fino ad oggi (cfr. Castellani, Saggi,cit., voll. i pp. 300 e 302, e ii p. 437, Id., La Toscana dialettale d’epoca antica, SLI, xxiii 1997, pp. 3-46, a p. 15). I senesi, testimonia il Politi, «naturalmente dicono fadiga, ma per uso anco fatica»,forma che secondo il Bargagli « in Siena non si sente fuor ch’allora quando vengono a cittài nostri contadini» (Bargagli, Turamino, cit., p. 143 n. 4). Il Gigli cita fatiga tra le voci chealternano c e g « tanto da’ Sanesi, che da tutti i Toscani» (Voc. Cat., s.v. c, p. 15; cfr. anche p. 305),ma era forma respinta dal Pallavicino, Avvertimenti, p. 38, e dal Bartoli («molti voglionoFatiga, per Fatica: io a gran fatica ho trovato Fatigarsi nel Barb. […]», Ortografia, p. 257). Laconvergenza toscana e letteraria fa sì che nel Settecento la forma ricorra abbondantementenella prosa arcaizzante di Vico (29 attestazioni; si consideri tra l’altro che le correzioni ap-portate alla Scienza nova prediligono fatiga: cfr. Nencioni, La lingua dei ‘Malavoglia’, cit., p. 291),in Genovesi (2) – senz’anche ipotizzare nei due autori l’influsso del sostrato napoletano – eCasti (1). Cfr. anche quanto detto dall’Amenta cit. in Matarrese, Il Settecento, cit., p. 178.
263. Consiglia il Rogacci: «Olio non oglio» (Prattica, p. 134; la g non « si tollera» in olio, ivi,p. 344; e su olio invece di oglio cfr. già il Bartoli, Ortografia, p. 167), «nevicoso, non nevigoso» (ivi,p. 134), «Fatica, e non Fatiga» (ivi, p. 133), «Non dirai dunque Nevigare, ma sol Nevicare: nonFatigare, ma Faticare» (ivi, p. 229); su aumentare da preferire a augumentare cfr. ivi, pp. 8 e 344(così già il Pallavicino, Avvertimenti, p. 37); ma, come per il Nelli, in un altro luogo dellagrammatica segnala semplicemente che « la g si trova sostituita dalla c in nevicare, bracia, bacio,
stefano telve
254
Bisogna tuttavia osservare che il Nelli, pure nella mera descrittività delleallotropie, non menziona molte alternanze marcate in senso dialettale to-scano citate invece dal Rogacci, sua fonte principale (cfr. sub § 5.1): nellaPrattica, oltre alle forme già dette, figurano anche, per rappresentare l’alter-nanza e/i, ordigno, patrigno, matrigna, casalingo,264 lignaggio, nighittoso,265 gitto etragitto, per a/e davanti a r vecchiarello, gentarella, casareccio, villareccio,266 per i/asindico, imbasciatore,267 per o/u longo, spelonca, e spogna, accanto a fromento, oncino,sustanza, voluntà, molino, facultà (Prattica, pp. 126-28); e ancora per i verbi:consigliare/consegliare, peggiorare/piggiorare (ivi, p. 228). Nel mettere sull’avvisocirca l’uso, il Rogacci s’appella di nuovo all’eleganza e al miglior suono,all’uso delle persone cólte: siffatto variare, «affinche non degeneri in oscu-rità, e affettazione, ha bisogno di consideratezza, e giudizio. Talche, chidella commemorata libertà vuol lodevolmente servirsi, fra le due manìereper altro permessegli di aumentare, ò nò qualche nome, di accorciarlo, ò dilasciarlo intiero, e di proferirlo con una, ò con altra sorte di lettere; a quellaspecialmente si appigli, la quale, oltre l’haver miglior suono, e conferire hìc,& nunc alla maggiore eleganza, e varietà dello stile; vedrà non esser nuova,& istrania nel linguaggio delle persone dotte, nè perciò ò innaturale è adusarsi, ò spiacevole a udirsi, e difficile a intendersi» (ivi, pp. 130-31).
Il Nelli non si spinge dunque oltre un certo segno, che non possiamo
fatica» (Prattica, p. 344). Oglio (voce citata dal Rhys nel paragrafo dedicato alla o “oscura” e alleeccezioni: cfr. Trattati di fonetica, cit., p. 151) è forma caratteristica del toscano popolare occi-dentale (cfr. Castellani, Saggi, cit., vol. ii pp. 361-62) attestata «anche a Pistoia e in Toscanaorientale, e con minore regolarità a Siena» (Castellani, Grammatica, cit., p. 340; cfr. anche p.397) e perdura nel Settecento presso autori settentrionali (Goldoni, P. Verri e S. Franci scrit-tori del Caffè e Piazza: dati LIZ 3; per Piazza cfr. Antonelli, Alle radici, cit., p. 126). Statutodiverso ha la sonorizzazione c- > g- promossa ancora dall’Amenta «perchè vengon le voci adesser più Toscane, che Latine; e per pronunziar la plebe col C, gli scrittori col G» (in Bartoli,Torto, p. 413; sulla preferenza dell’Amenta per le sonore cfr. Vitale, Oro, cit., p. 267 n. 204;s’alternano gastigare e castigare in Bartoli Ortografia, p. 256), come conferma il Gigli: la c «col gvariasi […] tanto da’ Sanesi, che da tutti i Toscani, e dicesi castigo, e gastigo, fatiga, e fatica, lacrime,e lagrime […]», Voc. Cat., s.v. c, p. 15 (gattivo è detto senesismo in uso «anco oggidì presso ilvolgo», Voc. Cat., s.v. gattivo, p. 40, voce che secondo il Bartoli è da alcuni così pronunciata«per vezzo», Torto, p. 404). Sulle voci con g- cfr. Poggi Salani, Poesia rusticale, cit., p. 246 e n. 73e, sulla sonorizzazione in generale del senese, Ludwig Hirsch, Laut- und Formenlehre desDialekts von Siena, «Zeitschrift für romanische Philologie», ix 1885, pp. 513-70, x 1886, pp. 56-70, 411-46, alle pp. 562-65, dove tra l’altro si nota che « gastigare ist germeinitalienisch» (p. 562).
264. Sull’anafonesi cfr. Castellani, Saggi, cit., vol. i pp. 73-87.265. Cfr. Castellani, Saggi, cit., vol. i p. 213.266. Sul passaggio ar > er cfr. Castellani, Saggi, cit., vol. i pp. 476-77, e Id., Grammatica, cit.,
pp. 293, 350, 364.267. Su sindico/sindaco cfr. Castellani, Saggi, cit., vol. ii p. 218.
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
255
ritenere violato neanche da forme come facultà (Grammatica, p. 120)268 edescire (ivi, p. 167), sospetti senesismi sì, ma soprattutto avallati dal modellolatino. Tant’è che se il Nelli non si esprime sulla connotazione di questeforme, non fanno altrettanto gli autori da lui più citati: il conterraneo Giglinegli esercizi delle più tradizionali e meno polemiche Regole corregge escirecon uscire («è meglio», p. 233; sempre con e- nel senese e in altri dialettitoscani: ivi, p. 194; così anche il Soave, Gramatica, p. 131, e Gramatica 1816, p.91) e nel Vocabolario ricorda che «Tutti gli altri Scrittori Sanesi dissero così[scil. escire], che per brevità non si citano. I Fiorentini dissero piuttosto usci-re» (Voc. Cat. s.v. escire, p. 30), menzionando il Rogacci, che ammise escire,esciamo, escirei (dato che «non è in obligo almeno rigoroso» mutare la e in uquando non è accentata: cfr. Prattica, pp. 181-82) benché «il Pergamino nelsuo Memoriale non porti veruno esempio di questo verbo alla Sanese» (Voc.Cat., s.v. escire, p. 31).269 L’argomento è ripreso dal Corticelli nella iii edizio-ne delle Regole, dichiarando che escire, escisse, escissero sono «presso i Poetiantichi, e con giudicio adoperar si possono, ma le accennate terminazionicon l’u sono più regolate. Così escito si dice, ma è meglio uscito» (p. 168).
Qualora si abbia che fare con tipologie eterogenee di esempi, il Nelli puòoptare, oltre che per il commento puntuale alle forme più significative (comeper le alternanze consonantiche), per un’osservazione di carattere generale,come già fece il Rogacci nel passo appena citato. A proposito del «cambia-mento irregolare di lettere, o intere sillabe», ad esempio, si menzionanoancora una volta forme non liberamente alternative: alla forma non marca-ta sono accostati ora latinismi (antico/antiquo, cheto/queto, frode/fraude, lode/laude), ora poetismi (o quasi: nascosto/nascoso),270 forme di diffusione soloprosastica e (post-)cinquecentesca (fracido/fradicio),271 arcaismi o demotismi
268. Cfr. Trovato, Senese letterario, cit., pp. 83-84.269. Minoritaria nella prosa settecentesca la forma in e-, che nel primo Ottocento appare
confinata agli scrittori toscani (Antonelli, Alle radici, cit., p. 102 n. 65). Il Bartoli collega l’alter-nanza tra escire e uscire a ragioni fonetiche, prescrivendo le voci verbali con e- se questa ètonica (come in esco, esce, ecc.), viceversa, quelle con u- (uscì, uscire, ecc.; p. 233). Sulle motiva-zioni dell’alternanza vocalica in esce/uscire cfr. Gianluca Lauta, ‘Esce’/‘uscire’, SLI, xxv 1999, pp.103-7.
270. Nel Settecento nascoso resiste ancora nella prosa letteraria del Di Capua (cfr. Vitale,Oro, cit., p. 207), del Chiari (cfr. Antonelli, Alle radici, cit., p. 169), del Gravina e del Baretti(dati LIZ 3).
271. La forma metatetica fradicio risalirebbe al XVI secolo (cfr. DELI, s.v.; cit. anche dalManni, Lezioni i, p. 248, Lezioni ev, p. 200, Lezioni iv, p. 226, tra le posposizioni del «modernotempo») ed è probabilmente questa assenza dalle autorità poetiche dei primi secoli ad averdecretato la totale esclusione della forma dalla poesia anche per i secoli successivi: nel corpus
stefano telve
256
(nuvolo/nugolo272, acquidoccio/acquidotto273 e stroscio/scroscio: Grammatica, p. 121;queste ultime due coppie sono anche in Rogacci, Prattica, pp. 129-30).274 Acommento di questa serie il Nelli, senza soffermarsi sulle singole forme,avverte più in generale che «in tali cambiamenti bisogna regolarsi col buonuso, e buon gusto per non fare scelta de’ peggiori vocaboli, richiedendo lapurgatezza della lingua di servirsi de’ migliori, e più usitati, quando però lanecessità, o la consonanza, o lo stile non obbligasse altrimenti»; che cosaegli intenda per buon uso è specificato subito dopo: «Circa poi al buono, ocattivo uso di alcune voci particolari potranno consultarsi varj grammatici,e spezialmente il Vocabolario della Crusca» (Grammatica, p. 122).
Quanto detto a proposito della «parentela delle lettere» vale, in misuraminore, anche per i prospetti riassuntivi delle forme verbali, che spessonon danno conto solo delle forme effettivamente disponibili all’epoca (comeci si potrebbe aspettare in una grammatica “didattica”) ma tendono a offri-re un panorama completo, non necessariamente selezionato, delle formepossibili.
Nella Grammatica del Nelli, ad esempio, si dispiegano senza commen-to il ventaglio delle desinenze della sesta persona del condizionale «ebbero,o ebbono, o iano, o ieno» (p. 133; nei paradigmi dei verbi più correnti -ianoe -ieno non sono sempre rappresentate), laddove gli altri grammatici ar-gomentano in favore dell’una o dell’altra forma,275 e le uscite del congiun-
della LIZ 3 [’500-’700] fradicio figura infatti solo in prosa (14 esempi), diversamente da fracido,che ha cittadinanza sia nella prosa (24) sia nella poesia (10).
272. Così il Gigli: « Il Vocabolario nuvola, nuvolo, e nugolo. I nostri Contadini, e Plebei,nuvila, e nugolo» (Voc. Cat., s.v. nuvila, p. 91).
273. Si noti che il Vocabolario della Crusca (iv edizione), citato spesso dal Nelli, lemmatizzaaquidoccio ancora insieme a acquidotto (cfr. Matarrese, Il Settecento, cit., p. 49; la LIZ 3 [’200-’700]fornisce esempi di a(c)quidoccio in Villani e Bartoli) e le forme sono date come alternativeanche in Bartoli, Ortografia, p. 172.
274. LIZ 3 [’200-’700]: Grazzini (strosciare), Bartoli (stroscio), Cesarotti-Ossian (stroscia, stroscie).Solo nuvola, dobbia- e abbia- in Bargagli, ma sempre debile (debili, debilezza, debilmente; LIZ 3).Su forme senesizzanti quali debilezza, fadiga, nuviluzzo cfr. Trovato, Senese letterario, cit., p. 64.
275. Anche il Rogacci nel prospetto dei verbi allinea le quattro terminazioni per tutte leconiugazioni (Prattica, p. 158), notando altrove che per alcuni verbi è «più communenemente»usata la desinenza -ieno che non -iano o -eano (havieno, languieno, venieno, stieno, diesi, sariesi, sie,«La qual varietà non vuol tuttavia, benche di rado, e discretamente usarsi. Vedi il Barto-li […]», Prattica, p. 229). Nell’errata corrige posta al fondo del volume il Corticelli, che in testoaveva affiancato le varie forme (« talora si dice» fia e fie, fieno, «Saria alle volte si dice per sarei,e sarebbe, e sariano, o sarieno per sarebbono», Regole i, p. 99), ritiene «giusto il sentimento delRuscelli nel Rimario, cioè, che la terminazione in ia nelle terze persone dell’imperfetto, ede’ preteriti dell’ottativo si possa liberamente usare in vece della uscita in ebbe: ma nelle
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
257
tivo imperfetto, del passato remoto e del condizionale presente di vi per-sona, per le quali si citano accanto a -ero e -ono anche quella d’origineoccidentale, di tradizione grammaticale antibembiana (Castelvetro, Trissino,Giambullari) -eno, promossa dai senesisti e ricordata anche dal Rogacci(piansero/-eno/-ono, Prattica, p. 143; nel condizionale: amerebbero/-ono/-iano/-ieno; nel congiuntivo solo amassero/-ono, ivi, p. 145),276 il quale, d’altronde,
prime persone, in vece della terminazione in ei, si voglia usar di rado, o forse solamente inVerso, e per necessità di rima» (Regole i, p. 533). Fie per fia è poetica secondo il Manni, Lezio-ni i, p. 182. Il Gigli alloga saria i pers. nella colonna del ‘poetico’ e saria iii pers. in quella del‘corretto’, insieme a sarei (Regole i, p. 59); tutte nel ‘corretto’ sarebbero/-eno/-ono/sarieno/sariano(ivi). Il Soave considera furo, fia, fieno, saria o fora, sariano, sarieno o forano «più del verso, chedella prosa» (Gramatica, p. 104, Gramatica 1816, pp. 64-65). Sul tipo saria, sariano in poesia cfr.Serianni, Lingua poetica, cit., § 37.1.5.1. A proposito del congiuntivo presente di dare, per ilquale il Corticelli aveva menzionato l’arcaico dea (Regole i, p. 111, e rimane anche in Regole iii,p. 138), il Nelli suggerisce diano e dieno (p. 247; terza persona dia), alternative effettivamentepraticate in prosa e in poesia, benché il Corticelli annoveri diano per dieno insieme a dasti,daste, dassi, dasse, dassero, tra le voci che non sono «di buon calibro» (Regole i, p. 111, e Regole iii,p. 139). Dieno è preferita anche dal Soave (Gramatica, p. 121; insieme a stieno, mentre per la iiipersona si dà solo stia, ivi, p. 122). Dieno aveva nel Settecento una circolazione ridotta rispettoa diano (dati LIZ 3 [’700]): Dian (solo in poesia: Metastasio 2, Goldoni 2, Alfieri, Casti), diano(prosa: Gravina, Goldoni 19, Bettinelli 3, Caffè 2, P. Verri; poesia: Goldoni 8), diansi (prosa:Goldoni; poesia: Goldoni 3, Casti), dianvi (poesia: Goldoni). Dien (Alfieri), dienne (Casti),dieno (prosa: Vico, Goldoni 2, Baretti 2, Il Caffè 4; poesia: Alfieri).
276. Cfr. Maurizio Vitale, La scuola “senese” nelle questioni linguistiche fra Cinque e Settecento, inLingua e letteratura a Siena, cit., pp. 1-40 (pp. 27-28). Il Gigli nel Voc. Cat. osserva tuttavia che « Ilcambiamento della sillaba ro in no ne’ verbi che hanno questa terza voce così terminata,come da risero, riseno, da temettero, temetteno &c. è stato in uso; ma i migliori per dare ad una talvoce miglior suono cambiarono anche la e in o, dicendo: risono, temettono &c. […]» (s.v. verbi,p. 318) e ancora nelle Regole: « fossi per fosse […] è usato malamente da più autori, e restaappresso i Fiorentini oggidì, più che altri. Così pure fossino coloro […] per fosseno […]» (p.64). La vi persona del passato remoto, dice il Nelli, «o è in ero, o in rono: la prima può mutarsiin ono, o in eno, e dirsi scrissero, scrisseno, scrissono» (pp. 129-30). Si vedano nei paradigmi deiverbi, le forme: cadetteno, detteno, disseno, dolseno, dovetteno, feceno, salseno, sedetteno, volleno;dovrebbeno, potrebbeno, vorrebbeno; dovesseno, potesseno, vedesseno, volesseno (pp. 147-60). Attestazionidi dovesseno nei toscani (dati LIZ 3 ’200-’600) si hanno solo in Scipione Bargagli (pur minoritarierispetto a dovesser(o)); sull’uso del congiuntivo imperfetto in -eno in Tolomei cfr. Tolomei,Cesano, cit., pp. cxix-cxx. Sulla desinenza -eno, che al presente indicativo sopravvive nellerevisioni toscaneggianti dell’Arcadia e del Furioso (cfr. risp. Serianni, La prosa, cit., p. 487, eAngelo Stella, Note sull’evoluzione linguistica dell’Ariosto, in Ludovico Ariosto: lingua, stile e tradizio-ne, a cura di Cesare Segre, Milano, Feltrinelli, 1976, pp. 49-64, a p. 55), cfr. Nuovi testi fiorentini,spec. pp. 146 e 155, Testi sangimignanesi del secolo XIII e della prima metà del secolo XIV, a cura diA. Castellani, Sansoni, Firenze, 1956, pp. 32 sgg., Castellani, Saggi, cit., voll. i pp. 319-22, ii pp.230, 299, 402, Della Valle, Lessicografia, cit., p. 229, Fabrizio Franceschini, Aspetti del cambiamen-to linguistico dal pisano antico al moderno, in Linguistica storica e cambiamento linguistico. Atti del xvi
Congresso Internazionale di Studi, Firenze, 7-9 maggio 1982, a cura di Luciano Agostiniani,
stefano telve
258
fornisce schemi verbali largamente, per non dire eccessivamente, ricettivi,come avviene per alcune voci di dare e stare: per la i persona si ha diedi/dettima anche diei (già in Bartoli, Torto, p. 258, poi in Gigli, Regole, p. 181, ma nonanche nel prospetto del verbo, ivi, p. 112, dove figura il poetico die’), per la vi
diedero/dierono/dettero/diero/diedono/diedeno/dettono/detteno; e stettero/stetteno/stettono/sterono/stero (Prattica, pp. 161-62; anche in Gigli, Regole, p. 112, nellacolonna del corretto, tranne diero, inserita in quella del poetico),277 laddove ilCorticelli prescrive soltanto diedi/die’ (Regole i, p. 110) e diedero/diedono/dierono (ivi, p. 111).278
Più selettivo è il Soave, che nel prospetto dei verbi essere e avere ammettepochissime forme concorrenti (oscillazioni perlopiù fisiologiche)279 e im-mediatamente dopo avverte: «Le qui notate sono le sole voci, che si debbanusare di questi due verbi» (Gramatica, p. 103), segnalando subito le altrecome «errori», «voci pur da guardarsene», «affettazioni», e proprie «piùdel verso, che della prosa» (ivi, pp. 103-4).280 Ciò che vale anche per i
Patrizia Bellucci Maffei, Matilde Paoli, Roma, Bulzoni, 1985, pp. 27-50 (pp. 35-42), G. Nen-cioni, Un caso di polimorfia della lingua letteraria dal sec. XIII al XVI, in Id., Saggi di lingua antica emoderna, Torino, Rosenberg & Sellier, 1989, pp. 11-188, M. Vitale, Di alcune forme verbali nellaprima codificazione grammaticale cinquecentesca, «Acme», x 1957, ora in Id., La veneranda favella,Napoli, Morano, 1988, pp. 243-75, Castellani, Grammatica, cit., pp. 321-22, 331, 350.
277. Così il Soave: per la i persona diedi/detti, per la iii diede/diè/dette, per la vi diedero/diedono/dierono/dettero (Gramatica, p. 121).
278. Su dierono e diero cfr. anche Bartoli e Amenta (in Bartoli, Torto, cit., pp. 622-23). Unsondaggio sulla LIZ 3 [’600-’700] conferma la rarità di alcune delle forme citate. Die’ conta 16occorrenze di contro a una di diei (Goldoni, Terenzio). Per la vi persona, dierono (4 occorrenzein Croce, una in Pona, una in Bettinelli) concorre con dettero (Costo 2, Basile 5, Baretti),mentre è eccezionale diedono (solo in Tassoni, Secchia rapita), connotato poeticamente diero(25 occorrenze complessive, sempre in testi in versi) e non hanno infine esempi dettono e ledue forme in -eno diedeno e detteno, forme che l’archivio LIZ 3 aduna ampiamente per i duesecoli precedenti (detteno 29 occorrenze, dettono 115), con l’eccezione di diedeno, che figura unsola volta in Ramusio. Per stare, tranne stettero (26 occorrenze tra XVII e XVIII secolo) lealtre forme sono attestate solo fino al Cinquecento (stettono 43, stetteno 14, sterono solo unavolta in Vasari e, come già per diero, solo in poesia stero 6). Sulla specificità poetica delle formein -ro cfr. Serianni, Lingua poetica, cit., § 37.1.4.4.
279. Per essere: « furono, e in poesia furo», « sarà, o fia», « saranno, o fieno» (p. 99); « tu sii o sia»« siano, o sieno» (p. 100; nell’edizione del 1816 si specifica che sieno «è di miglior uso», p. 64),« sarebbe, o saria, o fora», « sarebbero, o sarebbono, o sariano, o forano» (p. 101). Per avere: «Aveva, oavea», «avevano, o aveano» (ibid.), «avrebbe, o avria», «avrebbero, o avrebbono, o avriano» (p. 103).
280. Tra gli «errori» fossimo, avessimo o ebbimo per ‘fummo’ e ‘avemmo’, le forme di ii perso-na fosti o avesti; saressimo e avressimo (p. 103); tra le «voci pur da guardarsene» semo, sete e avemo(queste ultime tre nell’edizione del 1816 sono dette dello «stil famigliare», pp. 64-65); eramo, ele forme di v persona eri e avevi; io sii o abbi, essi siino o abbino, io saria e avria, e le forme pieneaverò, averai; tra le «affettazioni» ebben/ebbon e arò, arei; per le forme della poesia cfr. § 5.1.
prescrizione e descrizione nelle grammatiche del settecento
259
prospetti delle quattro coniugazioni, fortemente selettivi: basti dire cheper l’imperfetto si incolonnano le sole forme con labiodentale temeva-(no), leggeva(no), sentiva(no), e per il perfetto solo temei, temé, temerono, manel commento che segue si avvisa che sono possibili per l’imperfetto an-che le forme con dileguo e per il perfetto anche le desinenze -etti, -ette,-ettero (ivi, pp. 114-15). Appena meno selettivo è il prospetto del pronomepersonale soggetto di vi persona che allinea eglino, ei, e’ (ivi, p. 60) laddovenel testo si commenta che «ei, o e’ si trovan di rado, e s’usano in cambioeglino, o essi» (ivi, p. 62),281 ma la riserva espressa dal Soave riguarda la fre-quenza, non la correttezza.
Nelle grammatiche l’amore della completezza vince sul dovere dellaselettività anche in altre sezioni. Solitamente molto ricca è ad esempio laparte dedicata agli avverbi – per probabile riflesso della vasta classificazio-ne del Pergamini, un’autorità particolarmente ascoltata dai settecentisti enon solo in quest’àmbito grammaticale.
Nel paragrafo dedicato ancora dal Nelli agli avverbi (Grammatica, pp.268-74), ad esempio, che deve poco o nulla alla grammatica del Rogacci emolto al trattato del Pergamini, esplicitamente ripreso (ivi, p. 200), gli av-verbi di tempo sono elencati in relazione non all’uso coevo o al registro maalla funzione deittica (presente, imperfetto, passato, futuro). Si annoveranodunque insieme ai correnti orora, ador’adora, pocofà (alternabile con il sem-plice poco, ivi, p. 69) e a poc’era (o avea) che (ad es.: poco avea che io dormiva,poc’era ch’io ti credea morto) gli avverbi latineggianti abantico e perantico e ildisusato testeso, voce registrata già dal Bembo quindi bollata dal Mannicome «de’ prischi secoli soltanto» (Lezioni i, p. 199, Lezioni ev, p. 162, Lezio-ni iv, p. 181).282 Analogo l’atteggiamento degli altri grammatici: del Corticelli,che distingue solo in relazione alla funzione (tempo, luogo, esortazioneecc., Regole i, pp. 165-69), del Gigli, che fatta qualche osservazione rinvia al«profittevolissimo» trattato del Cinonio e, ancora, a quello del Pergamini(Regole, pp. 212-15), e del Soave, che tuttavia presenta un mannello di esem-pi piuttosto compatto, con occasionali glosse sulle funzioni ancora più chesull’uso (Gramatica, pp. 149-59). Si distingue su tutti il Manni, che si espri-
281. Registra e’ ed ei in luogo di egli e eglino il Nelli, Grammatica, p. 186.282. Il Bembo la disse impiegata «alcuna volta molto anticamente, e da Dante, […] e dal
Boccaccio», Prose, cit., iii 60, p. 277; a questa fonte risalgono (probabilmente non in mododiretto) tra l’altro anche gli esempi. Si confrontino quelli del Nelli: «quando ti mi tiravi testesoi capelli» ed « egli debbe venir quì testeso un che ec.»; con quelli bembiani: «Tu non sentivi quello cheio, quando tu mi tiravi testeso i capelli, e ancora: Egli dee venir qui testeso uno, che ha pegno il miofarsetto».
stefano telve
260
me a chiare lettere sulla variabilità di registro (non solo, come visto, pertesteso): per «un discorso familiare, e pedestre, ovvero rusticale, o pure alvolgo adattato, io mi varrò benissimo delle locuzioni A iosa, A biscia, A ufo,A vanvera, o A fanfera; se poi avrò fra mano un componimento grave, esostenuto, adoprerò in quella vece In abbondanza, Copiosamente, In copia,Senza ricompensa, Senza dispendio, Inavvedutamente, e somiglianti» (Lezioni i,pp. 217-18, Lezioni ev, p. 176, Lezioni iv, p. 198).283
(continua)
Stefano Telve
283. In termini analoghi sono commentate alcune locuzioni: « in un componimento umile,o giocoso, e da scherzo» si dirà trar l’aiuolo, tirar le cuoia; « in un altro, che gravità, e sublimitàricerchi, che gli antichi nostri appellano favellar dignitoso, sarà infinitamente più adatto ildire Render l’Anima al Creator suo; o vero Pagare alla natura il suo diritto» (Lezioni i, p. 224).