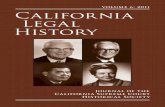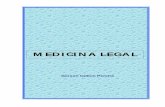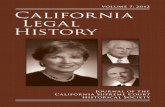T. Duve (ed.), "Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches, Global Perspectives on Legal...
Transcript of T. Duve (ed.), "Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches, Global Perspectives on Legal...
THOMAS CASADEI, Tra ponti e rivoluzioni. Diritti, costituzioni, cittadi-nanza in Thomas Paine, Torino, Giappichelli, 2012 (*).
Ideatore di ponti e di rivoluzioni: traendo spunto da unanotazione di Bertrand Russell, così Thomas Casadei presenta ailettori italiani l’autore trattato nel suo lavoro monografico. Unostudio, questo, che si pone come una compiuta ricostruzione delpensiero e dell’opera di Paine, contribuendo in tal modo a richia-mare l’attenzione attorno a una figura forse troppo a lungo passatain secondo piano o messa in ombra da altri pensatori dell’epocadello scrittore inglese ben più celebrati. Merito della ricerca diCasadei è perciò, innanzi tutto, quello di dare lustro all’operasuddetta e porla accanto a quelle di altri « classici » del pensierofilosofico-politico e giuridico.
Proprio sfruttando il parallelismo tra i progetti di ponti, cuiPaine si dedicò nel corso della sua vita, e i progetti di rivoluzioni(l’altra grande passione dell’intellettuale inglese (1)) l’autore raffigurail costituzionalismo painiano come informato da una logica ingegne-ristica: una ingegneria « civile » — come quella tipica dei ponti — intutti i sensi, perché « civile » è l’impegno di Paine come pensatore e« civile » la destinazione che egli intende dare alla sua opera; esoprattutto perché quel costituzionalismo implica una modalitànuova di concepire il rapporto tra governanti e governati, nonché ilmodello politico della cittadinanza e tutte le questioni ad essoconnesse: pensarle, cioè, con la stessa forza immaginativa, con lostesso « genio » che occorre per ideare un ponte, un’opera che sfidaleggi ferree, come la gravità, e creare una comunicazione, un pas-saggio là dove — e in un modo in cui — nessuno lo avrebbe maiimmaginato; così, anche il modello teorico e istituzionale
(*) L’occasione per recensire il volume in questione è stata offerta dall’incontroDiritti e costituzione in Thomas Paine, tenutosi a Pisa il giorno 11 aprile 2014 eorganizzato dalla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche (programma di Giustiziacostituzionale e diritti fondamentali — curriculum in « Teoria dei diritti fondamentali »)presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa nell’ambito del ciclo diincontri Lo stato dei diritti. Un percorso storico e teorico.
(1) Passione, peraltro, non meramente « speculativa »: oltre a proporre progettidi rivoluzioni, Paine partecipò attivamente da protagonista sia alla rivoluzione americanasia, su posizioni girondine, alla rivoluzione francese.
progettato da Paine sfida leggi consolidate della (tradizione) politica,sovverte la logica statica della cittadinanza, crea uno spazio nuovo, unapossibilità inedita per la politica e il diritto.
Già l’idea del « libero volere politico » di un popolo (p. 49), diuna sovranità popolare totalmente auto-riferita e auto-costituitasi (finoalla possibilità di costituirsi popolo separandosi dal popolo cui storica-mente si appartiene , a ciò bastando solo « una razionale spiegazione alresto dell’umanità »), come pure l’idea di una generazione di individuiche affermano una loro costituzione senza vincoli di sorta né con legenerazioni del passato né con quelle che verranno dopo, valgono adelineare, con tratti marcati, una dottrina costituzionale di ispirazionerivoluzionaria e un radicalismo democratico che si pone come una sfidateorica e una prassi politica senza precedenti.
In tal senso, Casadei mostra come appaia quanto mai originale iltipo di repubblicanesimo delineato da Paine, alternativo anche a quellodi ispirazione ‘federalista’, perché, lungi dall’essere inteso nel senso delbilanciamento dei poteri e della forza continua di una ancient constitu-tion — dunque, in sostanza, come un freno alla spinta delle passioni delpopolo — è tutto teso a valorizzare l’unicità della volontà popolareespressa nella « legge ». Ma l’orizzonte del costituzionalismo non è intal modo spazzato via in un colpo solo né la posizione di Paine puòessere pertanto ridotta a quella di chi vede nel costituzionalismoqualcosa di paralizzante (2): su questo punto la lettura più equilibrataproposta dall’autore è animata dall’intento, rinvenibile nella paginepainiane, di coniugare democrazia e costituzionalismo, con una solu-zione che è stata ripresa anche nel dibattito contemporaneo (in parti-colare, da James Tully, che ha avanzato l’idea di una costituzioneperiodicamente modificabile per mezzo della modalità groping towards,ovvero procedendo per tentativi ed errori (3)): una costituzione intesacome esperimento, come una « grammatica comune » (p. 121), dunquesempre « aperta »; un costituzionalismo progressivo, secondo la formulaimpiegata da Casadei.
Anche la tradizione filosofica e la storia delle idee vengonosovvertite con un movimento, nota l’autore, che non è tanto (o solo) di« rottura » quanto di « superamento », di innovazione e ri-pensamentoprofondo degli assunti teorici e degli esiti, ovvero delle implicazionipolitiche, delle dottrine consolidate. Un risultato, questo, che si ponecome ancora più eclatante se riferito al caso di un pensatore quale èstato Paine, che pure confessava candidamente di non aver letto libri né
(2) Si veda, per tutti, M. SHAPIRO, Introduction, in The Constitution of the UnitedStates and Related Documents, Id. (ed.), New York, Appleton-Century-Crofts, 1968, lacui posizione viene richiamata e discussa anche da Casadei nel suo volume (p. 118 e ss.).
(3) Cfr. J. TULLY, Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity,Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 60 e ss.
QUADERNI FIORENTINI XLIV (2015)970
di aver « studiato le idee degli altri » (p. 22); e opportunamente Casadeiosserva come in questo caso la qualifica di « scienziato delle idee », al dilà dell’apparente paradosso, possa valere a maggior ragione per unautore come Paine (pp. 22-23). Prova ne è la « democratizzazione » delpensiero lockiano che questi compie nella direzione di un egalitarismoche si articola in una riformulazione del ‘giusnaturalismo dei diritti’ e inun’innovativa concezione della proprietà.
È infatti un diritto naturale — quello che risalta dalle paginepainiane — che si nutre di una dimensione « popolare », essendo intesoe condiviso a livello del common people e che dunque non resta nel cielodelle teorie né tanto meno nei gangli di una legge oggettiva che puòessere solo « filosoficamente » intesa. Un diritto naturale dal voltodemocratico, si potrebbe dire, storicamente connotato e perciò sempre« al passo con i movimenti della società » (p. 75). Concepito in talmodo, il giusnaturalismo rafforza ancora di più la propria portata diistanza critica nei confronti del diritto « posto », quasi fosse una sorta dipublic opinion di contro al potere costituito, e diviene strumento dimutamento, « pensiero e azione », scrive Casadei, « dinamica apertura,che incontra l’esigenza painiana della partecipazione politica qualediritto per ogni individuo [...] e del continuo sforzo ad andare avanti »(p. 75).
In questa declinazione popolare del giusnaturalismo non potevanonon trovare posto delle « tipologie » di diritti naturali molto più comunie, al tempo stesso, più universali rispetto a quelle delle catalogazionitradizionali: i « diritti intellettuali, o diritti della mente », ad esempio (p.126); e d’altronde, non poteva non essere ripensato anche il rapportotra i diritti naturali così concepiti e i diritti civili, nonché il ruolo delpotere politico nel « supportare » il potere naturale degli individui e nelcolmarne le insufficienze; ma soprattutto, non poteva non venire mag-giormente in evidenza la dimensione dei doveri correlati ai diritti, ossiala condizione di reciprocità e il momento solidaristico che strutturano un« fondo comune » (p. 131) dei diritti naturali nella società civile. Suquesti aspetti il libro di Casadei si sofferma in modo particolare, perchéè da essi che si può evincere la « novità » rappresentata da Paine nelmoderno « discorso dei diritti », ovvero la forte spinta alla democratiz-zazione delle dottrine del diritto naturale e l’apertura a sviluppi futurie imprevedibili (eco della riflessione di Paine sono, ad esempio, le teoriesul basic income (4)).
Accanto a questo peculiare aggiornamento del giusnaturalismo,nel corso della trattazione vengono messi in risalto i tratti di un’inno-vativa concezione dell’istituto proprietario, che serve, appunto, a « su-perare » — democratizzandola — la dottrina lockiana dell’appropria-
(4) Allo sviluppo di questo tema è dedicata la parte conclusiva del capitolo IIIdel volume (cfr. p. 202 e ss.).
LETTURE 971
zione. Se Paine è infatti disposto, da un lato, a riconoscere il « dirittopersonale » sui beni ricavati dal lavoro della terra, e dunque la legittimaappropriazione del « valore » in tal modo prodotto, dall’altro lato,contra Locke, non riconosce la legittimità dell’appropriazione dei mezzinaturali che hanno consentito tale produzione. La terra rimane, per-tanto, proprietà comune del genere umano — e ciò, nota Casadei, « fatrasparire una chiara dimensione collettiva, pubblica nel pensiero diPaine, che ridimensiona notevolmente il carattere ‘possessivo’ del suoliberalismo — e per il suo uso esclusivo il proprietario è debitore aglialtri uomini di un ‘risarcimento’, di un ‘indennizzo’ » (p. 190). Comeper i progetti di costruzione dei ponti, anche qui Paine propone unprogetto « rivoluzionario » per la sua epoca, che avrebbe potutosenz’altro segnare una strada diversa della proprietà moderna: attra-verso l’istituzione di un suffragio universale non censitario e la pre-visione di una tassazione delle eredità terriere volta a costituire unfondo nazionale si sarebbero create le basi, secondo Paine, per un veroe proprio modello di welfare. Quest’ultimo avrebbe reso possibile ilversamento a favore di ciascun individuo, che avesse compiuto ventunoanni, di una somma sociale a titolo di « indennizzo », appunto, per laperdita originaria del diritto naturale alla proprietà comune; e, oltre aciò, con il fondo sociale, sempre a titolo di « risarcimento », si sarebbepotuto soccorrere gli anziani e gli inabili al lavoro. Sullo sfondo èl’argomento della « povertà » che si staglia e che Paine intendeaffrontare e discutere pubblicamente, trattandolo — al pari della« proprietà » — come un fatto collettivo: una « visione morale dellerelazioni economiche » (p. 175) tende dunque a profilarsi nelle operepiù mature del pensatore inglese e ciò vale senz’altro a sgomberare ilcampo da alcune interpretazioni, che pure sono state avanzate, tese apresentare la figura di Paine come quella di un « radicale-borghese »o di uno « smithiano » a tutto tondo (5).
Casadei sottolinea questi passaggi — che Paine compie soprat-tutto negli scritti successivi a Common Sense, e cioè in Rights of Man ein Agrarian Justice — come indice di una « embrionale, ma decisiva,giustificazione teorica dei ‘diritti sociali’ » (p. 195); ed è un’opinione
(5) Si vedano, in tal senso, tra le altre, le letture dell’opera painiana offerte daI. KRAMNICK, Republicanism and Bourgeois Radicalism. Political Ideology in LateEighteenth-Century England and America, Ithaca-London, Cornell University Press,1990 e, per certi versi, anche da T. MAGRI, Thomas Paine e il pensiero politico dellarivoluzione borghese, saggio introduttivo a Th. Paine, I diritti dell’uomo e altri scrittipolitici, a cura di T. Magri, Roma, Editori Riuniti, 1978; per l’interpretazione delpensiero di Paine in chiave « smithiana » cfr. E.P. THOMPSON, Rivoluzione industriale eclasse operaia in Inghilterra, Milano, Il Saggiatore, 1969, p. 97 e ss. Queste letture, comenota Casadei, si soffermano in particolar modo (se non quasi esclusivamente) su operedi Paine quali Common Sense e la prima parte di Rights of Man.
QUADERNI FIORENTINI XLIV (2015)972
indubbiamente condivisibile, soprattutto alla luce, come già detto, dellainnovatività del pensiero dello scrittore inglese su questi aspetti. Ciò chedesta qualche perplessità — e che qui si propone quale motivo diriflessione e di confronto, a partire dalla stimolante lettura offerta daCasadei — è invece una criticità che proprio il tentativo, da parte diPaine, di « superare » Locke rischia di ingenerare, se non altro perchétale superamento non sembra essere effettivamente tale.
Quello che viene elaborato da Paine su questo punto può vero-similmente costituire un tentativo di risoluzione dei cosiddetti « con-flitti tra diritti »: in tal caso, i due diritti in conflitto sono quello adivenire proprietari e quello di chi è già divenuto proprietario erivendica l’esercizio del proprio diritto. La soluzione prospettata dalloscrittore inglese non pare, tuttavia, essere in grado di risolvere ilproblema alla radice: indennizzare qualcuno per la lesione di un suodiritto potenziale a divenire proprietario di un determinato bene nonfinirà mai con il porre costui nella condizione effettiva di poter acquisireed esercitare quel diritto (su quel bene). Nel caso della proprietà questacircostanza appare in tutta la sua evidenza e problematicità, ponendoperaltro in questione la validità della distinzione tra « diritti fondamen-tali » (diritto a divenire proprietari) e « diritti patrimoniali » (diritto diproprietà) (6), ovvero la dicotomia inclusive claim-rights/exclusiverights (7). D’altronde, una volta che un diritto esclusivo/escludente vengaammesso nel novero dei diritti naturali/fondamentali — seppure conmolti « accorgimenti », come sembra fare Paine — appare arduo man-tenere fondamentale anche la pretesa/diritto di quanti sono rimastiesclusi. Questa criticità potrebbe, tra l’altro, far scaturire un problemaintergenerazionale, che rende più complicato sciogliere il ‘nodo dellegenerazioni’, secondo quanto prevede, invece, il costituzionalismo pai-niano: si consideri il caso di una generazione precedente che esauriscele risorse e viola i diritti inclusivi all’appropriazione della generazionesuccessiva (questa è la sua « costituzione », fondata evidentementesull’istituto proprietario); se la generazione successiva volesse fondare lagiustizia su un criterio distributivo diverso, non avrebbe allora alcundiritto ad essere indennizzata?
In realtà, la radice del problema sembra risiedere altrove, comealtrove potrebbe pertanto risiedere la sua soluzione: l’aspetto proble-matico è costituito infatti dalla circostanza per cui l’atto trasformativo èsempre un atto proprietario (è qui che viene in ballo in tutta la sua
(6) Si tratta, come è noto, della distinzione tracciata da L. FERRAJOLI, Dirittifondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. Vitale, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 13e ss. (poi ripresa in ID., Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. I,Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 759 e ss.).
(7) Su cui si veda J. TULLY, An Approach to Political Philosophy: Locke inContexts, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
LETTURE 973
sconcertante evidenza l’argomento lockiano); non sarebbe dunque piùopportuno porre limiti alla proprietà nel momento generativo della stessa,piuttosto che in quello successivo (come risarcimento sociale)? Lo stessoLocke aveva prospettato una soluzione, prevedendo, come è noto, qualicontenuti della legge naturale le clausole del divieto di spreco e dell’ob-bligo della sufficienza; salvo, poi, tradire questi nobili intenti della suateoria con l’introduzione della moneta. Resta, tuttavia, un’indicazioneimportante: è agendo ex ante sul momento appropriativo/trasformativoche si prevengono quei problemi sperequativi e quelle disuguaglianzeeconomico-sociali che i modelli a là Paine cercano di rimuovere (o quantomeno di attutire) ex post.
Ma tutto ciò non fa che rendere ancora più attuale e « contem-poraneo » un « classico » come Paine, perché pone la sua riflessione alcentro dei dibattiti correnti, al cuore di questioni oggi discusse pubbli-camente, come quella dei beni comuni (che rappresentano, forse,proprio una delle possibilità di azione ex ante) oppure quella del basicincome, che viene puntualmente richiamata da Casadei in pagine denseed estremamente interessanti. Senza tralasciare, poi, le tematiche che atali questioni vengono inevitabilmente a legarsi, e che lo stesso Paineaveva trattato, in una interconnessione costante appunto (in un « ori-ginale intreccio », come lo definisce Casadei) dei contenuti del suoattivismo politico e dei temi delle sue riflessioni: tra questi, il ripensa-mento di un’idea di progresso, civile e materiale, della società e laproiezione su scala globale di un « governo dei diritti dell’uomo » tesoa creare le condizioni per una « fioritura » dell’essere umano e per unapace universale tra i popoli (8).
ILARIO BELLONI
ENTANGLEMENTS IN LEGAL HISTORY: CONCEPTUAL APPROACHES 1, GlobalPerspectives on Legal History, Thomas Duve (ed.), Frankfurt amMain, Max Planck Institute for European Legal History, 2014, pp.
1-568.
I contributi che compaiono nella collettanea edita da ThomasDuve sono stati presentati nel 2012 in occasione del Convegno diStudi Entanglements in Legal History. Conceptual Approaches toGlobal Legal History (Francoforte sul Meno) e della 39. DeutscherRechtshistorikertag (Lucerna), e raccolgono tutti la sfida di un nuovomodo di fare la storia
(8) All’approfondimento di queste tematiche è dedicato il capitolo conclusivo(IV) del volume di Casadei.
QUADERNI FIORENTINI XLIV (2015)974
del diritto. Si può e, forse a questo punto, si deve assumere unaprospettiva globale nella conduzione della propria indagine storiogra-fica? Ha ancora un senso porsi dei limiti spazio-temporali nell’artico-lazione di una riflessione giuridica? E quindi, si possono scrivere dellestorie del diritto transnazionali? Qual è il limite di una lettura di ritornodelle prospettive locali sulle storie globali? Come si combina il solismodella sovranità statuale e la sua proiezione internazionale con l’emer-sione e il consolidamento di nuovi attori (anche e soprattutto privati)transnazionali? Esiste un nuovo ordine giuridico da risalire e raccon-tare?
Nel suo saggio introduttivo, Thomas Duve dà le direttrici di unpercorso avviato e non concluso, riconosce l’attualità delle dinamichedel Transnational Law e, pur restando prudente sui nuovi ordininormativi, apparentemente indipendenti dal diritto statale e internazio-nale, individua come temi comuni quelli del Global Constitutionalism edel Global Legal Pluralism, e saggia i processi legati ad una RegulatoryHybridization. Gli storici del diritto non possono più ignorarlo, sarebbeimbarazzante continuare a far riferimento a studi in cui la nozione di‘stato moderno’ resta prevalente e condizionante. Un primo passo si èfatto guardando al diciannovesimo e al ventesimo secolo: l’attenzionededicata ai fenomeni ‘recettivi’ del diritto europeo in aree non-europee,alle forme di transfer piuttosto che alla dissemination di expert-knowledge e ideas, ne è una prova tangibile. Si è approdati, così, ad unadimensione ‘transnazionale’ in senso stretto, come riflessione congiuntasui nazionalismi in Europa. Ed è in questa direzione che ci si proponedi andare. « The globalization of law, and of legal thought — sottolineaDuve — is not a new phenomenon »; « the gaps and cracks » derivanodall’appuntamento mancato con i Global Studies e la Global o Tran-snational History, piuttosto che con la Legal Theory o il ComparativeLaw. Ciò che emerge è una difficoltà oggettiva di pervenire ad un lavorodi sintesi, difficoltà complicata oltretutto dall’uso indiscriminato (espesso confuso) di paradigmi comuni solo in apparenza. È necessariodunque chiedersi: « What are the methods and theories legal historiansare using to reconstruct historical processes of interaction of differentnormative orders? Why are they using these concepts and not others?What are the individual strengths and weaknesses of these methodolo-gical tools? ». La direzione in cui si muove il lavoro è appunto quella difornire nuovi spunti metodologici utili all’indagine delle dinamiche diquei normative orders frutto, in particolare, di intensi cross-bordercommunication processes. Un contributo che parte perciò dall’analisi deirisultati, per spostare l’attenzione dalla stasi al dinamismo dei processi,reinterpretando la metafora del ‘movimento’ e delle sue declinazioni discambio, comunicazione e riproduzione e, al tempo stesso, per osser-vare come le transnational legal histories sono state finora scritte. Nellaconvinzione che non esista un solo « key concept appropriate for alllegal historical research », resta l’approccio critico, il più utile a mettere
LETTURE 975
in evidenza punti di forza e debolezza della nuova riflessione sulle« entangled legal histories ». La riflessione metodologica in alcuniambiti delle scienze umane e sociali, nonché dei cultural studies, soprat-tutto in tema di indagine storiografica, è cosa abbastanza recente, comeabbastanza recente è la consapevolezza dei « pitfalls » giocati dall’ap-proccio eurocentrico-occidentalistico. Come si può smettere di proiet-tare le nostre categorie e i nostri concetti su realtà completamentedifferenti da quelle che hanno portato alla loro stessa definizione? Unquesito che non ha nulla di originale, se si considera che la Transna-tional e la Global History si sono già interrogate sui metodi comparativie sulle recenti storie di transfer, denunciandone i limiti, tutti grosso-modo individuati nei paradigmi di partenza, nelle categorie e neiconcetti d’osservazione, prevalentemente ‘europei’. Nuovi approccisono stati proposti, enfatizzando la necessità di vagliare interconnes-sioni con ‘altre’ storie, anche di remote aree del globo, che non fosseroquelle (o comunque non solo) delle periferie coloniali. « The main claim— sottolinea Duve — is that categories, periodization, epistemic foun-dations of our scholarship would have to be reconsidered, and aself-conscious, reflexive scholarship was the only way to overcome ourepistemic positionality, at least partially, in a sort of a dialectic move-ment between the images of ourselves and the others ». L’approccioproposto è quello della Verflechtung (o entanglement), « useful — diceDuve — namely to transform the matrix of inquiry [...]: entangledsituations do not offer the luxury of a single point of departure ». Sideve cominciare a ragionare di « complex intertwined networks, withno beginning and no end, and a difficulty to fix the own point ofdeparture ».
La prima sezione del volume, Traditions of Transnational LegalHistory, ripercorre risultati e difetti della tradizionale ricerca storico-giuridica sul consolidato scenario dei Postcolonial e Global Studies. InEuropean Legal History — Concepts, Methods, Challenges, ThomasDuve ritorna a mettere in forse la bontà dell’approccio tradizionaledella storia del diritto europeo. Riprende la lettura grossiana diun’« Europa del diritto » alla quale sicuramente riconoscere il meritodella definizione di una cultura giuridica autrice di uno strumentario didiritto complesso e articolato, poi promosso inevitabilmente nell’ap-proccio con l’‘altro’. Questa posizione di forza è stata messa alla provadalla Global History e dai Postcolonial Studies: la storia europea non èsolo una storia di libertà, uguaglianza e fraternità; è anche una storia diviolenza, oppressione, sottrazione. È la storia di un’ambizione egemo-nica consolidata nei secoli, è anche la storia del suo « dark side ».L’eurocentrismo è stato criticato, ridimensionato e contrastato da ra-gionamenti provincializzanti. Ecco come la storia del mondo si è potutariscrivere, sganciandola da categorie e paradigmi storiografici europeicristallizzanti. La promessa della prospettiva globale è stata quella dimigliorare la storiografia. La storia del diritto europeo ha dovuto fare i
QUADERNI FIORENTINI XLIV (2015)976
conti con questa sfida, interrogandosi su Europa e non-Europa, sull’ef-fetto di ciò che non è europeo sulla testualità giuridica europea,sull’influenza di un approccio global. La questione si complica se siconsidera che anche l’atteggiamento transnazionale della storia deldiritto è stato pesantemente criticato. A questo punto, si chiede Duve,ha senso continuare ad usare concetti e metodi maturati dalla dottrinanella convinzione dell’esistenza di una sola spazialità giuridica europea?O sarebbe più opportuno immaginare e ricostruire « entangled histo-ries »? Ecco perché è necessario verificare l’impostazione tradizionaledella storia del diritto europeo, dai suoi assunti fondanti alle sceltemetodologiche. È necessario un atteggiamento critico, di retrospettiva eprospettiva. Partendo da un’indagine sulla storia della disciplina apartire dagli anni del dopoguerra, Duve si interroga sulla storia dellastoriografia sull’Europa, per comprenderne le tradizioni che ne hannocondizionato il passo fino ad oggi. Ciò che emerge nelle storie del dirittoè intanto un percorso binario Europa/Non-Europa, ed è chiara dunquela necessità di intervenire: quello che auspica è un’apertura metodolo-gica della storia transnazionale alla prospettiva globale, con un ridimen-sionamento dell’Europa a « global region ».
Intimamente legata alla lettura, dunque, di questi ‘intrecci’ nellastoria del diritto è l’intenzione ferma di considerare la storia del diritto« as a constant diachronic and synchronic process of ‘translation’ », e diripensare le spazialità giuridiche. Dall’indagine sulla definizione di‘Europa’, dalle radici romane ed ebreo-cristiane alla sua concettualitàpiù storica che geografica, ai suoi confini ‘flessibili’, dall’ipotesi di unacultura giuridica europea alla presa di coscienza che la storia del diritto‘europea’ « is not — and cannot be — written in a single book ». Lastoria del diritto europeo si conferma come luogo dell’« interplay ofunity and diversity ». Si ritrova il motto dell’Unione, in varietateconcordia, e si ragiona sulla costruzione dell’appartenenza per parteci-pazione ai modelli tipici (come può essere stato quello codificatorio).Parlare di ‘europeizzazione del mondo’, dando credito così alle teoriediffusioniste, non può essere considerato, comunque, politicamentecorretto perché, per definizione, escluderebbe qualsiasi interconnes-sione globale e negherebbe i risultati dei dettagliati studi in materia direception, transfer o transplant. Occorre interrogarsi invece sulle originimetodologiche della storia del diritto europeo, e Duve lo fa richia-mando Weber e Toynbee, per quanto senza presunzione di esaustività.Si tratta poi di ripensare lo spazio, di parlare di aree giuridiche fluide,meglio intese come spazi transnazionali; di abilitare concetti come‘multinormatività’ o ‘traduzione culturale’. I processi di appropriazionee acculturazione di normatività in aree diverse sono stati riferiti allessico della recezione, del trapianto, del transfer, o ancora dell’ibriditàpiuttosto che del métissage, tutti termini polisemici che Duve taccia diun’illusoria concretezza operativa: « They promise explanations, butonly provide descriptions ». È da ripensare dunque il loro contributo
LETTURE 977
alla storia del diritto, senza mai rinunciare ai suoi riferimenti fondanti o,peggio, minare alla sua identità. Aprire a discorsività intra- e inter-disciplinari, significa piuttosto confrontarsi con strumentari diversi;inquadrare nuove definizioni, prima fra tutte quella di ‘multinormati-vità’; leggere il diritto come un processo continuo di traduzione cultu-rale e scegliere come punto di vista privilegiato quello del conflitto. Cosìla storia del diritto può combinarsi agli studi locali in diverse aree,analizzarli con concetti e un dizionario utile ad una comunicazioneinterculturale, e cercare di integrare i risultati in un dialogo globale sullanormatività. Questo non significa condurre tutto ad una ricerca gene-ralista: « Good ‘Global history’ is by no means total history, but thecombination of local histories, open for global perspectives ». Bisognacambiare abitudini, riflettere su metodo e teoria, lavorare con soliditàsulle fonti con gli strumenti tipici delle aree coinvolte. Sarà questol’approccio migliore per i nuovi studi di Transnational Law, che inda-gheranno « the entangled normative orders ».
L’articolo di Inge Kroppenberg e Nikolaus Lindner, Coding theNation. Codification History from a (Post-) Global Perspective, è dedi-cato ad un tema centrale della moderna storiografia giuridica, la codi-ficazione, la stessa che Wieacker definiva una « delightful possession ofthe peoples of modern Europe ». Il funzionalismo strutturale dellostesso concetto di ‘codificazione’ determina inevitabilmente un approc-cio ‘culturalista’ all’analisi giuridica. Si prenda ad esempio il casosvizzero. Esso mostra chiaramente come identità collettive e gli stessiprocessi di nation-building si siano ottenuti attraverso codici, e come,dunque, la storia della codificazione debba essere riscritta da unaprospettiva diversa, magari globale.
Un’altra analisi critica è quella offerta da Geetanjali Srikantan nelsuo Towards New Conceptual Approaches in Legal History: Rethinking“Hindu Law” through Weber’s Sociology of Religion. Dopo aver mani-festato un’eloquente insoddisfazione per l’inconsistenza e la scarsachiarezza concettuale degli approcci storiografici attuali, Srikantanriprende l’analisi critica di Gordon e le affianca quella di Frankenbergper concludere sulla necessità di reimmaginare gli studi di dirittocomparato, riesaminare le relazioni così come emergono nell’uso deiconcetti giuridici e delle categorie del legal transplant, dei transfers, deiborrowings o della diffusion, e dare nella nuova agenda della disciplinamaggior spazio allo studio delle società. Ripercorre, dunque, la storiadel transfer, in particolare, dalle intuizioni di Watson alle criticità cosìcome evidenziate da Legrand e Cotterell, e premette l’impostazione diSaid alla riflessione per cui « concepts such as ‘religion’, ‘society’ and‘community’ have to be interrogated in order to understand how theyoperate in a milieu that is different from the West ». Il punto dipartenza resta dunque utile allo studio del caso indiano. Srikantanguarda, in particolare, alla costruzione del diritto indù a partire dallametà del diciannovesimo secolo, nel momento in cui cioè l’amministra-
QUADERNI FIORENTINI XLIV (2015)978
zione coloniale inglese definiva il suo body of law, individuando nellemaglie di quel diritto molte più categorie ‘familiari’ al diritto europeo diquante non ne sapesse percepire il diritto indù stesso.
Segue l’analisi di Gerge Rodrigo Bandeira Galindo e del suo LegalTransplants between Time and Space. Muovendo dalle premesse deiPostcolonial Studies, l’autore conferma lo spazio a principio ordinante eirrinunciabile per la sua riflessione comparatistica, ma non si ferma qui.Il punto della sua indagine si sposta verso una dimensione temporale:« a legal transplant can be viewed as a collection of experiences thathappened in one legal system and are expected to be realized in thefuture in a different legal system ». In particolar modo la storia, intesacome scienza giuridica o storiografia, può disporre metodologie everifiche per comprendere al meglio i legal transplants nel doppiotempo, quello dell’experience e quell’altro dell’expectation. L’attenzionesi rivolge, dunque, agli attori del transplant, e a quell’idea di ‘progresso’e di tentate ‘prognosi’ sullo stato di salute dei sistemi donante ericevente, idea che coinvolge inevitabilmente tanto il diritto comparato,quanto la storia del diritto.
Nella seconda sezione, Empires and Law, particolare attenzioneviene rivolta ai normative frameworks così come appaiono in particolaricontesti multiculturali, eredità degli imperi ‘antichi’, ‘premoderni’ e‘moderni’, risultato comunque di processi di « diffusion and hybridi-zation » operati dagli ‘artigiani del transfer’. Il riferimento all’imperoritorna come ad una categoria destruens le storiografie nazionali, perrileggere gli spaces of governance. Il confronto con temporalità prece-denti resta comunque fondamentale. L’impero emerge come spazioformale o informale, comunque come spazio di comunicazione utileall’evoluzione del diritto.
Emiliano J. Buis, in Ancient Entanglements: The Influence ofGreek Treaties in Roman “International Law” under the Framework ofNarrative Transculturation, rilegge la complessa interazione tra dirittodei greci e sistema giuridico dei romani alla luce dei trattati, in un’otticache egli stesso definisce di « narrative transculturation ». L’osservazioneè dunque volta a veri e propri fenomeni di ‘ibridizzazione’ tra identitàdiverse, funzionali alla creazione di una « single and complex societybased on the adaptation of colliding (or complementary) perspectives ».L’idea di una narrative transculturation nasce e si sviluppa negli anniSettanta del secolo scorso, nel contesto emergente di una critica aiPostcolonial Studies, e ritorna utile a rappresentare le strategie diadattamento in contesti politici e culturali asimmetrici. Buis cita dueintellettuali latinoamericani, Ortíz e Ramas per dimostrare come il lorocontributo si sia rivelato significativo nella narrazione di storie di« entangled worlds », certo conseguenza dell’approccio global dell’im-pero spagnolo premoderno.
E rivolto all’impero spagnolo, « an empire built on law », è ancheil contributo di Ana Belem Fernández Castro. Nel suo A Transnational
LETTURE 979
Empire Built on Law: The Case of the Commercial Jurisprudence of theHouse of Trade of Seville (1583-1598), l’autrice guarda alla giurispru-denza e riconosce le radici ‘transnazionali’ del governo e della giustiziadella « composite monarchy »: la transnazionalità non deriva soltantodal contributo di più nazioni (tutte parti della monarchia spagnola), maanche e soprattutto, guardando all’attività giurisdizionale della Casa deContratación de las Indias, al servizio reso ai mercanti non cittadini diCastiglia, vale a dire dall’assorbimento di pratiche giudiziali diverse,incorporate nella cultura locale. Fernández Castro parla di una formaemergente di « world trade » che contribuì alla diffusione delle pra-tiche giudiziali europee molto al di là dei confini del Vecchio conti-nente. Il declino e la successiva implosione dell’impero spagnolo nonsolo spianarono la strada ai movimenti indipendentisti del dicianno-vesimo secolo e alla formazione dei nuovi ordinamenti giuridici na-zionali, ma anche alla ricomposizione di nuovi assetti politici e terri-toriali tra vecchie e nuove potenze europee e i nuovi protagonistiamericani.
Nel suo contributo su Entangled up in Red, White, and Blue:Spanish West Florida and the American Territory of Orleans, 1803-1810,Seán Patrick Donlan si interroga preliminarmente sulla bontà di un’ana-lisi impostata sulle entangled histories, comunque diverse da quellesemplici comparative histories che finiscono con l’ignorare importantidinamiche trans -territoriali e -nazionali, e i connessi discorsi sulleinfluenze. Impostato come un case study sull’esperienza giuridica enormativa della Florida occidentale spagnola agli inizi del diciannove-simo secolo, il saggio di Donlan non sottovaluta gli aspetti teorici legatialla costituzione dei mixed legal systems, assumendo un punto di vistatransdisciplinare che coinvolge nella riflessione il diritto comparato, lastoria del diritto, la filosofia del diritto e le scienze sociali. Si parla dihybridity, diffusion e resta forte l’approccio pluralista, devoto a dina-miche spazio-temporali ora acquisite, ora in costante cambiamento.
Il lavoro di Jakob Zollman, German Colonial Law and Compara-tive Law, 1884-1919, ripercorre l’atteggiamento ‘d’ascolto’ della Ger-mania nei confronti delle esperienze coloniali delle altre potenze suquestioni centrali nella gestione della cosa coloniale, dalle istituzioni digoverno alle categorie speciali (come quella del protettorato o, inrelazione al soggetto, del nativo), il tutto in un’ottica di diritto colonialecomparato che mette in evidenza acquisizioni e deviazioni del ‘dirittocoloniale tedesco’.
La terza sezione, Analyzing transnational law and legal scholarshipin 19th and early 20th century, è dedicata più dettagliatamente ai casestudies. Guardando al diritto transnazionale e alla dottrina giuridica tradiciannovesimo e ventesimo secolo, il diritto comparato emerge a« natural practice », acquisita nei processi di osservazione, imitazione,traslazione, anche negli studi sulla formazione degli ordinamenti giuri-dici, nazionali e internazionali. Il mondo stava cambiando. Aumenta-
QUADERNI FIORENTINI XLIV (2015)980
vano i contatti internazionali, il vero volano della creazione di quella« global knowledge » nel campo del diritto. In Europa, ma non solo, siregistrava un incremento dell’attività legislativa che raccoglieva tutte leesperienze ed eredità, anche coloniali, del passato, combinandole aspecifici percorsi in ambito economico, sociale e politico. Una trasfor-mazione epocale, dunque, determinata anche dal peso delle migrazionidei gruppi elitari il giorno dopo le rivoluzioni e (da non trascurare) delleinnovazioni della tecnica, con la conseguente maggiore velocità discambio delle informazioni. Ordinamenti dapprima esclusi, o comun-que, fuori portata come il Giappone o la Cina, intensificavano la lorocomunicazione transnazionale grazie ai processi di law-making, all’os-servazione, ai viaggi, alla mediazione diplomatica, allo scambio dioggetti, informazioni e libri. Guardando ora ai case studies, ora all’emer-gere di una comunità scientifica transnazionale, i contributi dell’ultimasezione vanno a indagare come queste storie di cambiamento siano statescritte. Nel saggio di Francisco J. Andrés Santos, Napoleon in America?,per esempio, si guarda al ‘viaggio’ del codice civile napoleonico inAmerica latina dal punto di vista europeo. La scommessa che giuristi epolitici dovettero affrontare in quel momento fu quella della scarsapreparazione e delle grandi responsabilità. Era necessaria una certaversatilità d’azione in ambito politico, economico e diplomatico. Ilprocesso codificatorio in America latina viene ricostruito nell’ambito diuna complessa ed eterogenea situazione politica: sicuramente il codiceportò (e in breve) una serie di benefici, sia sul piano linguistico, chetecnico-giuridico, causa il profondo senso di ammirazione nei confrontidi Napoleone e del suo progetto codificatorio, considerato di granprestigio. Questo giustificava le due ondate d’approccio alla codifica-zione, meramente di traduzione la prima, più maturo e consapevolequello della seconda, a ridosso del quale è più facile azzardare ilriferimento ad una fusione tra la tradizione spagnola e il modellofrancese.
Nell’articolo di Agustín Parise, Libraries of Civil Codes as Mirrorsof Normative Transfers from Europe to the Americas: The Experiences ofLorimier in Quebec (1871-1890) and Varela in Argentina (1873-1875), inuna « veneration of the words » del diritto scritto, si continua a parlaredi codificazione nelle Americhe. Particolare attenzione è rivolta aiprocessi di comparazione, traduzione e adozione di soluzioni normativeper la codificazione del diritto civile, nonché al ruolo determinante deigiuristi negli studi preparatori, preziosi nell’operazione che Parisedefinisce di bricolage di pezzi europei e latinoamericani utili alla costru-zione dei codici nazionali. Il contributo pone in risalto il lavoro di duegiuristi, de Lorimier e Varela, che, in luoghi diversi, Quebec e Argen-tina, e negli anni Settanta dell’Ottocento, ricostruiscono l’apparato difonti formali di diversa natura e origine sulla codificazione, libraries dicodici civili che funzionano un po’ a « mirror of normative transfers »,
LETTURE 981
specchi cioè, capaci di restituire « a true description of somethingelse ».
Eduardo Zimmermann, in Translations of the “American Model”in Nineteenth Century Argentina: Constitutional Culture as a GlobalLegal Entanglement, continua il percorso latinoamericano guardandoalla costruzione del diritto argentino e al dialogo transnazionale incampo costituzionale, e ricostruisce la produzione letteraria degli ‘arti-giani del transfer’ in termini di traduzioni e manuali, tutti testimoni diuna graduale acquisizione del linguaggio del costituzionalismo liberalee, di conseguenza, di una cultura costituzionale frutto dell’incontro delmodello originale con i tanti adattamenti e interpretazioni prodotti daitraduttori locali. Mosso dalla convinzione per cui « exchange is notlinear, but a complex, process of knowledge creation brought intobeing by international networks, communication processes as well aslocal conditions », Zimmermann arriva a ricreare il mondo in cui questimodelli vengono letti, interpretati e trasformati in America, non man-cando di sottolineare lo ‘spirito’ del giurista argentino, frutto di quel« global legal entanglement », così come vien fuori dalle traduzionipiuttosto che dai manuali, e di proporre lo studio del costituzionalismolatinoamericano come utile a denazionalizzare la prospettiva storica diogni paese.
Stesso approccio si ritrova nel contributo di Bram Delbecke, chein Modern Constitutionalism and Legal Transfer: The Political Offence inthe French Charte Constitutionnelle (1830) and the Belgian Constitution(1831) mette in dialogo le storie del costituzionalismo belga e francese.Il costituzionalismo moderno è assunto a « the most important elementin recent history of public law ». Il transfer del modello costituzionalefranco-belga apre e guida l’impostazione del caso studio e prova afornire un’interpretazione del costituzionalismo moderno nell’ambitodi una storia globale che, senza tagliare fuori la ‘vecchia storia delcontinente’, non si limiti semplicemente ad evidenziare i punti dicontatto tra una costituzione ed un’altra, ma provi ad individuarne edenfatizzarne le differenze, guardando soprattutto al rapporto tra societàcivile e istituzioni politiche.
Il saggio di Lea Heimbeck, Discovering Legal Silence: GlobalLegal History and the Liquidation of State Bankruptcies (1854-1907),partendo dall’assunto per cui la storia del diritto globale offre diversistrumenti per affrontare lo studio di questioni cross-border, propone iltema della liquidazione degli stati in bancarotta tra diciannovesimo eventesimo secolo, tema ignorato dalla storiografia giusinternazionali-stica, se non per alcune sporadiche riflessioni di autori cittadini di staticreditori europei (Gran Bretagna, Francia, Germania). Ecco la ragionedella necessità di usare una storia del diritto globale, nota Heimbeck,partendo dai casi studio dell’Impero ottomano, dell’Egitto e del Vene-zuela (tutti stati debitori non-europei), e dall’evidenza di un limite,quello dell’approccio eurocentrico della riflessione sul tema del debito
QUADERNI FIORENTINI XLIV (2015)982
pubblico. Guardando al diciannovesimo secolo, in particolare, unprimo ostacolo all’analisi fu sicuramente la difficoltà da parte del dirittointernazionale di riconoscere il problema dei fallimenti (sensibilmenteeconomico) come interno alla disciplina e, allo stesso tempo, la volontàchiara e precisa dei governi di conservare una certa libertà d’azione neiconfronti degli stati debitori. Cosa decidere e come comportarsi era edoveva rimanere una prerogativa dello stato, rimessa alla valutazionedel singolo caso, e comportava l’azione politica o militare. Questodemotivava l’impegno della giusinternazionalistica. Nel tempo poi,l’assenza di una riflessione globale, ha finito col lasciare scoperto iltema. Resta ora l’urgenza di uno studio che non si limiti ad unaprospettiva statocentrica, e che finalmente superi questo « blind spot »nel diritto internazionale.
E di superare le tradizionali storie del diritto internazionale diprospettiva statocentrica dice anche Clara Kemme nel suo The Historyof European International Law from a Global Perspective: Entanglementsin Eighteenth and Nineteenth Century India. Il lavoro ripercorre lastoria del diritto internazionale come diritto degli stati sovrani (e civili)d’area euro-americana. Facendo sua la tesi di Becker Lorca, Kemmeabilita l’appropriazione a atteggiamento utile e necessario ad unauniversalizzazione della disciplina, a partire dal ventesimo secolo. Il suosguardo è rivolto all’India, abitualmente marginalizzata dal dirittointernazionale, al suo percorso d’adozione del diritto internazionaleeuropeo e a come esso è stato finalizzato. La linea è dunque quella diritenere indispensabile ai fini della costruzione di una prospettivaglobale della storia del diritto l’attenzione alle prassi locali, utile aregionalizzare e, dunque, ridimensionare, l’approccio eurocentrico deldiritto internazionale. Da una prospettiva asiatica, prima dell’egemoniaeuropea, le interazioni tra realtà politiche erano regolate tenendo fedead una specifica visione del mondo, dove ad avere la meglio erano ildiritto internazionale islamico, quello indù e quello confuciano. Indi-viduato un altro nervo scoperto della storia del diritto internazionale,quello relativo ai primi processi di partecipazione del diritto interna-zionale europeo ai sistemi giuridici locali in Asia, Kemme ricostruiscequesta fase delle origini del controllo britannico sugli stati indiani finoalla loro sostituzione con un nuovo sistema regionale, ed evidenzia lecaratteristiche del periodo di transizione monopolizzato dal ruolomediano della East India Company.
Del rapporto tra « globalizing models » e traduzioni locali tieneconto anche il contributo di Michele Pifferi a proposito di GlobalCriminology and National Tradition: The Impact of Reform Movementson Criminal Systems at the Beginning of the 20th Century, nel momentoin cui si potevano apprezzare le prerogative scientifiche di uno specia-lismo che condivideva la dimensione globale perché fondato sull’idea diuna conoscenza scientifica progressiva e universale, ma differentementeapplicata in differenti contesti. Nell’assunto della « global dimension »,
LETTURE 983
riconoscere le diverse mentalità, assieme al diritto costituzionale e alletradizioni del pensiero giuridico, contribuisce infatti al processo didifferenziazione e formazione delle peculiarità nazionali in campocriminologico, specie nei primi decenni del ventesimo secolo. Ancorauna volta, uno studio sulla dimensione transnazionale del diritto finisce,come attraverso un prisma, col proiettare storie locali su storie globalie con l’ammettere il bisogno di una maggiore consapevolezza delletraduzioni di questa circolazione di idee e modelli.
ELIANA AUGUSTI
PARADOXES OF PEACE IN NINETEENTH CENTURY EUROPE, edited by ThomasHippler, Miloš Vec, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp.
304.
La rappresentazione dell’allegoria della guerra e della pacerealizzata dall’artista americano Adam Rake incornicia il volume,riassumendo visivamente e anche con molta efficacia il suo conte-nuto: quando la pace è guerra e quando la guerra è pace. Dueconcetti opposti, antitetici, pericolosamente interscambiabili e inti-mamente attratti, attorno ai quali la storia dell’uomo ha costruito lasua intera esistenza.
In una società in cui oggigiorno domina costantemente unabuso della terminologia « pace » tanto nelle relazioni umanequanto a livello internazionale e in cui si assiste alla mistificazione diessa, attraverso cieche logiche di mercato e politiche, spesso nascostedietro le sembianze di estremismi religiosi, etnici e culturali, ènecessario un approccio storico che (ri)costruisca in modo critico,metodologicamente corretto e preciso, un aspetto della storia chespesso si preferisce non vedere o rilegare nel silenzio.
Thomas Hippler e Miloš Vec offrono in questo senso un’ana-lisi dettagliata, privilegiando sfaccettature, intrecci e zone d’ombradel XIX secolo, per cui la pace, in modo paradossale, molto spessosignificava qualcosa d’altro. La ricerca è articolata sullo studio dellerelazioni tra la pace e i concetti cardine dell’Europa ottocentesca,quali la sovranità, l’umanità, l’impero, la civiltà, la cristianità e ilcolonialismo.
Se è vero che « raccontare la storia della guerra e della pace inbianco e nero è, sul piano teorico, non solo discutibile, ma sempli-cemente sbagliato », allora si potrà senz’altro affermare che essadebba essere sempre contestualizzata, storicizzata a livello europeo eanche a livello globale (p. 10). L’esigenza di fare chiarezza sulla pacecome « concetto polemico » riveste un profondo significato cheaffonda la sue radici nella storia dell’umanità e nella storia delconcetto stesso. La
QUADERNI FIORENTINI XLIV (2015)984
storia della pace ha i suoi limiti perché tende ad essere a-storicizzata,idealizzata e privata di qualsiasi quadro storico, culturale e sociale.Infatti, il rischio che si corre è quello di scrivere una storia in cui la paceabbia una sola definizione, con analoghe caratteristiche nel tempo enello spazio.
L’obiettivo del libro è, invece, quello di discostarsi dal presup-posto che esista « la pace » come entità stabile, fissa, duratura eimmutabile, al contrario, guerra e pace si relazionano necessariamentel’una all’altra in un rapporto instabile e conflittuale. La pace, comeargomentato dai curatori, è un « valore qualificato », identificato in unadeterminata forma, che implica una stretta connessione con l’ordinenazionale e internazionale, entrambi a loro volta legati. Ed è per questomotivo che i vari contributi all’interno del testo si calano nella realtàdell’Ottocento, attraverso uno studio che contestualizza la terminolo-gia, l’uso e la sua concreta applicazione. Nel XIX secolo si assiste ad unnumeroso panorama di norme sociali, giuridiche, politiche che deli-neano una propria rappresentazione della pace; vi sono una pluralità diattori che ne definiscono la portata; valori per i quali debba essere« esportata » e questioni economiche che prendono le sembianze dellapace.
Quattro sono, dunque, le macroaree su cui si snoda l’indagine.La prima area è dedicata al diritto internazionale, al ruolo rive-
stito dagli avvocati internazionalisti per la definizione della pace, per itentativi di codificazione ottocenteschi e per la concreta attuazione degliarbitrati internazionali. I saggi presenti mettono in rilievo quantolontane fossero le elaborazioni teoriche rispetto alle esigenze che veni-vano avvertite dall’opinione pubblica, sia riguardo alla pace sia riguardoalla guerra.
Miloš Vec, utilizzando come fonti principali le enciclopediepolitiche e giuridiche pubblicate nell’Ottocento in Germania, in Fran-cia e in Italia, illustra la drastica riduzione del termine pace alla solasfera delle relazioni e dei trattati internazionali. Ciò che viene dimo-strato è la mancanza di una filosofia della pace all’interno della correnteprincipale del diritto internazionale e, al tempo stesso, la constatazioneche essa non fosse un concetto chiave su cui si fondavano i sistemigiuridici internazionali. Viceversa, non vi era alcuna interdizione gene-rale della forza, che era vista come naturale e proveniente dai principidel dogma della sovranità. L’influenza, tuttavia, della dottrina kantianacontribuì alla creazione di specifiche voci all’interno delle enciclopediegiuridiche dedicate alla pace perpetua e alla combinazione della stessacon la pace. Il risultato di queste posizioni è stato l’emergere di undualismo: la « pace » rientrante all’interno del diritto positivo e deldiritto internazionale e la « pace perpetua » legata, invece, alla filosofiadel diritto, al diritto naturale e alla teoria del diritto. Il riduzionismo el’unilateralità della pace incontrarono un limite quando gli internazio-nalisti si resero conto che la loro formulazione non rispondeva alle
LETTURE 985
esigenze avvertite dal crescente dibattito pubblico: è stato solo allorache gli avvocati stessi hanno iniziato ad impegnarsi in moltepliciprogrammi e ciò che « had seemed impossible for the formalistic juristsof the early nineteenth century had thus become an option for inter-national lawyers around 1900-peace as a juridical ‘justification narrative’for imperialism and aggression in international law » (p. 36).
La codificazione è stato un segno distintivo durante tutto il corsodel XIX secolo e cercò di coinvolgere, seppur in ritardo rispetto allealtre discipline, anche il diritto internazionale. Gli avvocati internazio-nalisti intravidero nel codice e nella risoluzione delle controversietramite l’arbitrato, specifici strumenti per realizzare e costruire la paceall’interno delle relazioni internazionali. I limiti, le debolezze e gliaspetti critici di un codice di diritto internazionale sono analizzati daEliana Augusti, la quale si concentra sull’apporto italiano, mettendo inrilievo luci e ombre della disciplina internazionalistica. Partendo dalleriflessioni elaborate da Jeremy Bentham in Principles of InternationalLaw, vengono presi in considerazione i primi progetti di codice elabo-rati da Lorenzo Collini, Augusto Paroldo, Pasquale Fiore e GirolamoInternoscia. Mentre la situazione europea a livello politico, geografico,sociale e nazionale lungo il corso dell’Ottocento assumeva connotatatidifferenti, il diritto internazionale si allontanava sempre più dal dirittonaturale e dalla diplomazia, aspirando alla sua più completa professio-nalizzazione e scientifizzazione. L’Autrice, all’interno di questo com-plesso contesto, esamina le problematiche inerenti ai tentativi di codi-ficazione, che si inseriscono in una ottica molto particolare, perchéaccanto alle istanze positivistiche che emergevano nel diritto interna-zionale, bisognava tener conto anche del carattere universale delladisciplina e delle relative peculiarità.
Il contributo di Kristina Lovrić-Pernak ha invece ad oggettol’arbitrato internazionale, il problema della sua attuazione e dell’im-posizioni di sanzioni internazionali. In modo particolare la ricerca sisnoda su due aspetti specifici presenti nella dottrina internazionalisticadel XIX secolo: in primo luogo viene analizzato in che modo l’istitu-zionalizzazione dottrinale dell’arbitrato abbia conseguentemente por-tato all’inclusione della guerra, per cui si realizzava la corrispondenza(quasi matematica) del fine identificato nella pace e della sanzioneindividuata nella guerra. In secondo luogo viene illustrato quanto lacrescente giustificazione giuridica dell’arbitrato e la necessità dellesanzioni fossero dettate da norme che dipendevano dalla morale. Ladottrina rappresentata da diversi autori quali, ad esempio, CarlosCalvo, Edouard Eugène François Descamp, Heinrich Lammasch, siserviva, al fine di rivendicare l’autorità dell’arbitrato internazionale neiconfronti degli stati, argomenti legati squisitamente ai modelli natu-ralistici della moralità. Il paradosso che si realizza è l’affermazione dellacomunità internazionale, in cui la guerra non solo era un ulteriore
QUADERNI FIORENTINI XLIV (2015)986
mezzo della politica, ma era il mezzo risolutore per il perseguimentodi obiettivi pacifici.
La seconda macroarea del volume è dedicata all’economia. Leposizioni di Adam Smith, di Friedrich List ed alcuni aspetti della paceanche all’interno commercio internazionale sono al centro del saggio diThomas Hopkins, il quale, dopo una introduzione sulle teorie econo-miche tra la fine del XVIII e il XIX secolo e, in particolare, sul pensierodi Constant, si sofferma sulle sostanziali differenze tra i due celebrieconomisti, illustrandone il loro impatto all’interno della comunitàinternazionale. L’investigazione si concentra sugli sviluppi del commer-cio internazionale attraverso la visione di Adam Smith riguardo all’-economia cosmopolitica o universale e quella di List sull’economiapolitica o nazionale. Il liberismo economico, teorizzato da Smith, venivaconsiderato da List come uno strumento di dominio dei paesi indu-strializzati su quelli più arretrati. Solo attraverso un intervento prote-zionistico dello stato anche i paesi più in difficoltà avrebbero potutoaffrontare la prima fase dell’industrializzazione, al riparo della concor-renza straniera. Per List, infatti, gli stati che non avessero ancoraraggiunto la piena efficienza industriale, avrebbero dovuto difendersidalla concorrenza mediante dazi protettivi, e soltanto dopo aver con-seguito questo intento avrebbero potuto, senza pericolo, adottare unlibero scambio che realizzasse l’ideale economico del maggiore benes-sere. Al tempo stesso questa posizione conservava però un paradossonei riguardi della pace perché « it would not lead to a world in whichtrade negated international rivalries, but rather reshaped them, andwith them the very form and purpose of the state. The future may notbelong to the nation states of List’s imagination, but the difficulties ofintegrating unequally situated states into international trade regimesremain as a potent challenge to the political imagination » (p. 91).
Con Niels P. Petersson la ricerca si sposta, in prospettiva europea,verso il libero commercio nell’economia globalizzata. Uno degli argo-menti principali del pensiero liberale e radicale dell’Ottocento erafondato sulla stretta connessione tra il libero commercio e la paceinternazionale. Nonostante alla fine del XIX secolo si fosse assistito allaglobalizzazione dell’economia internazionale e all’intenso sviluppo dellacomunità internazionale, il collegamento tra il libero scambio e lerelazioni internazionali era diventato progressivamente sempre menosemplice. Partendo da queste premesse, l’Autore illustra alcune teoriestoriche e attuali che collegano il libero scambio alla pace, analizza latensione tra geopolitica e diritto internazionale e le diverse concezionidi stati, mercati e la loro dinamica controversa. Ampio spazio è dedicatoalla disamina di concreti esempi del binomio « pace e commercio », incui emergono i rapporti ambivalenti tra l’imperialismo e i contraccolpiprotezionistici, tra la globalizzazione economica e le diverse teoriesull’interazione tra il potere statale e il commercio nell’età del naziona-
LETTURE 987
lismo. In alcuni casi, infatti, il libero commercio diventava un motivo diconflitto armato, piuttosto che un rimedio contro la guerra.
Debiti statali e insolvenza sovrana sono analizzati da Lea Heim-beck, la quale sottolinea come la relazione tra queste due patologieabbia costituito la creazione di una idea di pace contradditoria e piùincline all’intensificazione del potere e della forza. Durante i secoli XIXe XX, l’aumento dei default statali era direttamente proporzionale alcrescente numero di transazioni commerciali internazionali. L’assenzadi una precisa normativa nel diritto internazionale era causata dalmancato riconoscimento da parte dei giuristi dell’istituto dell’insol-venza sovrana, che, rilegato alla sfera squisitamente economica, nontrovava spazio all’interno del diritto internazionale. Di conseguenza siregistrava una flessibilità per quanto riguarda la regolamentazione delletransazioni finanziarie e la decisione sulla gestione delle insolvenzesovrane. Gli stati creditori spesso utilizzavano diverse forme di rappre-saglia e talvolta, paradossalmente, fecero ricorso alla forza e agli occhidella comunità internazionale: « New problems arising out of cross-border financial relations did not simply pacify state relations or fosterpower structures. In fact, they did both: yet, they did not lead to eitherthe one or the other result but to both consequences at the sametime-they constituted each other. Hence, such financial transactionsand the measures dealing with their failure were Janus-faced, forming aparadox of peace » (p. 127).
La terza sezione è dedicata agli attori dell’Ottocento, coloro chehanno costruito e agito all’interno del panorama internazionale: ilConcerto europeo, la Santa Alleanza, i Congressi di Pace di Parigi del1849 e di Ginevra 1867, le associazioni pacifiste e il Consiglio interna-zionale delle donne. Matthias Schulz delinea come a seguito delleguerre napoleoniche, l’ordine egemonico delle grandi potenze europeeabbia associato e ricondotto la pace ad una sorta di codice accettabileper un’ampia maggioranza di attori statali. L’analisi che viene propostasi articola attraverso una disamina storica e politica del Concertoeuropeo e del suo ruolo per il mantenimento della pace. Esso, infatti, siponeva contro l’egemonia e l’aggressione e a favore della protezionedegli stati più piccoli. Tuttavia il Concerto agiva da un lato per ragioniinerenti alle ambizioni politiche e alle rivalità statali e dall’altro avevacome scopo la tutela e la responsabilità degli stati stessi. Ben presto,però, si svilupparono fini che non erano visibili immediatamente: ilConcerto sostenne, per motivi strategici, cause apparentemente umani-tarie, diventando successivamente uno strumento per le mire imperia-listiche ed espansionistiche in nome della missione civilizzatrice euro-pea.
La ricostruzione della Santa Alleanza effettuata da Adrian Brisku,dà rilievo ad elementi ideologici, laici e religiosi che s’intrecciano con lelogiche di potere, facendo emergere il vero carattere nascosto dietrol’obiettivo del mantenimento di una pace duratura. L’Autore articola il
QUADERNI FIORENTINI XLIV (2015)988
saggio attraverso uno studio che coinvolge una pluralità di livelli, tenutiinsieme dal fine della pace. La Santa Alleanza, infatti, intesa comeprogetto di pace in Europa, basata sull’unità e sulla solidarietà cristiana,era paradossale, alla luce soprattutto dell’esperienza storica europea edelle reali mire espansionistiche che gli stati dell’epoca conservavano.Senza dubbio, essa è stata anche un’articolazione suggestiva di inten-zioni, ambizioni, potere geopolitico della Russia con gli altri firmatari.Combinando strategicamente vocaboli laici e religiosi, i termini, imetodi liberali e reazionari, il progetto di pace della Santa Alleanzadello zar Alessandro I, si palesava nella sua interezza come una sorta di« isola » attraente sia per l’impulso di autoconservazione, sia per quelloegemonico.
Il desiderio della pace non veniva tuttavia solo sentito a livellointernazionale, ma anche a livello di associazionismo civile e di mani-festazioni pacifiste. Tuttavia l’attivo impegno per pace assumeva rilievimolto singolari. Nel XIX secolo si è assistito, come dimostra ThomasHippler, ad un vigoroso movimento transnazionale di pacifismo liberaleche ha generato il grande paradosso della guerra contro i nemici dellademocrazia. Prendendo in considerazione la formazione delle primeassociazioni pacifiste, i congressi per la difesa della pace, quale in primisil Congresso di Pace di Parigi del 1849 e quello di Ginevra del 1867,l’Autore mette in relazione quanto il principio di nazionalità abbiainfluenzato il concetto di pace stessa, per poi divenire progressivamentesostituito dal principio democratico. Ciò significa che nel corso dell’O-ttocento all’interno della nozione di democrazia vi erano aspetti tipica-mente riconducibili e riferibili alla nazione, ma al tempo stesso sigenerava un concetto pace legato al tema della persona singola, alle suecapacità morali e intellettuali, alla ragione e alle sue aspirazioni naturali,politiche ed economiche. Gli obiettivi dei movimenti pacifisti liberali,per arginare la drammaticità della guerra, si trovano così ben riassuntinel motto di Charles Lemonnier secondo cui la pace nasceva dallalibertà e la libertà dall’istruzione.
La pace investigata attraverso le logiche di inclusione ed esclu-sione delle donne nell’Ottocento è il tema del saggio di Susan Zimmer-mann, la quale illustra e sviluppa i passaggi che hanno portato allafondazione nel 1888 a Washington dell’International Women’s Council,con l’obiettivo di sostenere gli interessi femminili in tutti i campi dellavita associata. L’investigazione predilige la ricostruzione di « some ofthe silences, recurrent discursive strategies, tensions, and conflicts in thepeace work and the institutional policies of the ICW » (p. 213). Il ruolodelle donne, infatti, all’interno della società si intreccia inevitabilmentecon i concetti di pace e di guerra che vengono dall’Autrice approfonditiattraverso la partecipazione attiva delle donne nei movimenti pacifisti.Questa presa di coscienza aveva un duplice impatto: a livello interna-zionale come eco della presenza delle donne nelle dinamiche politichee a livello nazionale per far sentire la propria voce nei complicati
LETTURE 989
meccanismi e dinamiche relative « al genere » nei differenti contestistatali.
La quarta macroarea si rivolge ai valori della civilizzazione cherisultavano essere un fertilissimo terreno per l’esportazione della pace eper la realizzazione di un fine squisitamente coloniale. In quest’ultimasezione sono presenti contributi che analizzano molteplici aspetti delrapporto tra l’Europa e il resto del mondo quali: il concetto di « bar-baro », la missione civilizzatrice europea e americana, le complicaterelazioni tra la religione, gli aspetti culturali e il diritto internazionale.Oliver Eberl, ricostruisce la figura dei « barbari » attraverso un excursusstorico-filosofico che inizia dell’antica Grecia. Nello specifico vienepresa in considerazione la posizione di Aristotele, secondo cui i barbarisono « schiavi di natura », sino ad arrivare alle teorie di Adam Smith eAdam Ferguson, allo sviluppo del termine « civilizzazione », dedicandoampio spazio alla posizione di John Stuart Mill, alle sue riflessioni sulladominazione coloniale e sul diritto internazionale. Lo studio prende inconsiderazione il cosiddetto Indian Removal Act degli Stati Uniti d’A-merica, che venne emanato nel 1830, con il preciso scopo di perseguireuna pacifica missione civilizzatrice attraverso l’espropriazione dellaterra, il trasferimento forzato degli indiani dalle regioni sudorientalidegli Stati Uniti verso quelle meno ospitali dell’Ovest e di conseguenzala progressiva sistemazione dei nativi nelle riserve.
L’obiettivo del saggio di Stefan Kroll è, invece, di indagare sulpassaggio tra il diritto naturale e la positivizzazione del diritto interna-zionale nell’Ottocento, illustrando il vivo dibattito che nasceva attornoalla percezione, da parte degli avvocati internazionalisti, della disciplinaintesa come positiva e la natura ibrida delle dottrine giuridiche. Conl’espressione « guerre culturali » l’Autore chiarisce la tensione tra le dueepistemologie legali, dimostrando che il conflitto tra il diritto naturale eil diritto positivo non fosse un dibattito puramente giuridico, ma fosseincorporato nella controversia più ampia riguardante lo scontro tra igoverni liberali-protestanti e la Chiesa cattolica. Successivamente laricerca si articola sull’analisi del cambiamento del modello del dirittointernazionale nel momento in cui si sono instaurate le relazioni tral’Europa e gli stati non-Europei, argomentando che dinnanzi alla sfidadi integrare i rapporti giuridici per le società non europee, gli interna-zionalisti, nel loro pensiero giuridico squisitamente eurocentrico, pre-ferirono ripiegare su identità culturali e religiose, invece di confidare nelloro impegno positivista. Lo studio privilegia le posizioni della dottrinadel diritto internazionale e le logiche politiche e imperialistiche dell’Eu-ropa dell’Ottocento, per mettere in evidenza tutte le profonde e strut-turali contraddizioni del missione civilizzatrice europea.
I complessi rapporti tra l’Impero Ottomano e l’Europa sonostudiati da Mustafa Aksakal, il quale ripercorre l’iter che ha condotto laSublime Porta a conformarsi progressivamente sempre più ai canonieuropei, al fine di partecipare al mantenimento della pace internazio-
QUADERNI FIORENTINI XLIV (2015)990
nale, sino ad arrivare alla costituzione della forma repubblicana neiprimi anni del Novecento. Il meccanismo adottato dall’Impero rispon-deva ad una sorta di « europeizzazione » che coinvolse diversi settori:militare, educativo, legislativo, culturale e amministrativo. Tuttavia ilprocesso fu attuato con l’uso della militarizzazione e dell’islamizzazionecome rimedi politici forzati, contribuendo così alla formazione di unostato molto più centralizzato. Attraverso tale sistema l’Impero Otto-mano entrava a far parte del Concerto europeo: « Only once the empirehad participated in an internationally sanctioned population exchangeand transformed itself into an ethnically homogeneous, European-stylenation state, was it permitted to reassert its sovereignty and indepen-dence as the Republic of Turkey and become part of the internationalsystem » (p. 257).
Questo viaggio all’interno del concetto pace nell’Ottocento, cheha visto coinvolte diverse sfere quale quella politica, internazionale,sociale, culturale, religiosa si conclude con le lucide riflessioni di BoStråth. La sua analisi prende in esame il concetto di pace perpetua nellasua multiforme veste ironica, utopica e politica. L’Autore, partendo daiprogetti di pace settecenteschi, tra cui quello dell’abate Saint-Pierre, sisofferma sul pensiero kantiano per poi illustrare le contraddizioniottocentesche, dove i congressi di pace dell’Aia nel 1899 e nel 1907hanno rappresentato l’acme del progetto del diritto internazionale e deltentativo degli internazionalisti di « canalizzare il sogno utopico di paceall’interno di direzioni pragmatiche » (p. 281). La storia del XX secoloinsegna quanto tali intenzioni abbiano, invece, dovuto scontrarsi con unpanorama internazionale ben diverso che ha portato drasticamenteall’instaurazione dei totalitarismi e al drammatico epilogo dei dueconflitti mondiali.
Il richiamo a George Orwell, al suo 1984 e ad uno dei tre celebrislogan del Socing, « la guerra è pace » è calzante e racchiude perfetta-mente l’obiettivo fondante del volume. I differenti contributi che danumerosi punti di vista, tematiche e argomentazioni indagano sullecomplesse relazioni e sui reali significati attribuibili alla « pace » nel-l’Ottocento, sono un terreno fertilissimo per aprire un dialogo sullacontestualizzazione storica della pace e sugli incredibili significati cheessa può assumere. La pace è simile ad un prisma dalle innumerevolisfaccettature che si infrange nei molteplici e contradditori intrecci tantonazionali quanto internazionali, e riflette la realtà dinamica dell’uomo,per cui essa si genera, si costruisce e assume determinati valori econtenuti in ogni stagione e civiltà umana.
ELISABETTA FIOCCHI MALASPINA
LETTURE 991