Studio tecno-funzionale dei supporti a morfologia triangolare dell’US 8 del Riparo...
Transcript of Studio tecno-funzionale dei supporti a morfologia triangolare dell’US 8 del Riparo...
Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria
Rivista di scienzepreistoriche
fondata da Paolo Graziosi
LXI - 2011 - Firenze
00_pagine editoriali_Layout 1 28/12/11 14.28 Pagina 1
Rivista di Scienze Preistoriche - lXi - 2011, 5-20
AnnAmARiA RonchiTElli(1) - mARGhERiTA FREGUGliA(1) - lAURA lonGo(2) -ADRiAnA moRoni lAnFREDini(2) - FilomEnA RAnAlDo(2)
Studio tecno-funzionale dei supporti a morfologia triangolaredell’US 8 del Riparo l’oscurusciuto (Ginosa - Taranto)
SUmmARY - TEcno-FUncTionAl AnAlYSiS oF TRiAnGUlAR ToolS FRom lAYER 8 oF ThE oScURUSciUTo
Rock ShElTER (GinoSA, TARAnTo - SoUThERn iTAlY) - Data from many middle Paleolithic sites demon-strate that neanderthals were able to hunt a wide range of preys and that they could use regular huntingstrategies to capture also medium and large - sized animals, perhaps by killing them at a distance. in addi-tion to the evidence of faunistic remains and of the high meat-intake diet observed by biochemical analysis,this assertion is based on the discovery of wooden javelins and thrusting spears in German and Englishmiddle Pleistocene sites. more recently scholars’ interest has been on functional interpretation of lithicpoints of the middle Paleolithic and the middle Stone Age and on their performance if used as spear points.These studies are especially based on morphometric (“ballistic”), residue (presence of adhesives for haft-ing) and use - wear (mainly impact scars) analyses.This paper focuses on 107 points and general triangular tools from US 8 of the oscurusciuto rock shelter aspart of a wider project on spear point technology related to some lithic assemblages of the middle Pale-olithic of Southern italy (castelcivita cave and oscurusciuto Shelter), which has been financed by istitutoitaliano di Preistoria e Protostoria. The shelter opens on the northern side of a ravine in mesozoic limestoneunderlying Quaternary calcarenites and has accumulated more than 5 m of deposits, consisting of siltysands with stone artefacts and bone remains. The ongoing excavations began in 1998 and are being carriedout by the Department of Environmental Sciences “G. Sarfatti” of the University of Siena, in co-operationwith the Archaeological office of Puglia, the city of Ginosa and the local division of legambiente.Artifacts were at first analysed from a technological perspective; six groups (technological categories) havebeen identified based on different core reduction systems: A) convergent Levallois products; B) unipolar re-current Levallois products; c) high transformation degree products; D) pseudolevallois blanks obtainedfrom Levallois débitage; E) volume débitage products; F) on - edge débitage products. Some flakes (n. 14)belonging to the first group have features in common: they are unretouched, smaller, shorter and broader,with maximum length at the base. Groups B, c and E contain only deeply retouched tools. Basal thinning isalways absent. Further observations underline the presence of two techno functional main groups. The firstone can be identified with the A category and it is the only one which produces triangular tools directly dur-ing the reduction stage. in the second group the triangular shape is, on the other hand, due to the retouchingprocess and elongated convex and/or concave cutting edges are pursued. The macro wear and micro wearanalysis have shown that use - wear traces are on the whole seldom present and broken tips are vary rareand not very characteristic; nevertheless tip fractures are described and taken into account. other criteriahave been considered so we may test whether the US 8 triangular tools (or same of them) could be effectiveas spear points. These criteria included mass, cross-sectional area (TcSA) and perimeter, tip penetrating an-gle and length / width ratio.
(1) Unità di Ricerca di Ecologia Preistorica - Dipartimentodi Scienze Ambientali “G. Sarfatti” - Università di Siena,Via Pendola 65; cell. 3204374453;e-mail: [email protected]., [email protected](2) Unità di Ricerca di Ecologia Preistorica - Dipartimento
di Scienze Ambientali “G. Sarfatti” e Scuola di Dottoratoin Scienze della Terra - Preistoria - Università di Siena,Via Pendola 65; cell. 3204374452;e-mail: [email protected], [email protected], [email protected].
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.19 Pagina 5
6 A. RonchiTElli - m. FREGUGliA - l. lonGo - A. moRoni lAnFREDini - F. RAnAlDo
inTRoDUzionE
indagini recenti hanno suggerito una nuovae più complessa valutazione dei modelli com-portamentali delle popolazioni del Paleoliticomedio, soprattutto per quanto riguarda il procac-ciamento delle risorse di origine animale. Sem-pre più numerosi sono infatti i dati provenientida insediamenti di questo periodo, situati nel Vi-cino oriente e in Europa occidentale, che con-fermerebbero l’adozione da parte dei gruppineandertaliani di vere e proprie strategie di cac-cia destinate alla cattura di animali di media(cervo, stambecco, daino) e grossa taglia (uro,cavallo, elefante, mammut) (odell e cowan1986; Plisson e Beyries 1998; Shea 2006; Stiner1994; Villa e lenoir 2006). All’origine di questeconsiderazioni ci sono, oltre all’evidenza, spes-so significativa, dei resti faunistici (Bartram emarean 1999; Boscato e crezzini 2007; Boyle2000; conard e Prindiville 2000; Gaudzinski1996, 2000; Gaudzinski e Roebroeks 2000;Grayson e Delpech 1994; hoffecker e cleghorn2000; Jaubert et alii 1990; kuhn e Stiner 2006;marean 2001; milo 1998; Patou-mathis 2000;Speth e Tchernov 1998)1, i ritrovamenti di gia-vellotti di legno a Shöningen in Germania(Thieme 1997, 2000; Thieme e Veil 1985; We-ber 2000) e di più probabili picche a clacton onSea (inghilterra - oakely et alii 1977) e lehrin-gen (Germania - Adam 1951; Jacob-Friesen1956), siti tutti risalenti al Pleistocene medio.Ultimamente si sono aggiunti i risultati di studifunzionali su complessi litici musteriani, neiquali la presenza di probabili tracce da impattosu manufatti a morfologia triangolare ha fornitol’input per affrontare il problema in modo più
approfondito (Bonilauri 2010; moncel et alii
2009; mussi e Villa 2008; Plisson e Beyries1998; Shea et alii 2001; Shea 2006; Sisk e Shea2009; Villa e lenoir 2006; Villa et alii 2009).Tali indagini si basano, in genere, sull’integra-zione di dati ricavati da approcci diversi, qualilo studio tecno-funzionale, l’analisi dei residui,la tracceologia e la balistica, corredati in alcunicasi dalla sperimentazione.
il Paleolitico medio del Vicino oriente, ca-ratterizzato da produzioni litiche ricche di puntee di generici prodotti triangolari ottenuti attra-verso modalità Levallois, ha rappresentatol’ambito di verifica più appropriato. i risultatiottenuti, che indicano comunque un impiego di-versificato di questi strumenti in attività dome-stiche sia per quanto riguarda le operazionisvolte (macellazione e lavorazione del legno)che i modi di utilizzo (tagliare, raschiare, perfo-rare), avrebbero effettivamente permesso diidentificare anche la presenza di armature2.
il presente lavoro3, a carattere preliminare,s’inserisce in una più ampia indagine cheaffronta lo studio di alcune produzioni litiche
The results of our study suggest that, on the whole, triangular tools from l’oscurusciuto (US 8) don’t ex-hibit any specific characteristics which allow us to suppose they were used as potential armatures. Accord-ing to their tecno-functional features and to the results of use-wear analysis, we believe these artefactswere, rather, employed as multipurpose knifes in which the active area is formed by the unit lateral edge -point. These results may be partially due to the fact that the site has been interpreted as a “base-camp” andnot as a “kill-site” on the base of both operative chain reconstruction and faunal analysis.
Parole chiave: strumenti litici, analisi delle tracce d’uso, tecnologia, neandertaliani, italia meridionale.Keywords: stone tools, use-wear analysis, technology, neandertals, Southern italy.
1 Studi di tipo biochimico (Bocherens et alii 1999, 2005),attestanti un elevato apporto carneo nella dieta neanderta-liana, sono in favore di questa tesi.
2 Tali armature sarebbero state utilizzate per armare lance(le hand-cast spears o throwing spears della letteraturaamericana: si differenziano dal giavellotto per la lunghez-za abitualmente superiore a due metri), picche (thrusting
spears) o giavellotti (callow 1986; Plisson e Beyries1998; lombard 2005; Shea 2006; Villa e lenoir 2006;mussi e Villa 2008; Villa et alii 2009).3 l’introduzione e l’analisi tipologica si devono ad Anna-maria Ronchitelli e Adriana moroni lanfredini; la descri-zione del sito e delle ricerche è opera di AnnamariaRonchitelli e Filomena Ranaldo; il paragrafo sulla produ-zione litica dell’US 8 è di Filomena Ranaldo; la descrizio-ne delle categorie tecnofunzionali è stata effettuata damargherita Freguglia e Filomena Ranaldo; l’analisi trac-ceologica e quella balistica sono rispettivamente di lauralongo e di margherita Freguglia e Adriana moroni lan-fredini. l’interpretazione dei dati, infine, è frutto del lavo-ro congiunto degli autori.
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.19 Pagina 6
STUDio TEcno-FUnzionAlE DEi SUPPoRTi A moRFoloGiA TRiAnGolARE DEll’US 8 7
4 le indagini sono condotte dal Dipartimento di ScienzeAmbientali “G. Sarfatti” dell’Università di Siena - Unità diRicerca di Ecologia Preistorica, con la collaborazione dellaSoprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e delcomune di Ginosa.
5 Per la base dell’unità superiore (US 1) è stata ottenutada collagene la datazione 14c di 38.500 ± 900 BP (Beta181165), cal 42975 ± 788 BP (http://www.calpal.de/, ac-cessed 2009-12-15, Weninger et alii 2007).
musteriane dell’italia meridionale con l’intentodi fornire nuovi dati al dibattito in corso. i com-plessi in esame provengono dal riparo l’oscu-rusciuto alla Gravina di Ginosa (TA) (Boscatoet alii 2004, 2011; Boscato e Ronchitelli 2008;Villa et alii 2009) e da Grotta di castelcivita(SA), sui monti Alburni (Gambassini 1997). Sitratta in entrambi i casi di siti del Paleoliticomedio finale, datati radiometricamente a circa40.000 anni BP (miS 3) e caratterizzati da unaproduzione Levallois con presenza di numerosepunte accanto a più frequenti raschiatoi, predo-minanti sui denticolati. in questa sede si pubbli-cano i risultati ottenuti su materiali provenientidalla US 8 del riparo l’oscurusciuto. Un prece-dente studio di sei punte rinvenute in strati dif-ferenti del medesimo riparo e selezionate sullabase di macrotracce apicali ha in effetti riscon-trato fratture da impatto (Villa et alii 2009); èapparso quindi opportuno analizzare in modosistematico un’intera unità stratigrafica (in que-sto caso l’US 8), selezionando tutti quegli og-getti identificabili genericamente come “punte”,ossia i manufatti triangolari con lati convergentia formare un apice di angolo ridotto, ricavatianche su supporti carenati (Bordes 1961; lapla-ce 1966), ritoccati e non. la scelta è caduta sul-l’US 8 in quanto scavata per esteso e caratteriz-zata da una quantità proporzionalmente rilevan-te di prodotti triangolari.
il SiTo E lE RicERchE
il riparo l’oscurusciuto è situato a 240 ms.l.m. sulla destra orografica della Gravina anord di Ginosa, a 20 km dalla costa ionica(figg. 1, 2). Geologicamente la gravina è costi-tuita da depositi calcarei del mesozoico cui sisovrappongono formazioni calcarenitiche delPleistocene inferiore; l’apporto più recente èrappresentato da conglomerati fluviali. la for-mazione degli strati antropici che costituisconol’attuale deposito archeologico ha inizio nelPleistocene superiore.
le ricerche4 all’oscurusciuto, avviate nel
1998, hanno messo in luce un deposito della po-tenza di oltre circa 5 m (fig. 3), costituito da piùunità stratigrafiche sabbiose a matrice siltosaricche di materiale litico e faunistico, attribuibi-li in toto al Paleolitico medio, indagate sistema-ticamente solo nella porzione superiore (UUSS11÷1), riconducibile al miS 35.
la serie stratigrafica, qui descritta a grosselinee a partire dal basso, presenta una porzioneinferiore (UUSS 15÷27) costituita da sedimentiderivanti soprattutto da prodotti di disfacimentodella calcarenite nella quale si apre il Riparo: sitratta di un accumulo relativamente rapido, for-mato in prevalenza da sabbie calcaree e, a zone,da blocchi di crollo dell’antica volta.
circa a metà della serie è stato messo in lu-ce un livello di tephra dello spessore di 70 cm(analisi in corso) che ha sigillato un livello conblocchi e porzioni d’ossa di grandi dimensioniche sembrano far parte di una vera e propria pa-leosuperficie d’abitato, indagata per ora solomarginalmente.
la sedimentazione prosegue verso l’altocon più livelli a matrice sempre calcarea, di co-lore grigio-rossastro, alcuni dei quali (UUSS 7,9, 11) caratterizzati dalla presenza di strutture dicombustione ben conservate e riconducibili a ti-pologie (e probabili funzioni) differenti (Bosca-to e Ronchitelli 2008).
le unità a tetto della serie (UUSS 2÷1)
Fig. 1 - Riparo l’oscurusciuto: localizzazione del sito.
The oscurusciuto Rock Shelter: location of the site.
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.19 Pagina 7
8 A. RonchiTElli - m. FREGUGliA - l. lonGo - A. moRoni lAnFREDini - F. RAnAlDo
sono state ridotte a lembi residuali dall’erosionee si sono conservate solo grazie al concreziona-mento dovuto alla percolazione di acque meteo-riche sulla parete di fondo del Riparo.
lA PRoDUzionE liTicA DEll’US 8
la materia prima è costituita da ciottoli didiaspro e selce, entrambi prevalentemente agrana fine, e, in minima parte, di quarzite, pre-senti negli apporti appenninici di terrazzi fluvia-li risalenti alle prime fasi del Pleistocene.
Ad un esame preliminare, lo schema di pro-duzione dell’insieme litico proveniente dall’US8 ha sequenze e modalità assimilabili a quelleriscontrate negli strati superiori (UUSS 1÷4) egià analizzate in modo più dettagliato (Boscatoet alii 2011)6. la produzione si esplica prevalen-temente attraverso metodi che rinviano al con-cetto Levallois (Böeda 1994), sebbene sianoattestate anche una produzione lamino-lamellareattuata per riduzione volumetrica dei ciottoli euna produzione di schegge e schegge allungatea partire da un generico débitage di superficiecaratterizzato da sequenze molto brevi; sonoscarsi, invece, gli elementi riferibili al metododiscoide.
Sia nello schema Levallois che in quello la-minare la ricerca di supporti allungati è evidentefin dalla fase di decorticamento che tende a sfrut-tare le naturali convessità dei ciottoli oblunghi.
Fig. 2 - Riparo l’oscurusciuto: panorama della Gravina nord.
The oscurusciuto Rock Shelter: view of the northern Ravine.
Fig. 3 - Riparo l’oscurusciuto: schema stratigrafico.
The oscurusciuto Rock Shelter: stratigrafic section.
6 lo studio degli insiemi litici provenienti dalle UUSS1÷4 è parte del progetto di dottorato di uno degli autori(Filomena Ranaldo).
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.19 Pagina 8
STUDio TEcno-FUnzionAlE DEi SUPPoRTi A moRFoloGiA TRiAnGolARE DEll’US 8 9
la produzione Levallois è volta a otteneresupporti allungati, spesso a dorso corticato, conla modalità ricorrente unipolare e supporti trian-golari attraverso i criteri tecnici del Levallois
convergente; nelle fasi finali è frequente unariorganizzazione del nucleo secondo la modalitàcentripeta o, più raramente, quella preferenzia-le, finalizzate entrambe alla produzione dischegge (Boscato et alii 2011).
All’interno dello schema lamino-lamellare,la riduzione dei nuclei evidenzia lo sfruttamentodi un fronte piuttosto ampio le cui convessitàsono in genere scarsamente gestite; i prodotti ri-cercati sono lame che possono eventualmentefungere da supporto per la costruzione di punteo comunque di elementi a lati convergenti.
in tutte le unità indagate le schegge triango-lari non rappresentano mai l’obiettivo prioritariodella produzione. ciò costituisce, in termini divariabilità degli obiettivi, una marcata differenzacon i siti del Paleolitico medio del Vicino orien-te, dove la produzione di schegge triangolari oc-cupa un ruolo proporzionalmente più rilevante erisulta organizzata in strategie operative più net-tamente finalizzate al loro ottenimento (Bar-Yo-sef e meignen 1992; meignen 1995).
DEScRizionE DEllE cATEGoRiE TEcnoloGichE
DEll’US 8
l’indagine è stata effettuata su un totale di107 elementi ottenuti da ciottoli di provenienzalocale ad eccezione di un’unica lama in selce al-loctona. Sulla base dei criteri tecnici utilizzatiper costruire la convergenza dei bordi laterali, isupporti a morfologia triangolare dell’US 8 so-no stati suddivisi in 6 categorie tecnologiche.
A) Supporti Levallois convergentiAppartiene a questa categoria la maggior
parte dei manufatti selezionati (n. 61 pezzi), frai quali sono compresi elementi sia tecnici chedel pieno débitage.
All’interno dei prodotti di pieno débitage
lo schema operativo prevede la presenza di 2, 3o più distacchi. i talloni, prevalentemente fac-cettati, sono talora a c.d.g. i bulbi, benché natu-ralmente prominenti, non sono mai assottigliati.le cornici risultano generalmente regolarizzate.
A seconda dei differenti criteri tecnici mes-si in atto nella fabbricazione dei manufatti sonostati individuati i seguenti gruppi:
1) Elementi a 3 distacchi (n. 26, 8 dei qualisono frammenti prossimali e 3 semplici apici),con ordine dei distacchi variabile (Boëda 1982).Possiamo distinguere due morfologie principali:- supporti mediamente di maggiori dimensioni econ larghezza massima non corrispondente allabase (n. 12) (fig. 4.1); in taluni casi questi pezzisono trasformati da un ritocco che solo di radomodifica sostanzialmente i margini originali(1 P2, 4 P1)7. Si distinguono due manufatti mol-to simili fra loro in cui il punto di percussione èposto lateralmente rispetto all’asse di simmetriadel pezzo (ricavati quindi dalla porzione lateraledella superficie di débitage).- Esemplari vicini al triangolo equilatero (n.14), con larghezza massima sempre alla base e,salvo un pezzo, privi di ritocco, nessuno deiquali presenta tracce d’utilizzo. All’interno diquesto insieme si distingue un modulo dimen-sionale più piccolo (n. 8 pezzi; l = 29-40 mm;l = 25-31 mm; s = 3-6,5 mm) caratterizzato datalloni a c.d.g e da accentuata concavità sullaporzione prossimale della faccia dorsale deter-minata dal negativo del bulbo del distacco cen-trale (che in questo caso è il primo dellasequenza) (fig. 4.2); i talloni particolarmentesottili e l’asimmetria della faccia dorsale indur-rebbero a considerare tre di questi pezzi comeprobabili errori. A quest’ultimo insieme appar-tiene l’unico manufatto ritoccato (P2).
2) Elementi a 2 distacchi (n. 11, 2 dei qualiframmentari). Di questo gruppo fanno parte6 schegge di piccolo formato (l = 27-37 mm;l = 14-21 mm; s = 4-6 mm), intere e non ritoc-cate ad eccezione di un esemplare (P1), che de-rivano dalla creazione del triangolo centralequando questo rappresenti l’ultimo termine del-la sequenza (schema c di Boëda 1982, p.28;punta di 1° ordine di Bordes 1961) (fig. 4.3).Fra i rimanenti, 4 pezzi sono interessati da unritocco bilaterale (3 P1 e 1 P2) (fig. 4.5).
3) Elementi con più di 3 distacchi (n. 9, 2dei quali spuntati) (fig. 4.4,6) di dimensionicomparibili (l = 36-59,5 mm; l = 24,5-33 mm;s = 3,5-8,5 mm) e bordi tendenzialmente irrego-lari: solo i moduli maggiori sono trasformati(2 P3 e 1 P2- fig. 4.4).
7 Per la classificazione tipologica è stata utilizzata la tipo-logia di G. laplace 1964.
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.19 Pagina 9
10 A. RonchiTElli - m. FREGUGliA - l. lonGo - A. moRoni lAnFREDini - F. RAnAlDo
4) n. 8 elementi (3 rotti) che, pur derivandoda una produzione convergente con nervatureche creano la tipica Y, hanno margini irregolari,sinuosi e frastagliati che non definiscono unavera e propria punta. Si tratta di errori nella pro-duzione che hanno dato luogo a morfologie noncorrispondenti al risultato atteso.
5) n. 7 schegge riconducibili a fasi (avan-zate) di decorticamento oppure a operazioni dicorrezione o messa in forma della superficie didébitage. È presente un manufatto ritoccato(P2).
B) Supporti da débitage Levallois unipolarericorrenteVi appartengono 8 pezzi (1 frammento di-
stale), tutti ritoccati (P2), tendenzialmente al-lungati e più grandi rispetto agli esemplaridella categoria precedente. Su tre strumentil’apice risulta asportato da fratture che nonpresentano però la morfologia ritenuta tipicadelle fratture da impatto (fig. 4.8) (Fischer et
alii 1984).
c) Supporti ad elevato grado di trasformazioneSi tratta di 24 pezzi in cui convergenza dei
lati e punta sono determinati da un ritocco pro-fondo bilaterale che oblitera in larga parte lamodalità tecnologica di produzione e la suc-cessione dei distacchi. otto esemplari sonoprodotti provenienti dalle prime fasi di débita-
ge (presenza di cortice); sette sono rotti allabase.
Si distinguono due morfologie:- n. 14 punte a bordi simmetrici più o menoconvessi (P2). Solo in alcune (n. 7 ) è ancora ri-conoscibile una generica derivazione da débita-
ge Levallois. Un esemplare presenta dorsoparzialmente corticato.- n. 10 punte a bordi asimmetrici: 6 di queste,su supporti stretti e lunghi ottenuti forse da undébitage di volume, hanno bordo concavo op-posto a convesso che determina un apice netta-mente déjeté (P3). É qui presente l’unica puntaricavata all’estremità prossimale del supporto(fig. 4.9).
D) n. 4 schegge pseudolevallois da débitage
Levallois, 3 delle quali caratterizzate da un mo-dulo dimensionale ridotto (tab. i) (fig. 4.7).
E) Fanno parte di questo gruppo 3 manufattiprovenienti da un débitage di volume. Si tratta
di 2 lame spesse di grandi dimensioni, con ner-vatura guida centrale e ritocco profondo su en-trambi i lati (P3), e di una lama sorpassataproveniente dal fianco del nucleo con ritoccopure bilaterale profondo (P2) (fig. 4.10).
F) l’ultimo insieme è formato da 6 elementiricavati da débitage su spigolo che può preve-dere l’utilizzo di nuclei-scheggia. Si tratta dischegge laminari a convessità uniforme dellafaccia ventrale aventi, in due casi, torsione ante-ro posteriore. Un pezzo ha ritocco marginale bi-laterale (P1).
Sono infine presenti 2 pezzi (non ritoccati)privi di elementi diagnostici dal punto di vistatecnologico e pertanto non inseribili in una spe-cifica categoria.
Riassumendo, si può rilevare che tutti gliesemplari riferibili alla prima categoria (A) nonmostrano caratteri specifici legati a uno o en-trambi i bordi. non emergono infatti ricorrenzesia nei valori dello spessore in corrispondenzadelle nervature che nella forma dei margini.Questi ultimi hanno sezioni con angolo compre-so tra 35° e 50°, con i ritoccati che si concentra-no nella fascia più alta dell’intervallo. Fannoeccezione i tre elementi classificati come errori,i cui angoli sono compresi tra i 24° e i 30°.
nelle categorie B, c e E, come si è visto, laconvergenza dei bordi viene realizzata princi-palmente nella fase di trasformazione. Si trattain genere di supporti più slanciati dei precedentiin cui la modifica effettuata dal ritocco conferi-sce ai margini un andamento convesso o, in mi-nor misura, concavo. È interessante sottolineareche nei manufatti che presentano maggiorestandardizzazione morfo-metrica anche l’ango-lo dei margini attivi è compreso in valori moltosimili (tra 55° e 65°).
nel complesso è possibile riconoscere duedifferenti modalità di trasformazione che porta-no a due diverse tipologie di strumenti accomu-nate dalla ricerca di margini attivi allungati: 1)un insieme più numeroso che è costituito daelementi con margini biconvessi; 2) un insiemeformato da 5 pezzi, peraltro molto simili tra lo-ro, in cui il ritocco costruisce un dorso convessoche diviene ancora più erto in prossimità dellaconvergenza (angolo compreso tra 80° e 90°),opposto ad un margine concavo (angolo com-preso tra 50° e 60°).
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.19 Pagina 10
STUDio TEcno-FUnzionAlE DEi SUPPoRTi A moRFoloGiA TRiAnGolARE DEll’US 8 11
Fig. 4 - Riparo l’oscurusciuto. Supporti Levallois convergenti (categoria A): 1, 2. Elementi a 3 distacchi. 3, 5. Elementi adue distacchi. 4, 6. Elementi a più di 3 distacchi. 8. Supporti da débitage Levallois unipolare ricorrente (categoria B). 9. Sup-porti ad elevato grado di trasformazione (categoria c). 7. Schegge pseudolevallois (categoria D). 10. manufatti provenienti dadébitage di volume (categoria E) (dis. Adriana Moroni Lanfredini) (1:1).
The oscurusciuto Rock Shelter. convergent Levallois products (A category): 1, 2. Three removal products. 3, 5. Two removalproducts. 4, 6. more than three removal products. 8. Unipolar ricurrent Levallois products (B category). 9. high transforma-tion degree products (c category). 7. Pseudolevallois blanks (D category). 10. Volume débitage products (E category) (dra-
wings by Adriana Moroni Lanfredini) (1:1).
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.19 Pagina 11
12 A. RonchiTElli - m. FREGUGliA - l. lonGo - A. moRoni lAnFREDini - F. RAnAlDo
in estrema sintesi osserviamo che solo laproduzione Levallois convergente integra i ca-ratteri funzionali dello strumento già nella fasedi estrazione del supporto, caratteri che si espli-cano nello spessore e nell’andamento della zonaattiva, costituita dall’unità lato-punta, e nellasua relazione ergonomica con la porzione pros-simale formata dallo spessore del tallone (zonaprensiva?). negli altri casi, diversamente, l’effi-cacia funzionale è acquisita, in massima parte,attraverso il ritocco.
AnAliSi FUnzionAlE E conSiDERAzioni
Di cARATTERE BAliSTico
nell’analisi funzionale le tradizionali os-servazioni delle tracce d’uso in microscopia ot-tica ed elettronica (longo et alii 2001; longo2003) sono state affiancate da una nuova appli-cazione tecnologica rappresentata dalla micro-scopia digitale.
Tutti i pezzi sono stati preparati attraversoun procedimento di lavaggio onde liberarli dalsedimento, che in alcuni casi si presentava con-crezionato e fortemente aderente alla superficie.A tale scopo le operazioni di lavaggio hannocontemplato anche un rapido passaggio in unasoluzione al 5% di hcl ma, nonostante ciò, al-cuni degli oggetti trattati hanno mantenuto partedelle concrezioni, alle volte dislocate in modotale da non permettere l’osservazione delle areefunzionalmente attive. lo stato di conservazio-ne delle superfici si è rivelato comunque buonoe adeguato all’esame microscopico. Per l’osser-vazione si è utilizzata la metodologia tradizio-nale in microscopia ottica (leica DmRXP) coningrandimento 100-400 x. la mancanza di alte-razioni meccaniche ha reso possibile sia l’anali-si delle macro-tracce (scheggiature e arrotonda-menti d’uso) che delle micro-tracce, grazie an-che all’applicazione delle potenzialità del mi-croscopio digitale hiRoX 7700; tale micro-scopio è infatti corredato delle ottiche per l’os-servazione in macro (mX-G 5040z), che per-mettono ingrandimenti molto elevati (ma inquesto caso è stato utilizzato nell’intervalloconsueto 20-100 x), nonché di quelle per l’os-servazione microscopica in luce riflessa (ol -140 ii) con le quali è stato possibile raggiun-gere ingrandimenti fino a 1000 x. A questo pro-posito è opportuno precisare che la qualità del-l’immagine consentita dalla microscopia digi-
tale è tale da essere paragonata a quella dellamicroscopia elettronica a scansione (SEm), conil vantaggio però di ovviare ad alcuni limiti delSEm. Grazie alla struttura dell’hiRoX 7700,che permette una gestione dei reperti analoga aquella del microscopio binoculare, è possibileinfatti osservare direttamente anche campioni digrandi dimensioni, come nel caso dei manufattioggetto della presente indagine, nella loro inte-rezza e senza trattamenti legati alla necessità diconduzione del fascio elettronico del SEm.
l’analisi delle tracce sulle punte dell’oscu-rusciuto ha seguito il protocollo standard con lacodifica delle evidenze su una scheda di raccol-ta dati in cui sono state riportate le localizzazio-ni delle Unità Funzionali (FU) distribuite sullasuperficie del supporto, le caratteristiche dellemacro e micro tracce osservate, i valori relativial peso, le dimensioni massime e la lunghezzasecondo l’asse di débitage. Una volta esauritol’esame in macro della superficie dei 107 manu-fatti, l’osservazione si è concentrata sulle por-zioni apicale e prossimale in modo daindividuare le eventuali morfologie distintive dimodificazioni a seguito di impatto e/o di imma-nicatura. Da questa indagine è emerso che, seb-bene una gran parte dei manufatti rechi almenoun piccolo distacco nella zona apicale, solo inpochi casi si ha a che fare con una vera e pro-pria frattura, dalla tipologia peraltro non assimi-labile a quelle riconosciute come derivate daimpatto (Fischer et alii 1984).
Un campione più ristretto di oggetti (n. 65pezzi), selezionato tenendo conto delle diversecategorie tecnologiche, è stato esaminato invecein microscopia ottica e digitale onde verificarela presenza di tracce d’uso anche lungo i possi-bili margini attivi8.
nella maggior parte del campione osserva-to non sono state registrate evidenze d’uso. intaluni casi il mancato rilevamento delle tracce èdovuto alla residuale presenza di un sottile velodi concrezione che copre le superfici rendendo-le poco leggibili. Su 19 pezzi il riscontro è sta-to, invece, positivo. Per 7 manufatti, di cui5 ascrivibili alla categoria A, 1 alla B e 1 allac, le tracce hanno consentito di risalire alla
8 Si ringrazia la dott. Simona Arrighi per l’aiuto prestatocinell’esame microscopico di alcuni manufatti che ha porta-to all’individuazione della loro cinematica.
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.19 Pagina 12
STUDio TEcno-FUnzionAlE DEi SUPPoRTi A moRFoloGiA TRiAnGolARE DEll’US 8 13
cinematica del supporto. Tre pezzi (tra i quali 1P1) appartenenti ad A1 presentano su uno o suambedue i bordi laterali macrotracce dovute adun’azione perpendicolare all’asse dello stru-mento, riconducibile a movimenti trasversali almargine (grattare) (figg. 4.1; 5.1,2); in un ma-nufatto con apice spezzato di A2 le tracce siamacro che micro interessano distalmente en-trambi i lati (FU 1 e 8) e indicano un’azione pa-rallela al margine e quindi un movimentolongitudinale (tagliare) (fig. 4.5); un altro pezzoda A3 presenta anch’esso tracce lungo i lati (FU1 e 8) che sembrano indicare un’azione perpen-dicolare all’asse (fig. 5.4). microtracce sonostate riconosciute anche nella porzione media-na-distale (FU 7 e 8) di uno strumento déjeté
(P3) della categoria B (fig. 5.6). l’ultimo esem-plare, infine, è l’elemento (P2) a dorso parzial-mente corticato della categoria c nel quale sonostate riscontrate politure che riguardano l’apice(FU 8 e 1) riferibili ad operazioni quali perfora-re/incidere, mentre politure sviluppate in modopiù leggero interessano la porzione distale ritoc-cata del lato corticato (FU 8) (fig. 5.5).
Sei supporti, appartenenti alle categorie A2(n. 2) (fig. 5.7,8), A3 (n. 3) (fig. 5.11) e B (n.1)(P2), mostrano tracce legate ad operazioni dimacellazione; politure e micro distacchi osser-vabili a partire da 140 x si trovano concentratinelle porzioni funzionalmente attive; le tracceriferibili alle prime fasi della macellazione (in-cisione della cotenna e primo taglio ventre-go-la) si focalizzano prevalentemente nelle FU 1 e8, che restano, anche per le fasi successive, leporzioni attive interessate maggiormente dallapresenza di politure, micro distacchi e rare stria-ture. Agli stadi successivi della macellazione(disarticolazione, distacco dei tendini ecc.) sonoconnesse anche tracce che si localizzano su unoo su ambedue i lati nelle porzioni FU 2 e 3 oFU 6 e 7. Azioni longitudinali all’asse del sup-porto, ossia di taglio di materiale animale, e ri-conducibili pertanto, anch’esse, ad operazionidi macellazione, sono state rilevate in altri 3manufatti che rientrano nelle categorie A3 (fig.5.10), A1 (P1) (fig. 5.3) e c (P3) (fig. 5.12). Sisono riscontrati inoltre 2 casi (categoria B) (P2)che mostrano tracce legate ad un’azione perpen-dicolare all’asse del manufatto, quale la raschia-tura, impiegati forse in operazioni dipreparazione / rastrematura / adattamento dimanici o comunque nella lavorazione di un ma-teriale vegetale come il legno (fig. 4.8). Solo un
esemplare reca tracce che potrebbero esserecompatibili con un utilizzo come armatura(figg. 4.3; 5.9). Si tratta di un supporto A2 (P1)con frattura apicale cui sono associate leggerestrie corte ad andamento subparallelo e politureconcentrate nella porzione adiacente alla frattu-ra; qualche raro micro distacco di tipo concoide,allungato e subparallelo all’asse del pezzo, èpresente nella porzione distale di entrambi imargini in norma dorsale.
Per quanto riguarda la localizzazione delletracce, ma anche certe specifiche morfologiedei supporti, confronti diretti sono istituibili conelementi del musteriano levantino provenientidai siti di kebara e Umm el Tlel (Plisson e Bey-ries 1998, pp. 7-9).
Accanto all’analisi delle tracce d’uso, unodegli approcci fondamentali ai fini di un corret-to inquadramento funzionale dei supporti amorfologia triangolare dei quali si intenda ap-purare l’eventuale utilizzo come armature di ar-mi da getto è costituito dalla verifica di unaserie di parametri che possono essere definiti diordine balistico, in quanto dovrebbero consenti-re di investigare gli aspetti più strettamente cor-relati alla maggiore o minore efficienza dellearmature medesime9.
Questo genere di indagine ha conosciutopiù ampio sviluppo in ambito nord americanodove svariati autori si sono occupati del proble-ma delle armi da lancio preistoriche e delle rela-tive armature, utilizzando come riferimentoanche dati desunti da reperti etnografici e avva-lendosi del contributo dell’archeologia speri-mentale (cfr. ad esempio: Bamforth 2009;Buchanan e collard 2009; Ellis 1997; hardy et
alii 2001; hughes 1998; lombard e Pargeter2008; lyman et alii 2009; Sellet 2004; Smith et
alii 2007; Yaroshevich et alii 2009). Quando siparla di armi paleolitiche una delle questioni ri-correnti riguarda l’individuazione dei fattori chepossono aver influenzato l’uso di armature inpietra rispetto a esemplari in materiali organicicome legno, osso e corno. Se nel settore dellatecnologia da proiettile è possibile basare leproprie ipotesi su dati concreti a partire dallestesse armature, siano esse litiche o in altro ma-teriale, il problema è ben diverso per il Paleoli-
9 la balistica è per definizione la scienza che studia il mo-to dei proiettili.
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.19 Pagina 13
14 A. RonchiTElli - m. FREGUGliA - l. lonGo - A. moRoni lAnFREDini - F. RAnAlDo
tico medio, periodo nel quale l’impiego di armida getto o di picche dotate di punte di pietra de-ve essere ancora, a differenza di quelle con lapunta di legno, provato in modo inconfutabile.le riserve avanzate risiedono, oltre che nell’og-gettiva difficoltà di distinguere nell’ambito del-le produzioni litiche musteriane dei supportisufficientemente standardizzati e idonei alloscopo, nella fragilità stessa delle punte se im-piegate in azioni a bassa velocità10. Pur conqueste criticità vi è sostanziale accordo nell’am-mettere che il livello tecnologico raggiunto daineandertaliani soddisfaceva oramai tutte lecondizioni necessarie a prevedere l’uso di arma-ture in pietra11. Per quanto riguarda il Paleoliti-co medio l’interesse degli studiosi si èconcentrato, perciò, sui manufatti a morfologiatriangolare12, prendendo spunto principalmentedalle caratteristiche riscontrate nelle punte Le-
vallois degli insiemi litici del musteriano levan-tino. in alcuni casi i risultati di questi studi,ancora alquanto preliminari, hanno portato adidentificare nell’ambito della categoria suddettaquei manufatti che, sulla base del loro assettobalistico, potrebbero essere stati maggiormenteadatti a fungere da armature per armi da getto.A tal fine vengono considerati diagnostici para-metri quali la massa, l’angolo di penetrazionedell’apice, l’area della sezione trasversale (tip
cross-sectional area TcSA) e il rapporto lun-ghezza massima / larghezza massima. Proprioquest’ultimo parametro avrebbe, secondo Sheaet alii (2001), un ruolo determinante nell’indivi-duare eventuali punte di lancia o di giavellotto amano in quanto i dati sperimentali, ottenuti uti-lizzando un nutrito campione di punte Levallois
(quindi prive di ritocco), avrebbero permesso distabilire che: «Shorter and broader points are
mechanically advantageous in low speed / high
mass impact» (Shea et alii 2001, p. 812) poichéresistono agli stress meccanici ben più efficace-mente delle punte lunghe e strette molto piùadatte, a detta degli Autori, ad essere utilizzatecome coltelli multiuso. Sulla scorta di questeosservazioni e di altri criteri interpretativi (Shea1988, 1991) gli stessi Autori distinguono, nel-l’ambito degli oggetti a morfologia appuntita,tre differenti gruppi funzionali:
1) punte di lancia - punte che mostranotracce dovute esclusivamente a impatto;
2) coltelli - punte che recano tracce d’usonon da impatto ma riferibili a azioni diverse co-me tagliare, grattare, forare;
3) strumenti misti - punte che presentanotracce da impatto insieme a tracce deri-vate da altri impieghi (Shea et alii 2001,p. 813)13.
Di diverso avviso sono altri studiosi che,pur ammettendo la congruità dell’ipotesi (Plis-son e Beyries 1998; moncel et alii 2009) relati-va all’utilizzo di armature litiche nelPaleolitico medio, sostengono che queste noncostituivano l’obbiettivo funzionale primariodei prodotti a lati convergenti. indagini effet-tuate sempre su insiemi del musteriano del Vi-cino oriente avrebbero infatti condotto aipotizzare che: «Plutôt que de pointes, il serait
fonctionnellement plus juste de parler d’instru-
ments triangulaires, c’est-à-dire de formes as-
sociant des angles et des tranchants aigus,
particulièrement adaptés à des actions de
coupe longitudinale sur matière tendre. Que ce
soit pour inciser, amorcer la découpe, ou facili-
13 A questo proposito sembra necessario ricordare un’ipo-tesi avanzata da alcuni (Ellis 1997, p. 54; Goodyear 1982,p. 391) circa la possibile doppia funzione assolta dall’armamedesima che, nel corso delle battute di caccia, poteva es-sere utilizzata anche come coltello per le operazioni di pri-mo depezzamento della preda.
10 Va tuttavia precisato che questa caratteristica, che èspesso all’origine della rottura anche in più pezzi dell’ar-matura all’interno della ferita, viene considerata da taluniun vantaggio in quanto contribuirebbe, secondo dati etno-grafici, a rendere l’arma maggiormente letale (Ellis 1997,pp. 51-52).11 Un suggerimento interessante, che potrebbe giustificarein termini di performance l’uso di punte litiche in un am-biente come quello neandertaliano che non sembra cono-scere ancora il concetto di proiettile, ci viene dal campoetnografico. Presso gli aborigeni australiani, infatti, dovel’uso della lancia costituiva la norma, è stata osservata unaprecisa associazione tra aste di bambù o di canna, maneg-gevoli e leggere, e punte di pietra. lance così concepite, seda un lato possono essere scagliate a maggiore distanzacon grande precisione, dall’altro, proprio per la loro legge-rezza, perdono in capacità di penetrazione, difetto al qualepuò essere posto rimedio utilizzando una punta litica (Ellis1997).12 Denominati, a seconda degli Autori, punte, strumentitriangolari (Plisson, Beyries 1998), punte Levallois, scheg-ge triangolari (Sisk e Shea 2009), punte con fratture da im-patto (Villa et alii 2009), punte di lancia (Shea et alii
2001).
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.19 Pagina 14
STUDio TEcno-FUnzionAlE DEi SUPPoRTi A moRFoloGiA TRiAnGolARE DEll’US 8 15
Fig. 5 - Riparo l’oscurusciuto. Elementi con tracce d’uso: 1-4. Tracce riconducibili ad una cinematica prevalentemente trasversalein cui il margine attivo è impegnato in un’azione quale grattare (categoria A). le tracce non sono abbastanza sviluppate per identi-ficare la materia lavorata. 5, 6. manufatti sui quali sono state individuate le porzioni funzionalmente attive ma nei quali il grado disviluppo delle tracce non permette di riconoscere né l’azione né il materiale lavorato (categoria c). 7-12. Tracce connesse ad ope-razioni di procacciamento (?) (n. 9) e trasformazione della preda (7, 8, 10-12) (categorie A e c). la n. 9 mostra tracce concentratenella porzione apicale dove ad una frattura trasversale di tipo rettilineo si associano fasci dispersi di sottili striature accompagnateda politure (armatura?).
The oscurusciuto Rock Shelter. Products showing wear-traces: 1-4. Traces referable to transversal cinematic, mainly related to ascraping action (A category). Due to the low development of the traces in all these and in the nos 5, 6 (c category) the worked ma-terial cannot be detected. 7-12. Products which show a good development of the wear-traces letting the detection of both the mo-tion and the worked material, which drive to the interpretation of the function as butchering heavy duty tools. Tool n. 9 (Acategory) is the only one showing traces concentrated on the tip of the point where a transversal linear fracture is associated tobunches of short striations with polish (armature?).
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.19 Pagina 15
16 A. RonchiTElli - m. FREGUGliA - l. lonGo - A. moRoni lAnFREDini - F. RAnAlDo
ter l’introduction du corps de l’outil dans le
matériau à transformer, l’extrémité effilée
trouve sa justification offrant, en outre, d’utiles
capacités de perçasage ou d’alésage...» (Plis-son e Beyries 1998, p. 14); questa interpreta-zione sarebbe confermata anche dall’etero-geneità dimensionale e morfologica dei prodot-ti in oggetto nonché dal volume del loro bulbo,caratteristiche che inciderebbero sui tempi ne-cessari all’adattamento dell’asta alla morfolo-gia specifica di ciascuna punta.
Ad una conclusione simile, che privilegial’aspetto polifunzionale, arrivano anche moncelet alii (2009) in uno studio sugli strumenti con-vergenti del Paleolitico medio antico del sito diPayre in Francia, in un contesto, questa volta, adébitage discoide; lungo i lati di manufatti uti-lizzati sperimentalmente come armature di lan-ce gli Autori hanno inoltre rilevato la presenzadi microritocchi legati alla penetrazione dellapunta dentro l’animale quando questa colpiscel’osso, dimostrando che le fratture da impattopossono non rappresentare l’unico indiziodell’utilizzo di pezzi litici come armature.
le punte dell’oscurusciuto mostrano dalpunto di vista dimensionale valori distinti a se-conda delle categorie; in particolare si nota chela A, la F e la D sono quelle che contengono glielementi più piccoli con medie che non supera-no la soglia di 43,1 per la dimensione massima(qui sempre la lunghezza); nel caso delle puntepseudolevallois (D) questo valore si abbassa ul-teriormente a 27,2. Ancora la A e la D si collo-cano nella fascia degli esemplari più corti conindici di allungamento medi pari a 1,7 (A) e 1,1(D), mentre i prodotti da débitage su spigolodella F mostrano, in questo caso, media più alta(2,2). le altre categorie (B, c, E), caratterizzatetutte da strumenti a ritocco profondo, hanno nelcomplesso lunghezza più sviluppata e sono ten-denzialmente più laminari. in special modo laE, i cui prodotti sono derivati da un débitage divolume, si distingue per la presenza di supportiparticolarmente grandi (media 81,7) e slanciati(media 2,8).
Un parametro che viene considerato unadelle principali variabili che influenzano la ca-pacità di penetrazione di un’arma a bassa velo-cità e quindi significativo ai fini dell’identifi-cazione di armature litiche è il valore dell’areadella sezione trasversale (TcSA)14. la TcSA èin genere bassa quando si parla di armature difreccia (media 33 mm2) o di giavellotto (da pro-
pulsore) (media 58 mm2), mentre il valore me-dio calcolato per le armature di lancia è di 168mm2 (Shea 2006)15.
Per quanto riguarda i supporti a morfolo-gia triangolare dell’US 8 dell’oscurusciuto nelloro complesso la media della TcSA è pari a103,9 mm2, valore che però va soggetto adun’ampia oscillazione tra le diverse categorietecnologiche (tab. i). Ad un esame più appro-fondito si nota che, in realtà, si discostano conevidenza dalla media generale solo le categoriemeno numerose (D, E e F, 14 pezzi in totale)che si collocano peraltro ai due estremi dimen-sionali; mentre le altre, alle quali fa capo laquasi totalità dei pezzi (A, B e c, 93 manufattiin tutto), si comportano in modo uniforme conmedie comprese tra 100 e 120 mm2. confron-tando il dato di 103,9 mm2 con quelli forniti daShea (2006) per le punte della mSA africana,del Paleolitico medio levantino e del sud-estasiatico, nonché di alcuni giacimenti musteria-ni europei si osserva, da un lato, che detto valo-re difficilmente scende al di sotto dei 100 mm2,dall’altro che la TcSA dell’oscurusciuto, purrientrando nel range previsto per le lance a ma-no, si colloca mediamente nella fascia più bas-sa in assoluto e più vicina senz’altro ai valoridel musteriano del Vicino oriente piuttosto chea quelli europei.
conclUSioni
Sebbene sia ormai assodato che il bagagliocomportamentale neandertaliano disponeva ditutti i presupposti tecnici necessari alla realizza-zione di armi composite, non vi sono prove al-trettanto attendibili di un effettivo utilizzo gene-
14 Parallelamente al valore della TcSA è stato calcolatoanche il perimetro della sezione trasversale secondo le duediverse metodologie proposte in letteratura (hughes 1998)poiché, in base a quanto sostenuto da Sisk e Shea in unostudio recente (2009), la capacità di penetrazione dellapunta sarebbe più strettamente correlata con la larghezza econ il perimetro della sezione trasversale, piuttosto checon l’area della sezione trasversale.15 mentre nei primi due casi (frecce e giavellotti) i valoririportati sono stati desunti dalla misurazione di punte etno-grafiche e archeologiche, per le punte di lancia a mano cisi è avvalsi di uno studio sperimentale che ha dimostrato lamaggior efficacia di armature la cui TcSA fosse compresatra 100 e 250 mm2 (Shea 2006).
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.19 Pagina 16
STUDio TEcno-FUnzionAlE DEi SUPPoRTi A moRFoloGiA TRiAnGolARE DEll’US 8 17
ralizzato di armature litiche, soprattutto quandose ne ipotizzi una diffusione su scala spazio-temporale molto ampia. Uno dei primi problemiche sorgono nell’affrontare l’argomento è lega-to al piano metodologico, un campo nel qualenon sono stati individuati finora approcci ingrado di produrre risultati univoci, anche a cau-sa delle troppe variabili implicate. Allo stato at-tuale non è dunque facile enucleare unparametro o più parametri che possano essereconsiderati di per sé indicativi dell’uso di certimanufatti come armature, salvo forse la presen-za delle cosiddette fratture da impatto. Anche inquesto caso, però, si ha bisogno di un’interpre-tazione che tenga conto dell’intero contestoeconomico in esame, a partire dalle informazio-ni relative alle modalità di sfruttamento delle ri-sorse disponibili sul sito.
Per quanto riguarda in modo specifico laproduzione litica, solo la concomitanza di piùfattori costituisce una premessa concreta al po-tenziale riconoscimento di armature nell’ambitodi un determinato insieme. nell’indagine non èinfatti possibile prescindere, oltre che dalla pre-senza/assenza di fratture da impatto, da un’ana-lisi atta ad individuare obbiettivi tecnici idonei,costituiti da supporti sufficientemente simmetri-ci e con adeguata standardizzazione morfome-trica; altrettanto importanti sono caratteristichequali la presenza di basi assottigliate e di speci-
fiche tracce d’uso. il tutto, possibilmente, inuna popolazione di manufatti statisticamentevalida in cui sia accertato anche il rispetto diuna serie di criteri “balistici” a garanzia dellareale efficacia delle ipotetiche armature.
Dai risultati dello studio effettuato secondoi differenti approcci presentati, l’insieme deisupporti a morfologia triangolare dell’US 8 del-l’oscurusciuto non sembra contenere manufattii cui caratteri rispecchino un loro eventuale im-piego come cuspidi di armi da getto, ad ecce-zione forse, come si è visto, di un unicoesemplare (fig. 5.9). Questo assunto si basa, inprimo luogo, sull’assenza di vere e proprie frat-ture apicali da impatto, ma è confermato anchedalla tipologia e dalla localizzazione delle trac-ce d’uso. Gli esemplari in cui tali tracce sonostate riconosciute (29,2% di quelli esaminati)contribuiscono, infatti, a proporre un utilizzoconnesso soprattutto a operazioni di macellazio-ne come evidenziato dalla presenza di stigmatericonducibili ad azioni di tipo longitudinale(taglio). nella stessa direzione conducono, delresto, anche i dati dell’analisi tecnica che indi-cano come obbiettivo prioritario della produzio-ne a morfologia triangolare la ricerca disupporti tendenzialmente stretti e allungati do-tati, dunque, di estesi margini laterali, una carat-teristica che trova pieno riscontro nel valoresostanzialmente basso dell’area della sezione
Cat L (mm) L/l l (mm) s (mm) l/s TCSA (mm2) SD (mm2) P1 P2 Angolo Peso (g)
A 27-65 43
1,1-6,5 1,7
14-41,5 28,3
3,5-11 6,8
3-8,8 4,2
34,9- 225,5 100,1 43,9 29,6-84,4
58,7 31,2-83
60 40°-87 65,5
1-36 8,4
B 55-78,5 67
1,9-2,5 2,2
22-35 28,3
4,5-11 7,2
2,5-4,8 3,9
55-166,2 106,2 40,5 45,2-72,4
58,9 46,2-74,8
60,4 74°-85 78,8
7-25 15,3
C 34-72 59,5
1,2-2,9 2,2
18-41,5 26,4
4-17,4 8,1
1,8-5,3 3,3
47,5-290,5 119,6 66,3 39,5-87,6
56,1 40,4-91,6
58,5 45°-85 66,5
2-45 11,5
D 27-27,5 27,2
1,1-1,2 1,1
21,5-43,5 28,1
3,5-8 6
3,6-6,7 4,8
41,1-174 89,4 58,4 44,8-88,4
57,5 46,1-89,9
58,7 76 3-10 5,3
E 78-116 97
2,6-3,9 3,4
21-45 30,3
8,5-19,5 13,7
19-2,5 2,2
89,2 -438,7
230,1 184,3 45,2-98 66,5
48-104,6 73,8
75°-89 82
18-120 58
F 32,5-58,5 41
1,3-3,2 2,2
13,5-24,5 18,7
4-8 5,3
2,3-5,4 3,7
30,4-85,6
51,2 17,5 28,4-49,6 38,9
29,7-50,5 40,4
45°-71° 61,3
2-5 3,2
TOT 27-116 56,8
1,1-6,5 2,0
13,5-45 27,3
3,5-19,5 7,8
1,8-8,8 3,7
30,4-438,7
103,9 60,9 28,4-98 56,7
29,7-104,6 58,5
45°-89° 66,8
1-120 11
Tab. i - Riparo dell’oscurusciuto US 8. in corsivo i valori medi. l = lunghezza, l/l = lunghezza/larghezza, l = larghezza, s =spessore, l/s = larghezza/spessore, TcSA = area della sezione trasversale, SD = deviazione standard, P1 = perimetro secondohughes 1998, P2 = perimetro secondo Sisk e Shea 2009, Angolo = angolo di penetrazione visto in norma frontale e misuratoin gradi.
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.20 Pagina 17
18 A. RonchiTElli - m. FREGUGliA - l. lonGo - A. moRoni lAnFREDini - F. RAnAlDo
trasversale. Anche l’assenza di trasformazionibasali verrebbe a configurarsi come ulterioreelemento in negativo, sebbene non si possascartare l’ipotesi che vi sia stato un progetto diadattamento della base, funzionale all’immani-catura, già nella fase di produzione con la pre-determinazione della concavità prossimale e/ola riduzione della cornice.
il mancato riconoscimento nell’US 8 dimanufatti a morfologia triangolare interpretabilicome armature non pregiudica naturalmenteuna loro possibile presenza in altri livelli dellostesso Riparo16, così come non esclude che taletecnologia possa aver fatto parte del back-
ground di conoscenze dei gruppi neandertalianiche popolarono l’italia meridionale. Va inoltreconsiderato che il Riparo, per le sue caratteristi-che, deve aver assolto una funzione soprattuttodi campo base e non certo di postazione di cac-cia (kill-site). Questo fattore risulta di primariaimportanza nell’ambito di una ricerca impostatasull’individuazione di una componente dellostrumentario litico che si pensi destinata proprioa tale attività; poiché, se allo stato attuale è pos-sibile identificare con ragionevole approssima-zione soprattutto le armature usate, ossia quelleche recano chiari danni provocati dall’impattocon la preda, è opportuno chiedersi quante dellearmature già adoperate (ed eventualmente rotte)venissero recuperate nei kill-sites e riportate in-dietro al campo base. la relazione tra attivitàpraticate (i.e. funzione degli strumenti) nell’ac-campamento e tipologia funzionale del medesi-mo viene, dunque, a configurarsi come unadelle principali variabili in grado di influenzarela percentuale delle diverse categorie di manu-fatti. le indagini orientate in questo senso sonoancora ad uno stadio troppo iniziale perché sipossa parlare già di risultati generalizzabili.
Il presente lavoro rientra nell’ambito dei progetti di
ricerca cofinanziati dall’IIPP “Analisi morfofunzionale
delle punte musteriane come contributo alla ricostruzione
dei comportamenti paleoeoeconomici”.
RiFERimEnTi BiBlioGRAFici
ADAm h.D. 1951, Der Waldelefant von Lehringen, eine
Jagdbeute des diluvial Menschen, Quartär 5, pp. 79-92.
BAmFoRTh D.B. 2009, Projectile points, people, and
Plains Paleoindian perambulations, JAS 28,pp. 142-157.
BARTRAm l.E., mAREAn c.W. 1999, Explaining the “Kla-
sies Pattern”: Kua ethnoarchaeology, the Die Kel-
ders Middle Stone Age archaeofauna, long bone
fragmentation and carnivore ravaging, JAS 26,pp. 9-29.
BAR-YoSEF o., mEiGnEn 1992, Middle Paleolithic vari-
ability in Kebara Cave, israel, in AkAzAWA T., Aoki
k., kimURA T., a cura di, The evolution and Disper-
sal of modern Humans in Asia, Tokyo, pp. 129-148.BochEREnS h., BillioU D., PAToU-mAThiS m., oTTE m.,
BonJEAn D., ToUSSAinT m., mARioTTi A. 1999,Palanvironmental and palaeodietary implications of
isotopic biogeochemistry of late interglacial Nean-
derthal and mammal bones in Scladina Cave (Bel-
gium), JAS 26, pp. 599-607.BochEREnS h., DRUckER D.G., BillioU D., PAToU-
mAThiS m., VAnDERmEERSch B. 2005, Isotopic evi-
dence for diet and subsistence pattern of the Saint -
Césaire I Neanderthal: review and use of a multi-
source mixing model, Journal of human Evolution49, 1, pp. 71-87.
BoëDA E. 1982, Etude expérimentale de la technologie des
pointes Levallois, Studia Praehistorica Belgica 2,pp. 23-56.
BoëDA E. 1994, Le concept Levallois: variabilité des mé-
thodes, monographie du cRA 9, Paris, cnRS.BonilAURi S. 2010, Les outils du Paléolithique moyen:
une mémoire technique oubliée? Approche techno-
fonctionelle appliquée à un assemblage lithique de
conception Levallois provenant du site d’Umm el
Tlel (Syrie centrale), Tesi di Dottorato dell’Univer-sità di Parigi ouest nanterre.
BoRDES F. 1961, Typologie du Paléolithique inférieur et
moyen, Delmas, Bordeaux.BoScATo P., GAmBASSini P., RonchiTElli A., 2004, Abri
“L’Oscurusciuto” à Ginosa (Taranto-Italie du Sud):
un noveau site moustérien, AttiUiSPP XiV, Univer-sité de liège, Section 5, BAR S 1239, pp. 275-282.
BoScATo P., RonchiTElli A. 2008, Strutture di combustio-
ne in depositi del Paleolitico medio del Sud Italia,Atti XVii congresso dell’Associazione Antropologi-ca italiana, international Journal of Anthropology(numero speciale), pp. 218-225.
BoScATo P., cREzzini J. 2007, The exploitation of ungulate
bones in Homo neanderthalensis and Homo sapiens,human Evolution 21, 3-4, pp. 311-320.
BoScATo P., GAmBASSini P., RAnAlDo F., RonchiTElli A.2011, Management of paleoenvironmental resources
and raw materials exploitation at the middle Pale-
olithic site of Oscurusciuto (Ginosa, Southern Italy):
units 1 and 4, in conARD n.J., RichTER J., a cura di,Neanderthal lifeways, subsistence and technology -
16 Si ricorda che, in effetti, il già citato studio di Villa et
alii (2009) ha permesso di individuare la presenza di alcu-ne punte con tracce da impatto provenienti da differentiUUSS del riparo.
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.20 Pagina 18
STUDio TEcno-FUnzionAlE DEi SUPPoRTi A moRFoloGiA TRiAnGolARE DEll’US 8 19
One hundred fifty years of Neanderthal study,Springer, pp. 87-98.
BUchAnAn B., collARD m. 2010, A geometric morpho-
metrics-based assessment of blade shape differences
among Paleoindian projectile point types from west-
ern North America, JAS 37, pp. 350-359.BoYlE k.V. 2000, Reconstructing Middle Paleolithic sub-
sistence strategies in the south of France, interna-tional Journal of osteoarchaeology 10, pp. 336-356.
cAlloW P. 1986, The flint tools, in cAlloW P., coRnFoRD
J., a cura di, La Cotte de St. Brelade, norwich Uk,pp. 251-314.
conARD n., PRinDiVillE T.J. 2000, Middle Paleolithic
hunting economies in the Rhineland, internationalJournal of osteoarchaeology 10, pp. 286-309.
ElliS c.J. 1997, Factors influencing the Use of Stone Pro-
jectile Tips. An Ethnographic Perspective, in knEchT
h., a cura di, Projectile Technology, new York,pp. 38-73.
FiSchER A., VEmminG hAnSEn P., RASmUSSEn P. 1984,Macro and Micro Wear Traces on Lithic Projectile
Points, Journal of Danish Archaeology 3, pp. 19-46.GAmBASSini P. a cura di 1997, Il Paleolitico di Castelcivi-
ta: culture e ambiente, materiae 5, napoli.GAUDzinSki S. 1996, On bovid assemblages and their con-
sequences for the knowledge of subsistence patterns
in the Middle Paleolithic, PPS 62, pp. 19-39.GAUDzinSki S. 2000, On the variability of Middle Pale-
olithic procurement tactics: the case of Salzgitter
Lebenstedt, northern Germany, international Journalof osteoarchaeology 10, pp. 396-406.
GAUDzinSki S., RoEBRoEkS W. 2000, Adults only. Rein-
deer hunting at the Middle Paleolithic sites Salzgitter
Lebenstedt, northern Germany, Journal of humanEvolution 38, pp. 497-521.
GooDYEAR A.c. 1982, The chronological position of the
Dalton Horizon in the Southeastern United States,American Antiquity 47, pp. 382-395.
GRAYSon D.k., DElPEch F. 1994, The evidence for Middle
Paleolithic scavenging from stratum VIII, grotte
Vaufrey (Dordogne, France), JAS 21, pp. 359-376.hARDY B.l., kAY m., mARkS A.E., moniGAl k. 2001,
Stone tool function at the paleolithic sites of Starose-
le and Buran Kaya III, Crimea: Behavioral implica-
tions, Proceedings of the national Academy ofSciences 98, 19, pp. 10972-10977.
hoFFEckER J.F., clEGhoRn n. 2000, Mousterian hunting
patterns in the northwestern Caucasus and the ecolo-
gy of the Neanderthals, international Journal ofosteoarchaeology 10, pp. 368-378.
hUGhES S. S. 1998, Getting to the point: evolutionary
change in prehistoric weaponry, Journal of Archaeo-logical method and Theory 5, pp. 345-408.
JAcoB-FRiESEn k.h. 1956, Eiszeitliche elefantenjäger
in der Lüneburger Heide, Jahrbuch des Römische-Germanischen zentralmuseums 3, pp. 1-22.
JAUBERT J., loRBlAnchET m., lAVillE h., SloTT-mollER
R., TURQ A., BRUGAl J-Ph. 1990, Les chasseurs
d’aurochs de la Borde, Documents d’ArchéologieFrançaise 27, la maison des Sciences de l’homme,Paris.
kUhn S.l., STinER m.c. 2006, What’s a mother to do?
The division of labor among Neanderthals and Mod-
ern Humans in Eurasia, current Anthropology 47,pp. 953-980.
lAPlAcE G. 1964, Essai de Typologie systématique, AnnaliFerrara XV, n.s., suppl. ii, pp. 1-79.
lAPlAcE G. 1966, Recherches sur l’origine et l’évolution
des complexes leptolithiques, École Française deRome, «mélanges d’Archéologie et d’histoire»,suppl. 4, Roma.
lYmAn R.l., VAnPool T.l., o’BRiEn m. 2009, The diver-
sity of North American projectile-point types, before
and after the bow and arrow, JAS 28, pp. 1-13.lomBARD m. 2005, Evidence of hunting and hafting aur-
ing the Middle Stone Age at Sibudu Cave, KwaZulu-
Natal: a multianalytical approach, Journal of humanEvolution 48, 279-300.
lomBARD m., PARGETER J. 2008, Hunting with Howiesons
Poort segments: pilot experimental study and the
functional interpretation of archaeological tools,JAS 35, pp. 2523-2531.
lonGo l., ioVino m.R., lEmoRini c. 2001, L’analisi fun-
zionale per lo studio delle industrie litiche. Con
un’appendice sull’analisi delle materie dure animali,RSP lV, pp. 389-454.
lonGo l. 2003, Lo studio delle tracce d’usura sui reperti
litici, in PERETTo c., minElli A., a cura di, Metodo-
logie per lo scavo archeologico. Il caso di Isernia La
Pineta (Molise), collana Ricerche 1, isernia,pp. 155-174.
mAREAn c.W. 2001, From the tropics to the colder cli-
mates: contrasting faunal exploitation adaptations of
modern humans and Neanderthals, in D’ERRico F.,BAckWEll l., a cura di, From Tools to Symbols.
From Early Hominids to Modern Humans, Johannes-burg, pp. 333-371.
mEiGnEn l. 1995, Levallois lithic production systems in
the Middle Paleolithic of the Near East : The case
of the unidirectional method, in DiBBlE h.l., BAR-YoSEF o., a cura di, The Definition and Interpreta-
tion of Levallois Technology, madison, pp.361-380.
milo R.G. 1998, Evidence for hominid predation at
Klasies River Mouth, South Africa, and its implica-
tions fot the behaviour of Early Modern Humans,JAS 25, pp. 99-133.
moncEl m.-h., chAcón m.G., coUDEnnEAU A., FERnAn-DES P. 2009, Points and convergent tools in the Eu-
ropean Early Middle Palaelithic site of Payre (SE,
France), JAS 36, pp. 1892-1909.mUSSi m., VillA P. 2008, Single carcass of Mammuthus
primigenius with lithic artifacts in the Upper Pleis-
tocene of northern Italy, JAS 35, pp. 217-248.oDEll G.h., coWAn F. 1986, Experiments with spears and
arrows on animal targets, JFA 13, pp. 195-212. oAklEY k.P., AnDREWS P., kEElEY l.h., clARk J.D.
1977, A reappraisal of the Clacton Spearpoint, PPS43, pp. 13-30.
PliSSon h., BEYRiES S. 1998, Pointes ou outils triangu-
laires? Données fonctionelles dans le Moustérien le-
vantin, Paléorient 24, pp. 5-24.
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.20 Pagina 19
20 A. RonchiTElli - m. FREGUGliA - l. lonGo - A. moRoni lAnFREDini - F. RAnAlDo
PAToU-mAThiS m. 2000, Neanderthal subsistence behav-
iours in Europe, international Journal of osteoar-chaeology 10, pp. 379-395.
SEllET F. 2004, Beyond the point: projectile manufacture
and behavioral inference, JAS 31, pp. 1553-1566.ShEA J.J., DAViS z., BRoWn k. 2001, Experimental Tests
of Middle Paleolithic Spear Points Using a Calibrat-
ed Crossbow, JAS 28, pp. 807-816.ShEA J.J. 2006, The origin of lithic projectile point tech-
nology: evidence from Africa, the Levant and Eu-
rope, JAS 33, pp. 823-846.SiSk m.l., ShEA J.J. 2009, Experimental use and quantita-
tive performance analysis of triangular flakes (Lev-
allois points) used as arrowheads, JAS 36, pp.2039-2047.
SmiTh m.J., BRicklEY m.B., lEAch S.l. 2007, Experimental
evidence for lithic projectile injuries: improving identifi-
cation of an under-recognised phenomenon, JAS 34,pp. 540-553.
SPETh J.D., TchERnoV E. 1998, The role of hunting and
scavenging in Neanderthal procurement strategies,in AkAzAWA T., Aoki k., BAR-YoSEF o., a cura di,Neanderthals and Modern Humans in Western Asia,new York, pp. 223-239.
STinER m. 1994, Honor among thieves. A zooarchaeologi-
cal study of Neandertal ecology, Princeton.ThiEmE h.1997, Lower Palaeolithic hunting spears from
Germany, nature 385, pp. 807-810.ThiEmE h. 2000, Lower Palaeolithic hunting spears from
Schöningen, Germany. The Oldest Spears in the
world, in DonG W., a cura di, Proceedings of the
1999 Beijing International Symposium on Paleoan-
thropology, Acta Anthropologica Sinica, 10, supple-ment, pp. 136-143.
ThiEmE h., VEil S. 1985, Neue Untersuchungen zum eem-
zeitlichen Elefanten-Jagdplatz, Ldkr. Verden, Diekunde, n.F. 36, pp. 11-58.
VillA P., BoScATo P., RAnAlDo F., RonchiTElli A. 2009,Stone tools for the hunt: points with impact scars
from a Middle Paleolithic site in southern Italy, JAS36, pp. 850-859.
VillA P., lEnoiR m. 2006, Hunting weapons of the Middle
Stone Age and the Middle Palaeolithic: spear points
from Sibud, Rose Cottage and Bouheben, SouthernAfrican humanities 18, 1, pp. 89-122.
WEBER T. 2000, The Eemian Elephas antiquus finds with
artefacts from Lehringen and Gröbern, ERAUl 51,pp. 177-185.
WEninGER, B., JöRiS, o., DAnzEGlockE, U. 2007, CalPal-
2007. Cologne Radiocarbon Calibration and Paleo-
climate Research Package, http://www.calpal.de/,accessed 2009-12-15.
YARochEVich A., kAUFmAn D., nUzhnYY D., BAR-YoSEF
o., WEinSTEin-EVRon m. 2010, Design and perform-
ance of microlith implemented projectiles during the
Middle and the Late Epipaleolithic of the Levant: ex-
perimental and archaeological evidence, JAS 37,pp. 368-388.
01_Ronchitelli-impaginato_Layout 1 16/01/12 15.20 Pagina 20
MoMoRie
a. RonchiteLLi, M. FRegugLia, L. Longo, a. MoRoni LanFRedini, F. RanaLdo, studio tecno-
funzionale dei supporti a morfologia triangolare dell’us 8 del Riparo L’oscurusciuto (ginosa -
taranto) ........................................................................................................................................
M. dini, J. conFoRti, Lo sfruttamento del quarzo nel Musteriano, uluzziano e aurignaziano di
grotta La Fabbrica (grosseto, italia) ...........................................................................................
n.n. skakun, M.g. zhiLin, v.v. teRekhina, technology of the processing of bone and antler at
ivanovskoje 7 Mesolithic site, central Russia .............................................................................
M.g. MeLis, a. d’anna, R. cappai, J.L. guendon, L. Manca, s. piRas, F. souLa, una ricerca
internazionale e interdisciplinare nel territorio di usini (sassari): la necropoli a domus de
janas di s’elighe entosu ..............................................................................................................
t. scaRano, Refuge or dwelling place? the MBa fortification wall of Roca (Lecce, italy): the
spatial and functional analysis of postern c ................................................................................
i. MaLoRgio, g, MaggiuLLi, Roca (Lecce), sas iX: la struttura incendiata dell’età del bronzo
finale. scavo e analisi del contesto ..............................................................................................
s.t. Levi, M. BetteLLi, a. di Renzoni, F. FeRRanti, M.c. MaRtineLLi, 3500 anni fa sotto il
vulcano. La ripresa delle indagini nel villaggio protostorico di san vincenzo a stromboli ........
g. BaRone, p. MazzoLeni, d. tanasi, c. veca, La tecnologia della produzione ceramica nel Bronzo
Medio siciliano: il caso dei pithoi di Monte san paolillo (catania) ..............................................
R. Leighton, La casa 16W del Bronzo Finale sulla cittadella di Morgantina (sicilia): aspetti
strutturali, zone di attività e status sociale ...................................................................................
g. pagLietti, analisi del corredo ceramico dei pozzetti della capanna 135 di su nuraxi (Barumini,
cagliari) .......................................................................................................................................
a. depaLMas, g. Fundoni, F. Luongo, Ripostiglio di bronzi della prima età del ferro a sant’imbenia -
alghero (sassari) ..................................................................................................................................
p. BeLLintani, progetto “Materiali vetrosi della protostoria italiana”. aggiornamenti e stato della
ricerca ...........................................................................................................................................
MetodoLogia
L. Longo, Lewis Roberts Binford, padre nobile della new archeology. In memoriam (1931-2011) .
L. MaRitan, R. piovesan, c. MazzoLi, a. guidi, M. saRacino, caratterizzazione archeometrica
preliminare di materiali ceramici provenienti dal territorio di Mondragone (caserta) ...............
notiziaRio
scoperte e scavi preistorici in italia nell’anno 2010 .............................................................................
Recensione .....................................................................................................................................
istituto itaLiano di pReistoRia e pRotostoRia. attività 2010 .....................................
noRMe peR gLi autoRi ................................................................................................................
5
21
39
59
95
123
157
173
197
215
231
257
285
315
331
349
351
367
Rivista di scienze pReistoRichevol. LXi - 2011
indice
19_INDICE VOLUME_Layout 1 30/12/11 08.58 Pagina 373
Edizioni ETSPiazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
[email protected] - www.edizioniets.comFinito di stampare nel mese di dicembre 2011
19_INDICE VOLUME_Layout 1 30/12/11 08.58 Pagina 374






















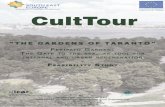











![Il corpo come immagine del non funzionale in "Recordaçoes da Casa Amarela. Uma Comédia Lusitana" di João César Monteiro (1989) [2004]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6331c6c4576b626f850d18d3/il-corpo-come-immagine-del-non-funzionale-in-recordacoes-da-casa-amarela-uma.jpg)








