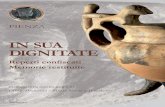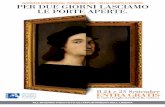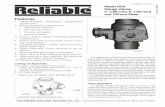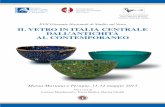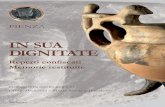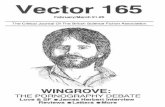ROMAN SCULPTURE / Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) I, in Picus 33, 2013, pp....
Transcript of ROMAN SCULPTURE / Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) I, in Picus 33, 2013, pp....
GIULIA BARATTA
REPERTI SCULTOREI DA TUFICUM (BORGO TUFICO, ALBACINA) I
Il presente contributo costituisce un primo approccio allo studio dei
reperti scultorei pertinenti al municipio di Tuficum, corrispondente alle attuali frazioni Borgo Tufico ed Albacina del comune di Fabriano (AN), che qui si presentano in un catalogo organizzato per singole schede, una scelta che è parsa la più appropriata alla luce del fatto che si tratta di ma-teriale estremamente eterogeneo e che abbraccia un ampio arco cronolo-gico, che va dal VI secolo a.C. al III e forse addirittura agli inizi del IV secolo d.C. (1).
Lo studio di questo materiale trova un primo grande limite nel fatto che tutti i pezzi attualmente noti sono frutto di rinvenimenti casuali, a partire almeno dal XVII secolo, la cui documentazione risulta in genere carente di informazioni sulle singole sculture e sui luoghi e contesti di rinvenimento. Mancano pertanto dati preziosi e soprattutto risulta molto difficile riuscire a ricostruire i loro originali contesti di pertinenza anche per le poche conoscenze che si hanno sull’organizzazione urbana di Tufi-cum in epoca romana, sui suoi antecedenti abitativi, sul suo sviluppo sto-rico e sulla sistemazione del suo territorio (2). A questo si aggiunge il fat-
(1) Questo lavoro si inserisce nell’ambito del progetto FFI2011-25113 e del Grup
de Recerca Consolidat LITTERA (2009SGR1254). (2) Su Tuficum ed in particolare sulle evidenze archeologiche del suo periodo roma-
no vedi I. VENANZONI, Il municipio di Tuficum, in La forma della città e del territorio, 2, Roma 2005 (= ‘A.T.T.A.’ 14), pp. 37-52; circa le difficoltà di lettura ed interpretazione
«Picus» XXXIII (2013), pp. 165-209 – ISSN 0394-3968
GIULIA BARATTA 166
to che molte sculture hanno subito una diaspora e sono confluite in colle-zioni private, sia locali che romane, o sono state acquistate da musei; diver-si pezzi, inoltre, sono oggi irreperibili, e vanno dunque ritenuti perduti.
Dall’analisi d’insieme delle sculture risulta che queste, pur abbrac-ciando un ampio arco cronologico di almeno nove secoli, si concentrano in due periodi ben distinti, il primo riferibile al VI-V secolo a.C. ed il se-condo compreso tra il I e il III-IV secolo d.C.
Il primo gruppo è composto esclusivamente da alcune figurine di bronzo di tradizione umbra, raffiguranti un guerriero, il così detto Marte in assalto (cat. nn. 1; 2; 3), che confermano la frequentazione o più pro-babilmente la presenza di un abitato sul sito di Tuficum in questo periodo. Del resto il territorio tuficano, che per la sua posizione nel settore setten-trionale della sinclinale camerte, ha rivestito sin dalla preistoria un ruolo molto importante nelle comunicazioni appenniniche attraverso il valico di Fossato di Vico, ha restituito testimonianze, seppure scarse, riferibili già al neolitico finale e all’eneolitico (3). Inoltre, lungo il torrente Giano, in località Sacramento e Santa Maria in Campo sono state individuate due necropoli (VII-VI secolo a.C.) i cui ricchi corredi comprendono, accanto a reperti metallici di produzione locale, anche elementi che mostrano i le-gami con il versante tirrenico della penisola (4).
Al momento le testimonianze figurate evidenziano un “vuoto” che abbraccia tutto il periodo repubblicano. Si tratta di secoli di difficile in-terpretazione per l’abitato tuficano e per il suo territorio a causa delle scarse attestazioni archeologiche tra cui spicca comunque la tomba galli-ca di Moscano di Fabriano databile al IV secolo a.C, caratterizzata tra
delle tracce archeologiche I. VENANZONI, Alcune considerazioni sul municipio di Tuficum e sul suo territorio, in M. DESTRO - E. GIORGI (a cura di), L’Appennino in età romana e nel primo Medioevo. Viabilità e popolamento nelle Marche e nell’Italia centro-settentrionale. Atti del convegno di Corinaldo (28-30 giungo 2001), Bologna 2004, pp. 289-291; vedi inoltre per una breve sintesi C. CARDINALI, Tuficum - Borgo Tufico, in M. LUNI (ed.), Archeologia nelle Marche. Dalla preistoria all’età tardo antica, Firenze 2003, pp. 178-179 e i contributi nel volume M.F. PETRACCIA (a cura di), Tuficum in età romana, Fabriano 2013 ed in particolare l’articolo di M. Mayer i Olivé sulla società del municipio.
(3) Vedi VENANZONI, Il municipio di Tuficum, cit., pp. 48-49. (4) A. NASO, I Piceni. Storia e archeologia nelle Marche in epoca preromana, Mi-
lano 2000, p. 101-109 e Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Sezione protostori-ca, i Piceni, Ancona 1998, p. 77.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 167
l’altro da una spada celtica di ferro con fodero di bronzo di stile latenia-no, così detto di Waldalgesheim, da bronzi etruschi e campani e da vasi attici a figure rosse e nere (5). Allo stato attuale risulta anche difficile de-finire i termini e i limiti cronologici della romanizzazione di questo terri-torio, il cui processo subisce probabilmente una accelerazione con la bat-taglia di Sentinum del 295 a.C. (6) e con l’apertura della via Flaminia, e della conseguente formazione dell’abitato romano di Tuficum. Pochi e scarsi elementi, tra cui in particolare la stele funeraria di Titus Statorius (7), rinvenuta a Rocchetta di Fabriano, ed alcuni frammenti di ceramica a vernice nera di produzione locale (8) rimontano alla fine dell’epoca re-pubblicana e potrebbero costituire un buon indizio per collocare la nascita del municipio romano in questo periodo, verosimilmente dopo il 90 a.C., data generalmente accettata per la creazione di municipi retti da una ma-gistratura quattuorvirale, quale è il caso di Tuficum (9).
Il secondo e ben più nutrito nucleo di sculture risale ad età imperiale. La maggior parte delle testimonianze sono inquadrabili tra il I e il II seco-
(5) D.G. LOLLINI, Museo archeologico Nazionale delle Marche. Sezione protostori-
ca, Roma 1991 (= ‘Itinerari dei Musei, Gallerie, Scavi e Monumenti d’Italia’ 4), pp. 43-45; Museo Archeologico Nazionale, cit., pp. 159-162.
(6) Per le vicende successive a Sentinum vedi G. BANDELLI, Roma e l’Italia centrale dalla battaglia del Sentino (295 a.C.) al plebiscito di Gaio Flaminio (232 a.C.), in D. PO-LI (a cura di), La battaglia del Sentino. Scontro fra nazioni e incontro in una nazione. Atti del convegno di Studi (Camerino-Sassoferrato, 10-13 giugno 1998), pp. 63-80. Per un e-ventuale rapporto federale con Roma vedi W.V. HARRIS, Rome in Etruria and Umbria, Oxford 1971, pp. 100-101.
(7) Ann. épigr. 1982, 257; G. SUSINI, Lapis Tuficanus, in «Epigraphica» 41 (1979), pp. 152-154; S.M. MARENGO, Documentazione epigrafica e insediamenti nell’Umbria a-driatica in età tardo-repubblicana, in Monumenti e culture nell’Appennino in età romana. Atti del Convegno (Sestino (AR), 12 novembre 1989), Roma 1993 (= ‘Studia archaeologi-ca’ 65), pp. 114-115; M. TRAMUNTO, Silloge epigrafica tuficana, in PETRACCIA (a cura di), Tuficum, cit., c.d.s.
(8) R. VIRZÌ, Recenti scoperte nelle province di Ancona e Macerata, in «Atti Mem. Dep. St. patr. Marche» LXXXIX-XCI (1984-1986), pp. 349-351.
(9) Vedi a tale proposito U. LAFFI, Sull’organizzazione amministrativa dell’Italia dopo la guerra sociale, in Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik (München 1972), München 1973, pp. 37-53; G. PACI, Umbria ed agro gallico a nord del fiume Esino, in «Picus» XVIII (1998), pp. 98-100. Più in generale per la romanizzazione di questo territorio vedi, con ricca bibliografia precedente, MAREN-GO, Documentazione epigrafica, cit., pp. 109-110.
GIULIA BARATTA 168
lo d.C. mentre al III secolo d.C. risale solo un ritratto maschile in bronzo (cat. n. 18) ed una statua di Musa (cat. n. 26) che forse può essere attri-buita anche ai primi anni del IV secolo d.C. Questo dato cronologico cal-za perfettamente con le altre testimonianze di cui si dispone per Tuficum (10). Il materiale epigrafico, infatti, abbraccia un arco cronologico che va dalla fine del I secolo a.C. al 203-204 d.C., anno al quale risale una dedi-ca a Plauziano, padre di Plautilla moglie di Caracalla, una delle iscrizioni più tarde del municipio (11), ed indica uno sviluppo della vita cittadina sostanzialmente compreso tra il regno di Tiberio e quello degli Antonini (12). Anche le fonti archeologiche testimoniano il fiorire del sito nel I se-colo d.C. e particolarmente nella prima metà del II secolo d.C., ma a dif-ferenza di quelle epigrafiche, attestano una continuità di vita ancora nel III e addirittura nel IV-V secolo d.C., periodo al quale sono state datate, sulla base dei materiali rinvenuti, alcune strutture pertinenti probabilmen-te ad una villa rustica (13).
Le sculture di epoca romana comprendono pezzi in bronzo e marmo. Tra i primi si distacca una statuetta maschile con iscrizione (cat. n. 4), oggi perduta, ed il ritratto in bronzo forse attribuibile a Treboniano Gallo (n. 18) che costituisce una delle testimonianze scultoree più tarde del sito. Tra le statue in marmo vanno segnalati alcuni ritratti sia maschili che femminili, anche di natura “ufficiale” (cat. n. 17), ed almeno un elemento di arredo di una fontana o di un ninfeo pertinente ad una ricca domus o ad un edificio di carattere pubblico (cat. n. 25). Per altri pezzi, perduti (cat.
(10) Anche i siti vicini, in particolare Attidium, mostrano le stesse fasi cronologiche: vedi S.M. MARENGO, Attidium, in Supplementa italica, 12, Roma 1994, pp. 13-17; C. PANDOLFI, Attidium: appunti per la ricostruzione della forma della città, in Architettura pubblica e privata nell’Italia antica, Roma 2007 (= ‘A.T.T.A.’ 16), pp. 37-52; M.F. PE-TRACCIA, Attidium in età romana, Fabriano 2009, pp. 14-16.
(11) C.I.L. XI 8050 = I.L.S. 9003 = Ann. épigr. 1894, 144 e da ultimo TRAMUNTO, Silloge epigrafica tuficana, cit., c.d.s.
(12) Vedi a tale proposito M. MAYER I OLIVÉ, Municipes et incolae Tuficani utrius-que sexus. Algunas consideraciones sobre la sociedad de una ciudad de la regio VI: Tufi-cum,in PETRACCIA (a cura di), Tuficum, cit., c.d.s. per la testimonianza epigrafica più tarda costituita dall’iscrizione dedicata a Plautianus.
(13) Per questa struttura vedi VENANZONI, Il municipio di Tuficum, cit., pp. 50-52; G. PIGNOCCHI - T. SABBATINI, Fabriano (AN), in «Picus» XXI (2001), pp. 234-235; M. MANCINI - G. PIGNOCCHI, L’insediamento romano imperiale in località Le Muse di Alba-cina (Fabriano - AN), in «Picus» XXV (2005), pp. 313-328.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 169
nn. 20; 21; 28) o frammentari (cat. nn. 22; 29) non è possibile stabilire né la reale natura dei soggetti né tantomeno l’ambito di pertinenza. L’ambiente religioso e cultuale del municipio è documentato da una sta-tua di Attis (cat. n. 23) e da due sculture, oggi perdute, raffiguranti, se-condo le fonti a disposizione, rispettivamente Cibele (cat. n. 24) e Cerere (cat. n. 27).
Allo stato attuale non è possibile trovare una corrispondenza certa tra le iscrizioni onorifiche, quelle legate all’ambito funerario o al mondo cultuale, a parte il caso della dedica della statua di Attis (cat. n. 23), ed il materiale scultoreo di cui si è a conoscenza. L’unica eccezione potrebbe essere costituita dal ritratto di Tiberio (cat. n. 17): questo infatti potrebbe essere posto in relazione all’iscrizione C.I.L. XI 8049, consacrata al Genius dell’imperatore, forse vincolata ad un Augusteum di cui potrebbe aver fatto parte anche la statua di Tiberio della quale oggi resta la sola testa.
Purtroppo neanche i reperti scultorei forniscono informazioni utili per ricostruire le vicende che hanno portato alla fine del municipio di Tu-ficum, la cui decadenza, nonostante la vita vi sia continuata sino ad alme-no il IV-V secolo d.C., sembra comunque iniziare già nel III secolo d.C., ed essere dovuta a diversi fattori di crisi, legati agli eventi bellici che hanno visto coinvolto questo territorio, dunque alla mancanza di sicurez-za ed ai mutamenti economici e demografici e forse anche a flagelli quali la “peste” (14) o eventi catastrofici come terremoti che potrebbero aver contribuito a decimarne la popolazione (15). Effettivamente il ritratto bron-zeo (cat. n. 18) raffigurante forse Treboniano Gallo sembrerebbe essere sta-to distrutto in conseguenza della damnatio memoriae decretata dal senato per l’imperatore, ma nulla esclude che possa aver subito danni anche a cau-sa di un evento naturale di grande portata come può esserlo un sisma.
Il silenzio delle fonti su quanto abbia portato al definitivo abbandono di Tuficum e quando precisamente collocarlo, è totale, e allo stato attuale
(14) Sulla peste vedi di recente J. VITAUX, Histoire de la peste, Paris 2010, part. p.
10 in cui si chiarisce che per quanto riguarda il mondo antico la definizione di epidemia di peste non sempre corrisponde alla peste vera e propria ma può essere relativa anche ad al-tre malattie, ad esempio il tifo.
(15) Sui terremoti nel mondo antico vedi E. GUIDOBONI (a cura di), I terremoti pri-ma del Mille in Italia e nell’area mediterranea, Bologna 1989 e EAD., Catalogue of an-cient earthquakes in the Mediterranean area up to the 10th century, Roma 1994.
GIULIA BARATTA 170
non rimane che rimandare molto genericamente alle note vicende storiche del VI-VII secolo d.C. ed in particolare alle conseguenze della conquista longobarda (16).
CATALOGO
1. Statuetta bronzea di guerriero o del tipo Marte in assalto (Fig. 1)
Luogo e contesto di rinvenimento: il bronzetto è stato rinvenuto in data non precisata, ma comunque anteriormente al 1733, nei pressi di Moscano ove si tro-vava Corrotone Castello.
Materiale: bronzo. Misure: non indicate. Sulla base dei confronti circa 15-20 cm. Luogo di conservazione: il pezzo, come si deduce dal testo del Graziosi, si
conservava almeno nella quarta decade del ‘700 presso i conti Stelluti; oggi non risulta reperibile.
Bibl.: F.C. GRAZIOSI, Memorie istoriche della città di Fabriano in sei libri,
Fabriano 1733 (17); ms. dell’archivio di S. Nicolò, p. 62 con fig.; ms. conservato nella Biblioteca Ramelli, pp. 72-73.
(16) Sull’abbandono dell’abitato vedi VENANZONI, Tuficum: ipotesi sull’assetto ur-
bano e sul territorio, in PETRACCIA (a cura di), Tuficum, cit., c.d.s. N. ALFIERI, Le Marche e la fine del mondo antico, in Istituzioni e società nell’alto Medioevo marchigiano (parte prima). Atti del convegno (Ancona-Osimo-Jesi, 17-20 ottobre 1981), Ancona 1983 (= ‘At-ti e Memorie’ 86), pp. 9-34, part. p. 26 e p. 30; M. DESTRO, L’abbandono delle città in-terne delle Marche settentrionali tra età romana ed alto medioevo, in E. MENESTÒ (a cura di), Ascoli e le Marche tra tardo antico e alto medioevo. Atti del convegno di studio svol-tosi in occasione della XVI edizione del «Premio internazionale Ascoli Piceno» (Ascoli Piceno, 5-7 dicembre 2002), Spoleto 2004, pp. 101-121, in part. 115. Vedi anche la teoria di S. DEL LUNGO, Spazi urbani e relativi territori nelle Marche centro-meridionali fra VI e IX secolo: alcuni esempi, in Tardo antico e alto medioevo tra l’Esino e il Tronto. Atti del XL convegno di Studi Maceratesi, Macerata 2006 (= «Studi maceratesi» 40), pp. 89-90 e pp. 98-99 secondo cui Tuficum nei secoli VII ed VIII è un oppidum del castaltato di castrum Petrosum di grande importanza perché posto in un punto strategico per il control-lo della viabilità.
(17) Il testo originale Memorie istoriche della citta’ di Fabriano in sei libri descritte da D. Francesco Carlo Graziosi scritte nell' anno del sig.re 1733 non risulta allo stato at-tuale reperibile negli archivi da me consultati. Del testo esistono però due trascrizioni ot-tocentesche conservate entrambe a Fabriano, rispettivamente nell’archivio Ramelli e in quello di S. Nicolò. Nel primo archivio si conserva una copia del manoscritto del Graziosi in 2 volumi, in ottimo stato di conservazione, per un totale di 1150 fogli, redatto a cura di
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 171
Fig. 1 – Bronzetto, ms. di S. Nicoló, p. 62.
Il pezzo viene descritto da Francesco Carlo Graziosi come una statua di mi-
litare, simile ad un’altra rinvenuta però in un territorio un tempo soggetto ad At-tidium (18) o Sentinum: «La 10a e 11a figura a mio credere sono due soldati, tro-
alcuni allievi di C. Ramelli verso il 1840, come si desume dalla filigrana della carta. La trascrizione di questo manoscritto si deve al Dott. Paolo Selini, responsabile dell’archivio, che ringrazio per avermene aperto le porte e permesso l’uso dei materiali. Il manoscritto conservato nell’archivio di S. Nicolò, probabilmente anteriore a quello dell’archivio Ra-melli, reso anonimo per la cancellazione del nome del Can. Francesco Graziosi, suo com-pilatore, contiene soltanto i primi tre libri delle Memorie istoriche… ma, a differenza dell’altro, vi sono riprodotte alcune delle immagini che dovevano essere presenti nel testo originale, la cui scansione mi è stata gentilmente concessa dal Dott. Paolo Selini che rin-grazio anche per questo.
(18) Nella sede dell’Archeoclub di Fabriano si conserva la documentazione fotogra-fica di un bronzetto rinvenuto in località Castiglione, presso Attiggio, ed oggi non più rin-tracciabile, raffigurante una guerriero o Marte di probabile produzione locale datato VI-V secolo a.C., vedi N. FRAPICCINI ALFIERI, Un bronzetto italico dal Fabrianese, in «Picus» VII (1987), pp. 139-142.
GIULIA BARATTA 172
vandosene di questi parecchi per essere stato il mestiere dell’armi, il più pra-ticato in quei tempi, onde, o essi, o i loro figliuoli potevano con quelle figure vederne i ritratti, come si fa oggigiorno in tela, ed anche in memoria di qual-che pericolo scampato farne una specie dirò cosi di voto per riconoscerne qualche lor falsa Deità.
Il cimiero, la positura, le mani così attuate, ad abito più naturale, che arti-ficiale, che portano, concorrono in questa mia opinione».
Il disegno del manoscritto sinora inedito conservato nell’archivio della chiesa di San Niccolò consente una identificazione molto più precisa del bronzet-to. Questo infatti rappresenta una figura maschile, mancante della porzione infe-riore delle gambe, nell’atto di avanzare con la sinistra e con indosso una corazza completa di spallacci i cui margini sono evidenziati dai tratti curvi sul torace, sotto la quale si intravedono due ordini di pteryges, resi con tratti orizzontali, che lasciano scoperto il sesso. Sul capo indossa un elmo con un grande cimiero che termina a punta nella parte posteriore. Il braccio destro, discosto dal corpo, è ab-bassato e presenta una mano chiusa e forata nella quale doveva essere inserita una lancia. L’altro braccio, invece, parzialmente mancante, è alzato e in origine doveva reggere uno scudo.
Per le sue caratteristiche sembra trattarsi di un bronzetto votivo di tradizio-ne umbra settentrionale, raffigurante un guerriero o Marte (19), un tipo assai fre-quente nel periodo arcaico, nel VI e soprattutto nel V secolo a.C. (20). In questo
(19) Circa la questione se questi bronzetti raffigurino guerrieri o Marte vedi da ulti-
mo, sinteticamente, N. FRAPICCINI, Bronzetti votivi italici nel Museo Civico Archeologico di Sassoferrato, in M. MEDRI (a cura di), Sentinum 295 a.C. Sassoferrato 2006, 2300 anni dopo la battaglia. Una città romana tra storia ed archeologia. Convegno internazionale (Sassoferrato 21-23 settembre 2006), Roma 2008, p. 259, nota n. 9.
(20) Per alcuni confronti vedi i pezzi della stipe votiva di Cagli in G. BENDINELLI, Bronzi votivi italici nel Museo Nazionale di Villa Giulia, in «Monumenti antichi» 26 (1920), pp. 222-266 in particolare i pezzi nn. 2-4 e 6-7 e i numerosi esemplari in G. CO-LONNA, Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana. I - periodo “arcaico”, Firenze 1970 (= ‘Studi e materiali di etruscologia e antichità italiche’ 8). Vedi inoltre due statuet-te etrusco-italiche in A. DE RIDDER, Bronzes antiques du Louvre. Tome premiér. Les figu-rines, Paris 1913, p. 47, nn. 279-280; W. DEONNA, Catalogue des bronzes figurés anti-ques. Extrait de l’indicateur d’antiquités suisses 1915-1916, p. 137, part. n. 136; S. BOU-CHER, Bronzes grecs, hellénistiques et étrusques (sardes, ibériques et celtiques) des mu-sées de Lyon, Lyon 1970 (= ‘Travaux edites sous les auspices de la ville de Lyon’ II), p. 76, n. 55; M.T. FALCONI AMORELLI (a cura di), Todi preromana. Cataloghi dei materiali conservati nel Museo Comunale di Todi, s.l., s.d., pp. 167-171; M.T. FALCONI AMORELLI, I materiali archeologici pre-romani del Museo Oliveriano di Pesaro, Roma 1982 (= ‘Univer-sità di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia’ 8), pp. 29-34, nn. 1-6; E.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 173
caso il bronzetto appartiene alla variante in cui il braccio che regge la lancia è abbassato e non alzato (21), e forse è inquadrabile nel gruppo «Fabriano» della classificazione di Giovanni Colonna (22).
2. Statuetta bronzea di guerriero o del tipo Marte in assalto (Fig. 2)
Fig. 2 – Bronzetto, G. ANNIBALDI, Il museo nazionale delle Marche in Ancona, Ancona 1958 (?), p. 20.
Luogo e contesto di rinvenimento: rinvenuto casualmente a Vallemonta-gnana, frazione di Fabriano, nel secolo XX.
Materiale: bronzo. RICHARDSON, Etruscan Votive Bronzes. Geometric, orientalizing, archaic, Mainz am Rhein 1983, p. 172 ss.; A.-M. ADAM, Bronzes étrusques et italiques, Paris 1984, in part. p. 175, nn. 259-260; C. CAGIANELLI, Bronzi a figura umana, Città del Vaticano 1999 (= ‘Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie. Museo Gregoriano Etrusco’), pp. 187-188, n. 26.
(21) Vedi ad es. COLONNA, Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana, cit., p. 97, n. 266. Vedi anche un esemplare in P. CÀSSOLA GUIDA, I bronzetti friulani a figura umana tra protostoria ed età della romanizzazione, Roma 1989 (= ‘Cataloghi e mono-grafie archeologiche dei civici Musei di Udine’), pp. 34-35, n. 6; FRAPICCINI, Bronzetti votivi italici, cit., pp. 259-260, n. 1
(22) Cfr. COLONNA, Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana, cit., pp. 39-56.
GIULIA BARATTA 174
Misure: h. 16,6 cm. Luogo di conservazione: Ancona, Museo Archeologico Nazionale delle
Marche, inv. 19412. Bibl.: G. ANNIBALDI, Il museo nazionale delle Marche in Ancona, Ancona
1958 (?), p. 20; G. COLONNA, Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana. I - periodo “arcaico”, Firenze 1970 (= ‘Studi e materiali di etruscologia e antichità italiche’ 8), p. 39, n. 47.
Il bronzetto mostra una figura maschile, mancante dei piedi, nell’atto di a-
vanzare con la gamba sinistra. Indossa una corazza completa di spallacci i cui margini sono evidenziati da una linea accompagnata da file di punti, che ne sot-tolinea anche il limite all’altezza del collo, e con altre decorazioni anch’esse rese con dei puntini. Sotto la corazza si intravede un ordine di pteryges piuttosto lun-ghe che lasciano scoperto il sesso. Sul capo indossa un elmo con un grande ci-miero, mancante dell’estremità inferiore, decorato da elementi lineari e caratte-rizzato dai paraguance alzati. Il braccio destro è alzato e nella mano chiusa a pu-gno doveva in origine essere inserita una lancia, mentre l’altro braccio è portato davanti al petto e doveva sorreggere uno scudo. Gli occhi sono resi con un ovale inciso meccanicamente caratterizzato da un punto centrale e la bocca è realizzata con tre tagli paralleli.
La statuetta del tipo Marte in assalto è stata attribuita da G. Colonna all’ambiente umbro settentrionale e più precisamente al gruppo «Fabriano» e va pertanto inquadrata cronologicamente al VI-V secolo a.C.
3. Statuetta bronzea di guerriero o del tipo Marte in assalto
Luogo e contesto di rinvenimento: rinvenuto casualmente a Vallemonta-gnana, frazione di Fabriano, nel secolo XX.
Materiale: bronzo. Misure: h. 15,5 cm. Luogo di conservazione: Ancona, Museo Archeologico Nazionale delle
Marche, inv. 9352.
Bibl.: G. COLONNA, Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana. I - peri-odo “arcaico”, Firenze 1970 (= ‘Studi e materiali di etruscologia e antichità ita-liche’ 8), pp. 64-65, n. 134.
Questa statuetta si caratterizza per avere le gambe allargate, ed un elmo
semplificato indicato dal solo cimiero liscio. Occhi, capezzoli ed ombelico sono resi con un cerchiello e la bocca con un taglio orizzontale. Il torso è laminare e la testa piuttosto stretta.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 175
Il pezzo è stato classificato da Colonna tra i bronzetti votivi umbro setten-trionali del tipo Marte in assalto del gruppo «Marzabotto». La sua datazione cor-risponde a quella degli altri esemplari (cat. nn. 1; 2): VI-V secolo a.C.
4. Bronzetto di C. Pomponius (Fig. 3)
Fig. 3 – Descrizione del bronzetto,
dettaglio del testo del ms. dell’archivio di S. Nicoló a Fabriano, p. 61.
Luogo e contesto di rinvenimento: il pezzo è stato rinvenuto nel giugno del 1600, in occasione della realizzazione di alcuni fossi sul sito dell’antico municipio di Tuficum, insieme ad altri 11 bronzetti (cat. nn. 5-15).
Materiale: bronzo. Misure: h. circa 30 cm (23). Luogo di conservazione: non più reperibile, perduto.
Bibl.: F.C. GRAZIOSI, Memorie istoriche della città di Fabriano in sei libri, Fabriano 1733, ms. dell’archivio di S. Nicoló, p. 61; ms. conservato nella Biblio-teca Ramelli a Fabriano, p. 72.
(23) L’unità di misura, il piede, citata dal Graziosi deve corrispondere al piede ro-mano in uso nel XVIII secolo nello Stato Pontificio e corrispondente a 29,6 cm.
GIULIA BARATTA 176
Riguardo a questo bronzetto F.C. Graziosi scrive: «Ancora nel 1600 facen-dosi certi fossi, ove era situato Tufico, nel mese di Giugno vi furono rinvenute 12 statue di bronzo, ciascuna delle quali era dell’ altezza di un piede, o poco meno, in una di queste erano scolpite queste parole C. POMPONIO VIRO l’altre poi erano rose, che non potevansi leggere, ma le altre erano senz’ alcuna descrizio-ne, come altresì una donna molto vaga, che sedeva».
Secondo la descrizione fornita dal Graziosi (Fig. 3) la statuetta sarebbe stata corredata da un testo epigrafico C. Pomponio viro che dobbiamo supporre apposto alla sua base. Non è escluso che questo sia stato trascritto solo in parte e che dopo viro ci fosse un aggettivo di qualifica del personaggio menzionato anche se, in questo caso, pare da escludere la formula viro clarissimo. È inoltre anche possibile che in origine si leggesse C. Pomponio Vero (24), con la E resa con due tratti verticali II, e che questa soluzione grafica possa aver indotto, forse a causa della cattiva conservazione del supporto scrittorio e del testo epi-grafico, la lettura viro.
Purtroppo non è possibile aggiungere altro non essendo il pezzo più rin-tracciabile e trattandosi, da un punto di vista onomastico, di un nome con un eventuale gentilizio piuttosto frequente che, almeno allo stato attuale delle co-noscenze, non consente di trovare una relazione certa con uno specifico perso-naggio del luogo o del circondario.
La cronologia esatta del bronzetto non è determinabile e va collocata, sulla base dei dati a disposizione sul municipio di Tuficum, tra il I secolo a.C. e il III d.C. e, preferibilmente, nei primi due secoli dell’impero.
5. Bronzetto muliebre
Luogo e contesto di rinvenimento: il pezzo è stato rinvenuto nel giugno del 1600, in occasione della realizzazione di alcuni fossi sul sito dell’antico municipio di Tuficum, insieme ad altri 11 bronzetti (cat. nn. 4; 6-15).
Materiale: bronzo. Misure: h. circa 30 cm (25). Luogo di conservazione: non più reperibile, perduto.
Bibl.: F.C. GRAZIOSI, Memorie istoriche della città di Fabriano in sei libri, Fabriano 1733; ms. dell’archivio di S. Nicoló, p. 61; ms. conservato nella Biblio-teca Ramelli a Fabriano, p. 72.
(24) Il nome è attestato in un’iscrizione di Mediolanum, C.I.L. V 5883 = Ann. épigr.
1994, 725. (25) Vedi supra nota 23.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 177
Del pezzo rimane solo la breve descrizione di F.C. Graziosi secondo il qua-le la statuetta alta «un piede o poco meno» ritraeva «una donna molto vaga, che sedeva» (Fig. 3). Probabilmente si tratta di un bronzetto di epoca romana inqua-drabile sulla base dei dati a disposizione sul municipio di Tuficum tra il I secolo a.C. e il III d.C. e, preferibilmente, nei primi due secoli dell’impero.
6.-15. Bronzetti vari (10 pezzi)
Luogo e contesto di rinvenimento: questi 10 pezzi sono stati rinvenuti nel giugno del 1600, in occasione della realizzazione di alcuni fossi sul sito dell’antico municipio di Tuficum, insieme al bronzetto di C. Pomponius (cat. n. 4) e a quello muliebre (cat. n. 5).
Materiale: bronzo. Misura: h. circa 30 cm (26). Luogo di conservazione: non più reperibili, perduti.
Bibl.: F.C. GRAZIOSI, Memorie istoriche della città di Fabriano in sei libri, Fabriano 1733, ms. dell’archivio di S. Nicoló, p. 61; ms. conservato nella Bi-blioteca Ramelli a Fabriano, p. 72.
Di questi bronzetti non rimane alcuna specifica descrizione che possa consen-
tirne una identificazione e tantomeno un inquadramento cronologico neanche per epoche preromana e/o romana anche se l’attribuzione a quest’ultima pare la più ra-gionevole. In questo caso i bronzetti andrebbero datati ad un periodo compreso tra il I secolo a.C. e il III secolo d.C. e preferibilmente al I-II secolo d.C. Il Graziosi, che ne fornisce l’altezza indicata in «un piede o poco meno», scrive solo «l’altre (cioè queste 10 statuette) poi erano rose, che non potevansi, leggere, ma le altre erano senz’alcuna descrizione» (Fig. 3) indicando, con questo, che a differenza della statuetta di C. Pomponius (cat. n. 4) queste erano in cattivo stato di conserva-zione e prive di iscrizione o corredate da un testo oramai illeggibile.
16. Bronzetto di offerente (Fig. 4)
Luogo e contesto di rinvenimento: nel 1712 ad Albacina, nello stesso cam-po dal quale proviene anche la statua muliebre in marmo (cat. N. 19), ad opera di un contadino che lavorava per i Monaci Camaldolesi.
Materiale: bronzo dorato (metallo di Corinto). Misure: h. circa 11 cm. Luogo di conservazione: non più reperibile, perduto.
(26) Vedi supra nota 23.
GIULIA BARATTA 178
Fig. 4 – Bronzetto, dettaglio dal manoscritto dell’archivio di S. Nicoló, p. 61.
Bibl.: F.C. GRAZIOSI, Memorie istoriche della città di Fabriano in sei libri, Fabriano 1733, ms. dell’archivio di S. Nicoló, p. 61 con fig.; ms. conservato nella Biblioteca Ramelli a Fabriano, p. 72; C. RAMELLI, Cenni storici sopra Tu-fico, Sanseverino 1848 (27), pp. 23-24; U. ALESSANDRONI, Storia albacinese, Fabriano 1975, p. 9.
Di questo pezzo si conosce sia un’immagine riprodotta nel ms. dell’archivio di S. Nicoló (Fig. 4), sia la descrizione fornita a suo tempo dal Graziosi «L’altra (statua), poi fu rinvenuta nel 1712 nel medesimo luogo da un lavoratore de P.P. Monaci Camaldolesi lavorando la terra, composta di metallo di Corinto, alta mez-zo palmo scarso di canna Romana, la quale rappresenta un Giovanetto nudo, che posa con ambedue i piedi, ma il destro avanti, ed il sinistro con il ginocchio un po-co piegato in atto di muoversi, nella pianta della mano destra porta un piattino in una piccola parte mancante a guisa di Patena, ma di più con un Orletto dalla par-te di sopra, il braccio, che si osserva steso è privo della mano, e del polso.
Nella schiena alla parte destra vedesi attaccato una figura di un grasso Priapo, ma senza genitali.
(27) Il volume Cenni storici sopra Túfico, pubblicato anonimo a Sanseverino nel 1848 è ritenuto in genere opera di Raffaele Ambrosini. Di recente però, Federica Petrac-cia, grazie ad una annotazione manoscritta, ha potuto attribuire l’opera a Camillo Ramelli.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 179
La testa è quasi rapata con una corona non di Lauro, o Mirto, ma bensì di Capelli inanellati, come si mira in fine nella 9a figura.
Questa rappresenta uno de Ministri de Sacrificj chiamati Jurificuli, quali erano molti, e di diversa età. L’ufficio de quali era il tenere in mano tutte le cose necessarie per il sacrificio. Altri avevano i coltelli per scannare la vittima, altri l’accerra (?) o Turribolo, altri certo Cappello, che ponevasi in capo il Sacerdote Sacrificante.
Morti poi questi i loro maggiori soleano farne fare il ritratto in quella for-ma, nella quale assistevano ai Sacrificj: questo di cui parliamo fù ritratto con la patena in mano, perché l’officio suo nei sacrificj era il tenere preparate le tazze di sangue, di latte, e di vino per versare il tutto in onore degli Dei».
La statuetta, alta circa 11 cm (28), rappresenta una figura maschile nu-da con ciocche di capelli scomposte sul capo e sulle spalle, caratterizzata da una leggera ponderatio, con il braccio destro disteso in avanti la cui mano reg-ge una patera umbilicata parzialmente mancante; l’altro braccio è raffigurato in posizione analoga, ma risulta privo della mano.
Si tratta con ogni probabilità di un ex voto raffigurante un offerente se-condo un tipo molto diffuso in Etruria ma anche in ambito romano (29). È meno probabile, invece, che possa trattarsi di una figura di divinità, ad esem-pio un Ercole, la cui leonté potrebbe essere stata sorretta dalla mano sinistra e risultare dunque perduta (30), oppure un Apollo rispetto al quale però manche-rebbe almeno un accenno di clamide (31).
(28) Una canna romana di 10 palmi corrisponde a 2,234 m. (29) Per un confronto vedi una statuetta conservata al Musée des Beaux-Arts di
Lyon ed attribuita al III secolo a.C. in cui, però, l’offerente tiene la mano sinistra alzata, BOUCHER, Bronzes grecs, hellénistiques et étrusques, cit., p. 96, n. 81. Sulla figura dell’offerente in genere e sui diversi modelli vedi M. BENTZ, Etruskische Votivbronzen des Hellenismus, Firenze 1992 (= ‘Biblioteca di Studi Etruschi’25); una buona selezione di pezzi è anche in L. FRANZONI, Bronzetti etruschi ed italici del Museo Archeologico di Verona, Roma 1980 (= ‘Collezioni e Musei archeologici del Veneto’). Per la variante di offerente coronato e vestito vedi, tra i tanti, un esemplare rinvenuto a Sassoferrato, l’antica Sentinum, in un contesto storico e culturale strettamente legato a Tuficum, N. FRAPICCINI, I bronzetti sentinati del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, in «Pi-cus» XVIII (1998), pp. 54-57.
(30) Per un esempio di statuetta raffigurante Ercole con leonté estremamente ridotta, portata nella mano destra vedi BOUCHER, Bronzes grecs, hellénistiques et étrusques, cit., p. 91, n. 72. Per figurine bronzee di Ercole con patera ed altri recipienti nella mano destra ed una leonté molto piccola nell’altra vedi DEONNA, Catalogue des bronzes figurés anti-ques, cit., p. 15, nn. 23-26.
(31) Vedi ad esempio due bronzetti raffiguranti Apollo con patera in G. ZAMPIERI, Bronzetti figurati etruschi, italici, paleoveneti e romani dal Museo Civico di Padova, Roma 1986 (= ‘Collezioni e Musei Archeologici del Veneto’), pp. 152-155, nn. 74-75.
GIULIA BARATTA 180
Il «grasso Priapo senza genitali» che sarebbe attaccato alla parte destra del-la schiena, e che non risulta visibile nel disegno, potrebbe essere un sostegno in forma di colonna, forse derivato da un modello di statua in pietra.
L’ampio arco cronologico nel quale sono attestate le statue di offerenti non consente una datazione precisa del pezzo di Tuficum, noto solo dal disegno del manoscritto, per il quale rimane aperta la possibilità di una attribuzione all’epoca di vita del municipio romano.
17. Ritratto di Tiberio (Fig. 5 a-b)
a b Fig. 5a-b – Ritratto di Tiberio.
Luogo e contesto di rinvenimento: Albacina. Materiale: marmo lunense. Misure: h. 40,5 cm. Luogo di conservazione: Museo centrale Montemartini - Sala Macchine,
inv. MC 846/S.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 181
Bibl. sul ritratto di Tiberio: «Bull. com.» 1877, p. 268, n. 2; J.J. BER-NOULLI, Römische Ikonographie II, 1, Berlin 1886, pp. 144-145, n. 4; H. STUART JONES, The Sculptures of the Museo Capitolino, Oxford 1926, p. 69, n. 2, tav. 22; L. CURTIUS, Ikonographische Beiträge VIII. Jugendbildnisse des Ti-berius, in «Röm. Mitteil. » 50 (1935), p. 309; E. DIEZ, Ein neuer Porträtkopf des Tiberius, in «Arch. Anz.» (1953), p. 116, nota 34; L. FABBRINI, Il ritratto giovanile di Tiberio e la iconografia di Druso maggiore, in «Boll. d’Arte» 49 (1964), p. 311; K. FITTSCHEN - P. ZANKER, Katalog der römischen Porträts in den Capitolinischen Museen und den anderen kommunalen Sammlungen der Stadt Rom, I. Kaiser- und Prinzenbildnisse, Mainz 1985 (= ‘Beitr. E. Sk. Ar.’ 3), pp. 12-13, n. 11, tav. 13.
Bibl. sul ritratto identificato con Cesare Augusto: C. RAMELLI, Cenni stori-ci sopra Tufico, Sanseverino 1848, p. 22; G.F. GAMURRINI, Albacina. Scoperte di antichità nell’area dell’antico Tufico, in «Not. Scavi» 1893, pp. 134-135; U. ALESSANDRONI, Storia albacinese, Fabriano 1975, p. 10.
C. Ramelli nel 1848 fa menzione di una testa rinvenuta in una zona
dell’antico municipio di Tuficum «innanzi la casa dei Bisci dalla parte che guarda il già ospitale di S. Lazzaro» dalla quale provengono numerosi altri re-perti architettonici, tra cui colonne marmoree, «avanzi di semibusti e di statue» e diversi basamenti per statue (32). Lo studioso fabrianese così scrive circa questo rinvenimento: «Nel 1846 pertanto vi si trovò in marmo bianco una testa d’Imperatore bella per disegno, e per esecuzione col collo tagliato a sghembo, che dal confronto dei lineamenti colle medaglie crediamo potere assicurare di Cesare Augusto».
Scarsi trenta anni dopo la Commissione comunale di Roma acquista una testa ritratto di Albacina che così viene descritta nel Bullettino del 1877: «Te-sta di buon lavoro, di un giovanetto della gente Giulia, che sembra Claudio, o Druso. Dovea essere inserita in una statua. – Proviene da Albacina, e fu acqui-stata dalla Commissione. Marmo lunense (alta m. 0,30). Si conserva nel Tabu-lario». La testa che si presenta in buono stato salvo la perdita della punta del naso e scheggiature ai margini delle orecchie e sull’occhio sinistro, mostra tracce di rilavorazione evidenti nei ricci dei lati della testa e della nuca, nel-l’incarnato e nella forma troppo allungata del viso, che conferiscono un’espres-sione poco antica, e nel rapporto tra le dimensioni della testa e del collo che appare troppo esile.
(32) Vedi infra nota 38.
GIULIA BARATTA 182
Verrebbe quasi da supporre che la testa descritta da C. Ramelli sia la stessa poi finita sul mercato antiquario ed acquistata dalla Commissione di Roma ed at-tualmente esposta ai Musei Capitolini, Centrale Montemartini, che non ritrae né Augusto né Claudio o Druso bensì Tiberio giovane, se non fosse che sia Laura Fabbrini (33) sia Klaus Fitschen e Paul Zanker (34) ritengono questo ritratto ri-lavorato, probabilmente nel XVI secolo (35), un fatto che porterebbe pertanto ad escludere che si tratti della medesima scultura essendo stata rinvenuta, quella de-scritta da C. Ramelli, solo nel 1846. È però anche possibile che i due ritratti in questione coincidano se si considera che il rimaneggiamento del volto possa es-sere avvenuto in un periodo diverso da quello supposto, ad esempio nel lasso di tempo trascorso tra il ritrovamento del busto di «Cesare Augusto», nel 1846, e l’acquisto di quello di «Claudio o Druso» da parte della Commissione. Questa seconda ipotesi sarebbe suffragata dalla mancanza di notizie specifiche circa il rinvenimento di un ritratto riconducibile alla gens giulio-claudia nella documen-tazione disponibile su Tuficum in data anteriore al 1846 e dall’identificazione della scultura rinvenuta in questo anno da parte di C. Ramelli come ritratto di «Cesare Augusto», eseguita, come lo stesso studioso ricorda, sulla base della do-cumentazione numismatica che potrebbe averlo fatto scivolare sullo sdrucciole-vole terreno della ritrattistica. Inoltre il Ramelli, anche se va detto che si tratta di osservazioni che possono adattarsi a qualsiasi altro ritratto, scrive della testa di «Cesare Augusto» che questa presenta un «collo sghembo», cosa che coincide con la terminazione del ritratto tiberiano, che, come scrivono anche K. Fittschen e P. Zanker, è un Einsatzkopf (36). Il ritratto esposto alla Centrale Montemartini raffigura Tiberio giovane secondo quello che K. Fittschen e P. Zanker definisco-no «der erste Bildnistypus», ed è attribuibile sulla base della disposizione delle
(33) L. FABBRINI, Il ritratto giovanile di Tiberio e la iconografia di Druso maggio-
re, in «Boll. d’Arte» 49 (1964), p. 311. (34) K. FITTSCHEN - P. ZANKER, Katalog der römischen Porträts in den Capitolini-
schen Museen und den anderen kommunalen Sammlungen der Stadt Rom. I. Kaiser- und Prinzenbildnisse, Mainz 1985 (= Beitr. E. Sk. Ar. 3), pp. 12-13, n. 11, tav. 13.
(35) J.J. Bernoulli addirittura si domanda se sia autentico, J.J. BERNOULLI, Römische Ikonographie II, 1, Berlin 1886, pp. 144-145.
(36) A questo proposito C. RAMELLI, Cenni storici sopra Tufico, Sanseverino 1848, p. 22-23 scrive: «E giova intorno ad essa notare col chiarissimo Archeologo conte Bor-ghesi che, avendo la città l’obbligo, e l’uso di porre una statua ad ogni nuovo principe, e la spesa non essendone indifferente usarono per risparmio di farle la testa amovibile, che così al sorger di un’altro Augusto si adoperava la stessa statua, e se le cambiava l’effigie, per cui la Tuficana dovrebbe essere una di queste teste ripudiate ed innestate già a tali sta-tue, comuni nei Musei».
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 183
ciocche sulla fronte «bei der die breite Reihe der nach rechts gebogenen Lö-ckchen genau in die Stirnmitte gerückt ist» ad una variante che trova un unico stringente parallelo in un busto ugualmente conservato ai Musei Capitolini (inv. N. 283) (37) e che, proprio per la sua rarità, viene attribuita ad una fase cronolo-gica alta, ovvero tardo-augustea.
L’esistenza di questo ritratto tiberiano, indipendentemente dal fatto che coincida o meno con la testa descritta da C. Ramelli, risulta tanto più interessante poiché nell’area dell’antico municipio di Tuficum, in una zona che si può identi-ficare sulla base del materiale rinvenuto con quella del foro della città romana (38), proviene un’iscrizione con dedica al Genius di Tiberio (39) riferibile, se-condo G. Paci, ad un edificio legato al culto imperiale e databile al massimo ai primi anni del regno di Tiberio (40), una cronologia che ben si accorda con quel-la del ritratto esposto alla centrale Montemartini. Non è da escludere pertanto che questo sia da porre in relazione al manufatto verosimilmente testimoniato dall’iscrizione e che corrisponda ad una delle statue esposte nell’Augusteum di Tuficum. Se la testa di “Cesare Augusto” descritta dal Ramelli dovesse essere di-versa dal ritratto di Tiberio non è da scartare l’ipotesi che possa trattarsi della te-stimonianza di un’altra delle statue esposte nell’edificio dedicato al culto impe-riale, tanto più che proviene dalla stessa zona in cui è stato ritrovato il testo epi-grafico.
(37) FITTSCHEN - ZANKER, Katalog der römischen Porträts in den Capitolinischen
Museen,I, cit., pp. 10-12, n. 10. (38) Sulla localizzazione del foro di Tuficum e i materiali rivenuti in zona vedi G.
GAMURRINI, Albacina. Scoperte di antichità nell’area dell’antico Tufico, in «Not. Scavi» 1893, p. 134 e in particolare p. 137 per l’iscrizione al Genio di Tiberio; VENANZONI, Il municipio di Tuficum, cit., pp. 40-41 e p. 51 e F. TASSON, Tuficum: un crocevia romano tra Appennino ed Adriatico, in PETRACCIA (a cura di), Tuficum, cit., c.d.s. Da questa zona provengono diverse iscrizioni tra cui ad esempio C.I.L. XI 5693, 5694, 5716, 5718 oltre a lastroni di pavimentazione, resti architettonici, colonne, cornicioni, ecc…
(39) C.I.L. XI 8049 = Ann épigr. 2003, 596. Per un commento e considerazioni sto-riche e sociali su questo testo epigrafico vedi S.M. MARENGO, Aspetti del culto imperiale in area medio adriatica attraverso le fonti epigrafiche, in L. GASPERINI - G. PACI (a cura di), Nuove ricerche sul culto imperiale in Italia. Atti dell’incontro di studio (Ancona 31 gennaio 2004), Tivoli 2008 (= ‘Ichnia’ 7), p. 153; G. PACI, La dedica incompiuta al Genius di Tiberio da Tuficum, in «Picus» XXIII (2003), pp. 140-151 e MAYER I OLIVÉ, Municipes et incolae tuficani utriusque sexus, cit., c.d.s.
(40) PACI, La dedica incompiuta, cit., pp. 148-150.
GIULIA BARATTA 184
18. Ritratto in bronzo (Fig. 6 a-b)
a b Fig. 6a-b – Ritratto bronzeo,
P. MARCONI, Il bronzo di Albacina, in «Boll. d’Arte» 28 (1934).
Luogo e contesto di rinvenimento: il pezzo è stato rinvenuto nel 1933 da un contadino in occasione di lavori agricoli ad Albacina nell’alveo del fiume Esino tra la strada Clementina e le pendici del monte Cone in contrada Case Lunghe.
Materiale: bronzo. Misure: h. 30,5 cm. Luogo di conservazione: Ancona, Museo Archeologico Nazionale delle
Marche. Bibl.: P. MARCONI, Il bronzo di Albacina, in «Boll. d’Arte» 28 (1934), pp.
97-103; L. MERCANDO, s.v. Tuficum, in E.A.A., I Suppl., Roma 1973, p. 872; M. BERGMANN, Studien zum römischen Porträt des 3. Jahrhunderts n. Chr., Bonn 1977 (= ‘Antiquitas’ 18), p. 141, nota 557; L. SENSI, Ritratto bronzeo, in G. DE MARINIS - S. RINALDI TUFI - G. BALDELLI (a cura di), Bronzi e marmi della Flaminia. Sculture romane a confronto, Modena 2002, pp. 136-138; M. LUNI, Statue di bronzo, in M. LUNI (ed.), Archeologia nelle Marche. Dalla preistoria all’età tardo antica, Firenze 2003, p. 366, fig. 32; G. DE MARINIS, Ritratto bron-zeo di imperatore, in G. DE MARINIS (a cura di), Arte romana nei Musei delle
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 185
Marche, Roma 2005, pp. 120-121; P. VITELLOZZI, Ritratto maschile di bronzo, in A. BRAVI (a cura di), Aurea Umbria. Una regione dell’impero nell’era di Costan-tino (= ‘Bollettino per i beni culturali dell’Umbria’, 10), Viterbo 2012, p. 126.
Il bronzo ritrae un uomo dal volto pieno con una fitta e corta capigliatura
resa con una serie di picchiettature, cui si raccorda sulle tempie una barba altret-tanto piena e corta con lo stesso tipo di caratterizzazione che è presente anche sulle sopracciglia (41). La fronte è solcata da due rughe orizzontali. Gli occhi dal-lo sguardo “melanconico”, asimmetrici, con gli angoli esterni leggermente ca-denti verso il basso e la palpebra inferiore molto curvata, hanno la caratterizza-zione dell’iride e della pupilla. Il naso, di forma e proporzioni piuttosto modeste, è dritto ed appuntito, la bocca non è troppo grande, il mento sfuggente e le orec-chie risultano piuttosto piccole in rapporto ai volumi del volto.
Il bronzo, la cui lega risulta essere di bassa qualità, si contraddistingue per una fusione poco accurata, forse realizzata con una matrice già stanca, con la tecnica a cera persa diretta (42). La superficie consunta presenta diversi fori, sotto il mento, sul labbro superiore, sotto l’occhio sinistro e sulla testa, ricon-ducibili a difetti di fusione. Due risarciture antiche sono visibili rispettivamen-te sulla parte destra della fronte e su quella sinistra del collo (5,5x1,9 cm); quest’ultima, fissata con dei chiodini, è in parte caduta. La parte posteriore si-nistra del collo è interessata da una toppa, realizzata con una diversa fusione, di forma approssimativamente triangolare (h. 11 cm; larg. 16 cm), che giunge sino alla nuca, il cui limite inferiore è ribattuto verso l’interno. La zona aurico-lare destra è interessata da una profonda fenditura (43) e prima del restauro ri-sultava fortemente deformata (Fig. 6a) a causa di un colpo che ha interessato tutta la parte destra del viso.
Purtroppo i dati a nostra disposizione sul municipio di Tuficum non consen-tono di identificare il personaggio ritratto, né di affermare con certezza che que-
(41) Le picchiettature che caratterizzano capelli, barba e sopracciglia in questo ri-tratto sono di fattura piuttosto grossolana, realizzate verosimilmente con due scalpelli di dimensioni diverse, più grande per i capelli (8-9 mm) e più piccolo per la barba (6-7 mm) sul bronzo già fuso, cfr. MARCONI, Il bronzo di Albacina, cit., p. 102-103 nota 1. Diver-samente L. Sensi ritiene che la picchiettatura fosse già realizzata nella matrice e che il tratto smussato, poco incisivo ed affatto vivace sia dovuto all’uso di una matrice già stan-ca oltre che al deterioramento della superficie metallica, cfr. L. SENSI, Ritratto bronzeo, in G. DE MARINIS - S. RINALDI TUFI - G. BALDELLI (a cura di), Bronzi e marmi della Flami-nia. Sculture romane a confronto, Modena 2002, pp. 136.
(42) Sulla tecnica utilizzata e sulla lega vedi DE MARINIS, Ritratto bronzeo di impe-ratore, cit., p. 120.
(43) Per i dettagli tecnici cfr. MARCONI, Il bronzo di Albacina, cit., p. 102-103, nota 1.
GIULIA BARATTA 186
sti sia stato colpito da damnatio memoriae, come suppone L. Sensi (44) in base al forte colpo subito dalla testa bronzea, inferto, secondo quanto scrive lo studio-so, con un oggetto contundente (45) e che, pertanto, farebbe pensare alla voluta distruzione della statua. Il dato sarebbe effettivamente di grande interesse poiché il provvedimento della damnatio doveva certamente riguardare un personaggio di rilievo e non solo per Tuficum. I caratteri stilistici di questa testa, in particolare la resa dell’acconciatura e della barba e la definizione dei dettagli dell’occhio, ri-chiamano quelli dei ritratti della metà del III secolo d.C. In particolare sembrano ravvisarsi somiglianze con quelli di Balbino, soprattutto per il mento sfuggente e l’accenno al doppio mento (46), e più ancora con quelli di Treboniano Gallo, ol-tre che per le proprietà della capigliatura e della barba anche per la forma del na-so, per l’asimmetria degli occhi e il lieve strabismo di quello destro, per le arcate sopraccigliari che scendono ai lati esterni, per la bocca piccola e la parte centrale del labbro superiore priva di barba, per le rughe attorno alla radice del naso, e per il mento di proporzioni ridotte (47). Non sarebbe del resto improbabile ipotizzare la presenza di un’effigie di questo imperatore a Tuficum, municipio posto lungo la via di comunicazione tra il Tirreno e l’Adriatico in un contesto geografico par-
(44) SENSI, Ritratto bronzeo, cit., p. 138. (45) SENSI, Ritratto bronzeo, cit., p. 138. (46) Vedi ad esempio un ritratto dalle Catacombe di Pretestato in M. WEGNER, Das
römische Herrscherbild. Macrinus bis Balbinus, Berlin 1971, p. 249, tav. 79 e B.M. FEL-LETTI MAJ (a cura di), Iconografia romana imperiale. Da Severo Alessandro a M. Aurelio Carino (222-285 d.C.), Roma 1958, p. 142, n. 136, tav. 15, 50. Vedi anche la testa bron-zea conservata in Vaticano, la cui attribuzione a Balbino è più discussa, ibidem p. 140, n., 133, tav. XIV 47-48. In generale sulla problematica dei ritratti di Balbino vedi WEGNER, Das römische Herrscherbild. Macrinus bis Balbinus, cit., pp. 242-243.
(47) Vedi in particolare il ritratto bronzeo presumibilmente di Treboniano Gallo conservato al Vaticano in FELLETTI MAJ (a cura di), Iconografia romana imperiale, cit., p. 202, n. 259, tav. 35, 111-112 e M. WEGNER, Das römische Herrscherbild. Gordianus III. bis Carinus, Berlin 1979, p. 85, p. 91, tav. 34; quello del Louvre a Parigi, ibidem p. 90, tav. 35 e quello di Firenze, H. v. HEINZE, Studien zu den Porträts des 3. Jahrhun-derts n. Chr., 2. Trebonianus Gallus - Traianus Decius, in «Ath. Mitteil.» 63 (1956), p. 59, tav. 27 e la statua bronzea di New-York, ibidem, p. 59, tav. 58, tav. 23, 1. In genere sulla problematica legata all’attribuzione dei ritratti a Treboniano Gallo, WEGNER, Das römische Herrscherbild. Gordianus III. bis Carinus, cit., pp. 83-91; HEINZE, Studien zu den Porträts des 3. Jahrhunderts n. Chr., cit., pp. 56-62 che divide i ritratti in due gruppi dalle caratteristiche sostanzialmente simili con la principale differenza data dall’età del ritrattato e che li attribuisce a Traiano Decio e non a Treboniano Gallo; J. BALTY, Trébonien Galle et Volusien, in EIKONES. Studien zum griechischen und römi-schen Bildnis. Hans Jucker zu seinem sechzigsten Geburtstag gewidmet, Basel 1980, pp. 49-56.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 187
ticolarmente caro a Treboniano Gallo del quale restano diverse iscrizioni nella regio VI e comunque nell’Italia centrale. Seppure la testa di Tuficum, opera pro-babilmente di un atelier itinerante che lavorò probabilmente in situ (48), presenta una resa formale modesta e piuttosto semplicistica, che non ne facilita l’identi-ficazione, sembra però possibile almeno avanzare l’ipotesi che possa essere o un ritratto privato ispirato a quelli di Treboniano Gallo o addirittura una copia, ap-punto “provinciale”, di quello dello stesso imperatore. Se così fosse si potrebbe giustificare l’affermazione di Sensi che la statua è stata distrutta per una opera-zione di damnatio memoriae, condanna che colpì Treboniano Gallo (49), anche se non si può escludere che i danni subiti siano riconducibili ad altro, ad esempio ad un evento sismico.
Sulla base dei caratteri stilistici della testa, però, non si può scartare del tut-to che possa essere di qualche decennio posteriore alla data proposta. Pur ricono-scendo analogie con i ritratti di Treboniano Gallo, per la sua rigidità e per una certa morbidezza e sfumatura nei trattamenti dei piani del volto e per l’esecu-zione poco «esperta e raffinata… quasi ingenua», P. Marconi si inclina a vedervi un’opera della fine del III secolo d.C., che prelude alla ieraticità dei ritratti di IV secolo d.C. (50). M. Bergmann, dal canto suo, propende per una datazione ad età tetrachica (51) inserendo la testa in un gruppo caratterizzato da «gezerrtem Inkarnat», «starken Asymmetrien» e «flüchtige Haarbehandlung».
19. Busto muliebre (Fig. 7)
Luogo e contesto di rinvenimento: nel 1717 in un campo di Albacina, lo stesso dal quale proviene anche il bronzetto di offerente (cat. n. 16), ad opera di una contadina.
Materiale: descritto come alabastro va probabilmente inteso come marmo traslucido. Marmo pario?
Misure: non indicate. Luogo di conservazione: secondo quanto scrive F.C. Graziosi nel 1733 ri-
sulta venduto al cardinale Alessandro Albani che l’avrebbe posto nella sua galle-ria. Perduto?
(48) SENSI, Ritratto bronzeo, cit., p. 138. (49) Su Treboniano Gallo vedi W. ENßLIN, s.v. Vibius, in R.E. XVI (1959), coll.
1984-1994. Diverse dediche all’imperatore sono state trovate nell’Italia centrale e nella regio VI (C.I.L XI 4870; C.I.L. XI 6030, 6031, 6032; C.I.L. IX 5431; 3961).
(50) MARCONI, Il bronzo di Albacina, cit., p. 98 e p. 102. (51) M. BERGMANN, Studien zum römischen Porträt des 3. Jahrhunderts n. Chr.,
Bonn 1977 (= ‘Antiquitas’ 18), p. 141, nota 557.
GIULIA BARATTA 188
Fig. 7 – Busto muliebre, ms. dell’archivio di S. Nicoló, p. 60.
Bibl.: F.C. GRAZIOSI, Memorie istoriche della città di Fabriano in sei li-bri, Fabriano 1733; ms. dell’archivio di S. Nicoló, p. 60 con fig.; ms. conserva-to nella Biblioteca Ramelli a Fabriano, p. 71; C. RAMELLI, Cenni storici sopra Tufico, Sanseverino 1848, p. 23; U. ALESSANDRONI, Storia albacinese, Fabria-no 1975, p. 9.
Di questo pezzo, allo stato attuale, oltre ad un disegno nel manoscritto di San Nicoló, si conosce solo la descrizione fatta a suo tempo da F.C. Graziosi: «una (statua) ritrovata da una Contadina nell’anno 1717 in un campo d’Alvacina, rappresentante un busto d’una donna giovane, d’alabastro finis-simo, la quale avea coperto il petto con un manto lavorato a meraviglia, avea la faccia molto vaga, e bella, labbri grossi, naso profilato, fronte spaziosa, collo carnato, l’orecchie di giusta grandezza.
Nella testa avea una treccia doppia a guisa di Cestello, e la metà di detta treccia si levava, e si poneva in esso capo mediante un maschio infisso nella sommità del Capo della medesima, quale Statua era collocata sopra di un piedi-stallo della stessa materia, e qualità fù venduta all’Eminentissimo Alessandro Albani, il quale la pose nella sua galleria.
A mio giudicio posso credere esser stata questa il ritratto d’una Persona molto nobile, ed illustre, poiché quel panneggiamento, che ha nel Petto mi da
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 189
a credere, che rappresenti la moglie, o la figlia di qualche Imperatore, o Con-sole Romano, per vedersene molte in Roma di tal sorte; così nella Villa del Si-gnor Principe Borghese vedesi il Busto di Livia moglie d’Augusto, ed in quella de Signori Casali, quello della figliuola di Tito Imperatore, ed altri, la figura sopradescritta si mira nella fig. 8 in fine».
Da questa descrizione e dal disegno a disposizione è difficile poter risalire ad uno dei pezzi ancora conservati nella collezione Albani di via Salaria a Roma o presenti nei vari musei in cui sono confluite diverse sculture della raccolta del cardinale, per la quale, stando alle parole del Graziosi, il busto sarebbe stato ac-quistato prima del 1733. La collezione Albani, infatti, ha subito negli anni alterne vicende e manca a tutt’oggi un archivio che consenta di chiarire «le modalità, i tempi e le fonti di approvvigionamento dell’onnivoro cardinale» (52).
Dalla succinta descrizione e dal disegno in nostro possesso non è possibi-le stabilire con certezza se il ritratto sia realizzato insieme al busto e formi con esso una unità o se questo sia moderno ed appositamente realizzato per la ven-dita del reperto o per la sua collocazione in seno alla collezione del cardinale. Il fatto però che il Graziosi riferisca dell’uso di un solo marmo, descritto come «alabastro finissimo», farebbe propendere per la prima ipotesi. Quanto al ma-teriale utilizzato, inoltre, si deve supporre che si tratti piuttosto di un marmo traslucido a grana molto fine, verosimilmente pario. Sulla base dei dati a di-sposizione non è possibile identificare la donna ritratta, ma la descrizione della capigliatura sembra offrire un appiglio almeno per un generico inquadramento cronologico. Infatti la sua foggia, come si desume dalle parole del Graziosi e dal disegno che ci è giunto, sembrerebbe richiamare i caratteri dell’accon-ciatura di Faustina maior, ben nota con alcune varianti da numerose repliche dei suoi ritratti, a cui forse è ispirata anche le torsione del volto girato verso destra (53), o quelli delle acconciature di Faustina minor, particolarmente i tipi 3 e 4 di K. Fittschen (54), all’ultimo dei quali è ascrivibile un ritratto della colle-
(52) Sulle difficoltà di ricostruire e ripercorrere tutte le tappe della storia della rac-
colta Albani vedi C. GASPARRI, Marmi antichi nella Villa Albani-Torlonia: appunti per una storia della raccolta, in H. VON STEUBEN - G. LAHUSEN - H. KOTSIDUE (eds.), Mou-seion. Beiträge zur antiken Plastik. Festschrift zu Ehren von Peter Cornelis Bol, Möhne-see 2007, pp. 73-87, da cui a p. 74 è tratta anche la citazione riportata nel testo.
(53) Per i ritratti di Faustina maior e la capigliatura che potrebbe corrispondere al busto di Tuficum vedi K. FITTSCHEN - P. ZANKER, Katalog der römischen Porträts in den Capitolinischen Museen und den anderen kommunalen Sammlungen der Stadt Rom. III. Kaiserinnen und Prinzessinnenbildnisse, Frauenporträts, Mainz am Rhein 1983 (= ‘Beitr. E. Sk. Ar.’ 3), pp. 13-20, nn. 13-16 e 18 e la ricca bibliografia citata.
(54) Vedi K. FITTSCHEN, Die Bildnistypen der Faustina minor und die Fecunditas
GIULIA BARATTA 190
zione Albani, che non sembra però coincidere con il nostro trattandosi di una te-sta inserita in un busto di alabastro moderno (55). Se così fosse il pezzo sarebbe inquadrabile ad un arco cronologico che va dall’epoca antonina ai primi decenni della seconda metà del II secolo d.C., un periodo, tra l’altro, per il quale numero-se sono le attestazioni, almeno epigrafiche, testimoni di un periodo vivace e fe-condo del municipio di Tuficum (56).
20. Statua di militare
Luogo e contesto di rinvenimento: la statua è stata trovata a Borgo Tufico nella zona di S. Lazzaro in data sconosciuta, ma certamente prima del 1848.
Materiale: non indicato. Misure: non indicate. Luogo di conservazione: nel 1848 si conservava a Fabriano in casa Ramelli,
oggi risulta irreperibile.
Bibl.: C. RAMELLI, Cenni storici sopra Tufico, Sanseverino 1848, p. 23. Poco o nulla si sa di questa statua che C. Ramelli descrive come segue:
«…una (statua) mutilata che serbasi in casa Ramelli, e mostra nel vestiario di es-sere appartenente ad un militare» e che allo stato attuale non è rintracciabile nella collezione archeologica di Palazzo Raccamadoro-Ramelli a Fabriano.
Se si scarta l’ipotesi che possa trattarsi di un bronzetto, come nel caso dei nn. 1-3, si può supporre, sulla base del fatto che il vestiario è quello di un mili-tare, che si tratti di una statua loricata raffigurante, qualora fosse di grandi di-mensioni, uno dei viri militares del municipio, di alcuni dei quali ci sono giun-te le iscrizioni, oppure un imperatore, nel qual caso la scultura non necessaria-mente dovrebbe essere di proporzioni simili al naturale, ma potrebbe essere anche più grande.
In ogni caso il pezzo rientrerebbe in uno dei due gruppi cronologici in cui è attestata scultura per il sito di Tuficum: VI-V secolo a.C. e I-III secolo d.C.
Augustae, Göttingen 1982 (= ‘Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göt-tingen, philologisch-historische Klasse, dritte Folge’ 126), pp. 48-51, tavv. 15-18.
(55) S. MORCELLI - C. FEA - E. Q. VISCONTI, La villa Albani descritta, Roma 1869, p. 27, n. 152; R. BOL, Weibliches Porträt, in P.C. BOL (ed.), Forschungen zur Villa Al-bani. Katalog der antiken Bildwerke III. Bildwerke in der Galleria della Leda, im ehe-maligen Tempel der ephesischen Arthemis und im Bigliardo, Berlin 1992, pp. 99-101, tavv. 68-70.
(56) Vedi a questo proposito MAYER I OLIVÉ, Municipes et incolae tuficani utrius-que sexus, cit., c.d.s.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 191
21. Statua muliebre
Luogo e contesto di rinvenimento: nulla si sa del luogo di rinvenimento, probabilmente nei pressi di S. Lazzaro a Borgo Tufico, di questa statua muliebre reimpiegata per la realizzazione degli argini del fiume.
Materiale: verosimilmente litica. Misure: non indicate. Luogo di conservazione: negli anni precedenti il 1848 era reimpiegata negli
argini del fiume. Attualmente non reperibile.
Bibl.: C. RAMELLI, Cenni storici sopra Tufico, Sanseverino 1848, p. 23.
Purtroppo sulla base di quanto scritto da C. Ramelli «vandalicamente im-piegata, sono appena tre lustri (1833), per una fortificazione sul fiume presso S. Lazzaro» non è possibile avanzare alcuna ipotesi né sul materiale della scultura, verosimilmente marmo, né sulle sue fattezze e dunque sul suo originario ambito di pertinenza.
Trattandosi con ogni probabilità di una statua riconducibile al municipo ro-mano di Tuficum la sua cronologia può essere compresa tra il I ed il III secolo d.C.
22. Statua muliebre frammentaria (Fig. 8 a-b)
a b
Fig. 8a-b – Statua muliebre frammentaria. Luogo e contesto di rinvenimento: provenienza locale non meglio precisata. Materiale: apparentemente marmo di Carrara. Misure: h. cons. 75 cm; larg. cons. 53 cm; spess. 36 cm. Luogo di conservazione: ad Albacina, nel giardino di Villa Censi Mancia.
Bibl.: inedita.
GIULIA BARATTA 192
Della statua femminile panneggiata rimane solo la porzione inferiore, a par-tire circa dall’altezza del ginocchio. Si conserva la parte del chitone, sino al pun-to in cui si ripiega sui piedi, e l’orlo inferiore del mantello; piedi e plinto sono perduti. L’andamento delle pieghe del chitone, sostanzialmente verticale, lascia intuire in due punti, ove appare leggermente sollevato, la posizione dei piedi. Quello sinistro era posto frontalmente, e doveva corrispondere alla gamba su cui poggia il peso della figura, mentre quello destro doveva esserlo di lato e corri-spondere a sua volta alla gamba leggermente flessa ed arretrata. La stoffa del mantello è caratterizzata da un panneggio poco pesante, con pieghe che scendono da sinistra verso destra, sulla parte anteriore, e denotano comunque anche sui lati e posteriormente una certa aderenza del tessuto dell’ himation al corpo.
La statua richiama il tipo iconografico così detto della Piccola Ercolanese (57), ispirato a prototipi greci di IV secolo a.C., le cui repliche in ambito romano si concentrano tra il I e il III secolo d.C. La sua frammentarietà non consente purtroppo di stabilire se si tratta di una statua di ambito privato, pubblico o fu-nerario ed ancora meno di avanzare ipotesi sul soggetto ritratto. La datazione trova evidenti limiti nel suo stato di conservazione e per il generale degrado della superficie litica; tuttavia è possibile ipotizzare un inquadramento crono-logico al I o meglio al II secolo d.C.
23. Statua di Attis (Fig. 9 a-c)
Luogo e contesto di rinvenimento: la statua è stata trovata negli anni prece-denti il 1877 ad Albacina in un terreno di proprietà di Enrico Boldoni di France-sco in località Moresine insieme ad una statua femminile identificata con Cibele (cat. n. 24).
Materiale: marmo lunense. Misure: h. 72 cm; plinto 4,5 cm. Luogo di conservazione: Roma, Musei Capitolini, Centrale Montemartini,
Magazzini.
Bibl. C.I.L. XI 5686; G. FIORELLI, Fabriano, in «Not. Scavi» 1877, p. 244; «Bull. com» 1877, p. 267, n. 4; H. HEPDING, Attis seine Mythen und sein Kult, Gie-
(57) Vedi H.-J. KRUSE, Römische weibliche Gewandstatuen des zweiten Jahrhunderts
n. Chr., Göttingen 1975, pp. 300-322 per il tipo C ispirato alla così detta Piccola Ercolanese. Per il tipo e numerosi possibili confronti vedi anche F.P. JOHNSON, Lysippos, Durham 1927, pp. 145-165; G. LIPPOLD, Handbuch der Archäologie 3,1, München 1950, p. 142, tav. 86, 1-2; A. LINFERT, Kunstzentren hellenistischer Zeit. Studien an weiblichen Gewandfiguren, Wiesbaden 1976 e E. FILERI, Statua femminile: tipo Piccola Ecolanese, in A. GIULIANO (a cura di), Museo Nazionale Romano. Le sculture I, 7, Roma 1984, pp. 388-389.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 193
szen 1903, p. 95, n. 60; H. GRAILLOT, Le culte de Cybèle mère des dieux a Rome et dans l’empire romain, Paris 1912 (= ‘BEFAR’ 107), p. 426, nota 3; R. SASSI, I ricordi romani di Fabriano. Conferenza (Appendice: Le epigrafi ro-mane del territorio di Fabriano), Fabriano 1938, p. 51, n. 1; G. MOLISANI, La collezione epigrafica dei Musei Capitolini. Le iscrizioni greche e latine, Roma 1973, p. 96, n. 6713; C. PIETRANGELI, Musei Capitolini. I monumenti dei culti orientali, Roma 1951 (= ‘Cataloghi dei Musei Comunali di Roma’ I), p. 15, n. 17; M.J. VERMASEREN, Corpus cultusque Cybelae Attidisque (CCCA), IV. Ita-lia – Aliae Provinciae, Leiden 1978, p. 75, n. 184; M.J. VERMASEREN - M.B. DE BOER, s.v. Attis, in L.I.M.C. III, 1, Zürich-München 1986, pp. 27, n. 90; S.M. MARENGO, I culti orientali dell’Italia centrale adriatica, in Les cultes polythéistes dans l’Adriatique romaine, Bordeaux 2000 (= ‘Études’ 4), p. 215; L. INNOCENZI, Il culto di Cibele ed Attis a Tuficum, in «L’Azione», n. 34, 6 settembre 2003, p. 10; G. ASDRUBALI PENTITI, Donne e vita religiosa. La do-cumentazione epigrafica della Regio VI, in «Epigraphica» 70 (2008), pp. 218-219; M.F. PETRACCIA - M. TRAMUNTO, Il contributo dell’epigrafia alla storia politica e sociale di un municipio dell’Italia romana: Tuficum. I culti e la vita quotidiana di Tuficum, in A. SARTORI - A. VALVO (a cura di), Identità e auto-nomie nel mondo romano occidentale, Iberia-Italia Italia-Iberia. Atti del III Convegno Internazionale di Epigrafia e Storia Antica (Gargnano 12-15 mag-gio 2010), Faenza 2011, p. 268; M. TRAMUNTO, Silloge epigrafica tuficana, in PETRACCIA (a cura di), Tuficum in età romana, cit., c.d.s. ove è considerata er-roneamente perduta.
Nel 1877 G. Fiorelli scriveva: “In un terreno del sig. Enrico Boldoni di
Francesco, nel territorio di Albacina provincia di Ancona, e propriamente in con-trada Moresine furono scoperte no ha guari due statue acefale gemelle, virile l’una rappresentante Ati, muliebre l’altra e rappresentante forse Cibele”.
La statua di Attis, priva di testa, che era un “Einsatzkopf”, e priva anche del braccio destro, raffigura il dio stante con corta tunica scappucciata, un mantello che copre entrambe le spalle e scende sulla schiena e sul fianco sinistro, anaxyri-des e calzari. Con la mano sinistra Attis sorregge un lungo pedum (58) mancante della parte sommitale. Il peso della figura insiste sulla gamba sinistra mentre la destra è leggermente piegata ed arretrata. Alla sinistra della statua è presente un sostegno in forma di tronco d’albero.
(58) C. PIETRANGELI, Musei Capitolini. I monumenti dei culti orientali, Roma
1951 (= ‘Cataloghi dei Musei Comunali di Rom’ I), p. 15, n. 17, descrive il pedum co-me cornucopia.
GIULIA BARATTA 194
Questa raffigurazione di Attis rientra nel gruppo «Attis stehend neben ei-nem Baum (meist Pinie). Ohne Attribute oder mit Syrinx, Pedum oder Tympa-non» della classificazione di M. Vermaseren e M. de Boer. Si tratta di una delle poche statue note (59) che raffigurano il dio da solo la cui immagine in genere è affidata piuttosto alla “Kleinkunst”.
Sulla parte anteriore del plinto della statua corre l’iscrizione dedicatoria (fig. 9 c): Attidi Autia Vera d(ono) d(edit) (60). Autia Vera, come si apprende dalla sua iscrizione funeraria (61), era moglie di Lucius Sibidienus Sabinus un personaggio noto per essere stato patrono di Tufi-cum oltre che curator viarum et pontium Umbriae et Piceni e procurator provin-ciae Africae (62), al quale sembra possano riferirsi diverse altre iscrizioni (63) inquadrabili cronologicamente ai decenni centrali del I secolo d.C. Essendo Au-tia Vera morta prima del marito è possibile datare l’iscrizione, e pertanto la sta-tua di Attis, intorno alla metà del I secolo d.C. (64), cronologia alla quale riman-dano anche i caratteri stilistici della scultura.
Più difficile è ricondurre la statua ad un culto (65) di tipo privato piuttosto
(59) A Sarsina è stata rinvenuta una analoga statua di Attis stante con pedum ed ap-poggio costituito da un tronco d’albero, cfr. G. MANSUELLI, Monumenti dei culti orien-tali scoperti a Sarsina, in «Röm. Mitteil.» 73-74 (1966-1967), pp. 164-165, tav. 58, 1. In genere sul dio e sulla sua iconografia vedi M.J. VERMASEREN, The legend of Attis in Greek and Roman Art, Leiden 1966; S. KARWIESE, Attis in der antiken Kunst (Disserta-tion), Wien 1967.
(60) Campo epigrafico: 4,5 x 24; h. lettere: 2-1,8. (61) C.I.L. XI 8058: D(is) M(anibus)/ Autiae / Verae / uxori / L(uci) Sibidieni / Sabini.
La stele funeraria si conserva attualmente nel giradino di Villa Censi Mancia ad Albacina. (62) C.I.L. XI 5689 = Ann. épigr. 2003, 594: [- - -] Aug[usti/ae] sacrum / [L(ucius)
Sibidienus L(uci) f(ilius) Ouf(entina) Sa]binus / trib(unus) mil(itum) cur(ator) viar(um)/ [et pont(ium) Umbr(iae) et Pic(eni) proc(urator) pr]ovin(ciae)/ Afric(ae) pat(ronus) mun(icipii) p(ecunia) s(ua) f(ecit).
(63) Per la carriera di questo personaggio e per la sua importanza nell’ambito del municipio di Tuficum oltre che per le attestazioni epigrafiche che lo riguardano vedi MA-YER I OLIVÉ, Municipes et incolae tuficani utriusque sexus, cit., c.d.s.
(64) Secondo Asdrubali Pentiti l’iscrizione sarebbe databile alla seconda metà del I secolo d.C., G. ASDRUBALI PENTITI, Donne e vita religiosa. La documentazione epigrafica della Regio VI, in «Epigraphica» 70 (2008), p. 219.
(65) Anche nel vicino municipo di Attidium un’iscrizione con dedica a Serapide o menzionante un Serapeo riflette la presenza di un culto orientale, vedi S.M. MARENGO, Silloge epigrafica, in M.F. PETRACCIA (a cura di), Attidium, cit., pp. 157-159. Più in gene-rale sulla natura, le modalità e la cronologia di diffusione dei culti orientali nell’ager Gal-licus e nel Piceno vedi S.M. MARENGO, I culti orientali dell’Italia centrale adriatica, cit., pp. 207-219.
GIULIA BARATTA 196
che pubblico; anche se la prima ipotesi non è da scartare (66) va detto che il pez-zo proviene da una zona, Moregine o Moresine, da cui provengono la maggior parte delle iscrizioni pubbliche del municipio tuficano e presso la quale si può ragionevolmente supporre l’esistenza del foro di Tuficum (67).
24. Probabile statua di Cibele
Luogo e contesto di rinvenimento: la statua è stata trovata negli anni pre-cedenti il 1877 ad Albacina in un terreno di proprietà di Enrico Boldoni di Francesco in località Moresine insieme alla statua di Attis (cat. n. 23).
Materiale: non indicato, verosimilmente marmo lunense. Misure: non indicate, verosimilmente simili a quelle della statua di Attis
(cat. n. 23). Luogo di conservazione: perduta.
Bibl.: G. FIORELLI, Fabriano, in «Not. Scavi» 1877, p. 244; H. GRAILLOT, Le culte de Cybèle mère des dieux a Rome et dans l’empire romain, Paris 1912 (= ‘B.E.F.A.R.’ 107), p. 426, nota 3; C. PIETRANGELI, Musei Capitolini. I mo-numenti dei culti orientali, Roma 1951 (= ‘Cataloghi dei Musei Comunali di Roma’ I), p. 15, n. 17; M.J. VERMASEREN, Corpus cultusque Cybelae Attidisque (CCCA). IV. Italia - Aliae Provinciae, Leiden 1978, p. 75, n. 184; L. INNOCENZI, Il culto di Cibele ed Attis a Tuficum, in «L’Azione», n. 34, 6 settembre 2003, p. 10; M. TRAMUNTO, Silloge epigrafica tuficana, in M.F. PETRACCIA (a cura di), Tuficum in età romana, cit., c.d.s. con erroneo riferimento a C. Ramelli e alla sta-tua di Venere o Ninfa (cat. n. 25).
Nulla è possibile dire circa la probabile statua di Cibele, attualmente non
rintracciabile e con buona probabilità perduta, della quale le fonti bibliografiche che ne fanno menzione non forniscono alcuna descrizione, salvo il fatto che era acefala e, come scrive G. Fiorelli, gemella di quella di Attis. Sicuramente le due sculture dovevano avere analoghe dimensioni ed essere realizzate con lo stesso
licus e nel Piceno vedi S.M. MARENGO, I culti orientali dell’Italia centrale adriatica, cit., pp. 207-219.
(66) M.J. VERMASEREN, Iconografia e iconologia di Attis in Italia, in «Stud. Rom.» 27 (1976), p. 57 ove scrive: …si può concludere che il culto di Attis durante la repubblica, …, deve essere stato in origine un culto privato che poi si è largamente diffuso. A propo-sito della natura del culto di Attis a Tuficum vedi anche MAYER I OLIVÉ, Municipes et in-colae tuficani utriusque sexus, cit., c.d.s.
(67) F. FRASSON, Tuficum: un crocevia romano tra Appennino e Adriatico, in PE-TRACCIA (a cura di), Tuficum, cit., c.d.s.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 197
materiale, marmo lunense. Allo stato attuale comunque è solo possibile ipotizza-re che la statua femminile sia da mettere in relazione con quella di Attis e che sia realmente il simulacro di Cibele, identificazione sulla quale, peraltro, tutte le fon-ti esprimono riserve e che si deve supporre incerta per la mancanza o la perdita degli attributi. Comunque, se così fosse, e la statua costituisse il pendant di quel-la di Attis sarebbe possibile inquadrarla cronologicamente, come quella raffigu-rante il dio, intorno alla metà del I secolo d.C.
Non è però da scartare la possibilità che la sua identificazione con Cibele sia erronea e solo condizionata dal suo rinvenimento avvenuto in concomitanza con la statua del dio frigio.
25. Statua di Ninfa con conchiglia (Fig. 10 a-c)
Fig. 10 a-d Statua di Ninfa con conchiglia.
GIULIA BARATTA 198
Luogo e contesto di rinvenimento: nel territorio di Tuficum in luogo e data non precisati, comunque anteriormente al 1848 e probabilmente dopo il 1840 poiché non se ne fa menzione nel manoscritto di Ramelli.
Materiale: Parti originali in marmo proconnesio, resaturi in marmo di Carrara.
Misure: h. 60. Luogo di conservazione: Fabriano, collezione Raccamadoro-Ramelli. Bibl.: C. RAMELLI, Studi storici Fabrianesi, ms. conservato nella biblioteca
Raccamadoro Ramelli, parzialmente trascritto in M.F. PETRACCIA (a cura di), Gli ´Studi Storici´di Camillo Ramelli e il Lapidario del Palazzo Comunale di Fa-briano, Fabriano 2007, p. 60; C. RAMELLI, Cenni storici sopra Tufico, Sanseve-rino 1848, p. 15; U. ALESSANDRONI, Storia albacinese, Fabriano 1975, p. 12; L. INNOCENZI, Con Venere a Tuficum, in «l’Azione», n. 22, 31 maggio 2003, p. 10.
C. Ramelli nei suoi «Cenni storici sopra Tufico» descrive la statua come simulacro di Venere e testimonianza di culto: «La religione dei Tuficani fu simi-le a quella dei loro vicini;…sappiamo bensì che ebbero caro il culto di Venere cuj innalzarono a premura de’ loro varj concittadini tempj, e statue, una delle quali in marmo bianco viene serbata in casa Ramelli (68), ravvisandosi per tale, sebbene mutila, dalla conchiglia che tiene innanzi alle parti pudende» (69).
La statua, spezzata in due a livello della vita, è acefala. Il braccio sinistro è mancante, mentre l’avambraccio destro è riattaccato ed è perduta la porzione centrale della mano; la parte anteriore dei piedi nudi, così come la corrispondente parte del plinto, sono di restauro. Si riscontrano inoltre diverse scheggiature su tutta la superficie litica. La diversa colorazione del busto rispetto a quella del panneggio e delle gambe è dovuta alle modalità di conservazione del pezzo: si tratta infatti di un unico blocco di marmo come mostrano le venature della pietra il cui andamento non presenta discontinuità tra la parte più chiara e quella più scura. La figura femminile è a torso nudo, con un ricco drappeggio che le cinge i fianchi e che, aperto sul davanti, lascia libere le gambe sino quasi all’inguine, mentre sulla parte posteriore è leggermente sceso così da lasciare scoperta buona parte dei glutei. Il peso del corpo poggia sulla gamba destra mentre la sinistra è flessa e leggermente discosta. All’altezza del pube, nel punto in cui la stoffa del manto si sovrappone e si annoda, tiene con le mani una grande conchiglia, liscia sia all’interno che all’esterno, quasi interamente perduta. Sulle spalle non si no-
(68) Nel manoscritto conservato nella biblioteca Raccamadoro-Ramelli, C. Ramelli
scrive: «serbasi in mia casa». (69) Per la trascrizione del testo del manoscritto vedi PETRACCIA (a cura di), Gli
«Studi storici di Camillo Ramelli», cit., p. 60.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 199
tano tracce di ciocche di capelli, segno che il volto doveva essere incorniciato da una capigliatura raccolta. Le gambe ben tornite sembrano contrastare con la parte superiore del corpo più minuta. Il panneggio della stoffa è nel complesso pesante e pastoso, piuttosto accostato alle gambe e poco gonfiato dal vento (70).
La statua raffigura una Ninfa con conchiglia secondo un tipo noto da nume-rose repliche (71) ispirato all’iconografia della così detta Afrodite di Siracusa o Venere Landolina (72). Si tratta in genere di sculture decorative pertinenti a fon-tane e ninfei, come confermano i fori per il passaggio delle fistule plumbee pre-
(70) Questa caratteristica ricorre anche in alcune repliche della Aphrodite di Siracu-sa, vedi A. DELIVORRIAS - G. BERGER DIER - A. KOSSATZ-DEISSMANN, s.v. Aphrodite, in L.I.M.C. II, 1 (1984), p. 83, part. n. 747.
(71) Per alcuni confronti del modello della Ninfa con conchiglia ispirato al tipo del-la Venere Landolina e per le altre varianti vedi un esemplare estremamente vicino da un punto di vista geografico, poiché rinvenuto a Fossato di Vico, località Capodacqua, F. ANNIBALDI, Statua, in M. MATTEINI CHIARI (a cura di), Antiquarium di Fossato di Vico. Materiali archeologici. Iscrizioni, sculture, elementi architettonici, ceramica, monete, Mi-lano 2007, pp. 203-204; i pezzi raccolti in S. REINACH, Répertoire de la statuaire grecque et romaine, I, Paris 1897, pp. 97, 436, 438; S. REINACH, Répertoire de la statuaire grec-que et romaine, II, 1, Paris 1897, p. 405; B. KAPOSSY, Brunnenfiguren der hellenistischen und römischen Zeit, Zürich 1969, pp. 13-14; M. HALM-TISSERANT - G. SIEBERT, s.v Nympahi, in L.I.M.C. VIII, 1, (1997), p. 893. Vedi inoltre un esemplare rinvenuto a Ro-ma, senza tubi per il passaggio dell’acqua, della seconda metà del II secolo d.C. in L. DE LACHENAL, Statua acefala di ninfa semipanneggiata con conchiglia, su base antica perti-nente e modanata, in A. GIULIANO (a cura di), Museo Nazionale Romano. Le sculture I, 2, Roma 1981, pp. 186-189; l’esemplare dei Musei Vaticani con foro per conduttura d’acqua in G. LIPPOLD, Die Skulpturen des vatikanischen Museums III, 2, Berlin 1956, p. 284-285, n. 19 (167), tav. 12, 5; l’esemplare di II secolo d.C. in J.M. EISENBERG, Art of the Ancient World. A Guide for the Collector and Investor. IV Ancient, European, Oriental, Pre-Columbian & Tribal Works of Art, New York 1985, p. 77, n. 237; la statua di II secolo d.C. con foro per il passaggio dell’acqua conservata a Tarragona, in M. KOPPEL, Die rö-mischen Skulpturen von Tarraco, Berlin 1985 (= ‘Madrider Forschungen’ 15), p. 119, n. 187. Una variante è costituita da alcuni esemplari in cui l’apertura del panneggio è meno ac-centuata e soprattutto più bassa tale da lasciare scoperta una porzione minore di gambe: vedi ad esempio la statua di II secolo d.C. conservata alla Galleria Borghese, P. MORENO - A. VIACAVA, I Marmi antichi della Gallerie Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese, Roma 2003, pp. 103-104, n. 66 con ricca bibliografia precedente; ana-loga quella dei Musei Vaticani di II secolo d.C. e con foro passante per l’acqua in W. AME-LUNG, Die Skulpturen des vatikanischen Museums, II, Berlin 1908, p. 213, n. 77, tav. 8.
(72) In generale sulle raffigurazioni di Afrodite vedi J.J. BERNOULLI, Aphrodite. Ein Baustein zur griechischen Kunstmythologie, Leipzig 1873. Per il tipo della Landolina e la sua origine A. GIULIANO, La Afrodite Callipige di Siracusa, in «Arch. class.» 5 (1953), pp. 210-214 e più recentemente con ricca bibliografia DELIVORRIAS - BERGER DIER - KOS-SATZ-DEISSMANN, s.v. Aphrodite, cit., p. 83 ss.
GIULIA BARATTA 200
senti in numerosi esemplari e come è documentato anche da alcune pitture parie-tali (73) e da mosaici (74). La Ninfa con conchiglia è un soggetto piuttosto fre-quente che ricorre, soprattutto nella statuaria (75), anche in altre varianti (76) che differiscono principalmente per la tipologia del panneggio, per la postura della conchiglia e per la sua eventuale sostituzione con un catino. La variante più fre-quente presenta il chitone che lasciando libero il torso scende dai fianchi avvol-gendo le gambe tra le quali ricade con abbondanti pieghe che nascono dal nodo formato dalla stoffa all’altezza dell’inguine (77), e che richiama il modello della
(73) Vedi la pittura parietale del viridarium, parete O della Casa di Romolo e Remo
a Pompei (I secolo d.C.) raffigurante una fontana a forma di cratere tra due ninfe con in mano un bacino che talvolta anche nella statuaria sostituisce la conchiglia, V. SAMPAOLO, VII, 7, 10. Casa di Romolo e Remo, in P.P.M. VII (1997), pp. 271-274 e M. BIEBER, The Sculpture of the Hellenistic Age, New York 1955, p. 150, fig. 636; un affresco della casa delle Vestali di Pompei, oggi al Louvre di Parigi, datato agli anni 70 del I secolo d.C. in cui due ninfe stanti e semidrappeggiate, che affiancano la personificazione di un fiume, forse il Sarno, reggono ciascuna un catino che funge da lacus, T.T. TRAN, Catalogue des peintures romaines (Latium et Campanie) du musée du Louvre, Paris 1974, pp. 35-37, n. 10; la pittura raffigurante tra l’altro due Ninfe fontana su pilastrino con bacino a conchi-glia della parete S del viridarium della Casa di Sallustio a Pompei (VI, 2, 4), V. SAMPAO-LO, VI 2, 4 Casa di Sallustio, in P.P.M. IV, 1 (1991), p. 135, figs. 76, 80a-b.
(74) Vedi il pavimento dell’impluvium della Casa di Industrius a Cartagine oggi al Museo del Bardo che raffigura Venere tra due Ninfe nude con conchiglia da cui scende dell’acqua, in F. DU COUDRAY LA BLANCHÈRE - P. GAUCKLER, Catalogue du Musée Ala-oui, Paris 1897, p. 26, n. 123.
(75) Il tipo meno frequentemente è presente anche su gioielli e monete, cfr. HALM TISSERANT - SIEBERT, s.v Nymphai, cit., p. 893, nn. 15 e 19.
(76) Per una prima classificazione delle Ninfe con conchiglia vedi F. GHEDINI, Scultu-re dal ninfeo e dal pretorio di Gortina, in «Ann. Scuola archeol. Atene» 63 (1985), pp. 63-248 che divide queste statue in: tipo A ispirato alla Venere Pudica, tipo B con veste aperta derivato dalla Venere Landolina, tipo C caratterizzato dalla nudità e tipo D completamente vestito. Vedi anche un’altra classificazione meno convincente, perché più semplicisticamen-te basata sulle dimensioni della conchiglia e non sul modello iconografico alla base delle re-pliche, proposta da M. KOPPEL, Die römischen Skulpturen von Tarraco, cit., pp. 118-119.
(77) Per alcuni confronti vedi la così detta Nymphe de Sainte-Colombe rinvenuta all’interno delle terme romane, in M.P. WUILLEUMIER, La Nymphe de Sainte-Colombe, in «Gallia» 4 (1946), pp. 195-198 con numerosi altri paralleli citati così come quelli presentati in KAPOSSY, Brunnenfiguren der hellenistischen und römischen Zeit, cit., pp. 12-13; l’esemplare di Tralles al Museo di Istanbul in G. MENDEL, Catalogue des scul-ptures grecques, romaines et byzantines, II, Constantinople 1914, pp. 263-264, n. 543 con ricca bibliografia; un pezzo di prima età imperiale con incerto alloggiamento per la fistula dell’acqua in L. DE LACHENAL, Frammento di statua di ninfa semipanneggiata, in A. GIULIANO (a cura di), Museo Nazionale Romano. Le sculture I, 3, Roma 1982, pp. 150-151; l’esemplare di II secolo rinvenuto nel teatro di Leptis Magna privo di fori per
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 201
Venere Pudica drappeggiata (78). Più rara, ma ispirata allo stesso modello, un’altra variante in cui le pieghe centrali del drappeggio finiscono con confluire le condutture dell’acqua in G. CAPUTO - G. TRAVERSARI, Le sculture del teatro di Lep-tis Magna, Roma 1976 (= ‘Monografie di archeologia libica’ 13), p. 60, n. 38, tav. 35; l’esemplare di età imperiale dal ninfeo di Gortina in F. GHEDINI, Sculture dal ninfeo, cit., pp. 147-153, n. 28; l’esemplare della collezione Cook in E. STRONG, Antiques in the Collection of Sir Frederick Cook, bart., at Doughty House, Richmond, in «Journ. Hell. Stud.» 28 (1908), pp. 18-19, n. 26, tav. 13; l’esemplare della fontana di Poseidon di Corinto di II secolo d.C. in R.L. SCRANTON, Corinth volume I, part III. Monuments in the lower agora and the north of the arcaic tempel, Princeton, New Jersey 1951, p. 34, tav. 15, 2; un esemplare rinvenuto a Sagalassos e conservato al Museo archeologi-co di Burdur in Turchia (Inv. n. SA 02 DA1/151); la statua frammentaria, datata all’inizio del III secolo d.C., rinvenuta a Trier e caratterizzata dall’alloggiamento per il passaggio del tubo dell’acqua in W. BINSFELD - K. GOETHERT - POLASCHEK- L. SCHWINDEN, Katalog der römischen Steindenkmäler des Rheinischen Landesmuseums Trier. 1. Götter- und Weihedenkmäler, Mainz 1988 (= ‘Trierer Grabungen und Forschungen’ 12, 1 / CSIR Deu-tschland 4, 3), pp. 140-141, n. 293, tav. 70; la statua di II secolo d.C. con foro per fistula conservata a Tarragona, KOPPEL, Die römischen Skulpturen von Tarraco, cit., pp. 118-119, n. 186; l’esemplare rinvenuto nelle terme di Sestinum con condotto per l’acqua, M.M. MORCIANO, La ninfa con conchiglia di Sestinum, in G. RONCAGLIA - A. DONATI - G. PUNTO (a cura di), Appennino tra antichità e medioevo, Città di Castello 2003, pp. 77-80 e le rilavorazioni di una statua conservata al Prado in S.F. SCHRÖDER, Katalog der antiken Skulpturen des Museo del Prado in Madrid. 2, Idealplastik, Mainz am Rhein 2004, pp. 169-173, n. 128. Vedi anche la statuetta (h. 33) in bronzo rinvenuta non lontano dal tricli-nio estivo della Casa dell’Efebo a Pompei (I, 7, 10-12), M. BIEBER, The sculpture of the hellenistic Age, New York 1955, p. 150, fig. 637. Una variante di questo gruppo si carat-terizza per la posizione della conchiglia che non è sorretta in orizzontale come fosse un bacile ma collocata in verticale, aderente al corpo, in modo da coprire il nodo del panneg-gio e la parte superiore delle cosce: vedi ad esempio il pezzo rinvenuto nelle Terme Gran-di di Thamugadi datata ad epoca antoniniano-severiana in H. MANDERSCHEID, Die Skul-pturenausstattung der kaiserzeitlichen Thermenanlagen, Berlin 1981 (= ‘Monumenta Ar-tis Romanae’ 15), p. 122, n. 477, tav. 48; un bronzetto di soli 12,5 cm di altezza, attribuito con riserva al III secolo d.C., poiché ritenuto anche copia rinascimentale, in F. HERMANIN, Il Palazzo di Venezia, Roma 1948, p. 297; A. SANTANGELO, Museo di Palazzo Venezia. Catalogo delle sculture, Roma 1954, p. 8. Questo modo di tenere la conchiglia ricorre an-che su una serie di rilievi rinvenuti a Salona e nel territorio circostante, dove forse è con-dizionato dal fatto che non si tratta di sculture a tutto tondo, in cui le ninfe sono del tipo semidrappeggiato o vestite, D. MARŠIĆ, Ikonografski tip nimfa sa školjkama, in «Vjesnik arh. muz. Zagreb» 3.s., 30-31 (1997-1998), pp. 103-124.
(78) Per questo tipo e per la discussa cronologia della sua origine vedi A. DI VITA, L’Afrodite Pudica da Punta delle Sabbie ed il tipo della Pudica drappeggiata, in «Arch. class.» 7 (1955), pp. 9-23 che ne fissa l’elaborazione a poco dopo la metà del II secolo a.C. Vedi anche con ricca bibliografia DELIVORRIAS - BERGER DIER - KOSSATZ -DEISSMANN, s.v. Aphrodite, cit., pp. 76-78.
GIULIA BARATTA 202
e unirsi ad un vero e proprio sostegno per la conchiglia (79). In alcuni altri spo-radici casi la veste è invece totalmente assente (80). Esistono inoltre altre varian-ti, seppure meno frequenti, che si differenziano per la postura delle figura: in al-cuni casi questa presenta le gambe piegate per bilanciare il peso della conchiglia, che non regge dinnanzi a se facendola aderire al corpo, ma che si sta accingendo a sollevare (81). Questo modello si ritrova anche nella variante in cui la conchi-glia, sostituita da un catino, è posata su una colonnina (82). Infine, seppure molto raramente, la ninfa con conchiglia può essere anche inginocchiata al suolo e te-nere la valva appoggiata sulle cosce (83).
La statua di Fabriano non presenta fori per l’alloggiamento delle fistule d’acqua ma non per questo può essere considerata una testimonianza di culto dell’antico municipio di Tuficum (84), come supposto a suo tempo dall’erudito C. Ramelli ed ancora di recente da L. Innocenzi. Si tratta piuttosto di un elemen-
(79) Vedi l’esemplare verosimilmente di epoca antoniniana rinvenuto nel teatro di
Leptis Magna e caratterizzato dal foro per il passaggio dell’acqua in F. TOMASELLO, Fon-tane e ninfei minori di Leptis Magna, Roma 2005 (= ‘Monografie di archeologia libica’ 27), pp. 171-173, tav. C, 3-6 e CAPUTO - TRAVERSARI, Le sculture del teatro, cit., p. 60, n. 39, tav. 36.
(80) Vedi la statua frammentaria rinvenuta a Peirene in F.P. JOHNSON, Corinth, IX, Sculpture 1896-1923, Cambridge, Massachusetts 1931, p. 39, n. 37.
(81) Vedi l’esemplare conservato a San Pietroburgo in HALM TISSERANT - SIEBERT, s.v. Nymphai, cit., p. 893, n. 13 a. Una variante è costituita dall’esemplare di II secolo d.C. conservato alla Galleria Borghese in cui la conchiglia è sostituita da un bacile, vedi MORENO - VIACAVA, I Marmi antichi della Gallerie Borghese, cit., p. 228, n. 214.
(82) Vedi l’esemplare del Museo Pio Clementino in AMELUNG, Die Skulpturen, cit., pp. 616-618, n. 405, tav. 58.
(83) Vedi i due esemplari di Ninfa inginocchiata e vestita con un chitone e con la conchiglia poggiata sulle cosce e sorretta dalle mani, conservati al Nationalmuseum di Stockholm, Inv. n. NM Sk 21 e 22 in A.-M. LEANDER-TOUATI, The Piranesi marbles from Rome to Stockholm, in «Opuscula Romana» 30 (2005), p. 13, fig. 4 e p. 13, fig. 5.
(84) Il culto di Venere a Tuficum è comunque attestato da almeno due iscrizioni. C.I.L. XI 5688 : Mamilia Urbana Tifania Amoena / basim aediculam Veneri aram / d(e) s(uo) d(ederunt). C.I.L. XI 5687: C(aius) Caesius C(ai) f(ilius) Ouf(entina) / Silvester p(rimi)p(ilaris) / aedem Veneris / s(olo) p(rivato) p(ecunia) s(ua) f(ecit). Per una panora-mica generale sui culti nell’area centro-adriatica orientale vedi G. PACI, I culti pagani sul-le due sponde dell’Adriatico centrale, in Les cultes polythéistes dans l’Adriatique romai-ne, Bordeaux 2000, pp. 155-169, part. p. 161.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 203
to di arredo di un giardino, verosimilmente legato ad una fontana oppure un nin-feo (85), pertinenti ad una ricca domus o ad un edificio di carattere pubblico.
Per considerazioni stilistiche e storiche e sulla base dei confronti quasi tutti inquadrabili al II secolo d.C., l’esemplare tuficano può essere datato a questo stesso periodo e più verosimilmente verso la fine del secolo.
26. Statua di Musa (Fig. 11 a-c)
Fig. 11a-c – Statua di Musa (Roma, Musei Capitolini, Magazzini, inv. 1632). Luogo e contesto di rinvenimento: genericamente indicato come Albacina. Materiale: marmo proconnesio. Misure: h. 75 cm; plinto 3,5 cm. Luogo di conservazione: Roma, Musei Capitolini, Magazzini, inv. 1632.
Bibl.: «Bull. com» 1877, p. 267, n. 3.
(85) Sulle fontane e sui ninfei vedi N. NEUERBURG, L’architettura delle fontane e
dei ninfei nell’Italia Antica, Napoli 1965 (= ‘Memorie dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli’ 5).
GIULIA BARATTA 204
La statua muliebre, il cui “Einsatzkopf” è perduto, risulta mancante del braccio destro, del piede destro, di una porzione del plinto e presenta diverse scheggiature sulla superficie litica. La figura indossa un chitone senza maniche, trattenuto sotto il seno da un nastro annodato, ed un mantello che dalla spalla si-nistra scende sul fianco destro ed è sorretto dall’avambraccio sinistro. Il tratta-mento delle superfici è piuttosto appiattito ed i panneggi di entrambi i capi di ab-bigliamento, caratterizzati da poche, pesanti pieghe, sottolineate da profonde in-cisioni a trapano, risultano pastosi e del tutto privi di movimento. La piega infe-riore del manto e la parte terminale di quelle del chitone mostrano un solco “in-certo” e “tremante” mal definito nel suo andamento. La mano destra è appoggia-ta al corrispondente fianco e l’indice è posto tra le pieghe del mantello, mentre la sinistra regge un volumen con entrambe le estremità arrotolate, la cui parte cen-trale, svolta, è ripiegata su se stessa (86). La parte posteriore della scultura è la-vorata in maniera più sommaria.
Questa statua pubblicata nel Bollettino Comunale del 1877 tra gli acquisti della Commissione veniva all’epoca descritta come «Musa. Statua muliebre ace-fala e mancante del braccio diritto. È vestita di tunica e pallio, e rappresenta pro-babilmente Clio, la musa della Storia, tenendo essa con la sinistra un volume svolto nel mezzo, e ravvolto alle due estremità, come sovente si osserva. Marmo lunense (alta m. 0,75). Fu trovata in Albacina nelle Marche, e venne acquistata dalla Commissione. Nei magazzini del Tabulario».
L’identificazione come Musa non pare scorretta anche se non è del tutto certo che possa trattarsi proprio di Clio, come pure sembrerebbe indicare la com-binazione tra il tipo iconografico e l’attributo, il volumen (87), anche se in genere
(86) Per un confronto di volumen arrotolato ad entrambe le estremità ma con la parte
svolta ripiegata su se stessa in modo la lasciare l’iniziale e la terminale all’esterno, vedi un frammento di sarcofago in L. MUSSO, Frammento di sarcofago con figura femminile seduta e orante, in A. GIULIANO, Museo Nazionale Romano, Le sculture I, 10, Roma 1995, pp. 73-77, fig. 51; L. MUSSO, Sei frammenti di lenòs con gruppo di filosofi, in A. GIULIANO, Mu-seo Nazionale Romano, Le sculture I, 10, Roma 1995, p. 79, fig. 52; infra nota 89.
(87) Per una raffigurazione di Clio con volumen vedi una pittura della Villa di Giu-lia Felice a Pompei (II, 4, 3), W. HELBIG, Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Stä-dte Campaniens, Leipzig 1878, p. 173, n. 859; vedi anche il rilievo del teatro di Hierapo-lis in cui la Musa con papiro è identificata come Clio, F. D’ANDRIA - T. RITTI, Le sculture del teatro. I rilievi con i cicli di Apollo ed Artemide, Roma 1985 (= ‘Hierapolis, scavi e ri-cerche’ II), p. 85. Sul frammento di sarcofago conservato a Palazzo Cardelli a Roma è raf-figurata, tra le altre, una Musa con manto trasverso e volumen nella sinistra abbassata la cui identificazione con Clio o Calliope resta incerta, cfr. M. WEGNER, Die Musensarko-phage, Berlin 1966 (= ‘A.S.R.’ 5, 3), pp. 62-63, n. 161. e L. PADUANO FAEDO, I sarcofa-gi romani con Muse, in A.N.R.W. 12, 2 (1981), p. 140 e nota n. 215.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 205
la musa della storia è raffigurata in scultura, in particolare sui sarcofagi, con un dittico (88). Il volumen caratterizza normalmente Calliope e Polimnia (89) i cui schemi iconografici non corrispondono però a quello della statua di Tuficum, ri-conducibile invece al gruppo D I della classificazione di L. Faedo che risulta at-testata per Clio, oltre che per Talia ed Urania, con varianti relative agli attributi ed ai gesti, in un arco cronologico che va dal 130 sino all’inizio del IV secolo d.C. (90).
La statua era probabilmente parte di un ciclo decorativo, comprendente, si deve immaginare, anche le altre muse, e pertinente forse all’arredo di una villa o di un edificio a carattere pubblico (91). Il fatto che la parte posteriore sia meno rifinita e che la scultura si caratterizzi per uno spessore piuttosto ridotto farebbe pensare ad una sua collocazione all’interno di una nicchia.
Le caratteristiche stilistiche e la resa del panneggio inducono a datare la sta-tua almeno alla seconda metà del III secolo d.C. e più probabilmente alla sua fine se non addirittura agli inizi del IV secolo d.C. Si tratta, pertanto, insieme al ritrat-to maschile bronzeo (cat. n. 18) di una delle attestazioni scultoree più tarde del municipio di Tuficum.
Forse non è un caso che ad Albacina, da dove la statua proviene, nei pressi dell’attuale villa Censi Mancia, esista una località detta Le Muse e che proprio in
(88) Per l’iconografia delle Muse vedi O. BIE, Die Musen in der Antiken Kunst, Ber-
lin 1887, part. p. 72 per il tipo “Muse stehend mit der Rolle”; WEGNER, Die Musensarko-phage, cit., part. pp. 107-109 per Clio; C. PANELLA, Iconografia delle Muse sui sarcofagi romani, Roma 1968 (= ‘Studi Miscellanei’ 12), pp. 15-39 e in part. pp. 16-17 in cui chia-risce «A Clio…la vecchia esegesi aveva attribuito il rotolo, mentre a Calliope era stato assegnato, attraverso un processo ingiustificabile, il dittico che invece, in base alle fonti figurate esistenti…, dovrebbe caratterizzare Clio», e pp. 25-26 specificatamente sulla musa delle storia; PADUANO FAEDO, I sarcofagi romani con Muse, cit., in part. pp. 109-113 per Clio; J. LANCHA - L. FAEDO, s.v. Mousa, Mousai / Musae, in L.I.M.C. VII, 1 (1994), pp. 1013-1059; M.T. CAMILLONI, Le Muse, Roma 1998, in part. pp. 41-47. Vedi anche il paragrafo dedicato alla Musa Clio in P. PENSABENE, Il teatro romano di Feren-to. Architettura e decorazione scultorea, Roma 1989 (= ‘Biblioteca archeologica’ 8), pp. 80-81.
(89) Per le caratteristiche iconografiche di queste due Muse vedi i rispettivi capi-toli nella bibliografia citata supra alla nota 88. Vedi inoltre il braccio frammentario at-tribuito a Calliope dal teatro di Ferento, PENSABENE, Il teatro romano di Ferento, cit., p. 81.
(90) LANCHA - FAEDO, Mousa, Mousai / Musae, cit., p. 1033 e p. 1054. Per il tipo e la sua origine vedi anche PADUANO FAEDO, I sarcofagi romani con Muse, cit., p. 148.
(91) Per i cicli di muse nei teatri, la loro origine e lo sviluppo dei modelli iconogra-fici vedi PENSABENE, Il teatro romano di Ferento, cit., pp. 65-67.
GIULIA BARATTA 206
questa sia stata ritrovata una struttura, pertinente probabilmente ad un villa con annessa parte agricola, che risulta, sulla base dei materiali rinvenuti, ancora in uso tra il IV e il V secolo d.C. (92). In via del tutto ipotetica si potrebbe pensa-re che la scultura di Musa attualmente conservata ai Musei Capitolini, insieme alle altre oggi perdute, abbiano suggerito il toponimo e fossero in origine per-tinenti alla villa che vi è stata identificata, a meno di non pensare che esso de-rivi da un mosaico o altro.
27. Probabile statua di Cerere
Luogo e contesto di rinvenimento: sconosciuti, comunque attribuita al terri-torio del municipio di Tuficum.
Materiale: marmo. Misure: non indicate. Luogo di conservazione: perduta? inesistente?
Bibl.: C. RAMELLI, Studi storici Fabrianesi, p. 32, ms. conservato bibliote-ca Raccamadoro Ramelli, parzialmente trascritto in M.F. PETRACCIA (a cura di), Gli ´Studi Storici’ di Camillo Ramelli e il Lapidario del Palazzo Comunale di Fabriano, Fabriano 2007, pp. 60-61; C. RAMELLI, Cenni storici sopra Tufico, Sanseverino 1848, p. 15.
Poco si sa di questa statua alla quale C. Ramelli fa solo un breve accenno
nel manoscritto «Studi storici Fabrianesi», ripreso poi con maggiore sinteticità nel volume del 1848, in cui scrive: «Il culto inoltre di Cerere con il titolo di alma datogli recentemente dagli antichi ( ) sarebbe provato presso i Tuficani, se non ci nascesse qualche dubbio sull’autenticità dell’analogo monumento (Isc. IX) (93) che, mai veduto da alcuno, vogliono parecchj scrittori ( ) essersi rinve-nuto sopra la porta di una marmorea cappelletta, nel VI seco dissotterrata. E maggior peso riceve la nostra dubbiezza dallo asserire essi, che nel mezzo di quel tempietto esistesse anche una statua in marmo di quella Dea, mandata poi da Giovanni di Vitaliano a Roma, e che tale rinvenimento ebbe luogo, allorché il celebre Belisario, dopo presi li quartieri d’inverno in Alba, edificò su quel suolo il castello che da Cerere ebbe nome Cerreto…».
Il rinvenimento di quella che apparentemente sembrerebbe essere un’edi-cola o un piccolo tempio dedicato a Cerere e di una statua marmorea della dea, è
(92) MANCINI - PIGNOCCHI, L’insediamento romano imperiale, cit., pp. 313-328. (93) C. Ramelli scrive a proposito dell’iscrizione «Non trovasi oggi più ed ai tempi
stessi del De Vecchi venne riferita da lui p. 79 sull’autorità di antichi manoscritti, come scoperta in Cerreto; e spettante peraltro al vicino Tufico…», vedi RAMELLI, Cenni storici, cit., iscr. n. 9.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 207
messo in dubbio già dallo stesso Ramelli. Purtroppo rispetto all’edificio, testi-moniato da un’iscrizione non più esistente, e alla statua, entrambi rinvenuti stan-do alle fonti usate dal Ramelli nel VI secolo d.C. all’epoca di Belisario, non è possibile aggiungere nulla. Rimane solo la singolare vicenda della statua che sa-rebbe stata mandata a Roma per volontà o presso Giovanni di Vitaliano, nipote di Vitaliano console nel 520 d.C., magister militum sotto Giustianiano, si deve supporre quale bottino di guerra.
28. Dito di bronzo
Luogo e contesto di rinvenimento: Albacina, in un terreno di proprietà del Sig. Enrico Boldoni di Francesco in contrada Moresine nello stesso luogo da cui provengono le statue di Attis (cat. n. 23) e Cibele (n. 24) e la testa forse identifi-cabile con quella di Tiberio (cat. n. 17).
Materiale: bronzo. Misure: non indicate. Il pezzo viene descritto come pertinente ad una statua
“colossale”. Luogo di conservazione: non rintracciabile, perduto.
Bibl.: « Not. Scavi »1877 p. 244. Alla luce delle scarse informazioni sul “dito di statua colossale in bronzo”
nulla si può evincere sulla natura e la cronologia della scultura cui era pertinente. Si tratta comunque di una notizia interessante che testimonia l’esistenza di un’altra statua bronzea, oltre al ritratto maschile (cat. n. 18), addirittura di dimen-sioni più grandi del naturale.
29. Mano frammentaria (Fig. 12)
Fig. 12 – Mano frammentaria.
GIULIA BARATTA 208
Luogo e contesto di rinvenimento: sconosciuti, ma sicuramente nel territo-rio di Albacina o Borgo Tufico.
Materiale: marmo di Carrara. Misure: lung. mass. cons. circa 17 cm. Luogo di conservazione: Albacina, Villa Censi Mancia.
Bibl: inedito. Si tratta di una mano destra, più grande del naturale, mancante della parte
vicina al polso, di quattro dita e della falange terminale del medio che risulta leggermente curvo. Lo stato di conservazione non consente di avanzare ipotesi sulla natura e la cronologia della statua cui era pertinente.
Appendice.
Presunto fallo o Priapo (Fig. 13)
Fig. 13 – Colonna.
Reperti scultorei da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina) 209
Luogo e contesto di rinvenimento: il pezzo viene segnalato come prove-niente da Tuficum in luogo e data sconosciuti, comunque anteriormente al 1848, e conservato ad Albacina innanzi alla casa della Famiglia Mattioli.
Materiale: litico. Dimensioni: h. circa 1,50 cm. Luogo di conservazione: Albacina, dinnanzi alla casa che fu della famiglia
Mattioli.
Bibl.: C. RAMELLI, Cenni storici sopra Tufico, Sanseverino 1848, p. 15; U. ALESSANDRONI, Storia albacinese, Fabriano 1975, p. 13.
C. Ramelli così descrive il reperto: «…anche Tufico n’ebbe (di phalli ossia
Priapi) ad advertendum fascinum, serbandosene tuttora uno in Albacina innanzi la casa della famiglia Mattioli, coll’aggiunta vicino al glande di alcune lettere, che danno però una troppo misera, e quasi abrasa iscrizione per poterne dire qualche cosa con fondamento». Un sopralluogo condotto ad Albacina ha con-sentito di verificare che il reperto in questione non corrisponde ad una scultura bensì ad un frammento di fusto di colonna dalla sommità stondata e privo di testo epigrafico, ancora oggi presente nel giardino della casa che fu della fami-glia Mattioli (94).
RIASSUNTO
In questo articolo si presentano le sculture di Tuficum che è stato possibile ve-dere o comunque documentare sino alla fine del 2012. Altri pezzi attualmente non vi-sibili verranno studiati in un prossimo lavoro.
Scultura, Tuficum, marmo, bronzo.
SUMMARY
In this paper are presented Tuficum’s sculptures that it has been possible to see or in any case to document until the end of the year 2012. Other pieces nowadays not visible will be studied in a near work.
Sculpture, Tuficum, bronze, marble.
(94) Allo stesso modo si deve ritenere che anche il “fallo” custodito nel giardino di
Villa Censi Mancia corrisponda ad una porzione di fusto di colonna ivi conservato, vedi ALESSANDRONI, Storia, cit., p. 13 ove si fa menzione del pezzo.