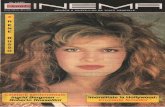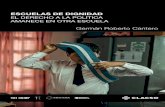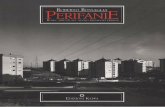Roberto Guicciardini drammaturgo
Transcript of Roberto Guicciardini drammaturgo
UN ALBERO IN MEZZO AL PRATOINTORNO AL QUALE BALLARE
Teatro popolare Teatro pubbliconella Toscana del dopoguerra
da Vito Pandolfi al Gruppo della Rocca
a cura diAndrea Mancini
testi diRoberto Guicciardini, Marzia Pieri, Valerio Valoriani
Citta di San Gimignano
•Titivillus
Un albero in mezzo al Pratointorno al quale ballarea cura di Andrea Mancini
esce in occasione della mostra, promossa dall'Assessorato alIa Cultura delComune di San Gimignano col patrocinio della Regione Toscana,
Teatro popolare Teatro pubbliconella Toscana del dopoguerrada Vito Pandolfi al Gruppo della Rocca
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Raffaele De Grada"San Gimignano, 7 dicembre 2005 - 26 febbraio 2006
ideazione: Roberto Terribile e Andrea Mancinicoordinamento organizzativo: Pilade Cantini, Meri Malagutiallestimento mostra: Angelo Italianoriprese e montaggio film: Angelo Italianotrascrizione interviste: Chiara Simonesegreteria organizzativa: Gabriel Stohrer, Lucrezia Armano, Renzo Caporossicura editoriale e collaborazione tecnica (in particolare per tutta la sezione dedicata a Perela,Candido e per Ie teatrografie): Nicoletta Freschi e Elena Del Savioufficio stampa: Agenzia Impress (Comune di San Gimignano)
Photocreditspp. 33, 34, 36, 47, 76 Fondo Pandolfi, Roma; pp. 35-37 Fondo Gastone Bosio, Museo Biblioteca dell'Attore, Genova; pp. 38,42,43,46,54 Fondo Ridenti, Centro Studi Teatro Stabile Torino; pp. 39-41 Archivio Teatro Comunale Firenze; pp. 48-53, 80, 83-127 ArchivioGuicciardini, San Girnignano; pp. 44,45 Archivio Carla Bizzarri, Roma; pp. 55, 56 Fondo Robert van Nuffe1, Bruxelles; pp. 57-67, 75 Foto Fontanelli, San Girnignano, ArchivioGuicciardini; pp. 68-80 Centro Studi Teatro Stabile Torino; pp. 71-74 Foto Fontanelli, FotoLocchi, Archivio della Proloco di Certaldo; p. 129 Centro Maschere e Strutture Gestuali,Abano Terme; pp. 132, 133, 208, 216-222 Foto L. Cirninaghi; p. 139 Antonio Sferlazzo;pp. 205,206 Gianfranco Mantegna; p. 207 Tapparo e Trentin (Cinecolorfoto); p. 209 PaoloZappaterra; pp. 210-214 Pino Abbrescia, L. Cirninaghi - E. Ghiringhelli, Studio Fotograficodel Piccolo Teatro di Milano; p. 215 Studio Pedrotti; pp. 224, 225, 227-230 Tommaso LePera; p. 226 Elisabeth Hausmann.
Gli editori hanno cercato, per quanta possibile, di risalire agli autori delle foto pubblicate, provenienti da collezioni private, dall'archivio del curatore 0 daquello di RobertoGuicciardini, che ci preme ringraziare per la sua eccezionale disponibilita. Se hanno commesso errori od omissioni si dichiarano disponibili a correggerli in sede di un'eventualeristampa.
Si ringraziano per la collaborazione tutti coloro i quali hanno creduto nel progetto ehanno reso possibile la realirzarione della mostra e del presente volume, in particolareit Comune di San Gimignano (Sindaco Marco Lisi, Assessore alla Cultura Gianna Coppini, Dirigente del Settore Cultura Valerio Bartoloni e Direttore dei Musei Ovid Antonello Mennucci), la Fondazione Istituto del Dramma Popolare, it Teatrino dei Fondi,la Fondazione Aida, it professor Dilvo Lotti, Dario Marconcini, Valerio Valoriani (oltreche per l'intervista, per it prezioso materiale messo a disposizione}, Lanfranco Binni,Mariangela Zucconi e it Dipartimento Spettacolo della Regione Toscana.
impaginazione: Massimo Nigi e Cristiano Minelli
In copertinaIsabella comica gelosa a San Gimignano, 1959
© 2005 Comune di San Gimignano
© 2005 Titivillus Edizionivia Zara, 58 56020 Corazzano (Pisa)Tel. 0571 462825/35 - Fax 0571 462700internet: http://www.titivillus.ite-mail: [email protected]
Roberto Guicciardini drammaturgo
Marzia Pieri
Nel 1970 il Gruppo della Rocca - nato nell'anno precedente come «collettivo sociale» quindi ridefinitosi cooperativa - poteva apparire una fra Ietante nuove compagnie teatrali animate dai fervidi entusiasmi sessantottini, spazio di giovani appassionati, di diverse provenienze, che difendevanoun'utopia alternativa di tipo collettivo dalle radici antiche. Ne facevanoparte un regista trentenne, Roberto Guicciardini, uno scenografo pieno difantasia, Lorenzo Ghiglia, dieci attori (Laura Mannucchi, Marcello Bartoli, Mario Mariani, Halo Dall'Orto, Egisto Marcucci, Paila Pavese, GianniDe Lellis, Dorotea Aslanidis, Nelide Giammarco, Alvaro Piccardi) e alcuni tecnici, legati da un accordo di uguaglianza economica nella divisionedi rischi e utili, e dall'ambizione di lavorare insieme a tutti i livelli dellaprogettazione e della realizzazione degli spettacoli. Era un'ipotesi generosa e difficile, in quegli anni assai attuale, che si sarebbe rivelata prestodi corto respiro per alcuni che l'avevano abbracciata. Molti altri gruppi,come si sa, si sarebbero dovuti arrendere di fronte aIle contraddizioni delmercato, ai nodi irrisolti del rapporto con Ie istituzioni, aIle oggettive difficolta di praticare eticamente e creativamente un duro lavoro comune;ideologismi eccessivi e confusi, debolezze metodologiche, carenze tecniche avrebbero fatto il resto, ricacciando ai margini tanto di questa giovaneteatro di innovazione.«Roma non era ancora la citta sinistra e spettrale che divento nel dopo-Morocon quegli odori di putrefazione gia COS! forti dopo la morte di Pasolini, enon pili tollerabili dopo il ritrovamento di quel cadavere rannicchiato nelbagagliaio. Era una citta agitata, eccitata da ogni forma di sporcizia, animata dal gusto di far teatro e dal bisogno di travestirsi. Un campo profughi, una riserva di lusso dove la pittoresca gioventu del Sessantotto cercavadi mettere radici, gia troppo cresciuta, invecchiata, dispersa come una tribu di zingari allo sbando coi loro ori, scialli, maxi e minigonne, stivaloni,
165
Marzia Pieri
criniere» (Un po' prima del piombo. Il teatro in Italia negli anni Settanta,J;?refazione di Ferdinando Taviani, Sansoni, Firenze 1998, p. 347).E il ricordo malinconico e vivido di un grande critico teatrale, Cesare Garboli, che in quegli anni, «un po' prima del piombo» stragista e terroristicoche avrebbe insanguinato il paese, coglie bagliori e premonizioni di unacrisi decisiva prossima ventura. Intorno c'era l'altra capitale, Milano, nonancora «da bere» e spesso di gusti teatrali antagonisti, e il vasto arcipelago delle piccole e medie citta italiane e dell'eterna provincia pili 0 menoprofonda. I giovani del gruppo della Rocca, pen'>, venivano dalla Toscana,un'enclave anomala da cui sembrano derivare a1cuni potenti anticorpi checonsentiranno 101'0 di mettere solide radici: un senso forte del mestiere, della disciplinata fatica dellavoro comune, una solida cultura di riferimento, lamodestia tenace di un progetto pedagogico e popolare che presto Ii caratterizzera come una duratura eccezione nel panorama di quegli anni. La 101'0
natura di collettivo teatrale si collega del resto, nell'eredita di Pandolfi, alIagrande tradizione delle compagnie italiane, ed esprime, da questa punto divista, tutta la freschezza e la vitalita di una provincia ricca di storia e dotatadi un sicuro mestiere: «ogni spettacolo era un laboratorio dove verificareuna curiosita, dove tracciare un'esperienza, dove far esplodere entusiasmi enostalgie: in maniera a volte. confusa e ingenua, ma altrettanto spesso conintelligenza e poesia».Le loro scelte di repertorio cominciano dalla Clizia di Machiavelli e dalleFarse di Brecht (ma Guicciardini si era gia distinto in una celebre Mandragala al forte di Belvedere di Firenze), cioe da due autori decisivi nel patrimonio genetico del teatro italiano moderno, e si coagulano in due spettacoli-manifestoPerela e Candido, concepiti e realizzati quasi a dittico fra il1970 e il1971, che costituiscono la lora referenza e delineano illoro ritrattoartistico con una significativa complementarieta,Furono infatti due grandi successi di pubblico e di critica, che consacraronol'attivita del gruppo come una delle pili originali nel panorama nazionale,in una curiosa zona liminale fra tradizione e avanguardia. L'ampio paratesto recensorio che sopravvive testimonia, come spesso accade alle fontisecondarie utilizzabili per la storia dello spettacolo, molte cose soprattuttoper via indiretta e obliqua; i vuoti e Ie contraddizioni a volte contano pilidi cio che si dice apertamente: all'entusiasmo dei critici pili attrezzati esensibili, e all'adesione maggioritaria del pubblico, 'riscaldato' dalla festaintelligente .regalata da questi spettacoli, si accompagna talvolta 10 sconcerto intimidito delle .platee di provincia, la diffidenza accigliata di a1cunetestate molto schierate 'a destra', il biasimo di sacche d' opinione ancoraquasi comicamente clericali. Ripercorrendo il panorama di queste testi-
166
Roberto Guicciardini drammaturgo
monianze, peraltro foltissimo di presenze e molto vivace, si ricostruiscela radiografia di una Italia ancora a meta del guado fra provincialismo emodernizzazione, dove l' energia intelligente e giovanile di Guicciardinie dei suoi appare in grado di incidere e di scombussolare, e dove, semmai,sono proprio i linguaggi e le liturgie della critica ad apparire fragili, afasicio scontati. Col senno di poi si percepisce, in diversi recensori che ancorascrivono in una sorta di prosa d'arte giornalistico-letteraria, un imminenteesaurimento, l'ansiosa consapevolezza del venir meno della propria funzione istituzionale, in un processo di cui possiamo oggi misurare tutta la gravita. In molti ripetono che il teatro ein crisi, denunciano che sta perdendoterreno, lamentano il degrado strisciante degli spettatori e l'opacita ritualedi alcuni appuntamenti istituzionali, come quello della Biennale. Ad alcunipubblici di provincia, dunque, che disertano e si intimidiscono, i cattolicifanno le loro riserve d'uf~cio, i vecchi critici un po' a disagio si sforzanoloro malgrado di capire, e i nuovi e pili agguerriti leoni (Quadri, Pagliarani,Greco, Moscati, Cibotto, Radice, De Monticelli, Prosperi) inneggiano conentusiasmo al nuovo, ma il grosso degli spettatori applaude a scena apertae si diverte.Da parte lora questi giovani teatranti si muovono con leggerezza, come fanno i guitti, occupando tutti gli spazi disponibili - i festival, i teatri ufficiali,le case del popolo, ogni genere di palco grande 0 piccolo ai quattro angolid'Italia - cercando comunque di raggiungere e di toccare queste platee, incui si mescolano gli habitue borghesi provvisti di abbonamento (turbatidal mix sconcertante loro somministrato di Brecht, Living, Grotowsky equant'altro), e frange giovani e irrequiete di spettatori che si affacciano alconsumo culturale con occhi nuovi.Proprio in quegli anni a Costanza, in Germania, un gruppo di filologi e dicritici stava mettendo a punto uno strumento di indagine dei testi letterari la cosiddetta teoria della ricezione che si proponeva di supplire alIa crisi disaturazione del sociologismo marxista come del formalismo strutturalista,portando, per la prima volta, l'attenzione sullettore, considerato un terzo,fondamentale oggetto di indagine accanto all'autore e al testo. E anche inteatro si avvertivano problemi identici, carenzeda colmare e aggiornamentida compiere in direzioni analoghe, mentre ai pili apparivano esauriti sia ilteatro di tradizione che Ie audacie dell'avanguardia. II problema dello spettatore, del destinatario, era pili chemaiinprimopianodopoArtaud.Copeau e Brecht, e il Gruppo della Rocca sembra particolarmente sensibile einteressato a stringere con questa pubblico italiano - disorientato e confuso,o impaziente e naif- un dialogo di tipo nuovo e paritario, nel segno di unaricerca condivisa che vuole essere soprattutto 'popolare in senso alto, e che
167
Marzia Pieri
punta infatti sul decentramento distributivo come su di una caratteristicaessenziale. I1loro obiettivo programmatico equello di garantire dappertutto la stessa qualita del prodotto, con scenografie funzionali adattabili a spazi diversi, e con una cura artigianale di tutti i linguaggi della messinscena;gli spettacoli, frutto di un approfondito scavo collettivo e di lunghe prove,entrano nel repertorio in maniera stabile.COS! illavoro laboratoriale, all' insegna di uno sperimentalismo drammaturgico molto avanzato rna non fine a se stesso (alIa fine si deve comunque andare in scena e 'mostrare un risultato), si coniuga esemplarmente, inquesti due spettacoli-manifesto, con la ricerca di una fruibilita pili ampiapossibile attraverso un linguaggio rappresentativo attento alla parola rnaanche alIa visivita e al ritmo. Guicciardini, che del gruppo euna sorta dimentore e dramaturg, primus inter pares, va a cercare la teatralita in direzioni inconsuete, laqdove non ci si aspetterebbe di trovarla, e segnatamentein due diversissimi romanzi, che riscrive per la scena utilizzando una seriedi 'utensili' (la clownerie, l'avanspettacolo, la Commediadell'Arte, il teatroepico, la biomeccanica) che sono altrettanti riferimenti stilistici per animare un' idea di teatro intrisa di forti valori civili.La sua matrice dichiarata, del resto, ein qua1che modo letteraria:
sono stato sempre attratto dalla scrittura. Ma l'idea di immaginare un mondo diparole che invece di vorticare nella propria immaginazione diventasse visibile eoggettivo, mi esempre sembrato un miracolo. Capace cioe di produrre un gradodi coinvolgimento piu intenso, in quanta condivisibile con altre persone, riunitenell'atto di partecipare a una sorta di rito [... JHo scoperto la regia che considerouna forma di scrittura, certamente mediata e forse di secondo grado, rna certamente sorretta da una propria autonomia. Su un piano esistenziale, procedendonellavoro, ho scoperto anche il valore della collaborazione: il teatro nel suo farsieprima di tutto partecipazione attiva, in cui ciascuno contribuisce con il bagagliodell'esperienza e dell'inventiva personale; solo da questa amalgama nasce l'operateatrale e ognuno si sente uomo vivo in mezzo a uomini vivi. Mi attrae anche ilfatto che qualsiasi spettacolo, anche il piu perfetto, non eche una ipotesi di lettura,un progressivo avvicinamento al nucleo del testo, del quale non puo che illuminarea1cuni aspetti [... J A differenza della letteratura il teatro eun modo di conoscereil mondo con forze non solo razionali, rna anche emozionali. E illuogo delle contraddizioni: e dove c'e contraddizione c'e vita, c'e dialogo.
Inqueste dichiarazioni, rilasciate in un' intervista di qua1che anna pili tardi,sono evidenziati quasi tutti gli elementi della sua personale poetica: scrittura e vita, testa e spettacolo, rito e collaborazione comunitaria, conoscenza epassione. La sua lunga ricerca, che si stava allora delineando, sara fondatasull'idea 'alta' e un po' controcorrente di una regia che «oltrepassa il me-
168
Roberto Guicciardini drammaturgo
stiere per accomunarsi ad altre discipline, quali 10 studio critico dei testi,l'analisi delle componenti sociologiche che definiscono il fenomeno del teatro, .I'applicazione e l'estensione della scienza della formazione e della comunicazione allavoro teatrale, [...Jarte spuria, una menzogna che tuttaviaha il compito di trovare la verita del senso poetico del testa e di calibrare nelcontempo il grado di partecipazione della spettatore all'evento» (8 giugno1998, dichiarazioni rese in occasione del conferimento della laurea, honoris causa, presso l'Universita di Palermo).Ci si puo chiedereper quali canali e in cerca di che cosa Guicciardini si siarivolto proprio al Perela di Palazzeschi, su cui peraltro avrebbe continuatoa riflettere negli anni a venire come su un testa capitale di riferimento, e dicui avrebbe realizzato, nel 1971, anche una riduzione radiofonica, che glivalse il Premio Italia della RAI. La qualita riconosciuta di questa ulterioreriscrittura, con musiche di Sergio Liberovici, conferma il forte valore dellasua drammaturgia anche a prescindere dal contributo visivo dell'apparatodi Lorenzo Ghiglia, che fu essenziale coautore della rappresentazione. Forse gioco in questa scelta anche il ricordo della riduzione radiofonica dellastesso romanzo gia tentata da Pandolfi, rna soprattutto evero che, in quelmomento, occuparsi di Palazzeschi voleva dire collegarsi alla discussionein corso sulla neoavanguardia - iniziata nel fatidico '63 e presto brutalmente e inesorabilmente testata a confronto con le cronache sessantottine - chesi stava appunto incrociando con un revival futurista a trecentosessanta gradi, teatro compreso.Nel 1968 esce da Mondadori, a cura di Luciano De Maria, una ponderosa raccolta di .scritti di Marinetti (Teoria e invenzione futurista); nel 1969Sanguineti pubblica da Einaudi un'antologia in due volumi della Poesiaitaliana del Novecento, che ripropone settant'anni di poesia italiana in unaprospettiva storiografica completamente nuova, dove Palazzeschi trova ampia spazio in una decisiva rna anomala sezione «fra liberty e crepuscolarismo»; l'anno dopo Mario Verdone fa uscire per i tipi di Officina il suoTeatro italiano d'avanguardia. Drammi e sintesi futuriste , che raccogliemanifesti, testi, bozzetti della "rivoluzione teatrale" di inizio secolo. L'inquieta stagione di riflessioni critiche sulle avanguardie vecchie e nuove si .incrocia COS! con la crisi di crescenza all'interno del teatro italiano, che stacercando nuovi spazi, nuovi pubblici, nuovi linguaggi, ed e facile capireoggi - a distanza di sicurezza e ora che il futurismo con le sue eventuali attualizzazioni eritornato nel cassetto - quanta di quel dibattito si collegasseingenuamente e un po' precipitosamente alla realta circostante.C'era poi la questione del rapporto fra Palazzeschi e il teatro, e delle sueeventuali e personali reazioni all'operazione. Le vocazioni teatrali, si sa,
169
Marzia Pieri
sono misteriose e dissimulate, ed efacile cogliere oggi un curiosa, profondo legame di complementarieta fra 10 scrittore ottuagenario e il giovaneregista: l'intima teatralita del «pili illetterato degli scrittori italiani spessoletteratissimi e inconcludenti» (Baldacci) e tutta travasata nei funambolismi incendiari della pagina, rna egli riconosce nel teatro un proprio decisivo punta di partenza. A suo tempo Palazzeschi non era riuscito, evero,a diventare attore dopo aver frequentato la scuola di Luigi Rasi e dopo unfugace esordio con Virgilio Talli, rna al teatro non aveva mai cessato di riferirsi, sia indossando la maschera ambigua del «buffo» che coltivando linguaggi attenti alle sonorita, ai colori, in una sapiente naivete mista di risoe di malinconia. Consumata con abile marginalita l'avventura futurista, dagran funambolo 10 scrittore era quindi rifluito nei romanzi naturalisti deglianni '30, COS! rassicuranti per il pubblico borghese, salvo poi, da vecchio,scompigliare nuovamente le carte, dissolvendo la maschera amabile delnarratore toscano per tornare allo sberleffo anarcoide e libertario di Stefanino (un erede di Perela venuto alla luce proprio nel 1969): storia di unmostro scandaloso e umanissimo che riproponeva antichi sghignazzi e unadiversita misteriosa e irredimibile da parte del Potere. L'autore e l'opera,in quel momento, erano dunque pili che mai accattivanti e promettevanoun incontro molto teatrale. Paolo Poli nel suo Aldino mi cali un filino harecentemente ricostruito il cammeo di questa avanguardista inafferrabilefra odori di minestre, the gozzaniani, pianerottoli di periferia e perfidefantasmagorie; Chiti ne eun erede altrettanto ambiguo e fedele con il suoraffinato artigianato strapaesano.II giovane Guicciardini, colto, nutrito di letteratura, innamorato del teatro,e molto fiorentino (l'appartamento della famiglia Giurlani, nel quartierepopolare di Santo Spirito, non era lontano dal palazzo gentilizio della suafamiglia, e si sa che la prossimita spaziale, a Firenze, eanche sociologica),condivide con il poeta incendiario un'analoga humus amabilmente 'provinciale e artigianale, e compie, per COS! dire, un tragitto inverso: dalla Ietteratura al teatro. Nonostante la gran yoga del futurismo, Perela uomo di fumocontinuava a subire la disaffezione distratta del grande pubblico, pagando ilfio della sua forma sperimentale COS! anomala nel nostro panorama culturale e del disagio suscitato dal suo messaggio criptico e inquietante. II romanzo era uscito nel 1911 con il titolo Il codice di Perela. Romanzo futurista,rna se ne erano accorti in pochi; nel 1958 l'autore 10 aveva ripubblicato conmolte varianti in un'edizione sostanzialmente 'normalizzata' per i classiciMondadori, espungendo il riferimento al futurismo e correggendo il titoloin Perela uomo di fumo, con la dichiarazione di accompagnamento: «Perela ela mia favola aerea, il punto pili elevato della mia fantasia». Ancora una
170
Roberto Guicciardini drammaturgo
volta non ci furono reazioni adeguate, a parte un memorabile saggio di Luigi Baldacci su «Belfagor», che Guicciardini indubbiamente deve aver letto,per cui la sua scelta non eaffatto banale emerita particolare attenzione. Esingolare e interessante che egli non si rivolga alIa balbettante e reattivadrammaturgia futurista, rna appunto a un romanzo, che giudica immediatamente e intimamente teatrale per il suo impianto dialogico e nello stessotempo perfettamente congruo con gli interrogativi pili urgenti della ricercache gli stava a cuore. II suo Palazzeschi somiglia al ritratto critico che netraccia uno dei protagonisti della neo-avanguardia, Edoardo Sanguineti: «ilrifiuto della poesia, la lotta contro il sublime nella forma del rovesciamento,l'infantilismo proclamato, la celebrazione degli elementi psicotici, depravati, monomaniaci, il trionfo del grottesco, il palio dei buffi, trascendonoi termini originari del giuoco letterario, del divertimento (del «lasciatemidivertire») e diventano i documenti rappresentativi e inconfutabili di unaparticolare condizione storica dell'anima europea: diventano uno dei simboli pili lucidi, dei simboli pili responsabili della crisi della cultura e dellavita del mondo borghese alIa vigilia della sua prima. tragica congestionespirituale e politica: la prima guerra mondiale» (Tra liberty e crepuscolarismo, Milano, Mursia, 1961, p. 104).Va detto che il grande vecchio affetto inizialmente un certo disinteresse:decline gli inviti a collaborare, rimase chiuso nel suo appartamento romanosenza televisore, e si fece vedere a teatro soltanto la seconda sera, commentando secco secco che quei giovani erano pili pessimisti di lui che si avviavaai novanta, e tuttavia benedisse sornionamente da lontano illoro lavoro:
non sono stato io a ritoccare il libra. Anzi, in un primo tempo, mi sono oppostoa1 giovane Guicciardini che mi aveva chiesto il permesso di farlo. Eppoi il teatropretende qualcosa di diverso dalla pagina raccontata. II romanzo e il raccontodevono pagare un certo scotto alla scena per acquistare gli elementi di teatralitarichiesti da1 regista e dal pubblico. Evera che il Codice di Perela estato completamente trasformato, rna l'unica obiezione 1ecita e se fosse preferibile apportarecambiamenti diversi da quelli che Guicciardini ha saputo e ha vo1uto vedere. Unacosa ecerta: l'opera non poteva asso1utamente restare come io l'avevo strutturata.Per quanta riguarda poi la versione , chiamiamo1a COS! "guicciardiniana", per que1che ne posso capire io, che pur non essendo uno scrittore di teatro, tuttavia sonoun appassionato e in gioventu ho fatto anche l'attore nella compagnia di Baseggio,ebbene mi epiaciuta molto, a1 punto che mi sento di condividerla pienamente (C.Angelini, Incontro con Palazzeschi. Del mondo di oggi mi place la smania, «LaFiera Letteraria», n. 2, aprile 1971,p. 6)
Dopo la sua morte, Raul Radice rese pubblica una lettera che 10 scrittore gliaveva inviato nel gennaio 1955 a proposito della riduzione teatrale del suo
171
Marzia Pieri
romanzo Roma (unico precedente significativo in questa senso), dove i tonisi fanno ancora pili espliciti:
Giustissimo, a uno scrittore non poteva sfuggire la mia origine, [000] io sono natodal teatro, e potrei dire che il teatro e stato la mia vera e sola scuola, e del suoinsegnamento molte cose mi sono rimaste pure avendolo abbandonato per la carriera affine dello scrittore, e tante volte mi sono detto: 'sono un uomo di teatromancato'. [000] II teatro e, sicuramente, una delle espressioni pili alte e pili completedello spirito e dell'ingegno, e Ie strepitose e stupefacenti invenzioni venute dopomi appaiono degli esperimenti per arrivare ad esso,E ad esso si dovra sicuramente tornare non appena l'uomo sentira la elevata necessita e bellezza del pensiero,L'alimento visivo non bastera pili a una generazione meno turbata e distratta della nostra, meno disgraziatamente sconvolta, meno bisognosa di facile evasione, 0 0
(Palazzeschi e it teatro, «Corriere della Sera» 24 agosto 1974)
Guicciardini, dunque, aveva captato, con lucida sensibilita, un elemento costitutivo della scrittura palazzeschiana che va molto oltre il dato estrinseco,unanimente rilevato dai recensori, di una presunta natura 'teatrale dei suoidialoghi, gia quasi pronti per essere portati in palcoscenico. 11 suo lavorosul testa nasce da una reciproca, intima congenialita; 10 spettacolo vi si sovrappone come un lucido su un'immagine di riferimento, ed equesta, forse,la ragione segreta di un risultato tanto felice. Questa genesi romanzescadel testo, peraltro, non convince tutti: pili d'uno non la capisce, la giudicail sintomo e la riprova delle eterne carenze della drammaturga nazionale,censura le riscritture e i passaggi di genere in quanta tali come abnormi econfusive (M. Guerri, Una trasposizione poco felice, «Secolo d'Italia», 16gennaio 1971); si parla di isterismo e di happening, si arriva a dichiarare chequesta non eteatro (Mosca, Fumo negli occhi, «Corriere d' informazione»,17 marzo 1971). E tuttaviala reazione prevalente edi entusiasmo e persinodi sollievo di fronte ad una riscoperta che sembra illuminare e spiegare tanta parte della realta italiana: La fantasia al potere e if grido di Palazzeschi(<<Messaggero», 15gennaio 1971), Illieto malumore dell' uomo libero (<<IIgiorno» 18 marzo 1971),Lafavola raffinata dell' uomo di fumo (<<L'Unita»18 marzo 1971), Un grido di giovinezza (<<Gente» 3 aprile 1971), Lluomodi fumo amara presenza (sl.a Stampa» 17 febbraio 1972), Lluomo di fumocontro i potenti (<<Gazzetta del Popolo» 17 febbraio 1972), Con Perela difumo solidissima metafora (<<II Piccolo» 7 marzo 1972), La ricognizioned'una societa in piena crisi (eAvvenire» 18 marzo 1972).11 copione dello spettacolo escrupolosamente fedele all'originale, ed esuddiviso in un prologo e due tempi, rispettivamente di due e sei quadri: nelprimo tempo la nascita dell'omino di fumo dall'utero nero del camino e i1
172
Roberto Guicciardini drammaturgo
suo svagato ingresso nel mondo con la trionfale apoteosi cortigiana; nel secondo il succedersi delle sue 'esplorazioni', quindi la parabola discendente,il processo, la condanna e la scomparsa. II prologo assembla materiali dell'Antidolore e di Lazzi, Fischi e Schizzi come essenziale chiave di lettura e,insieme, ad una citazione esplicita sulla «guerra sola igiene del mondo» diMarinetti nella seconda scena del primo quadro, segnala con forza l'interpretazione per COS! dire 'ideologica' dello spettacolo, favola premonitrice eesemplare di come il Potere strumentalizzi e distrugga la diversita,La scena eun luogo non identificato, rna comunque teatrale, con alti pannelli bianchi sormontati da un graticciato al quale sono appesi surreali oggetti e fantocci; gli attori in calzamaglia grigia, con le facce impiastricciatedi biacca (personaggi di fumo in un'mondo di fume tutto fra il grigio e ilnero), provvisti di maschere, suppellettili e costumi di fogge stravaganti,si avvicendano nell'interpretazione dei molti personaggi e, in particolare,impersonano a turno la parte del protagonista, incarnandone COS! metaforicamente l'inafferrabile identita. La trovata entusiasma a1cuni per il suotrasparente allegorismo (per esempio De Monticelli sul «Giorno» del 18marzo 1971), irrita altri come un errore vero e proprio: «Perela viene adiventare il simbolo dell'uomo generico. 10 mi domando: l'uomo genericopuo essere un diverso? Non 10 credo [...] A causa di questa soluzione cheoffre una circolarita indebita a quello che dovrebbe essere un perno, unperno esile perche di fume e comunque un perno, 10 spettacolo si spaccairrimediabilmente in due parti» (I. Moscati, Perela eun diverso ma Guicciardini non 10 sa, in «Settegiorni», n. 190, 31 gennaio 1970).IIloro marionettistico avvicendarsi scenico ricorda le figurine di un mazzodi carte, 0 i clown; un metronome scandisce i tempi di un vivere meccanicoe alienato; i giochi della luce e il contrappunto musicale, spesso epicamentestraniato, danno il ritmo. Ne risulta un' impressione di stralunata surrealta,bizzarramente umoristica e a tratti acre e crudele, riconosciuta come digrande raffinatezza e intelligenza. L'espressivita gestuale e la straordinariaomogeneita e coereriza della recitazione guadagnano quasi universalmenteagli attori un consenso senza ombre. L'eredita figurativa e dinamica delfuturismo, reimpastata in forma di favola allusiva e paradossale, rivela lasorprendente vitalita di questa romanzo vecchio allora di sessant'anni, rna,proprio l'assoluta nitidezza del prodotto finito induce in a1cuni un sospettodi calligrafismo intellettuale, di freddezza raziocinante. Guicciardini, se neassume l'onere, spiegando COS! il proprio disegno interpretativo:
In fondo si tratta di dare al futurismo di Palazzeschi quella dimensione teatrale che fu anche una delle tipiche dimensioni del futurismo. La versione scenica
173
Marria Pieri
174
ripete dunque strutturalmente la scansione del libro che per sua natura si reggesu un giuoco variatissimo di allegorie e metafore che illettore stesso echiamatoa comporre e a collocare in una propria prospettiva fantastica. Rispetto ad unmateriale COS! cangiante, il problema oltre a quello di identificarne il nucleo e lapin profonda tensione morale che 10 sottende, equello di conservare ai materialiscenici l'identica felicita espressiva, quel margine di fruibilita a diversi livelli, queltanto di ambiguita che non neghi l'evidenza, e quella chiarezza che non divengaschematica, pur nella costrizione delle tecniche e dello stile adottato. Sulla spintadelle innumerevoli sollecitazioni fantastiche si ecercato di procedere in un climadi estrema liberta, in cui l'indagine satirica 0 la disponibilita allegorica del codiceconservasse oltre il giuoco scenico la propria forza eversiva e consentisse insiemeun giudizio non solo sul clima culturale da cui esorto, rna anche sulle motivazioniche resero indistruttibili e pertinaci alcune istituzioni, moralismi, regole di vita,ancora oggi tenacemente arroccate all'interno della nostra organizzazione sociale.II "lasciatemi divertire" di Palazzeschi, che guida anche la vicenda di Perela, l'uomo di fumo catapultato in una realta corposa e pesante, ein effetti testimonianzadi una situazione storica piu ampia, in cui la cultura europea si stava dibattendoper ovviare ad uno stato di crisi, e che vanamente (e colpevolmente) la societa borghese tentava di nascondere. Termini fino ad allora considerati intangibili,Patria, Religione, Famiglia, perche "sublimi", cominciavano a subire una lentacorrosione. E non bastava certo a quella societa rifarsi alla immutabilita dei valoritradizionali e chiudere viceversa gli occhi alle realta piu pregnanti e drammatiche, per supplire alla sostanziale carenza di valori civili morali. E cosa ePerelase non desiderio di disponibilita assoluta in un mondo che di liberta ne concedeben poche? Quello che tutti vorrebbero essere, per compensare la costrizione delvivere con una risoluzione fantastica ed emotiva, in un mondo che piano piano stascivolando nell'atteggiamento triste dell'accettazione prona, 0 si ancora ad unafatua e melodrammatica visione della vita.Visto che si eperduto anche quell'atteggiamento irriverente e cinico che pure eratipico della nostra cultura (Machiavelli e Aretino per esempio), la collocazione diPalazzeschi funziona da sberleffo risolutore. Perela vive nel mondo rarefatto dellametafora, eun personaggio essenzialmente poetico, rna questa non gli impediscedi far parte anche della categoria delle vittime predestinate. Sta con uno stivale inun mondo astorico (la sua contestazione vagamente anarchica einfatti di originemetafisica) , rna rivela anche un malumore effettivo, 0 una nostalgia terrena, 0 denuncia un disagio concreto a contatto con la comunita, che gli detta sogghigni peril moralismo altrui, 0 una profonda tristezza per la mediocrita e miseria di tutti.Anche in questo caso, fra le varie ipotesi sul personaggio Perela, ne abbiamo accentuata una. Perela potrebbe essere un marchingegno costruito nelle Alte Sfere aifini del mantenimento del potere. Gli si affida la stesura del Codice, che dovrebbedare un libero e nuovo assetto al Consorzio Umano. Ma i potenti sanno bene che lavirtu precipua di una simile operazione consiste proprio nel rimandarne la stesura,dopo avere per un poco rinnovato la speranza. Non appena Perela diventa pericoloso, perche pure nella sua inconsistenza possiede il germe capace di infettare(l'insofferenza alla ipocrisia e alla mediocrita, il bisogno di salvaguardare ad ognicosta la propria qualita e identita) verra eliminato, con la stessa cinica disinvolturacon la quale era stato idealizzato.Detto COS! anche questa pare una tendenziosita alquanto schematica, come una
Roberto ·Guicciardini drammaturgo
lente applicata sopra. Ma nellinguaggio scenico tale ipotesi era semplicemente unsegnale da decifrare da parte dello spettatore.
L' inserto prologhistico, che suscita discordi consensi, consegna dunque ilsenso fondamentale della sua riscrittura, giudicata da alcuni troppo circoscritta, parzialmente estranea alIa aerea surrealta dell' originale, non abbastanza incendiaria e troppo malinconica. II Perela di Guicciardini stadel resto in un contesto molto riconoscibile, attraversa i topoi borghesi diun'Italia destinata al fascismo e approdata a quell'ambiguo presente. Qualcuno e estasiato e elettrizzato da tante corrispondenze, qualcun' altro denuncia una cerebralita perfetta e diligente che non tocca l'anima.Riscrivendo il testa per un saggio dell'Accademia di Arte drammatica del1998, il regista, che di questa romanzo ha fatto una sorta di proprio livre dechevet, avrebbe comunque approfondito la sua interpretazione, ampliando iltesta in otto quadri per complessive 24 scene e riconfermando l'amara eonsapevolezza ehe ne rieava di un bilancio storieo radiealmente negativo. Lafantasia, del resto, non era nel frattempo andata al potere; l' entusiasmanteipotesi di una continuita storiea delle avanguardie, plausibile negli anni '70,appariva ormai definitivamente destituita di fondamento, e il suoPalazzesehi sardonieo profeta dei disastri del Noveeento ne usciva inveee pin ehemai attuale. Per quanta troppo ideologieo 0 troppo tetro, troppo puntualeo troppo sfuggente si potesse giudieare 10 spettaeolo, la sua qualita restavaper tutti molto alta e il eritico dell' «Avanti!» la sintetizzava con effieacia,il16 gennaio 1971, in quattro punti di forza: 1) la difesa e la centralita di untesto, 2) la fedelta a un teatro di parola, ehe non tradisee ne limita il valoredella teatralita, 3) la capacita di mettere insieme "politica" e "poesia", 4) laforza di esprimere un'attualita non banalmente letterale, ma problematica ecritica (Un romanzo per it teatro).Sono i tratti distintivi anche del parallelo adattamento seenieo del romanzodi Voltaire, presentato con sueeesso alIa Biennale di Venezia del 1971:
Il Candido fu realizzato la prima volta nel momenta in cui nacquero le grandi cooperative teatrali che furono, in senso culturale e politico, una novita nel panoramateatrale italiano. E chiaro che il testo gia rifletteva un modo di gestire il teatroche era al di la del primo attore. Erano compagnie basate sull'autogestione, su unlavoro di carattere corale in cui tutti partecipavano anche alla stesura del testo. Inquesta senso euno spettacolo storico perche, insieme ad altre cose che facemmoallora, era un modo diverso di fare teatro. [... ] Ecerto che il senso interno del testaeimmutabile: questa appello alla tolleranza, questa appello al capire. Allora c'erauna sorta di denuncia. Questo tentativo di rinchiudersi nel proprio orto da parte diCandido eil sogno della grande borghesia. Non si puo fare a meno dello Stato e
175
Marzia Pieri
pens are al proprio particolare, Oggi puo essere una provocazione pili grossa perche ormai moiti di noi hanno abdicato alla propria funzione: tentare di cambiareIe cose. C'e oggi una forma di maggiore acquiescenza, si sopporta un po' di tutto,Invece, come dice Ludwig Wittgenstein, «la filosofia a questa deve servire, adaiutare Ia mosca a uscire dalla bottiglia».
COS!, in un'intervista rilasciata 1'11 gennaio 1997 dalla trincea del TeatroBiondo di Palermo, Guicciardini ricorda la seconda tappa fondamentale diquegli anni di esordio. Dall'ambigua avanguardia locale del futurismo alIagrande avanguardia europea dell' Illuminismo (altrettanto carica di ombre),il punto di partenza adottato si fa ancora pili difficile rischioso. II romanzodi Voltaire, questa volta, non e certo comodamente dialogato, ma al contrario tutto astratto e narrativo: esemplare conte philosophique affollatodi personaggi-silhouettes ambientato in una geografia fantastica, sembra aprima vista teatralmente impraticabile, ma questo non scoraggia Guicciardini. Con grande audacia egli 10 smonta e 10 rimonta intorno all'elementonarratologico e teatrale del viaggio. Come segnala illungo titolo a chiave,Viaggio controverso di Candido e altri negli arcipelaghi della Ragione,10 spettacolo affronta il nodo - ancora una volta di capitale importanza inquell'epoca di entusiasmi rivoluzionari un po' a buon mercato - del malepresente nella vita degli uomini, attraverso il metaforico giro del mondoche il protagonista, seguace dell'ottimismo leibneziano, compie fra millegrottesche peripezie, prima di rinchiudersi, deluso e ravveduto, nel proprioorticello privato. II tema del viaggio come percorso simbolico della Ragione sarebbe tornato in una tappa successiva della medesima ricerca: 10 spettacolo co-prodotto nel 1981 dal Teatro Regionale Toscano e dalla Biennaledi Venezia e scritto da Guicciardini in collaborazione con Fabio Doplicher,dal titolo I Gioielli indiscreti-Viaggio con Diderot sulle vie della ragione edell'Immaginario.Ma torniamo a Candido. Devoto discepolo del filosofo Pangloss (convintoche tutto «vada per il meglio nel migliore dei mondi possibili»), il giovaneprotagonista viene scacciato, a causa di un bacio proibito, dal castello dellaWestfalia in cui vive la sua amata Cunegonda, ed etrascinato in una queteai quattro angoli del globo, dove si imbatte in una serie impressionante didisastri e di violenze (compreso il terremoto di Lisbona) provocati dallaNatura e dagli uomini; viene incarcerato, tormentato, perseguitato in tuttii modi, mentre la donna amata, che egli continua a inseguire e veneraremalgrado tutto, subisce a sua volta un degrado devastante.Fra Perela e Candido, due testimoni del passato scelti da Guicciardini peraiutarsi a decifrare il presente, si conferma COS! la coerenza di una ricerca appassionata intorno agli snodi critici della cultura moderna, puntando
176
Roberto Guicciardini drammaturgo
strumentalmente l'attenzione su due momenti della storia (il primo Novecento delle avanguardie e l'incubazione della Rivoluzione Francese) in cuienecessario (come in quel 1971?) smascherare con coraggio delle illusionicollettive circa la praticabilita del reale, coltivate in pigrizia e malafedee potenzialmente devastanti. Al crepuscolarismo trasognato di Perela sicontrappone una sorta di fantasmagoria indiavolata, cifra stilistica di un'etadei lumi crudelmente vitalistica e illusoria che e10 sfondo ideale della storia di Candido; se Palazzeschi aveva suggerito toni ambiguamente allusivi,Voltaire lancia invece una sfida di corposa e sanguigna energia polemica estimola un progetto davvero ambizioso, che ancora una volta intreccia vita,storia e teatro:
L'itinerario che Voltaire ha disegnato per il suo eroe e una mappa puntigliosadei fondamentali tabu con i quali la tradizione, puntellata da una politica che faaggio sull'assolutismo, imbriglia l'uomo europeo del '700. Precisi affondi polemici, accaniti quanta implacabili, si condensano all'interno di ogni tappa di questoviaggio in cui ambienti e situazioni si succedono veloci, abilmente individuatinei loro contorni grotteschi con pochi tratti lievitati dall'ironia. In questa senso,gia come struttura, Candido euna perfetta provocazione teatrale. Una occasionepalpabile per leggere poeticamente in azione alcune pagine fondamentali nellasviluppo della coscienza dell'uomo. Egli e capace di ricondurre tutto cia che epensiero puro ad una realta vivente, immediata. La navigazione di Candido [... ] eil suo estremo appro do si svolgeva in uno spazio di distacco critico, surrogato damateriali eterogenei ma coevi, in cui entravano in giuoco con evidenza domandeinquietanti sul nostro stesso tempo. II '700 non fu soltanto come tutti sappiamo ilsecolo della clarte, ma un grande palcoscenico in cui venivano spesso alIa ribaltaanche i grandi visionari, dalla coscienza separata fra sentimento e ragione. Perchenon cercarvi i nodi irrisolti di tante nevrosi moderne, oggi facilmente conglobabilinel pili vasto problema etichettato come "eclissi della ragione"? Nel Candido infatti si rivela in controluce un modello di uomo che eanche dentro di noi, ma chenon ci puo piacere. La metodica spoliazione del nostro eroe da tutti i travestimentifilosofici di un fideismo ottimistico, che epoi rifiuto a pensare, e una crociera affascinante verso l'uomo che impara a contare sulle proprie forze e sui propri limiti,Ma nell'individualismo in cui egoisticamente si rifugia, 1'0ltO che si accinge acoltivare, sentiamo cadere le sementi di un vuoto, pili subdolo ottimismo: quello diuna societa che, soffocando Ieintuizioni da cui ha trovato impulso, elabora di fattouna concezione della vita che ha il suo fondamento reale nell'interesse privato. PerVoltaire, che si eCOS! accanitamente battuto tutta la vita per il primato della ragione, la rassegnazione finale del suo eroe puo essere un malinconico ripiegamentodell'ironia su se stessa. Ma per gli eredi del 1789? Non potrebbe essere diventatauna segreta forma di compiacimento verso la propria impotenza? Anche nel casodel Candido la legittimita della riduzione econfermata dal suo grado di tendenziosita, come intervento autonomo nella spazio di un confronto.
177
Marzia Pieri
La densita di queste note ein parte scoraggiante, rna 10 spettacolo che nederive fu un sogno colorato e ironico di leggerezza. Giuicciardini coglie,da un suggerimento di Italo Calvino, proprio nel ritmo e nella leggerezza lanota di fondo dell'opera voltairiana, in cui «personaggi filiformi, animati dauna guizzante mobilita si allungano, si contorcono in una sarabanda di leggerezza graffiante. [...JNel Candido oggi non eil racconto filosofico, non ela satira, non eil prendere forma d'una morale e di una visione del mondo:eil ritmo. Con velocita e leggerezza, un susseguirsi di disgrazie, supplizi emassacri corre sulla pagina, rimbalza di capitola in capitola, si ramifica emoltiplica senza provocare nell'emotivita dellettore altro effetto che quellodi una vitalita esilarante e primordiale».In questa caso l'elemento decisivo, il segno continuo di riferimento in gradodi unificare la materia debordante e felicemente accumulatoria fu costituitodalla scenografia. Lorenzo Ghiglia costrui un dispositivo di scena fissa aquinte di grande effetto: una sorta di scatola magica, di bomboniera di trine(dietro cui si intravedono a tratti, in trasparenza, gli ingranaggi mostruosidella Ragione, motore e filo conduttore dell'intera vicenda) entro cui va eviene una vera e propria folla di personaggi. Dodici attori ne impersonanoinfatti pili di cento, in un frenetico avvicendarsi trasformistico, alla Fregoli,di travestimenti sontuosi e coloratissimi. La scena iniziale e quella finale, diuna spettrale e livida immobilita, racchiudono la rappresentazione nella suafissita di ragionamento filosofico e l'intero spettacolo, diviso in due tempi ein 22 scene, alterna i momenti narrativi delle varie tappe del viaggio, con lecatastrofi che continuamente investono i protagonisti, a pause di commentocorale nel salotto dei quattro filosofi (rosso, bianco, giallo e marrone) e deiloro interlocutori, che snocciolano le proprie ideologie come puri artificilogici, recitando brani di opere di Voltaire, Rousseu, Diderot e altri, a cuialludono le tavole dell'Enciclopedia proiettate sullo sfondo. L' apologo diVoltaire, COS! affollato e iperbolico, esceneggiato in forme che mescolanoil cabaret e gli autos spagnoli (qualcuno fa riferimento a Calderon) con unaserie di gags e di trovate teatrali strepitose: la ruota dei lumi, la tempestadi nastri neri per il maremoto di Lisbona, la pioggia di coriandoli doratinell'Eldorado, la scena della lavanderia, la visione magica di una carnevaleveneziano; la recitazione etutta giocata sui toni del sarcasmo e della parodia, in chiave antirealistica di fantasia delirante.Le reazioni dei pili sono di sbalordito e grato entusiasmo e, ancora unavolta, il dibattito interpretativo si accanisce a cercare spiegazioni, segnodella riuscita e della forza dello spettacolo: le disavventure dell'intellettualealle prese con le contraddizioni della prassi risultano graffianti e attuali,rna e l'ambiguo finale a sollevare le maggiori discussioni: approdato infine
178
./
Roberto Guicciardini drammaturgo
in Turchia, dove ritrova l'amata Cunegonda ingrassata e passata per moltiletti, Candido se la sposa comunque e si ritira canonicamente in campagnaa coltivare il proprio privato, rna l'ultima battuta, molierianamente, tocca alservo Caeambo, mentre zappa di malumore un orto non suo, prefigurandoun'altra rivoluzione sociale che avrebbe rimesso in discussione i fasti deiLumi e i trionfi ambigui della borghesia di ieri e di oggi. E significativocome questa finale scateni critiche da destra e da sinistra: sul «Borghese», n. 43 del 24 ottobre 1971 Luciano Cirri legge in filigrana nello spcttacolo l'assunto che «gli enciclopedisti e gli illuministi, i festosi narratorie pensatori del vuoto hanno cambiato abito, parrucca, gergo e liturgia. Masono rimasti, immutabili e immortali, fra noi, sempre intenti ad avvelenare i pozzi della gente che vuole vivere, e dei candidi che hanno bisognodi folli illusioni» (Candido jra noi, p. 505), mentre Nicola Chiaromonte,sull'«Espresso» della stesso 24 ottobre, 10 giudica «un errore», un confusoprodotto di manierismo ideologico che tradisce Voltaire ed equivoca totalmente il senso del romanzo (Strip-tease tra illuministi); non mancanole accuse di ridondanza e di oscurita e Ie diffidenze per tanta ricchezzaformale, rna i pili apprezzano la qualita della ricerca compiuta, l'alto tasso di comunicabilita dello spettacolo e la sua raffinata piacevolezza. Forsesta proprio nell' ossimoro fra un'assunzione di responsabilita critica tantolucida e «controversa» e un'esibizione di espressivita COS! lussureggiante ilmiracolo di questa spettacolo, che, nella sua amara denuncia delle trappoledelle ideologie, si imparenta forse con quell'altro Candido, ovvero un sognojatto in Sicilia, che Sciascia avrebbe scritto nel1977.Proprio a Palermo, questa volta in un teatro pubblico nel cuore di una citraassediata e insanguinata, Guicciardini avrebbe tenacemente riproposto unCandide nella stagione 1995-96.
179