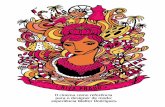rita sCuDeri
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of rita sCuDeri
rita sCuDeri
PAVIA ROMANA (RI)VIVE NELLE SUE EPIGRAFI
Pier Vittorio Aldini, il primo docente di archeologia della nostra Università, nel 1824 osservava come i grandi monumenti sculto-
rei siano anche «gradito spettacolo alla turba de’ curiosi», mentre «le lapidi scritte [...] attirano principalmente a se lo sguardo severo degli archeologi»1. Purtroppo la sua notazione è valida anche al giorno d’og-gi, ma, una volta che si sia fatta un po’ di esperienza sulle pietre iscrit-te, ci si rende subito conto dell’ampia e variegata messe d’informazioni fornite dalle epigrafi2. Inoltre la mentalità pratica dei Romani portava
1 Conferenza tenuta il 29 novembre 2012 nel Salone teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia, in occasione della presentazione del volume 2012 del “Bol-lettino della Società Pavese di Storia Patria”.
1 Aldini dal 1819 insegnò all’Università di Pavia archeologia, numismatica, di-plomatica e araldica e ne fondò il Museo archeologico: augusto Campana, Aldini, Pier Vittorio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 2, Roma, Istituto della Enciclo-pedia Italiana, 1960, p. 92; Cesare saletti, Pietro Vittorio Aldini e la formazione del Museo dell’Istituto di Archeologia, in “Bollettino della Società Pavese di Storia Patria” [“BSPSP”], LXXXI (1981), pp. 305-311; guiDo De Caro, Pietro Vittorio Aldini: tra dilettantismo e professionalizzazione, tra collezionismo pubblico e privato, in “BSPSP”, CXII (2012), pp. 103-117.
2 Cfr. Epigraphic Evidence. Ancient History from Inscriptions, edited by John Bodel, London-New York, Routledge, 2001; rita sCuDeri, Epigrafia fonte della storia, in Un’officina della memoria. Percorsi di formazione storica a Pavia tra scuola e università. Omaggio a Giulio Guderzo, a cura di Antonio Brusa, Alessandra Ferraresi, Pierangelo Lombardi, Milano, Unicopli, 2008 (Annali di storia pavese. Nuova Se-rie. Fonti e ricerche storiche, 2), pp. 253-276.
RITA SCUDERI420
a produrre iscrizioni che chiaramente si rivolgevano al pubblico, evi-denziando a colpo d’occhio gli elementi principali del testo con grandi lettere e con un’impaginazione delle righe ben centrata3. L’intento dei nostri antenati era lasciare un messaggio a massima divulgazione, con un confine cronologico esteso fino alla capacità dei lettori di recepire i contenuti espressi4. Quindi anche con noi volevano comunicare.
Vediamo ora qualche esempio epigrafico significativo della vita civica dei nostri concittadini di un paio di millenni fa. Dopo le gene-rali premesse sulla casualità dei ritrovamenti e sulla percentuale molto bassa delle iscrizioni pervenuteci rispetto a quelle prodotte, conside-riamo che dal territorio pavese l’esiguo numero di reperti epigrafici è anche condizionato dalle varie distruzioni subite da Pavia nei secoli e dalla collocazione della città in pianura, lontano da cave di pietra5.
3 Le iscrizioni greche non richiamavano altrettanto l’attenzione del lettore, con fitte righe di piccoli e uniformi caratteri, di cui lo stile stoichedon, caratterizzato dall’al-lineamento orizzontale e verticale delle lettere, è un esempio perfetto di monotona eleganza formale: reginalD p. austin, The Stoichedon Style in Greek Inscriptions, London, Oxford University Press, 1938; miCael j. osBorne, The Stoichedon Style in Theory and Practice, in “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik”, X (1973), pp. 249-270. Le epigrafi romane invece richiamavano il lettore, manifestando la volontà di comunicare il messaggio in modo chiaro e permanente: per gli antichi costituivano un’evidenza presente nell’orizzonte visivo urbano. Cfr. mireille CorBier, L’écriture dans l’espace public romain, in L’urbs. Espace urbain et histoire (I siècle av. J.c. - III siècle ap. J.c.). Actes du colloque international organisé par le centre national de la recherche scientifique et l’école française de Rome (Rome, 8-12 mai 1985), Roma, école française de Rome, 1987, pp. 27-60; gianCarlo susini, Le scritture esposte, in Lo spazio lettera-rio di Roma antica. II: La circolazione del testo, Roma, Salerno Editore, 1989, pp. 271-305; antonio sartori, L’impaginazione delle iscrizioni, in Acta colloquii epigraphici Latini Helsingiae 3-6 sept. 1991 habiti, Helsinki, Societas Scientiarum Fennica, 1995 (Commentationes Humanarum Litterarum, CIV), pp. 183-200; greg woolF, Mo-numental Writing and the Expansion of Roman Society in the Early Empire, in “Journal Roman Studies”, LXXXVI (1996), pp. 22-39; marCos mayer, El paisaje epigráfico como elemento diferenciador entre las ciudades. Modelos y realizaciones locales, in ciudades privilegiadas en el Occidente romano, ed. Julian González, Sevilla, Secretariado de Publi-caciones Universidad de Sevilla, 1999, pp. 13-32; antonio sartori, Presenza e fun-zione delle epigrafi esposte nelle città romane, in ciudades privilegiadas, cit., pp. 117-126.
4 Cfr. antonio sartori, L’epigrafia del villaggio, il villaggio dell’epigrafia, in L’epigrafia del villaggio, a cura di Alda Calbi, Angela Donati, Gabriella Poma, Faen-za, F.lli Lega, 1993, pp. 26-27.
5 Non si raggiungono le due centinaia: DelFino amBaglio - laura BoFFo, Regio xI Transpadana: Ticinum - Laumellum et vicinia, in Supplementa Italica, n.s., 9
PAVIA ROMANA (RI)VIVE NELLE SUE EPIGRAFI 421
Peraltro ricaviamo documenti importanti pure da epigrafi che non sono conservate materialmente, ma sono tramandate da fonti lettera-rie. Così per l’impianto urbano di Ticinum, approfonditamente studiato nella sua planimetria da Pierluigi Tozzi6, i resti archeologici, a parte le fognature7, sono quanto mai scarsi. Il perimetro della cinta muraria rimane ricostruibile solo ipoteticamente8, ma per le porte urbiche l’epi-grafia fornisce dati interessanti. Quando il monaco pellegrino, l’anoni-mo autore del codice di Einsiedeln9, passò da Pavia fra VIII e IX sec.,
[Suppl. Ital. 9], Roma, Quasar, 1992, pp. 213-347; rita sCuDeri, Ticinum - Lau-mellum et vicinia, in Supplementa Italica, n.s., 22, Roma, Quasar, 2004, pp. 255-264.
6 pierluigi tozzi, L’impianto urbano di Ticinum romana, in Storia di Pavia. I: L’età antica, Milano, Banca del Monte di Pavia, 1984, pp. 183-203; iDem, Pavia antica città, Var-zi, Guardamagna, 1997, pp. 11-25; iDem, Pavia. Origini e tradizioni, Varzi, Guardamagna, 2003, pp. 5-12; iDem, Pavia. I fili della memoria, Pavia, Tipografia PI-ME Editrice, 2007, pp. 6-7, 26-39; iDem, Pavia. Ventuno secoli dalla fondazione. 89 a.c.-2011 d.c., Pavia, Rota-ry Club Pavia Ticinum, 2011, pp. 9-19. Cfr. anche gianFranCo tiBiletti, La struttura topografica antica di Pavia, in Atti convegno di Studio sul centro Storico di Pavia, 4-5 luglio 1964, Pavia, Fusi, 1968, pp. 3-20; iDem, Storie locali dell’Italia romana, Pavia, Università di Pavia, Istituto di Storia Antica, 1978, pp. 203-222; Cesare saletti, L’urbanistica di Pavia romana, in “Athenaeum”, n.s., LXI (1983), pp. 126-147. Sul fatto che il piano di urbanizza-zione fu concepito a partire dalla concessione dello ius Latii nell’89 a.C., ma compiuto in età protoimperiale cfr. di recente: valentina Dezza - giorgia Brameri, Pavia: lo scavo di via Omodeo e il reticolo viario di Ticinum, in Forme e tempi dell’urbanizzazione nella cisalpina (II secolo a.c. - I secolo d.c.). Atti delle Giornate di Studio (Torino, 4-6 maggio 2006), a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli, Borgo S. Lorenzo, All’Insegna del Giglio, 2007, pp. 318-319.
7 Cfr. Carlamaria tomaselli, Il sistema di fognature romane di Pavia, Pavia, Collegio Costruttori Edili della Provincia di Pavia, 1978.
8 Flavio Fagnani, Il tracciato delle mura romane di Ticinum, in “BSPSP”, LIX (1959), pp. 3-42, ricostruisce il perimetro con riscontri nell’impianto urbano e riferi-mento a documenti medioevali, ma la carenza dei dati archeologici impone cautela. Cfr. anche Faustino gianani, Le mura e le porte di Pavia antica, Pavia, Edizioni Antares, 20052. Per un generale ripensamento critico: peter j. huDson, Le mura romane di Pavia, in Mura delle città romane in Lombardia. Atti del convegno, Como, Associazione Archeologica Comense, 1993, pp. 107-118; laurent ChrzanovsKi, L’urbanisme des villes romaines de Transpadanie (Lombardia, Piémont, Vallée d’Aoste), Montagnac, éditions Monique Mergoil, 2006, pp. 299-303.
9 Il codice 326, conservato nell’abbazia svizzera di Einsiedeln, contiene una miscellanea di testi, tra i quali è interessante l’Itinerario, che comprende una silloge di epigrafi, quasi tutte di Roma, ma anche di Pavia. Cfr. Pellegrinaggi a Roma. Il co-dice di Einsiedeln, L’itinerario di Sigerico, L’itinerario Malmesburiense, Le meraviglie di Roma, Racconto delle meraviglie della città di Roma, a cura di Massimo Miglio, Roma, Città Nuova, 1999, pp. 29-45 per l’itinerario romano.
RITA SCUDERI422
vide ancora nella sua monumentalità la porta orientale, costituita da un arco a tre fornici: l’autore della silloge Einsiedelnensis copiò le iscrizioni che stavano sotto le dieci statue (ormai perdute) della famiglia imperiale augustea, trascrivendo di seguito le righe di ciascun arco (figura 1). Il guazzabuglio prodotto dalla mescolanza delle titolature dei personaggi fu poi risolto dall’acume di Mommsen10. Il monumento, databile al 7-8 d.C. in base alla titolatura di Augusto, doveva apparire imponente e sce-nografico a chi arrivava a Ticinum, che esibiva una sentita fedeltà all’im-peratore e alla dinastia, con le figure e le iscrizioni onorarie di Augusto
10 theoDor mommsen, corpus Inscriptionum Latinarum [cIL], V, 2, Berolini, apud Georgium Reimerum, 1877, 6416. Cfr. poi hermann Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae [ILS], I, Berolini, apud Weidmannos, 1892, 107; giovanna mo-rone, La Domus di Augusto nell’iscrizione di Pavia, in “BSPSP”, XXXIV-XXXV (1934-1935), pp. 223-241; BoFFo, Suppl. Ital. 9, pp. 232-233.
1 – Codice di Einsiedeln: iscrizioni sulla porta orientale di Pavia (cIL, V, 6416) e nel foro (cIL, V, 6431).
PAVIA ROMANA (RI)VIVE NELLE SUE EPIGRAFI 423
e Livia al centro del fastigio, accompagnati, a sinistra dell’imperatore, da Tiberio, Germanico (suo nipote, adottato), Druso Minore (figlio di Tiberio) e Nerone (figlio di Germanico), mentre accanto a Livia erano Gaio e Lucio Cesari (nipoti e figli adottivi di Augusto, ormai defun-ti), Druso III (figlio di Germanico) e Claudio (il futuro imperatore)11. Più che un normale segno di lealismo dinastico, ciò ricorda un legame speciale di Ticinum con Augusto e Livia, che vi soggiornavano nel 9 a.C., quando li colse la drammatica notizia del mortale incidente oc-corso a Druso in Germania: suo fratello Tiberio, con un viaggio famoso per la celerità, riuscì a raggiungerlo prima che morisse e poi ne curò il trasporto della salma a Pavia e infine a Roma12. Valorizzando questi avvenimenti, è stato proposto che la porta monumentale fosse dedicata specificamente a Druso Maggiore (che peraltro non compare fra i dieci personaggi)13, ma appare eccessivo pensare che più di un quindicennio dopo la morte di Druso Maggiore si volesse onorare proprio lui anzi-ché l’intera famiglia imperiale. Emilio Gabba ha validamente confutato l’ipotesi discutibile che questo grandioso arco si trovasse a Roma in Por-ta Appia anziché in Porta Papia (com’è scritto sul codice), a causa di un presunto errore di trascrizione dell’Anonimo Einsiedelnensis14: fra l’altro le iscrizioni della famiglia imperiale augustea si trovano appunto tra le epigrafi pavesi, come si legge subito dopo «in foro Papie»15.
11 Cfr. emilio gaBBa, Ticinum: dalle origini alla fine del III sec. d.c., in Storia di Pavia. I, cit., p. 229; Cesare saletti, I cicli statuari giulio-claudi della cisalpina. Presenze, ipotesi, suggestioni, in “Athenaeum”, LXXXI (1993), p. 379. Sull’attacca-mento di Ticinum alla famiglia augustea cfr. anche gianFranCo tiBiletti, città appassionate nell’Italia settentrionale augustea, in “Athenaeum”, fasc. spec. 1976, pp. 63-64; tiBiletti, Storie locali dell’Italia romana, cit., pp. 131-132.
12 val. maX. V 5, 3; taC., Ann. III 5, 1; svet., Tib. 7, 6; Cass. Dio LV 2, 1.13 FranCesCa De Caprariis, Un monumento dinastico tiberiano nel campo
Marzio settentrionale. Appendice II: cIL, V, 6416 e il c.d. arco di Pavia, in “Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma”, XCV (1993), pp. 108-110.
14 Charles Brian rose, New contributions to Roman Topography: The “Arch at Pavia” and the Einsiedeln 326 Manuscript, in “American Journal of Archaeology”, XC (1986), p. 189; Charles Brian rose, The Supposed Augustan Arch at Pavia (Ticinum) and the Einsiedeln 326 Manuscript, in “Journal of Roman Archaeology”, III (1990), pp. 163-168; emilio gaBBa, L’arco augusteo di Pavia, in “Athenaeum”, LXXVIII (1990), pp. 515-517.
15 Cfr. anche géza alFölDy, in cIL, VI, pars VIII, fasc. II, Berolini-Novi Eboraci, G. de Gruyter, 1996, p. 4301.
RITA SCUDERI424
Un frammento di epistilio in marmo di Carrara, conservato nel palazzo centrale dell’Università, porta la dedica a Tiberio di un edi-ficio pubblico16(figura 2), che non è riconoscibile, ma doveva essere notevole, se consideriamo le proporzioni del testo superstite e l’altezza delle lettere di 11 cm.
Probabilmente era un’opera pubblica ciò che il seviro L. Tiburtius Priamus, liberto di Lucio, dedit, come è scritto, con caratteri eleganti (databili al I sec.) su un grosso blocco di trachite dei colli Euganei (figura 3), ora nel Civico Museo Archeologico17. Il sevirato era rive-stito soprattutto da liberti benestanti, che, attraverso questa funzione pubblica per il culto imperiale, venivano gratificati da una posizione di prestigio nella propria civitas18, nonostante l’origine servile preclu-desse le magistrature. E l’atto evergetico19, col diritto di iscrivere il proprio nome sulla costruzione offerta20, rendeva ancor più evidente il riconoscimento sociale.
Personaggio più importante era Sex. Sextilius Fuscus, che pure offrì un edificio a favore della comunità, visto dall’Anonimo di Einsiedeln in foro Papie21: anche in questo caso non sappiamo di quale costruzione si trattasse, ma il verbo dedit iscritto bastava a indicare ciò che tutti vede-vano22. Sestilio Fusco era stato praefectus fabrum, cioè ufficiale del genio,
16 cIL, V, 6417; amBaglio, Suppl. Ital. 9, p. 233.17 amBaglio, Suppl. Ital. 9, 23, p. 274.18 Cfr. roBert Duthoy, Les Augustales, in Aufstieg und Niedergang der Römi-
schen Welt, II, 16.2, herausgegeben von Wolfgang Haase, Berlin-New York, G. de Gruyter, 1978, pp. 1254-1309; anDriK aBramenKo, Die munizipale Mittelschicht im kaiserzeitlichen Italien. Zu einem neuen Verständnis von Sevirat und Augustalität, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1993; Carmen Castillo garCía, Sevirato y au-gustalidad: un estamento intermedio en la vida ciudadana, in Sociedad y economía en el Occidente romano, Carmen Castillo García, Juan Francisco Rodríguez Neila, Fran-cisco Javier Navarro editores, Pamplona, Eunsa, 2003, pp. 73-89.
19 Sulla diffusione delle evergesie nell’Italia settentrionale: Bettina goFFin, Euergetismus in Oberitalien, Bonn, Habelt, 2002.
20 Dig. L 10, 2-3.21 cIL, V, 6431; gaBBa, Ticinum: dalle origini, cit., pp. 234-235; BoFFo, Suppl.
Ital. 9, p. 238; ClauDia maCCaBruni, Il forum di Ticinum, in “Forum et basilica” in Aquileia e nella cisalpina romana. [Atti della XXV Settimana di Studi Aquileiesi, aprile 1994], a cura di Mario Mirabella Roberti, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1995, p. 366; goFFin, Euergetismus, cit., pp. 508-509.
22 Cfr. rita sCuDeri, Iscrizioni su opere pubbliche in Transpadana, in Est enim ille flos Italiae. Vita economica e sociale nella cisalpina romana. Atti delle Giornate di
PAVIA ROMANA (RI)VIVE NELLE SUE EPIGRAFI 425
2 – Dedica a Tiberio di un edificio pubblico (cIL, V, 6417). Pavia, Univer-sità, cortile del Leano.
3 – Epigrafe del seviro L. Tiburtius Priamus (Suppl. Ital. 9, 23). Pavia, Musei Civici.
RITA SCUDERI426
alle dirette dipendenze del comandante, carica che permetteva ai nota-bili locali di entrare nell’ordine equestre23 e che spesso si collegava ad attività edilizie ed evergetiche nelle città24. Egli ricoprì la massima ma-gistratura municipale, essendo quattuorvir iure dicundo25, nonché tutti i principali sacerdozi cittadini, tra i quali più prestigioso è il flaminato di Roma e del divo Claudio26. Fu inoltre pontefice27, augure28, salio29
Studio in onore di Ezio Buchi (Verona 30 novembre - 1 dicembre 2006), a cura di Pa-trizia Basso, Alfredo Buonopane, Alberto Cavarzere, Stefania Pesavento Mattioli, Verona, QuiEdit, 2008, p. 250.
23 Cfr. yann le BoheC, L’armée romaine, Paris, Picard, 1989, p. 44; massi-miliano Cerva, La praefectura fabrum. Un’introduzione, in Les élites municipales de l’Italie péninsulaire de la mort de césar à la mort de Domitien entre continuité et rupture. classes sociales dirigeantes et pouvoir centrale, a cura di Mireille Cébeillac Gervasoni, Rome, école française de Rome, 2000, pp. 177-196.
24 moniKa verzár Bass, Il praefectus fabrum e il problema dell’edilizia pubbli-ca, in Les élites municipales, cit., pp. 197-224.
25 Rispetto alla coppia magistratuale aedilicia potestate (che si occupava della polizia, dei ludi, dell’approvvigionamento e dell’edilizia), quella giurisdicente aveva il privilegio dell’eponimia, presiedeva le assemblee e i comizi e aveva potere giudiziario su controversie non superiori a 15.000 sesterzi. In particolare sulle competenze giuri-sdizionali nell’Italia settentrionale: umBerto laFFi, La lex Rubria de Gallia cisalpina, in “Athenaeum”, LXXIV (1986), pp. 5-44. Quattuorviri aedilicia potestate di Ticinum sono testimoniati in cIL, V, 6428; Suppl. Ital. 9, 3, 20; IIIIvir in cIL, V, 6427.
26 Cfr. maria silvia Bassignano, Flaminato e culto imperiale nelle Regiones xI e Ix, in “Atti Istituto Veneto”, CLXIII (2005), pp. 328-329. Sulle tipologie dei flamines municipali (sempre domi nobiles): aDelina arnalDi, Flamines “nude dic-ti”, flamines civitatis, flamines coloniae nell’Italia romana, in Epigrafia 2006. Atti della xIVe Rencontre sur l’épigraphie in onore di Silvio Panciera, a cura di Maria Letizia Caldelli, Gian Luca Gregori, Silvia Orlandi, II, Roma, Quasar, 2008, pp. 773-802; aDelina arnalDi, Studi sul flaminato del culto imperiale nell’Italia romana. I: Le denominazioni del sacerdozio, in Ouj pa`n ejfhvmeron. Scritti in memoria di Roberto Pre-tagostini, a cura di Cecilia Braidotti, Emanuele Dettori, Eugenio Lanzillotta, Roma, Quasar, 2009, pp. 871-896.
27 Il pontefice era preposto al culto pubblico (sacra municipalia): cfr. enri-Ca leDa rosetta zanon, Pontefici municipali di Patavium, in “Patavium”, XXIV (2004), p. 61.
28 Gli augures municipali erano di norma eletti dai comizi e, come il nostro Sextilius Fuscus, rivestirono in larga maggioranza anche altre cariche sacerdotali e magistratuali: vittorio spinazzola, Gli augures, Forlì, Victrix Religio Romana, 20112, pp. 108-170 (pp. 152-153 per la nostra epigrafe).
29 Nei municipi anche i sacerdozi seguivano il modello di Roma: quindi per un’altra esemplificazione locale di questi sacerdoti di Marte cfr. anna pasQualini,
PAVIA ROMANA (RI)VIVE NELLE SUE EPIGRAFI 427
gratuitus per decreto dei decurioni: l’esenzione dal pagamento della summa honoraria, decisa dal senato locale, era un onore che spettava a chi si era già reso benemerito per precedenti evergesie30.Quest’epigra-fe è un esempio indicativo della prassi di autorappresentazione di una personalità eminente, volta a promuovere il consenso dei concittadi-ni31. Il principale sacerdozio esercitato da Sextilius Fuscus, il flaminato di Roma e del divo Claudio, permette di datare nella seconda metà del I sec. e ribadisce il particolare legame di Ticinum con la famiglia im-periale (ricordiamo Claudio sul fastigio della porta orientale nel 7-8, quando era ancora lontanissimo dalla successione all’impero).
Al culto delle donne della domus imperatoria erano addette le fla-miniche32, che qui a Pavia non potevano mancare: con ogni probabi-lità doveva essere sacerdotessa di Livia Mania Betutia, la cui epigrafe porta la titolatura di flaminica [d]ivae Aug(ustae)33. Il testo è material-mente diviso in due frammenti in marmo di Carrara (figura 4), rin-venuti a Gualdrasco: l’uno era stato portato nei Musei Civici di Pavia e l’altro, ritrovato poi nel 1976, è rimasto murato nella chiesa di S. Ambrogio a Gualdrasco34. Dato che al prestigioso sacerdozio rivesti-
Riflessioni su alcuni sacerdozi tuscolani (a proposito di C.I.L. xIV 2580), in jEpigrafaiv. Mi scellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, a cura di Gianfranco Paci, II, Tivoli, Tipigraf, 2000, pp. 695-710 (specialmente p. 708).
30 Più frequentemente è ricordata l’offerta della summa honoraria in ambito sacerdotale per il più prestigioso flaminato piuttosto che per altri sacerdozi come il pontificato o l’augurato: ClauDe BrianD ponsart, Summa honoraria et ressources des cités d’Afrique, in Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes xe Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain (Rome, 27-29 mai 1996), Rome, école française de Rome - Università di Roma La Sa-pienza, 1999, p. 222.
31 Cfr. antonio sartori, La promozione del consenso: autorappresentazione e modelli epigrafici nelle comunità municipali cisalpine, in Sociedad y economía, cit., pp. 283-308.
32 Il titolo di queste matrone poteva essere flaminica o sacerdos: emily a. he-melrijK, Preistesses of the Imperial cult in the Latin West: Titles and Function, in “An-tiquité Classique”, LXXIV (2005), pp. 137-170.
33 cIL, 6435; amBaglio, in Suppl. Ital. 9, 21, p. 272. Il fatto che Livia fosse stata divinizzata nel 41 e la bella paleografia orientano la datazione alla seconda metà del I sec.
34 Cfr. DelFino amBaglio, cIL, V, 6435, in “Epigraphica”, XLI (1979), pp. 171-175; Cinzia Bearzot, Osservazioni su cIL, V, 6435: per una localizzazione del-la ‘leggenda’ della fuga di S. Ambrogio, in “Aevum”, LVII (1983), pp. 109-122.
RITA SCUDERI428
4 – Iscrizione della flaminica Mania Betutia (Suppl. Ital. 9, 21). Pavia, Musei Civici e Gualdrasco, chiesa di Sant’Ambrogio.
5 – Dedica a T. Didius Priscus (cIL, V, 6419). Pavia, Musei Civici.
PAVIA ROMANA (RI)VIVE NELLE SUE EPIGRAFI 429
to dalla matrona si associavano spesso atti evergetici35, si è dapprima integrata l’iscrizione frammentaria con [f(aciendum) c(uravit)], ipotiz-zando l’offerta di un edificio pubblico; tuttavia la recente osservazio-ne dell’elemento decorativo fitomorfo sul soffitto dell’epistilio iscritto induce ad avanzare anche l’ipotesi di un’edicola funeraria, collegata a una villa suburbana36.
Fra i nostri antichi concittadini di rilievo, quello che compì la carriera più brillante documentata dall’epigrafia ticinense37 è T. Didio Prisco (figura 5), che divenne patrono del suo municipio, essendo da tempo nel senato di Roma, poiché arrivò a rivestire la pretura38. Il pa-tronato municipale, che comportava un decreto d’investitura da parte del consiglio dei decurioni39, era una funzione di prestigio, rivestita da chi era al di sopra dell’élite locale40. Nei Musei Civici è conservata la lastra di marmo di Proconneso, che era stata reimpiegata come mensa d’altare nella chiesa di S. Giovanni in Borgo41: si tratta della fronte di
35 Discussione sui complessi legami tra il flaminato femminile, le evergesie e i pubblici onori: emily a. hemelrijK, Priestesses of the Imperial cult in the Latin West: Benefactions and Public Honour, in “Antiquité Classique”, LXXV (2006), pp. 85-117. Sul rilievo fra i concittadini di queste sacerdotesse, che avevano come mo-dello le donne della famiglia imperiale: emily a. hemelrijK, Local Empresses: Prie-stesses of the Imperial cult in the cities of the Latin West, in “Phoenix”, LXI (2007), pp. 318-349.
36 steFano maggi - Cristina troso, cIL, V, 6435 e i bambini: una piccola Altamira pavese, in In ricordo di Dino Ambaglio. Atti del convegno (Università di Pa-via, 9-10 dicembre 2009), a cura di Rita Scuderi e Cesare Zizza, Pavia, Pavia Univer-sity Press, 2011, pp. 147-157.
37 P. Valerius Patruinus e c. Minucius Fundanus arrivarono a consules suffecti: géza alFölDy, Senatoren aus Norditalien. Regiones Ix, x und xI, in Atti del col-loquio Internazionale AIEGL su Epigrafia e ordine senatorio (Roma, 14-20 maggio 1981), II, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1982, pp. 356-357. Cfr. gaBBa, Ticinum: dalle origini, cit., p. 237.
38 cIL, V, 6419; BoFFo, in Suppl. Ital. 9, pp. 233-234.39 La lex Malacitana (cIL, II, 1964, col. 61) prescriveva per la votazione la
presenza di almeno due terzi dei decurioni: è probabile che la norma valesse anche per le altre città.
40 Sulle differenze fra il rilievo locale dei decuriones e il potere di chi apparteneva al ceto senatorio: Daniëlle slootjes, Local Potentes in the Roman Empire: A New Approach to the concept of Local Elites, in “Latomus”, LXVIII (2009), pp. 416-432.
41 Quando la chiesa fu distrutta nel secondo decennio del XIX sec., il marchese Malaspina aggiunse alla sua collezione epigrafica questa iscrizione, la cui bellezza non era sfuggita ai precedenti studiosi, da Grutero a Muratori, da Zaccaria a Cap-
RITA SCUDERI430
una base di statua, posta dal riconoscente liberto T. Didius Hermias. Possiamo datare fra seconda metà I sec. e inizi II sec. per l’accurata esecuzione delle lettere e l’onomastica, perfettamente impaginata e completa nei suoi cinque elementi: notiamo la tribù Pap(iria), propria di Ticinum42. L’illustre personaggio iniziò il suo regolare cursus ho-norum ricoprendo una delle cariche del vigintivirato, preliminare alla carriera senatoria43: come tresvir capitalis aveva svolto funzioni di po-lizia e di controllo sulle carceri e sulle esecuzioni capitali. Era poi stato nominato comandante di uno dei sei squadroni, il V, che partecipava alla rassegna dei cavalieri, la transvectio equitum, cerimonia solenne creata da Augusto44. Didio Prisco perciò fin da giovane ricoprì una
soni: rita sCuDeri, La raccolta epigrafica, in Luigi Malaspina di Sannazzaro (1754-1835). cultura e collezionismo in Lombardia tra Sette e Ottocento. Atti del convegno Pavia, Musei civici, Milano, Aisthesis, 2000, pp. 602-605, 627.
42 In altre iscrizioni pavesi è indicata la tribù Pap(iria): cIL, V, 6427, 6431; Suppl. Ital. 9, 20, 37, 38, 48. Data la normale abbreviazione, anche pier vittorio alDini, Sulle antiche lapidi ticinesi con appendice sopra un’epigrafe di casteggio. Eser-citazioni antiquarie, Pavia, Stampatori Fusi e C., 1831, pp. 43-60, seguendo lui-gi malaspina, Guida di Pavia, Pavia, Fusi e Success. Galeazzi, 1819, pp. 29-30, 159-160 e precedenti studiosi, come siro severino Capsoni, Memorie istoriche della regia città di Pavia e del suo territorio antico e moderno, I, Pavia, Monistero di S. Salvatore, 1782, pp. 153-157 (che enumera gli antecedenti), sciolse in Pap(ia), attratto dall’idea di spiegare la mutazione onomastica da Ticinum a Papia. Si attirò così le severe critiche del Mommsen, che chiarì definitivamente l’appartenenza di Ticinum alla tribù Papiria: cIL, V, pp. 564, 706. Ampia discussione sulle ipotesi per il cambiamento del nome in emilio gaBBa, Il nome di Pavia, in Storia di Pavia. II: L’alto Medioevo, Milano, Banca del Monte di Pavia, 1987, pp. 9-18 ed anche in “Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere. Rendiconti. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche”, 121 (1987), pp. 37-57; emilio gaBBa, Pavia domici-lium sapientie. Note storiche, Como, New Press, 2000, pp. 81-92.
43 Sul vigintivirato, che si articolava in xviri stlitibus iudicandis, IIIviri capitales, IVviri viarum curandarum, IIIviri monetales: hans sChaeFer, voce Vigintiviri, in Paulys Realencyclopädie classischen Altertumswissenschaft [RE], II Reihe, 8A.2, Stutt-gart, A. Druckenmüller, 1958, coll. 2570-2587.
44 In questa grande parata, che avveniva alle Idi di luglio, gli equites cavalca-vano bianchi cavalli nel centro di Roma: FernanDo reBeCChi, Per l’iconografia della transvectio equitum. Altre considerazioni e nuovi documenti, in L’ordre équestre. Histoire d’une aristocratie (IIe siècle av. J.c. - IIIe siècle ap. J.c.). Actes du colloque In-ternational (Bruxelles - Leuven, 5-7 octobre 1995), organisé par Ségolène Demougin, Hubert Devijver, Marie Thérèse Rapsaet Charlier, Rome, école française de Rome, 1999, pp. 191-214.
PAVIA ROMANA (RI)VIVE NELLE SUE EPIGRAFI 431
carica in vista, propria di chi, appartenendo a una ricca famiglia sena-toria, poteva spendere per organizzare i ludi sevirales. Come di norma per gli esponenti della sua classe sociale, il nostro compì il servizio militare da tribunus militum laticlavius, l’ufficiale più importante dopo il comandante della legione45, nel suo caso la III Augusta, stanziata in Africa46. La questura pro praetore rivestita dal personaggio com-portava compiti giurisdizionali nell’amministrazione della provincia senatoria della Gallia Narbonese47. Il cursus di Didio Prisco proce-dette col tribunato della plebe, una magistratura che in età imperiale aveva perduto significato, ma rimaneva per il conservatorismo tipico della mentalità romana48. La carica di pretore, fornita di imperium49, rappresenta il vertice della carriera del nostro.
Di C. Valerio Sabino ci è pervenuta la base onoraria in marmo bianco (figura 6), anche se non vi fu mai collocata la statua, perché l’iscrizione costituisce un interessante esempio di “non finito”, dato che le ultime due righe sono soltanto dipinte50. Il reperto, reimpiegato
45 Gli altri cinque tribuni erano angusticlavi (cioè con una più stretta striscia di porpora sulla tunica), appartenenti alla classe equestre, ma dotati di maggiore esperienza militare rispetto al giovane dell’ordo senatorius: giuseppe CasCarino, L’esercito romano. Armamento e organizzazione II: Da Augusto ai Severi, Rimini, Il Cerchio, 2008, pp. 31-32.
46 La III legio, nata durante le lotte triumvirali, passò da Lepido a Ottaviano, fatto che pochi anni dopo le valse il soprannome di Augusta. Dall’epoca augustea si sedentarizzò a difesa dell’Africa: yann le BoheC, Legio III Augusta, in Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes congrès de Lyon (17-19 septembre 1998), rassem-blés et édités par Yann Le Bohec avec la collaboration de Catherine Wolff, I, Lyon, De Boccard, 2000, pp. 373-381.
47 Il giurista gaio, Inst. I 6, ricorda la iurisdictio esercitata dai questori nelle province populi Romani, non in quelle caesaris. Dalla tarda repubblica il governatore provinciale poteva delegare l’imperium con tali competenze al questore, che assume-va così il titolo di pro praetore: cfr. FranCesCo De martino, Storia della costituzione romana, II, Napoli, Jovene, 19732, pp. 403; IV, 19742, pp. 631-632.
48 mario attilio levi, Il tribunato della plebe e altri scritti su istituzioni pub-bliche romane, Milano, Cisalpino-La Goliardica, 1978, p. 28.
49 Sul peso magistratuale della pretura: jean ClauDe riCharD, Praetor col-lega consulis est: contribution à l’histoire de la préture, in “Revue de Philologie”, LVI (1982), pp. 19-31; arminius FelDer, Aliquid de praetore Romano, in “Vox Latina”, XL (2004), pp. 75-79.
50 cIL, V, 6421; laura BoFFo, Iscrizioni, in Museo dell’Istituto di Archeolo-gia. Materiali. III: Gemme e anelli, iscrizioni, Milano, Cisalpino-La Goliardica, 1987
RITA SCUDERI432
in un pilastro della Porta S. Giovanni, tornò alla luce quando questa fu demolita, nel 1818, e si trova ora nel Museo di Archeologia dell’Uni-versità. Facile è la datazione, perché a Piacenza è stata rinvenuta una dedica dello stesso Val(erius) Sabinus, p(erfectissimus) v(ir), rat(ionalis) all’imperatore Aureliano, la cui titolatura si riferisce al 274-27551. Il titolo di vir perfectissimus spettava ai funzionari d’ordine equestre che rivestivano alte procuratele: il personaggio era appunto procurator a rationibus, cioè ministro delle finanze imperiali52. Il suo stretto col-legamento con la nostra città deriva dal fatto che egli doveva essere a capo della zecca, trasferita a Ticinum da Aureliano, in coincidenza con la sua riforma monetaria53. Perché non fu compiuto il monumento, deciso per decreto dei decurioni54, cioè del senato cittadino? Probabil-mente, dopo l’uccisione dell’imperatore cui Valerio Sabino era legato, anche l’atto d’omaggio verso di lui perdeva interesse e quindi la base onoraria venne abbandonata e forse tratta dall’officina per il reimpie-go in un breve lasso di tempo. Anche se le prime notizie certe sulla Porta S. Giovanni hanno come terminus ante quem il 57255, il fatto che
(Fonti e studi per la storia dell’Università di Pavia. 11), pp. 162-167, 230; BoFFo, in Suppl. Ital. 9, pp. 234-235.
51 cIL, XI, 1214. Sabinus probabilmente fu il successore di Felicissimus, il ratio-nalis più noto del III sec.: angela Bellezza, Epigrafi latine da Porta S. Giovanni in Pavia (cIL, V, 6427 e 6421), in “Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere. Rendiconti. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche”, 107 (1973), p. 794.
52 willy lieBenam, voce Rationalis, in RE, 1A.1, 1914, coll. 263-264.53 gaBBa, Ticinum: dalle origini, cit., pp. 240-241; miChael h. CrawForD,
La zecca di Ticinum, in Storia di Pavia. I, cit., p. 251.54 Sulle ampie competenze del consiglio decurionale: josé D’enCarnação,
Decreto decurionum. Algunas notas sobre o mecanismo decisório municipal na Hispânia romana, in ciudad y comunidad cívica en Hispania (Siglos II y III d.c.). cité et com-munauté civique en Hispania. Actes du colloque organisé par la casa Velázquez et par le consejo Superior de Investigaciones cientificas (Madrid, 25-27 janvier 1990), Madrid, Casa de Velázquez, 1993, pp. 59-64.
55 Il re longobardo Alboino sarebbe entrato in città attraverso Porta S. Giovan-ni: paul. DiaC., Hist. Lang. II, 27; huDson, Le mura romane, cit., p. 117. Bellez-za, Epigrafi latine, cit., p. 797: il terminus post quem è il 274. Giustamente Fagnani, Il tracciato delle mura, cit., p. 35, per l’ampliamento della cinta muraria considera come terminus post quem le iscrizioni di I-III sec. che vi furono reimpiegate. Clau-Dia maCCaBruni, Pavia: la tradizione dell’antico nella città medievale, Pavia, EMI, 1991, p. 15, conferma la tarda età imperiale, pur non escludendo il reimpiego dei materiali nel corso di un restauro di epoca successiva.
PAVIA ROMANA (RI)VIVE NELLE SUE EPIGRAFI 433
7 – Epigrafe sepolcrale del quattuorviro L. cassius Labeo (cIL, V, 6427). Pavia, Università, cortile del Leano
6 – Base onoraria di c. Valerius Sabinus (cIL, V, 6421). Pavia, Università, Museo di Archeologia.
RITA SCUDERI434
la zona presso Pavia fosse stata devastata dagli Alamanni, poi scon-fitti da Aureliano Ticinensibus campis56, rende plausibile l’ipotesi che il pericolo dei barbari avesse dato il via a un rifacimento della cinta muraria.
Per concludere la panoramica sui cittadini di spicco, scegliamo il caso in cui si può intravvedere qualcosa della loro vita privata. Sotto il porticato dell’Università si trova un grosso blocco di trachite dei colli Euganei (figura 7), rinvenuto reimpiegato ancora nella Porta S. Gio-vanni, con ogni probabilità parte di un monumento funerario. L’epi-grafe riporta la completa onomastica del quattuorviro L(ucius) cassius c(ai) f(ilius) Pap(iria tribu) Labeo e quella della sua liberta cassia Tro-phe57, dal tipico cognomen grecanico, entrambe al nominativo, come usava quando l’iscrizione era decisa dagl’interessati ancora in vita. Non risulta quindi la dedica dell’inferiore al patrono, ma i due compaiono l’uno accanto all’altra, probabilmente legati da un rapporto affettivo.
Esemplifichiamo la presenza di militari a Ticinum con due epigrafi funerarie di soldati appartenenti alla legio II Adiutrix58: l’una è incisa su una stele frammentaria in marmo di Ornavasso-Candoglia (figura 8), rinvenuta nel 1825 fra le rovine della Porta Marenga, ora nel Museo di Archeologia dell’Università59. Il nome del defunto, Aurelio Pater-
56 Epitome de caes. 35, 2. Cfr. gaBBa, Ticinum: dalle origini, cit., p. 240; john F. DrinKwater, The Alamanni and Rome 213-496 (caracalla to clovis), Oxford-New York, Oxford University Press, 2007, p. 76.
57 cIL, V, 6427; Bellezza, Epigrafi latine, cit., pp. 773-781; BoFFo, in Suppl. Ital. 9, pp. 236-237. L’elegante paleografia e la perfetta onomastica portano a datare fra I e II sec. Sul materiale lapideo: maria gloria zezza, I materiali lapidei locali impiegati in età romana nell’area compresa tra il Ticino e il Mincio, Milano, Centro Studi della Società Italiana di Scienze Naturali, 1982, p. 132, n. 5. Per l’ipotesi che il blocco iscritto appartenesse a un recinto funerario: maria elena gorrini, in maria elena gorrini - mirella t.a. roBino, I monumenti funerari urbani di Ticinum: alcune considerazioni, in “ [Ostraka”, XIX (2010), p. 269.
58 La legio II Adiutrix, istituita nel 70 da Vespasiano, che vi arruolò classiarii, fu dapprima impegnata nella guerra batava del 71, stanziata poi in Britannia fino all’86, inviò vexillationes in Germania. Partecipò alle spedizioni in Dacia di Domi-ziano e di Traiano e nel 118 stabilì la sua base in Pannonia, ad Aquincum. Prese parte alle guerre contro Marcomanni e Sarmati al tempo di Marco Aurelio, poi contro Alamanni e Quadi nel 213-214, contro i Goti con Claudio Gotico nel 269. Cfr. BarnaBás lorinCz, Legio II Adiutrix, in Les légions de Rome, cit., pp. 159-168.
59 cIL, V, 6422; BoFFo, Iscrizioni, cit., pp. 167-171; eaDem, in Suppl. Ital. 9, p. 235.
PAVIA ROMANA (RI)VIVE NELLE SUE EPIGRAFI 435
no, integrabile dalle fratture e sbrecciature dello specchio epigrafico, si presenta in genitivo, dipendente dalla dedica agli Dei Mani, che poteva trovarsi sul perduto coronamento della stele. Dopo il gentilizio Aurelius, generalmente diffuso, interessante è il cognomen Paternus, della categoria riguardante le relazioni di parentela, frequente nell’area celtica60. Da questo indizio verrebbe la tentazione di immaginare il nostro miles di origine cisalpina; però morì evidentemente lontano dai suoi familiari, perché l’esecutore testamentario è un commilitone, Valerius Aper61. Il defunto teneva al monumento sepolcrale, in materiale di pregio quale il marmo (impiegato qui a Pavia solo per un quinto delle iscrizioni fune-rarie62): l’epigrafe ricorda che fu posto dal legionario L. Valerio Apro, cui iudic(iis) suis il dedicatario procurandum iniuncx(it), cioè gli affidò questo compito, esplicitato nei codicilli del testamento.
L’altra iscrizione di un appartenente alla II legione Adiutrix è sul sarcofago in ghiandone (ora nei Civici Musei del Castello), che il ve-terano M. Volusienius Victor da vivo si fece preparare63. Egli potrebbe essere tornato a casa dopo il congedo, ma il suo raro gentilizio, unicum nell’Italia settentrionale, e il diffuso cognomen64 non forniscono indizi sulla sua origine. Oppure potrebbe essersi stabilito a Ticinum, dopo aver combattuto nella nostra zona contro gli Alamanni al tempo di Aure-liano65. Aurelius Paternus sarebbe caduto durante quella campagna? La
60 iiro Kajanto, The Latin cognomina, in “Societas Scientiarum Fennica. Commentationes”, XXXVI (1965), pp. 18, 79-80; cfr. 134, 304; henar gallego FranCo, Los cognomina de parentesco en las provincias romanas del alto y medio Danu-bio, in xI congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 18-24 settembre 1997), Roma, Quasar, 1999, pp. 697-705.
61 Il gentilizio Valerius è il più frequente a Ticinum (cIL, V, 6413, 6427, 6454, 6455, 6465) e in genere nell’Italia settentrionale (indice di cIL, V, pp. 1129-1131).
62 pierluigi tozzi - mario oXilia, Le pietre di Pavia romana, in “BSPSP”, LXXXI (1981), p. 18: il marmo è utilizzato di solito per le lastrine sepolcrali cristia-ne e per i tituli onorari.
63 heCtor pais, corporis inscriptionum Latinarum Supplementa Italica. Fasc. I: Additamenta ad vol. V Galliae cisalpinae, Romae, ex Typis Salviucci, 1884, 869; amBaglio, in Suppl. Ital. 9, p. 252.
64 Victor nel conteggio di Kajanto, The Latin cognomina, cit., pp. 29-30, è tra i 18 cognomina più frequenti.
65 Cfr. nota 56. gaBBa, Ticinum: dalle origini, cit., p. 240, nota 162, ipotizza inoltre il conflitto, di poco precedente, fra pretendenti all’impero: Aureolo sconfitto era stato costretto a chiudersi in Milano e Claudio II ebbe la meglio.
RITA SCUDERI436
8– Stele funeraria del militare Aure-lius Paternus (cIL, V, 6422). Pavia, Università, Museo di Archeologia.
9 – Ara a Iuppiter Agganaicus (cIL, V, 6409). Pavia, Musei Ci-vici.
PAVIA ROMANA (RI)VIVE NELLE SUE EPIGRAFI 437
paleografia di entrambe le iscrizioni porterebbe a un’epoca anteriore, ma non possiamo certo considerarla una prova indiscutibile66.
Nell’ambito delle epigrafi sacre la più interessante mi sembra la dedica a Iuppiter Agganaicus67 (figura 9), incisa su un’ara in ghiando-ne rinvenuta nel 1756 in un muro dell’Ospedale della Colombina68, giunta dopo il 1810 nella collezione Malaspina69, ora sotto il porti-cato del Castello Visconteo. È un significativo esempio dell’incontro e compenetrazione della Romana religio e di culti locali. Al principa-le dio del pantheon ufficiale, invocato coi canonici epiteti di Ottimo Massimo, si aggiunge un appellativo tipicamente epicorico, che subito suscitò l’interesse degli studiosi70. Già Aldini notò giustamente un collegamento linguistico con la popolazione preromana71 e Majocchi ipotizzò un toponimo Agganae o Adganae72. Piuttosto che di un vicus, si tratta di entità divine galliche, protettrici del luogo73. A conferma dell’interpretatio romana del culto celtico, un’altra ara votiva a Medio-lanum è dedicata I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Adceneico74, con una pic-cola variante grafica75. Nella dedica Matronis et Adganais, da Galliano
66 elisaBetta toDisCo, I veterani in Italia in età imperiale, Bari, Edipuglia, 1999, pp. 187, 237, propone la datazione alla metà del III sec. o dalla fine del II in avanti.
67 cIL, V, 6409; amBaglio, in Suppl. Ital. 9, p. 230.68 susanna zatti, L’architettura a Pavia nel xVII e xVIII secolo, in Storia di
Pavia. IV: L’età spagnola e austriaca, 2, Milano, Banca del Monte di Pavia, 1995, pp. 876-877: i padri Somaschi del convento di S. Maiolo spostarono la sede del loro collegio nel luogo dell’Ospedale della Colombina, che fu oggetto di demolizioni e ampliamenti.
69 sCuDeri, La raccolta epigrafica, cit., pp. 600-602, 626.70 FranCesCo eugenio guasCo, Musei capitolini antiquae inscriptiones, I,
Romae, Salomon, 1775, p. 93, iniziò a dare un’interpretazione erudita, derivando l’epiteto da ajganov~ (amabile, propizio): ma il greco non è correlato con l’ambiente traspadano!
71 alDini, Sulle antiche lapidi ticinesi, cit., pp. 14-15. 72 roDolFo majoCChi, Antiche iscrizioni ticinesi, Pavia, Tip. Istituto Artigia-
nelli, 1897, p. 8.73 giuviana meneghetti, Probabile natura e sopravvivenza delle divinità cel-
tiche “Adganae”, in “Athenaeum”, XXXVIII (1950), pp. 116-127.74 cIL, V, 5783 = ILS, II 1, 1902, 4619.75 Nell’onomastica celtica si riscontrano varianti degli stessi temi, da Adcene-
cus ad Agganaicus: Xavier Delamarre, Noms de personnes celtiques dans l’épigraphie classique, Paris, Errance, 2007, pp. 11-12.
RITA SCUDERI438
presso Cantù76, le Adganae sono accomunate alle Matronae, tipiche divinità galliche, spesso identificate con le Iunones77. La nostra ara, con una buona paleografia e l’onomastica del dedicante, M. Nonius Verus, perfettamente romana78, si può datare ormai al II sec. e testimo-nia il perdurare del sostrato culturale celtico, tranquillamente inserito nella piena romanità.
Un altro indizio di ciò si scorge nel fatto che, nel ben scarso nu-mero di epigrafi pavesi, due siano dedicate a Mercurio79, l’interpretatio romana della massima divinità gallica80. Entrambe le iscrizioni, ora in Università, furono rinvenute nel 1726 durante i lavori edilizi del
76 cIL, V, 5671 = ILS, 4820. Le Adganae sono divinità epicorie; in altre dedi-che le Matronae compaiono con appellativi che alludono ad aggregazioni vicane e pagensi, come Dervonnae (cIL, V, 5791), Ucellasicae concanaunae (cIL, V, 5584): giovanni mennella, in giovanni mennella - lorenza lastriCo, Le Ma-tronae - Iunones nell’Italia settentrionale: anatomia delle dediche, in continuity and Innovation in Religion in the Roman West, edited by Ralph Haeussler and Antony C. King, II, Portsmouth, JRA Editor (“Journal Roman Archaeology”, Suppl. Ser. 67), 2008, p. 125.
77 Nella Cisalpina le dediche alle Matronae sono più frequenti nelle zone rurali della Transpadana e Liguria, mentre in città e nella Venetia, di precedente roma-nizzazione, sono più diffuse le Iunones. Cfr. CeCil Bennett pasCal, The cults of cisalpine Gaul, Bruxelles, Berchem, 1964, p. 117; FranCa lanDuCCi gattinoni, Un culto celtico nella Gallia cisalpina. Le Matronae - Iunones, Milano, Jaca Book, 1986, pp. 90-92. Sulla sicura tipicità celtica delle Matronae: ClauDio zaCCaria, Alla ricerca di divinità “celtiche” nell’Italia settentrionale in età romana. Revisione del-la documentazione per le regiones Ix, x, xI, in “Veleia”, XVIII-XIX (2001-2002), pp. 132-133, 149-155; jaCQues laCroiX, Les noms d’origine gauloise. La Gaule des dieux, Paris, Errance, 2007, pp. 168-175.
78 Un omonimo M. Nonius Verus pone un’iscrizione funeraria a Mediolanum: cIL, V, 6049. Il cognomen Verus, che ha altre attestazioni pavesi (cIL, V, 6465, 6481; BoFFo, in Suppl. Ital. 9, 55), rientra nella diffusa categoria derivata dai concetti astratti (veritas): Kajanto, The Latin cognomina, cit., pp. 22, 68, 133, 253.
79 cIL, V, 6410, 6411; BoFFo, in Suppl. Ital. 9, pp. 230-231.80 Caes., B.G. VI 17, 1: Deorum maxime Mercurium colunt. Sui vari epiteti gal-
lici di Mercurio: miranDa j. green, Dictionary of celtic Myth and Legend, London, Thames and Hudson, 19972, pp. 148-150. Tra l’ampia bibliografia cfr. di recente: zaCCaria, Alla ricerca di divinità “celtiche”, cit., p. 138, nota 99; anDreas hoFene-Der, Mercurius Arvernus. Überlegungen zu Plin., Nat. Hist. 34. 45-47, in continuity and Innovation, cit., pp. 103-118. Per l’identificazione con Teutates (= padre del popolo): martín almagro gorBea - alBerto j. lorrio alveraDo, Teutates el héroe fundador y el culto heroico al antepasado en Hispania y en la Keltiké, Madrid, Real Academia de la Historia, 2011, pp. 269-274.
PAVIA ROMANA (RI)VIVE NELLE SUE EPIGRAFI 439
palazzo Mezzabarba: è possibile che lì esistesse un tempio, monu-mentale realizzazione di un culto preesistente. L’ara di gneiss della Val d’Ossola, conservata abbastanza bene, è dedicata da due coniugi, cn. Papirius Oculatius e Salvia Pudentina81, mentre l’altra epigrafe, ridotta a frammento di lastra in calcare (figura 10), scioglie il voto di M. cor-nelius Hermes82, probabilmente un liberto, dato il cognomen grecanico, anche se la frammentarietà del testo sottrae ogni altra indicazione.
A breve distanza, inserita nello stesso muro del cortile del Miliario dell’Università, una tavola ansata in marmo bianco è l’unica documen-tazione di un culto orientale nel territorio, la dedica a Iside da parte di Plotia Vitalis, liberta di Lucio83 (figura 11). L’eleganza della cornice modanata, l’ottima impaginazione e incisione delle lettere permetto-no di datare fra I e II sec. questa testimonianza di religione egizia, che in Italia si diffuse ancora in età repubblicana nei porti del Sud84, portata soprattutto da mercatores e marinai. La dea, con l’appellativo di Pelagia, soccorreva i naviganti85 e anche nella Cisalpina il porto di Aquileia era il maggior centro di penetrazione del culto isiaco86. Ma il
81 cIL, V, 6411: l’onomastica e la paleografia portano la datazione al I sec.82 cIL, V, 6410 è paleograficamente databile al II sec.83 cIL, V, 6406; amBaglio, in Suppl. Ital. 9, pp. 229-230; laurent Bri-
Cault, Recueil des inscriptions concernant les cultes isiaques, II, Paris, De Boccard, 2005, p. 661.
84 Città lungo la costa campana come Pompei furono centri di propagazione del culto isiaco: paolo gallo, Luoghi di culto e santuari isiaci in Italia, in Iside: il mito, il mistero, la magia, a cura di Ermanno A. Arslan, Milano, Electa, 1997, pp. 290-296. L’Iseo di Pompei esisteva almeno dal I sec. a.C.: steFano De Caro, L’Iseo di Pompei, in Iside: il mito, cit., pp. 338-343; Carla alFano, La penetrazione della cultura egizia in Italia al tempo di cleopatra, in cleopatra regina d’Egitto, a cura di Susan Walker e Peter Higgs, Milano, Electa, 2000, p. 211 (risalenza almeno al II sec. a.C.); eriC m. moormann, The Temple of Isis at Pompeii, in Nile into Tiber. Egypt in the Roman World. Proceedings IIIrd International conference of Isis Studies (Leiden, mai 11-14, 2005), edited by Laurent Bricault, Miguel John Versluys, Paul G.P. Meyboom, Leiden-Boston, Brill, 2007, pp. 137-154.
85 Ogni anno la cerimonia del navigium Isidis affidava i viaggi per mare alla protezione della dea: thea tiBiletti, La festa del “Navigium Isidis”, in Iside: il mito, cit., pp. 658-659.
86 marie Christine BuDisChovsKy, La diffusion des cultes isiaques autour de la mer Adriatique. I: Inscriptions et monuments, Leiden, Brill, 1977, pp. 117-161; enri-Chetta leospo, La diffusione del culto isiaco nell’Italia settentrionale, in Iside: il mito, cit., pp. 365-366.
RITA SCUDERI440
10 – Dedica a Mercurio da parte di M. cornelius Hermes (cIL, V, 6410). Pavia, Università, cortile del Miliario.
11 – Dedica a Iside da parte di Plotia Vitalis (cIL, V, 6406). Pavia, Univer-sità, cortile del Miliario.
PAVIA ROMANA (RI)VIVE NELLE SUE EPIGRAFI 441
fascino della religione orientale, che prometteva salvezza e assommava sincreticamente le prerogative di altre divinità classiche, arrivò anche nel cuore della pianura padana: nell’xI regio sono state rinvenute altre tre iscrizioni a Iside, ad Angera, a Milano e a Torino87.
Per concludere questa breve carrellata di iscrizioni pavesi, ne ricor-diamo una decisamente tarda, ma legata in vario modo a epoche pre-cedenti (figura 12). Si data fra 528 e 529, essendo posta da Atalarico nel terzo anno del suo regno88, ma si tratta del reimpiego di una fronte di sarcofago in roccia carbonatica89, databile al terzo venticinquennio del II sec.90. Il re dei Goti, erasa l’originaria iscrizione sull’elegante tabula ansata sorretta da due eroti, ne fece incidere un’altra (in un latino non del tutto corretto91), in cui celebrava la costruzione di un edificio per spettacoli. Tale vanteria evidentemente dev’essere ridi-mensionata, perché si tratta della manutenzione dell’anfiteatro roma-no92. Già il predecessore Teoderico aveva fatto restaurare l’edificio93. Il reperto epigrafico, pervenuto ai Musei Civici attraverso la collezio-ne Malaspina dopo aver subito diversi spostamenti94, fu per la prima volta localizzato verso la metà del XVI sec. «nella facciata di un’antica chiesetta detta di S. Secondiano»95, che si trovava in una zona vicina alla probabile localizzazione dell’anfiteatro classico96. Questo infatti è
87 Rispettivamente cIL, V, 5469, 5770, 6953. Cfr. BriCault, Recueil des in-scriptions, cit., pp. 661-662.
88 cIL, V, 6418; amBaglio, in Suppl. Ital. 9, p. 233.89 tozzi - oXilia, Le pietre di Pavia, cit., tav. XIV, fig. 2.90 Cesare saletti, Nota sui monumenti funerari di Ticinum, in “BSPSP”,
LXXXIII (1983), pp. 148-149.91 D(ominus) n(oster) Atalaricus rex / gloriosissimus has / sedis (!) spectaculi anno /
regni sui tertio fieri / feliciter precepet (!).92 Probabilmente Atalarico fece restaurare le gradinate: gian luCa grego-
ri, Regiones Italiae VI-xI, in Epigrafia anfiteatrale dell’Occidente romano, II, Roma, Quasar, 1989, pp. 84-85.
93 anonimus valesianus, in Monumenta Germaniae Historica Ix, chronica Minora, p. 324, 71: Ticino palatium, thermas, amphitheatrum et alios muros civitatis fecit (= restaurò). Cfr. lellia CraCCo ruggini, Ticinum: dal 476 d.c. alla fine del Regno Gotico, in Storia di Pavia. I, cit., p. 308.
94 sCuDeri, La raccolta epigrafica, cit., pp. 616-617.95 luigi malaspina, Iscrizioni lapidarie raccolte dal marchese Malaspina di San-
nazzaro nella di lui casa in Pavia ed altre relative corredate d’illustrazioni, Milano, Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1830, p. 24.
96 malaspina, Iscrizioni lapidarie, cit., p. 24, considera un «andamento di fab-
RITA SCUDERI442
collocabile tra via Porta e la parte meridionale di via Volta, più preci-samente fra via Ressi e via Corridoni, dove la toponomastica lo ricorda con un vicolo Anfiteatro97, che è vicino ai pochi resti della chiesetta di S. Secondiano, inglobati nel muro di cinta del giardino già Beccaria98. L’epigrafe di Atalarico mi sembra un esempio particolarmente signifi-cativo di quante vicende una pietra iscritta possa racchiudere in sé, dal monumento funerario di II sec. all’edilizia di età gotica, dall’anfiteatro romano alla chiesa romanica.
bricato curvilineo» vicino a «S. Dalmazio, non lungi dalle citate chiese soppresse» (e vicolo S. Dalmazio è appena a Sud-Ovest di vicolo Anfiteatro).
97 giuseppe noCCa, Sul luogo dell’anfiteatro romano a Pavia, in “BSPSP”, LVI (1956), pp. 93-94; Cesare saletti, La civiltà artistica, in Storia di Pavia. I, cit., p. 318. steFano maggi, Anfiteatri della cisalpina romana (Regio IX, Regio XI), Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1987, p. 57, collocando l’anfiteatro nella zona a giardino tra via Ressi e via Corridoni, nota che era appena fuori dalla cinta muraria antica, secondo l’uso per questo tipo di grandi edifici. Cfr. anche ChrzanovsKi, L’urbanisme des villes, cit., p. 305.
98 chiese di Pavia (con resti, entro le vecchie mura): www.paviaedintorni.it/temi/arteearchitettura.
12 – Iscrizione del re dei Goti Atalaricus (cIL, V, 6418). Pavia, Musei Ci-vici.