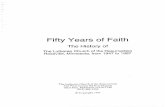Mito e psicologia, psicologia del mito: Thomas Mann su Richard Wagner
Resurrection. Ripresa e variazione del mito in Skyfall
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Resurrection. Ripresa e variazione del mito in Skyfall
Resurrection. Ripresa e variazione del mito in Skyfall
I. “I am become a name”, ammette, non sappiamo se conamarezza, l’Ulisse di Alfred Tennyson, in una celebrelirica: e la sentenza si adatta come un guanto al destinodi uno degli ultimi eroi della contemporaneità – Bond,James Bond. Fin da quando, “all’alba di una giornata del1952 che sarebbe stata piena di sole” 1, Ian LancasterFleming ne progettò la creazione sulle pagine di CasinoRoyale, e il personaggio dell’agente segreto inglese assursead una oceanica popolarità, la sua forza vitale ha superato– tutto, o il contrario di tutto: l’andante mosso di una verae propria saga in più romanzi, alcuni tra l’altropubblicati postumi: lo smembramento in vari film el’incarnazione in visi diversi di attori, dal primissimo,Sean Connery, assurto a diventare l’eidolon di Bond perreferendum, all’ultimissimo, Daniel Craig, che hacontraddetto la tipologia consueta coi suoi capelli biondie i suoi lineamenti ‘plebei’ aggravati dalle inscusabiliorecchie a sventola, pur ottenendo, contro ogniaspettativa, un rinnovarsi della passione e dell’adorazionein legioni di fan: l’accumularsi di pagine e pagine distudi critici, letterari e cinematografici: conindistruttibile, indiscutibile vitalità. Cambiando tutto,rimane una certezza: il suo essere un “semioforo, unattrattore di senso”, come sostiene Paolo Fabbri, sidimostra dal fatto che abita “una nicchia dell’immaginariocollettivo”2 dalla quale può sprigionarsi in tutta la suacaptivation al solo pronunciare il ritornello: Bond, JamesBond. Here he is. 3
1? L. Tornabuoni, Un fenomeno di costume, in AA.VV., Il caso Bond , a c. di U. Eco e O.del Buono, Milano, Bompiani, 1965, p. 11. 2 P. Fabbri, Ulisse è Bond , “Alfabeta” 2, n. 26, febbraio 2013, p. 1. 3 Del resto, fin da subito la forza energetica del personaggio lo ha quasi reso capace di incarnarsi realisticamente: dai primi critici, che se ne resero biografi (cfr. O.F. Snelling, Double O seven – James Bond – A report , Spearman-Holland Press, London, 1964) , fino alla notizia recentissima che l’Università di Nottingham si è preoccupata di esaminarne le abitudini di bevitore ed ha pubblicato una diagnosi nefasta, secondo la quale l’agente segreto rischia una morte prematura per alcoolismo che è stata riecheggiata, con titoli diversi, in tutti i quotidiani del Regno Unito, pare davvero di occuparci di una persona, niente affatto di un personaggio.
II. La critica ha consumato fiumi di inchiostro attorno aquesta figura, prima esaminandola come personaggioletterario, poi prendendola in considerazione – spesso coneffetti di rovinosa confusione – come caratterecinematografico. Una prima ondata, capitanata da TerenceYoung, negli ultimi anni Cinquanta giudicò che il successoinnegabile del personaggio si fosse installato nellamentalità collettiva per “coincidenze sociologiche: ilpubblico era saturo di film intellettuali e Bond è arrivatoal momento giusto. Ma sono stati gli intellettuali atrasformare questo successo in trionfo”4: erano stanchi, enella loro stanchezza, e pigrizia, non hanno reagito, e“hanno permesso che James Bond diventasse un simbolo” 5 .Stanchezza intellettuale o no, come asserisce Laura Lilli,“dopo il 1958 la bondite divampa. Agli articoli sui libri diFleming si aggiungono quelli sui film: oltre ai criticiletterari e cinematografici si muovono i sociologi, glipsicologi, gli studiosi di cultura di massa; e igiornalisti di ogni livello. È una valanga. Si scrive suFleming, su Bond, su Fleming-Bond, su Connery, su Bond-Connery: sulle ragioni di tutto questo”6. Passa il tempo ela letteratura critica su 007 assume una trama sempre piùaggrovigliata: dipanarla è quasi impossibile. Senza pretesedi ordine, o di esaustività, non resta che registrarne lepunte più originali, o comunque più emergenti. Uncontributo non ignorabile rimane quello di Kingsley Amis,che compone nel 1965 un saggio a vari livelli7, alcuniinnegabilmente validi: ad esempio, la sua reference guide deilibri di Fleming, “con anno di pubblicazione, luoghid’azione, nomi della ragazza ( o delle ragazze), delcattivo (o dei cattivi), progetto e datore di lavoro diquesti, nome del cattivo minore, amici di Bond, highlights,rapido giudizio sui libri, fa sospettare un suo presuppostosottinteso che la storia in Fleming sia sempre la stessa,una diversa variazione su un identico tema”,8 e apre la viaall’indagine combinatoria, certo ben più geniale, diUmberto Eco, tempo dopo. E anche nella prima parte delsaggio, quella più prevedibile, biografica,caratteriologica, Amis tocca livelli piuttosto raffinati, e
4 T. Young, Portrait de Monsieur Bond, “Le Nouvel Observateur”, 25 febbraio 1965. 5 Ibidem. 6 L. Lilli, James Bond e la critica, in AA.VV., Il caso Bond, cit., p. 235. 7 K. Amis, The James Bond Dossier, Jonathan Cape, London, 1965. 8 L. Lilli, James Bond e la critica, in AA.VV., Il caso Bond, cit., p. 239.
riesce a cogliere il processo di deterioramento di Bond,che, invece di restare variabilmente ineccepibile, pianpiano crolla, invecchia, va in pezzi, passando dalla“figura niente affatto brillante, un uomo ordinario a cuiaccadono cose straordinarie” in Casino Royale, al carattere“incrostato di manierismi e di peculiarità” degli ultimiromanzi9: intuizione felice, utile ad ulteriori analisi.
Molti critici, in seguito, si sono interrogati non solo sullecaratteristiche strutturali e di stile dei romanzi di Fleming,ma meramente sul tipo di eroe che Bond rappresenta. L’eroebyroniano, come sostiene Amis? Oppure, come pensa Dino Buzzati,un “neo – superuomo”, un nuovo Achille, un nuovo Sigfrido,“l’uomo dotato di facoltà superiori, negate agli esserinormali”10? O una figura grottesca, burlesca, ridicola nella suainverosimiglianza, o anche un’incarnazione deleteria delrazzista decadente, una specie di Andrea Sperelli da strapazzo?Certamente un eroe connesso alla pop-art, nell’opinione di molti,almeno nella sua incarnazione cinematografica, con i coloricrudi, la mancanza di ombre, l’inverosimiglianza tecnica, lescene più vere del vero. E poi? Che altro? Per Guido Piovene, ilpubblico si affolla nei cinema che proiettano i film di Bond permotivi analoghi a quelli che inducevano i veneziani delSettecento ad assistere alle fiabe di Carlo Gozzi, “con le loroforeste magiche, le loro teste mozze e i loro mostriportentosi”11. Questa intuizione, la possibilità di decifrare lasaga Bond in chiave fiabesca, annovera vari condivisori: adesempio Boileau – Narcejac, secondo il quale Fleming avrebbe,abilmente, “ritrovato i temi che affascinarono la nostrainfanzia: la scoperta del tesoro, sorvegliato non più daldragone ma da qualche personaggio diabolico: l’eroe prigionieroe già legato al palo del supplizio: la bella che va liberatadagli artigli del mostro. La tentazione di scorgere il paladinoavventuroso dei poemi cavallereschi nei panni del tonicodetective imbottito di vitamine è davvero grandissima, tanto piùse si confrontano i contesti, i simboli, gli objects poétiques chericorrono nelle trame stupefacentemente uguali ma sfasate neltempo a un secolo di distanza. Dopo tutto l’equazione sta fra laDurlindana e la Colt, Baiardo e una limousine Bentley, l’elisirdi lunga vita, gli unguenti miracolosi e la benzedrina”12. Così,
9 Ibidem. 10 D. Buzzati, Neo- superuomini, “Corriere della Sera”, 9 marzo 1965. 11 G. Piovene, Perché mi divertono i films di James Bond , “La Stampa”, n. 50, 2 aprile 1965. 12 Boileau – Narcejac, La mort de James Bond , “Corriere della Sera”, 9 marzo 1965.
sotto la penna del critico francese, Bond potrebbe somigliare aOrlando, invulnerabile, fortissimo, disinvoltamente omicida comelui, oppure tutto il mondo di Bond potrebbe essere “un’Alice nera,i racconti delle fate dell’era atomica. Ci sono tutti: l’Eroevolta a volta cavaliere e principe azzurro. Le belle, gli orchi.Gli incantatori: e, naturalmente, le Fate”13. Questa linea interpretativa è apparsa seducente anche a RomanoCalisi, che ha esplicitamente connesso il Bond – world ai contes desfées . Per molteplici motivi: come nelle favole il fantasticotrionfa sul reale, così l’universo di Bond si delinea a buondiritto totalmente privo di ruoli e stratificazioni sociali, econnotato in maniera diversa, altra: così come altre sono lecategorie funzionanti nel clima dei racconti di fate.All’interno di questo mondo multicolore, “l’Eroe James Bondcompie le prove che il Fato gli assegna. Sotto figurazionimoderne e attuali è possibile rinvenire le tracce delle proveiniziatiche e fondamentali proprie dei contes des fées . Si pensi,ad esempio, al tema della morte e della resurrezione. Bondaffronta sempre un calvario (di percosse o di torture) chenessun altro potrebbe sopportare senza morire. Quando i suoinemici meno se lo aspettano, ecco risorgere trionfante l’EroeBenefattore, e spesso anche Vendicatore”14.Percependo, sensibilmente, l’uso di parole pesanti, complicate daaffordances non ignorabili (eroe, prova, fato, and so on), chepotrebbero farlo scivolare da un campo culturale all’altro, dauna categoria culturale all’altra (e appunto nel titolo delsaggio si parla non di conte ma di mito), l’autore si preoccupa difrenare la scivolata e di definire i propri spazi di ricerca. Siaggrappa addirittura a Mircea Eliade e alla sua indiscussaauctoritas15 per dichiarare che il mito sarebbe un discorso vero(fondante, sacro e significativo, derivante dal rito e influentesulla cultura collettiva), contrapposto e contrapponibile aldiscorso falso del racconto favoloso (desacralizzato, sradicato dalreale, meraviglioso, ed eminentemente evasivo). Al limite,esiste per Calisi “una solidarietà profonda fra mito e conte :certi motivi dei contes rappresentando un ‘camuffamento’ dimotivi e personaggi mitici”16, probabilmente tramite quei“pretesti narrativi” che sono “le saghe di origine nordica”.Esisterebbe, dunque, una ‘sceneggiatura’ narrativa che, sebbene
13 Ibidem. 14 R. Calisi, Mito e destorificazione nell’epopea di James Bond, in AA.VV., Il caso Bond, cit., p. 136. 15 M. Eliade, Aspects du Mythe , Paris, Gallimard, 1962. 16 R. Calisi, Mito e destorificazione…, cit., p. 132.
desacralizzata e alleggerita, “ascrive le sue originidirettamente al mito e al rito”17.
III. In un saggio memorabile per sagacia ed abilità, Le strutturenarrative in Fleming18, Umberto Eco, inaugurando le ricerche dicombinatoria narrativa, tracciò una mappa di costanti e unsicuro framework dei romanzi e dei racconti relativi a Bond,isolando e collegando a coppie i valori in opposizione(Occidente vs. Comunismo, Logos vs. Improvvisazione, etc.),e le loro dieci combinazioni: individuava poi i trepersonaggi (Bond, il Malvagio, la Donna) che realizzano innove mosse narrative tutte le possibilità immaginabili.Libera da qualsiasi sospetto di realismo, lontana datemperie sociologiche di ogni tipo, l’avventura di Bonddiventa una tabella di costanti – viaggi, eros, cibo,dolore, piacere and so on – certamente variabile in volti diattori e sottovalori storicizzati, ma estremamentepermanente. Perciò, se “le invenzioni collaterali sonoassai ricche e formano la muscolatura dello scheletronarrativo”, costituendo uno dei fascini maggiori deiromanzi di Fleming, “la trama vera e propria rimaneimmutabile e la suspance si stabilisce curiosamente sullabase di una sequenza di eventi totalmente scontati”19 . Insintesi, la trama di ogni libro di Fleming, secondo Eco, èquesta: “Bond viene inviato in un dato luogo per sventareun piano fantascientifico di un individuo mostruoso diorigini incerte e comunque non inglese che, avvalendosi diuna propria attività organizzativa o produttiva, non sologuadagna denaro ma fa il gioco dei nemici dell’Occidente.Nell’affrontare questo essere mostruoso Bond incontra unadonna che ne è dominata e la libera dal suo passatoinstaurando con lei un rapporto erotico, interrotto dallacattura, da parte del cattivo, e dalla tortura. Ma Bondsconfigge il cattivo che muore orribilmente e si riposadalle gravi fatiche fra le braccia della donna, seppure èdestinato a perderla”20 .
Come è possibile, si chiede Eco, che i lettori di romanzigialli, tradizionalmente intesi come portatori di meraviglia e
17 Ibidem. 18 U. Eco, Le strutture narrative in Fleming, in ID., Il Superuomo di massa. Retorica e ideologia nel romanzo popolare, Milano, Bompiani, 2005, pp. 145-184. 19 Ivi, p. 166. 20 Ibidem.
di imprevedibilità, si accontentino di uno schema prefissato edelle sue variazioni? Con ogni evidenza, invece di constare delbrivido dell’imprevisto, “il piacere del lettore consiste neltrovarsi immesso in un gioco di cui conosce i pezzi e le regole– e persino l’esito – traendo piacere semplicemente dal seguirele variazioni minime attraverso le quali il vincitore realizzeràil suo scopo”. Un romanzo di Bond, insomma, sarebbe, col suoframework rigido e semi invariabile, l’equivalente letterario diassistere a una partita di pallacanestro giocata dagli HarlemGlobetrotters contro una piccola squadra di provincia. Siconosce già, ovviamente, la squadra vincitrice: e dunque “ilpiacere consisterà allora nel vedere con quali trovatevirtuosistiche i Globetrotters protrarranno il momento finale,con quali ingegnose deviazioni riconfermeranno comunque laprevisione ultima, con quali jongleries terranno in ballol’avversario”21….
IV. “Chi ama la letteratura classica, ha certo presente quelsentimento come di familiarità che prende il lettore difronte al ventaglio di intrecci che ne costituiscono labase narrativa: si legge, e si corre lungo il filo distorie che molto spesso appaiono già note”, affermafluidamente Maurizio Bettini occupandosi di riscritture delmito classico22nel formarsi della letteratura latina.Naturalmente, in campo classico, in area di mito classico,l’intreccio è chiaro fin dall’inizio (tutti sanno comefinisce il mito di Edipo…) , e gli autori non si occupanodi scrivere, ma di ri-scrivere. Asserito questo, si deveasserire anche che l’intreccio ha comunque, e sempre, unafondamentale importanza. È già portatore di significaticulturali e narrativi: ha già il dono e la capacità dicondizionare la fantasia, ancora prima che i suoimessaggeri sulla pagina, le ‘parole per dirlo’, scattino inazione, verso una propria costruzione formale o verso unparticolare stile. Per Jasper Griffin, il mito offre alloscrittore, o al riscrittore, molti vantaggi: familiarità,vividezza, plasticità, significatività: e quindi “theattention of the audience is immediately focused on thenovelties of the details, the particular interpretation
21 Ivi, p. 168. 22 M. Bettini, Le riscritture del mito, in G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina, Lo spazio letterario di Roma antica, Roma, Salerno Editrice, 2004, vol. I La produzione del testo, p. 15.
which the artist is putting on his subjects”. Offrendo unostraordinario effetto di intreccio, il mito offre lapossibilità di suscitare “strong and simpleemotions”23connettendo, di nuovo e sempre, una storia giànota, eppure funzionante ed efficace – anche e soprattutto– proprio per la sua prevedibilità. Infatti, “myths are notjust stories, but stories of guaranteed importance. Thehuman persons who appear in them possess a special status,not only because they are familiar, but because they areexemplary”24. Col passare dei secoli, e delle riscritture,col mutamento delle condizioni sociologiche, psicologiche,epocali, l’esemplarità in parte si attenua (effettuando ilglittering mirror tanto caro all’arte antica), il mito siassimila al romanzo, si verifica magari lo “scoronamentodell’epica” percepito da Bachtin 25 , ma sempre e comunquel’inerzia della trama, la ‘storia già nota’, conferisce unaspinta formale non ignorabile agli autori che, proprio persuperare il blocco di un plot invariabile, si lanciano incombinatori, e inesauribili, effetti di forma.L’accumularsi delle narrazioni, con il loro intrecciosempre riproducibile e variabile, è proprio una dellecaratteristiche principali del mito in sé: “il mito, si sa,esiste solo per essere narrato, e narrato ancora, ciò faparte del suo destino”26: perciò, ricapitolando: una storiadi cui conosciamo il plot prima ancora di affrontarla – unplot mutevole all’infinito negli effetti, ma noto nellaradice iniziale – una particolare esemplarità del racconto– familiarità, vividezza, plasticità, significatività …Cosa manca per ascrivere l’epopea di James Bond al gruppomulticolore e eterno dei miti, e il suo protagonista allatipologia, appunto, dell’eroe?
V. Un eroe: quali tratti costitutivi? Per Alberto Camerotto(che certamente non ha ignorato, nel tracciare il profilodel suo hero’s journey, il celebre monomyth di JosephCampbell27) almeno quattro fondamentali: “gli eroi sonoeroi perché compiono erga, ossia imprese memorabili: a), le
23 J. Griffin, The Mirror of Myth: Classical Themes and Variations . The T. S. Eliot Lectures (1986), London, Faber and Faber, 1986, p. 104. 24 Ibidem. 25 M. Bachtin, Epos e romanzo , in AA.VV., Problemi di teoria del romanzo, Torino, Einaudi, 1978, p. 35. 26 M. Bettini, Le riscritture del mito, cit., p. 20. 27 Cfr. J. Campbell, The Hero with a Thousand Faces, 1949.
lotte spaventose contro i mostri: b), le battaglie e iduelli contro i nemici: c) grandi viaggi attraversol’ignoto, in luoghi irraggiungibili e attraverso pericoliinsuperabili per i comuni mortali, ai quali si aggiunge ilrischio del non ritorno, specialmente nella prova piùdifficile di tutte, il descensus ad inferos”28. Se così è, epare impossibile non approvare questa identity card, il nostroJames potrebbe essere classificato con sicurezza.Professione: eroe. E c’è di più. Già negli anni Cinquanta,Angelo Brelich aveva messo in luce che quella dell’eroe è,e rimarrà sempre, una figura “di carattere ambivalente”29,insieme fondatore e distruttore, salvatore e ambiguamentedotato di tratti mostruosi, inquietanti. Studiando lecaratteristiche di uno degli eroi costitutivi dellamitologia greca, Eracle, Geoffrey Kirk stabilì unafondamentale tabella di opposizioni (“humane-bestial, serious-burlesque, sane – mad, salutary – destructive, free – slave, humane – divine”30) che potremmo, combinatoriamente, applicare per interoalla figura di James Bond: killer spietato con tratti dimostro, specie negli ultimi episodi della sagacinematografica, ma turbato e sconvolto quando la suapartner in Casino Royale, Vesper Lynd, resta scioccata dallasua violenza: coinvolto in dinamiche fondamentali per lasopravvivenza dell’Occidente e insieme capace di pensarecon frivolezza a riaggiustarsi la giacca planando, ferito eall’inseguimento del nemico, nel vagone di un treno turcodal soffitto sfondato (Skyfall): esempio di energia evitalità sovraumane e insieme dipendente da alcool edroghe, salvezza per gli uni e rovina per gli altri, ingrado di sbandare seguendo improvvisazioni ribelli maincatenato dal carisma del suo superiore, M, e infine uomocomune e superuomo, tutte le voci hanno un corrispettivo.Potremmo chiosarle con Burkert, che asserì con eleganza che“l’eroe raggiante è nel contempo schiavo, femmina, folle”31:e nel suo percorrere faticando la ruota zodiacale di ognifatica, e di ogni impresa, come Eracle 32, proprio questoavviene a James Bond, quasi senza soluzione di continuità.
28 A. Camerotto, Come diventare un eroe, “Incontri triestini di Filologia Classica 6”(2006-2007), 257 – 287, p. 1. 29 A. Brelich, Gli eroi greci, Milano, Adelphi, 2010, p. 34. 30 G. Kirk, La natura dei miti greci, Bari, Laterza, 1977, p. 145. 31 W. Burkert, Greek religion: Archaic and classical , London, Blackwell, 1987, p. 125. 32 Secondo la felice definizione di R. Galasso, Le nozze di Cadmo e di Armonia, Milano,Adelphi
Però, al di là dei riflessi eraclei, attribuibili al personaggioin sé e per sé, a cavallo delle sue infinite avventure, un altroè il mito che impronta il film che abbiamo scelto come oggettodi questa analisi, l’ultimo della saga, Skyfall. Il regista, SamMendes, non ha ammesso equivoci, e tra le mille spie simbolichedecifrabili o meno, ne ha inserita una visibile come unriflettore. Nella scena in cui M, magistralmente interpretata daJudi Dench, è costretta a rendere conto al Primo Ministrodell’apparente fallimento e conseguente inutilità dell’MI6partecipando ad un’udienza che diventa il centro attrattore didue diversi vettori (la corsa disperata, a difenderla, di Bondper il traffico di Londra, il tenace avvicinamento, aducciderla, di Silva implacabile nella vendetta), - il momento“più politico della storia”, nell’opinione di Paolo Fabbri – ilpersonaggio pronuncia alcuni versi vittoriani, “talmente fuoricontesto da focalizzare il loro intento simbolico”33. Si trattadi una citazione dall’Ulysses di Alfred Tennyson, celeberrima:“anche se molto è già stato preso, molto ci aspetta: e anche senoi/ non siamo quella forza che nei vecchi giorni/ mosse cielo eterra, quel che noi siamo, siamo:/ un’eguale tempra di eroicicuori,/ logorati dal tempo e dal fato, ma forti nella volontà/di battersi, di cercare, di trovare, e di non cedere”.Funzionalissimi per riaffermare, nella crisi, la britannicaostinazione a una rapida ripresa, questi versi sono anche unaspia culturale: avvertono avvisano proclamano: chiedi chi eraOdisseo, e ti risponderai: adesso è Bond.
VI. Su una sola spia non si costruiscono salde connessioni, quindipotremmo dubitare della legittimità della nostra: ma le spiesono molteplici. Odisseo, si sa, è l’uomo del mare, dellanavigazione, del vento tra le vele: “tutta l’Odissea sa di mare:navi partono dal porto, ci sono tempeste, uragani, bonacce,venti favorevoli, venti infidi, navi che arrivano in porto, navimiracolose”34: navi, navi, navi: addirittura, Laura Farandasostiene che “potremmo ripercorrere l’intera Odissea come
33 P. Fabbri, Ulisse è Bond, cit., p. 4. 34 P. Citati, La mente colorata, Milano, Mondadori, 2002, p. 118. Sull’uso del mare,e della linea narrativa, dell’ Odissea nel cinema, cfr. S. Pietrosanti, ‘Un cinema che cerca per chi cerca’: per un uso della grammatica visiva in letteratura attraverso l’opera di Paolo e Vittorio Taviani , “Bollettino dell’Accademia degli Euteleti”, 2013, n. 80, pp. 79-91. Per l’attenzione con cui la cultura inglese ha riutilizzato sulla scena e ritradotto e attualizzato il poema omerico cfr. S. Pietrosanti, A. Frattali, ‘Homer’s wave machine’: Odyssey di Simon Armitage per la regia di Robert Wilson, “Dionysus ex machina”, n. 4, anno 2013.
l’epopea della vittoria di un eroe sui pericoli dell’onda”35.Incontrando il nuovo Q alla National Gallery, Bond si trova acontemplare un’icona della pittura anglosassone, The FightingTemeraire tugged to her last berth to be broken up, di J.M.W. Turner (1839).Ovviamente, nel simbolismo trasparente dello splendido velierotrascinato alla demolizione il quadro allude alla fine di unmondo, alla grande crisi che l’avvertito invecchiamento, eindebolimento, provoca nell’agente segreto fino a ieriimbattibile e instancabile: ma si tratta pur sempre, comesospira ironico Bond, di “tanta acqua e una barca, a bloody bigship”: ovvero, il fondale stabile delle avventure di Odisseo.Navi, in effigie: e questa non è l’unica. Nell’ufficio del nuovoM subentrato al vertice dopo la disgraziata fine della collegacampeggia una riproduzione di un altro dipinto navale, HMS Victory,Nelson’s flagship, at Trafalgar, sempre di Turner: l’altra faccia dellamedaglia, il trionfo e la ripresa invece dell’imminente rovina:solo i connoisseurs ricordano che, in Moonraker, era proprio questala tela che Bond trafiggeva ironicamente di freccette… Qui ètrionfante, e se potremmo pensare che si tratti di una spiavisiva, l’ennesima, per dotare di sicura sfragkis un film che èuna lettera d’amore per l’Inghilterra, altre scene cisoccorrono. Quando, a bordo della Chimera (nome ovviamente pernulla casuale sia dal lato simbolico, eterno, che da quellogreco, contestualizzato), Bond si avvicina all’isola di Silva,la scena rimanda visivamente a mille immagini archetipiche: ilmare sotto il sole, l’eroe bloccato sul ponte, e l’avvicinamentoall’isola del mostro – e addirittura la bella donna ferma comeuna polena, come una divinità protettrice – Atena, forse, o lemille altre ninfe che hanno accompagnato l’eroe dai mille viaggi– tutto si fa chiamare irresistibilmente con un nome solo… Delresto, Massimo Bonafin ci ha già ricordato nel 2008 che definirel’identità di un personaggio è un’operazione che può svolgersiin primo luogo indagando i rapporti orizzontali di quelpersonaggio con gli altri che abitano la stessa storia, ma puòanche svolgersi indagando “l’aria di famiglia che spesso ha conaltri suoi simili presenti in altri testi: una relazioneverticale o paradigmatica con personaggi di altre opere e altreepoche e altre lingue”36. Se applichiamo questo metodo, una
35 L. Faranda, Viaggi di ritorno. Itinerari antropologici nella Grecia antica, Roma, Armando, 2009,p. 55. 36 M. Bonafin, Prove per un’antropologia del personaggio, in Le vie del racconto. Temi antropologici, nuclei mitici e rielaborazione letteraria nelle narrazioni medievali germanica e romanza, ac. di A. Barbieri, P. Mura, Padova, Unipress, 2008 , p. 2.
strada precisa ci conduce da Odisseo a Bond – senza nessunrischio di smarrimento.Le somiglianze, dunque, sono in primo luogo antropologiche: Bondè un eroe che ha conservato e rinnovato alcune, o molte,peculiarità odissiache: le strade per valutare questepeculiarità sono, o possono essere, narrative: del resto,l’Odissea è, per una frangia non poco cospicua della critica, ilpoema dell’esperienza: e per tutti un viaggio, il viaggio37.Skyfall, non a caso, comincia proprio con un viaggio: “il primopiano – sequenza anticipa tutto il film; James Bond è in fondo aun corridoio, la sua figura totalmente fuori fuoco tra luciuterine. Cammina verso la macchina da presa, lento e guardingo,indistinguibile, fino all’istante in cui il suo viso raggiungeun punto di luce intensa e l’immagine va finalmente a fuoco: isuoi occhi comunicano algida chiarezza e determinazione, èuscito dal limbo”38, pronto alla sua prima partenza: e tutto èsubito viaggio: prima l’inseguimento del killer, in acrobazia, sultetto del gran bazar – poi replicato dallo spostamento delvettore stesso, il treno in corsa e infine – il viaggio piùgrande: la katabasis. È un tratto fondamentalmente odissiaco: il viaggionell’oltretomba. “La discesa agli Inferi dell’eroe omericoappare anche come emblematica conquista culturale di un tempostorico consacrato all’ineluttabilità del divenire. Attraversol’immersione iniziatica nel regno dei morti, fronteggiando losguardo dolente di una madre-ombra, il sapiente Ulisse potràriformulare il tema della nascita oltre le soglie profetichedelle acque umbratili. Potrà emergere dal buio alla luce,sottomettendo il tema della nascita all’ideale della ‘bellamorte’ eroica”39: e lo stesso avviene in Skyfall. Preda della manogigantesca di una donna, o dea, sconosciuta, che lo riduce a unostato minuscolo, fetale, introiettato, Bond sprofonda in un aldi là d’acqua, dove, svenuto e senza controllo, deve affrontarela propria peggiore paura: sé stesso, la verità su di sé. Nelfrenetico balletto di difesa che cerca di compiere non spara ainemici, ma alla sua stessa ombra, allo specchio o proiettata sulpavimento: colpito, ferito (la bocca rossa dello sparo appenaricevuto è sempre visibile, una specie di stimmataidentificativa come la ferita del cinghiale sulla gamba di
37 Cfr. in merito G. Chiarini, Il viaggio nella letteratura greco – latina, in F. Rosa, F. Zambon, a c. di., Pothos. Il viaggio, la nostalgia, Trento, Editrice Università degli Studi, 1995, p. 68 e sgg. 38 M. Mazzitelli, Bond sulla linea d’ombra, Com.Unità, 27 Novembre 2012, p. 1. 39 L. Faranda, Viaggi di ritorno, cit., p. 55.
Odisseo, un mezzo per dire io sono), lotta con se stesso,affrontando la propria inadeguatezza, la propria fallibilità,enjoying the death. E questo tuffo agli Inferi, questa caduta dalcielo non è univoco: ha in sé una capacità di rigenerarsi,duplicandosi in variazioni, che fa pronunciare nuovamente laparola mito. Ecco Bond, appena resuscitato, nuotare in unapiscina blu che dovrebbe purificarlo prima della revenge che avràluogo a breve. Eccolo precipitare volontariamente nell’acquagelida del lago scozzese ricoperto di ghiaccio, dal qualeriemergerà per l’ultimo colpo, per presentarsi puntuale al suofinale di partita. Ed eccolo, nella sequenza più evocativa ditutte, lottare col nemico finalmente raggiunto in una Shanghaitotalmente blu, fantasmagoricamente rabbrividente, un fondo delmare silenzioso e totale, dove la luce – medusa palpita piano,un’altra katabasis, invertita questa, che si concluderà in unaperfetta Ringkomposition con la caduta dal cielo, priva diresurrezione stavolta, dell’alter ego dell’eroe, il nemicosconfitto. E del resto, nella dominante blu della sequenza, enel fatto che siamo di nuovo penetrati in un’altra dimensione(su, questa volta, verticale, grazie all’acrobatico aggrapparsidi Bond all’ascensore vicino a quello preso dal killer)riconosciamo che altitudo equivale a profondità, e che cielo emare coincidono, possono coincidere, si cade dal cielo, sisprofonda nel mare, nel mare infinito della nostra interiorità.Katabaino, in greco, significa questo: cadere verso il basso,sprofondare: nel cielo, nel mare, in noi stessi.
VII. La critica al completo non ha mancato di rilevare che unodei motori dell’azione in Skyfall è proprio il suo procedere“a passo di gambero”40: quando M, trascinata viadall’udienza da Bond e imbarcata sulla celebre AstonMartin, si informa su dove il suo quasi rapitore intendaportarla, James risponde che da quel momento in poi siprocede back to the past: e, geograficamente e concettualmente,proprio questo avviene, visto che l’auto coi due personaggisi muove verso la dimora scozzese di famiglia, le tombe deigenitori di Bond, e, più indietro, verso tecniche di lottaben distanti da quelle contemporanee, la tatticadell’assedio, la battaglia frontale, la scelta dello
40 P. Fabbri, Ulisse è Bond, cit., p. 2. Si dice del resto che il regista Guy Hamilton, che ha diretto quattro Bond- movies, abbia suggerito al proprio sceneggiatore Tom Manckiewicz che poteva tranquillamente avvisare i pompieri prima di far scoppiare un incendio perché, in questa categoria cinematografica, “everything works backward”.
scontro all’arma bianca: indietro alle radici di tutto.Sale alle labbra un’altra parola tipicamente omerica:nostos, il ritorno. È il vero motore dell’azione di tutta lapellicola. Il protagonista esegue il suo privato nostos dasubito: messo alla prova dalla sua katabasis marina, naufraganel locus amoenus di una sconosciuta isola dove lointravediamo consumare sesso veloce con una fiacca Calipsoe poi rintronarsi di alcool e pillole, e sfidare l’unicasorte, l’unico kleos che ancora gli rimane per divertire gliavventori di un bar da spiaggia che scommettono sulla suasopravvivenza nella sfida contro uno scorpione: ma untecnologico messaggero degli dei, incarnatosi senza saperlonel giornalista della CNN, lo richiama al suo destino,mostrandogli la sede dell’MI6 sotto attacco: è tempo diriprendere il viaggio, di salpare di nuovo, rinunciandoalla tentazione della resa o all’autodistruzione. Da lì,ancora più indietro: dopo l’udienza, “this is Bond at hisslow point – Silva is free, M is in danger, any place witha computer is unsafe. The only thing he can do is to gohome”41. Incapace di prevalere altrimenti alla sfida diSilva, Bond deve arretrare ancora, tornare alla sua Itacapossibile, la casa di famiglia, Skyfall: là avviene unriconoscimento ancora odissiaco, l’incontro colguardiacaccia Kincade, un aiutante alla Popper che forniràl’arma di base, quella che sola servirà a concluderedefinitivamente lo scontro: un pugnale, nient’altro che unpugnale.
Ma, ci avvisa Gian Biagio Conte, una parola, contenuta con tuttala sua nuvola di senso nel dizionario, anche se “quando esce daldizionario ed entra nel testo, acquista una sola delle suepossibili accezioni”42, è in grado di trascinarsi dietro unanebulosa di suggestioni non dette che però sono là, a costituirelo sfondo inconscio dell’interpretazione. Nostos è una delleparole chiave di Skyfall, considerando, ad esempio, il modo in cuiviene costruito il personaggio di M, che, sia per età anagraficache per carisma e valenza narrativa, è leggibile come una madreper Bond e per il suo rivale Silva: quest’ultimo addirittura lachiama così: “Mommy was very bad”, dice ironico a Bond sconfittotemporaneamente e legato alla sedia. Orfano dei genitori, privodella madre naturale, Bond è attirato a tornare a questa madredi sacrificio che ha accettato la sua morte (M lo ammette quando
41 T. Alcott, Skyfall part. 7, www.toddalcott.com, 16/01/2014, p. 5. 42 G.B. Conte, Virgilio, l’epica del sentimento, Torino, Einaudi, 2007, p. 76.
Bond si fa trovare nel suo appartamento, dichiara che, fraperdere tutto, o perdere eventualmente un solo agente, avevascelto la via meno costosa, pronunciando il decisivo ‘take thebloody shot!’ – e, convinta dell’etica del sacrificio, afferma chenon pronuncerà nessuna bloody apology) e verso la quale si sviluppauna tensione edipica che è la vera forza sotterranea dellapellicola – molto di più dell’attrazione fugace verso le varieBond girls. Come il suo status vuole, Silva reduplica eingigantisce, da antagonista, quanto nel protagonista è menoesibito, e proclama a gran voce la sua pulsione verso la madre,a metà tra un desiderio archetipico di tornare bambino,rientrare tra la braccia, nella considerazione, nell’utero dellagenitrice, e un desiderio sessuale non dichiarato ma evidente –nell’ultima scena, ad esempio, quando stringe M tra le braccia ele propone di ucciderlo e uccidersi con un unico colpo dipistola – una piccola grande morte, un orgasmo che diventerebbemorte, amore e morte, in breve, all’estremo livello. In Bond, lapulsione è meno esibita (anche se l’apparizione di Daniel Craigstravolto di stanchezza, angoscia e alcool in casa di M ha unpotenziale ambiguo efficacemente sottolineato dalla perfezionecon cui Judi Dench ritma la sua battuta in chiusura di scena:“well, you’re bloody well not sleeping here - certo non dormirà qui”), mamolto più raffinatamente, simbolicamente elaborata: a che altroallude, in fondo, la katabasis acquorea, questo sprofondamentoarchetipico, se non che al nostos più radicale di tutti, tornarenella madre – mare che ci ha creati, e può farlo di nuovo, sesolo – volesse? C’è una disseminazione di nostoi in Skyfall, filmpotentemente archetipico in cui tutti vanno all’indietro: Bond eSilva, e anche M, che accetta di partire con James, anche lei,in un viaggio verso l’ignoto – che la porterà invece versol’area più nota, e insieme inimmaginabile, che tutti affrontiamo– la morte. L’inquadratura di M morente, riversa tra le bracciadi Bond affranto, con le luci gialle della cappella che aiutanoa sfalsare i piani e a localizzare magnificamentenell’immaginario questa Pietà invertita, alla Caravaggio,risulta affascinante: “I did get one thing right, qualcosa di buonol’ho fatto,” commenta l’agonizzante, lasciando apertal’interpretazione: che cosa? Farsi amare dal proprio figlio,farsi accompagnare quasi aldilà dei confini da lui? Morire perlui, per nostalgia di lui, come dichiarava di aver fatto, secoliprima, Anticlea per Odisseo, stridendo di rimpianto per l’animadel figlio sulle soglie degli Inferi?
VIII. Di lato, comunque, a questo movimento archetipico –all’indietro, verso l’inizio, o la fine capovolta – Skyfallannovera almeno altri due movimenti, complementari. Unoorizzontale, i grandi inseguimenti, le grandi cavalcate –in moto sul tetto del gran bazar, sul treno in corsa cheriduce a balletto la lotta delle piccole figure umane, unmeandro dopo l’altro, oppure, livello ultimo, di base -l’affannosa corsa di Bond, con le sue molteplici repliche(per le vie di Londra cercando di salvare M in pericolo,lungo i cunicoli della metro inseguendo Silva appena evasosotto la guida di Q come un avatar di un videogame, nellabrughiera scozzese verso l’ultima luce prima della finaleoscurità). È un movimento lineare, volitivo, razionale, unmovimento che si rifà al Bond classico, vincente, sicuro,eroico. C’è poi un altro movimento, verticale, ma nonun’ascesa, una caduta: la prima, archetipica, nellacascata, replicata da Patrice dal millesimo piano delgrattacielo, e poi ancora Bond, prima sotto e poi sopra illago ghiacciato – e questo è un movimento involontario,fatale, profondo, irrazionale, intimo, il movimento delnuovo Bond che deve tuffarsi nella crisi, farsi male,cambiare, ripensarsi, modificarsi, rinascere. Tutti e due imovimenti laterali sono tipicamente odissiaci – ricordiamoOdisseo tessitore di inganni, grande guerriero, vincitore esignore della guerra – e Odisseo naufrago, trasportatodalle onde e dai venti, sofferente per destino, infine“bello di fama e di sventura”, non di gloria e di vittoria.O non solo. Sono ambedue modalità estremamente epiche diconcepire il movimento narrativo: per Nancy Felson Rubin,nel corso della performance epica il pubblico venivacondotto dall’arte e dalla tecnica dell’aedo a formularedelle ipotesi, delle previsioni (adduction) che avrebbe poivagliato via via che la narrazione lo avrebbe aiutatofornendogli nuovi dettagli, conducendolo in nuovi set:caratteri e intreccio si sarebbero evoluti in modocomplementare, e quindi sarebbe necessario connetterel’indole dei personaggi con la percezione delle strutturenarrative. Di qui la constatazione che Omero “first setsforth a rather standard or conventional way of thinking andthen undetermines or challenges it in subtle ways” 43:
43 N. Felson Rubin, Regarding Penelope: from character to poetics, London, Cloth, 1994, p. 76.
proprio quanto avviene nello speciale entrelacement di Skyfall.Ad esempio, il movimento orizzontale, la corsa di Bondesemplarmente veloce, può complicarsi quando tocca la sferaproblematica, interiore, e produrre un nuovo schema,imprevedibile, che assomma tutte e due le modalità (Jamesche corre a perdifiato nel passaggio segreto sotto labrughiera, per salvarsi dall’incendio da lui stessoscatenato e dall’esplosione imminente). Questa volta, lacorsa positiva e propositiva diventa invece processo dicambiamento: anzi, di rinascita, perché il procederedoloroso, testa in avanti, meandro dopo meandro, in unbudello oscuro, è simbolico di rinascita, che staavvenendo, che è in atto. D’altro canto, durantel’inseguimento di Silva nei corridoi della metro londinese(un ennesimo tuffo sotterraneo? Forse…) lo scivolarevertiginoso di 007 lungo la scala mobile, a precipizio,sebbene evochi un’ennesima, simbolica caduta dal cielo, lacambia di segno, rendendola una volta tanto l’oppostodell’archetipo: un trucco, un espediente razionale, ilbisogno di accelerare al massimo il proprio avvicinamento ecatturare l’avversario: nulla di divino, nulla di fatale,come le altre sequenze ci avevano invece autorizzato apensare.
La coazione a ripetere il doppio movimento, peraltro, appareaddirittura contagiosa: dall’umanità alle macchine: il movimentodal basso verso l’alto, ad esempio, viene replicato in tecnichecadute (l’elicottero di Silva che esegue un personale skyfallsulla casa in fiamme, il convoglio della metro londinese chederaglia per schiantarsi clamorosamente a livelli maggiori diprofondità davanti agli occhi ironici di Silva, sconvolti diJames) . Ugualmente, quello in orizzontale si affida a diversimezzi di trasporto: la Land Rover della scena d’apertura, lamoto della prima sequenza, l’Aston Martin mitologica, infine,che assurge, durante l’assalto del commando di Silva a Skyfall,quasi al livello di un cavallo di Troia, nascondendo Bond al suointerno e permettendogli di usare tutti i congegni disponibiliper bersagliare di colpi i nemici ignari – ed esplodere, poi, inun definitivo addio a un’altra epoca che vediamo tramontare inun ultimo lampo di fuoco luminoso. Certamente un tale tentativodi analisi potrebbe apparire esagerato, voluto, artefatto: maSeymour Chatman era stato il primo ad avvisare che “il ruolo cheun personaggio interpreta e le parole con cui è rappresentatonel testo (o le battute che pronuncia nel film) non bastano a
spiegare le implicazioni, le inferenze e le interpretazioni cheil pubblico legittimamente ne trae”44, e che gli giungono datutt’altro, dal movimento, dalle luci, dalla simbolica, dalla‘relazione d’incanto’ che nel buio della sala lega l’audience alfilm, e il film alle grandi tappe della storia della cultura,della mentalità, della vita.
IX. Tuttavia, ancora nella sfera del ‘ritorno all’indietro’ -il passato, se esiste e costituisce una sfera essenzialenelle nostre vite, occupa anche un posto privilegiatonell’identità di stati e nazioni, permettendo loro dicreare un mito di sé, una propria fisionomia, emanando unaserie di messaggi interpretativi che costruiscono il birthcertificate di un popolo o di un altro. La tradizione,inventata e conservata, talvolta disprezzata, ma semprepotente, è in Skyfall uno dei punti base dell’arco di cerchioche la collega, polemicamente, alla modernità. L’interofilm potrebbe, con ogni evidenza, essere letto comeun’esemplare interazione tra modernità e tradizione. Quandola modernità si rivela pericolosa (il cyberattacco all’MI6,ad esempio) è nella tradizione che troviamo la salvezza(rifugiandoci nel bunker di Churchill, in questo caso).Quando un esercito di invasori high-tech si scatenatempestosamente contro di noi, ci salveranno oggetti ditradizione – vecchi fucili, un coltello. Anchel’Inghilterra deve tornare indietro, eseguendo il suopersonale nostos: non può illudersi di fare a meno dellapropria tradizione, non può pensare di eliminare il suogruppo di agenti segreti come inutile e obsoleto, perché ilpericolo sussiste, è semplicemente slittato da identitàdichiaratamente nemiche a pericolose ombre, contro le qualiè solo back to the roots che possiamo difenderci. Se “age is notguarantee of experience”, come sostiene Q, e “youth is not guaranteeof innovation”, come ribatte Bond, lo stesso non ci sonodubbi. Non esistono. Ce li dissolve tutti l’ultima scena.In una mattina di sole – la prima sull’Inghilterra semprepiovosa e nebbiosa durante la crisi di Silva – Bondcontempla, in una scena che deve molto al linguaggio visivodi Christopher Nolan in The Dark Knight45, un perfetto skylinelondinese con tanto di bandiera sventolante: riceve, dalle
44 S. Chatman, Storia e discorso. La struttura narrativa nel romanzo e nel film, Parma, Pratiche Editrice, 1981, p. 45.
mani presenti di Eve e da quelle, lontane, di M, iltestimone della tradizione, il China nick nack bulldog diChurchill: ed è pronto a tornare al lavoro. Pochi minutidopo il nuovo M glielo conferma: c’è un’infinità di lavoroda fare. Back to the future.
X. Passato e futuro – comunque sia – sono mare, lo abbiamoreiterato, e - il mare, si sa, non è mai vuoto: Odisseo,figlio di un Argonauta, lo seppe da subito, e ora lo hannoimparato anche gli spettatori. Se il mare odissiaco è culladi divinità ( gli dei azzurri, Poseidon in primo luogo), èanche una ininterrotta galleria di mostri. E anche Bondtroverà via mare il suo mostro, Silva, che abita inun’isola di macerie, dove tutto quello che è normale sembrasovvertito, dove le statue crollate sembrano evocaregiganti distesi su un fianco – e dove, però, è possibiletrovare una tale concentrazione di computer dacondizionare, come dice ironico Silva, “i risultati delleelezioni in Uganda? Fatto…”. Su quest’isola di crolli abitaun mostro simile a Polifemo per varie caratteristiche. Laprima, paradossalmente, è proprio l’ordine, la razionalitàcibernetica. Anche il gigante monocolo dell’Odissea ha ilsuo logos, e quando Odisseo ispeziona la sua grotta non puònon notarlo, non ammirare la precisione e l’abilità con cuil’abitatore della caverna ha separato i piccoli agnelli daquelli di media età e dai più grandi, o il caglio dalsiero, con metodo e chiara abilità. Si tratta però di unlogos altro, lontano da quello condiviso dal resto dellacultura greca (noi, contro loro): manca il rispetto perl’ospitalità, manca il tabu relativo al cannibalismo: e unaparabola di cannibalismo racconta Silva, nel suo sensuosodiscorso che lo accompagna avvicinarsi a James legato allasedia, sequenza che reduplica la prima di Bond e che, nellastoria dei due ratti, serve proprio a inserire i palettidella reciprocità fra i due protagonisti. Un link ulterioredi collegamento alla nebulosa del cannibalismo lo fornisce
45 E qualcosa anche, probabilmente, all’Ulysses di Tennyson, il quale, nonostanteproclamata forza di volontà e di ripresa, resta pure, secondo Gregory Tate, in qualche modo “a listless and melancholy figure on the shore. He is stuck in a sort of limbo, looking back on the fading glories of the past and facing an uncertain future. This is a peculiarly Victorian state of mind, but, according to Skyfall, it might also be characteristic of twenty-first-century Britain” (Surrey English Blog, 11 Aprile 2012.
la scena dell’imprigionamento di Silva, chiuso in unagabbia di vetro che non può non evocare la cella diHannibal Lecter ne Il silenzio degli innocenti – e Hannibal, si sa,si definisce come il più affascinante, inquietantecannibale dei nostri tempi. Dentro la sua culla di vetro,Silva svela finalmente la sua parte mostruosa: la capsuladi cianuro malfunzionante non lo ha ucciso, ma solosfregiato, e la mascella distorta insiste proprio sullacostruzione dell’immagine di un mostro divoratore.
Insieme cannibale e tecnico raffinato, Silva è l’alter ego diBond, come la sceneggiatura si preoccupa di suggerire decine divolte. Orfani ambedue, splendidi agenti ambedue, collegati a Mda pulsioni edipiche forti e da lei traditi, in competizionefatale. Potrebbero addirittura conoscere un contatto sessuale,come sembra proporre la scena (un succès de scandale) in cui Silvasbottona carezzevole la camicia di James, gli passa carezzevolele mani sulle cosce. Ma non si procede in questa direzione, eforse non sarebbe stato neppure necessario46. L’intimità evocatada Silva è già in atto. Lo è nelle tappe dell’avvicinamento cheBond ha attuato per trovarlo, e che hanno comportato la morte dimolti, anche della donna condivisa, tramite per Bond perarrivare all’avversario, e sacrificata da Silva con uno sparo inpiena testa – a waste of a good scotch, commenta cinico Bond. Lui eSilva sono legati dall’intimità di un sentimento forte quantol’amore, una strana specie d’amore che sbotterànell’inevitabilità dell’autoeliminazione. Non esiste vicinanzapiù prossima…
XI. L’amore obliquo di Skyfall prende strane vie, a partire daquella appena nominata, la tensione attrattiva e repulsivadi Silva verso Bond e viceversa. La vera calamita, la veraforza, la home a cui entrambi, protagonista e antagonista,vogliono tornare, la vera Itaca di ambedue, è M,contenitore chiuso d’amore che ambedue non riescono adaccettare di non sapere aprire. Ma il genere ha le proprieregole, e un film di Bond non sarebbe tale se il
46 Del resto, la tensione omosessuale tra avversari sembra avere un proprio spazio canonico nel cinema contemporaneo. In uno degli ultimi film su Sherlock Holmes, A Game of Shadows, Holmes trascina via Watson dal proprio matrimonio, una specie di ‘ratto della sposa’ capovolto, e celebra in varie sequenze la propria attrazione per Moriarty – attrazione che verrà ribadita in scene chiarissime nell’ultima serie BBC su Holmes, che vede come protagonista Benedict Cumberbatch, attratto visibilmente dal proprio nemico e per lui altrettanto evidente oggetto di desiderio.
protagonista non si concedesse, classicamente, a variescene appassionate durante lo scorrimento della pellicola.L’incontro con Eve, sebbene raffinato e gradevole, non sidimostra devastante: visivamente molto più incisivo risultail personaggio di Sèvérine. Umberto Eco lo inserirebbesenza esitazioni nel cliché della Bond – girl, che dev’esserebellissima, ferita dal cattivo e in suo possesso,redimibile e salvabile da Bond, che poi, fatalmente, laperderà. Così infatti è per Sévèrine, almeno locomprendiamo nella breve biografia che Bond ne traccia:“facevi parte del traffico sessuale a Macao, vero? Quantianni avevi, dodici? Tredici? E poi lui ti ha liberato,magari credevi anche di essere innamorata…” Ma l’episodioconosce insieme una inudita velocità – la ragazza muoresubito, appena adempiuto il suo compito di funzionare davettore Bond – Silva, senza avere neppure il tempo didiventare un personaggio – e un più di bellezza, di poesiavisiva. La prima volta che intravediamo Sévèrine, questoavviene con gli occhi di Bond, che la rintraccia, senzasaperlo, in un ritratto che la evoca e la esalta: la Donnacon Ventaglio di Amedeo Modigliani. Il ritratto si trova inun appartamento di fronte a quello nel quale Patrice si èappostato per uccidere qualcuno che è stato adescatoproprio dalla possibilità di comprare il quadro (cheinfatti è stato rubato a Parigi nel 2010): con le sue lineeallungate e l’incomparabile femminilità di ogni tela diModigliani, e con in più il particolare sorrisomalinconico, asimmetrico e distaccato che Lunia Czechowska,la modella, regalò al proprio pittore, la tela evoca ilviso della donna viva che le è accanto, identica bellezza eidentico destino. Un cammeo prezioso per un breve episodio,più raffinato del previsto e dolcemente compiuto: forsequalcosa del rapporto tra Modigliani e la propria modellaslitta sulla trasposizione cinematografica, se è vero cheil pittore tracciò il primo nucleo di questa tela chiedendoalla ragazza di sollevare un attimo la testa e scrivendopoi, sotto il disegno appena creato, che “la vita è un donodei pochi ai molti: dei pochi che hanno e che sanno aimolti che non sanno e che non hanno”. Qualsiasi forma dibellezza si trasmette così.
XII. I tratti ‘odissiaci’ in Skyfall costituiscono dunque unanebulosa, una sorta di pulviscolare connessione di
particolari in grado di collegare ripetutamente le duefigure. Ma c’è un’altra somiglianza, evidente più di tuttele altre e forse più di tutte sfuggente, che costituisce lachiave di volta del rapporto. Non balza agli occhi se sianalizza l’Odisseo del poema eponimo, anche se “plusieurspassages de l’ Iliade présentent d’ailleurs Ulysse comme unhomme d’age mur, riche de l’expérience qu’apportent lesannées: lui-meme rappelle à Achille qu’il est son ainé eten sait plus que lui” 47: l’evidenza aumenta se ci riferiamoinvece ai protagonisti delle riscritture di Dante,Tennyson, Pascoli, gli autori delle cosiddette secondesOdyssées 48: l’anzianità dell’eroe. Dopo mille prove e millecimenti e mille viaggi, Odisseo non è più giovane. Haperduto l’energia, la fiducia, l’imbattibilità dellagioventù, ha misurato la sua fragilità, anche la suasolitudine, e la paura. Così succede a Bond nell’ultimofilm: “cosa ne sai della paura?” gli domanda Sèvérine:“tutto,” risponde lui, sincero. Il suo corpo lo tradisce,non concedendogli i consueti risultati nei testpsicoattitudinali: la mano gli trema, sparando: quandoTanner vorrebbe continuare a parlargli mentre fa esercizidi sollevamento, dichiara che è meglio che il colloquiocontinui dopo e, una volta rimasto solo, crolla a terra inuna sequenza che, incorniciandone il corpo sfinito,piegato, nel profilo d’acciaio dell’attrezzo ginnico comein una macchina di tortura, è estremamente evocativa. Comenell’ Odissea, la realtà è qui un sistema con cui fare iconti: l’indebolimento fisico va accettato, comel’ineluttabile sorpasso che gli altri compiono su di noi, oil tradimento che ci ferisce: come Odisseo qui Bond riescea morire e risorgere, a elaborare le proprie finitezze, asuperarle, accettando di essere solo, di avere solo séstesso su cui contare: sé stesso e la propria mentemultiforme, sé stesso e la propria inesauribile capacità disoffrire.
XIII. Ma, in questo labirinto di segnali che è Skyfall, un altrobrilla di luce propria: il nome del successore di M, “the newChairman of Intelligence and Security Committee, a charming man, I think you and heare really going to hit it off”, ironizza Tanner presentandolo a Bond –
47 C. Jouanno, Ulysse. Odyssée d’un personnage d’Homére à Joyce, Paris, Ellipses, 2013, p. 16. 48 Ivi, p. 391.
questo nuovo M si chiama nientepopodimeno che – Gareth Mallory.Un nome come un altro? Forse: ma forse no. Gareth Mallory, perchiunque sappia qualcosa di letteratura inglese – e Sam Mendesha studiato a Cambridge… - evoca immediatamente un altro nome,un altro sfondo. Nel nono anno del regno di Edoardo IV, al tempodella Guerra delle due Rose, ser Thomas Malory, un avventurierocondannato per violenza e rapine, riandando con la memoria alregno di un mitico sovrano e all’epoca ormai lontana dei grandiideali cavallereschi, scriveva imprigionato nella Torre la Storiadi Re Artù e dei suoi nobili cavalieri. Pubblicata nel 1485 da WilliamCaxton, il primo stampatore britannico, l’opera raggruppa ottoromanzi in prosa che Malory trasse dal più celebre ciclo dileggende medievali – gli incantesimi di Merlino e di Morgana laFata, gli amori di Lancillotto e Ginevra, la passione infelicedi Tristano e Isotta, la ricerca del santo Graal – e, avendosostituito alla complessità strutturale delle narrazionicicliche francesi, i cui temi si alternavano rincorrendosi eripetendosi, una prosa continua e coerente e uno stile “terso eobiettivo”49, la saga divenne ben presto universalmentepopolarissima. Il primo link tra i due omonimi, quindi, scattasubito a livello di condizione biografica, senza neppure bisognodi calarsi all’interno dell’opera. Come Thomas Malory è uncavaliere che scrive, forse nostalgicamente, di altri cavalieri,quando non può più cavallerescamente operare (è prigioniero, ela sua opera si chiude con una supplica a Dio affinché gli vengarestituita la libertà) così il suo quasi omonimo (Gareth, tral’altro, è un nome parlante, il nome di uno dei cavalieripresenti nel testo quattrocentesco, il protagonista del libroVI, Storia di Ser Gareth di Orkney che fu chiamato Bellamano) è passato allavoro d’ufficio dopo anni di servizio attivo e dopo unasofferta prigionia nelle mani dell’IRA: ma in caso di bisogno,come durante la sparatoria che interrompe l’udienza, riesce aricordarsi le proprie radici, intervenendo per proteggere M acolpi di pistola e rimanendo ferito: e a cambiare, passando daantagonista (la sua prima scena era stata quella in cui avvisavaM del suo prossimo licenziamento) a collaboratore (qualche scenadopo la sparatoria frenetica, cogliendo Q e Tanner che tentanodi depistare elettronicamente Silva dalla pista di M e Bond, liincita a proseguire anche se, come dichiara, se il PrimoMinistro ne venisse informato, ‘saremmo tutti fottuti, allbuggered. Carry on…’).
49 M. Praz, Storia della letteratura inglese, Firenze, Sansoni, 1983, p. 53.
Segnali, dunque, non ignorabili. Il primo è il nome delpersonaggio. È un riflettore su un’ulteriore identificazione:come avveniva con Bond- Odisseo, adesso la corrispondenza siinnesta su Artù. In molte sfaccettature. Come il mitologico re,anche James è orfano, allevato, lo sappiamo dai romanzi diFleming, da una zia affettuosa, come Artù da ser Hector. Come ilsuo predecessore medievale è aiutato e controllato da unaiutante magico, il mago per eccellenza, Merlino, così qui è ilnuovo addetto all’approvvigionamento, il giovanissimo Q, apassargli una ‘magica’ pistola che ‘riconosce’ la stretta delsuo proprietario, funzionando solo per lui – proprio come laspada nella roccia avrebbe obbedito solo alla mano del destinodel futuro re d’Inghilterra, lasciandosi svellere senza opporreresistenza. Come la dama del Lago passerà ad Artù Excalibur,così il guardiacaccia Kincade gli consegnerà il pugnale che,nella scena finale, consentirà finalmente all’eroe disbaragliare il proprio nemico nella forma più drastica delloscontro, quello a distanza estremamente ravvicinata, quasi‘corpo a corpo’. E ancora oltre. Nei titoli di testa che illustrano la katabasis,Bond potrebbe citare alla lettera il sogno di Artù: “gli parveche un drago terrificante, giunto in volo dalla parted’Occidente, affogasse molta della sua gente. Esso aveva latesta smaltata d’azzurro e le spalle che brillavano come oro, ilventre simile a maglie di straordinari colori, la coda copertadi scaglie, le zampe di splendido zibellino e gli artigli comeoro fino: dalla bocca gli scaturiva un’orrenda fiamma che facevaapparire di fuoco la terra e il mare”50. La scena in cui Bond,fermo in piedi sulla prua della piccola barca, deve penetrarenelle fauci del dragone per accedere al casino di Macao(all’interno del quale, peraltro, altri, viventi, draghi diKomodo lo assalteranno poco dopo), ha un’eco estremamente epica,che lo scintillio coloristico dei rossi e dei gialli sottolineaal meglio. E se il drago è un animale simbolo di Artù Pendragon,altrettanto potremmo dire del cervo, che orna, scolpito, lacolonna d’accesso al viale della tenuta di Skyfall. Nellasimbolica celtica è estremamente importante (ad esempio un diogallico si chiama Cernunnos, ‘colui che ha la cima del craniocome un cervo’), anche in epoca di contaminazione cattolica,perché san Patrizio si trasforma in cervo per sfuggire alleimboscate del pagano Loegaire, grazie all’incantesimo detto feth
50 T. Malory, Storia di re Artù e dei suoi cavalieri , Milano, Mondadori, 1985, p. 136.
fiada, che procurava l’invisibilità e la trasformazione 51. Se erasimbolico di longevità e di abbondanza, il cervo era anche, inarea celtica, uno psicopompo: il Morholt d’Irlanda, zio diIsotta, è raffigurato giacente, cucito non a caso in una pelledi cervo: eppure, con la rigogliosa rinascita delle corna, èun’icona di vitale immortalità: e se, magari nella propriaversione candida, balza davanti alla Tavola Rotonda alla qualesono assisi Artù e i suoi cavalieri, basta seguirlo per avere lagaranzia di essere guidati verso meravigliose, complicateavventure. Ma le somiglianze tra James Bond in Skyfall e il mitologico KingArthur sono assai più profonde – più complesse. La morte di Artùsembra avvenire per ferita di spada, un colpo micidiale inflittodalla mano di Mordred, figlio dell’incesto avvenuto tra lostesso re e la sorella Morgana: morte dovuta quindi al colpo diqualcuno insieme troppo lontano e troppo vicino, troppo uguale einfinitamente diverso, specchio e lastra deformante – come Silvarispetto a Bond52. E invece, la morte di Artù non è una veramorte. Artù sparisce in un lago, e rimarrà lontano – assente,dormiente – finché la patria non avrà bisogno di lui: alloraritornerà. Nel 1191, quando Riccardo Cuor di Leone stavapartendo per le Crociate, la tomba non identificata di Artù fuscoperta presso l’abbazia benedettina di Glastonbury, nelSomerset. Una cronaca coeva, il Chronicon Anglicanum di Raoul diCoggeshall, ci informa che i monaci avevano rinvenuto la tombadi Artù insieme a quella di Mordred e di Ginevra, e sulla lapidedel sepolcro regale era incisa la seguente iscrizione: Hic iacetinclitus rex Arturius, in insula Avallonis sepultus. Sembra esservi una chiaraallusione alla sparizione del sovrano, ricoverato nell’ isola diAvalon (insula Pomorum quae Fortunata vocatur53), un locus amoenuscircondato dalle acque in cui il re può spendere l’eternità in
51 J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, Milano, Rizzoli, 1997, I, p. 255. 52 Un modello forse ancora più funzionante per il link Bond- Silva sarebbe l’antagonismo tra Balin e Balan, fratelli, speculari l’un l’altro, di cui il primo, Balin il Selvaggio, è definibile come “a near- tragic monster of self-destruction, carrying along with him his own twin brother”(B. Gates, Victorian suicide: mad crimes and sad histories, Princeton University Press, 1988, p. 234.). La tragica storia di somiglianza e di autodistruzione sarebbe, per vari critici, alla base dell’ispirazione di Stevenson per Jekyll ed Hyde. 53 L’etimologia del nome sembra collegarlo con la parola apple, quindi Avalon come isola delle mele, della frutta miracolosa, dell’eterna estate. Si ricorda inoltre nella stessa cronaca che un albero di mele d’oro copriva sia la tomba dire Artù che quella della regina Ginevra, perfettamente preservato ma pronto a cadere in polvere non appena i monaci scopritori lo sfiorarono.
riposo, in attesa, almeno, di tornare al proprio paese quando vene sarà bisogno. Artù, infatti, non è mai morto: soltantosparito. Lo sa bene Geoffrey de Monmouth, che raccontandonel’ultimo combattimento scrive: “and there was Arthyr woundedmortally and from the midst of Kam Lan he was borne and wentthence to Ynys Avallach to be healed. And there is no said hereof the death of Arthyr more than this”54 . Anche Malory non mancadi menzionare “the passing of King Arthur to Avalon in a bargewith his half-sister Morgan-Le Fay “, e di informare che sullasua tomba era scolpito un motto profetico: “hic iacet Arthurus,rex quondam rexque futurus”55. Ferito, non morto: sparito, nonmorto: e pronto a risorgere. Destino comune a molti sovrani,quest’ultimo, una mitologia europea che attraversa i secoli e leregioni: Napoleone non muore a Sant’Elena, è ancora vivo eimpegnato ad arruolare nuove armate: il re Sebastiano diPortogallo, sparito in un combattimento nel 1578, ritornerà acacciare gli spagnoli dal reame: il principe Dimitririvendicherà la corona di Russia nel 1604 dopo essersivolatilizzato nel 1598. È un topos di enorme spessore, un sovranoche svanisce (si nasconde in una caverna, in fondo a un lago, inun mondo paradisiaco), si addormenta, si allontana – e poiritorna: “lorsque la justice l’exige, ce prince avisé revientrétablir le bon droit”, scrive Yves-Marie Bercé, che hafinemente indagato il mito de le roi caché56. Questo tema, notaGeneviéve Béduneau, “se retrouve dans les contes et les grandsmythes. C’est Oedipe abandonné sur la montagne, Arthur caché parMerlin dés sa naissance”57, e anche Bond: non manca nessuntratto: sono tutti presenti, il tuffo fatale nella cascata, iltradimento, il soggiorno sospeso nell’isola perduta, il ritorno.
XIV. E comunque, poiché tutto si tiene, e come ultima lezione diquesta indagine potremmo avvederci di quanti spazi sono comunitra un mito e l’altro, di come rimangano archetipici, di come siincastrino e si sostengano e costruiscano un tessuto di rimandi
54 Nella battaglia di Camelot, a cui si allude qui, muoiono altri re, il sovrano di Norvegia e quello di Danimarca, ad esempio, “et là aussi Arthur fuit mortellement blessé et de la melée de Kam Lan il fut emporté et alla à Ynis Avallach pour y etre gueri”. Historia Regum , èd. Griscom, p. 501. 55 D. T. Hanks Jr., J. Jesmok eds., Malory and Christianity: Essays on Sir Thomas Malory’s ‘Morte Darthur’, Studies in Medieval Culture, 51, p. 203. 56 Y.-M. Bercé, Le roi caché, Paris, Fayard, 1990. 57 G. Béduneau, Trafic de mythes: la saga du Grand Monarque, in “Liber Mirabilis” n. 12, 1998, pp. 22-56. Cfr anche R. Badinand, Le retour du roi. Essai sur un mythe européen , “Etudes Métapolitique”, 2014, pp. 1- 12.
e di echi, anche se uno può definirsi splendidamente classico,l’altro naturalmente no – è inevitabile osservare che ancheOdisseo, all’inizio del poema eponimo, “a disparu du mondeconnu: ses proches et compagnons, depuis dix ans, sont sansnouvelles de lui, et l’écart est maximal, entre le gloire de sonpassé guerrier et l’obscurité qui, désormais, est son lot”. Nona caso, alla dea Atena, che gli appare sotto le spoglie diMente, re dei Tafi, il giovane Telemaco dice che suo padre èdiventato “le plus invisible des hommes”58. Trattenuto da Calipsonella sua caverna incantata, in un’isola perduta, ai confini delmondo, nascosto lontano, è un morto vivente: la sua stessaassenza nei libri iniziali del poema è un modo per il suo autoredi mimare “l’effacement de son héros dans l’espace du non-etre”59 , da cui, come Artù, come Bond, ritornerà – e altre cosesuccederanno…
XV. Non esiste mito senza trasmissione, senza variabili evarianti, lo abbiamo visto esaminando le mille sottostorieche costituiscono l’albero del mito odissiaco presente inquesto film. E anche la linea Artù non sarebbe un vero eproprio filo mitico se non conoscesse il destino di esseretramandata. Condiziona, innanzitutto, un autore che avevagià costituito il segnale attrattivo della linea Odisseo:Tennyson. I suoi Idilli del re riprendono centinaia di versidall’opera di Thomas Malory, compreso l’intero episodiodella sparizione di Artù60. Il nucleo poetico dell’opera siconcretizzò nella mente del creatore nel 1833 dopo la mortedel suo carissimo amico, Arthur Hallam: la pena per questoavvenimento lo ispirò a comporre una elegia direttamenteconnessa con questa dipartita, In Memoriam, e anche unaMorte d’Arthur che infine, nel 1842, anno di pubblicazionedell’intero lavoro, si intitolò invece The passing of Arthur. Lacritica ha insistito su questa connessione, sostenendo cheil centro ispiratore dell’opera sia appunto l’esperienzadel lutto, il dolore, la sensazione della perdita e deldisfacimento che Tennyson conobbe direttamente essendoprivato della figura chiave dell’amico e vide riflesso nel
58 C. Jouanno, Ulysse. Odyssée d’un personnage d’Homère à Joyce, cit., p. 32. 59 Ivi, p. 33. 60 Per alcuni, la ripresa da Malory è però scarsamente efficace: “Malory made into ‘idylls’: the spear of Malory’s Launcelot twisted into a china’s shepherd’scrook: in short this highly coloured fowl which the Victorians thought a bird ofParadise turns out to have been only a parrot after all” (F.L. Lucas, Eight Victorians Poets, Cambridge, Cambridge University Press, 1930, p. 76)
destino di un’Inghilterra orbata del proprio re. Per GeorgeLandow, questo specifico punto del testo, “like the entirepoem, concerns itself with the same problems as In Memoriamand offers much the same solutions. This close resemblanceshould remind us that in its earliest form the tale ofArthur’s departure from this earth, like Tennyson’s greatelegy, was a direct response to Hallam’s death”61. Fra moltialtri, Tyler Tychelaar ha insistito sulle sfaccettaturecristologiche di entrambi i giovani defunti, figurerappresentate nella propria sofferenza e consapevolidell’approssimarsi alla morte (Artù addirittura pronunciaun motto quasi evangelico: “My God, thou hast forgotten mein my death” I, 27) 62. Il senso di sconfitta e di disastroevocato dalla dipartita di un re luminoso e puro, perquanto non pienamente definibile ‘morte’ (“Nay, God myChrist, I pass but shall not die”, si corregge Artù),stende un terribile velo di tristezza sul mondo,sull’Inghilterra, sul lettore. Questo terribile travaglioche avviene non lontano dalle sponde del lago nel quale,appena più tardi, la piccola barca involerà il sovrano,questa dipartita connessa alle acque, dalle quali si èappena elevato il braccio rivestito di seta della dama diAvalon a cui Bedivere, l’ultimo compagno di Artù, ha dovutoriconsegnare Excalibur, ha in sé molteplici tratti che laconnettono al senso di débacle cosmica di Skyfall, e ancheall’esito finale: “everyone needs a hobby”, commenta sarcasticoBond legato e neutralizzato da Silva, il quale replica:“and what about yours?”: ed ecco, la parola, unica, con laquale Bond risponde, evade totalmente dalla sferamitopoietica odissiaca e affonda a piombo nelle acque dellago arturiano: “resurrection”. Non si poteva dir meglio.Tennyson, quindi, lavora a tenaglia nel film, in una lineaesibita (la citazione dichiarata di Ulysses fatta da M) e inuna più nascosta, più segreta, camuffata sotto il sintomo –civetta del nome epico di Gareth Mallory: e quest’ultima,forse, inaspettatamente, è la più fertile, la più potente.
XVI. E la più sorprendentemente ‘cinematografica’. Meraviglia,certamente, notarlo, ma la versione di Tennyson del
61 G.P. Landow, Closing the Frame: Having Faith and Keeping Faith in Tennyson’s ‘The passing of Arthur’, “Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester, 56 (1974), p. 423. 62 T. Tychelaar, King Arthur’s children: a study in Fiction and Tradition , London, Modern History Press, 2010.
‘passaggio’ di Artù ci riporta sottilmente al cinema: aSkyfall? Forse. Riflettiamo sull’impianto dell’episodio. Artùavanza verso la propria sparizione e quasi – morte in pienaconsapevolezza, e da solo, fatta salva la presenza di ununico cavaliere, Bedivere. A lui vengono affidati varicompiti (restituire la spada alla sua antica donatrice, adesempio, compito che esita a portare a termine per varimotivi, da un appetito per i beni materiali che loesorterebbe a tenerla per sé a una comprensibile confusionee senso di inadeguatezza davanti alla manifestazione magicadel braccio che esce dalle acque) che si riassumono,narratologicamente, in uno solo: essere insieme se stesso eno, agire da ‘doppia coscienza’. “Formally what we have isa perceiver (Bedivere removed by time and age) perceiving aperceiver (Bedivere at the centre of the action)”, scriveJ. H. Buckley 63, analizzando lo status del cavaliere che,unico, sopravvivrà all’età d’oro di Artù, testimoniandoneinsieme la condizione inarrivabile e la perdita, ilcambiamento. Potremmo dire che in una delle sue funzioniBedivere è noi – gli spettatori, fermi nel buio della saladi proiezione a vedere svolgersi la pellicola e a subirel’incanto della narrazione. Nell’altra, nell’essere anche‘attore’ dell’ultima convulsione di un mondo che siscrolla, Bedivere è Bond nella scena della morte di M,passaggio epocale a cui deve assistere, impotente, e che,lo voglia o no, deve superare: c’è un altro M nella scenasuccessiva che annuncia non a caso che nulla è finito, chec’è ‘del lavoro da fare’, che non esistono rimpianti, anchese la memoria delle cose passate è nobile, costitutiva dinoi, della nostra identità, e irrinunciabile.
XVII. Nella scena di cui parlavamo prima, quando Silva entranella cappella dove hanno cercato rifugio Kincade e Mferita e sanguinante, commenta: ” of course, it had to be here. Ithad to be this way”. Non possiamo che convenirne, se decidiamodi muoverci all’interno della linea Artù: la dipartita delre, infatti, avviene in una cappella, dove Bedivere consofferenza lo ha trasportato, non lontana dal mare e dallospecchio d’acqua del lago. Una topografia ripresa conprecisione nel set di questa scena conclusiva. La morentequi è M, vero, e il personaggio maschile funziona solo da
63 J. H. Buckley, Tennyson: the Growth of a Poet, Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, 1960, p. 36.
testimone. Ma Elliot L. Gilbert ha sostenuto64 che non sidebbono trascurare nella versione di Tennyson delpersonaggio di Artù delle caratteristiche connesse allafemminilità, e che se, certo, Artù è re meritatamente, perla sua straordinaria forza e capacità, tuttavia latrasmissione del potere, con la consegna della magicaExcalibur donatagli da una mano femminile, sembra insisteresu un nuovo ruolo dell’autorità della donna: del restoquesti Idylls sono stati e sono tuttora un terreno di studioprivilegiato di quanti abbiano per obiettivo l’analisi delruoli di gender nella letteratura vittoriana. Come nonpensare alla forza e al carisma che la M di Judi Denchesalta nella pellicola – tanto da far scrivere ai criticicinematografici che, dopo la connessione visiva di DanielCraig alla regina Elisabetta nella cerimonia di aperturadelle Olimpiadi, l’iniziale di M poteva alludereaddirittura a – Her Majesty? Come non pensare alla tensioneverso di lei, edipica e sotterranea, gemella, davvero, atutte le forze oscure che nel poema di Tennyson connettonouomini e donne – Artù alla sua incestuosa sorella,Lancillotto a una regina pericolosa e traditrice, icona difascino e di pericolo, e addirittura Igraine a Uter, einfine, mito dei miti del potere della donna incantatricesull’uomo incantato, Viviana e Merlino?
XVIII. La linea Artù si rivela dunque estremamente prolifica. Da Thomas
Malory a Tennyson, in mille sottotemi, e oltre. La suacontinuazione estrema ha luogo ad Oxford, laddove si riunisce,discute e produce il celebre gruppo degli Inklings, Tolkien e isuoi amici – Clive Staples Lewis, Owen Barfield, CharlesWilliams e molti altri. Tutti, nelle loro riunioni creative alpub prediletto, il celebre The Eagle and the Child, lavoranoattivamente su Artù, convinti della fertilità mitopoieticadell’argomento. Charles Williams, ad esempio, scrisse ben trelibri di soggetto arturiano: due raccolte poetiche (Taliessinthrough Logres (1938) e The region of the Summer Stars (1940), non moltoapprezzate da Tolkien che le definiva ‘supernatural thrillers’sottolineandone l’atmosfera bizantineggiante, e una raccolta disaggi, The figure of Arthur – incompiuta. Clive Staples Lewis,invece, inserì il personaggio nel terzo capitolo della sua CosmicTrilogy. Nessuna meraviglia dunque se J.J.R. Tolkien si avvicinò,
64 E.L. Gilbert, The female king: Tennyson’s Arthurian Apocalypse, “PMLA” 98, (1983), pp. 863-878.
- o tentò di farlo- attraverso la figura di Artù, a placare ilsuo “desire of faërie”: nonostante Artù e Ginevra non fosserofate, permettevano però l’entrata in un mondo altro, i cuiconfini, limitrofi a quelli del nostro universo, sono permeabilie confondibili: “the good and evil story of Arthur’s court is afairy story”, scrisse Tolkien, perché “most good fairy-storiesare about the aventures of men in the Perilous Realm or uponits shadowy marches”. Riprese, quindi, in considerazione lafigura di Artù, in un poema in versi allitterativi pubblicatodal figlio Christopher solo nel 2013, e disgraziatamenteincompiuto: e sentiremo il brivido del riconoscimento quandosapremo che il titolo di questo che è stato definito “the finestand the most skillful achievement in the use of Old Englishallitterative meter”65è, straordinariamente – The Fall of Arthur... C’è un motivo, per questo titolo che fa rabbrividire per laconsonanza perfetta con lo skyfall di Bond - o ce ne sono molti.La critica, deliziata dalla pregevole bellezza edall’inaspettata apparizione dell’opera creduta inarrivabile, hainsistito sul fatto che il senso di ‘caduta’ spesseggia nelpoema, alludendo ad un’ ineffabile, ben percepibile decadenza –l’Inghilterra ha superato la propria età d’oro, il sovrano non èpiù lo splendente eroe di una volta, “the old world to its endfalling”66 – che spiega l’uso del termine con tutto il sovrasensostorico (la fine dell’Impero) e religioso (la fine del bene –luce, di cui è aureolato Artù, di fronte all’avanzamentodell’oscurità che Mordred ha in sé: l’ultima battaglia infattisi combatterà in una gelida bruma, una misty darkness antiteticaalla luce del sole del giorno in cui il giovane re ha vinto ilsuo dominio sul campo) implicito. Benissimo: e la spiegazionenon fa che ribadire la sorpresa di un ulteriore collegamento:questo Artù stanco, decadente, decaduto, consapevole della suafine e da essa spaventato, un Odisseo inaspettato (l’Artù diTolkien combatte battaglie navali contro i pirati Sassoni,naviga quasi continuamente sulla sua ammiraglia ‘fair and pride’ perrendere sicure le coste d’Inghilterra) teso alla protezione diun paese non più al meglio di sé, un’Itaca malata sul punto dicrollare – si lega con mille legami al Bond di Skyfall,autorizzando a pensare che davvero i miti – friabili, fragilicose – siano corde di metallo nel creare connessioni,impossibili a svellere una volta innestate: e che il vero valore
65 J.R.R. Tolkien, The Fall of Arthur, Boston – New York, Houghton Mifflin Harcourt, 2013. 66 Ivi, p. 24, Canto I v. 178.
simbolico della caduta di Bond nell’acqua spumeggiante dellacascata e poi dentro, sotto, in fondo, alluda semplicemente aquesto, al bolide lucente del mito che sempre affonda in noi, siricrea, cade e si rinnalza, luminosa stella danzante.
ALCOTT 2014: T. Alcott, Skyfall part. 7, www.toddalcott.com,16/01/2014, p. 5.
AMIS 1965: K. Amis, The James Bond Dossier, Jonathan Cape, London.
BACHTIN 1978: M. Bachtin, Epos e romanzo , in AA.VV., Problemi diteoria del romanzo, Torino, Einaudi .
BADINAND 2014: R. Badinand, Le retour du roi. Essai sur un mytheeuropéen , “Etudes Métapolitique”, 2014, pp. 1- 12. BEDUNEAU 1998: G. Béduneau, Trafic de mythes: la saga du Grand Monarque,in “Liber Mirabilis” n. 12, 1998, pp. 22-56.
BERCE’ 1990: Y.-M. Bercé, Le roi caché, Paris, Fayard.
BETTINI 2004: M. Bettini, Le riscritture del mito, in G. Cavallo, P.Fedeli, A. Giardina, Lo spazio letterario di Roma antica, Roma, SalernoEditrice, vol. I La produzione del testo.
BOILEAU – NARCEJAC 1965: Boileau – Narcejac, La mort de James Bond ,“Corriere della Sera”, 9 marzo 1965.
BONAFIN 2008: M. Bonafin, Prove per un’antropologia del personaggio, inLe vie del racconto. Temi antropologici, nuclei mitici e rielaborazione letteraria nellanarrazione medievale germanica e romanza, a c. di A. Barbieri, P.Mura, Padova, Unipress, pp. 3- 18.
BUCKLEY 1960: J. H. Buckley, Tennyson: the Growth of a Poet, CambridgeMassachusetts, Harvard University Press.
BURKERT 1987: W. Burkert, Greek religion: Archaic and classical , London,Blackwell.
BUZZATI 1965: D. Buzzati, Neo- superuomini, “Corriere della Sera”,9 marzo 1965.
CALISI 1965: R. Calisi, Mito e destorificazione nell’epopea di James Bond,in AA.VV., Il caso Bond, a c. di U. Eco e O. del Buono, Milano,Bompiani.
CAMEROTTO 2006: A. Camerotto, Come diventare un eroe, “Incontritriestini di Filologia Classica 6” (2006-2007), 257 – 287.
CAMPBELL 1949: J. Campbell, The Hero with a Thousand Faces, 1949.
CHATMAN 1981: S. Chatman, Storia e discorso. La struttura narrativa nelromanzo e nel film, Parma, Pratiche Editrice.
CHEVALIER – GHEERBRANT 1997: J. Chevalier, A. Gheerbrant,Dizionario dei simboli, Milano, Rizzoli, voll. 2.
CHIARINI 1995: G. Chiarini, Il viaggio nella letteratura greco – latina, inF. Rosa, F. Zambon, a c. di., Pothos. Il viaggio, la nostalgia, Trento,Editrice Università degli Studi.
CITATI 2002: Citati, La mente colorata, Milano, Mondadori.
CONTE 2007: G.B. Conte, Virgilio, l’epica del sentimento, Torino, Einaudi.
ECO 2005: U. Eco, Le strutture narrative in Fleming, in ID., Il Superuomodi massa. Retorica e ideologia nel romanzo popolare, Milano, Bompiani.
ELIADE 1962: M. Eliade, Aspects du Mythe , Paris, Gallimard, 1962.
FABBRI 2013: P. Fabbri, Ulisse è Bond , “Alfabeta” 2, n. 26,febbraio 2013.
FARANDA 2009: L. Faranda, Viaggi di ritorno. Itinerari antropologici nellaGrecia antica, Roma, Armando.
FELSON – RUBIN 1994: N. Felson Rubin, Regarding Penelope: fromcharacter to poetics, London, Cloth, 1994.
GALASSO 2009: R. Galasso, Le nozze di Cadmo e di Armonia, Milano,Adelphi.
GATES 1988: B. Gates, Victorian suicide: mad crimes and sad histories,Princeton University Press.
GILBERT 1983: E.L. Gilbert, The female king: Tennyson’s ArthurianApocalypse, “PMLA” 98, (1983), pp. 863-878.
GRIFFIN 1986: J. Griffin, The Mirror of Myth: Classical Themes and Variations. The T. S. Eliot Lectures (1986), London, Faber and Faber.
HANKS – JESMOK 1997: D. T. Hanks Jr., J. Jesmok eds., Malory andChristianity: Essays on Sir Thomas Malory’s ‘Morte Darthur’, Studies in MedievalCulture, 51.
KIRK 1977: G. Kirk, La natura dei miti greci, Bari, Laterza.
JOUANNO 2013: C. Jouanno, Ulysse. Odyssée d’un personnage d’Homère àJoyce, Paris, Ellipses.
LANDOW 1974: G.P. Landow, Closing the Frame: Having Faith and Keeping Faithin Tennyson’s ‘The passing of Arthur’, “Bulletin of the John RylandsUniversity Library of Manchester, 56 (1974).
LILLI 1965: L. Lilli, James Bond e la critica, in AA.VV., Il caso Bond,a c. di U. Eco e O. del Buono, Milano, Bompiani.
LUCAS 1930: F.L. Lucas, Eight Victorians Poets, Cambridge, CambridgeUniversity Press.
MALORY 1985: T. Malory, Storia di re Artù e dei suoi cavalieri , Milano,Mondadori.
MAZZITELLI 2012: M. Mazzitelli, Bond sulla linea d’ombra, Com.Unità,27 Novembre 2012.
PIETROSANTI 20013: S. Pietrosanti, ‘Un cinema che cerca per chi cerca’:per un uso della grammatica visiva in letteratura attraverso l’opera di Paolo eVittorio Taviani , “Bollettino dell’Accademia degli Euteleti”, 2013,n. 80, pp. 79-91.
PIETROSANTI, FRATTALI 2013: S. Pietrosanti, A. Frattali, ‘Homer’swave machine’: Odyssey di Simon Armitage per la regia di Robert Wilson,“Dionysus ex machina”, n. 4, anno 2013.
PIOVENE 1965: G. Piovene, Perché mi divertono i films di James Bond , “LaStampa”, n. 50, 2 aprile 1965.
PRAZ 1983: M. Praz, Storia della letteratura inglese, Firenze, Sansoni.
SNELLING 1964: O.F. Snelling, Double O seven – James Bond – A report ,Spearman-Holland Press, London.
TOLKIEN 2013: J.R.R. Tolkien, The Fall of Arthur, Boston – New York,Houghton Mifflin Harcourt.
TORNABUONI 1965: L. Tornabuoni, Un fenomeno di costume, inAA.VV., Il caso Bond , a c. di U. Eco e O. del Buono, Milano,Bompiani.
TYCHELAAR 2010: T. Tychelaar, King Arthur’s children: a study in Fiction andTradition , London, Modern History Press.
YOUNG 1965: T. Young, Portrait de Monsieur Bond, “Le NouvelObservateur”, 25 febbraio 1965.