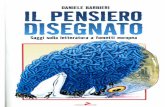YŌKAI E LETTERATURA: LA LETTERATURA AL SECONDO GRADO DI KYŌGOKU NATSUHIKO
Poetiche 2011 (Renata Vigano' e la letteratura resistenziale)
Transcript of Poetiche 2011 (Renata Vigano' e la letteratura resistenziale)
Comitato di direzione: Andrea Battistini (Università di Bologna); Marco An-tonio Bazzocchi (Università di Bologna); Giuliana Benvenuti (Università di Bo-logna); Aurora Conde Muñoz (Universidad Complutense, Madrid); Fausto Curi (Università di Bologna; coordinatore); Francesco Erspamer (Harvard Univer-sity, Cambridge MASS); Carlo Gentili (Università di Bologna); Niva Lorenzini (Università di Bologna); Piero Pieri (Università di Bologna); Luca Somigli (Uni-versity of Toronto).
Redazione: Daniela Baroncini, Francesco Carbognin, Stefano Colangelo, Valen-tina Mascaretti, Caterina Paterlini, Antonio Schiavulli, Luigi Weber (coordinato-re). Dipartimento di Italianistica, via Zamboni 32 - 40126 Bologna
Editore: Mucchi Editore, Modena
Abbonamenti e amministrazione: Mucchi Editore S.r.l., Via Emilia est, 1527 41122 Modena, Tel. 059.37.40.94, Fax 059.28.26.28, c/c postale 11051414, e-mail: [email protected]
Responsabile: Marco MucchiAutorizzazione del Tribunale di Modena n. 350 dell’11 luglio 1958
Prezzo abbonamento annuo: Italia € 63,00 - Estero € 75,00
Grafica e impaginazione, Mucchi Editore (MO), stampa, Editografica (BO)
In copertina: Enrico Baj Passeggiata al Central Park (1969).Si ringrazia sentitamente la signora Roberta Baj per la gentile concessione
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ogni articolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’ac-cordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione scritta rilasciata dall’editore. Vietata la pubblicazione in Inetrnet.
© Mucchi Editore s.r.l.Via Emilia Est, 1527 - 41122 [email protected]: CONFINDUSTRIA, AIE, USPI
Finito di stampare nel mese di dicembre 2011
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 171-184
Fausto Curi
Sul soggetto nella poesia1
I
Esiste qualcosa come “il soggetto”? A que-sta domanda alcuni filosofi analitici ri-sponderebbero che non esiste ma c’è; altri
che, in quanto non esiste, non c’è. Per mancan-za di competenze lasciamo irrisolta la questio-ne, che, così come l’abbiamo posta, è questio-ne strettamente filosofica, e cerchiamo di ragio-nare da storici. Come è noto, Cartesio è stato il primo, con il Cogito, ad assumere l’esistenza del soggetto, inaugurando una tradizione che, non senza importanti variazioni, giunge fino al No-vecento e a Husserl. A partire da Nietzsche, al-cuni fra i maggiori pensatori contemporanei e tutti gli psicoanalisti negano che il soggetto esi-sta, non servendosi però, per la loro negazio-ne, degli argomenti radicali dei filosofi analitici ma sostituendo alla nozione di soggetto propo-ste suggerite sia dal pensiero nietzscheano sia dalla dottrina di Freud. Nella Volontà di poten-za, per esempio, Nietzsche, anticipando la no-zione freudiana di un apparato psichico com-posto di diverse istanze, sostiene che «Ammet-tere un soggetto non è forse necessario; forse è altrettanto lecito supporre una molteplicità di soggetti». E Wittgenstein, nel Tractatus, afferma che «Il soggetto che pensa, immagina, non v’è».
Il compito dello storico, pensiamo, è tener conto delle diverse posizioni, senza che ciò si-
1 Per gentile concessione della casa editrice Mimesis di Mi-lano pubblichiamo il primo capitolo del libro di Fausto Curi Il cor-po di Dafne. Variazioni e metamorfosi del soggetto nella poesia mo-derna.
Fausto Curi172
gnifichi tendere a un’impossibile oggettività e a un’altrettanto impossibile neutralità. Che cer-te proposizioni e certi concetti risultino obsole-ti o insufficienti o approssimativi, e pur occorra non ignorarne la relativa importanza che hanno e hanno avuto nella storia della cultura, dovreb-be, oltre che essere intuitivo, risultare dall’an-damento stesso dell’indagine. In certi casi non ignorare è la strada migliore per arrivare a cono-scere. Non dimentichiamo, in ogni caso, che la riflessione in cui siamo impegnati non riguarda il soggetto sic et simpliciter, ma il soggetto nel-la poesia. O, per essere precisi, ciò a cui da tutti gli studiosi di poesia ci si continua a riferire con il termine di soggetto, qualunque cosa poi si in-tenda con questa parola.
II
Considerate alla luce di più recenti e più sottili acquisizioni, non però recentissime, certe nozioni possono oggi apparire alquanto elemen-tari, anche se a proporle fu un tecnico e un te-oreta geniale come Gianfranco Contini. Il qua-le, nel 1958, pubblicava in «L’Approdo» un sag-gio dal titolo assai promettente di Dante come personaggio-poeta della “Commedia”. Per la ve-rità, in quel caso, Contini mostrava di avere più a cuore l’interpretazione di certi passi danteschi che l’elaborazione, sia pure ellittica, di qual-che proposta teorica. Intanto, però, che occor-resse aver chiaro in mente che del suo poema Dante, oltre che autore, è anche “personaggio”, diveniva un locus communis della storiografia. Con le conseguenze che, sul piano generale, i più provveduti seppero trarne. Perché, ripeto, la nozione proposta era elementare e teoricamen-te minima, ma la distinzione fra “poeta” e “per-sonaggio” mostrava l’impossibilità di continua-
Sul soggetto nella poesia 173
re a gestire ‘unitariamente’ la questione dan-tesca, come qualsiasi altra questione analoga, e insinuava fruttuosamente il dubbio riguardo a ciò che si dovesse intendere per soggetto in poesia. Tanto più che Contini, prima di arriva-re a Dante, si soffermava inaspettatamente su Proust, trasformando così quello che poteva ap-parire un problema particolare in un problema generale, e ‘moderno’. Non senza qualche osser-vazione niente affatto elementare:
Il personaggio che dice “io” nella Recherche du temps perdu non ha nome – categoria che pertiene infatti al “lui”; ma le rare volte, due in tutto, e non prima della prisonnière, che un nome occorre, esso è di necessità registrato come Mar-cel. È l’autore? è altro dall’autore? In questa ambiguità e in quest’intervallo consiste l’essenziale problematica prou-stiana. Non alludo alla lunga industria dell’erudizione spe-cifica, soprattutto negli ultimi anni, che consente di sceve-rare un po’ meglio ciò che è autobiografia diretta, ciò che è autobiografia trasposta e ciò che è interpolazione temati-ca o sollecitazione ritmica e tectonica, insomma quello che a scuola si chiama “l’inevitabile trasfigurazione fantasti-ca”, nel gran libro francese. Varrebbe quanto fermarsi alla scorza della questione. Va chiesto piuttosto: l’“io” di Proust (una volta appurato che esso non è il banale mezzo flessivo della conversione d’un romanzo in terza a romanzo in pri-ma persona, consueta dalle Metamorfosi di Apuleio a non so quanta produzione moderna) è il soggetto d’una limi-tata, definita esperienza storica irripetibile o è il soggetto trascendentale di qualsiasi avventura vitale e conoscitiva?
Come si vede, davvero Contini non si ferma-va alla «scorza della questione» e poneva doman-de e proponeva nozioni che, chi sapesse giovar-sene, non riguardavano il solo Proust. Quanto a Dante, preso l’abbrivo e percorrendo non inutil-mente la strada à rebours, egli, citando Charles Singleton, notava come
nell’“io” di Dante convergano l’uomo in generale, sog-getto del vivere e dell’agire, e l’individuo storico, titolare d’un’esperienza determinata hic et nunc, in un certo spa-
Fausto Curi174
zio e in un certo tempo; Io trascendentale (con la maiu-scola), diremmo oggi, e “io” (con la minuscola) esistenzia-le. Anche grammaticalmente, rileva il Singleton, qualche spia non manca, se, fino dal limine, alla “nostra vita”, vita di quell’“io” che è noi, si oppone “mi ritrovai”, azione di quell’“io” che è solo io.
Sia discorrendo di Proust sia discorrendo di Dante, Contini elaborava insomma concetti e distinzioni che avevano una portata metodo-logica non limitata a quei due autori. Utili an-cora oggi, anche se, si capisce, l’idea di un sog-getto ridotto soltanto all’“io” non è ormai da noi più accettabile.
Distinzioni più sottili, per quanto riguarda il genere narrativo, ha in seguito proposto, come è noto, Seymour Chatman in Storia e Discorso. Chatman, citando Monroe Beardsley (per il qua-le è «essenziale non confondere autore e narra-tore») e Wayne Booth (che ha avanzato la propo-sta di un «autore implicito»), osserva che «l’au-tore implicito»
non è il narratore, ma piuttosto il principio che ha inven-tato il narratore insieme a tutto il resto della narrazione, che ha sistemato le carte in un certo modo, ha fatto suc-cedere queste cose a questi personaggi… […] L’autore im-plicito stabilisce le norme della narrativa […] è un princi-pio strutturale…
È, a giudizio di Kathleen Tillotson, l’“alter ego” dell’autore. Figure secondarie o minori, ma tutt’altro che insignificanti, appaiono il lettore implicito, il narratore e il narratario. Il lettore implicito è «il pubblico presupposto dalla nar-rativa stessa», il lettore ideale che ha in mente l’autore implicito mentre compone la sua ope-ra; il narratore è colui cui è affidata la narrazio-ne, il narratario chi nell’opera ascolta il raccon-to. S’intende che narratore e narratario possono esserci come non esserci.
Sul soggetto nella poesia 175
La comunicazione narrativa è esemplificata da Chatman nel seguente schema:
Autore reale > [Autore implicito > (Narratore) > (Narratario) > Lettore implicito] > Lettore reale
Conclude Chatman:
Il riquadro indica che solo l’autore implicito e il lettore im-plicito sono immanenti alla narrativa, e che il narratore e il narratario, posti fra le parentesi, sono opzionali. L’auto-re reale e il lettore reale sono fuori del patto narrativo in quanto tale, sebbene, è ovvio, gli siano fondamentalmen-te indispensabili.
III
Ma che ne è del “soggetto” nella poesia? Proviamo a procedere gradualmente, giovando-ci anche noi, in un primo momento, di concet-ti e di termini elementari, che hanno se non al-tro il pregio di farsi intendere immediatamente. Diremo allora che il soggetto è, in primo luogo, l’“autore” della poesia. L’“autore” può assume-re le sembianze di un “personaggio” della poesia stessa (Dante “personaggio-poeta” della Com-media), o essere visibilmente presente nel testo come colui che dice “Io” senza per questo as-sumere la concreta figura di un vero e proprio “personaggio” (l’“Io” dei Rerum vulgarium Frag-menta petrarcheschi, o delle Contemplations di Hugo). L’“Io” che compare nel testo ha, si capi-sce, di volta in volta una fisionomia diversa, a seconda che la sua egoità sia più o meno ac-centuata, più o meno visibile, caratterizzata ora in questo ora in quel modo. Non mancano però casi di somiglianze più o meno rilevanti, dovute soprattutto al principio dell’imitazione, all’«an-goscia dell’influenza», ecc.: basti pensare per un verso ai petrarchisti, per un altro verso ai dan-
Fausto Curi176
nunziani. L’“Io” di Montale, comunque, non è l’“Io” di Apollinaire, né l’“Io” di Dylan Thomas è l’“Io” di Rilke.
Posto però che l’“Io” abbia qualcosa a che fare con il soggetto, intorno all’“Io” occorre inter-rogarsi. Rinviamo, per quanto riguarda la con-cezione psicoanalitica, al capitolo Freud, l’Incon-scio, la poesia, dove fra l’altro si dà ragione della scelta di usare l’iniziale maiuscola. Stiamo, ora, alle proposte della linguistica, e in particolare a quelle di Émile Benveniste. Partiamo dalla pre-messa che egli enuncia:
Io può essere definito solo in termini di “parlare”, e non in termini di oggetti, come lo è invece un segno nominale. Io significa “la persona che enuncia l’attuale situazione di di-scorso contenente io”. Situazione unica per definizione, e che vale solo nella sua unicità.
Cosicché
… Io non può essere identificato che dalla situazione di di-scorso che lo contiene e solo da essa. Io vale solo nella si-tuazione in cui è prodotto. Ma, al tempo stesso, deve esse-re preso anche in quanto situazione di forma io; la forma io non ha esistenza linguistica se non nell’atto di parola che la proferisce. In questo processo vi è quindi una dupli-ce situazione coniugata: situazione di io come referente, e situazione di discorso contenente io, come riferito. La de-finizione può allora essere precisata in questo modo: io è l’“individuo che enuncia la presente situazione di discorso contenente la situazione linguistica io”.
Così prosegue Benveniste: Io
È […] un segno legato all’esercizio del linguaggio e afferma il parlante come tale. È questa proprietà che fonda il di-scorso individuale, in cui ciascun parlante assume su di sé l’intero linguaggio. […] Quando l’individuo se ne appro-pria, il linguaggio si trasforma in situazioni di discorso, caratterizzate dal sistema di referenze interne la cui chia-ve è io…
Sul soggetto nella poesia 177
Abbiamo scelto, come è evidente, senza troppo indugiare. E, forse, senza che dell’esem-plificazione vi fosse uno stretto bisogno, se non su un terreno assai pianamente didascalico, che è quello che ora preferiamo. Sarà lecito pen-sare, insomma, che oltre che «nell’atto di paro-la che la proferisce» la «forma io» abbia «esisten-za linguistica» anche nell’atto di scrittura che corrisponde a un testo poetico; che lo scrivente possa non essere altra cosa dal “parlante” e che quindi «discorso individuale» sia anche il discor-so poetico.
L’indagine di Benveniste, comunque, diven-ta per noi ancora più interessante quando egli esamina «la soggettività nel linguaggio»:
è nel linguaggio e mediante il linguaggio che l’uomo si costituisce come soggetto; poiché solo il linguag-gio fonda nella realtà, nella sua realtà che è quel-la dell’essere, il concetto di “ego”. La “soggettività” di cui ci occupiamo in questa sede è la capacità del parlante di porsi come “soggetto”. Essa non è defi-nita dalla coscienza che ciascuno prova di essere se stesso […] ma come l’unità psichica che trascende la totalità delle esperienze vissute che essa riunisce, e che assicura il permanere della coscienza. Noi rite-niamo che questa “soggettività” […] non è altro che
Io non so ben ridir com’io v’entrai… (Inf.,10)
Io son sì stanco sotto ´l fascio anticode le mie colpe e de l’usanza riach’i’ temo forte di mancar tra via… (LXXXI)
Je ne sais plus ni si je l’aime… (Apollinaire, Le guetteur melancolique)
I grow old…I grow old…I shall wear the bottoms of my trousers rolled. (Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock)
Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der EngelOrdnungen? (Rilke, Duineser Elegien, I)
Yo quiero ver aqui los hombres de voz dura.
Fausto Curi178
l’emergere nell’essere di una proprietà fondamentale del linguaggio. è “ego” che dice “ego”. In ciò troviamo il fondamento della “soggettività”, che si determina attraverso lo status linguistico della “persona”. […] è nella situazione di discorso in cui io designa il par-lante che quest’ultimo si enuncia come “soggetto”. è quindi vero alla lettera che il fondamento della sog-gettività è nel linguaggio. Se ci si riflette seriamente, si vedrà che non ci sono altre testimonianze oggetti-ve dell’identità del soggetto fuorché quella che in tal modo egli stesso dà su se stesso.
Solo usando il linguaggio, quindi, a giudi-zio di Benveniste, posso costituirmi come sog-getto, perché, usando il linguaggio, non posso non costituirmi come “persona” e precisamen-te come “prima persona”, cioè come io. In quan-to, dicendo “io”, mi differenzio sia dalla seconda persona “tu” sia dalla “non-persona egli”, mi ri-conosco come prima persona, cioè come io, cioè come soggetto. Non vi possono essere dubbi che sia io il soggetto di ciò che dico, e dunque io non posso non riconoscermi, e non posso non esse-re riconosciuto da “tu” e da “egli”, come sogget-to. Del soggetto, secondo Benveniste, non esiste un fondamento ontologico, esiste solo un fonda-mento linguistico. O meglio, l’unico fondamento ontologico valido e accettabile, perché fondato nella concreta e accertabile realtà della lingua, è il fondamento linguistico.
Siamo però sicuri che «è “Ego” che dice “Ego”»? O meglio, siamo sicuri che quando io parlo sono io che parlo? Benveniste non igno-ra la dottrina di Freud, ma, quando elabora così lucidamente la sua teoria del linguaggio, non ne tiene alcun conto. Se ne tenesse conto ricono-scerebbe probabilmente che l’Io è soltanto una parte dell’apparato psichico e che una parte al-trettanto importante è costituita dall’Es, cioè dall’inconscio.
Sul soggetto nella poesia 179
L’Io – spiega Freud – rappresenta ciò che può dirsi ragio-ne e ponderatezza, in opposizione all’Es che è la sede delle passioni. […] L’Io può […] essere paragonato, nel suo rap-porto con l’Es, al cavaliere che deve domare la prepotente forza del cavallo… […] Come il cavaliere, se non vuole es-sere disarcionato dal suo cavallo, è costretto spesso a ub-bidirgli e a portarlo dove vuole, così anche l’Io ha l’abitu-dine di trasformare in azione la volontà dell’Es come se si trattasse della volontà propria.
Può allora accadere che l’Es, che non ha fa-coltà di parola, riesca però a costringere l’Io a parlare per suo conto.
Al di là di Freud vanno due suoi seguaci eretici, Georg Groddeck e Jacques Lacan. Il pri-mo afferma infatti che «L’espressione “io vivo” è vera solo in un certo senso», giacché «l’uomo è vissuto dall’Es»; il secondo sostiene che «l’incon-scio è linguaggio», giacché «è strutturato come un linguaggio» ed è il solo che «dice il vero sul vero», e che, inoltre, «non si tratta di sapere se parlo di me in modo conforme a ciò che sono, ma se, quando ne parlo, sono lo stesso che co-lui di cui io parlo». Se io sono vissuto e parlato dall’Es, o se, in ogni caso, l’Es partecipa in mi-sura maggiore o minore all’invenzione del lin-guaggio, potrò dire ancora che quando io parlo sono io che parlo?
IV
Il soggetto che più varia e presenta maggiori problemi ermeneutici è, in ogni caso, il soggetto invisibile, o scarsamente visibile, o più enigma-tico, in una parola quello che un tempo si deno-minava l’autore, colui che è il facitore del testo. Che costui sempre si mascheri, alteri in misura maggiore o minore la propria ‘personalità’, è pa-cifico. La questione è: in che modo si maschera? Che senso ha, a quali intenzioni corrisponde o
Fausto Curi180
a quali coazioni soggiace quel suo mascherarsi? E quale rapporto sussiste fra il soggetto visibile e il soggetto invisibile, cioè l’“autore”?
Proviamo ora a dare alle parole un significa-to più preciso: scrivendo il proprio testo un po-eta (sia quando elabora un vero e proprio “per-sonaggio”, sia quando decide che un “personag-gio” non corrisponde alle sue possibilità e alle sue esigenze, non fa, insomma, al caso suo) non tanto si maschera quanto piuttosto si atteggia, costruisce, a fini comunicativi, una propria im-magine. Il problema, per l’interprete, o per lo storico, sta nel determinare le ragioni, i modi e il senso di quella costruzione. Che, si capisce, è costruzione tutta verbale, ma proprio per que-sto ha una rilevante, rilevantissima consisten-za psicologica. Anzi, psicologico-ideologica, tan-to più che ‘testi’ non sono soltanto i testi poetici, ‘testi’, soprattutto quando si tratti di grandi au-tori, sono anche le dichiarazioni di poetica e le proposte teoriche. In giuoco, infine, sono anche la concezione o la percezione dell’Io che quegli autori hanno, e segnatamente ciò che non è l’Io ma più dell’Io è psichicamente attivo, si chiami inconscio o Es. Quello che noi cogliamo di un poeta quando leggiamo la sua opera non è ciò che egli è, ma la rappresentazione che, consa-pevolmente e al tempo stesso inconsciamente, egli ci fornisce di sé. Un’immagine, una figura, una maschera rivelatrice, un simulacro verace.
Può tornare utile, a questo punto, costru-ire, per la poesia, uno schema simile a quello elaborato da Chatman per la narrativa:
Autore reale > [ Enunciatore o Autore implicito > Lettore implicito] > Lettore reale
Il vero soggetto, in quanto è autore dell’e-nunciazione, è, si capisce, l’autore implicito. Costui propone al lettore implicito l’immagine
Sul soggetto nella poesia 181
di sé che intende comunicargli. Poiché la poesia è sempre un atto comunicativo e un atto comu-nicativo implica sempre almeno una dualità di attori; poiché inoltre il lettore implicito altro non è, in certa misura, che una creazione dell’autore implicito, costui elabora quell’immagine model-landola, oltre che sulle proprie esigenze, sulle esigenze e sulle aspettative del lettore implicito che egli riesce a percepire. Anche il lettore im-plicito, pertanto, entra a far parte del processo di produzione. Di questo processo, e del rappor-to di complicità che lega l’autore implicito al let-tore implicito, fornisce una chiara rappresenta-zione Au lecteur di Baudelaire. Il quale intende comunicare al lettore che «È il Diavolo che tiene i fili che ci muovono», così come intende comu-nicargli tutte le altre notizie atroci e inquietan-ti che la poesia contiene, ma non oserebbe mai farlo, né oserebbe chiamare il lettore «ipocrita lettore, – mio simile, – mio fratello» – cioè “simi-le” e “fratello” nel peccato e nell’essere schiavo del Diavolo – se non avesse intuìto e al tempo stesso non avesse contribuito a provocare l’in-sorgenza delle esigenze e delle aspettative del lettore e non avesse stabilito con lui una relazio-ne di complicità. Il soggetto, dunque, in quanto è l’autore implicito che in sé comprende il letto-re implicito, è sempre un soggetto parzialmente alienato, fatto in certa misura altro dalla neces-sità di comunicare con un altro. O, se si preferi-sce, è una duplicità autoriale
V
Per poter affermare che due cose sono in-comparabili in qualche modo bisogna averle comparate. “Incomparabile”, più che dichiara-re un’effettiva incomparabilità, funziona come una forma retorica, è, precisamente, un’iperbo-
Fausto Curi182
le: “una bellezza incomparabile”. Sostenere che le poetiche della modernità sono incomparabili con le poetiche della classicità vuol dire che in qualche modo e in certa misura esse sono sta-te messe a confronto. Per arrivare alla sconso-lata (e bugiarda) conclusione che un confronto non è possibile. In realtà il confronto non solo è possibile, ma necessario e utile, giacché per-mette di stabilire, e sia pure in attesa di ponde-rate verifiche, le profonde differenze che distin-guono i modi di intendere e praticare la poesia dei moderni dai modi propri degli scrittori clas-sici. La poetica degli elegiaci latini, per esempio, paragonata con le poetiche romantiche, a giudi-zio di Paul Veyne appare, come vedremo meglio nel prossimo capitolo, del tutto differente. Un discorso analogo sembra di poter fare riguardo all’idea di soggetto in poesia. Ciò che a noi più interessa, però, è un altro tema, e precisamente questo: quanto più la poesia avanza nel tempo fino a diventare quella che, approssimativamen-te, e intendendoci alla lesta, possiamo chiamare ‘poesia moderna’ tanto più le singole poetiche e le singole concezioni del soggetto si differenzia-no, fino a giungere a un punto di massima di-stanza dalla classicità. Cosicché mentre gli ele-giaci latini fondavano la loro poetica su un uni-co modello, per tutti uguale, nei moderni, anche quando le poetiche sono simili (facciamo il caso dei romantici tedeschi, o degli ermetici italiani), domina la più netta diversità. E profondamen-te diverse sono le concezioni del soggetto che ciascun poeta elabora e le immagini del sogget-to che ciascuno di essi più o meno chiaramente percepisce. Diremo, per essere più precisi, che, concordando su certi aspetti di ordine generale, tutti i poeti, consapevolmente o inconsapevol-mente, tendono a differenziarsi l’uno dall’altro e a possedere una fisionomia culturale e stilisti-ca irriducibilmente propria. Per quanto possa
Sul soggetto nella poesia 183
forse apparire ragionevolmente accettabile sen-za esigere verifiche, e quasi ovvia, questa è però soltanto un’ipotesi che di verifiche ha invece bi-sogno. Sono tali verifiche, nel senso di un’ana-lisi di testi e di poetiche il più possibile attenta, che la presente indagine si propone di fornire. Quanto alla scelta degli autori, il criterio della rappresentatività in rapporto al tema enunciato dal titolo del libro e qui ripreso e ellitticamente svolto, è sembrato il più conveniente.
Sul soggetto nella poesia - About the subject of poetry
Fausto Curi
È evidente che fra la forma di un testo po-etico e il soggetto che crea quella forma esi-ste un rapporto organi-co. Ne segue che ana-lizzare i mutamenti che si verificano nel sogget-to storicamente inte-so permette di meglio intendere i mutamenti che investono gli asset-ti formali dei testi. Fon-dandosi su questa tesi, nel suo libro Il corpo di Dafne. Variazioni e me-tamorfosi del soggetto nella poesia moderna, che è pubblicato ora dalla Casa editrice Mi-mesis di Milano, e di cui “Poetiche” ristam-pa qui il primo capito-lo, Fausto Curi esami-na con nuovi criteri e nuovi strumenti le ope-re dei principali poeti moderni, da Baudelai-re a Rimbaud, da Lau-tréamont a Breton, da Eliot a Pound, da Mari-netti a Palazzeschi, da Montale a Sanguineti, ecc.
There is an obvious or-ganic relation between the form of a text in verse and the subject that creates that form. Therefore a study of the changes that affect the subject as seen from a historical point of view allows a better under-standing of the chang-es affecting the for-mal structures of texts. Based on this theo-ry, Fausto Curi’s book Il corpo di Dafne. Vari-azioni e metamorfosi del soggetto nella poe-sia moderna (Dafnes’ body. Variations and metamorphosis of the subject in modern po-etry), now published by Mimesis, Milano, and whose first chapter is reprinted here by “Poet-iche”, uses new criteria and new tools to deal with the work of major modern poets, such as Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Breton, Eliot, Pound, Marinetti, Palazzeschi, Montale, Sanguineti, etc.
Riassunto - Abstact
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 185-210
Fausto Curi
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica1 Freud, Lacan e altro
I
Si dica con il rispetto che meritano la sua fertile e inesausta azione didattica, certe sue scoperte e certe sue proposte, indub-
biamente interessanti e utili, ma non si può ne-gare che l’operazione compiuta da Lacan si fon-da preliminarmente su questo atto: dichiara-re una piena fedeltà a Freud e al tempo stesso piegare il pensiero di Freud ad alcune partico-lari esigenze della propria ricerca, alterandolo più o meno gravemente. Si guardi alla questio-ne dell’Io, che è certamente esemplare. Freud si limita a dichiarare che «L’Io non è padrone in casa propria», in riferimento alla circostanza che spesso l’Io è costretto a cedere alla coerci-zione esercitata dall’Es. è questa una pura con-statazione, non è affatto un tentativo di squa-lificare la funzione che l’Io esercita nella vita psichica. Tale funzione, che è, sostanzialmen-te, di mediazione fra le diverse e spesso contra-
1 è bene dichiararlo subito. Non perché altrimenti si tema di ingannare l’eventuale lettore (Tracce fin troppo evidenti di man-canza di professionalità vanificano il rischio). Ma affinché almeno la chiarezza tenga il luogo della professionalità mancante. E allo-ra: l’autore di queste pagine non è né un analista né uno psico-logo, è uno storico della letteratura. Totalmente sprovvisto sia di una formazione professionale sia, di conseguenza, della necessa-ria pratica clinica, egli non ha avuto a disposizione altri congrui e specifici strumenti che la lettura e la rilettura delle opere di Freud e di Groddeck, di qualche libro di Jung e di alcuni saggi di Lacan. Troppo poco per cimentarsi in un’impresa superiore alle sue for-ze, abbastanza per non riuscire a resistere al demone della curio-sità intellettuale. Che è notoriamente incurante della divisione del lavoro e delle distinzioni professionali.
Fausto Curi186
stanti esigenze dell’Es, del Super-io e del mon-do esterno, agli occhi di Freud rimane intatta e fondamentale, anche se, in più occasioni, egli non manca di dare tutto il suo peso alla pres-sione spesso incontenibile attuata dall’Es e dal Super-io. Per Freud l’Io è così poco un ente im-maginario che in Al di là del principio di piacere (opera assai cara a Lacan, il quale finisce per so-pravvalutarla) egli parla di un “Io coerente”. L’af-fermazione «L’Io non è padrone in casa propria», e altre analoghe, vanno direttamente collegate con la famosa dichiarazione «Wo Es war, soll Ich werden». Che, per essere intesa correttamente, va riportata nel contesto del periodo di cui fa parte. Dice infatti Freud che l’«intenzione» degli sforzi terapeutici della psicoanalisi «è in definiti-va di rafforzare l’Io, di renderlo più indipenden-te dal Super-io, di ampliare il suo campo percet-tivo e perfezionare la sua organizzazione, così che possa annettersi nuove zone dell’Es. Dove era l’Es, deve subentrare l’Io. è un’opera di ci-viltà, come ad esempio il prosciugamento dello Zuiderzee». Il testo non lascia dubbi. Tanto più che una tesi uguale a questa Freud aveva già sostenuto nel paragrafo «Rapporti di dipenden-za dell’Io» di L’Io e l’Es (1923): «La psicoanali-si è uno strumento inteso a rendere possibile la conquista progressiva dell’Es da parte dell’Io». Che altro fa l’analista in sede clinica se non cer-care di far «subentrare l’Io dove era l’Es»?
Incurante di tutto ciò, ma affermando di appoggiarsi all’autorità di Freud, Lacan tradu-ce arbitrariamente la frase tedesca in questo modo: «Là où fut ça, il me faut advenir», ossia «Là dove fu l’Es, debbo avvenire».2
2 Nonostante le precisazioni che egli fornisce nell’Avverten-za del traduttore, non si capisce perché Giacomo Contri, l’esper-to curatore degli Scritti di Lacan nell’edizione italiana di Einaudi, traduca con «così» il «ça», che notoriamente per Lacan indica l’Es.
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica 187
Lacan riduce l’Io a una costruzione immagi-naria, o, peggio, alla «malattia mentale dell’uo-mo», deprivandolo della funzione attribuitagli da Freud. Liquidato l’Io, non rimane, si capisce, che rivolgere tutta l’attenzione all’inconscio, so-vraccaricandolo anche di funzioni che Freud non gli ha mai conferito e che, stando alla teoria freudiana, ripugnano alla sua natura. E si noti, chi voglia tener conto del piano lessicale, che Lacan, con buone ragioni, parla quasi sempre di inconscio, di rado di Es, che, per quanto lo riguarda, quando deve nominarlo, egli indica di preferenza con il termine di «ça». Assumere l’Es come protagonista del proprio discorso avreb-be comportato un continuo, irrefutabile, pur se implicito, riferimento alla triade freudiana (Es, Io, Super-io), dove l’Io appariva cardinale e ine-liminabile, mentre l’uso del sostantivo «incon-scio» consentiva un’incontestabile ortodossia e al tempo stesso la possibilità di sottrarsi all’ob-bligo di quel riferimento.
La nota frase di Lacan «Penso dove non sono, dunque sono dove non penso» sollecita in-dubbiamente alla riflessione. Essa può essere interpretata, e così la interpretano i lacaniani, come una totale soppressione dell’Io, in quan-to l’Io né pensa né è, o, se pensa, non pensa il vero, e, insomma, non esiste; ma può significare anche, ci sembra, che l’Io è un Io ubiquo, mul-tiforme, policentrico, mutante, in cui coesisto-no inconscio e preconscio, e per questo è sfug-gente, ma esiste. Pensare l’Io come una funzio-ne, e non come una sostanza, o come un com-plesso di funzioni, non vuol dire, infatti, negar-ne l’esistenza. E come una funzione lo intende-va Freud. Il quale, pur giudicando fondamenta-le, come si è visto, la funzione dell’Io, suddivi-dendo in tre “province” l’apparato psichico abo-liva di fatto il soggetto o meglio la sua unità. Prima di lui, nella Volontà di potenza, Nietzsche
Fausto Curi188
aveva dichiarato: «Ammettere un soggetto non è forse necessario; forse è altrettanto lecito sup-porre una molteplicità di soggetti». Lacan, aboli-to l’Io, non abolisce però il soggetto, ma lo pensa come «il soggetto dell’inconscio». Che è un con-cetto e una denominazione che avrebbero fat-to infuriare Freud, tanto si oppongono alla sua idea di inconscio.
Un altro punto in cui la dottrina di Lacan appare contestabile è la tesi, veramente fonda-mentale, secondo la quale «l’inconscio è struttu-rato come un linguaggio». Non saremo noi, na-turalmente, a compiere la contestazione, sia per incompetenza, sia perché essa è già stata au-torevolmente attuata da due lacaniani ‘eretici’, Jean Laplanche e Serge Leclaire, autori del li-bro L’inconscio: un saggio psicoanalitico (Prati-che, Parma 1980; prima ediz. francese 1966). Secondo Lacan, osservano i due studiosi, si do-vrebbe «identificare ciò che Freud chiama il pro-cesso primario, il libero scorrere dell’energia li-bidinale […] con le leggi fondamentali della lin-guistica». Ma, essi obbiettano, «ciò che [Freud] mette in relazione col linguaggio è essenzialmen-te il sistema preconscio e il processo che lo ca-ratterizza: il processo secondario che, precisa-mente, oppone le sue dighe e i suoi sotterfugi al libero gioco dell’energia libidinale». Finalmente, sembra il caso di dire, due allievi di Lacan ci-tano Freud correttamente, senza alterarlo. Ciò che i due studiosi fanno seguire è in parte pre-vedibile, in parte sorprendente. Dopo aver op-portunamente ricordato che, per Freud, esiste «una distinzione capitale tra le rappresentazio-ni di cosa (Sachvorstellungen) e le rappresenta-zioni di parola (Wortvorstellungen)» e che men-tre le seconde comprendono la rappresentazio-ne di cosa più la rappresentazione di parole cor-rispondenti, le prime sono soltanto rappresen-tazioni di cosa, Laplanche e Leclaire osservano:
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica 189
… A livello del linguaggio preconscio, la distinzione del si-gnificante (le parole) e del significato (le “immagini”) esiste. A livello di linguaggio inconscio ci sono soltanto immagi-ni contemporaneamente e indissolubilmente in funzione di significanti e di significati. In un certo senso si può dire che la catena inconscia è puro senso, ma si può anche dire che è puro significante, puro non-senso, o anche aperta a tutti i sensi.
E chiedono poi:
Quanto allo statuto ontologico dell’inconscio […] dobbiamo ricordare che se c’è uno statuto di linguaggio, questo lin-guaggio non può in alcun modo essere uguagliato al nostro linguaggio “verbale”?
Dimostrazione impeccabile, ci pare, quella di Laplanche e Leclaire. Dopo la quale non si può non domandarsi: che ne è del «linguaggio dell’inconscio», di cui così spesso si parla, an-che da non lacaniani e da non analisti? La sola risposta congrua e persuasiva sembra essere: il linguaggio dell’inconscio è, in realtà, il linguag-gio del preconscio, giacché, se si tiene conto di ciò che dice Freud, è solo nel preconscio che può compiersi la verbalizzazione delle immagi-ni inconsce. Verbalizzazione di cui l’inconscio è incapace.
Ci sono però nel Motto di spirito alcune af-fermazioni che non possono non suscitare per-plessità. In primo luogo questa frase: «Un pen-siero preconscio viene abbandonato per un mo-mento all’elaborazione inconscia e ciò che ne ri-sulta viene colto immediatamente dalla percezio-ne cosciente»3. I teorici, che io ricordi, di solito trascurano una frase come questa. Mentre essa sembra contenere la soluzione di un problema estetico-genetico che da secoli affatica i filosofi: come nasce e si costituisce il testo poetico? Ma
3 Il corsivo è nel testo.
Fausto Curi190
Freud parla di «elaborazione inconscia». Cosa intende precisamente? L’«elaborazione incon-scia» si compie nel preconscio o nell’inconscio? Nel secondo caso, tutta la teoria freudiana del-le rappresentazioni di parola, possibili soltan-to nel preconscio, vedrebbe gravemente messa in dubbio la propria fondatezza. A pag. 158 del Motto di spirito troviamo una spiegazione che, se ben comprendiamo, per un verso risolve le nostre perplessità, giacché mostra che si tratta proprio di inconscio, di sistema Inc, per un altro verso le aggrava. Perché Freud dice:
Osserviamo […] il caso in cui trova espressione spirito-sa un pensiero […] Per far sì che questo pensiero diventi un motto, occorre evidentemente una scelta tra le possibi-li forme d’espressione […] Questa scelta, non è compiu-ta dall’attenzione cosciente; invece sarà certamente avvan-taggiata se l’investimento preconscio s’abbassa a quello inconscio, perché nell’inconscio […] i tramiti connettivi che si diramano dalle parole sono trattati allo stesso modo dei collegamenti tra le cose. L’investimento inconscio offre le condizioni di gran lunga più favorevoli alla scelta dell’e-spressione.
Se si tratta di un “pensiero”, esso, mental-mente, non può che avere una forma verbale, e sia pure una prima forma, suscettibile di tra-sformazioni. Come può una forma verbale esse-re “avvantaggiata” dall’abbassamento all’incon-scio, tranne che «l’investimento inconscio» non sia un puro investimento di energia pulsionale?
II
Dal poco che (senza, naturalmente, alcuna pretesa di originalità e di esaustività) si è cerca-to di mettere in luce risulta abbastanza chiaro, crediamo, quanto grande sia la distanza di La-can da Freud. E quanto poco fosse lecito pre-
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica 191
sentare come “ritorno a Freud” lo smantella-mento o l’alterazione di alcune delle principali sue teorie.
Un brillante tentativo di spiegare, e giustifi-care, il doppio comportamento di Lacan è quello esperito da un giovane analista lacaniano, Mas-simo Recalcati, nel suo libro Per Lacan (Bor-la, Roma 2005). Recalcati, sia detto a suo me-rito, è molto legato a Freud e si è segnalato re-centemente per la pubblicazione di due volumi di successo quali L’uomo senza inconscio (Raf-faello Cortina, Milano 2010) (molto importanti sono i primi quattro capitoli), e Cosa resta del padre? (Raffaello Cortina, 2011). Altre sue ope-re sono L’Universale e il singolare. Lacan e l’al di là del principio di piacere (Marcos y Marcos, Milano 1995), Jacques Lacan, in collaborazio-ne con A. Di Ciaccia (Bruno Mondadori, Milano 2000), Introduzione alla psicoanalisi contempo-ranea (Bruno Mondadori, 2003). Ma occorre se-gnalare anche il volume Il miracolo della forma. Per un’estetica psicoanalitica (Bruno Mondado-ri, 2007), che, come mette in evidenza il titolo, è un coraggioso e davvero stimolante tentativo di fondare un’estetica psicoanalitica, andando al di là di Freud e sviluppando, ancora una volta, certe intuizioni di Lacan.
A giudizio di Recalcati occorre «distinguere un campo lacaniano da un campo freudiano». La ricerca di Freud comprenderebbe due fasi. La prima fase manterrebbe la riflessione dentro l’orizzonte dell’Edipo, la seconda fase sarebbe caratterizzata da un oltrepassamento di quell’o-rizzonte, oltrepassamento consentito dalle sco-perte che Freud compie con Al di là del principio di piacere:
Nell’Edipo di Freud la Legge simbolica interviene a inter-dire il godimento incestuoso. […] La Legge agisce sbarran-do il godimento, introducendo un limite e la figura simbo-
Fausto Curi192
lica del Padre si pone come garante di questo limite. Con l’al di là del principio di piacere Freud introduce invece il reale di un godimento che si sottrae alla normativazione edipica. L’al di là del principio di piacere è infatti il modo freudiano per accostare l’al di là dell’Edipo. Il reale del To-destriebe scardina la logica dell’accordo tra Legge e desi-derio…
Quanto a Lacan, anche la sua ricerca va suddivisa in due fasi, delle quali la prima si ispira al «ritorno a Freud», la seconda si fon-da invece su «una ripresa a rovescio di Freud». Questa «ripresa a rovescio» si compie attraver-so due «svolte» della carriera lacaniana. La pri-ma “svolta” si manifesta nel Seminario intitola-to L’etica della psicoanalisi, che Lacan tiene nel 1959-1960 e che pubblicherà nel 1986 come Li-bro VII; la seconda “svolta” è segnata dal Semi-nario che ha per titolo Il rovescio della psicoa-nalisi, tenuto nel 1969-1970 e pubblicato nel 1991 come Libro XVII. Riassumiamo molto rapi-damente e molto schematicamente, sacrifican-do argomenti di particolare importanza, come, per esempio, quello costituito dalla Cosa (das Ding), cui Lacan, in L’etica della psicoanalisi, dedica ben due capitoli. Nei due Seminari La-can, compiuta una rilettura di Al di là del prin-cipio di piacere di Freud, ne ricaverebbe la con-vinzione che sussiste una contrapposizione net-ta del «godimento» al «piacere». Il «piacere» si dà nell’orizzonte dell’Edipo e della Legge del Padre, appartiene all’ordine simbolico e consiste so-pratutto nel mantenere il più possibile basso il livello delle tensioni interne. Il «godimento» (Jou-issance), invece, è «al di là del principio di pia-cere» in quanto è del tutto estraneo alla Leg-ge del Padre, non appartiene né all’ordine sim-bolico né all’ordine immaginario, dunque non è suscettibile di significazione. Assoggettato dalla coazione a ripetere, postosi cioè al servizio del-la pulsione di morte, esso consiste in un «godi-
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica 193
mento» che non ha nulla di vitale giacché ricon-duce l’essere umano allo stato preorganico.
Commenta Recalcati nel suo libro:
Con la pulsione di morte, con la scoperta dell’al di là del principio di piacere, Freud incontra qualcosa che resiste al mito edipico del Padre. Il secondo Freud, la “svolta di Freud”, prelude già ad un al di là dell’Edipo. In questo senso è Freud stesso a praticare e a rendere pensabile un post-freudismo. è Freud già post-freudiano.
Affermazione coraggiosa. Che contiene in-dubbiamente una certa verità. Non si può però tacere che se è vero che Freud non rinneghe-rà mai le ipotesi avanzate in Al di là del princi-pio di piacere, non è meno vero che tali ipotesi non sostanziano le principali opere che seguo-no quel libro né vi lasciano tracce significative4. Mentre per poter parlare di «svolta di Freud» e addirittura di «Freud già post-freudiano» sareb-be stato necessario che, concluso il libro sul-la coazione a ripetere e sulla pulsione di mor-te, il Maestro indirizzasse coerentemente tutto il suo cammino verso mete il cui nucleo profondo fosse costituito da quelle nozioni. Nell’orizzon-te di Freud l’Edipo non tramonta mai. Quan-to al Rovescio della psicoanalisi, Recalcati, con un’immagine efficace, sostiene che esso «è, se si vuole, il Seminario del parricidio lacaniano di Freud». Lo è anche se non si vuole. Ci guardia-mo bene, quindi, dallo smentire tale affermazio-ne, tuttavia conserviamo i nostri dubbi, se è le-cito, riguardo al fatto che il «parricidio di Freud» venga consumato soltanto a partire dal Semina-rio XVII. Che, come si è detto, Lacan tiene negli
4 Tacendo di altre opere, basterà pensare a L’Io e l’Es (1923), La negazione (1925), Inibizione, sintomo e angoscia (1926), Il disa-gio della civiltà (1930), Introduzione alla psicoanalis (nuova serie di lezioni) (1933), Analisi terminabile e interminabile (1937), Costru-zioni nell’analisi (1937).
Fausto Curi194
anni 1969-1970, anche se il testo viene pubbli-cato a Parigi solo nel 1991. Gli Écrits, che con-tengono tutti i principali saggi di Lacan, esclu-si i Seminari, appaiono presso Seuil nel 1966. La discordanza cronologica è dunque patente. Sempre che, si capisce, si sia disposti a ricono-scere che sono le massicce alterazioni del pen-siero freudiano presenti negli Écrits che costitu-iscono il vero «parricidio».
Tutto questo non significa che il lavoro di scavo compiuto da Lacan con L’etica della psi-coanalisi e con Il rovescio della psicoanalisi, es-sendo eterodosso, sia stato inutile. In quei due Seminari l’analisi di Lacan è, come spesso rie-sce ad essere, sottile, penetrante, affascinante. Che non sia né ortodossa (ma non vuole esser-lo) né del tutto persuasiva, che inquieti, solleci-ti, incalzi, ma lasci insoddisfatti, non toglie che certe proposte risultino particolarmente acute e stimolanti. Certo, non si può non ricordare che onestamente e prudentemente Freud ha segna-lato che Al di là del principio di piacere rimane nell’ambito della «speculazione», mentre Lacan ha edificato su quel libro una teoria che preten-de di essere scientifica. Detto questo, occorre al-meno aggiungere che, in un lettore diffidente, resta, fra altri, il sospetto che vi sia stata un’in-debita, anche se a volte fruttuosa, riduzione a linguistica della psicoanalisi, o almeno di alcu-ni fondamentali aspetti di essa. Per non parlare di certe ambiguità, o forse, meglio, di certe plu-ralità di senso. Spesso, in Lacan, il senso, piut-tosto che ambiguo, è inquieto, mutevole, strut-turalmente instabile, polimorfo, genera da sé al-tri sensi, a volte omogenei, a volte contrari. è un senso germinativo, ancipite, anzi multiplo. Si propone, si rovescia, rinasce diverso, eppu-re permane. Un esempio, tratto da L’etica della psicoanalisi:
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica 195
Se tutto ciò che è immanente o implicito nella catena degli eventi naturali può essere considerato come sottomesso a una pulsione detta di morte, è solo nella misura in cui c’è la catena significante. È in effetti esigibile in questo punto del pensiero di Freud che ciò di cui si tratta sia articolato come pulsione di distruzione, in quanto essa mette in cau-sa tutto ciò che esiste. Ma essa è pure volontà di creazione a partire da niente, volontà di ricominciare.
Ciò che in Freud è un evento della natu-ra più profonda, segreta, inconoscibile, e perciò stesso nella sua realtà occulta rimane indicibile – la pulsione di morte –, si trasforma in un fatto connesso con la «catena significante». La pulsio-ne di morte, come pulsione di distruzione, «met-te in causa». No, la pulsione di distruzione non «mette in causa», la pulsione di distruzione di-strugge, o tende a distruggere. Poi, improvviso, inaspettato, ingiustificato, totalmente estraneo a Freud, ma geniale, il rivolgimento: la pulsione di morte diventa anche «volontà di creazione a partire da niente, volontà di ricominciare».
Il linguaggio di Lacan è un linguaggio im-pervio, ostico, quasi inaccessibile, a volte im-motivatamente arduo? Impossibile negarlo. Ma questo passo (siamo sempre fra le pagine di L’e-tica della psicoanalisi), e non è l’unico, è incre-dibilmente limpido, agevole, pianamente dida-scalico:
Ciò che è inconscio funziona dal lato del principio di pia-cere. Il principio di realtà domina ciò che, conscio o pre-conscio, si presenta in ogni caso nell’ordine di un discorso meditato, articolabile, accessibile, proveniente dal precon-scio. […] I processi di pensiero, in quanto li domina il prin-cipio di piacere, sono inconsci. Freud lo sottolinea. Essi pervengono alla coscienza solo nella misura in cui li si può verbalizzare, nella misura in cui una spiegazione ragionata li mette alla portata del principio di realtà, alla portata di una coscienza sempre desta, interessata grazie all’investi-mento dell’attenzione a cogliere qualcosa che può prodursi e permetterle di orientarsi rispetto al mondo reale.
Fausto Curi196
Freud, a dire il vero, non dice che tutti i pro-cessi di pensiero sono inconsci, ma che «grandi zone» dell’Io e del Super-io lo sono. A parte ciò, per una volta, il passo è pienamente rispettoso dell’insegnamento freudiano.
Rispettoso di quell’insegnamento, e, forse, dello stesso Freud, non è sempre, invece, Il ro-vescio della psicoanalisi. Ma si tratta, appunto, di un «rovescio»… Spicca, in particolare, quel-lo che si potrebbe chiamare l’accanimento con-tro il complesso di Edipo. Accanimento che, dal punto di vista di Lacan, come si è accennato, non è sprovvisto di ragioni euristiche. Rinun-ciamo ad indugiare su certi argomenti, sia per-ché la loro trattazione non è né perspicua né del tutto persuasiva sia perché chiederebbe troppo lungo discorso. Non rinunciamo però a riferire almeno due esigui specimina. Dice Lacan, dopo aver ripetuto ancora una volta che «il deside-rio dell’uomo è il desiderio dell’Altro»: «…Il sape-re del padrone si produce come un sapere inte-ramente autonomo dal sapere mitico, ed è quel che si chiama scienza». Eccessiva chiarezza (nel senso che non c’era bisogno di Lacan per sape-re che la scienza è «autonoma» rispetto al mito) o eccessiva oscurità? Dice ancora: «Per stupido che possa essere, il discorso dell’inconscio ri-sponde a qualcosa che attiene alla istituzione dello stesso discorso del padrone. è questo che si chiama inconscio». Se capiamo bene, vi sa-rebbe, a questo punto, per Lacan, identità di in-conscio e «discorso del padrone». C’è qualcuno disposto ad accettare tale identità? Meglio guar-dare all’Edipo. Anche se ci viene detto che «L’E-dipo gioca il ruolo di un sapere con pretese di verità» ed è quindi «strettamente inutilizzabile». Conviene rifarsi al commento di Recalcati, so-brio ma abbastanza chiaro, pur nell’ambito di una lacaniana mancanza di chiarezza:
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica 197
L’agente della castrazione […] si dissocia dal padre e si re-alizza come significante-padrone. Con questa tesi Lacan apre l’al di là dell’Edipo innanzitutto disgiungendo il pa-dre dalla castrazione: la castrazione è un effetto della cate-na significante, è un effetto del linguaggio sul soggetto, che rende superfluo il riferimento alla figura ideale del Padre.
Abbastanza chiaro, abbiamo detto. Non così chiaro che non si desideri, se è lecito, un’e-segesi dell’esegesi.
III
Guardàti da un occhio non professionale, certi settori della psicoanalisi sembrano oggi ca-ratterizzarsi per la tendenza a congiungere i ne-cessari sviluppi teorici e clinici con un’accen-tuata presenza sociale. Forse la società uma-na non ha mai avuto, come oggi, tanto bisogno di un soccorso psicoanalitico di massa, forse la cultura odierna, per quanto riguarda il campo medico, non ammette una riflessione teorica se questa non si converte immediatamente in una proposta terapeutica collettiva, se, insomma, al di là della clinica, la teoria stessa, abbandonan-do i propri cieli, non si trasforma in una sorta di propedeutica generale alla tutela della salu-te. Fatto sta che certi libri si distinguono per-ché curano con uguale zelo l’elaborazione me-tapsicologica (tanto più in quanto sono stimola-ti dall’ineludibile confronto con le neuroscienze) e un discorso pedagogico che, essendo appun-to tale, e pur risultando arricchito dagli esiti di quella elaborazione, prima che agli specialisti si rivolge a comuni lettori. Un libro siffatto è Elogio dell’inconscio di Massimo Recalcati, pubblicato da Bruno Mondadori, che, pur uscito nel 2007, per l’acutezza delle sue analisi e la novità delle sue proposte merita ancora piena attenzione, e, credo, qualche riflessione e qualche ipotesi.
Fausto Curi198
Qual è l’inconscio di cui Recalcati tesse l’e-logio? è «l’inconscio freudiano», egli risponde. Non sembra facile persuadersene, a una prima lettura del suo libro. Che, comunque lo si giu-dichi, è una trattazione molto stimolante per chiunque – qualunque posizione occupi e qua-lunque professione eserciti – si interessi di psi-coanalisi. Diciamo subito, per incominciare, che, agli occhi di un (presunto, sedicente, mol-to selvaggio) freudiano ortodosso, l’inconscio di Recalcati pare, per molti aspetti, profondamen-te diverso dall’inconscio di Freud. Il quale ha sempre trattato con rispetto l’inconscio, met-tendone in luce la forza strapotente e la fonda-mentale importanza nella vita psichica e, quin-di, nella società umana, ma non lo ha mai elo-giato. Dal suo punto di vista, aveva buoni mo-tivi per non farlo. Nel saggio L’inconscio (1915), uno dei capolavori delle indagini metapsicologi-che freudiane, la descrizione dei «Caratteri spe-cifici del sistema Inc» è tanto precisa quanto lu-cida e distaccata:
Il nucleo dell’Inc è costituito da rappresentanze pulsiona-li che aspirano a scaricare il proprio investimento, dunque da moti di desiderio. Questi moti pulsionali sono(?) fra loro coordinati, esistono gli uni accanto agli altri senza influen-zarsi, e non si pongono in contraddizione reciproca. […] I processi del sistema Inc sono atemporali, e cioè non sono ordinati temporalmente, non sono alterati dal trascorrere del tempo, non hanno, insomma, alcun rapporto col tem-po. […] Parimenti, i processi inc non tengono in considera-zione neppure la realtà.
Le cose sostanzialmente non cambiano se dalla prima topica si passa alla seconda, e, quindi, dall’inconscio all’Es. Forse pago della descrizione fornita nel saggio del 1915, in L’Io e l’Es (1923) Freud indugia assai più nell’analisi dell’Io che sulla illustrazione dell’Es, del quale, scartando termini scientifici, si limita a dire che
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica 199
«è la sede delle passioni». Tanto poco scientifico sembra essere l’approccio che il saggio contiene il famoso (e assai efficace) paragone del caval-lo indomito (l’Es) e del cavaliere (l’Io) costretto a ubbidirgli per non essere sbalzato di sella. «L’Io non è padrone in casa propria», dirà non meno efficacemente altrove.
Esemplari per esaustività e chiarezza sono, infine, le pagine dedicate all’Es in Introduzione alla psicoanalisi (Nuova serie di lezioni), 1932. Scrive fra l’altro Freud che l’Es
è la parte oscura, inaccessibile della nostra personalità […] All’Es ci avviciniamo con paragoni: lo chiamiamo un caos, un crogiuolo di eccitamenti ribollenti. […] Attingen-do alle pulsioni, l’Es si riempie di energia, ma non possie-de un’organizzazione, non esprime una volontà unitaria, ma solo lo sforzo di ottenere soddisfacimento per i bisogni pulsionali nell’osservanza del principio di piacere. Le leggi del pensiero logico non valgono per i processi dell’Es, so-prattutto non vale il principio di contraddizione. […] Non vi è nulla nell’Es che si possa paragonare alla negazione […] Nulla si trova nell’Es che corrisponda all’idea di tem-po, nessun riconoscimento di uno scorrere temporale e […] nessuna alterazione del processo psichico ad opera del-lo scorrere del tempo. Impulsi di desiderio che non hanno mai varcato l’Es […] sono virtualmente immortali, si com-portano dopo decenni come se fossero appena accaduti. […] Investimenti pulsionali che esigono la scarica: a parer nostro nell’Es non c’è altro.
Nulla che possa far pensare a un elogio, in-vece una sorta di pacato sbalordimento senza sorpresa che probabilmente si rinnova da de-cenni, ogni volta che il Maestro ritorna sulle proprie scoperte.
è vero, Recalcati non parla di Es, parla di «inconscio», mai di Es, sempre di «inconscio». Si tratta di una scelta di cui occorre tener conto, perché essa aiuta a comprendere certe cose. Le ragioni sembrano essere evidenti. C’è, innanzi-tutto, l’esempio di Lacan, il quale, come si è vi-
Fausto Curi200
sto, senza per questo rifiutare la denominazio-ne di Es, preferisce quella di «inconscio». Ma c’è, soprattutto, il bisogno di non riferirsi a una de-terminata, determinatissima (anche questo si è visto) «provincia psichica» e di pensare invece a un universo, certo non generico, fornito, anzi, di caratteristiche precise, ma, come dire, panpsi-chico, trasversale, comprensivo, o inclusivo: l’u-niverso dell’inconscio. Ossia, usando termini freudiani, all’inconscio inteso non in senso to-pico ma in senso descrittivo; meglio, all’incon-scio quale Freud lo concepisce nella seconda to-pica. Il quale, spiega Freud, non occupa soltan-to l’Es, ma abita anche ampie sezioni delle al-tre istanze dell’apparato psichico. Fin da L’In-terpretazione dei sogni Freud si era infatti reso chiaramente conto che «l’inconscio è lo psichi-co reale nel vero senso della parola», con un’af-fermazione che, nei primissimi anni del Nove-cento, non poteva che suonare come rivoluzio-naria, ed era effettivamente tale, in un campo filosofico in gran parte ancora legato al Cogito di Cartesio, ma anche in un campo psicologico che non ignorava l’esistenza dell’inconscio ma era ancora ben lontano dal conoscerne l’impor-tanza nella normale vita quotidiana e il preci-so funzionamento. «L’inconscio – dunque lo psi-chico –…», aggiunge per soprammercato Freud. Non mancando di rafforzare la sua analisi con alcune illuminanti precisazioni: «… Le attività intellettuali più complesse sono possibili senza la partecipazione della coscienza»; «…I proces-si ideativi più complessi e corretti, ai quali non si negherà certo il nome di processi psichici, possono verificarsi senza stimolare la coscien-za del soggetto». Tanto da poter tranquillamen-te dichiarare: «Probabilmente siamo troppo in-clini a sopravvalutare il carattere conscio anche della produzione intellettuale e artistica». Negli anni successivi l’elaborazione metapsicologica,
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica 201
in una con l’individuazione e la descrizione delle tre istanze o province psichiche (inconscio, pre-conscio, conscio; Es, Io, Super-io), renderà più solido l’impianto generale e ribadirà la presen-za dell’inconscio in tutte e tre: «Sì, grandi zone dell’Io e del Super-io possono rimanere incon-sce, e normalmente sono inconsce» (Introduzio-ne alla psicoanalisi. Nuova serie di lezioni).
Abbiamo citato con forse eccessiva genero-sità, ma non senza, crediamo, qualche buona ragione. Perché non si tratta, ora, per noi, di contrapporre Recalcati a Freud, l’inconscio del primo all’inconscio del secondo. Si tratta di di-stinguere. Distinguere per cercare di arrivare a capire, noi per primi, s’intende, anche riper-correndo, forse un po’ noiosamente, una strada ben nota agli analisti.
E allora, ecco che le cose incominciano a chiarirsi. Quando Recalcati pronuncia un elogio dell’inconscio non compie un’operazione retori-ca ma dell’inconscio tenta di attuare una valo-rizzazione radicale, totale e coerente nei partico-lari che la costituiscono. E può farlo perché non si riferisce né al rimosso né al sistema Inc ma guarda all’inconscio che domina e spesso gover-na gran parte dell’universo psichico. Nessuna «provincia», nessuna «istanza», bensì la globa-lità del mondo psichico, ricco di risorse, aper-to sul mondo esterno, da cui riceve informazio-ni e stimolazioni. Si capisce allora come Recal-cati possa affidare all’inconscio responsabilità e compiti tanto impegnativi. Egli lo vede niente-meno come «una ragione dotata di un suo rigore etico e di una sua propria grammatica», giacché uno dei principali risultati raggiunti da Freud starebbe nell’aver proposto «l’inconscio stesso come una ragione»; e come «un’intenzionalità che si manifesta come irriducibile a quella della coscienza. Un’intenzionalità, un progetto, un’a-zione orientata da un fine e non un caos di pul-
Fausto Curi202
sioni in ebollizione». Ce n’è abbastanza, sem-bra, per dire, con compiacimento o con sdegno, che siamo di fronte a una seconda rivoluzione metapsicologica. O, forse, per tornare a parla-re, con assai minore originalità, di revisionismo freudiano. Senza tenere conto, nel caso, che, al-meno alcune volte, è proprio il “revisionismo” che ha mostrato e mostra la vitalità dell’inse-gnamento di Freud.
Chi, digiuno di psicoanalisi, voglia avere un’idea, molto approssimativa e parziale, e tut-tavia efficace, delle profonde trasformazioni che la dottrina psicoanalitica ha conosciuto in poco più di cent’anni, non ha da far altro che sape-re che, per Georg Groddeck, contemporaneo di Freud, l’inconscio non è altro che il residuo del-la nostra vita animale. Probabilmente Groddeck aveva ragione. E se Recalcati ha, a sua volta, ra-gione nel proporre l’ipotesi dell’inconscio come «intenzionalità» e come «progetto», ciò si deve sia al fatto che, mentre Groddeck si riferiva al siste-ma Inc, Recalcati ha invece in mente un incon-scio diffuso, non sistematico, sia, probabilmen-te, alla circostanza che, in un secolo, l’inconscio non ha potuto non mutare, almeno in parte, la propria natura ferina. Ma è mutato l’inconscio o è mutata l’idea che gli psicoanalisti si sono venuti facendo dell’inconscio? Nel primo caso, non c’è dubbio, sarebbe necessario rimeditare la dottrina di Freud secondo la quale l’inconscio non percepisce il tempo e quindi non è sogget-to ad esso.
Per la verità, se si prescindesse da ciò che ne dice Recalcati, dell’inconscio che egli ha in mente sapremmo assai poco. Né, in questo caso, varrebbe il ricorso a Freud. Non essendo, questo inconscio, un luogo, una sede, una «pro-vincia psichica», ma, piuttosto, un procedimen-
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica 203
to, una modalità funzionale non coglibile nel-la sua purezza, come è invece il sogno, o il sin-tomo, esso offriva scarsi appigli alla descrizio-ne, né il Maestro, una volta che ne ebbe messo in luce le straordinarie capacità di invenzione e elaborazione intellettuale, poteva essere sol-lecitato più di tanto a fornirne un’ampia anali-si. Difficile, se non impossibile, individuare l’og-getto. Che non è a sé stante, isolabile, ma dob-biamo immaginare, almeno fino a un certo se-gno, frammisto alla coscienza, o circondato da essa e ad essa contiguo. Certi «processi idea-tivi» di particolare complessità, ci dice Freud, sono inconsci: benissimo, dobbiamo però allora supporre che essi non possano sussistere sen-za la facoltà di accesso alla parola e che, insom-ma, si costituiscano quasi alle soglie della co-scienza. Nel citato saggio L’Inconscio Freud par-la di «sapere cosciente», precisando però che «la massima parte» di esso «deve comunque trovar-si per lunghissimi periodi di tempo in uno stato di latenza, e cioè di inconsapevolezza psichica». Una volta accertato che espressioni come «stato di latenza» e «inconsapevolezza psichica» sono equivalenti, o meglio sinonime, è agevole com-prendere che «l’inconscio» di cui discorre Recal-cati non è altro che un infinito campo di ener-gie latenti di cui gli esseri umani possono sem-pre e liberamente disporre. Resta da risolvere, per noi, la questione, che deleghiamo allo stesso Recalcati, se tale energia sia «libera» (freie Ener-gie) o «legata» (gebundene Energie). In quanto è latente essa è inconscia e in quanto è inconscia è, o dovrebbe essere, libera. Inconscia e libera, sì, ma funzionalizzata ad operazioni che finisco-no per travalicare la sfera dell’Io e per investire la sfera della «civiltà». Non si tratterà di una sor-ta di energia “meticcia”? O, guardando a quelle operazioni nella completezza del loro itinerario, non si tratterà invece di qualcosa che ha a che
Fausto Curi204
fare con il concetto di «compromesso», che è fon-damentale in Freud?
Comunque sia di ciò, vi è un dubbio che, fra altri, affiora in chi di Recalcati abbia letto il recente L’uomo senza inconscio. Dice l’autore in questo libro:
…L’esperienza dell’inconscio è un’esperienza del desiderio. Del desiderio, precisa Freud, in quanto indistruttibile, ov-vero impossibile da redimere, educare, governare, adatta-re. In questo senso l’indistruttibilità del desiderio evoca un nocciolo singolare che resiste a ogni addomesticamento, a ogni dressage normalizzante di tipo disciplinare. Il movi-mento del desiderio è un movimento insistente di apertu-ra verso l’Altro.
Se il desiderio, in quanto risulta «impossibi-le […] da governare», «resiste ad ogni addomesti-camento» (difficile non essere d’accordo), come è possibile pensare che sia suscettibile di essere imprigionato nell’«esperienza del limite»? E se è «impossibile da redimere», se è, insomma, una forza anarchica, come è possibile immaginare che il suo sia «un movimento insistente di aper-tura verso l’Altro»?
Anche se Recalcati si limita a parlare del «carattere fortemente dissonante della proposta psicoanalitica nei confronti della tendenza para-noica che l’etica nel nostro tempo sta assumen-do», il suo progetto, ancorché discutibile, è af-fascinante e rivoluzionario nella misura in cui ambisce trasferire all’universo psichico funzioni e attività che, dall’inizio della civiltà, sono sem-pre state proprie della ragione. Non vi è il ri-schio, badiamo bene, di una sconfitta della ra-gione, o di una caduta nell’irrazionalismo. Si tratta, al contrario, di preservare la ragione da ogni minaccia di repressione e da ogni rischio di eclissi fortificandola con le risorse che solo l’in-conscio può fornire, o, meglio, di portare alla
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica 205
luce e di rendere beneficamente attivo un nu-cleo della vita psichica per millenni ignorato o guardato con sospetto e timore. In certe biblio-teche esiste “l’Inferno”, la zona in cui sono rele-gati i libri proibiti, osceni o maledetti. Il proget-to di Recalcati vuole riscattare “l’Inferno” della nostra vita psichica, liberarlo dalle maledizioni che per tanto tempo l’hanno colpito, e ancora oggi lo colpiscono, riconoscerne pienamente la dignità e la funzionalità. L’elogio dell’inconscio, insomma, tende a convertirsi in un’opera di re-denzione. Utopia? Può darsi. Ma, anche pre-scindendo dalla circostanza che l’utopia è spes-so un modo di rimettere in moto la storia (L’uto-pia è il desiderio nella sua forma collettiva), gli oggetti di cui tratta Recalcati, a dispetto di certe banalizzazioni spiritualistiche da cui egli è im-mune, sono oggetti materiali. Contro i quali alla fine è destinata ad infrangersi, posto che sussi-sta, ogni ingannevole tensione utopica.
Certo, Freud ha, come sempre, aperto la strada. Un conto è però prendere atto che «pro-cessi ideativi» complessi possono essere incon-sci, un conto ben diverso è attribuire diretta-mente all’inconscio la capacità di agire come una seconda ragione o una seconda coscienza. A questo proposito non si può non chiedersi: che ne è della coscienza nel nuovo universo psi-chico inconsciocentrico disegnato da Recalca-ti? Nessuna caduta nell’irrazionalismo, abbia-mo detto. Ma ci accontenteremo di sapere che, spettando all’inconscio ogni iniziativa, alla co-scienza, o, se si preferisce, alla ragione, rimane solo un compito di controllo?
A fronte di ciò che di nuovo e stimolan-te propone (nuovo, ci sembra, anche rispetto a Lacan, di cui pure riprende e sviluppa cer-ti spunti), la teoria elaborata da Recalcati pre-senta alcuni aspetti che non possono non su-
Fausto Curi206
scitare perplessità, se non dissenso. Sorpren-de, e dispiace, in primo luogo, che un teorico tanto coraggioso e di così strenua e aperta in-telligenza arrivi a formulare una dottrina che nega ogni «ideologia della liberazione» e fini-sca per assumere, nella vita culturale e sociale, una prospettiva riformistica e antirivoluziona-ria. Un’ideologia riformistica, d’altro canto, cir-cola in tutta la teoria di Recalcati, che, per al-tri aspetti, sembra invece accendere la speran-za di un rovesciamento dei vecchi assetti e di un rinnovamento radicale. Non vi è dunque in-coerenza in lui, vi è, semmai, a margine del suo libro, lo sguardo conquistato e illuso del suo lettore. Conquistato soprattutto dal discorso sul desiderio, che è davvero centrale nella trat-tazione di Recalcati e che è tanto affascinante quanto, alla fine, non dirò deludente, ma certo tale da inquietare e lasciare inappagati coloro che a quel discorso si siano affidati. È indub-bio, come egli propone, che compito di ciascuno sia l’«assunzione» del proprio desiderio, che non va negato o ignorato, dal momento che è in esso la vitalità e la verità dell’esistenza di tutti noi, la possibilità di ogni invenzione e costruzione umana. Ed è persino accettabile, forse, che, in certi casi, in certe situazioni, sia «l’esperienza del limite» su cui esso dovrebbe fondarsi a ren-dere benefico e produttivo il desiderio. Su che cosa precisamente consista «l’assunzione» del desiderio sarebbe stato opportuno, tuttavia, ri-volgendosi a un pubblico di non analisti, forni-re più didascaliche precisazioni. Se si dovesse interpretare tale «assunzione» in termini freu-diani, si avrebbero di fronte, sembra, due pos-sibilità: o «l’assunzione» corrisponde al soddi-sfacimento, o essa va identificata con la subli-mazione, qualora il desiderio altro non sia che il desiderio sessuale, e cioè la libido. Recalca-ti però sembra avere in mente una terza possi-
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica 207
bilità, pensando il desiderio come una sorta di grande e inesauribile riserva energetica.
Ma è benefico e produttivo immaginare l’e-sistenza umana come del tutto priva di ecces-si, di infrazioni, di violazioni, chiuderla e sigil-larla una volta per tutte in una tranquillizzan-te e narcotizzante «esperienza del limite»? Re-calcati, peraltro, passa dalla coerenza all’incoe-renza quando scrive: «Ogni volta che c’è inven-zione, creazione, atto, poesia c’è inevitabilmen-te infrazione, sovversione, alterazione, deviazio-ne soggettiva dal codice simbolico universale di riferimento». Felice incoerenza, non c’è dub-bio, ma pur sempre incoerenza: come si con-ciliano queste parole con l’elogio dell’“esperien-za del limite”? Dunque «l’esperienza del limite» non sarebbe inventiva, non sarebbe creativa. Per quale motivo, allora, assumerla, farne il nu-cleo fondamentale della nostra vita? Lo stesso Elogio dell’inconscio, pur non senza cautele e ri-chiami al senso di responsabilità, nasce da un atto eversivo. Ed è vitale e inventivo in quanto è eversivo. Si comprende allora perché, mentre la teoria generale su cui il libro poggia è rivolu-zionaria, sono riformistiche certe proposte par-ticolari. La vita psichica consentita dal «disa-gio della civiltà» ammette eccezioni, scarti, vio-lazioni purché essi siano bilanciati e tenuti sot-to controllo dalla repressione o dalla sublima-zione delle pulsioni. Ciò che conta non è la feli-cità degli esseri umani; ciò che conta – sembra – è la «civiltà», la quale, nella sua manifestazio-ne più moderata e tollerabile, è «l’esperienza del limite». Recalcati non dice esplicitamente que-sto, ma certe parti della sua proposta sembrano orientate verso conclusioni analoghe a queste.
Probabilmente, però, se non sbagliato, è improprio parlare di coerenza e di incoerenza. La materia trattata da Recalcati è troppo com-plessa e incognita per consentire un comporta-
Fausto Curi208
mento teorico univoco. Da un punto di vista psi-cologico ubbidienza alla Legge e infrazione del-la Legge sono ugualmente necessarie e legitti-me. Il problema è: sarà davvero possibile conci-liare inconscio e «esperienza del limite», deside-rio e «civiltà»?
Vi è però dell’altro e si tratta, per me, di ciò che non è meno importante. Da Sade a Leopar-di, da Leopardi a Byron, da Byron a Baudelai-re, da Baudelaire a Lautréamont, da Lautrèa-mont a Rimbaud, da Rimbaud a Nietzsche, da Nietzsche ad Artaud, da Artaud a Bataille, vi è tutto un filone della letteratura occidentale, ed è il filone maggiore, che si fonda sulla protesta, sullo scarto, sull’infrazione, sull’eccesso, sulla rottura dell’«esperienza del limite». Come dob-biamo considerare gli scrittori che fanno par-te di quel filone: degli illusi, dei piagnoni, degli estranei, dei fuorilegge, dei sovversivi, o, peg-gio dei testimoni irrilevanti di vicende persona-li? Non saranno, semmai, i testimoni e i con-fessori di eventi umani universali, ad attestare che il trauma, il lutto, il dolore, e, per contro, la ricerca inesausta del piacere sono aspetti con-sustanziali della condizione umana? Non sarà che, oltre alla verità presente nel desiderio as-sunto e nel limite rispettato, vi è anche la verità dell’eccesso e del limite violato? Milioni di donne e di uomini hanno sperato per anni nella libe-razione, milioni, contro ogni appagante riformi-smo, ancora vi sperano: erano, sono degli illusi, o degli squilibrati? Chi ogni giorno della propria vita è alle prese con la fame, con la miseria, con la tirannide, con la repressione, con la tortura, può affidarsi alla speranza che sarà solo il porre un confine al proprio desiderio che lo riscatte-rà? Chi muore sconsolato e disperato può dav-vero pensare che i suoi figli, o i figli dei suoi figli, saranno un giorno liberi e contenti se avranno
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica 209
saputo accettare e vivere l’«esperienza del limi-te»? Tutti costoro – e Recalcati lo sa bene – chie-dono giustizia prima che equilibrio psichico.
La pagina di Recalcati, in Elogio dell’incon-scio, è piana e limpida come a volte non è nei volumi dedicati a Lacan. Spesso conquista non solo perché è persuasiva, ma anche perché è ap-passionata e sa accendere la speranza. è però, a tratti, pur senza provocare fastidio, oltre che pedagogica, anche ortatoria, prescrittiva, otti-mistica, talvolta persino predicatoria. La pagi-na di Freud non lo è mai. Un saggio come Il di-sagio della civiltà è stupendo anche per le ama-rissime verità che riesce a dire con ferma paca-tezza e lucido pessimismo. Forse la novità della nuova psicoanalisi sta soprattutto qui, nel far-si dottrina nel senso etimologico della parola, nel proporsi come una metapsicologia pragma-tica e, addirittura, come una nuova etica. Del resto un aspetto centrale dell’insegnamento di Lacan è proprio l’ambizione a fare della psicoa-nalisi un’etica. Oltre il titolo, L’etica della psico-analisi reca, fin dalle prime pagine, dichiarazio-ni assai significative: «…Non c’è nessuno nella psicoanalisi che non sia stato tentato di tratta-re il tema di una qualche etica, e non sono io ad aver creato questo termine. è allo stesso tempo impossibile misconoscere che, per dire le cose come stanno, siamo immersi nei problemi mo-rali fino al collo». E più avanti Lacan parla della «nostra pratica in quanto etica».
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica. Freud, Lacan e altro - New psychoanalysis and prag-matic metapsychology. Freud, Lacan and others
Fausto Curi
Passando in rassegna alcune delle principali teorie di Freud e di La-can, il quale è qui vi-sto non come un fede-le seguace di Freud, ma come colui che ne ha profondamente mu-tato la dottrina, Fau-sto Curi esamina il li-bro dello psicoanalista lacaniano Massimo Re-calcati Elogio dell’in-conscio. Dodici argo-menti in difesa della psicoanalisi, mettendo in luce soprattutto che, per Recalcati, “l’incon-scio non è l’antiragione ma il cuore della ragio-ne”. Ne derivano una teoria e una pratica della psicoanalisi che, pur non senza frequen-ti richiami a Lacan, e non senza prese di po-sizione a volte discuti-bili, mostrano notevoli e apprezzabili novità di impostazione.
Reviewing some of the main theories by Freud and Lacan, who is con-sidered not as a loyal disciple of Freud, but as the scientist who radically changes his doctrine, Fausto Curi examines the book by lacanian psychoanal-ist Massimo Recalca-ti, Elogio dell’inconscio. Dodici argomenti in difesa della psicoanali-si (The Praise of the Un-conscious. Twelve ar-guments in defence of psychoanalisis), high-lighting the fact that, according to Recalcati, ”the unconscious is not the opposite of reason but the core of reason”. From this assumption originate a theory and a praxis of the psycho-analysis that, although frequently referring to Lacan, and mak-ing some questionable statements, display a new and noteworthy approach.
Riassunto - Abstact
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 211-235
ElisabEtta CaldEroni
Arte e civiltà urbana nel giovaneD’Annunzio giornalista
L’onnivora curiosità e il desiderio di essere protagonista portano Gabriele D’Annunzio a riflettere sul contesto urbano che lo cir-
conda, interpretandolo con straordinario acume nella propria attività letteraria. Particolarmen-te interessante è cogliere i prodromi di quest’at-titudine su pagine poco note, quelle degli ar-ticoli redatti per il «Fanfulla» e per il suo sup-plemento domenicale, per la «Cronaca Bizanti-na», per il «Capitan Fracassa» e soprattutto per la «Tribuna»1. In tali sedi, all’ombra di pseudo-nimi, il giovanissimo poeta allestisce un profi-cuo laboratorio di scrittura giornalistica, estre-mamente ricettiva nei confronti di tutte le sug-gestioni offertegli dalla Roma dell’ultimo Otto-cento.
Infatti, oltre a proclamarsi esteta ed «adora-tore della santa Natura», egli nutre un profondo interesse nei confronti della città e soprattutto della metropoli: qui risiede, a suo avviso, un’«a-nima collettiva», dinamica e volta alla costruzio-ne del futuro2. Il poeta se ne mostra convinto
1 È stata Annamaria Andreoli a curare l’edizione di tutti gli articoli dannunziani, distinguendo la fase giovanile, più speri-mentale, da quella matura: G. d’annunzio, Scritti giornalistici 1882-1888, Milano, Mondadori 1996 e Id., Scritti giornalistici 1889-1938, ivi, 2003 (d’ora in avanti, rispettivamente, SG1 e SG2).
2 Un giovanissimo D’Annunzio, sotto lo pseudonimo di «Bull-Calf», si definisce «adoratore della santa Natura» sul «Fanfulla» del 30 gennaio 1882, nell’articolo Effetti di luce. Le considerazioni sul-la città sono vergate invece una decina d’anni più tardi per la «Tri-buna», in Preambolo, da un intellettuale ormai esperto, «giornalista militante e di alto profilo» impegnato fieramente nella difesa «del-la Bellezza inutile e pura». SG1, pp. 7-9, citazione a p. 7. SG2, pp.
ElisabEtta CaldEroni212
il 7 giugno 1893, presentandosi ai lettori della «Tribuna» con l’articolo Preambolo:
La conoscenza dell’idea si sviluppò sempre – e soltanto – là dove molti uomini erano adunati, là dove ferveva la lotta e si moltiplicavano gli sforzi. […] Conviene dunque all’artista moderno immergersi di tratto in tratto nelle medie corren-ti vitali e mettere la propria anima in contatto con l’anima collettiva per sentirne la tendenza oscura ma incessante e inarrestabile, – se egli aspira a divenire l’interprete e il messaggero del suo tempo3.
Del resto, lo scrittore nel corso della pro-pria vita alterna sempre momenti di ritiro pen-soso a periodi di fervida attività cittadina. La sera del 28 dicembre 1898, seguendo la tournée di Eleonora Duse in Alessandria d’Egitto, com-menta sui Taccuini: «Tutti quelli che si lamenta-no e si desolano perché le sedi della Bellezza e del Sogno sono invase dal tram e dalla ferrovia, sono impotenti. Io mi sono inebriato leggendo il Baedeker, bevendo lo Champagne, al Cairo»4. Lo attrae, quindi, proprio l’oggetto di riflessio-ne degl’intellettuali europei tra XIX e XX secolo: la città moderna, cuore della civiltà industriale e crogiuolo di una società nuova. Essa attira e concentra grandi masse d’uomini con innovati-ve possibilità di lavoro ed inediti e dinamici sti-li di vita5. Non diversamente da Charles Baude-
195-200, citazioni a pp. XIII, 200. Ancora utili Le cronache de «La Tribuna» (1882-1888), a cura di R. Puletti, Bologna, M. Boni 1992; indispensabile M. GazzEtti, D’Annunzio giornalista nella cultura eu-ropea della fine del secolo (1883-1888), Pisa, Pacini 1986.
3 SG2, p. 200. 4 Si tratta del taccuino XXV. G. d’annunzio, Taccuini, a cura
di E. Bianchetti e R. Forcella, Milano, Mondadori 1965, p. 302.5 Non sarà un caso se, dal 1927 fino alla morte, Benjamin
cercherà l’«espressione definitiva» di «tutti i motivi del suo pensie-ro» tentando la «ricostruzione storica globale del XIX secolo nel-lo specchio di una città»: Parigi, capitale del XIX secolo. Cfr. W. bEnjamin, Parigi, capitale del XIX secolo, a cura di R. Tiedemann, Torino, Einaudi 1986, p. VII.
Arte e civiltà urbana nel giovane D’Annunzio giornalista 213
laire, secondo D’Annunzio l’artista contempora-neo deve «sposare la folla» metropolitana, radi-calmente diversa dalla popolazione cittadina di un tempo6. La modernizzazione urbana, infatti, s’impone agli abitanti, mutandone anche l’im-maginario. Il paesaggio tradizionale scompare tra l’addensarsi delle fabbriche in periferie sem-pre più grandi e gli sventramenti dei piani rego-latori che aprono il centro cittadino all’intenso traffico ed alla vita sociale dei boulevards.
Tuttavia, il giovane giornalista a Roma spe-rimenta non un’avanzata metropoli industriale, bensì quella Città Eterna che il governo libera-le intende trasformare da «addormentata» sede di memorie in propulsiva capitale della «nuova Italia»7. Alla sua attenzione si offre perciò un pe-culiare milieu composto di antico e moderno, di stasi e movimento. Da un lato, le mutate con-dizioni politiche stimolano fortemente l’immigra-zione e la città si anima di nuovi strati cittadini, provenienti da tutta la penisola8. Dall’altro, resta inalterato il carattere terziario e non produttivo della sua economia, anche perché la classe diri-gente di età umbertina intende evitare agglome-rati di povere periferie ed agitazioni operaie9. Il dinamismo consentito da nuovi abitanti, mercati e progetti si trova perciò a dover fare i conti con la spiccata fisionomia amministrativo-burocrati-ca e con tradizionali eredità ed arretratezze10.
6 Cfr. Baudelaire: il modernismo per le strade, terzo capitolo di M. bErman, L’esperienza della modernità, tr. it., Bologna, Il Mu-lino, 1985; citazione a p. 185.
7 V. Vidotto, Introduzione e M. CasCiato, Lo sviluppo urbano e il disegno della città, in Roma capitale, a cura di V. Vidotto, Ro-ma-Bari, Laterza 2002, pp. VII e 126.
8 F. bartolini, Condizioni di vita e identità sociali: nascita di una metropoli, in Roma capitale, cit., pp. 3-9, 17-23; suggestivo G. FontErossi, Roma fine Ottocento, Roma, Edizioni moderne Ca-nesi 1960.
9 G. PaGnotta, L’economia, in Roma capitale, cit., p. 213.10 Ibidem.
ElisabEtta CaldEroni214
Eredità fondamentale, che agli occhi dei più esaurisce l’identità romana, è costituita da mo-numenti e vestigia dell’Antichità e del Rinasci-mento. Definendo il volto urbano, essi sono in-sieme all’origine di una «sconfinata ammirazio-ne» per la città soprattutto da parte degli stra-nieri e di difficoltà strutturali per i cambiamenti demografici e d’immagine della nuova capitale11. Roma è impreparata all’arrivo di tanti funziona-ri, politici, imprenditori e più in generale di tut-ti quegli uomini in cerca di fortuna che faranno raddoppiare la popolazione nell’ultimo trenten-nio del XIX secolo. Manca di un adeguato siste-ma di trasporto pubblico, di una rete stradale moderna, di alloggi, ed affida in molti casi la ri-sposta all’«iniziativa privata, incapace di risolve-re le questioni di grande scala»12.
Il poeta abruzzese, in fondo anch’egli un immigrato alla ricerca del successo, giunge a Roma in un momento cruciale della storia ur-banistica. Agli espropri dei beni ecclesiastici, ai provvedimenti d’emergenza ed agli aumenti ver-tiginosi degli affitti sta succedendo infatti quella speculazione edilizia che insieme rinnova il vol-to della città e crea grande fermento economi-co13. Così, sempre in Preambolo, D’Annunzio ri-evoca acutamente quegli anni:
Era il tempo in cui più torbida ferveva l’operosità dei di-struttori o dei costruttori sul suolo di Roma. Insieme con nuvoli di polvere si propagava una specie di follia edifica-toria, come un turbine improvviso, afferrando non soltan-
11 M. CasCiato, Lo sviluppo urbano e il disegno della città, cit., p. 125. Testimonianze fotografiche d’epoca, assai perspicue, in Roma: il riuso dell’antico. Fotografia tra XIX e XX secolo, a cura di G. Borghini, P. Callegari, L. Nista, Bologna, Bononia Universi-ty Press, 2004.
12 M. CasCiato, Lo sviluppo urbano e il disegno della città, cit., pp. 139, 142, 145.
13 M. CasCiato, Lo sviluppo urbano e il disegno della città, cit. e G. PaGnotta, L’economia, cit., pp. 135-142, 213-214, 221-225.
Arte e civiltà urbana nel giovane D’Annunzio giornalista 215
to i familiari della calce e del mattone ma ben anche i più schivi eredi dei majorascati papali, che avevano fino allo-ra guardato con dispregio gli intrusi dalle finestre dei pa-lazzi di travertino incrollabili sotto la crosta dei secoli. […][…] cresceva rapidamente l’opera brutale che doveva occu-pare i luoghi già per tanta età sacri alla Bellezza e al Sogno.Sembrava che soffiasse su Roma un vento di barbarie e minacciasse di strapparle quella raggiante corona di ville gentilizie a cui nulla è paragonabile nel mondo delle me-morie e della poesia. […]Fu allora, da per tutto, come un contagio di volgarità. Nel contrasto incessante degli affari, nella furia quasi feroce degli appetiti e delle passioni, nell’esercizio disordinato ed esclusivo delle attività utili, ogni senso estetico fu smarri-to, ogni rispetto del passato fu deposto14.
In questo contesto rivendica per sé un ruo-lo preciso, quello di pubblico difensore dell’«in-tegrità estetica di Roma»
in assoluto contrasto con la moltitudine diffusa su cui il giornale esercitava il suo influsso cotidiano.Tutte le cose elette delicate ed estremamente rare ebbe-ro qui il loro inno; di tutti gli artefici isolati e misconosciu-ti fu fatto qui l’elogio iperbolico; a tutte le forme più alte e più acute dell’arte fu reso omaggio. Le invettive contro i di-struttori di Villa Ludovisi s’alternarono con le decapitazio-ni dei pittori ciociari che avevano bruttato il palazzo del-le Arti Belle15.
In Preambolo il poeta intende accreditare presso i lettori l’alto profilo del proprio giornali-smo militante denunciando il boom edilizio degli anni Ottanta ormai inceppato con gravi riper-cussioni economiche, finanziare e politiche16.
14 SG2, pp. 195-196.15 Ivi, p. 197.16 La frenetica costruzione di abitazioni ed opere di pubblica
utilità, retta da un circolo vizioso di prestiti, cambiali ed ipoteche, giunse nel 1887 alla saturazione del mercato mentre i prezzi dei terreni erano arrivati alle stelle. Siccome quello edilizio era dive-nuto il settore trainante dell’economia cittadina dal 1883, dilagò la disoccupazione mentre diverse grandi banche furono coinvolte.
ElisabEtta CaldEroni216
Sorretto da un’attenta e moderna riflessione sul potere dei media, inequivocabile indizio dell’u-so dell’esperienza in una redazione, indica come sia possibile sfruttare la pervasività tipica del-la scrittura giornalistica per battaglie meritorie. Esse rivelano tanto la partecipazione allo spiri-to del suo tempo quanto un gusto vicino al no-stro, attento all’impatto che la vita contempora-nea ha sulle tracce del passato.
Infatti, aspetto fondamentale, ma miscono-sciuto dell’estetismo dannunziano, è un impe-gno nella difesa dei beni culturali ed ambienta-li destinato a sopravvivere alla sua origine con-tingente, ossia all’attenzione rivolta ai problemi specifici della città d’arte per eccellenza17. Le co-lonne dei giornali costituiscono per D’Annunzio le sedi predilette per denunciare l’abbandono all’incuria o alla speculazione edilizia di gemme dell’arte italiana e per stimolare ampi strati del-la popolazione ad una più avvertita sensibilità. Sempre in Preambolo si legge:
[…] non sempre, in verità, quell’assiduo lavoro di propa-gazione estetica riuscì vano: anzi, ebbe qualche effetto in-sperato.L’idea seminata nel giornale, più che nel libro, o prima o poi germina e produce il suo frutto. E non v’è forse spiri-to ottuso di lettore, in cui l’insistenza di chi scrive non rie-sca a produrre qualche fenditura, ad aprire un piccolo var-co. Inoltre, la passione ha una efficacia straordinaria su la massa popolare. Tutti i sostenitori appassionati di un’i-dea emanano una forza suggestiva più cattivante di qual-siasi sofisma18.
Soprattutto, lo scandalo travolse la Banca Romana, che aveva fi-nanziato Crispi e Giolitti – il cui governo cadde proprio alla fine del 1893. Cfr. G. PaGnotta, L’economia, cit., pp. 221-225.
17 SG2, p. XX; cfr. A. andrEoli, D’Annunzio, l’uomo, l’eroe, il poeta, Roma, De Luca 2010, pp. 43-51.
18 SG2, p. 198.
Arte e civiltà urbana nel giovane D’Annunzio giornalista 217
Proprio per questo il «Mattino» ospita nel 1892 il richiamo di D’Annunzio all’allora Mini-stro dell’Istruzione Pasquale Villari per la cura del «più bello e più importante monumento dell’arte romanica in Italia», la basilica di San Clemente a Casauria, dimenticata ed in rovi-na19. Allo stesso modo, il «Corriere della Sera» costituisce in séguito lo strumento d’opposi-zione del poeta all’abbattimento di tre storiche torri bolognesi in ordine al riordino di via Riz-zoli per l’innalzamento del nuovo Palazzo del-la Provincia nel 1917 e nel 1926 alle demolizio-ni necessarie nel centro storico di Firenze al fine d’impiantarvi una lussuosa galleria tra il Bat-tistero di San Giovanni e Borgo San Lorenzo20.
Com’è noto, saranno solo le devastazioni portate dalle due Guerre Mondiali a far matu-rare criticamente l’esigenza di specifiche norme di tutela21. Prima ancora, però, i grandi sventra-
19 L’articolo, del 30-31 marzo, s’intitola esattamente L’ab-bazia abbandonata. A Pasquale Villari. Ivi, pp. 25-29; citazione a p. 28.
20 Si tratta di Per la salvezza di tre storiche torri bolognesi, del 23 aprile, e di La galleria nel centro di Firenze. Una lettera di Gabriele D’Annunzio, del 25 marzo, firmato «Principe di Montene-voso». Ivi, pp. 691-692, 780-781.
21 L’UNESCO elabora la definizione e la prima normativa a tutela dei beni culturali tra il 1949 ed il 1954; l’Italia lavorerà alla propria normativa nazionale dal 1964. La nuova sensibilità è figlia perciò delle due Guerre Mondiali, come riconosce anche il «Co-mandante D’Annunzio» a proposito delle torri di Bologna: «Que-sta divina e spietata guerra, che cancella interamente col medesi-mo acciaio le facce degli uomini e quelle dei luoghi, ha reso in noi più patetico il senso della vita murale costruita e nutrita dai se-coli e dalle generazioni, non imitabile né sostituibile mai». Si noti che il poeta reagisce alla speculazione borghese: durante la Prima Guerra Mondiale riconosce invece, nel discorso Voci della riscos-sa. Alle reclute del ’99 pubblicato dal «Corriere della Sera» nel Na-tale del ’17, come la ricchezza artistica del nostro paese, squisita, ma gravosa, sia pronta per essere sacrificata. Il genio della civiltà italiana si spegnerebbe altrimenti in un museo vigilato da «custo-di vacillanti» e non continuerebbe eroicamente a brillare nella sua gente, «creatrice col proprio stesso sangue dell’opera d’arte vera e suprema». L’esteta è assorbito dal superuomo e rintraccia l’eredità
ElisabEtta CaldEroni218
menti per la rete viaria e la febbre edilizia che stravolgono, come un «immenso tumore bianca-stro», il centro di Roma dopo il piano regolatore del 1882 suscitano già l’indignata reazione del giovane scrittore22. Con pungente ironia o ram-marico, egli denuncia lo spirito industriale ed affaristico che guida con grossolanità ed igno-ranza le sorti dell’edilizia, mentre abbandona all’incuria ed alla distruzione i tesori del passa-to. Ha come bersaglio, però, solo la classe bor-ghese. D’Annunzio tace invece le colpe dell’ari-stocrazia terriera romana che «non appena […] ha scoperto la possibilità di realizzare un po’ di soldi con le magnifiche ville che i loro antenati avevano costruito […] non ha esitato un minuto a vendere, metro per metro, la gloria e l’orgoglio delle loro famiglie»:
La costruzione della città moderna cancella l’impareggia-bile paesaggio che si era formato nel migliaio di ettari non costruiti all’interno delle mura: l’insieme di vigne, orti e grandi ville che in quella campagna si erano insediate dal Cinquecento in poi. Scompaiono decine di strutture mo-numentali e sparisce soprattutto uno scenario che aveva reso unica la città di Roma23.
Caso emblematico è la distruzione della Vil-la Ludovisi, venduta dal principe di Venosa ad
dell’«artiere» italiano nella stirpe e non nel patrimonio monumen-tale. SG2, pp. 691, 709-717, 1695, 1700-1701; V. oriolEs, “Beni culturali”: genesi e fortuna di un’espressione giuridica, in id., Per-corsi di parole, Roma, Il Calamo 2006, pp. 53-59.
22 Fortunatamente, non solo la sua: in quel decennio ha «inizio una politica di protezione rivolta ad alcuni ambiti di par-ticolare interesse archeologico e monumentale, e vedono la luce iniziative volte ad ampliare le conoscenze della città antica, so-prattutto attraverso lo studio e scavo dell’area centrale dei Fori». SG2, p. 196; M. CasCiato, Lo sviluppo urbano e il disegno della cit-tà, cit., p. 150.
23 Ivi, pp. 150, 151. Ulteriore bibliografia in D’Annunzio a Roma. Atti del Convegno, Roma, Istituto Nazionale di Studi Ro-mani 1990.
Arte e civiltà urbana nel giovane D’Annunzio giornalista 219
una società immobiliare convenzionata col Co-mune per realizzare una zona residenziale di prestigio. La villa e le sue piante secolari era-no particolarmente care al poeta, che le celebra in diversi scritti e ne depreca la scomparsa il 25 aprile 1886 sulla «Tribuna»:
L’anno scorso per arrivare alla Porta Salaria, passavamo lungo le mura di Villa Ludovisia incoronate di verdura no-vella. Dalle mura macchiate di musco e dai roseti sover-chianti e dalle punte acute dei cipressi discendeva una dolce poesia conventuale. Per una gran cancellata sorret-ta da due cariatidi muliebri, fuggiva in lontananza un via-le di alti bussi. Presso una cappella gentilizia si stendeva un portico vegetale popolato di statue corrose, un portico circolare, uno di quelli ordini d’alberi fitti e bruni di mez-zo a cui rampollavano le rose meravigliosamente; e dalla chiusa selva usciva un cantico di uccelli pieno di variazio-ni dotte.Ora invece, passeremo tra le rovine e tra il polverio. I gi-ganteschi alberi giaceranno sul terreno, con tutto il gran viluppo delle radici nere ed umide esposto al sole. I roseti saranno rasi. Appena qualche atleta verde qua e là resterà a piangere su la iniqua sorte dei fratelli maggiori24.
Il 12 maggio 1885 D’Annunzio ha del resto già notato come «Roma diventi la città delle de-molizioni. La gran polvere delle ruine si leva da tutti i punti dell’Urbe»25. In questo caso, però, l’obiettivo è diretto sui «piccoli borghesi roma-neschi» che assistono perplessi alla distruzione delle loro case e dei loro negozi espropriati, «in-
24 La Villa Ludovisi, oltre che in Preambolo e in due contri-buti per la «Tribuna», compare nella Chimera, nel Piacere, in Gio-vanni Episcopo e nelle Vergini delle Rocce, in cui l’autore ripren-de proprio l’articolo del ’93. Il 17 aprile 1885 con lo pseudonimo «Vere de Vere» in Le corse in via Salaria ne descrive ancora gli splendidi giardini, mentre come «Myr» il 25 aprile 1886 nella ru-brica Sport e altro non può che assistere al loro scempio. SG1, pp. 287-291, 535-537, 1284-1285.
25 L’articolo, sempre per la «Tribuna», è genericamente inti-tolato Piccolo Corriere e firmato dal «Duca Minimo». Ivi, pp. 310-315; citazione a p. 310.
ElisabEtta CaldEroni220
goiando con molta pazienza la polvere bianca. Tutti stanno col naso all’aria e con il collo teso e con gli occhi spalancati e con in tutta la per-sona una espressione grottesca di stupidità»26. Un canzonatorio, aristocratico, ribrezzo nei con-fronti della mediocre vita popolare innerva lo scritto, sebbene emerga, qua e là, un malinconi-co senso di lutto suggerito particolarmente dal-le piante estirpate. Esse sono simboli per il po-eta pànico, difensore dei beni ambientali gra-zie proprio alla lezione emotiva dell’inimitabile poesia dei giardini romani. Lamenta in Pream-bolo la triste fine di «lauri e […] roseti di Vil-la Sciarra», dei «giganteschi cipressi ludovisii» e dei «bussi della Villa Albani che […] rabbrividi-vano nel pensiero del mercato e della morte»:
In alto, a un quarto piano, un altro balcone tutto coperto di piante rampicanti vien saccheggiato senza misericordia. Le belle piante lunghissime e flessibili ondeggiano, scom-pigliate, come capigliature verdi, tra il polverio che sale. Al-cuni rami pendono spezzati, reggendosi alla pianta madre per mezzo d’una sola fibra sottile. Tutta la massa vegeta-le ha in sé qualcosa di doloroso, come per una violazione ed uno strazio.E pensare quante buone merende su quel balcone e quan-te buone cene nelle notti d’estate, quando le piante fioriva-no ed odoravano! Passando nella via ed alzando li occhi, si vedevano allora dei visi femminili tra il verde, o si vedeva qualche cappellino appeso ad un ramo e qualche scialle di colore vivo ed anche talora una bambola rosea.A molte case sono già state demolite le facciate. Le stanze rimangono quindi scoperte, e con le loro tappezzerie di car-ta somigliano a scenarii d’un teatrucolo di provincia. Su le pareti i mobili han lasciato i segni. […] Dappertutto si scorgono le tracce untuose e laboriose della vita domesti-ca; dappertutto, alla cruda luce solare, si scorge quel che v’è di sudiciume e di gretteria e di meschinità nella vita ca-salinga dei piccoli borghesi27.
26 Ivi, p. 311.27 Ivi, pp. 310-311; SG2, pp. 195,196.
Arte e civiltà urbana nel giovane D’Annunzio giornalista 221
In tale senso d’angoscia per «case spoglia-te», per nudità domestiche offese, si fondono quindi il sentimento del dolore ed il disprezzo dannunziano nei confronti di quelle classi im-piegatizie, popolari, ritenute colpevoli dello sca-dimento del gusto per passiva acquiescenza ai miti di modernità urbana:
Ma dalle rovine sorgerà e risplenderà la nuova Roma, la Roma nitida, spaziosa e salutare, la Roma costruita dal-li architetti giovani che lasceranno da parte le eleganze spontanee del Bramante e s’ispireranno utilmente al pa-lazzo del Ministero delle finanze, al gran mostro della mo-derna architettura, alla caserma degl’impiegati28.
Infatti nei ricchi borghesi, «i nuovi eletti del-la fortuna, a cui né il parrucchiere né il sarto né il calzolaio avevano potuto togliere l’impronta ignobile», si mescolano volontà d’apparire, scar-sa educazione artistica e grossolana mentalità
28 Il ribrezzo per il declino della casa arredata con gusto ca-ratterizza tutti gli scritti dannunziani, emergendo anche, in modo pungente e doloroso, negli articoli che trattano di aste. Il Piccolo Corriere del 6 luglio 1885, per la «Tribuna» a firma del «Duca Mini-mo», prefigura già, ad esempio, la chiusa del Piacere. Per il poeta, infatti, una casa «povera e nuda» costituisce solo il punto di par-tenza per la ricerca appassionata e lo studiato accumulo di cose belle, che la trasformino veramente nella dimora e nell’espressio-ne di chi la abita. La «tenerezza» goncourtiana per le cose e l’at-tenzione del dandy per gli scenari si uniscono allora in un gusto per l’arredamento assai simile allo stile dello scrittore, prezioso e cumulativo. Ancora nell’Atto di donazione del Vittoriale allo Sta-to Italiano, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 7 novembre 1930, D’Annunzio scrive: «Non soltanto ogni casa da me arreda-ta, non soltanto ogni stanza da me studiosamente composta, ma ogni oggetto da me scelto e raccolto nelle diverse età della mia vita fu sempre per me un modo di espressione, fu sempre per me un modo di rivelazione spirituale, come uno dei miei poemi, come uno dei miei drammi, come un qualunque mio atto politico o mi-litare, come una mia qualunque testimonianza di diritta e invitta fede». SG1, pp. 311-312, 473-476. Cfr. per questo gusto raffinato E. dE GonCourt, La casa di un artista, a cura di B. Briganti, Paler-mo, Sellerio 2005, p. 49; A. andrEoli, I libri segreti. Le biblioteche di Gabriele D’Annunzio, Roma, De Luca 1993, p. 17.
ElisabEtta CaldEroni222
monetaria29. La loro assoluta mancanza di gu-sto si rivela tanto nell’insensibilità per le gran-di opere del passato quanto nella committen-za, umiliata proprio dal paragone con il passato. Essa erige il proprio simbolo, «un assai feroce simbolo della tirchieria e della piccineria moder-na», «tra la vecchia e la nuova Roma», nel nuo-vo Teatro Drammatico Nazionale30. D’Annunzio mette alla berlina l’intruso «novello edifizio ci-vettante nel suo lezioso candor di stucco presso ai vecchi e cogitabondi cipressi colonnesi» sulla «Tribuna», con tre articoli tra il 25 ed il 28 luglio 188631. In particolare
io non accuso quei signori che soprintendono al Teatro drammatico nazionale di non aver profuso nel nuovo edifi-zio qualche altro centinaio di migliaia di lire. […] Io li accu-so di aver voluto con pochi quattrini raggiungere un effet-taccio di volgarità gettando negli occhi del pubblico grandi manate di falsa porporina che dopodomani sera acceche-rà chi sa quanta brava gente. Io li accuso di aver voluto, per pochi soldi, fiorami e fogliami su le pareti, soffitti di-pinti, statue di cartapesta inargentata, carta di Francia e bacchettine d’oro dappertutto, invece di contentarsi di una onesta e nobile semplicità che il commendatore Azzurri [l’architetto] avrebbe potuto ravvivare con qualche bella e nuova ricerca d’arte.[…]Un vero artista, uno di quei belli artisti decoratori di cui abbonda il nostro cinquecento, avrebbe saputo, anche spendendo molto di meno, fare opera nitida e lieta; e la casa di Goldoni (chiameranno così il nuovo teatro?) sareb-be stata un ritrovo geniale ed elegante32.
29 SG2, pp. 196-197.30 Firmati «Miching Mallecho», gli articoli s’intitolano Il tea-
tro drammatico nazionale, Ancora del teatro drammatico nazionale, Ancora del teatro. SG1, pp. 602-616; citazione a p. 602.
31 Ibidem.32 Ivi, p. 606. La stroncatura del nuovo Teatro ci fa conosce-
re anche un D’Annunzio spiritoso. Il poeta, infatti, nelle feroci cri-tiche a committenti borghesi o artisti popolari predilige l’ironia e il sarcasmo. Gustosa ad esempio la parodia dell’«anima» delle cose, motivo assai caro allo scrittore, richiamata dalla particolare brut-
Arte e civiltà urbana nel giovane D’Annunzio giornalista 223
Del resto, assai diverso è il valore degli arti-sti e decoratori romani attuali rispetto ai gran-di predecessori. Le origini culturalmente medio-cri li macchiano di una tara originaria, di una ristrettezza d’orizzonti che da questione lega-ta alla classe di provenienza diviene etica, una vera e propria «inferiorità intellettuale»33. D’An-nunzio può dar voce, così, al proprio darwini-smo artistico, commentando l’Esposizione ro-mana di pittura e scultura del 1888:
E mi son domandato: «Per qual ragione mai tutta questa meschina gente vuol pubblicare ogni anno la sua meschi-nità e chiamare li estranei a prender cognizione delle sue vergogne? Per qual ragione mai tutta questa gente, che è nata tutt’al più ad un mestiere, a un’opera manovale, a un ufficio umile, ha scelta la via dell’arte, ha preso in mano il pennello piuttosto che la sega, lo scalpello piuttosto che il maglio? Per qual ragione mai tutta questa gente che non ha speranza di guadagno, che forse lotta con le necessità della vita cotidiana, che certamente con un’altra fatica tro-verebbe un pane onorato e la pace, per qual ragione mai persevera fino alla morte?»[…] la maggioranza dei pittori è composta di figli d’operai e di borghesi assai umili. Essi han frequentate, per lo più, le scuole elementari; sanno a pena leggere […].Per necessità, appare nell’opera di tali artisti la terribile in-fluenza del cosiddetto «ambiente» in cui son nati e in cui son vissuti. La teoria del Lamarck è, certo, applicabile al caso. Quell’ambiente di stupidità, in cui son vissuti, li ha formati a sua imagine e simiglianza. Se osassi esprimermi
tezza e mancanza di funzionalità di alcuni elementi architettoni-ci. Certi assurgono quasi al rango di personaggi, come i muricciu-oli che cingono i due palchi della Direzione, destinati a diventare «una istituzione nazionale; e si scriverà allora nelle cronache dei giornali: “Perfino i muricciuoli direttivi piangevano!” Oppure: “Ri-devano a crepagesso perfino i muricciuoli direttivi!” Oppure anco-ra: “Erano indignati i muricciuoli direttivi, perfino!”». Ivi, p. 609.
33 Tra il 20 febbraio e il 15 aprile, il «Duca Minimo» firma sei articoli sull’Esposizione: L’Esposizione annuale, Prima della Rivi-sta, Polemica Inutile, I Paesisti ed In conspetto della Natura, La bot-tega si chiude. Ivi, pp. 1067-1070, 1076-1078, 1092-1095, 1099-1107, 1132-1136; citazione a p. 1070.
ElisabEtta CaldEroni224
con villana franchezza, direi che le bellissime osservazio-ni del Darwin su l’addomesticamento di certi animali s’a-dattano a codesti artisti perfettissimamente. Essi han per sempre acquistata quella ristrettezza del cervello risultan-te dalla inerzia mentale delli animali (de’ conigli, per esem-pio) che vivono in dimestichezza. Per la massima parte, essi non sfuggiranno mai a quella tirannia domestica che ha formato la loro intelligenza, né alla eredità della stupi-dezza plebea, né al sentimentalismo grossolano che occu-pava lo spirito delle loro madri allor quando esse, incinte, nelle ore d’ozio si dilettavano de’ romanzetti tradotti del Ri-chebourg o del De Kock, e delle raccolte di canzonette per musica34.
Il poeta resta comunque convinto che l’ar-te non può morire nella città moderna, a diffe-renza dei contemporanei che guardano con ti-more alla perdita di aura poetica determinata dalla progressiva prosaicità dell’esistenza come esiziale per la letteratura e le arti35. Ritiene però
34 Ivi, pp. 1068-1069. Per la diffusione capillare del darwi-nismo in quegli anni, cfr. D. stErnbErGEr, Panorama del XIX seco-lo, a cura di E. Raimondi, Bologna, Il Mulino 1985, pp. 123-160.
35 D’Annunzio, esteta sociologo, lo afferma in esplicita po-lemica coi «più» all’inizio degli anni Novanta. Considerando i mu-tamenti del mercato librario, segnato dal successo di giornali ed editoria economica, individua negli uomini e nelle donne del suo tempo, di ogni classe sociale, un insopprimibile «appetito senti-mentale», un «bisogno del sogno» e del «meraviglioso» da cui tra-luce «un’inquieta aspirazione ad escir fuori dalla realtà mediocre, […] comune» per «vivere una vita più fervida e più complessa». Non a caso allora nuovi autori, riconducibili all’alveo simbolista e decadente, vivificano il panorama delle arti e della letteratura immergendosi con inedite indagini nelle «più acute malattie del-lo spirito», in un proficuo ma libero dialogo proprio con la scien-za che esamina le condizioni di vita della società borghese ed in-dustriale avanzata, la «psicologia contemporanea». Cfr. gli articoli Note su l’arte. Il bisogno del sogno, Una tendenza ed Elogio dell’e-poca, pubblicati rispettivamente sul «Mattino» del 31 agosto-1 set-tembre 1892 e del 30-31 gennaio 1893, e sulla «Tribuna» del 23 giugno 1893; saranno poi parzialmente ripresi nell’intervista con-cessa ad Ugo Ojetti, all’inizio del 1895, per il suo volume Alla sco-perta dei letterati, in cui netta convinzione del poeta è che «tut-to sia favorevole ad un Rinascimento». SG2, pp. 72-76, 201-207, 1375-1390. Per il problema estetico della morte dell’arte nella cul-
Arte e civiltà urbana nel giovane D’Annunzio giornalista 225
necessario sgombrare il campo da tutti quei se-dicenti artisti intenti a rovinare con le loro ope-re il Palazzo delle Arti Belle:
Bisogna troncar le gambe a tremila pittori, ogni anno; se no, fra dieci anni, tutti saranno pittori e non ci sarà più pittura.Non io, per certo, mi metterò a sollecitare il Governo per-ché dia alli artisti tutela, protezione, incoraggiamenti, soc-corsi. […] L’Arte non è una istituzione di beneficienza. E non è un mestiere. E quindi non ha per iscopo l’alimenta-zione della gente bisognosa. […]Non vi pare una pretensione ben singolare quella di tan-ti scarpellatori e pennellatori d’oggi? Dopo aver fatto bric-conerie, stupidezze e volgarità d’ogni sorta, essi vengono a dire al buon pubblico: «Bisogna ben che viviamo.» Ma come? Ma in nome di che? Essi non han dato alcun indizio d’ingegno […]. E sol perché si chiamano «artisti», il buon pubblico dovrà provvedere ai loro alimenti?Muojano, più tosto. È l’unico, in verità, utile esempio che possano dare. La lor trista fine servirà almeno di ammoni-mento alli altri. La Fame sarà la liberatrice dell’Arte36.
Anche in questo caso è l’esteta parlare, propugnando, senza temere le polemiche, una sensibilità elitaria per le cose d’arte37. Del re-
tura moderna e nella coscienza dei poeti, cfr. inoltre F. Curi, Per-dita d’aureola, Torino, Einaudi 1977.
36 SG1, pp. 1094-1095. 37 Il giovane giornalista individua anzi proprio nel risenti-
mento e nelle proteste suscitate dalle proprie sprezzanti afferma-zioni la «prova certa ch’egli ha colpito giusto». Infatti, il critico e l’artista devono affrontar da soli la propria ricerca, impermeabi-li al «grigio diluvio democratico odierno» che travolge e sommer-ge le «belle cose e rare». Del resto, i sei articoli sull’Esposizione del 1888 nascono anche come risposta alle critiche dell’opinione pub-blica ed alle lettere di protesta giunte in redazione. Un altro col-laboratore della «Tribuna», Ettore Natali, nella mischia ha infatti toccato un nervo scoperto in D’Annunzio, la dispendiosa passione per il bel mondo e l’eleganza. Sarebbe quest’ultima a distogliere la committenza da «coloro che veramente sentono e sanno esprime-re l’arte […] lasciati vivere e morire nella miseria». Ivi, pp. 1094, 1367-1368; G. d’annunzio, Il Piacere, in Prose di romanzi, vol. I, a cura di A. Andreoli e con introduzione di E. Raimondi, Milano, Mondadori 1988, p. 34.
ElisabEtta CaldEroni226
sto, l’attenzione per i beni culturali rientra pro-prio nell’alveo dell’estetismo europeo. Già Wil-liam Morris, il sodale esteta di John Ruskin, s’e-ra scagliato contro la speculazione edilizia lon-dinese, mentre lo stesso modo dannunziano di godere delle opere del passato si distingue per l’accensione fantastica che trasforma gli antichi palazzi in un ulteriore scenario per la Vita-Ope-ra d’Arte del dandy38.
Il poeta non relega infatti i monumenti a morta pietra: quando nel luglio del 1887 sugge-risce ai lettori della «Tribuna» di ricercare la «de-lizia del corpo e dello spirito» visitando a Roma le gallerie nobiliari, propone in realtà d’intra-prendere un percorso intimo e solitario, dai connotati mistici, nel cuore museale della cit-tà deserta39. Le pinacoteche sono libere dai tu-risti stranieri «e il vostro piacere è purissimo e intenso, non disturbato da alcuna cosa estra-nea, non amareggiato dalla presenza dei soliti britanni e dei soliti germani», relegati al ruolo di barbari40. Il lettore è finalmente «signore del luo-
38 M.T. marabini moEVs, Gabriele D’Annunzio e le estetiche della fine del secolo, L’Aquila, Japadre 1976, pp. 14-23, in cui si nota anche un parallelo tra il senso dannunziano di tutela per i beni culturali – esacerbato nella prefazione programmatica del «Convito» che invita a «sostenere militarmente al causa dello Spi-rito contro i Barbari» – e la volontà di Cantelmo di difendere la Bellezza del passato dalla «rabbia degli schiavi ubriachi». Infat-ti, per il protagonista della Vergini delle Rocce «il mondo è la rap-presentazione della sensibilità e del pensiero di pochi uomini su-periori […] oggi […] dono magnifico largito dai pochi ai molti, dai liberi agli schiavi, da coloro che pensano e sentono a coloro che debbono lavorare». Per un panorama di tutti gl’interessi di Mor-ris, cfr. Ch. FiEll - P. FiEll, William Morris (1834-1896), Köln, Ta-schen 1999.
39 I due articoli sono Preludio, del 20 luglio, e Nella Galleria Borghese, del 22. Ad essi si può aggiungere la valorizzazione spi-ritualistica del Cimitero degli Inglesi e del Colosseo realizzata ri-spettivamente il 3 (Nel cimitero degli Inglesi) ed il 13 agosto (Ca-dentia Sidera), tutti firmati dal «Duca Minimo». SG1, pp. 876-883; citazione a p. 877.
40 Ivi, p. 878.
Arte e civiltà urbana nel giovane D’Annunzio giornalista 227
go», libero d’immergersi in una profonda e per-sonale contemplazione poetica41. Nella Galleria Colonna può
far sedere su la sedia più illustre della sala del Trono la dama che accompagna e parlarle a lungo, in ginocchio su ’l meraviglioso tappeto antico di Persia memore d’altre ge-nuflessioni, figurandosi d’essere innanzi a Lucrezia Tor-naceli Colonna, dipinta dal Van Dyck, o a quella Vittoria che sta così nobilmente pensosa nel quadro del Muziano42.
Nella Galleria Borghese si può sperimenta-re invece l’«attrazione misteriosa che ha la dol-cezza e la profondità del fascino d’una musica» esercitata dalle opere di uno degli artisti predi-letti da Walter Pater e dai Preraffaelliti, Sandro Botticelli43. Come in pellegrinaggio, quando i più fuggono da Roma, il dannunziano cultore d’ar-
41 Ibidem.42 Ivi, p. 879.43 Il giovane giornalista coglie l’opportunità di mostrarsi fine
intenditore, presentando le opere di quello che definisce «certo fra tutti i pittori del quattrocento il più originale, il più sottile, il più ardente, l’elegantissimo», «il poeta lirico […] alla ricerca della no-vità». Diffondendosi sulla «vita profonda ed acuta, quasi sopran-naturale» di quelle figure animate da «un fuoco spirituale» e dal-la «felice mescolanza […] del sentimento cristiano col sentimento pagano», il poeta recupera con «note […] assai giuste nel loro va-lore critico» un artista quasi completamente dimenticato, proba-bilmente sulla scorta di aggiornatissime letture inglesi, come gli studi sul Rinascimento di Pater. Anche in questo caso quindi, la valorizzazione dell’arte del passato rientra nella sensibilità at-tuale nel tardo Ottocento. Si ricordi poi che Botticelli, nell’alveo del «gusto appassionato per i Primitivi, per gli incomparabili arti-sti precursori del Rinascimento», è prediletto dal protagonista del Piacere, in cui D’Annunzio riconosce, sulla «Revue Hebdomadai-re», «molta parte di sé, viva». SG1, pp. 881, 882; B. tamassia maz-zarotto, Le arti figurative nell’arte di Gabriele D’Annunzio, Milano, Fratelli Bocca 1949, pp. 388-389; SG2, p. 173. Per i modelli in-glesi cfr. la bibliografia raccolta in The Pre-Raphaelites and Italy, ed. by C. Harrison and Ch. Newall, Oxford, The Ashmolean Mu-seum 2010; per il rapporto di sintonia e mutuo scambio con l’of-ficina artistica e critica italiana, di cui D’Annunzio ora subisce le influenze, ora si propone guida, cfr. invece A. mazzanti, Simbolismo italiano fra arte e critica. Mario de Maria e Angelo Conti, Firenze, Le
ElisabEtta CaldEroni228
te accede al «santuario» tràmite una silenziosa «cerimonia» – «Bisogna suonare un campanello, come alla porta d’un monastero» per chiamare il muto custode – e si viene accolti da una frescu-ra e da una «quiete quasi conventuali»44. Risulta allora evidente come, agli occhi del poeta capace di evocare antichi splendori dalle pagine di Go-ethe – all’epoca delle Elegie romane – ma anche di un qualsiasi Baedeker, l’edilizia seriale nella Roma degli anni Ottanta si macchi d’una vera e propria profanazione.
D’Annunzio, però, non è affatto un «rèto-re conservatore» arroccato su posizioni retri-ve, estetizzanti, come scrive nella celebre lette-ra aperta a proposito dei lavori urbani fiorenti-ni45. Una «prova di irrefutabile eclettismo», di un gusto moderno – e davvero non comune all’epo-ca soprattutto in Italia –, è offerta dall’apprezza-mento per affiches, illustrazioni e caricature46. Il poeta sa vedere per tempo l’arte in questi pro-dotti di consumo, figli diretti – e fino a quell’e-poca senza apologeti – della civiltà industriale. Già l’11 giugno 1885 dalle pagine della «Tribu-na» addita ai pubblicitari romani, i cui medio-cri annunci «deturpano le mura di Roma in ogni stagione come una lebbra schifosa», un modello esemplare, proprio quello oggi annoverato fra i padri del manifesto moderno47. La citazione del poeta ha davvero valore storico:
Lettere 2007 e Il Simbolismo in Italia, a cura di M.V. Marini Clarel-li, F. Mazzocca, C. Sisi, Venezia, Marsilio 2011.
44 SG1, p. 880.45 SG2, p. 780.46 G. d’annunzio, Pagine sull’arte, a cura di S. Fugazza con
introduzione di P. Gibellini, Milano, Electa 1986, p. 26.47 In effetti, «la stagione aurea della grafica pubblicitaria ita-
liana» seguirà questo Piccolo Corriere del «Duca Minimo», collocan-dosi tra il 1896 ed il 1915. SG1, pp. 421-424, citazione a p. 422; M. mazza, Belle Époque tempo d’affiches, in La Belle Époque: arte in Italia 1880-1915, a cura di F. Cagianelli, D. Matteoni, Cinisel-lo Balsamo, Silvana Editoriale 2008, pp. 56-61, citazione a p. 56.
Arte e civiltà urbana nel giovane D’Annunzio giornalista 229
Questo artista è Giulio Chéret, il fabbricante di affissi, un disegnatore sapiente e uno stampatore magistrale, che fa certe composizioni d’una magnificenza decorativa, d’una eleganza, d’una correttezza, d’una vigoria, d’una originali-tà, d’una gaiezza ammirabili. Giulio Chéret con il suo gu-sto è giunto a temperare e moderare la brutalità della ré-clame commerciale e a dare ad un semplice annunzio un certo cachet d’arte. I colori de’ suoi affissi sono combinati con una malizia prodigiosa, sono floridi, hanno la vivaci-tà dei fiori, attirano lo sguardo del passante, sono dilettosi alla vista e rallegrano48.
Il giovane giornalista coglie per primo l’im-portanza, nella vita dei suoi lettori – e quindi nella vita moderna, industriale e urbana – di queste opere pur effimere e di statuto incerto nell’estetica fin de siècle. I manifesti s’impongo-no alla vista non meno dei tram e delle ferrovie che invadono le città. Sono però validi interpre-ti del gusto dell’epoca, soprattutto nell’innova-tiva dimensione di un’arte di consumo. Le cari-cature di certe affiches ancor più costituiscono un efficacissimo barometro degli umori politi-ci e sociali. Questo è tanto vero che il 10 giugno 1885, trattando sulla «Tribuna» l’opera del dise-gnatore francese Alfred Grévin, D’Annunzio può scrivere: «I disegni di Grévin ormai sono cele-bri. Sono agili e vivi. Vedendo passare sul mar-ciapiede una donnina saltellante e dondolante, piena di grazie e di eleganze, i parigini spesso dicono spontaneamente: «Un Grévin»»49.
Solo una decina d’anni più tardi, in Inghil-terra, un altro giornale elogerà i manifesti pub-
48 SG1, p. 422. Cfr. Jules Chéret e la Belle Époque. Lo spetta-colo. Galleria dell’Accademia, Loggetta Lombardesca, a cura di R. De Grada, E. Barelli, M. Tabanelli, Ravenna, s. e., 1972 e M. VEC-Chia, Persuasione e cartellonismo: da Jules Chéret ad Armando Te-sta, Milano, Cuem 2003.
49 L’articolo è un Piccolo Corriere del «Duca Minimo», ripre-so poi quasi integralmente in Figure e figuristi del 1° agosto 1887. Ivi, pp. 417-420; citazione a p. 417.
ElisabEtta CaldEroni230
blicitari grazie alla penna di un osservatore d’ec-cezione. Aubrey Vincent Beardsley, eccentrico illustratore, non mancherà infatti di cimentar-si in cartoline d’invito a clubs londinesi e visto-se affiches che «i giornalisti fecero […] a gara a commentare», esaltando sulla «New Rewiew» il trionfo di un inedito legame diretto tra arte e pubblico:
La pubblicità è un’assoluta necessità della vita moderna, e se sarà gradevole e appariscente, tanto meglio […]. Nessu-no si aspetta che [l’arte] abbia uno scopo utile o una parte nella vita di ogni giorno. Il pittore moderno deve soltanto dare al quadro un bel titolo e appenderlo.Oggi, primo fra tutti, il manifesto pubblicitario giustifica la sua esistenza sul terreno dell’utilità, e se in seguito aspi-rasse a bellezza di linea e di colore, perché i nostri po-sters non potrebbero reclamare una parentela con le gal-lerie […]?Ma è ancora convinzione generale che l’artista che si dedi-ca al manifesto declassi la sua arte portandola nelle stra-de e non sia per conseguenza un vero artista. I critici non riescono a vedere un lavoro di pennello su cui cianciare; il pittore guarda con sospetto a quella cosa, bella ma sen-za modelli nel passato, che si fa conoscere pubblicamen-te fuori da una cornice; il pubblico trova difficile prende-re sul serio quel povero foglio stampato lasciato alla mercé del sole, dello smog e degli acquazzoni, come un vecchio affresco sul portale di una chiesa italiana. […]Londra presto risplenderà di manifesti pubblicitari, che contro un cielo di piombo tracceranno i loro espliciti ara-beschi. La bellezza ha preso sede nella città […]50.
50 S. WEintraub, Il prezioso perverso. Beardsley alle radici del Liberty, a cura di A. Piva, Bari, De Donato 1970, pp. 127-131; m. maymonE sinisCalChi, Aubrey Beardsley. Contributo ad uno studio della personalità e dell’opera attraverso l’epistolario, Roma, Edi-zioni di Storia e Letteratura, 1977, p. 223; G. d’annunzio, Pagine sull’arte, cit., p. 26. Cfr. CH. dElPortE, De Bibendum à Culture-pub. La publicité à la conquête des masses, in La culture de masse en France de la Belle Époque à aujourd’hui, a cura di J.P. Rioux, J.F. Sirinelli, Paris, Fayard, 2002, pp. 410-434, in cui si mette in luce il ruolo fondamentale, per una nobilitante legittimazione del-la pubblicità, giocato da autori di manifesti come Chéret, Manet o
Arte e civiltà urbana nel giovane D’Annunzio giornalista 231
D’Annunzio sa dunque captare assai per tempo certi mutamenti del gusto internaziona-le, sebbene sia ancora immerso in un contesto romano con problematiche provinciali. Aman-te imprevedibile dell’editio picta, nei suoi curiosi consigli di lettura segnala albi e volumi decora-ti da artisti su modelli stranieri, anche molto di-versi tra loro51. Spazia dai raffinati Poèmes de la libellule illustrati dal pittore giapponese Yama-moto alle graffianti vignette sulla vita balneare raccolte in Aux bains de mer d’Ostende del bel-ga Maurice Bonvoisin, meglio noto come Mars, e dalla «grave e soave castità» tipica dell’editoria britannica alla satira politica ed alla tematica erotica dei Francesi52.
Inoltre, sempre ergendosi a maestro di gu-sto, il poeta approfitta dei giornali per informare il suo pubblico della rivoluzione in atto nel pa-norama artistico, passando in rassegna gl’illu-stratori liberty londinesi e soprattutto parigini. Lo attira in particolare la nuova immagine fem-minile che i disegnatori francesi propongono in modo sensualmente aggressivo e lontano ormai dalla temperie del tardo romanticismo. Quan-
Toulouse-Lautrec: sono le affiches fin de siècle a trasformare in-fatti la réclame in un prodotto di valore artistico.
51 Cfr. per il D’Annunzio attento committente d’illustrazioni per i propri scritti P.R. FErraris, D’Annunzio e la rinascita dell’e-ditio picta, in Gabriele D’Annunzio e la promozione delle arti, a cura di R. Bossaglia e M. Quesada, Milano, Mondadori - Roma, De Luca Ed. d’Arte 1988, pp. 61-64.
52 Il poeta critica Yamamoto il 14 luglio 1885 sulla «Crona-ca Bizantina», in occasione dell’articolo-saggio sulla Letteratura Giapponese che firma a proprio nome, ma anche nel Piccolo Cor-riere del «Duca Minimo» pubblicato il 1° giugno sulla «Tribuna». In questa sede presenta anche Mars, riproposto poi nelle rasse-gne d’illustratori francesi ed inglesi dei due Piccolo Corriere del 10 ed 11 giugno e nel contributo per la rubrica Figure e Figuristi del 1° agosto 1887, tutti sulla «Tribuna» a firma «Duca Minimo». SG1, pp. 160-169; 388-391; 417-424; 894-899; citazione a p. 421. Cfr. per il giapponismo liberty del poeta M. muramatsu, Il buon suddito del Mikado. D’Annunzio japonisant, Milano, Archinto 1996.
ElisabEtta CaldEroni232
do il 10 giugno 1885 esamina sulla «Tribuna» i diversi artisti, si concentra sull’eleganza delle donne rappresentate nella grafica coeva, soffer-mandosi specialmente sul belga Félicien Rops. Un profeta dell’eros più pungente, acre, grato ad una società solo in apparenza perbenistica:
Ma nella corruzione, ma nella voluttà, nell’intensità della lascivia nessuno supera Félicien Rops.Félicien Rops è un grande artista di cui forse un giorno potremo parlare a lungo e degnamente. Egli ha un’affinità spirituale con Carlo Baudelaire: è di una modernità pro-fonda, d’una sottilità meravigliosa. I fiori della sua arte sono fiori del male, fiori che sorgono nutriti dalla putre-dine della vita contemporanea. Egli è uno di quelli che si chiamano decadenti e che amano e studiano la decadenza e vogliono nella decadenza rimanere.Ricordiamo di lui una Tentazione di Sant’Antonio che si può dire sia l’espressione più alta e completa dell’arte sua. Il quadro rappresenta il santo in cospetto di una croce gi-gantesca su cui una femmina ostenta l’impudicizia delle sue membra ignude, mentre il cadavere magro e livido di Cristo cade.Quella femmina non è più la Venus Victrix, principio sacro della vita, ma la Venus vulgivaga dai fianchi non fecondi. L’Etera, l’ultima incarnazione della femminilità nei popo-li sfrenati ed estenuati, oscura ogni altra luce con la gran luce del suo vizio. Ella non ha la bellezza ritmica e decente; è grassa e florida, ed ha l’attitudine scomposta e oscena; è il Piacere, non è più l’Amore. Su l’alto della croce, nel luogo dell’iscrizione cattolica, è incisa la parola Eros.Così Félicien Rops simbolizza l’abbrutimento della razza umana sotto le rosee calcagna dell’etera; e par che gridi: – I tempi sono prossimi. Ben presto questo ventre, aper-to come una bocca, riassorbirà il mondo; questo seno dal-le punte rosse ed acute diventerà il Calvario dell’umanità agonizzante; questa chioma, come la nuvola che sommer-se Sodoma, involgerà la rovina dell’anime.Intanto Félicien Rops co’l suo bulino illustra i baci e le ca-rezze, mirabilmente53.
53 SG1, pp. 418-419.
Arte e civiltà urbana nel giovane D’Annunzio giornalista 233
D’Annunzio presenta per primo nel nostro paese questo disegnatore simbolista, recupe-rando, con intelligenza, i recentissimi saggi apo-logetici scritti su di lui da Camille Lemonnier e da Joséphin Péladan54. Il poeta mostra allo-ra di sapersi mantenere in sintonia con la pro-pria epoca secondo il doppio binario della cul-tura europea di punta e del pubblico italiano, senza limitare la propria competenza di critico ai tradizionali àmbiti della storia dell’arte. Anzi, deliba Rops probabilmente seguendo i fronte-spizi e le illustrazioni da lui realizzate per auto-ri come Baudelaire o lo stesso Péladan. L’inci-sore, durante gli anni parigini, aveva stretto le-gami di stima e di amicizia con gli scrittori mo-derni, condividendone la passione per un’arte seducente di massa. Oltre all’«eternità del vizio» declamata nelle Diaboliques e nelle Sataniques, sul modello di Barbey d’Aurevilly, l’artista bel-ga ama infatti indagare l’essenza sensuale della donna contemporanea non escludendo il fetici-smo e l’attrazione per l’eros trasgressivo e gra-to alla nuova borghesia intellettuale, ma repres-sa55.
La stessa presentazione dannunziana ri-specchia l’attenzione – allora inedita – per l’o-stensione carnale artificiosa e provocante, in-dulgendo anche ai modi della pornotopia pro-to-novecentesca, ricreandone l’atmosfera spiri-
54 E. Coda, Perverso e voluttuoso – Rops e la critica italiana, in Félicien Rops. La modernità scandalosa, 1833-1898, Milano, Jandi Sapi, 1996, pp. 65-66. Cfr. inoltre la summa di r.G. dElE-Voy, G. lasCault, j.P. VErhEGGEn, G. CuVEliEr, Félicien Rops, Lau-sanne-Paris, Bibliothèque des Arts 1985.
55 Cfr. Félicien Rops. Opere grafiche, a cura di R. Guarino, con un saggio di J.K. Huysmans, Roma, Savelli, 1980, p. 18; b. bonniEr - V. lEblanC, Rops sono, altri esser non voglio, in Félicien Rops. La modernità scandalosa, 1833-1898, cit., p. 31; per l’ero-tismo represso della modernità, H. marCusE, Eros e civiltà, tr. it., Torino, Einaudi 1967 e Id., La dimensione estetica e altri scritti, a cura di P. Perticari, Milano, Guerini 2002.
ElisabEtta CaldEroni234
tuale. La cornice morale e l’eleganza stilistica adattano poi al nostro pubblico romano tale do-cumento del gusto francese, intrigante, ma as-sai poco diffuso in Italia56. Il giovane giornalista fa perciò convergere il proprio desiderio di raffi-nata eccentricità e le esigenze di lettori e lettri-ci che intendono mantenersi à la page. Non ab-bandona così, nemmeno in questo caso, il pro-posito di divenire l’indiscusso maestro del gusto progressista della Roma moderna.
56 Anche il Piacere documenta questa passione per il malio-so erotismo femminile, condividendo ad esempio l’attrazione fe-ticista di Rops per i guanti. Così Andrea Sperelli, in occasione di un’esibizione al pianoforte, ne chiede uno in dono a Maria Ferres: «di tratto in tratto, i suoi occhi dalle dita della sonatrice andava-no ai lunghi guanti che pendevano sul leggìo conservando l’im-pronta di quelle dita, conservando una inesprimibile grazia nella piccola apertura del polso ove dianzi appariva appena appena un po’ della cute femminile»: G. d’annunzio, Il Piacere, cit., pp. 300-301, 1115, 1231. Cfr. S. alExandrian, Storia della letteratura ero-tica, tr. it., Milano, Rusconi 1994, pp. 335 e sgg; E. mErtnEr - h. mainusCh, Pornotopia: das Obzöne und die Pornographie in der lite-rarischen Landschaft, Frankfurt am Main, Athenäum 1971; vasta bibliografia in Verba tremula. Letteratura, erotismo e pornografia, a cura di N. Catelli, G. Iacoli, P. Rinoldi, Bologna, Bononia Uni-versity Press 2010.
Arte e civiltà urbana nel giovane d’Annunzio giorna-lista - Urban art and civility in d’Annunzio as a young journalist
Elisabetta Calderoni
Sin dagli esordi, D’An-nunzio propone un in-tellettuale attivo ed at-tento al mondo che lo circonda. I poco noti articoli degli anni Ot-tanta e Novanta, ver-gati sotto pseudonimo per diverse testate ro-mane, offrono anzi oc-casioni di riflessione sulla città come crogiu-olo di antico e moder-no, come sede dell’«a-nima collettiva» ma an-che culla del genio in-dividuale. A stimolarla è proprio la capitale del neonato Stato italiano, sino a quel momento arroccata nel passato, ora ansiosa di rinno-varsi sul modello del-le metropoli europee. Il poeta s’impegna allo-ra nella difesa di tutto ciò che è arte nella vita concreta, dal patrimo-nio tradizionale di pa-lazzi e giardini minac-ciati dalla speculazio-ne edilizia fino alle affi-ches, figlie vivaci e fra-gili della nuova società dei consumi.
Since the beginning, D’Annunzio appear as an active intellectu-al who cares about the world around him. The little known articles that in the eighties and the nineties he wrote under a pen-name for several newspapers in Rome offer many oppor-tunities to reflect upon the city as a mixture of ancient and modern, as the seat of the “col-lective soul” but also as the cradle of individual genius. Such consider-ations were arousen by the capital of the new-born Italian nation, that had been cling-ing to the past and was longing to be renewed taking the European metropolis as a model. The poet commits him-self to defend all that is art in real life, such as the traditional her-itage of buildings and gardens threatened by the real estate specu-lation or the affiches, vivacious and delicate daughters of the new consumer society.
Riassunto - Abstact
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 237-268
GiorGio Sica
Il Giappone di Ezra Pound
Ezra Pound fu tra i principali diffusori de-gli ideali estetici della classicità giappone-se all’interno della tradizione poetica eu-
ropea e americana e il ruolo di questi ideali ebbe una rilevanza tale nello sviluppo della sua opera da meritare una riflessione approfondita.
L’incontro di Pound con il Giappone avven-ne in età giovanile e lo accompagnò lungo l’inte-ro arco della sua produzione poetica, motivan-done spesso le direttrici stilistiche e giocando un ruolo decisivo nell’elaborazione di quelle teo-rie che contribuirono a modificare il corso della poesia e dell’arte occidentale del secolo scorso.
Il Giappone, come è noto, dopo secoli di iso-lamento, si era ritagliato sul finire del secolo XIX con rapidità sorprendente uno spazio cen-trale nel cuore della contemporanea produzione artistica europea e americana. Le acquisizioni tecniche e contenutistiche dei pittori impressio-nisti e degli artisti liberty, come pure le sugge-stioni poetiche evidenti nell’opera di Mallarmé, di Wilde e di D’Annunzio testimoniano il ruo-lo fondamentale giocato dall’arte giapponese nel rinnovare i canoni estetici occidentali1.
1 Della fondamentale influenza dell’arte giapponese nello sviluppo di quella occidentale, con particolare attenzione alla ri-cezione dell’haiku nel mondo poetico anglosassone, francese e ita-liano, ho avuto modo di parlare nel saggio Schegge di un unico cristallo. L’haiku e il rinnovo della poesia occidentale, in «Interse-zioni», n.1, a. 2006, pp. 75-104. In esso, oltre ad ampliare lo spet-tro di autori studiati in relazione all’arte giapponese, ho voluto sottolineare l’interdipendenza tra il fenomeno del Japonisme e la successiva diffusione dell’haiku, evidenziando la centralità dell’ar-te e dell’estetica giapponese nello sviluppo dell’arte e dello stesso pensiero occidentale.
GiorGio Sica238
Il passo ulteriore, agli inizi del ventesimo secolo, verrà dalla diffusione in Europa e ne-gli Stati Uniti della poesia del Sol Levante che, soprattutto attraverso il fascino esercitato dall’haiku e dal tanka2 su scrittori e critici, favo-rirà una decisiva evoluzione della poesia e della letteratura occidentali.
In questo contesto Ezra Pound giocò un ruolo chiave. Fu, infatti, tra i primi in occiden-te, se non il primo, a comprendere le possibilità rivoluzionarie insite nella struttura dell’haiku, e si dedicò con tutta la sua non trascurabile ener-gia al compito di diffondere presso i suoi con-temporanei i raffinati codici estetici del Sol Le-vante. Questa sorta di apostolato, come vedre-mo, sarà una costante della sua produzione po-etica e critica, e un devoto amore per la classi-cità cinese e giapponese lo accompagnerà sino alla stesura dei Cantos finali e all’ultima del-le sue mirabili imprese di traduzione, The Clas-sic Anthology Defined by Confucius. Ma cerchia-mo di ripercorrere diacronicamente questa lun-ga storia, iniziando dagli anni londinesi in cui il giovane Ezra, ancora alla ricerca di una propria identità poetica, si avvicinò a Laurence Binyon e agli esteti di The Poets’ Club.
L’incontro con Binyon, uno dei primi seri di-vulgatori dell’arte giapponese in Europa, avven-
2 Ricordo brevemente che tanka e haiku sono i due metri più popolari della storia poetica del Giappone. Il primo, presente fin dalle origini, consta di trentuno sillabe (in cinque misure, rispetti-vamente di 5-7-5-7-7 sillabe). L’altro, evolutosi secondo una com-plessa serie di passaggi dal renga, poesia in alternanza di voci, è formato da sole 17 sillabe (in tre misure di 5-7-5). Quest’ulti-mo si affermò, a partire dalla seconda metà del 1600, come metro principe della poesia nipponica, grazie all’opera dell’eccelso poeta Matsuo Bashō. Sull’argomento si vedano almeno: D. Keene, Japa-nese Literature, London, J. Murray 1953; K. YaSuDa, The Japane-se Haiku, Vermont & Tokyo, Rutland 1957; R.H. BlYth, A History of Haiku, II vol., Hokuseido, Tokyo 1964; S. Kato, Storia della let-teratura giapponese, II vol., Venezia, Marsilio 1989 (I vol. 1987).
Il Giappone di Ezra Pound 239
ne al principio del 1909, e permise a Pound di approfondire il suo nascente amore per la cultu-ra giapponese. Pound che, come molti suoi con-temporanei, aveva apprezzato The Flight of the Dragon3 e Painting in the Far East4, intavolò con Binyon un discorso che durerà anni e i concetti di “vitalità ritmica o ritmo spirituale”, esplicita-ti dal critico inglese in The Flight of the Dragon, saranno al centro dell’elaborazione dei Cantos, specialmente di quelli pisani5. Alle conversazio-ni con Binyon sull’estetica dell’epoca Ashikaga e sulla spiritualità del buddismo zen6, si affian-carono presto quelle con T. H. Hulme e con i membri di The Poets’ Club, il gruppo di giova-ni artisti e poeti che, sotto la guida dell’eclettico Hulme, solevano riunirsi nei caffé di Soho, con l’obiettivo di dare una scossa alla calma piat-ta in cui pareva vegetare la poesia inglese alla fine dell’epoca vittoriana7. Erano gli stessi anni
3 l. BYnion, The Flight of the Dragon: An Essay on the Theory and Practice of Art in China and Japan, based on Original Sourc-es, in «Wisdom of the East Series», London, Murray 1918 (reprint: 1972). In questo saggio Bynion descrive le concezioni della natu-ra e le teorie estetiche in Cina e Giappone, con particolare atten-zione alle relazioni tra lo zen e l’arte. Istituisce anche interessan-ti confronti con l’estetica occidentale, stabilendo i primi paralleli tra la pittura estremoorientale e alcuni poeti inglesi, tra cui Word-sworth, Keats e Shelley.
4 l. BYnion, Painting in the Far East: An Introduction to the His-tory of Pictorial Art in Asia, Especially China and Japan, London, Ar-nold 1908 (4th ed. rev., 1934; reprint New York, Dover 1959).
5 Come ha ben rilevato carrol terrell in The Na-Khi Docu-ments I’ in «Paideuma», 3 1974, pp. 91-122.
6 Ricordiamo che Pound, recensendo The Flight of the Dra-gon, criticherà Bynion per «non essersi ribellato abbastanza», ma d’altro canto ne loderà l’intelletto e la capacità di analisi e di de-scrizione poetica. (cfr. e. PounD, Pavannes and Divagations, Nor-folk, New Directions 1958 (reprint: 1975).
7 Pound definirà la poesia del tempo in Hell, un articolo del 1934: «A doughy-mess of third-hand Keats and Wordsworth, he-aven knows what, fourth-hand Elizabethan sonority blunted, half melted, lumpy». Ora in e. PounD, Literary Essays, with an Intro-duction by T.S. Eliot, London, Faber and Faber 1954 (1985), p. 205. («una poltiglia pastosa di Keats e Wordsworth di terza mano,
GiorGio Sica240
in cui venivano inaspettatamente scoperti e re-staurati i brandelli di pergamena che amplia-vano il canone di Saffo. Da uno di questi fram-menti, quello dedicato alla bella Atthis8, lo stu-dente diciannovenne Richard Aldington, futuro marito di H. D., alias Hilda Doolittle, ricavò una versione che incontrò la convinta approvazione di Pound che la inserirà, poi, nell’antologia Des Imagiste9. Lo stesso Pound, oltre a una Imerro ispirata da una Atthis “irrequieta, mai colta”10, compose Papyrus e Ione, dead the long year, en-trambe con l’occhio ai ritrovati frammenti.
Papyrus colpisce per la sua singolarità, con i suoi tre versi ciascuno composto di una sola parola seguita da puntini di sospensione, al fine di imitare, non senza ironia, la fascinazione dei contemporanei per il frammento:
Spring . . . . . . . . .Too long . . . . . . . . .Gongula . . . . . . . . . 11
Ione possiede invece la potenza e la grazia di un epitaffio alessandrino:
Empty are the ways,Empty are the ways of this landAnd the flowersBend over with heavy heads.They bend in vain.Empty are the ways of this land
di sonorità elisabettiane di quarta mano, orami logora, mezza li-quefatta, piena di escrescenze» in Pound, E., Saggi letterari, a cura di T.S. Eliot, trad. di N. d’Agostino, Milano, Garzanti 1957, p. 434.
8 Frammento 49 nell’ed. Voigt ( = 43 nell’ed. Gavallotti ).9 e. PounD, Des Imagiste. An Anthology, New York, Boni
1916.10 Nell’originale: «restless, ungathered». Cfr. e. PounD, Lus-
tra, London, Elkin Mathews, 1916; ora in iD, Personae. The Short-er Poems of Ezra Pound (1926), New York, New Directions 1990, p. 116.
11 Ivi, p. 115.
Il Giappone di Ezra Pound 241
Where IoneWalked once, and now does not walkBut seems like a person just gone12.
Era un’epoca già preparata da Poe e dal Simbolismo a ritenere la brevità una virtù. I frammenti aumentarono l’interesse per il detta-glio, affascinarono con il loro mistero. Nel Deca-dentismo era stata d’importanza centrale l’ab-bandonarsi all’istante: nella trasfigurazione del dettaglio si sperimentava la possibilità di sot-trarsi alla monotonia dell’esistenza, s’intravede-va una via all’estasi. La teoria del particolare lu-minoso di sir Walter Pater «adombrava la meta-fisica dell’illuminazione»13. Era l’estetica di un’e-poca, quella che Hugh Kenner felicemente defi-nirà «un’estetica di barlumi»14. Pound, nel perio-do che va da Lustra a Mauberley, fu attratto da questa estetica e con il suo genio, e la sua pro-fonda comprensione della tecnica dell’haiku, la ripulì dalla dilatazione, dal sentimentalismo e da altre scorie post-impressioniste.
L’incontro con Hulme rappresentò un mo-mento decisivo in questa evoluzione di Pound. Poeta, filosofo e brillante aforista, Hulme vole-va rompere con il romanticismo e ritornare ad un “classicismo” inteso soprattutto come capa-cità di compattezza e brevità, accuratezza di lin-guaggio e mancanza di sentimentalismo. Ritro-vare la parola, ridonarle il valore e la potenza originari, era il suo obiettivo primario. In que-sta crociata non era solo. Se nei suoi frammen-tari scritti leggiamo «usa sempre la parola dura, definita, personale»15 , in quegli stessi anni un
12 Ibidem.13 Cfr. h. Kenner, The Pound Era, Berkeley, Univ. of Cali-
fornia, 1971, p. 69: «Adumbrate the metaphisics of the glimpse». 14 Ivi, p. 96: «An aesthetic of glimpses».15 Cfr. t.h. hulme, The New Philosophy, in «The New Age»,
V (19-08-1909), p. 135: «Always use the hard, definite, person-al word».
GiorGio Sica242
altro amico e maestro del giovane Pound, Ford Madox Ford, era, infatti, martellante sulla sin-tassi e la dizione del discorso naturale: «nulla, nulla, che non si potrebbe dire in qualche cir-costanza, sotto la spinta di qualche circostan-za, dire veramente»16. O, secondo i dettami di Hulme: «ogni parola deve essere un’immagine vista, non un racconto […] È questa immagine che precede la scrittura e la rende ferma». E «le immagini visive possono essere trasferite solo da un nuova scodella di metafore. Le immagini in versi non sono mere decorazioni, ma le vere essenze di un linguaggio intuitivo»17. Metafore vive, come quelle che Fenollosa, altro maestro del Nostro, vedeva negli ideogrammi cinesi. In questa ricerca risuona il basso continuo di un’e-poca, un’epoca che, con le sue menti più lucide, andava in cerca del suo linguaggio. Molte delle intuizioni di Ernest Francisco Fenollosa risulta-rono decisive in tale direzione. Vale senz’altro la pena soffermarci a ricordare il nocciolo delle te-orie di questo studioso errante che, di ritorno da un lungo soggiorno giapponese, contribuì come pochi all’incontro e alla comprensione reciproca tra Estremo Oriente e Occidente.
Con i suoi anticipatori studi sulla lingua ci-nese e giapponese Fenollosa aprì, infatti, una pi-sta nella ricerca di una lingua nuova, influen-zando in maniera decisiva le idee del giovane Pound nei riguardi della potenza del linguaggio e della funzione stessa della poesia. I suoi preziosi
16 Cfr. h. Kenner, The Pound Era, cit., p. 81; «Nothing, noth-ing that you couldn’t in some circumstance, under the stress of some emotion, actually say». (Trad. it. in m. GrazioSi: L’età di Pound, Bologna, Il Mulino 1996, p. 111).
17 Cfr. t.h. hulme, The New Philosophy, cit., p. 135: «Each word must be an image seen, not a counter […] It is this image which precedes the writing and makes it firm». E «visual images can only be transferred by the new bowl of metaphor. Images in verse are not mere decoration, but the very essence of an intui-tive languages».
Il Giappone di Ezra Pound 243
quaderni di appunti che, alla sua morte, furono donati dalla vedova a Pound, permisero al poe-ta americano di affacciarsi su un mondo nuovo che sembrava custodire le risposte alla sua fre-netica ricerca. In segno di gratitudine e ricono-scenza il giovane Ezra, con un abile lavoro di si-stemazione di quei manoscritti, riuscì a far pub-blicare quello che sarebbe diventato il lascito let-terario più importante di Fenollosa, The Chinese Written Character as a Medium for Poetry18. Del-le idee del professore di Boston, Pound nell’Intro-duzione scrisse semplicemente: «Più tardi gli svi-luppi artistici hanno confermato le sue teorie»19.
Vediamo ora, brevemente, il nocciolo di queste teorie per comprendere quanto dovettero impressionare i suoi contemporanei20: «Le paro-le cinesi sono vive e plastiche come la natura, poiché cosa e azione non sono formalmente se-parate. La lingua cinese naturalmente non co-nosce grammatica»21. Come la natura: «La natu-ra stessa non conosce grammatica»22. Dalla sco-
18 Cfr. e.F. Fenollosa, ed. Ezra Pound, The Chinese Written Character as a Medium for Poetry: Ars Poetica or the Roots of Po-etic Creation? London, «The Little Review» 5/6 (September 1919); trad. it. di M. de Rachewiltz: L’Ideogramma cinese come mezzo di poesia - una Ars Poetica, introduzione e note di E. Pound, Milano, All’Insegna del Pesce d’oro 1960. Tutte le citazioni seguenti da Fe-nollosa sono tratte da questo libro.
19 Cfr. ivi, p. 7: «The later movements in art have corrobo-rated his theories».
20 Le teorie di Fenollosa sono state in buona parte smentite dai sinologi contemporanei, perché nella sua ricerca dell’idea ver-bale di azione lo studioso avrebbe trascurato il valore puramen-te fonico di molti dei caratteri cinesi. Ma, a giustificarlo, se ce ne fosse il bisogno, sta il fatto che l’erudizione filologica dei sinologi dei nostri giorni era impensabile ai suoi tempi, e che, inoltre, mol-te delle sue intuizioni risultano valide ancora oggi. Il suo, in ogni caso, fu uno di quegli errori particolarmente fecondi, che scandi-scono lo sviluppo dello spirito umano.
21 Cfr. e.F. FenolloSa, The Chinese Written …, cit., p. 21: «Like nature, the Chinese words are alive and plastic, because thing and action are not formally separated».
22 Ivi, p. 20: «Nature herself has no grammar».
GiorGio Sica244
perta che nella lingua cinese ogni parola conser-va viva la sua radice verbale di azione, Fenollosa poté comprendere che «il verbo deve essere il fat-to principale della natura poiché in essa non ri-conosciamo che moto e cambiamento»23 e, con-tro l’impoverimento delle lingue occidentali do-minate dalla «tirannia della logica medievale»24, ricordò l’origine «dinamica e vitale del discorso umano»25. Da qui il richiamo ai poeti, con un in-vito che era già stato di Nietzsche26, a riandare alla radice metaforica della realtà, a ritrovare la potenza e la verità delle metafore originarie e a trovare tra di esse «l’accordo e l’armonia più in-tensa, come nel discorso di Romeo sulla mor-ta Giulietta»27, accordo e armonia mirabilmente presenti nello «splendore di certi versi cinesi»28, dove, grazie alla tecnica pittografica, il poeta è più vicino al movimento ininterrotto della natu-ra, alla sua armonia. Come il poeta primitivo, il poeta di oggi «deve toccare le emozioni col fasci-no dell’impressione diretta, lampeggiando per regioni ove l’intelletto può solo brancolare»29. E
23 Ivi, p. 23: «The verb must be the primary fact of nature, since motion and change are all that we recognise in her».
24 Ivi, p. 29: «The tyranny of mediaeval logic». 25 «La natura stessa ha imposto all’uomo primitivo la forma
della frase …» e «Ogni verità deve essere espressa in frasi perché ogni verità è trasferimento di potere» possono valere come esempi delle sue idee a tale proposito.
26 Il problema attraversa tutti gli scritti giovanili di Nietzsche (v. almeno Su verità e menzogna in senso extramorale) ed è alla base della sua produzione poetica (Idilli di Messina, Ditirambi di Dioniso). Per un’edizione completa delle sue opere, si veda F. nietzSche, Tutte le Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Mila-no, Adelphi 1969 (poi 1994).
27 Cfr. e.F. Fenollosa, The Chinese Written …, cit., p. 36: «The concord or harmonising at its intensest, as in Romeo’s speech over the dead Juliet».
28 Ibidem, loc. cit.: «The full splendour of certain lines of Chi-nese verse».
29 Ivi, p. 25: «Must appeal to emotions with the charm of di-rect impression, flashing through regions where the intellect can only grope».
Il Giappone di Ezra Pound 245
deve farlo, sull’esempio dei cinesi, «con ricchez-za di verbi concreti», con frasi in cui «una parola insegue l’altra avvolgendosi nei loro gusci lumi-nosi fino a che le frasi divengono chiare, fasci di luce continua»30. La suggestione che questo di-scorso poté esercitare sugli artisti e i poeti con-temporanei è evidente. Potremmo affermare che l’Occidente aveva finalmente trovato l’Ars Poeti-ca di cui andava in cerca.
Ma i meriti di Fenollosa non si esaurisco-no qui. Grazie ai suoi quaderni di traduzioni Pound scoprì, infatti, le liriche del sommo po-eta cinese Li Po e il teatro Nō. Prima di parlare di entrambi questi incontri, destinati a lascia-re un segno profondo, ritorniamo però al Po-ets Club e a un altro folgorante incontro, quel-lo con l’haiku.
Dai disordinati scritti di Hulme, e, soprat-tutto, dalle sue illuminate conversazioni31, Pound aveva, ormai, tratto quella idea e quel-la parola, Image, che dovevano cambiare la sto-ria poetica del mondo anglofono. E, mentre Hul-me smetteva di scrivere versi per dedicarsi alla filosofia, il giovane Ezra veniva iniziato da uno dei membri del Poets Club ai segreti della poe-sia giapponese.
L’iniziatore in questione fu F.S. Flint. Il fu-turo imagista, nonché storico del gruppo, appar-teneva da tempo alla banda di Hulme. L’obietti-vo comune era rinnovare il verso inglese sul mo-dello di quanto avevano fatto i simbolisti france-si. La parola d’ordine, anche per loro, era: vers libre. E il ruolo dell’haiku, già sensibile in Fran-cia, fu determinante. Nella sua Storia dell’Imagi-smo, Flint ricorda: «Noi tutti ne scrivemmo doz-
30 Ivi, p. 36: «Words crowd upon words, and enwrap each other in the luminous envelopes until sentences become clear, continous light-bands».
31 Cfr. de M. de rachewiltz, Ezra Pound, in Novecento ameri-cano, a cura di E. Zolla, Roma, Lucarini 1982, p. 399.
GiorGio Sica246
zine per divertimento…»32. Una volta giunto nel-le mani di Pound, l’haiku andò ben oltre il ruolo di semplice intrattenimento. Era lo strumento di cui aveva bisogno per svecchiare la poesia ingle-se e che lo aiuterà a compiere il salto qualitativo definitivo. Anche lui, infatti, fino a allora non era riuscito a svincolarsi del tutto dalla moda post-impressionista. Nelle sue prime prove l’impres-sionismo era già espresso in forme più rigorose, ma non era tuttavia esente da eccessi eruditi e da illanguidimenti romantici. Riportiamo, a mo’ di esempio, un aneddoto relativo a una gustosa critica ricevuta dal suo amico Ford Madox Ford: nell’estate del 1911, il giovane Ezra Pound, re-duce da un lungo studio dei trovatori, si recò a Giessen per fare dono a Ford di una copia del suo Canzoni, che si apriva con cinque poesie in forme provenzali. L’idea era buona perché Ford era figlio di un celebre studioso dei trovatori e aveva scritto anche lui, e pubblicato con Har-dy e Conrad, canzoni di stile analogo. Ma i ri-sultati non si dimostravano all’altezza. Il giovane Pound era perso nella retorica della «alta mes-sa della poesia», e tra Incenso e Luce, manca-va di quell’accuratezza che Ford predicava e che sarebbe presto divenuta il suo segno distintivo. Così, l’esperto amico, alla prima lettura, per ma-nifestare il suo disappunto, si gettò per terra, e con tutta la sua notevole mole, iniziò a rotolarsi. Una critica sincera, spesso, è la migliore: «quel-la rotolata» – scriverà Pound anni dopo – «mi fece risparmiare tre anni»33.
Anche la metrica, inoltre, era quella tradi-zionale, e basta guardare ai titoli di quel perio-do per avvertire ancora il forte influsso di Whi-
32 Cfr. F.S. Flint, History of Imagism in «The Egoist», II (I-V-1915): «We all wrote dozens of the latter (haiku) as an amuse-ment…».
33 L’aneddoto è un prestito da h. Kenner, L’età di Pound, cit., pp. 105 ss.
Il Giappone di Ezra Pound 247
stler. Wyndham Lewis, compagno di battaglie nei furiosi anni di Blast, riconobbe l’analogia: «L’a-mericano del passato più vicino a Pound fu …. un pittore, James McNeill Whistler. Come Pound nell’arte delle lettere, fu nell’Estremo Oriente che Whistler scoprì gli aggiustamenti fondamenta-li al suo gusto»34. Ma, Pound, pur riconoscen-do l’importanza di Whistler in un celebre artico-lo del 191435, non poteva accontentarsi di filtri interpretativi. Il suo rapporto col Giappone era pronto ad approfondirsi, svincolato da ogni tute-la. In quegli anni, per un giovane poeta privo di risorse, unica salvezza era l’attività pubblicistica. E Pound, che andava sviluppando la sua inna-ta vocazione pedagogica, ad articolo aggiungeva articolo. È un periodo decisivo per la sua cresci-ta. In questi anni il suo pensiero e il suo gusto si affilavano e la sua critica letteraria36 dava i suoi frutti più maturi. E, così, il I settembre del 1914, apparve il famoso saggio sul Vorticismo37.
Questo articolo è uno dei più celebri e ci-tati di Pound. E non lo è a torto. Il modo in cui
34 «Pound’s nearest American analogue in the past is… a painter, James McNeill Whistler. Like Pound in the literary art, it was in the extreme-orient that Whistler discovered the fundamen-tal adjustments of his preference». Cit. in e. miner, The Japanese Tradition in British and American Literature, Princeton, Princeton University 1958, p. 108 (la traduzione è mia).
35 e. PounD, E. Wadsworth, Vorticist, in «The Egoist», (I-VI-1914).
36 Quella che Eliot definisce «la più importante critica con-temporanea del suo genere» nella prefazione a e. PounD, Saggi let-terari, cit., p. 6.
37 Cfr. e. PounD, Vorticism, in «The Fortnightly Review», n. CII del I-IX-1914 (le trad, it., a cura di M. de Rachewiltz, sono in e. PounD, Opere scelte, Milano, Mondadori 1970, pp. 1198-1215): «Three years ago in Paris I go out of a metro train at La Concorde, and saw suddendly a beautiful face and another and another, and then a beautiful child’s face, and then another beautiful women, and I tried all that day to find words for what this had meant to me, and I could not find any words that seemed to me worthy, or as lovely at that sudden emotion». Tutte le citazioni seguenti di Pound sono tratte da questo saggio.
GiorGio Sica248
Pound descrive l’epifania che lo spinse a scrive-re In The Station of The Metro merita per la sua emblematicità di essere ricordato ancora: «Tre anni fa a Parigi uscivo da un treno della metro a La Concorde, quando improvvisamente scor-si un bel viso, poi un altro e un altro, poi un bel viso di bimba, poi un’altra bella donna, e cer-cai durante tutta la giornata di trovar le parole che esprimessero ciò che questo aveva, per me, significato e non potevo trovare parole che mi sembrassero degne o graziose come quella subi-tanea emozione». Il dilemma lo terrà impegnato per quasi due anni: «Scrissi una poesia di tren-ta versi e la distrussi perché era quello che noi [vorticisti] chiamiamo un lavoro di ‘seconda in-tensità’. Sei mesi più tardi composi un poema di metà di quella lunghezza; un anno dopo questa frase simile a un haiku (hokku-like sentence):
The apparition of these faces in a crowdPetals on a wet, black bough38.
Come era arrivato a questa frase? Poco pri-ma, parlando dell’immagine, aveva spiegato il suo carattere di sintesi, sintesi immediata ed evidente agli occhi che la ricevono come si rice-ve un dono. Ritorna in mente la visione trasfigu-rante e salvifica dell’artista apollineo che Frie-derich Nietzsche, un altro spirito profondamen-te artistico e con una vocazione pedagogica ana-loga a quella di Pound, aveva descritto anni pri-ma ne La nascita della tragedia39.
38 Ibidem: «I wrote a thirty-line poem and destroyed it be-cause it was what we call work of second intensity. Six months later I made a poem half that length; a year later I made the follow-ing hokku-like sentence: The apparition of these faces in a crowd / Petals on a wet, black bough».
39 Cfr. F. nietzSche, La nascita della tragedia dallo spirito della musica, in Tutte le Opere, a cura di G. Colli e M. Montina-ri, Milano, Adelphi 1999, vol. I. Le affinità tra Pound e Nietzsche sono notevoli e meriterebbero uno studio approfondito: sarebbe
Il Giappone di Ezra Pound 249
Ma continuiamo il viaggio nell’immagi-ne: «L’immagine è un complesso emotivo e in-tellettuale in un istante di tempo, per richiamo visivo»40. E, poco oltre, l’immagine, «vero pig-mento del poeta», «è la parola al di là del lin-guaggio formulato»41. Siamo nel «linguaggio dell’esplorazione», il linguaggio vergine dei bam-bini e della vera arte, scevro d’ornamenti super-flui. Linguaggio che Pound ritrova nella poesia giapponese: «I giapponesi hanno avuto il senso dell’esplorazione. Essi hanno compreso la bel-lezza di questo genere di conoscenza. Un cine-se disse molto tempo fa che se non si è capaci di esprimere quello che si ha da dire in dodici li-nee è molto meglio star zitti. I giapponesi han-no evoluto la forma ancor più breve dell’haiku:
il fiore cadutorivola al suo ramo,
una farfalla42.
interessante verificare se Pound avesse letto la produzione giova-nile del filosofo tedesco – in particolare Le considerazioni inattua-li – che presenta numerose affinità tematiche e stilistiche con la sua produzione critica. Un tramite interessante tra i due potrebbe essere stato l’intellettuale inglese A. R. Orage, profondamente af-fascinato dalla vena mistica di Nietzsche. Ricordiamo che Pound frequentò assiduamente la cerchia di Orage, il quale patrocinò la rivista The New Age, vero e proprio strumento dell’Avanguardia inglese. Alla rivista collaborarono, oltre allo stesso Pound, che vi lanciò la sua “dottrina dell’Immagine”, T. E. Hulme e Wyndham Lewis. – Sul rapporto Pound-Orage lo studio più penetrante è, a mio parere, quello di D.S. thatcher, A. R. Orage, in Nietzsche in En-gland 1890-1914: The Growth of a Reputation, Toronto, Universi-ty of Toronto Press 1970. In esso, però, Thatcher, pur descrivendo la partecipazione del Nostro al milieu di Orage, non dice, purtrop-po, quasi nulla sul rapporto di Pound col pensiero di Nietzsche.
40 «Image is that which presents an intellectual and emo-tional complex in an instant of time». Questa definizione, riporta-ta in nota all’inizio del saggio citato, era originariamente nell’ar-ticolo di Pound A Few Dont’s By an Imagiste apparso su «Poetry» del I marzo 1913.
41 Cfr. e. PounD, Vorticism, cit.: «poet’s pigment», «is the word beyond formulated language».
42 Ibidem: «The Japanese have had the sense of exploration. They have understood the beauty of this sort of knowing. A Chi-
GiorGio Sica250
In questo celebre haiku, attribuito a Mo-ritake, Pound vede una tecnica che si rivelerà fondamentale per la maturazione della sua poe-sia, tecnica con cui si misureranno presto altri grandi dell’Occidente. L’haiku, «poema di una sola immagine (one-image poem) è una forma di sovrapposizione (super-position form), cioè è un’idea messa sopra un’altra»43. E, concluden-do: «in una poesia come questa si cerca di nota-re il preciso momento in cui un oggetto esterio-re e oggettivo si trasforma o saetta in una cosa interiore e soggettiva»44. L’effetto poetico è evi-dente. La capacità di “affilare” la propria visio-ne, fino a vibrare all’unisono con ciò che si vede, è altrettanto evidente, per chi abbia «a discer-ning eye»45. Pound non abbandonerà mai que-sta tecnica46. Era l’immagine allo stato puro. Ne farà ampio uso in Lustra, la raccolta in cui l’ap-prendistato della lezione giapponese è più pa-lese e dove, insieme, alla celebre In the Station of the Metro, abbondano componimenti chiara-mente ispirati all’haiku. Leggiamo, ad esempio, Fan-Piece, for Her Imperial Lord, che Miner ritie-
naman said long time ago that if a man can’t say what he has to say in twelve lines he had better to keep quiet. The Japanese have evolved the still shorter form of the hokku. The fallen blossom flies back to his branch:/ A butterfly».
43 Ibidem: «one-image poem is a form of super-position; that is to say one idea set on top of another».
44 Ibidem: «in a poem of this sort one is trying to record the precise instant when a thing outward and objective transforms it-self, or darts into a thing inward and subjective».
45 Much madness is a divine sense / To a discerning eye, ci ricorda Emily Dickinson in una delle sue poesie più celebri (J. 431). Le analogie tecniche contenutistiche e formali tra la Dickin-son – che della brevità e della suggestione fece i suoi emblemi – e i migliori poeti di due generazioni successive alla sua sono pro-fonde e molteplici.
46 Per una rassegna dettagliata, si veda e. miner, The Japa-nese Tradition …, cit., pp. 114 ss. Miner, tuttavia, non cita esempi dall’Omaggio e limita l’uso della «super-position form» nel Mauber-ley al solo finale. Per altri esempi, vd. infra.
Il Giappone di Ezra Pound 251
ne il lavoro «che si avvicina più di qualsiasi altro a meritare il titolo di haiku in inglese»47:
O fan of white silk,clear as frost on the grass-blade,You also are laid aside48.
La applicherà nelle splendide versioni dal cinese di Cathay, su cui torneremo tra breve, ne farà ampio uso nell’Omaggio a Sesto Proper-zio dal quale citiamo l’Hokku-like che apre la pe-nultima sezione:
The harsh acts of your levityMany and many.I am hung here, a scare-flow for lovers49.
In questo suo haiku Pound dimostra una profonda comprensione tecnica del modello: i giochi allitterativi («harsh-hung», «levity-lovers»), le assonanze interne, il senso di sospensione generato dalla virgola nel verso finale sono tut-ti accorgimenti derivati dallo studio dell’haiku.
Si ricorderà di tali acquisizioni tecniche in vari brani di Mauberley, tra cui il finale, anche se, probabilmente, l’esempio piu bello resta il V componimento:
There died a myriad,And of the best, among them,
47 Ivi, p. 104: «closer to any other attempt to meriting the title haiku in English». − A differenza di Miner, credo che Pound, pur rispettando in questo componimento la metrica dell’origina-le (5-7-5), non abbia realmente colto lo spirito dell’haiku. Fan-Pie-ce risente, infatti, di un certo languore romantico che, se presen-te nell’antica poesia cinese, è piuttosto raro in quella giapponese, specialmente nell’haiku. Pound ci darà esempi di una compren-sione più fine dello spirito dell’haiku nel corso dei Cantos, in spe-cie quelli pisani.
48 e. PounD, Lustra, cit., p. 108.49 e. PounD, Homage to Sextus Propertius, London, Faber
1934, p. 54.
GiorGio Sica252
For an old bitch gone in the teeth,For a botched civilization.
Charm, smiling at the good mouth,Quick eyes gone under earth’s lid,
For two gross of broken statues,For a few thousand battered books50,
con quegli Quick eyes gone under earth’s lid (“occhi veloci andati sotto le palpebre della ter-ra”) che riassumono in una immagine perfetta il disastro di una civiltà. Come vedremo in segui-to, questa tecnica sarà il vero e proprio collante poetico nel flusso narrativo dei Cantos.
L’haiku era «energia concentrata nell’esattezza»51. In questo la sua importanza trascende la questione puramente tecnica, e ri-suona del basso continuo di un’epoca. A con-clusione del suo discorso sull’haiku, Pound scrive: «Immagino che ciò sia senza significato a meno che non si sia entrati in una certa vena di pensiero»52. Ora, in questa vena di pensiero scorreva il sangue di uomini che in ogni campo dell’arte, ma anche nell’economia o nella fisica, tentavano un rinnovamento radicale. Einstein aveva appena proclamato l’identità di massa e energia. Erano gli anni del ritrovamento degli scritti di Mendel, che porteranno nel 1909 al primo manuale di genetica, gli anni di Gugliel-mo Marconi e dei coniugi Curie. Parole come energia, struttura molecolare e radioattività erano sulla bocca di tutti. Pound poteva scri-vere che «si potrebbe arrivare a credere che la
50 e. PounD, Hugh Selwyn Mauberley, London, The Ovid Press 1920, section V.
51 L’espressione è un prestito di H. Kenner, L’età di Pound, cit., p. 225.
52 Cfr. e. PounD, Vorticism, cit., p. 89: «I dare say it is mean-ingless unless one has drifted into a certain vein of thought». Trad. it.: Vorticismo, cit., p. 1204.
Il Giappone di Ezra Pound 253
cosa che importa in arte è una sorta di energia, qualcosa di più o meno simile alla elettricità o alla radioattività»53 e, altrove, poteva paragona-re la lettura di un libro a un nutrimento a una perdita, in termini di energia54. Erano paragoni freschi di legittimazione. Emergevano tradizio-ni esoteriche che celebravano l’universo come un organismo vivo, scandito da dinamismi ordi-nati. Yeats poteva ritenere la danza una forma di esistenza normale, mentre Joyce si divertiva a fare il verso ai teosofi irlandesi. Anche la poe-sia doveva adattarsi alla nuova realtà. Fenollo-sa aveva già insegnato che «Non esiste in natu-ra un vero nome, una cosa isolata. Le cose non sono che i punti terminali, o meglio i punti d’in-contro delle azioni sezioni intersecanti le azio-ni, istantanee. Né è possibile in natura un ver-bo puro, un moto astratto. L’occhio vede nome e verbo tutt’uno, cose in moto, moto nelle cose …»55. Così, l’uomo che meglio lo comprese de-scriverà l’immagine poetica come «un nodo rag-giante, un grappolo; […] quello che posso, devo per forza chiamare un VORTICE, dal quale at-traverso il quale e dentro il quale le idee si pre-cipitano continuamente»56. Travolta da questa
53 Cfr. e. PounD, Literary Essays, cit. p. 49: «We might come to believe that the thing that in art is a sort of energy, something more or less like electricity or radioactivity, a force transfusing, welding and unifiyng».; trad. it.: e. PounD, Saggi letterari, cit. p. 78.
54 ID. in The New Age, 4-1-1912. 55 Cfr., e.F. FenolloSa, The Chinese Written.., cit., p. 17; «A
true noun, an isolated thing, does not exist in nature. Things are only the terminal points, or rather the meeting point of actions, cross sections cut trough actions, snapshots. Neither can a pure verb, an abstract motion, be possible in nature. The eye sees noun and verb as one, thing in motion, motion in things»; (trad. it.:, L’ideogramma cinese come mezzo di poesia, cit., p. 17).
56 e. PounD, Vorticism, cit., p. 92: «A radiant node or cluster; it is what I can, and must perforce, call a VORTEX, from which, and through which, and into which, ideas are constantly rush-ing». (trad. it.: Vorticismo, cit., p. 1201).
GiorGio Sica254
ondata rigenerante, l’impalcatura dell’univer-so newtoniano crollava, tutto era di nuovo mo-vimento perpetuo, le avanguardie sguazzavano nel fiume in piena. Era un mondo nuovo, che esigeva una nuova, diversa attenzione. Gli ar-tisti più avveduti capirono subito che nel gode-re delle energie liberate, dovevano stare attenti a non compiacersi e perdersi senza un criterio di selezione nella molteplicità, destino di tanti strombazzanti futuristi. Pound, da par suo, an-dava in cerca di una sintesi. La sua intelligenza gli impediva il solo pensiero di un rifiuto in bloc-co della tradizione, «la curiosa mania di distrug-gere le glorie passate»57 caratteristica di Mari-netti. A quanti accostavano le sue idee a quel-le dei futuristi, rispose senza mezzi termini che «il Futurismo […] era una sorta di impressio-nismo accelerato» e che pur «non avendo dub-bi che l’Italia aveva bisogno del Sig. Marinetti, pure non è stato lui a sedersi sull’uovo che mi ha covato»58.
57 Ivi, p. 92: «this curious tic for destroying past glories»; (trad. it.: e. PounD, Vorticismo, cit., p. 1210).
58 Riporto integralmente la distinzione effettuata da Pound: «Futurisme is descended from Impressionism. It is, in so far as it is an art movement, a kind of accelerated impressionism. It is a spreading, or surface art, as opposed to vorticism, which is in-tensive. The vorticist has not this curious tic for destroying past glories. I have no doubt that Italy needed Mr. Marinetti, but he did not set on the egg that hatched me, and as I am wholly op-posed to his aesthetic principles I see no reason why I, and vari-ous men who agree with me, should be expected to call ourselves futurists. We do not desire to evade comparison with the past. We prefer that the comparison be made by some intelligent per-son whose idea of «the tradition» is not limited by the convention-al taste of four or five centuries and one continent». Ibidem. Po-che settimane prima, il 20 giugno 1914, sulle colonne di Blast Pound era stato ancor meno diplomatico: «Impressionism, Futu-rism, which is a only a sort of accelerated Impressionism, DENY the Vortex. They are THE CORPSES of VORTICES. POPULAR BE-LIEFS, movements, etc., are THE CORPSES OF VORTICES. Ma-rinetti is a corpse».
Il Giappone di Ezra Pound 255
Memore dell’insegnamento di Hulme, Pound combatteva una battaglia titanica per una nuo-va classicità, per un’arte che tornasse ad essere visione, senza prescindere da un assoluto rigo-re formale. «La tecnica, prima di tutto la tecnica» era già allora il suo motto e l’invito ai tanti gio-vani aspiranti poeti che lo avvicinavano in cer-ca di consiglio. Ed è in questa precisa volontà di distacco dalla tecnica “polentosa”59 del simbo-lismo e dalle indefinitezze dell’impressionismo, che si caratterizza a partire da quegli anni la po-esia sua e dei suoi colleghi imagisti. E possiamo immaginare l’attrazione che esercitò sulle menti di questi giovani innovatori una poesia formal-mente “perfetta” e sobriamente visionaria come quella giapponese e cinese. Quando, nel marzo 1913, pubblica i suoi famosi Donts for those be-ginning to write verses60, invitando a non usare «parole superflue, o aggettivi che non significhi-no qualcosa», viene da pensare all’assoluta con-centrazione verbale dell’haiku. Il legame appare ancora più evidente quando ammonisce l’aspi-rante scrittore a non dimenticare mai che «l’og-getto naturale è sempre il simbolo adeguato». Pochi mesi dopo specificherà quanto sia grande la differenza con i simbolisti. «Imagismo non è simbolismo. I simbolisti commerciavano in “as-sociazioni”, cioè una specie d’allusione, quasi d’allegoria. Degradarono il simbolo alla condi-zione di una parola […] gli Imagisti non usano le immagini come ornamenti»61. E nel 1918, or-mai reduce da quel capolavoro di Cathay, riba-dirà: «io credo che il simbolo appropriato e per-
59 «mushy» nell’originale (ivi, p. 1203).60 Cit. in E. miner, The Japanese Tradition …, cit., p. 123.61 e. PounD, Vorticism, cit. p. 84: «Imagism is not symbol-
ism. The symbolists dealt in association, that is, in a sort of allu-sion, almost of allegory. They degraded the symbol to the status of a word. They made it a form of metronomy.» (trad. it.: Vortici-smo, cit., p. 1203).
GiorGio Sica256
fetto è l’oggetto naturale, che se uno adopera dei simboli deve adoperarli in modo che la loro funzione simbolica non si renda importuna; in modo che un senso, e la qualità poetica del pas-so, non vadano perduti per coloro che non capi-scono il simbolo come tale, per coloro ad esem-pio per i quali un falco è un falco»62. Nulla di più vicino allo spirito della poesia giapponese e ci-nese, Pare quasi di sentire una eco di queste af-fermazioni poundiane quando Blyth demarca in questi termini il carattere dell’haiku:
«It is necessary to state with some vehemence that haiku is not symbolic, that is not a portrayal of natural phenom-ena with some meaning behind them»63,
e continua, citando Matsuo Bashō:
«When our master told us to learn about the pine-tree from the pine-tree and about the bamboo from the bam-boo, he meant that he would trascend self and learn… To learn means to submerge oneself into the object until its intrinsec nature becomes apparent, stimulating poetic impulse»64.
62 e. PounD, Literary Essays, cit., p. 9: «I believe that the proper and perfect symbol is the natural object, that if a man use ‘symbols’ he must so use them that their symbolic function does not obtrude; so that a sense, and the poetic quality of the passage, is not lost to those who do not understand the symbol as such, to whom, for instance, a hawk is a hawk» (trad. it.: Saggi Lettera-ri, cit., p. 25).
63 Cfr. R.H. BlYth, History of Haiku, cit., vol. I, p. 13: «È ne-cessario affermare con una certa forza che l’haiku non è simbolico, che non è il ritratto di un fenomeno naturale con qualche signifi-cato alle spalle» (il corsivo e la traduzione sono mie). − Ricordo che il libro di Blyth ha costituito un veicolo fondamentale di diffusione dell’haiku presso un pubblico più vasto.
64 Ibidem, loc. cit.: «Quando il nostro maestro ci disse di im-parare cosa sia il pino dal pino e cosa sia il bambù dal bambù, voleva dire di trascendere se stessi e imparare […]. Imparare vuol dire immergersi nell’oggetto fino a che la sua intrinseca natura appaia, stimolando l’impulso poetico»
Il Giappone di Ezra Pound 257
Il maestro giapponese ci invita a compren-dere che l’oggetto è gia il simbolo, che solo dalla compenetrazione con esso nasce l’“impulso po-etico” o, nella terminologia di Pound, l’immagine. «There is no separation between the thing and its meaning», prosegue, a sua volta, Blyth, «one thing is not used to imply another thing»65. Questo discorso ci aiuta a capire quanto raffi-nata e in anticipo sui tempi fosse la compren-sione dell’haiku da parte di Pound e quanto questa stessa comprensione abbia modellato la poetica imagista e vorticista.
Dall’incontro con Fenollosa nascerà, come avevo accennato in precedenza, Cathay, un li-bro che all’Europa devastata dalla Grande Guer-ra parlava di guerre in una terra lontana, di ad-dii al chiaro di luna e di giovani spose abban-donate, di arcieri disperati e di dinastie abbat-tute, di guardie solitarie e di interminabili esili. I preamboli sono noti, le polemiche e lo sdegno dei pedanti pure. Queste traduzioni di poesie ci-nesi, in buona parte attribuite a Li Po66, furono
65 Ivi, p. 14: «Non c’è separazione tra la cosa e il significato. Una cosa non è usata per implicarne un’altra».
66 Li Po (in cinese: 李白; Suiye, 701 – Chang Jiang, 762) è stato uno dei massimi poeti della Dinastia Tang (assieme a Du Fu e Bai Juyi) e dell’intera letteratura cinese. La pronuncia “Po” (pinyin: Bo) del suo nome, è una variante oramai desueta, tan-to che è correntemente conosciuto in Cina come Li Bai, mentre in Occidente rimane più noto come Li Po. Viene chiamato an-che l’«immortale caduto» e l’«immortale poeta» (dove per immorta-le – xiān, 仙 – si intende un eremita taoista di eccezionale longevi-tà). Di lui rimangono circa 1.100 poesie, alcune delle quali dalla paternità contestata. − Li Po, che passò gran parte della sua vita viaggiando, è conosciuto per l’esuberante immaginazione visiva, l’amore per la natura e il desiderio di distacco dalla mondanità, per gli elementi taoisti nelle sue poesie e per la gran passione per l’alcol (la leggenda vuole che sia morto annegato nel Chang Jiang cadendo dalla barca mentre, ubriaco, tentava di prendere la luna riflessa nelle acque). La sua lingua è semplice, aborre ogni forma di erudizione e di intellettualismo, e le sue poesie, per lo più brevi e di argomento quotidiano, catturano un istante, un dettaglio che la magia del verso trasfigura in categoria dell’anima. In Occidente
GiorGio Sica258
compiute sulle note, a volte oscure, a volte im-precise, del sinologo scomparso.
All’epoca Pound era, infatti, del tutto ignaro della lingua cinese, ma volle affrontare comun-que l’impresa, convinto che la traduzione fos-se, piuttosto che una resa letterale, una sorta di ricreazione dello spirito che animava l’origina-le67. Benché la sua lettura “creativa” degli ide-ogrammi abbia causato lo sdegno dei sinologi, Pound ci ha lasciato, in tanta precarietà, quel-la che George Steiner ha definito la sua «opera più ispirata […] e l’impresa che più si avvicina a giustificare l’intero programma imagista»68, con-
si cominciò a conoscerlo grazie alla traduzione in francese di al-cuni suoi componimenti inseriti dal marchese d’Hevrey de Saint-Denis nell’antologia Poésies de l’epoque des Thang del 1862 (in séguito tradotta anche in tedesco e in inglese). Tra le traduzioni più recenti della sua opera ricordiamo: Liriche Cinesi, a cura di G. Valensin, con prefazione di E. Montale, Torino, Einaudi 1943 (ri-stampa: 1994); A. Waley, The Poetry and Career of Li Po, 701-762 AD, London, Geroge Allen & Unwin 1950; A. Cooper, Li Po and Tu Fu, Harmondsworth, Penguin 1973; S. Wong, The Genius of Li Po, AD 701-762, Hong Kong, University of Hong Kong Press 1974; V. Costantini, Coppe di giada. Antologia della poesia cinese classica, Li Po, Tu Fu, Po Chu-i, Torino, Utet 1985.
67 Attratto dalle intuizioni poco ortodosse di Fenollosa, Pound ritenne che le poesie si dovessero tradurre facendo in modo che di ogni logogramma si esprimessero anche i pittogrammi (nel radicale o nella parte fonetica) in essi contenuti, anche se il ca-rattere era puramente fonetico o un elemento unicamente gram-maticale. Questo potrebbe essere paragonato a una traduzione da una lingua in caratteri latini in cui a ogni lettera dell’alfabeto fos-se dato il suo originario valore semantico e pittografico (ad esem-pio: la testa di bue per la lettera A). Ovviamente questo conduceva a notevoli salti di senso e a una confusione non gestibile se non tagliando e omettendo senza criterio i caratteri che non riuscivano a rientrare nel gioco della traduzione. Se i sinologi, per compren-sibile spirito di casta, non apprezzarono Cathay, l’accoglienza del mondo poetico fu però entusiasta.
68 Cfr. G. Steiner, After Babel: Aspects of Language and Translation, Oxford, 1975; trad. it.: Dopo Babele. Aspetti del lin-guaggio e della traduzione, Milano, Garzanti 1984, p. 426. Nel suo viaggio nell’arte della traduzione, Steiner si sofferma a descrivere l’incredibile capacità mimetica di Pound, esaltandone «la facilità
Il Giappone di Ezra Pound 259
tribuendo in maniera fondamentale al rinnova-mento del verso inglese.
Pochi mesi dopo, sempre dai quaderni di Fe-nollosa, il suo «genio autometamorfico»69 done-rà all’occidente la prima versione poeticamente degna del teatro Nō giapponese, con alcune tra-duzioni che, nel suo stile, sono vere perle, tra cui spicca il bellissimo Nishikigi. L’entusiasmo di Pound per questa opera è degno di essere ri-cordata. La lettera che, insieme al manoscrit-to della traduzione inviò ad Harriet Monroe, l’a-mica direttrice di Poetry, non lascia dubbi al ri-guardo: la pubblicazione di Nishikigi, egli scri-ve, «ci darà una ragione di esistere», aggiungen-do di ritenere che la Monroe concorderà con lui nel considerare questa «scoperta giapponese la trovata più fortunata che abbiamo avuto dall’i-nizio della rivista»70.
La passione di Pound per il Nō, il cui fascino presto stregò Yeats71, fu trascinante e costante nel tempo. «Il Nō è incontestabilmente una delle più grandi forme d’arte del mondo», scrisse nel-la breve introduzione alla sua prima traduzione.
Nel dramma giapponese, inoltre, Pound vide la possibilità di costruire un lungo poema vorticista: «Mi chiedono spesso come potrebbe essere un lungo poema imagista o vorticista. I giapponesi, che svilupparono l’haiku, sviluppa-rono anche i drammi Nō. Nei migliori Nō, l’intero
[…] di penetrare la forma aliena, di assumere la maschera e l’an-datura di altre culture».
69 L’espressione è di G. Steiner, Dopo Babele, cit., p. 426.70 Cfr. The Letters of Ezra Pound, 1907-1941, edited by D.
D. Paige. 1950. Reprinted as Selected Letters of Ezra Pound, 1907-1941, New York, New Directions 1971 (letter to H. Monroe, 31 Ja-nuary, 1914): «will give us some reason for existing»; «this Japanese find is about the best bit of luck we’ve had since the starting of the magazine».
71 Sulle relazioni tra Yeats e il Nō v. la dettagliata analisi di Miner, The Japanese Tradition …, cit., pp. 232-265.
GiorGio Sica260
dramma può consistere di una sola immagine. Voglio dire che è raccolto su una sola immagi-ne. La sua unità consiste in una sola immagine, rinforzata dal movimento e dalla musica. Non vedo nulla contro un lungo poema vorticista»72.
Se ne ricorderà costantemente nei Cantos, e per molti anni lo accompagnerà il desiderio, che purtroppo resterà tale, di una traduzione più completa e fedele di altri drammi.
Ma, se con grande rammarico di chiunque ami la poesia questo nuovo incontro con il Nō non si avverò, il rapporto tra Pound e l’Estre-mo Oriente proseguirà fecondo in altre direzio-ni. L’haiku, come ha ben rilevato Kenner73, ab-bonderà anche nei Cantos pisani, probabilmen-te il vertice qualitativo del vasto poema vortici-sta del Nostro, specialmente nel canto LXXVI, il cui celebre inizio, ad esempio, risuona della tec-nica appresa dai maestri del Sol Levante:
And the sun high over horizon hidden in cloud banklit saffron the cloud ridgedove sta memora74
Altre volte, nel medesimo Canto, tre versi isolati dal flusso discorsivo ne spezzano la tra-ma, impreziosendola come un improvviso intar-sio:
72 Cfr. E. PounD, Gaudier-Brzeska, cit., p. 140: «I am often asked whether there can be a long imagiste or vorticist poem. The Japanese, who evolved the hokku, evolved also the Noh plays. In the best Noh the whole play may consist of one image. I mean it is gathered about one image. Its unity consist of one image, en-forced by movement and music. I see nothing against a long vor-ticist poem».
73 H. Kenner, The Moving Image’ in The Poetry of Ezra Pound, Norfolk, New Directions 1951 (reprint: Lincoln, Univ. of Nebras-ka P. 1985).
74 E. PounD, The Cantos of Ezra Pound, New York, New Di-rections 1970, p. 480.
Il Giappone di Ezra Pound 261
from il triedro to the Castellarothe olives grey over grey holding wallsand their leaves turn under Scirocco75.
E, nel primo dei Cantos Pisani, il LXXIV, Pound volle esprimere tutta la profondità del proprio dolore in uno splendido haiku:
under the grey cliff in periplumthe sun dragging her starsa man on whom the sun has gone down76.
Siamo di fronte ad una vera e propria tra-smutazione della struttura dell’haiku: i primi due versi, densi di allitterazioni, evocano, attra-verso la dominanza delle consonanti, la fatica del sole prolungata indefinitamente dall’in pe-riplum posto alla fine del primo verso (ma che potrebbe avere la valenza di una kakekotoba, “parola-perno” giapponese, e riferirsi anche alla scogliera); il terzo verso, costruito secondo la tecnica della form of super-position, racchiude in un’immagine di potenza epigrammatica la so-litudine dell’uomo.
Se nei Cantos pisani la presenza dell’haiku è una costante, tutto il poema testimonia l’as-siduo studio di Pound dell’ideogramma cinese, visto nel solco di Fenollosa come un’immagine, un centro energetico e poetico che inserirà a più riprese in tappe centrali del lungo viaggio dei Cantos. E sulle dinastie cinesi incentrerà la bel-lezza di dieci Cantos consecutivi, indossando gli abiti di uno storico confuciano, amorevole verso il dettaglio che diventa archetipo, preoccupato sempre e innanzitutto di un giudizio morale che stia saldo come roccia nel fiume mutevole degli eventi. Di Confucio, nel Canto LXIII, lamenterà
75 Ibidem, loc. cit.76 Ivi, p. 457.
GiorGio Sica262
la morte con una scrittura densa di echi dei me-moriali dell’epoca:
in the 40th year of King OuangDied Kung aged 73Ming Kong’s line was six century lastingand there were 84 princesSwine think of extending bordersDecent rulers of internal orderFen-Li sought the five lakesTook presents but made no highwaysSnow fell in mid summerApricots were in December […]77.
Confucio, si sa, diverrà la sua più profon-da, duratura passione filosofica. Inizierà tradu-cendone dal francese il testamento, il Ta Hsio, di cui leggenda vuole che i primi sette paragra-fi fossero stati scritti dal maestro in persona su liste di bambù. Lo tradurrà prima in inglese e poi, negli anni della seconda guerra, in italiano. Diverrà la sua guida, un libro in cui credere, e a T.S. Eliot che gli chiedeva: «In cosa crede Mr. Pound?» risponderà: «Io credo nel Ta Hsio»78. E, quando la polizia militare lo arresterà a Rapallo per tradimento, gli troveranno in tasca una co-pia di una ristampa pirata della traduzione in inglese dei Quattro Libri di Confucio di James Legge79, libro da cui aveva tratto, con notevoli modifiche dovute alla personale interpretazione “poetica” degli ideogrammi, la sua versione del Chung Yung (L’asse che non vacilla), testo che continuava senza sosta a studiare.
Confucio continuerà ad accompagnarlo ne-gli anni del manicomio, gli anni dell’“Ultimo Vortice”, fino a quando ormai settantenne, pub-
77 Ivi, pp. 284-285. 78 Cfr. e. PounD, Literary Essays, cit. pp. 85-6: «to what Mr.
Pound believes? I believe the Ta Hio». (trad. it.: Saggi letterari, cit. p. 115).
79 Cfr. H. Kenner, L’età di Pound, cit., p. 230.
Il Giappone di Ezra Pound 263
blicherà quel capolavoro assoluto di musicali-tà e di penetrazione in un altro universo poeti-co che è la Classic Anthology Defined by Confu-cius, in cui l’intera tradizione inglese e le sue ac-quisizioni degli anni trascorsi in compagnia dei trovatori e di Sesto Properzio, sono chiamate a raccolta per confrontarsi con lo splendore senza tempo del Libro delle Odi.
Leggiamo dal I libro delle Folk Songs, Chou and the South, una canzone popolare che cele-bra le dame di una grazia di corte:
“Hid! Hid!” the fish-hawk sait,by isle in Ho the fish-hawk sait:“Dark and clear,Dark and clearSo shall be the prince’s fere”.
Clear as a stream her modesty;as neat dark boughs her secrecy,reed against reedtall on slightas the stream moves left and right,dark and clear,dark and clear.To seek and not findas a dream in his mind,think how her robe should be,distantly, to toss and turn,to toss and turn.
High reed caught in ts’ai grassso deep her secrecy;lute sound in lute is caught,touching, passing, left and right.Bang the gong of her delight80.
Attraverso il sapiente uso di rime (slight: right; right: delight; find: mind; clear: fere), al-
80 Cfr. e. PounD, The Classic Anthology Defined By Confu-cius. With an Introduction by Achilles Fang, Cambridge, Harvard University Press, 1954, p. 53.
GiorGio Sica264
litterazioni e assonanze (bang: gong; Ho: hawk; modesty: secrecy) e le numerose ripetizioni e onomatopee, Pound crea un gioiello di musica-lità in cui figure e metafore tipiche della poesia estremo-orientale (paragonare le virtù dell’ama-ta a elementi della natura è, ad esempio, un to-pos della poesia cinese, come pure la corrispon-denza tra i moti del paesaggio e i moti dell’a-nima) si fondono perfettamente con la proso-dia e la metrica inglese. È l’opera che conclude una ricerca durata una intera vita, il percorso di uno spirito profondamente religioso e onesto, che non poteva esprimere il suo amore per l’ar-te in forme meno che perfette.
In definitiva, Pound fu il maestro di un’e-tà. Il Giappone gli aveva mostrato da giovane la via per donare una nuova tecnica e soprattutto «nuovi occhi»81 a una generazione che sarà se-gnata dal suo messaggio, come Eliot sottoline-erà con forza nella sua introduzione ai Literary Essays:
«Mr. Pound is more responsible for the twentieth century revolution in poetry that is any other individual»82.
Dalla rivoluzione imagista il verso e la stes-sa lingua inglesi usciranno rigenerati. Sotto la guida di Pound, il genio di Eliot troverà la sua strada e il già maturo W.B. Yeats avrà modo di imparare ancora. Un’intera generazione – tra gli altri: E.E. Cummings, W.C. Williams, James Laughlin, Louis Zukofsky e Kenneth Rexroth – lo reputerà apertamente un maestro e molti gio-vani artisti si recheranno a Rapallo per formarsi alla cosiddetta “Ezuniversity”.
81 Così Pound riporta, approvandolo, il giudizio di un cor-rispondente russo sulla sua opera: «I see you wish to give people new eyes, not to make them see some new particular thing» (in Vorticism, cit., p. 464).
82 Cfr. e. PounD, Literary Essays, cit., p. 9.
Il Giappone di Ezra Pound 265
Ma l’influenza del poeta americano va ben oltre l’ambito anglofono. Mi piace affidarmi, per una sintesi finale, a W.H. Auden, la cui compe-tenza in fatto di poeti e di poesia è al di sopra d’ogni sospetto:
«Ci sono pochi poeti viventi che, anche se non sono consa-pevoli di aver subito l’influsso di Pound, potrebbero dire: la mia opera sarebbe esattamente la stessa se Pound non fosse esistito»83.
Bibliografia
R.H. BlYth, A History of Haiku, Tokyo, Hokuseido, 1964, IV vol.
L. BYnion, Painting in the Far East: An Introduction to the History of Pictorial Art in Asia, Especial-ly China and Japan, London, Arnold, 1908 (4th ed. rev.: 1934; reprint: New York, Dover, 1959).
L. BYnion, The Flight of the Dragon: An Essay on the Theory and Practice of Art in China and Japan, Based on Original Sources, in «Wisdom of the East Series», London, Murray, 1911 (reprint: 1972).
A. cooPer, Li Po and Tu Fu, Harmondsworth, Pen-guin, 1973.
V. coStantini, Coppe di giada, antologia della poesia cines e classica, Li Po, Tu Fu, Po Chu-i, Torino, Utet, 1985.
M. De rachewiltz, Ezra Pound, in Novecento ameri-cano, a cura di Elemire Zolla, Roma, Lucarini, 1982.
e. FenolloSa, The Chinese Written Character as a Me-dium for Poetry, London, 1919; trad. it. a cura di M. de Rachewiltz: L’Ideogramma cinese come mezzo di poesia - una Ars Poetica, introduzione e note di Ezra Pound, Milano, All’Insegna del Pe-sce d’oro, 1960.
83 Cit. in G. SinGh, Pound, Firenze, La Nuova Italia 1979, p. 10.
GiorGio Sica266
F. S. Flint, History of Imagism, in «The Egoist», II (1-5-1915).
T. H. hulme, The New Philosophy, in «The New Age», V (19-08-1909).
S. Kato, Storia della letteratura giapponese, Venezia, Marsilio, 1989, II vol. (I vol.: ivi, 1987).
D. Keene, Japanese Literature, London, J. Murray, 1953.
H. Kenner, The Moving Image in The Poetry of Ezra Pound. Norfolk, New Directions, 1951 (reprint: Lincoln, Univ. of Nebraska, 1985).
H. Kenner, The Pound Era, Berkeley, Univ. of Cali-fornia, 1971 (trad. it.. di M. Graziosi: L’età di Pound, Bologna, Il Mulino, 1996).
Liriche Cinesi, a cura di Giorgia Valensin, con prefazione di Eugenio Montale, Torino, Einaudi, 1943 (ivi, 1994).
E. miner, The Japanese Tradition in British and Ame-rican Literature, Princeton, Princeton Universi-ty, 1958.
F. nietzSche, La nascita della tragedia dallo spirito della musica, in Tutte le Opere, a cura di G. Col-li e M. Montinari, Milano, Adelphi, 1999, vol. I.
E. PounD, A Few Dont’s By an Imagist, in «Poetry» (3/1/1913).
E. PounD, E. Wadsworth, Vorticist, in «The Egoist», (I-VI-1914).
E. PounD, Vorticism, in «The Fortnightly Review», n. CII (I-IX-1914); trad. it. a cura di M. de Ra-chewiltz: Vorticismo in Opere scelte, Milano, Mondadori, 1970, pp. 1198-1215.
E. PounD, Gaudier-Brzeska: A Memoir Including the Published Writings of the Sculptor and a Selec-tion from His Letters, John Lane, 1916, New Directions, 1961; trad. it. a cura di M. de Ra-chewiltz: Gaudier-Brzeska, Milano, Guerini e Associati, 1989.
E. PounD, Lustra, London, Elkin Mathews, 1916 (ora in Pound, E., Personae. The Shorter Poems of Ezra Pound (1926), New York, New Directions, 1990).
Il Giappone di Ezra Pound 267
E. PounD, Hugh Selwyn Mauberley, London, Ovid, 1920.
E. PounD, Homage to Sextus Propertius, London, Fa-ber, 1934.
E. PounD, The Letters of Ezra Pound, 1907-1941, ed. by D. D. Paige, 1950 (poi Selected Letters of Ezra Pound, 1907-1941. New York: New Directions, 1971).
E. PounD, Literary Essays, ed. by T. S. Eliot, London, Faber and Faber, 1954 Saggi letterari, a cura di T.S. Eliot, trad. it. di N. d’Agostino, Milano, Gar-zanti, 1957.
E. PounD, The Classic Anthology Defined By Confu-cius. With an Introduction by Achilles Fang, Cambridge, Harvard University Press, 1954.
E. PounD, The Cantos of Ezra Pound, New York, New Directions, 1970.
G. Sica, Schegge di un unico cristallo. L’haiku e il rin-novo della poesia occidentale, in «Intersezioni», a. 2006, n.1, pp. 75-104.
G. SinGh, Pound, Firenze, La Nuova Italia, 1979.G. Steiner, After Babel, Oxford, 1975 (trad. it. a cura
di N. D’Amico: Dopo Babele, Milano, Garzanti, 1992).
D. S. thatcher, A. R. Orage in Nietzsche in England 1890-1914: The Growth of a Reputation, Toron-to, University of Toronto Press, 1970.
terrell, F. carroll, The Na-Khi Documents I, in «Pai-deuma», a. 1974, n. 3, pp. 91-122.
K. YaSuDa, The Japanese Haiku, Vermont & Tokyo, Rutland, 1957.
A. waleY, The Poetry and Career of Li Po, 701-762 A. D., London, Geroge Allen & Unwin, 1950.
S. wonG, The Genius of Li Po, AD 701-762, Hong Kong, University of Hong Kong Press, 1974.
E. Zolla (a cura di), Novecento americano, Lucarini, Roma, 1982.
Il Giappone di Ezra Pound - Ezra Pound’s Japan
Giorgio Sica
L’intera opera poetica di Ezra Pound è segna-ta da un rapporto pri-vilegiato con la lettera-tura e il pensiero giap-ponese e il poeta ame-ricano contribuì più di chiunque altro alla dif-fusione presso i suoi contemporanei di mo-tivi stilistici, tematici e formali propri di quel-la tradizione. Attraver-so l’analisi di momenti centrali dell’attività let-teraria di Pound, riper-corro diacronicamen-te lo sviluppo di que-sto rapporto, sottoline-ando il ruolo centrale svolto dall’incontro con l’haiku e con la spiri-tualità giapponese nella formazione ed evoluzio-ne delle sue teorie po-etiche e della sua ma-niera di scrivere versi
All works in verse by Ezra Pound are marked by a privileged relation with Japanese literature and philos-ophy and more than anyone else the Amer-ican poet has helped to spread the stylis-tic, thematic and for-mal motives of that tra-dition among his con-temporaries. Through a survey of the crucial events in Pound’s liter-ary activity, I trace the development of this re-lation from a diachron-ical point of view, high-lighting the crucial role of the discovery of the haiku and Jap-anese spirituality in the building and devel-opment of his poetical theories and his man-ner of writing verses.
Riassunto - Abstact
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 269-304
MiMMo Cangiano
La tentazione dell’impressione.Riguardo ai giudizi di Boine su Soffici
I. «Da molti giorni non vedendo nessuna lettera tua»
Nel maggio 1908 due lettere (scritte a un giorno di distanza) si incrociano fra Mila-no e Poggio a Caiano. Si tratta di due an-
titetiche prese di posizioni nei confronti di una crisi esistenziale, nei confronti, vale a dire, di quella crisi che, nietzschianamente, ha colpito la possibilità di riordinare l’indistinto rimesco-lio della vita in un codice a valenza accentrati-va che permetta di selezionare, giudicare, ordi-nare. Gli autori sono, rispettivamente, Giovanni Boine e Ardengo Soffici:
E mi sono convinto che vita vera e piena non è possibile senza la continua coscienza di questa angoscia che mina non solo me; ma tutti gli uomini e le cose.1
una volta più per ischerzo che per altro dissi che ogni fi-losofo allorché ha scritto l’ultima riga del suo sistema do-vrebbe aggiungervene un’altra per riderne […]. Io non so se la bellezza sia nella natura o in me né in che rapporto stia-no le bellezze naturali ed artistiche: ma so che l’unica feli-cità è di vivere in simpatia con le cose2
Forte è la tentazione di istituire subito una contraddizione canonizzante, quella classica fra Espressionismo ed Impressionismo, fra intro-
1 Giovanni Boine a Ardengo Soffici, 10 maggio 1908, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici della «Voce» – Vari. 1904-1917, vol. IV, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 1979, p. 46.
2 Ardengo Soffici a Giovanni Boine, 11 maggio 1908, ivi, p. 48.
MiMMo Cangiano270
missione deformante dell’Io e passiva accetta-zione del dato: ma se in Soffici gli elementi si presentano più regolari, più immediatamente disposti ad offrire quella connessione individua-ta da Lukács fra Impressionismo e lebensphi-losophie, fra contingenza ed estrema soggetti-vazione, non altrettanto vale per Boine, la cui esperienza (come è ampiamente noto) si com-pone di una serie di piani alternati e spesso in-trecciati, e in cui l’Espressionismo è ben lun-gi dal giocare un ruolo totalizzante, ma è ben-sì momento dialettico di un orizzonte assai più ampio.
Nell’impossibilità di seguire ora, per ragio-ni di spazio, l’intero arco della poetica boinia-na (dall’esperienza Modernista già venata di esi-stenzialismo alla visione gnostica incentrata sul tropo avverso della Trascendenza, dalla espe-rienza civile in provincia al frammentismo), vor-remo provare a seguire la strada dei giudizi dati da Boine al lavoro del collega toscano. Crediamo che in questo modo non solo la contrapposizio-ne fra Impressionismo ed Espressionismo risul-terà più nitida, ma che anche la prospettiva boi-niana si rivelerà più definita, proprio nell’oppo-sizione (non sempre così netta) a quell’ottica che congenialmente gli dovette apparire avversa.
Soffici ricompare nel carteggio boiniano il 16 giugno del 1909. Boine ha letto l’Ignoto to-scano e ne parla a Casati:
Qui e là qualche idea buona e due o tre cose che m’hanno commosso. Poi ingenuità buffe […] garbugli metafisici sen-za senso (il Nulla verità inconcepibile, etc.) […] Volevo scri-vergli: «Bravo Soffici, sei tutto quanto in questi venti pa-gine» ma ho pensato ch’è capace di pigliarla per una lode. In compenso non è una cosa brutta ma la dedica a Didimo Chierico… e ci corre3
3 Giovanni Boine a Alessandro Casati, 16 Giugno 1909, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnovamento»,
La tentazione dell’impressione 271
E direttamente a Soffici dieci giorni dopo:
Codesto Ignoto toscano è per intero Ardengo Soffici col suo aspetto – tra di predicatore e di guerriero – (anch’io t’ho de-scritto così una volta ad un tale che non ti conosceva) e con l’odio inestinguibile a tutte quante le estetiche (specie le crociane). Ci sono delle cose ch’io ti confesso di non capi-re, quelle per esempio che tu profetizzi intorno al Nulla […]. L’ombra di Didimo s’è probabilmente fregata le mani…4
La valenza antifrastica delle due lettere non deve far pensare a una semplice dichiarazione “di comodo”; Boine, infatti, anche quando trar-rà fuori i giudizi su Soffici dall’ambito della cor-rispondenza privata, manterrà il consueto tono ambivalente. È sulla natura di questa ambiva-lenza, sulle concessioni che egli fa alla poeti-ca dichiaratamente impressionistica del collega, che vale la pena interrogarsi.
II. Il porto dell’Ordine e il naufragio di Dio
Nel marzo 1912 Boine scrive una recensio-ne al Lemmonio Boreo dal titolo significativo: Don Chisciotte in Toscana. Anche in questo caso la critica non è del tutto aliena da elementi positivi:
E tutto ciò potrebbe essere ingenuità e semplicità di spi-rito. Ma poiché qui non siamo ragazzi o donnette, qui vo-gliam essere uomini, io chiamo ciò col suo nome, dico che questa è disonestà. […] Ma se l’Italia è così rotta a fram-menti, è così persa nei suoi mille particolari interessi […] dico che è perché non la teoria […], ma la vita – e talvol-ta con aspetto di profondo, di religioso, di vattelapesca – trionfa e tripudia da noi. […] ma l’estate c’è, e la Toscana
vol. III, tomo I (1905-1910), Roma, Edizioni di Storia e Letteratu-ra 1977, pp. 230-231.
4 Giovanni Boine a Ardengo Soffici, 26 Giugno 1909, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici della «Voce» – Vari, vol. IV, cit., pp. 89-90.
MiMMo Cangiano272
anche, mi pare. […] quadretti finiti, acquarelli, idilli, schiz-zi vivi che non ti dimentichi più. […] anche se l’interesse morale non è suscitato e se le cose dipinte sono strambe un poco la viva pittura c’è.5
L’atteggiamento passivo-percettivo (anti-morale) che Boine ritrova nel Don Chisciotte dell’amico (così diverso da quello unamuniano che aveva recensito nel 19076), si inserisce an-cora in quel proposito di «simpatia con le cose» espresso nella lettera sofficiana del 1908. La consonanza degli oggetti al mondo sentimenta-le dell’artista si esprime in un propositivo de-scrittivo-decorativo a valenza impressionista, che assolutizza la sensazione dell’attimo come esperienza partecipativa, come connessione dell’Io ad un movimento vitale a carattere con-tingente. Il momento fluido, vitale, sottolinea cioè dell’assolutizzazione soggettiva dello stato d’animo, esperienza vera nella brevità del mo-mento e, dunque, passibile di essere accomu-nata (nel crollo di qualsiasi giudizio di valore) a ogni altra esperienza. Nella decadenza della so-lidità del fatto tutto ciò che può condurre a un significato resta l’opinione individuale, ma que-sta si ritrova a sua volta immersa in un flusso che le nega qualsiasi possibilità ordinativa. La sensazione si erge come sovrano conducendo a un’ipostatizzazione del transeunte.
L’immersione dell’Io nelle cose ha di fatto sancito la sua sparizione in queste: la passivi-tà che il finto movimento ordinativo della sen-sazione comporta viene di conseguenza. Il pro-cesso comunicativo che in ciò si origina si dà già in partenza come problematico, chiudendo-
5 g. Boine, Don Chisciotte in Toscana (1912), in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, a cura di D. Puccini, Milano, Garzanti 1983, pp. 456-459.
6 Cfr. g. Boine, Miguel de Unamuno – Vida de D. Quijote y Sancho (1907), ivi, pp. 345-351.
La tentazione dell’impressione 273
si in un procedimento affermativo dove il valo-re appena creato, appunto nell’atto comunicati-vo, deve immediatamente distruggere se stesso. La nietzschiana «anarchia degli atomi» si è cioè tramutata in una classica-anarchia che eleva a Sistema la propria cronica incapacità di giunge-re a ciò che Lukács definì «l’essenza delle cose»7. Il tentativo di recupero di quest’essenza, il ten-tativo di opporsi al procedimento perverso del-la negazione di qualsiasi valore, sarà, per l’ap-punto, il grande proponimento dell’Espressioni-smo8. Era del resto un problema che a Boine fu chiaro fin dall’inizio:
quella dolorosa sensazione che ho avuto spesso anche da ragazzo e che m’ha angosciato, di non poter penetrare l’es-senza delle cose che mi stanno attorno. Un velo tra me e le cose. Come se mi rimanessero estranee, come se non si-gnificassero nulla9
Sui caratteri dell’Espressionismo di Boine ritorneremo in seguito, ma dobbiamo intanto notare come la sua prospettiva abbia a quest’al-tezza già subito numerosi rivolgimenti. Il senso di un legame fra la Trascendenza e un procedi-mento ordinativo (così come espresso con parti-colare vigore nel saggio Serveto e Calvino10) aveva
7 Cfr. g. LukáCs, The parting of the Ways (1910), in The Lukács reader, Cambridge (US), Blackwell 1995, pp. 167-173.
8 Come è ampiamento noto Lukács modificherà in seguito questa prospettiva giovanile affermando, contro Bloch, l’incapa-cità “politica” dell’Espressionismo di concepire la società capita-lista come un intero, richiudendosi di conseguenza in una prote-sta soggettivistica a carattere elitario rientrante nel quadro della «distruzione della ragione». Ma questo problema al momento non ci riguarda.
9 Giovanni Boine a Alessandro Casati, 11 Luglio 1908, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnovamento», vol. III, tomo I, cit., p. 88.
10 g. Boine, Serveto e Calvino (1908), in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., pp. 351-367. Boine in pratica difende l’intolleranza calviniana nei confronti di Serveto inquan-
MiMMo Cangiano274
già trovato una prima impasse nel San Giovan-ni della Croce11, ma qui il sentimento dell’ango-scia veniva principalmente a porsi nella distin-zione fra estasi e ascesi, vale a dire nella riatti-vazione continua di inquietudine12 che caratte-rizza il desiderio umano di «possesso» del divino. Tale inquietudine era però destinata a esplodere come problema gnoseologico nella Prefazione al Monologio di S. Anselmo del 1910, acquisendo caratteri decisamente esistenzialistici13:
drandola in un procedimento teso a salvaguardare il legame fra reale e divino nell’immediata soppressione di qualsiasi elemento “disturbatore”, vale a dire di qualsiasi elemento a valenza critico-contraddittoria.
11 id., San Giovanni della Croce (1908), in La ferita non chiu-sa, a cura di Mario Novaro, Modena, Guanda 1939, pp. 211-261.
12 Cfr. Giovanni Boine a Tommaso Gallarati Scotti, 21 ago-sto 1906, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinno-vamento», vol. III, tomo I, cit., p. 17: «L’anima mia è angosciata: ha gustato le gioie supreme della contemplazione ed ha sentito che in esse è la felicità e la perfezione. Ma poiché nella perfezione non sa rimanere, essa è angosciata».
13 L’esistenzialismo di Boine, veicolato in parte dalla lettu-ra proprio di Unamuno, era però in embrione sin dai primordi dell’esperienza Modernista. Si guardi agli Scritti inediti, a cura di G. Bertone, Genova, il melangolo 1977. Se nel 1906 Boine è im-pegnato in un lavoro sulle Memorie di Mistral e ne parla in questi termini: «In Mistral vi è una grande quiete» (p.25), cominciando a formarsi quei propositi di “religione della terra e della tradizione” che ritorneranno in seguito, già appaiono affermazioni di questo tipo: «Hai concepito Iddio come l’assenza assoluta di modo» (Fram-menti di un diario giovanile, p. 49), oppure «questa strana sete an-gosciosa» in uno scritto dal chiaro debito kierkegaardiano (Fra-ter taciturnus, p. 74). Cfr. Miguel de Unamuno a Giovanni Boine, 18 Gennaio 1907, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnovamento», vol. III, tomo I, p. 42: «Conosce Sören Kier-kegaard, un pensatore danese morto nel 1855? Glielo raccoman-do». Cfr. e. gioanoLa, Il mistico senza estasi, nell’opera collettiva Giovanni Boine, Atti del convegno nazionale di studi, Imperia, 25-27 Novembre, 1977, a cura di F. Contorbia, Genova, il melango-lo 1981, pp. 129-130: «il misticismo di Boine è già subito tragico e presuppone l’aut-aut del Frater Taciturnus di Danimarca, inter-locutore perpetuo di Unamuno. Contro le confusioni mistico-sen-suali di Fogazzato, i sogni di onnipotenza magica dei fiorentini, le prospettive di conciliazione scientifico-religiose di James». Gioa-
La tentazione dell’impressione 275
è infatti in ogni filosofia, in ogni tentativo d’unificazione del mondo, l’immancabile hiatus che impedisce all’unificazio-ne di attuarsi e che è tuttavia di questo sforzo d’unificazio-ne, la radice e la molla14
Il pensiero religioso […] confessa la sua originale impos-sibilità: Dio ha in esso dominio pieno e vi si erge come in un paese conquistato la fortezza del conquistatore. […] Esso starà in faccia al mondo come l’affermazione violenta e perpetua di una realtà che lo trascende15
La Trascendenza acquista ora un valore di-verso: essa si erge dinnanzi agli uomini come Ve-rità irraggiungibile (estremo Altro!) rende vano il bisogno di certezza, di Ordine, che gli uomini inseguono, che la stessa religione insegue. L’in-compiuto si sviluppa come inevitabile modo di essere, ma, nell’opposizione continua alla Tra-scendenza, questo modo di essere si rivela im-mediatamente fasullo: la vita si fa così palude dell’inautentico. E nella crisi del pensiero reli-gioso (nella sua impossibilità, nell’impossibilità cioè di arrivare a Dio con le armi del pensiero) anche il pensiero laico incontra, per Boine, un ostacolo insormontabile:
Nel pensiero religioso […] il pensiero laico può per così dire vedere proiettata e messa rudemente a nudo, sebbene in-gigantita e quasi fatta mito, la sua più reale essenza: la non mai chiusa ferita che (sostituito all’Essere, fortezza di Dio, il Divenire) si manifesta ancora in questa necessaria instabilità di equilibrio in quest’ansia, in questa consape-volezza dell’incompiuto che ogni serio pensatore confessa.
Tale affermazione troverà manifestazione teorica nel saggio del 1911 intitolato L’esperien-za religiosa. Boine vi si ritroverà costretto a ope-
nola fa qui riferimento alla ritrattazione anti-modernista di Di cer-te pagine mistiche.
14 g. Boine, Prefazione al Monologio di S. Anselmo, in La fe-rita non chiusa, cit., p. 15.
15 Ivi, p. 19.
MiMMo Cangiano276
rare una distinzione fra sentimento religioso e esperienza religiosa16, provando a ricomporre in quest’ultima il proposito di una vita che non sia resa incondizionata ad un fluire che sta acqui-sendo tratti via via più demoniaci, cioè via via più divini:
Iddio non si dimostra con logica, lo si ha, lo si sente […]. Il centro vivo della religione, l’anima viva, essenziale, irri-ducibile della religione è l’esperienza che non si comunica.Ma un tempo per religione s’intendeva qualcosa di ben più complesso e compatto, qualcosa di decisamente extrain-dividuale: di obiettivo […]. La vita religiosa era la tradizio-ne […]. Vivere religiosamente voleva dire annientare la mia empirica individualità […] per ciò che è più reale di me, più sicuramente, più provatamente reale di me17
Il senso di un legame che coinvolga Logica, Tradizione e Religione si infrange nel momento in cui la Religione passa sotto il dominio dell’E-sperienza. Il frantumarsi di una kultur condivi-sa fa irrompere una distinzione all’interno del-lo stesso orizzonte religioso. L’empiria scava un fossato fra gli uomini religiosi, coloro per i quali «credere in Dio è necessario e naturale […] for-tunati uomini per cui questo garbuglio dell’es-
16 Cfr. Giovanni Boine a Giovanni Amendola, 12 Novembre 1911, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici della «Voce» – Vari, vol. IV, cit., p. 274: «Le religioni positive non sono religio-ne: sono tradizione, sono quasi compiutamente storia. Ed d’ora innanzi per intenderci io chiamerò “religioso” tutto ciò che è fuori dall’ordine, non nella disgregazione dopo l’ordine, ma nell’anar-chia avanti l’ordine. Anarchia pericolosa e necessaria. Un uomo che volesse restare in essa sarebbe un mostro; io ho paura di lui, perché ho una terribile paura del mio stesso sentimento religio-so. Cercare attraverso il sentimento religioso, cercare in Dio un ordine nuovo, è mostruoso, è assurdo. L’ordine, è questo che gli uomini han creato: l’unico ordine possibile, l’unico ordine che poteva, che può uscire dall’abisso di Dio, è questo che andiamo creando».
17 g. Boine, L’esperienza religiosa (1911), in L’esperienza re-ligiosa e altri scritti di filosofia e di letteratura, a cura di G. Benve-nuti e F. Curi, Bologna, Pendragon 1997, p. 101.
La tentazione dell’impressione 277
sere e della vita è spontaneamente senza fa-tiche ed angosce ordinato in sistema»18, colo-ro che non hanno bisogno di una Legge ester-na per imbrigliare le cose perché le cose sono «immediatamente a se medesime legge»19, e co-loro per cui dentro risorge l’angoscia, per cui, usiamo parole boiniane, il mondo si sfa, ritor-na ombra e apparenza, e per cui «l’immediatez-za dell’esperienza religiosa che par così piena e compiuta è povera e vuota»20. Per costoro la fi-losofia (Boine fa riferimento alla filosofia hege-liana) non può bastare, perché se pure essa è in grado di ri-contenere nel concetto l’indistinto amorfo dell’esistenza, ad esso quel concetto do-vrà nuovamente tornare ad arrendersi, perché in esso la vita riproduce la sua infinità: «Il con-cetto è l’affermazione della razionalità, la razio-nalità è l’essere; ma la concretezza dell’essere è la vita, la inesauribilità della vita»21. In ciò la fi-losofia laica si presenta come specchio del sen-timento religioso, nella dolorosa accettazione di questo sentimento dell’inesauribile, nel quid oscuro che non permette, sono ancora parole di Boine, di uccidere ed esaurire il mondo. Un quid che
È sgomento, è spavento, è sbigottimento per questo pro-digioso senza posa fluttuare di vita (da dove?) dal nulla, come nella cava immensità di un mare notturno.22
Con ogni mio sforzo io vorrei definire e vorrei sistemare perché il sistematico, per il definito (la santità di ciò che gli uomini hanno fatto) hanno per me, infinito più pregio di tutto il torbido oceano delle cose non fatte, sentite.23
18 Ivi, pp. 109-110.19 Ivi, p. 118.20 Ivi, p. 120.21 Ivi, p. 127.22 Ivi, p. 130.23 Ivi, p. 131.
MiMMo Cangiano278
Il proposito risulta insomma ambivalente, il regno del fare24 dell’esperienza religiosa (quello stesso regno che di qui a breve si concretizzerà nella “religione della terra” di La crisi degli oli-vi in Liguria) mantiene una certa fascinazione, proprio nel suo valore costruttivo a cui si oppo-ne l’abisso incerto della Verità:
Non mi posso, non mi debbo adagiare nella sentimenta-le esperienza come questi illusi uomini religiosi dicon di fare (non cederò all’ondata, non mi farò del gregge vago dei sentimentali) […]. E se essere religiosi volesse davvero dire perdersi, inabissarsi nello sgomento del sentimento (come chi è incantato, attratto, inghiottito da un’abissale voragi-ne) vivere d’esperienza; essere compiutamente uomini vor-rà dire aver piena coscienza della certa realtà di questo umano fare25.
Certo, nel finale del saggio l’immagine di Dio viene a contrapporsi alla religione positiva del fare: «E l’imagine del dimonio – più quella del dio tutelatore – potrebbe io dico con vigore rappre-sentare il fondo vero della religiosità»26. La «tor-renzialità anarchica» va ad identificarsi con il fondo della religione: l’eresia, l’«antitradizionale violenza»27, si identifica con la mistica in un’idea di ribellione saldamente legata ad un visione di inesauribilità28. Alla spalle della regolata esperien-za dell’Ordine si situa l’atroce visione del Divino:
24 Cfr. Giovanni Boine a Tommaso Gallarati Scotti, settem-bre-ottobre 1909, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnovamento», vol. III, tomo I, cit., p. 288: «Anche il mio ide-ale di perfezione s’è, ora, qualche poco mutato: io penso che gli uomini tanto più diventan puri e veri quanto più agiscono. In cer-to modo io proietto fuori di me ciò che una volta quasi esclusiva-mente contemplavo in me stesso: io sono per me ciò che faccio».
25 g. Boine, L’esperienza religiosa, cit., p. 132.26 Ivi, p. 133.27 Ivi, p. 134.28 Cfr. e. gioanoLa, Il mistico senza estasi, cit., p. 132: «Il
Dio che muore è quello del contesto socio-culturale, che fa da ga-ranzia suprema all’ordine raggiunto: è il Dio-perfezione custode dell’ordine perfetto, è il Dio-ragione custode dell’inesorabile logi-
La tentazione dell’impressione 279
Ma, fuori d’Iddio, ma, per contro a Dio la legge dell’ordi-ne, la logica dello spirito è una sola, tende ad essere una sola, (la tradizione tende verso la storia) e dell’umana at-tività, dello spirituale procedere Iddio, se mai, è fonte, è come polla di fiume, sta lontano alle spalle, sta nemica-mente dietro […] noi, innanzi a Dio, fuggiamo e Dio pauro-samente c’insegue29
La costruzione storica si origina su un nul-la che la incalza da presso, un nulla alle cui al-tezze non è concesso vivere30. Tale concezione gnostica della Trascendenza31 giocherà un ruo-
ca, è il Dio-giusto custode della legge, è il Dio-bene custode del-la moralità».
29 g. Boine, L’esperienza religiosa, cit., p. 137.30 Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 24 ottobre
1911, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnova-mento», vol. III, tomo II, cit., p. 643: «Perché, tu che mi hai dato il gusto delle cose quadre dove il sentimento non entra, il gusto del sistema e della compostezza, non m’hai tolto di dentro del tutto, questo spavento, questo senso del sacro, questo sbigottimento del nuovo ch’io voglio nascondere e che mi angoscia? […] Gli uomi-ni che hanno ordinato il loro mondo io li venero: anche se del loro mondo vedo le crepe, io li venero. […] Io sono ora pieno di rispet-to per chi ha osato pensare, chiudere il suo pensiero: non si può gettarsi, scagliarsi contro il pensiero di un uomo così come contro un fantoccio. Anche il più fiacco pensiero, se è conchiuso, è sacro. Ci vuol del coraggio a conchiudere».
31 Legame diretto con questa questione avrà anche la po-lemica che Boine muoverà all’idealismo di Prezzolini nel 1913. Nell’impossibilità del passaggio diretto dalla speculazione filoso-fica alla storia, sarà infatti ancora possibile riconoscere il lavorìo della Trascendenza (e non a caso una prospettiva che si dà come antitetica a quella di Soffici). Cfr. g. Boine, Parole d’un uomo mo-derno (1913), in Carteggio, Giovanni Boine – Giuseppe Prezzolini, vol. I, pp. 89-90: «L’irreligiosità tua è sì piena. (E tu anche l’abbelli con codesta eroica faccenda della disperazione moderna e col ba-ratro buio del “nulla” che sa di Soffici, che potrà tentare i poeti…). Ma se tu badi, è piena appunto perché non è più irreligiosità nega-tiva. È piena del filosofare tuo […] una echeggiante misteriosità di trascendenza permane, entra ad inquinare la purità dell’atto me-desimo». E si guardi anche allo scritto Congedo del 1914 leggibile nel medesimo volume. Qui il fare viene ormai messo in diretta cor-relazione con la tematica del peccato elaborata l’anno precedente: «Che quando, dopo aver pensato, agisco, a me pare di dirompere il mondo, non di incarnarvi il giudizio che n’avevo fatto, ma come di scombuiarlo, di ridurlo, questo mio giudizio, e che solo per ap-
MiMMo Cangiano280
lo determinante in tutta la successiva produ-zione boiniana, nel suo essere abisso negativo dell’Essere finirà per gettare, sul faticoso tenta-tivo di ricostruzione, l’ombra infinita dell’inau-tentico32. Tale inautenticità, come detto all’ini-zio di questo saggio, finirà sempre per contrap-porsi all’arcadia del nulla veicolata da Soffici, abitabile, quella, perché fondata positivamente, vale a dire fondata su un principio di passivi-tà che si accontenta di esaltare come assoluto il valore della superfice.
III. Che fare?
Il proposito di fedeltà al fare giocherà un ruolo determinante a partire dal 1910, svilup-pandosi dapprima in un contesto ancora so-stanzialmente religioso e poi in un ambito più schiettamente civile. Sin da subito è il concetto di “tradizione” ad acquisire una valenza deter-minante, concretandosi prima nell’opera di por-tare alla luce il comune sfondo cattolico della ci-viltà italiana33, e poi in una prospettiva di lavoro che, per Boine, va a coincidere con l’attività di “organizzatore culturale” a Porto Maurizio:
prossimazioni, per apparenti analogie si possa dire esso avere una essenziale relazione con il mio agire […] E quasi mi è parso al con-trario del Blondel che tu citi, s’io vado scavando bene addentro, bene addentro, giù, come in una buia miniera, l’azione, non dio finalmente io vi trovi, ma sì un tenebroso dimonio che m’impau-ra» (p. 243).
32 Cfr. F. Curi, “Sul discrimine dei mondi”. Premessa a Boi-ne, in L’esperienza religiosa e altri scritti di filosofia e di letteratu-ra, cit., p. 13: «Boine non sceglie […] un’ermeneutica (o una semi-otica) della perplessità».
33 Cfr. g. Boine, Che fare? (1910), in Carteggio, Giovanni Boi-ne – Giuseppe Prezzolini, vol. I, cit., p. 33: «Non ha dunque sentito mai questa gente l’angoscia di chi, volendo italianamente opera-re, convinto che nessuno sforzo è durevole fuori di una tradizione, perché nessuna cosa dura se armonicamente non ci contempera con tutte le altre presenti e passate».
La tentazione dell’impressione 281
Maledetta superiorità! Io non son giunto con essa tant’al-to da vivere nella sicurezza dei Santi, nell’equilibrio perfet-to dei grandi ed ho perduto per essa l’umile, l’elementare equilibrio della naturale umanità. […] vorrei poter essere quidam e grege porcorum: guarirei.34
Sempre nel 1910, nelle lettere che Boine va scrivendo a Casati, sembra concretizzarsi quel-la prospettiva di attivismo, di ordine, che troverà poi una definizione compiuta nella parte finale di Di certe pagine mistiche: «operare duramente in silenzio; cocciutamente, zitti, senza frangie, senza dorature, operare senz’altro»35. Il definiti-vo tramonto dell’esperienza Modernista sembra guidare Boine nella rifondazione di un princi-pio di sicurezza lontano dai territori controversi della mistica36:
Ma qui ho buttato a mare tutto ciò che di metafisico e di mistico mi navigava nell’anima e mi son fatto homo prati-cus. […] Mi è crollato il castello dorato che credevo d’aver costrutto con voi e tento di ricostruirmi una piccola casa, umile e salda.37
34 Giovanni Boine a Alessandro Casati, 8 gennaio 1910, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnovamento», vol. III, tomo I, cit., pp. 325-326.
35 g. Boine, Di certe pagine mistiche, in La ferita non chiu-sa, cit., p. 51.
36 Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 13 ottobre 1910, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnova-mento», vol. III, tomo I, cit., p. 512: «Mi è affine il cattolicesimo che teologizza e dogmatizza obbligandoti a credere con l’intelligenza e non con slanci e sdilinquimenti: freddamente, definitamente. […] Mi è affine un giurista che stabilisce i rapporti gerarchici fra gli uomini ed ordina il mondo col compasso […]. C’è qualcosa in co-mune fra tutte queste cose: c’è la rigidità di un disegno imposto alle cose […]. È il definito, il chiaro, il distinto, che piglia la rivin-cita sul caotico sul fluttuante».
37 Giovanni Boine a Stefano Jacini, 7-11 febbraio 1910, ivi, pp. 354-355.
Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 25 gennaio 1910, ivi, p. 339: «Questa vita di provincia non è l’uniforme vita addor-mentata che ti fan credere i romanzi: io ci ho scoperte molte pic-cole polle d’intima vita diversamente gustose».
MiMMo Cangiano282
Tale intento andrà a trovare un sistema d’attuazione nell’articolo vociano intitolato La crisi degli olivi in Liguria. Il proposito ordinativo, continuamente modulato dalla sicurezza dell’«Io dico», ricostruisce qui la possibilità di un qua-dro armonico, di evidente ascendenza mistralia-na, giocato sulle tradizioni intrecciate di lingua, fede, razza, religione, terra:
Io dico che questa è, in cospetto della vita, la forza, io dico che è dentro, in questa ostinazione la forza, io dico che è questo cieco, ostinato, religioso attaccamento alla terra, la trave più salda, la base più salda della nostra nazione. Perché questa è, io dico, religione, perché questa è saldez-za, questa è immutabilità religiosa, il segno, nella torbida cecità ostinata, della saldezza, della sicurezza, della stabi-lità profonda dell’anima, di ogni anima religiosa che sen-te oltre la sventura d’oggi, oltre la mutevolezza dell’oggi, al di là dell’oggi mutevole e sventurato la realtà sicura del sempre.38
Il proposito di Conversione al codice trova così riscontro nel rifiuto dell’ambiguo che l’oggi prospetta, una conversione che Boine prova ad attuare su piani differenti, persino, nell’articolo dedicato al Purismo, nell’ambito del linguaggio:
Spirito integro e puro, (rivelazione), è come dire paro-la pura. E se tu intorbidi la tua parola avrai torbida an-che l’anima. Una parola infetta, corrotta, è una corruzio-ne dell’ordine delle idee; è un’eresia. […] è l’ingenuità della «fede di Cristo» che importa salvare, e come salvarla, senza salvare nel tempo stesso la lingua, che meglio l’ha espres-sa? […] La gente crede che si stia spulciando dei vecchi manoscritti per corregger la Crusca, in verità si sta compi-
Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 3 febbraio 1910, ivi, p. 344: «Ma io voglio buttarmi innanzi ingenuamente, e piglia-re con serietà la minuta pratica di questa piccola vita: voglio esse-re provinciale per davvero».
38 g. Boine, La crisi degli olivi in Liguria (1911), in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 407.
La tentazione dell’impressione 283
lando il codice pratico (si sta costruendo i confini murati) dell’anima nostra.39
Proprio in tale movimento di conversione appare, nella scrittura boiniana, un certo gu-sto bozzettistico a carattere idillico-impressioni-stico:
(oh i meriggi di quand’ero ragazzo e seccavano sul parapet-to al sole, i fichi neri, bianchi, carnosi, polposi, gravemente odoranti e goccianti di miele gommoso! Oh al sole le api a migliaia ronzanti ed io queto all’ombra, disteso, meriggian-te da solo in ascolto40
Il programma di “fedeltà alla terra”, e all’or-dine che questa prospetta, veicola un messag-gio di consonanza con le cose che si rinsalda nel tronco avito della tradizione. Ma se pure i risul-tati sono apparentabili a quelli della scrittura sofficiana, ben diverso è l’alveo dal quale scatu-riscono. Il soggettivismo, vale a dire, non ha qui valore in se stesso, ma trova il valore delle sue affermazioni nel legame solidissimo con il pas-sato. La significanza dell’oggi non si origina ir-relata nella funzione ambigua del transeunte; il bozzettistico si dà come possibile solo nell’origi-ne che lo sostiene.
Tale fondamentale differenza non esclude però un’inevitabile consonanza: l’allontanamen-to della componente che, per semplificare, defi-niamo ora angoscia. Se da un lato Soffici trova la possibilità di una simpatia con le cose nell’i-postatizzazione della temporalità, nel comune sfondo contingente che sottrae valore alla real-tà, Boine la ritrova nella costruzione di un uni-verso ordinato, salvaguardato, nel suo valore, dalla tradizione storica che lo rende possibile, tradizione che si sviluppa infatti (diversamen-
39 id., Purismo (1912), in ivi, pp. 462-463.40 id., La crisi degli olivi in Liguria, in ivi, p. 396.
MiMMo Cangiano284
te che in Soffici) nell’opposizione a una compo-nente di ambiguità (parola boiniana) identificata nella Città e nel regno del Denaro.
In Conversione al Codice tale parentesi del-la prospettiva del ligure troverà una perentoria stabilizzazione, proprio in opposizione a quel-la Trascendenza identificata l’anno precedente:
Darò al Signore padrone degli spiriti, le genuflessioni e la lunga recitazione dei salmi: – Non permetterò che mi turbi nell’intimo mio. Mi difenderò contro Iddio; difenderò la mia terrena individualità contro la strapotenza invadente d’Id-dio […] ed avendo con me il mio codice, la giustificazione di un codice ordinato e bollato, ecco io vivrò tranquillo.41
Ma tale componente acquisisce in Boine un chiaro risalto difensivo: la prospettiva indi-viduale trova riscontro nel codice solo al prez-zo di una differenziazione con un movimento del tutto opposto, assimilabile all’inautenticità, per usare i termini coevi di Michelstaedter, del-la componente rettorica del vivere, della falsifi-cazione dei rapporti nella prospettiva della tem-poralità.
Per di più già in Conversione al codice il mi-raggio della sicurezza viene allontanato nella narrazione in prima persona di un cinquanten-ne: più che una definita certezza, un porto si-curo, la prospettiva del saggio si dà come ironi-co auspicio per l’avvenire. Nel decadimento del sogno del fare42 e nel crollo del mito della pro-
41 id., Conversione al codice (1912), in ivi, pp. 486-487.42 Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 25 dicembre
1910, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinno-vamento», vol. III, tomo I, cit., p. 548: «Che cosa scialba e sporca il mondo! Io sono in questo caso, che sento il dovere di viverci, di mescolarmene, di fare, in conclusione, con gli altri; e tutte le volte che faccio, soffro. […] Ed allora ecco l’angoscia: – debbo violare la mia coscienza morale, debbo restringerla e fare? O debbo ritirar-mi nel mondo della purezza e non fare? […] Non Dio, ma il pecca-to circola in ogni cosa, e l’avviluppa e la penetra».
La tentazione dell’impressione 285
vincialità, infatti, la componente espressionisti-ca riacquisterà a breve un vantaggio decisivo. Ma ciò che per ora ci interessa è comprendere le ragioni per cui la stroncatura dell’operato di Soffici non sarà mai così netta, e tali ragioni vi-vono appunto nel continuo oscillare di Boine tra posizioni differenti, in una dicotomia che a livel-lo letterario si esprimerà nella contrapposizione fra il paesaggio mediterraneo e quello monta-gnoso della Svizzera, nella antitesi giorno/notte e in quella fra città e campagna.
Sempre nel ’12, nell’articolo Ragionamento al sole, Boine toccherà il punto massimo del suo sofficismo:
Basta sussulti, basta tensione, basta cose profonde, ba-sta dolore43 […] Basta libri, basta libri dico […]. (Di notte tuttociò lo bollo, con una parola, così: semplicismo. […] Di notte non faccio mai meco medesimo il paladin della vita44
Ma la “prospettiva della vita”, il soggettivi-smo estremo rinsaldato dall’unità garante della tradizione, viene ormai equiparato all’illusione del sogno45. Il passaggio ad una scrittura diret-
43 Evidente, in questo articolo, l’avvenuta lettura di Nietzsche. Un Nietzsche ancora attraversato, con la mediazione di Halévy, sul versante della “filosofia della vita”.
Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 1 aprile 1910, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnovamento», vol. III, tomo I, cit., p. 382: «Questo suo enorme sforzo per affer-mare, avendo tutto il cuore pervaso dalla negazione, questo ribel-larsi al dolore, cantando al di sopra di esso a squarciagola la gio-ia».
44 g. Boine, Ragionamento al sole (1912), in Il peccato, Plau-si e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 473.
45 Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 7 novembre 1912, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnova-mento», vol. III, tomo II, cit., p. 724: «Ma io volevo rappresentare non una conversione reale, ma il corruccio di uno che è acculé al codice la cui volgare grossolanità gli ripugna. Il mio uomo di cin-quantanni è un dibattuto ed il cuore lo ha tutto nel mare umano fuor del codice. La lode al codice è paradossale: la realtà qui è la
MiMMo Cangiano286
tamente narrativa segnerà un più deciso ingres-so nei territori dell’Espressionismo.
IV. Il polo negativo dell’impressione
Il malanno è che io non avrò tempo di equilibrarmi e ri-marranno di me solo gli oscillamenti.46
Non posso ottenere da me di essere un «sicuro»: uno che possegga chiaramente tutto se medesimo sempre. Sono, sarò sempre un «vergine», un «a scatti».47
Nella polemica con Croce che si sviluppa sulle pagine di «La Voce», Boine giunge al rifiuto del programma romanzesco inteso come strut-tura logica-idillica48 (secondo l’equiparazione di questi due termini fatta nel paragrafo preceden-te). Il proposito di cogliere la «contemporanei-tà multivaria» del reale si ricollega a quella Tra-scendenza anarchica evidenziata all’altezza di L’esperienza religiosa. Tale movenza va dunque a coinvolgere quella possibilità di una descri-zione serena prima messa in evidenza. La quie-tezza della piccola città provinciale (pur travata dal senso dell’ordine e della tradizione), la dol-cezza del paesaggio mediterraneo (il sole, il gior-
bontà anarchica, ma si fanno sforzi per uscirne: sforzi e strappi verso la legale quietudine».
46 Giovanni Boine a Alessandro Casati, 16 gennaio 1912, ivi, p. 669.
47 Giovanni Boine a Alessandro Casati, 3 novembre 1912, ivi, p. 723.
48 g. Boine, Un Ignoto (1912), in L’esperienza religiosa e altri scritti di filosofia e di letteratura, cit., p. 149: «Dico che ad esempio un romanzo è, gonfialo finché vuoi, un racconto, ed un racconto è un idillio; e dico che il romanzo ci costringe a rappresentare e a vedere il nostro mondo a idilli. È questo, appunto, che mi ripu-gna: il veder pezzo per pezzo, ad idilli il mondo, a quadratini, a di-segnetti ordinati […]. Il mondo non è una successione ordinata di cose, di pensieri di oggetti, di azioni con conclusioni finali […], più o meno scimmia della logica-vita».
La tentazione dell’impressione 287
no, ecc.), finiscono per diventare polo negativo di un dialogo a due voci giocato sull’opposizione fra Realtà e Apparenza. La travatura dell’Ordi-ne ricade fatalmente sotto questo secondo ter-mine; il Nulla, veicolato dal sintomo di una flu-idità del mondo49, rivela la mancanza dell’Esse-re. La stessa Storia, la stessa Tradizione, si sve-lano costruzione artefatte, trascinando con sé, questo ci interessa sottolineare, la quieta rap-presentazione paesaggistica.
Nella novella L’agonia tale passaggio si rive-la con evidenza: il senso d’angoscia provato din-nanzi al paesaggio svizzero (Boine soggiornava nel sanatorio di Davos) si contrappone inizial-mente al desiderio del mediterraneo, del «pae-sello». Nel paesaggio nordico il dramma gnostico della Trascendenza si ripercuote nel corpo ma-lato del protagonista:
E gli pareva d’esser sceso in sé come alle radici embriona-li, nell’incerto umidore di un plasma di carne e di spirito, d’esser sceso giù alla scaturiggine buia dell’essere suo, e d’avervi nel viscidume del male, di là dal male come sen-tito toccata l’eterogeneità dell’oggetto. Come se il male, la originaria inimicizia del male fosse il palpabile segno, il vi-sibile indice di un sostanziale mondo di là dal nostro, non nostro.50
L’esperienza demonica della sorgente dell’Essere non permetterà più la quiete artefat-ta di una vita fasulla. Nel ritorno in Liguria, le immagini religiose non saranno più in grado di produrre l’inganno:
49 Cfr. id., La città (1912), in Il peccato, Plausi e botte, Fran-tumi, Altri scritti, cit., p. 429: «Fu, dentro a sé, fu, intorno a sé, la disgregazione, l’irrazionale caotica, il male e il bene insieme con-fusi, il giusto e l’ingiusto, il vero e il non vero. Il mondo fluiva come la bufera […]. Non v’era più legge, non v’era più ordine, non v’era più razionale perché».
50 id., L’agonia (1913), ivi, p. 498.
MiMMo Cangiano288
Primavera! Maggio, maggio! Quasi gli pareva d’esser lui stesso il maggio […], questo giovane gioco di vita. […] Gio-ia indifferente e curiosa […]. Ma gli si era come sfasciata allentata la coscienza; non c’era più fisso pensiero a occu-parlo, né sforzo ordinato verso alcunché come prima. Pul-lulare germinare infinito d’infiniti atomi […]. era come se tutto si fosse innanzi a lui disgregato, sminuzzato, precipi-tato a titillarlo in tepida pioggia51.
La tecnica impressionista viene sì utilizza-ta, ma caricata di un significato esistenziale che la destina ad essere immediatamente travolta, perché ormai inevitabilmente inquadrata nei termini di un nichilismo passivo:
E questo era il mondo veduto dal lato del nulla: percezion delle cose […] come non fatte ancora, non manipolate an-cora di pensiero e di spirito. S’era come affondato a dove non era ancora il costrurre e lo sforzo; giù dove non era né il bene né il male, né il no, né il sì, né il falso, né il vero, nella vagabondante non legge. Indifferenza gioiosa.
L’esperienza dell’irrimediabilmente Altro ha venato di non-senso il faticoso ordinare de-gli uomini, il soggettivismo, pur rinsaldato nel-la Tradizione, non può che svelare un’abissale lontananza dall’essenza delle cose52 (che infatti, termini di Boine, si fanno opache):
51 Ivi, p. 503.52 Anche il romanzo Il peccato vive di un procedimento si-
milare, si noti ciò Boine scrive a proposito della musica, quella musiche che dà inizio all’avventura amorosa e, di conseguenza, all’ingresso del protagonista nel consorzio umano. Cfr. g. Boine, Il peccato (1913-1914), Bologna, Millennium 2003, p. 18: «La musi-ca a lungo, se non t’arrobustisci di più quadro, di più sostanzio-so pensiero, ti sfiacca e t’effemina […], e dentro ti muta ogni legge e il volere. Perché muta i geometrici rapporti delle cose, le sfalda nell’impalpabile ritmo (le scioglie); perché sostituisce alla precisio-ne del netto concetto, l’ondeggiamento della mobile intuizione per-ché t’affonda di là dal mondo delle rigide forme e della tradizione consueta nell’umido fumigante mistero del Caos. Dico che il mon-do della musica non è (non è!) quest’altro delle restanti arti e del consueto pensiero».
La tentazione dell’impressione 289
Ed infatti ogni cosa, sì (giunse a questo) moriva, ch’egli aveva un istante goduta. Brillava, moriva, s’accendeva mo-riva. […] Sentiva il nulla, era come nell’ansia del nulla […], era reale e irreale, era areato di nulla e di vita […]: il mon-do non era53.
Ma ancora non basta. L’Espressionismo54 di Boine non riesce mai a darsi compiutamen-te: il tentativo di deformazione della realtà me-diante l’introduzione dell’interiorità dell’artista in essa, la ricerca spasmodica dell’essenza del-le cose, lo sviluppo anti-simbolico degli oggetti, ecc., continuano a determinarsi come parti di un dialogo irrisolto, come parti di un’opposizio-ne non-dialettica tesa a inquadrare l’uomo, in termini tragici, come essere paradossale.
Se, infatti, ancora nel ’13, Soffici è aspra-mente criticato nell’Epistola al tribunale:
resta appunto l’impressionismo collo svalutamento della grandezza (il cielo appassionato di un contadino toscano, grande quanto la maestà sicura del Cristo giudice nella cappella di Michelangelo) […]. Questo il Vangelo di Soffici; questa la rinnovazione del mondo secondo il pittore Soffi-ci. […] Filosofia che partirebbe da una terribile disperazio-ne metafisico-morale, dal nulla, dall’abisso del niente a cui irrimediabilmente arrivi dopo aver a fondo lottato con tutti i sistemi, e ci consiglia d’aggrapparci come vien viene, qui, alla vita, di viverla, di cantarla; di farla col canto reale55
si registra anche un paradossale elogio di Pa-pini nel suo capaneismo56 distruttore di filoso-
53 Ivi, pp. 505-506.54 Per ciò che concerne l’espressionismo linguistico di Boi-
ne non possiamo che rimandare al saggio di g. Contini, Espressio-nismo letterario, in Ultimi esercizi ed elzeviri (1968-1987), Torino, Einaudi 1989.
55 g. Boine, Epistola al tribunale (1913), in Il peccato e le al-tre opere, Parma, Guanda 1971, pp. 364-365.
56 Cfr. Giovanni Boine a Emilio Cecchi, 12 maggio 1913, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Emilio Cecchi (1911-1917), vol. II, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 1983, p. 30: «Io dico che c’è intanto quasi dappertutto nel libro di Papini una sobrie-
MiMMo Cangiano290
fici assoluti, mentre nell’epistolario, di contro, si insiste sull’importanza della chiarezza e della compostezza della speculazione crociana.
V. L’ultimo Boine
Ancora nel ’14 il proposito di ordine si di-mostra tutt’altro che sopito (si guardi ovviamen-te ai Discorsi militari57). Eppure una nuova con-cezione della storia, veicolata in particolar modo dalla lettura delle Inattuali di Nietzsche58 (Boi-ne iniziò a tradurre la II), sta venendo avan-ti59. Essa avrebbe probabilmente dovuto trova-
tà magra di stile che è onestà […] capaneismo doloroso. […] per mio conto ora che tutti fan gli inchini alla filosofia del tutto e del-la Universale Ragione, mi viene voglio di ripigliar Max Stirner e Nietzsche». Elementi in questa direzione si riscontrano anche nell’articolo Il vero Montaigne (1913), in g. Boine, Il peccato e le altre opere, cit., pp. 377-386. Cfr. anche Giovanni Boine a Emi-lio Cecchi, 30 settembre 1913, g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Emilio Cecchi (1911-1917), vol. II cit., p. 46: «Debbo confessarti che il Papini dell’epistola io l’ho coscientemente mitizzato. Vorrei ci fosse in Italia quel che dicevo e non c’è».
57 È sempre necessario riproporre all’attenzione del letto-re alcune lettere di Boine, immediatamente successive allo scrit-to, che ridimensionano significativamente ciò che lo stesso scritto dovrebbe rappresentare per il suo autore. Ne proponiamo qui al-cune. Cfr. Giovanni Boine a Emilio Cecchi, 15 ottobre 1914, ivi, p. 137: «Non credere troppo al mio militarismo. Scrissi il libro que-sta primavera. Ed il libro ha una prefazione». Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 20 aprile 1914, in g. Boine, Carteggio, Gio-vanni Boine – Amici del «Rinnovamento», vol. III, tomo II, cit., p. 834: «Considero questo lavoro come quel tanto di tassa che è giu-sto pagare alla nazione che ci ha fatti». Cfr. Giovanni Boine a Ste-fano Jacini, 12 aprile 1915, ivi, p. 891: «Quanto ai Discorsi è roba trapassata. Specie di servizio militare che fatto che sia nessuno si sogna più di rifare».
58 Giovanni Boine a Alessandro Casati, 9 gennaio 1915, ivi, p. 876: «Ma son cose che ha dette definitivamente quarantanni fa Nietzsche su quelle considerazioni inattuali che sono il processo e la condanna addirittura di tutta la nostra falsa civiltà».
59 Cfr. Giovanni Boine a Emilio Cecchi, 4 luglio 1915, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Emilio Cecchi (1911-1917), vol. II, cit., p. 159: «Il primo risultato ideale di questa guerra è una in-
La tentazione dell’impressione 291
re sistemazione in quei Dialoghi de tempore bel-li60 che il ligure progettava di scrivere. L’indiffe-renza, allegorizzata nell’immagine mobile delle nuvole61, si porrà d’ora in avanti come uno dei vettori principali della scrittura boiniana. L’im-peto guerriero (Boine progetta ripetutamente di andare al fronte62) lascia ben presto il posto ad una concezione fatalmente nichilista i cui im-mediati bersaglio sono le stesse idee di progres-so e valore:
Però la vita non è tutta nella guerra: de tempore belli uno come me costretto a meditare invece che come te a caval-care, tanto più se n’accorge. E quanto alla tristezza chi non ha gioia, dominiddio gli ha dato diritto alla tristezza. Che potrebb’essere l’eredità di tutti domani, quando dopo tanto sbracciarci ci raccoglieremo. O tu credi viceversa che saremo tutti felici?63
feci la trottola per gli ospedali e mi occupai toto corpo-re di beneficienza. Le cose che vidi sono di un tale violen-to strazio che la bestia pietosa uscì dalle stalle dell’anima
sopportabile miseria […]. Il secondo sarà che per ventanni la pa-tria empirà di sé tutte le rettoriche. Sono i soliti trabocchetti del-la storia e della società. Quando si comincia a intendere e si vede lucido, un giro di manovella ed il sipario cala, coi soliti cartelloni suoi […] La Storia, caro Cecchi, è un barile di merda che il diavo-lo rotola per la china della morte: sotto sopra, su giù la merda è sempre quella».
60 Cfr. Giovanni Boine a Emilio Cecchi, 9 settembre 1915, ivi, p. 167: «Sto componendo certi dialoghi de tempore belli un po’ diabolici. Insomma ho sui panni quella pillacchera patriottica dei “discorsi militari” bisogna pure che mi redima innanzi ai posteri».
61 Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 13 giugno 1915, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnovamento», vol. III, tomo II, cit., p. 899: «Le nuvole seguitano ad andare secon-do dei venti e tutto è paurosamente sereno».
62 Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 22 maggio 1915, ivi, p. 895: «Mi basta poter arrivare dove si battono».
Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 26 maggio 1915, ivi, p. 896: «Ma insomma, ci ho una certa smania, in fondo allegra e primitiva: picchiare».
63 Giovanni Boine a Stefano Jacini, 25 settembre 1915, ivi, p. 909.
MiMMo Cangiano292
dove l’avevo legata e mi fu padrona. […] La gente non muta nemmeno se scroscia il cannone; c’è canaglia che pensa alla carriera in mezzo ai maribondi, vanitosi che si stan preparando il posto ai futuri congressi, mediocri che son mediocri e fan mediocre e grigio tutto quanto […]: se vuoi sapere se i soldati si battono hai venti riposte differenti, venti impressioni e trecento fatti contraddittori. Si battono si fanno scannare qui, più giù fuggono: lo stesso che oggi gli dan la medaglia, domani è un vigliacco […] la conclu-sione è che non c’è nessuna conclusione che manca una coscienza unica, perché dove non è, nemmeno la guerra la mette, e che dopo sarà come prima.64
Il ritiro a Porto Maurizio acquista così valo-re ben diverso da quello avuto nel 1910. Il leo-pardismo feroce di un testo come Varsavia equi-para il lavorío degli uomini a quello delle for-miche. La caduta dell’illusione antropocentrica trascina con sé, nella nietzschiana problematiz-zazione storica, anche l’antico mito agonistico della moralità: «– Vedi che scempio! Pare il cam-po della Marna, mesi sono. Ma eccoti la Storia… Guarda guarda come agitan le zampe quelle di-sgraziate là!»65.
Ma ciò che qui ci interessa notare è che tale movimento schiude l’uscio ad un paradossale elogio dell’apparenza che, modulato sulla con-sueta dolcezza del paesaggio ligure, ci ricondu-ce nuovamente in territori non distanti dalla po-etica sofficiana:
Per esempio a quelle nuvole laggiù in processione. Così alte, vedi, così impettite e lente sul mare lustro dell’oriz-zonte! Tutte le sere passano, di questa stagione. Dal levan-te al ponente, lentissime zitte, vanno che paiono vere. […] Domani il sole si leverà lo stesso di laggiù anche se così, oggi, il dolore lo sbigottimento ci ottenebrassero che tutto paresse finito. […] Tutto il mondo pare d’echi lontanissimi:
64 Giovanni Boine a Emilio Cecchi, 30 novembre 1915, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Emilio Cecchi (1911-1917), vol. II, cit., pp. 183-185.
65 g. Boine, Varsavia, in Scritti inediti, cit., p. 223.
La tentazione dell’impressione 293
la bellezza d’ogni cosa è un vago soffio: così di lieve spettro ch’io respiro appena e non son più.66
L’attitudine ricettivo-passiva nei confronti dell’altro che il paesaggio offre viene ripetuta-mente a sottolineare l’impossibilità dell’approdo all’autenticità del significato.
Ma è ancora necessario sottolineare due cose: la prima è che in Boine risulta sempre im-possibile parlare di un punto di vista totaliz-zante: l’attitudine agonico-morale, infatti, per quanto indebolita, continua a giocare un ruolo determinante. La seconda è che l’elogio dell’ap-parenza preserva il suo retroterra angoscioso; l’accettazione, nel giudizio sul reale, della sua amorfica indeterminatezza, è ben lungi dal pre-sentarsi scevra di un doloroso sottotesto:
La nostra leva, la nostra torbida generazione è giudica-ta e maledetta col giudizio di Nietzsche (nelle Unzeitgema-esse Betrachtungen) sullo storicismo amorfo della cultura contemporanea […]. Però Nietzsche lo diceva con passione, non con cruccio ed ironia. Perché Nietzsche era un grande ed è la grandezza, la pienezza dolorosa del sentimento che invece manca a questo svelto giudice, al Serra.67
Il giudizio sul lavoro di Serra rivela in con-troluce ancora il nome di Soffici: l’assenza di «grandezza» (si ricordi la necessità della grandez-za teorizzata nella polemica con Croce) aveva già fatto capolino nel giudizio sul Lemmonio Boreo, ed era riapparsa, ancora in relazione a Croce, in una lettera a Casati nella primavera del ’13:
E Soffici che svaluta la grandezza non s’accorge nella sua concettuale vuotaggine che fa, come ha sempre fatto del crocismo schietto ed al più buon mercato. Il crocismo è inerente all’impressionismo.68
66 Ivi, p. 225.67 g. Boine, Plausi e botte, Firenze, Vallecchi 1978, p. 109.68 Giovanni Boine a Alessandro Casati, 25 maggio 1913, in
g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnovamento», vol. III, tomo II, cit., p. 778.
MiMMo Cangiano294
In Plausi e botte, un lavoro che impegna Boine per circa due anni e permette dunque di rilevare il continuo oscillare della sua posizio-ne, i due atteggiamenti risulteranno finalmen-te intrecciati.
La critica si è finora concentrata nel met-tere a fuoco i motivi della riflessione critica boi-niana e nell’analizzare le recensioni che più fa-cilmente aiutano a collocare l’autore sotto l’eti-chetta di Espressionismo (Rebora69, Sbarbaro70, ecc.) o comunque di anti-Impressionismo (Basi-le71). Eppure Plausi e botte aiuta non solo a de-terminare come la scelta per una letteratura a valenza anti-musicale fosse per Boine una scel-ta necessaria, ma dolorosa, ma anche a rilevare come la tentazione del versante opposto sia sta-ta sempre presente. Si guardi ad esempio la re-censione alle Liriche di Onofri:
non so, sento della simpatia per essa, e mi par nel contem-po ci sia dentro una fiacchezza senza speranza, quasi il se-rale dormiveglia, il letargo, fossero cronici.72
Oppure si vedano le pagine, dedicate alle nuvole, sopra L’altipiano di Savarese:
69 Cfr. g. Boine, Plausi e botte, cit., p. 47: «E la tragedia vera ecco qui da che cosa è data: non dall’ansia per sé stessa, non dallo sfarsi del travaglio […] ma da ciò che questo bruto travaglio ucci-de, sacrifica; […] ma da ciò che questo bruto travaglio uccide, sa-crifica; senti continuamente nello sforzo morale di questa poesia il lamento di una intimità musicale che l’esteriorità rumorosa, quasi il moto, dell’atto, soffoca ed ogni momento nega».
70 Cfr. ivi, p. 65: «Ora ecco qui una poesia, questa dello Sbarbaro, la quale ci appare il meno possibile canto di gioia e di vita […] Poesia della plumbea disperazione».
71 Cfr. ivi, p. 81: «l’anime qui non s’urtano, non si feriscono, e non soffrono; non si dibattono nella terribilità del buio come de-vono, come in fondo è SEMPRE per chi si sprofondi un tratto oltre la stessa loro coscienza breve […] senza colorare di sé, modellare violenta a sé l’amorfo del mondo».
72 Ivi, p. 44.
La tentazione dell’impressione 295
mutano sempre, precise confuse, continue e improvvise come il pensiero che ho dentro, come l’ansimo vagulo della mia stessa anima, quasi vivo discorso del colorato infinito che l’occhio mi abbraccia.73
O quelle dedicate a L’inaugurazione della primavera di Govoni:
Son tutti nonnulla; le gioie son blande come giornate di va-canza, i dolori come i sogni dell’adolescenza, vaghi e incon-sistenti. […] sono proprio nonnulla e li diran superati. Ma a me la primavera che torna ogni anno mi piace sempre, l’a-prile mi fa sciamare per i campi e mi mette in subbuglio.74
Ma è ovviamente riguardo Soffici che il di-scorso si sviluppa in tutta la sua complessità. Già la critica all’Arlecchino, che pur nel fina-le presenta un perentorio rifiuto dell’arte a va-lenza impressionistica75, aveva concesso un’evi-dente apertura alle ragioni dell’amico, una con-cezione modulata appunto su quella dissillu-sione storica di cui abbiamo parlato all’inizio di questo paragrafo:
Ma questa primavera-prefazione, dice più umanamente ed in persona prima: – signori, io, uomo che ho vissuto e sofferto, uomo disilluso, mi sono arrovellato il cervello sul rompicapo della filosofia, per intendere il mondo, e ci ho capito proprio poco. Il mondo in questi contraddittori ar-zigogoli sissignori lo si perde: non c’è più. Ti si scava sot-to, una voragine fredda, ed i sistemi vi stan su inutilmen-te penduli come tele di ragno a tapparla. Ora vedete qui; ci
73 Ivi, p. 117.74 Ivi, p. 149.75 Cfr. ivi, p. 75: «Si direbbe che la vita gli giunga dal di fuo-
ri e viaggiandogli in ordine sparso verso la centrale caldaia dell’a-nima, gli si impelaghi per gli idillici rivi dei sensi e trovandocisi bene, lì, si fermi. Tutta questa minuteria d’imagini come vengo-no, quasi la bellezza fosse di cose belle, da chiapparsi colla ragna come gli uccelli a spasso, ti stanca e ti sperde. Ma la bellezza no, non l’acchiappi colle ragne dei sensi così come viene; la ti bale-na dentro e la rifletti tu nelle cose per improvvise dilacerazioni. La bellezza non ti sperde: ti fa, ti rinsalda».
MiMMo Cangiano296
son delle cose semplicissime intorno che mi commuovono e sento belle. Io me ne voglio accontentare. Non so com’è, ma s’io scordo la voragine, la vita fermenta in me come il mosto in un tino; mi faccio tutto musica e colore. […] Re-sta convenuto senza più dirlo che la voragine c’è, ma che non c’è rimedio e nessuno la colma. E sì, questo è un di-scorso che mi piace! Sarà forse che di giovane mi son fat-to vecchio, che l’ardore è tutto caduto, e le meditazioni, da parecchio fattesi molte ed angosciose. Comunque, sì, a questo ci sto; a questo vivere e dipingere immediatamente senza impalcature senza pregiudizi, senza sistemi. […] un generale senso di amarezza ironica e spregiudicata, di gra-zia disillusa, di non so che disperazione sorridente […] ed è ormai troppo mia perché io non l’ami.76
È nello svelamento del background doloroso connesso, nella paralisi storica, all’affermatività sofficiana, che si delinea ora una possibile con-vergenza. Questa verrà infatti a rimarcarsi nella lettura del Giornale di bordo.
In un primo momento, in un rivelatorio pa-rallelo con Sterne (e sempre con lo sguardo ri-volto alla II Inattuale), Boine esclude categori-camente la valenza, positivamente fondata, del frammentismo impressionista:
quella libera sensibilità a cui niente fa velo né schemi né dogmi […] quella vagula leggere VERGINITÀ, quella deli-cata immediatezza, complicata nel raffinamento di secoli, nessuno l’ha più ora, son perdute per tutti. – Soffici non ci ha colpa se è Soffici solo. […] ma è codesto stesso scettici-smo settecentesco che è poi immediatezza spregiudicata, codesto epicureismo tra di Lucrezio e di Catullo, codesta spensierata frammentarietà, questo epifenomenismo medi-terraneo verso cui agognava il singhiozzante Nietzsche, che è difficile sia spontaneo ora, sia totale. C’è in tutti un gemi-to, c’è in tutti un grido a lacerare la gioia.77
Il Sì alla vita, alla transitorietà, risulta escluso per i moderni: «il suo epifenomenismo
76 Ivi, pp. 73-74.77 Ivi, pp. 123-124.
La tentazione dell’impressione 297
di colori e di vita è ancora troppo teoria, trop-po voluto, per imporsi con la immediatezza delle cose naturali e felici».78
Ma ecco il cambio, un cambio dettato pro-prio, ci sembra, da quell’epifenomenismo medi-terraneo:
- Ma questa roba io la volevo dire l’altro giorno quand’e-ro proprio di malumore. Stamattina sul Giornale di bordo che sfoglio ci batte un sole giovane che mi fascia d’ardente luce ogni cosa che leggo. Scorrono via le pagine e le imagi-ni, e son tutte belle. Sono così belle, così vagabonde, così schiette, così giorno per giorno, così come viene, così come capita; così gioiose di ciò che fugge, così melanconiche, di transitorietà, ch’io son tentato di dire all’autore: «e accet-tami dunque per buon amici, perché il tempo è passato, son passati i dolori e anche le gioie, è passato tutto o tan-te cose che mi parevano ferme per l’eternità, e con in meno un po’ di cinismo e purtroppo con tratto tratto un po’ più di improvvisa angoscia, ma proprio con elementare spon-taneità, è questa che tu descrivi la vita ch’io voglio vivere». (O quella che m’impedisce di vivere?)79
La chiusa dolorosa rivela ancora l’alterità del paesaggio, la consueta impossibilità affer-mativa (che in Boine è certo dominante), ma qui interessa mettere a fuoco la tentazione di una via diversa che pure è presente all’autore. Ciò verrà infatti definito con chiarezza nella recen-sione ai Poemi lirici di Bacchelli:
Io non ho il moralistico sprezzo di Bacchelli per il panico naturalismo. La fantasia, mi piglia improvvisa come una brezza di mare; mi rifà di nubi e di blù la felicità che ho perduta. Ho chissà come una inconfessabile tendenza a narcotizzarmi con oppï; la campagna, l’odore dell’aratura, l’esperienza di città, le donne, i visi, le passioni, le glorie mi paiono tutte cose arcibelle e sempre infine, da godersi. Dirò che mi ci riposo con ironia. Certo è ridicolo ad esse-
78 Ivi, p. 125.79 Ivi, pp. 125-126.
MiMMo Cangiano298
re vergine, ma quando la primavera viene è per me sempre «una delizia l’assillo di non riuscire ad esprimermi». Me ne sto le giornate intere sdraiato sul greto a guardare il fiu-me lentissimo. Ora mi son anche comprata una canna e da uno scoglio del molo, pesco smemorato del mondo, nel-la luminosità mattinale.80
La tentazione dell’impressione si rivela così resa e catastrofe storica, il momento dell’amor-fismo, strettamente correlato all’esperienza del-la guerra81, si traduce in orrore e dolcezza della capitolazione:
E ci è chi ci credeva nella nazione, compostamente; chi, poniamo, aveva scritti (con fede) dei «Discorsi militari» – Ma la guerra, il cataclisma, l’incertezza neutrale te l’han gettato in una paralisi di malinconia (come un mal cardia-co, un viscere ferito) né sa come possa guarirne.82
La tendenza agonico-morale mantiene certo una predominanza, ad essa si affianca però una malinconia83, anche essa di matrice esistenzia-lista, che esclude la significatività della meta. La tentazione dell’irresolutezza si esprime nell’eli-sione reciproca e continua di sentimenti con-trastanti:
la pace e la guerra son troppo grande fatica alla mia imbe-cillità. Vado per la campagna e par che la brezza mi porti. Non so niente, non so proprio niente. Quelle profondissime
80 Ivi, p. 133.81 Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 22 dicembre
1915, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnova-mento», vol. III, tomo II, cit., p. 927: «È un po’ una cosa sconcer-tante anzi da ultima disperante specie se chiedevi con la speranza di auscultare i segni di quella intima coscienza unica che questa cataclisma avrebbe dovuto darci».
82 g. Boine, Plausi e botte, cit., p. 87.83 Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 30 Gennaio
1915, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnova-mento», vol. III, tomo II, cit., p. 880: «una ambiguità morbosa tra l’ironia ed il disfacimento che, dentro, quando non scatto o m’in-fiammo, mi è abituale».
La tentazione dell’impressione 299
anime che fanno puah sul panismo, ovverossia naturali-smo! Dicono che è superato. Ma io aspetto ogni primavera per ridire con voluttà questa sempredette sciocchezze sulle nuvole sfatte e sui fiori fioriti. Ho la fortuna di ammalarmi tutti gli inverni e di guarire ogni primavera.84
VI. Chiudere in frammenti
Ad accontentarmi per es. di mettere giù impressioni uso Soffici il mio diario ne sarebbe pieno. Ci sono giorni che le cose mi piacciono tutte di per sé ad una ad una; la gente la leggo come i libri, discorro con i cani e le mucche che incon-tro: quanto agli alberi, prati, rocce e nubi è come ci si strin-gesse la mano. Mi mettessi anch’io a far l’impressionista su-bito mi farei una reputazione; ma appena rientro a casa o in me, appena rientro la sera, una sera che è in me sempre, subito gli episodi mi paiono futilità. Così questo godere del mondo via via, con occhio che accarezza qua, là, assaggia, lo scontento non lo appacia. […] Sul tardi il verde dell’erba si fa cupo da metter paura; è una valle zitta, liscia come un tappeto, tutta incavi di morbida insondabile ombra. Allora questi dorsi muti questo immoto silenzio, mi si contrappon-gono, mi fissano. Nella notte che viene siamo io e la Sfinge.85
La consueta ambivalenza giorno/notte ri-presenta l’abituale dilemma. L’Impressionismo, nella incancellabile «ferita non chiusa», deve darsi come polo negativo, illusione da respin-gere. I Frantumi, anch’essi dominati (nella con-sueta ambivalenza) dalla componente espres-sionistica, presentano per l’appunto lo sforzo di riattualizzare «la traccia dinamica dell’unità perduta»86. Il tentativo di superamento della re-altà fenomenica si spinge nella ricerca di una superiore dimensione delle cose, da qui il per-turbante della loro autonomia:
84 Giovanni Boine a Alessandro Casati, 14 marzo 1915, ivi, p. 885.
85 Giovanni Boine a Leopolda Casati, 30 settembre 1916, ivi, pp. 1066-1067.
86 n. Lorenzini, Il frammento infinito: percorsi letterari dall’e-stetismo al futurismo, Milano, Franco Angeli 1988.
MiMMo Cangiano300
Allora guatando il fisso lampione, ritto ed immoto, spento e di ferro, che par l’Assolutoe dice di no, ch’esso non rulla nel finimondo: sta lì come un Dio87
La poetica espressionista si esprime ora nella sua pienezza: deformazione insistita, dia-lettica di caos e geometria, critica del processo formativo, paradossali valori coloristici88, crollo del sistema comunicativo-referenziale nell’equi-parazione di questo alla ciarla89 kierkegaardia-na, percezione del nulla e così via.
Eppure anche qui l’ambiguo paradiso del non-essere gioca un ruolo tutt’altro che margi-nale90. Se da un lato si presenta come consueto polo negativo91, ad esempio nel frammento pro-grammaticamente intitolato Idillio:
Passeggiando talvolta con passi senz’eco per l’opacità del nulla, bimbo su rena, per ozio mi svago, a disegnarlo d’i-dillio.Mi faccio un sentiero di ciottoli su per un clivio, e in fretta, sopra e disotto, ci stendo a scalini le terrazze di olivi[…]
87 g. Boine, Delirii, in Frantumi, a cura di V. Pesce, Genova, San Marco dei Giustiniani 2007, p. 63.
88 Già presenti, del resto, nel romanzo Il peccato. In Boine il giallo è sempre connesso al polo negativo dell’ambiguità.
Cfr. g. Boine, Delirii, in Frantumi, cit., p. 66: «L’amico da lungi mi guata con ambiguo giallore».
89 Cfr. Giovanni Boine a Emilio Cecchi, 9 dicembre 1915, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Emilio Cecchi (1911-1917), vol. II, cit., p. 193: «Sono ridotto che quasi tutti i miei discorsi sono nella falsità: li faccio per star con gli altri, ma sempre sento chiaro: “Non serve a nulla”».
90 Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 23 gennaio 1917, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnova-mento», vol. III, tomo II, cit., p. 938: «La fantasia, le nubi, la musi-ca, il mito; qui è la vita. Ma mi è negata».
91 Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 12 settembre 1916, ivi, p. 933: «Mi piacerebbe non avere questa zavorra di lo-gicità che è ormai appena un rimprovero non più un atto: allora piangerei e riderei come capita e sarei sicuro che questo è il mon-do. Ma questa nube che si sfascia so che è l’inconsistenza».
La tentazione dell’impressione 301
Oh sì, oh sì questo è certo il mio idillio d’allora, ma bene si sente, ma chiaro si sente, ma troppo, troppo si sente agli orli dell’orizzonte la insondabile ansia del buio.Sebbene accada ch’io via non mi curi del disfatto mistero e mago ostinato, vi finga un noncalente reale.92
dall’altro lato resistono spazi di fuga, fuga de-cisamente connotata dal nuovo valore dell’«ir-realtà»:
Ora mareggia l’irrealtà, ora è slegata la schiavitù, non c’è più legge, non c’è mio padre non ci sei tu, ora è disciolta ogni pietà: – rompono febbri di terribilità ed è stravinta la realtà.93
***
Tutto il mondo è scamiciato, l’universo è liberato, ogni schiavo scatenato; il gabbiano grida ohé! La ciurma can-ta ohilà!
Allor giunge l’al di là, veggo rive con città, corre il mondo per di qua; vien la Spagna, vien l’Australia, passa l’India con il Gange, l’Imalaja veggo già (chi ci pensa a voi laggiù!) tutto selve tutto brezze, è il paese-libertà.94
Se il contesto continua a pendere verso il momento antagonistico proprio dell’Espressio-nismo, supportato da un impeto morale che non si stanca nel dichiarare la falsità del con-testo sociale, pure, ci sembra, l’elogio dell’appa-renza, configurandosi come luogo del riposo e della resa, mantiene uno spazio significativo95.
L’ambivalenza, pur pendendo decisamente dal lato dell’angoscia, resta aperta, costringe il
92 Ivi, pp. 69-70.93 g. Boine, Frantumi, in Frantumi, cit., p. 73.94 g. Boine, Fuga, ivi, cit., p.p. 82-83.95 Cfr. Giovanni Boine a Alessandro Casati, 23 gennaio
1917, in g. Boine, Carteggio, Giovanni Boine – Amici del «Rinnova-mento», vol. III, tomo II, cit., p. 938: «io per una buona metà di me sono un idillico».
MiMMo Cangiano302
lettore ad un choc ricettivo. Il significato arbi-trario che il frammento, proprio nel suo essere frammento, sostituisce ad una totalità perdu-ta, si fa, con Benjamin, costruzione melanconi-ca tesa alla critica di qualsiasi armonica riconci-liazione. Accanto a ciò, pur ironizzata e rifiuta-ta, l’irrazionale speranza della totalità inauten-tica si pone come oppiacea dolcezza, seducente proprio nel suo essere illusoria, proprio nel suo porsi, sottesa ad essa la crisi, come innocente.
La tentazione dell’impressione. Riguardo ai giudizi di Boine su Soffici - The lure of impression. Boine’s judgments about Soffici
Mimmo Cangiano
Analizzando diacronica-mente i giudizi che Gio-vanni Boine riserva, fra il 1909 e il 1915, al la-voro di Ardengo Soffi-ci, il saggio permette da un lato di rimarcare la classica distinzione fra Espressionismo ed Im-pressionismo e, dall’al-tro, di puntualizzare la particolare forma di Espressionismo perse-guita dallo scrittore di Porto Maurizio.Soffici rappresenta per Boine, almeno fino al 1911, una sorta di mo-dello antitetico di scrit-tore, placidamente inse-rito all’interno di un ni-chilismo arcadico e sem-pre proiettato a salva-guardare, in nome del-la temporalità e della contingenza, un’idea di vita (di placida simpa-tia per le “cose”) fonda-ta su un’assolutizzazio-ne del transeunte, sull’e-saltazione passiva della componente inautentica dell’esistenza.La strada intrapresa da Boine fu certo diversa, modulata, fin dalla gio-vanile “esperienza reli-
By diachronically ana-lyzing Giovanni Boine’s reading of Ardengo Sof-fici’s work, this pa-per examines the clas-sic distinction between Impressionism and Ex-pressionism, and stress-es the peculiar form of Expressionism that the writer of Porto Maurizio was pursuing.Soffici represents for Boine, at least un-til 1911, a kind of anti-thetic model of writer: a supporter of an Arcadi-an nihilism, concerned with preserving, in the name of temporality and contingency, an idea of life, of quiet sympathy for “things”, based on the absolutization of the transient, on the pas-sive exaltation of the in-authentic element of the existence.The path that Boine chooses is radically dif-ferent. Since his juve-nile “religious experienc-es”, he concentrates on a gnostic-existentialist drama, which intends to express the nonsense of reality, but also aims to
Riassunto - Abstact
giosa”, su un dramma di matrice gnostico-esi-stenzialista, proiettato da un lato ad esprime-re il non-senso da cui la realtà e abitata e, dall’al-tro, finalizzato alla ricer-ca ininterrotta di questo senso. Eppure più vol-te la tentazione di una resa all’impressione, alla credenza nello stato d’a-nimo come garante di certezza, compare nei suoi scritti, e in partico-lar modo in quelli aventi Soffici come argomento (è ad esempio il caso fa-moso dei due articoli de-dicati, in Plausi e botte, all’autore toscano).Certo in Boine la parte-cipazione dell’Io al movi-mento fluido di una vita al di là delle forme (per usare parole di Lukács) non si presenta mai pri-va di un doloroso sot-totesto: ciò che in Soffi-ci è pacifica esaltazione del non-senso del mon-do, in Boine si può dare solo (e solo a tratti) come resa, dopo dura lotta, al non-senso del mon-do, ma ciò che qui inte-ressa è far notare la pre-senza di questa tenta-zione in uno dei maggio-ri rappresentanti dell’E-spressionismo italiano.
the continuous research of this sense. Neverthe-less, the lure of impres-sion appears in Boine’s writings, and particular-ly in those of which Sof-fici is the topic, as is the case, for instance, of the two articles dedicated, in Plausi e botte, to the Tuscan writer.Naturally, in Boine the participation of the Self in the fluid movement of a life beyond the Forms (to use Lukács’ words) will never occur with-out a painful subtext: what in Soffici is peace-ful exaltation of the non-sense of the world, in Boine can appear only (and only sporadically) as a capitulation, after a hard struggle, to the nonsense of the world. Nonetheless, in my pa-per I am interested only in pointing out the pres-ence of this temptation in one of the most im-portant authors of Ital-ian Expressionism.
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 305-333
RobeRto Risso
«Povera mamma Agnese…»Il tema della maternità nella narrativaresistenziale di Renata Viganò.
In un passo del Taccuino di viaggio nell’Unio-ne Sovietica, precisamente all’inizio della set-tima parte intitolata Ballerine per televisione,
Italo Calvino, in visita presso una casa editrice per la gioventù sovietica, passa in rassegna una serie di riviste e di libri dedicati ai ragazzi. Per quanto riguarda le opere italiane in traduzione, il Calvino viaggiatore e osservatore non trascu-ra di annotare, dopo aver constatato il perdu-rare dell’amore dei sovietici per le commedie di Carlo Goldoni, che: «Il libro italiano più letto in Unione Sovietica è un romanzo dell’Ottocento: Spartaco di Raffaele Giovagnoli [!]; qui è un libro di gran letteratura popolare, tradotto in tutte le lingue»1. Non solo, a sorpresa, e precorrendo di molto la rivalutazione operata fra gli anni Set-tanta e Ottanta della Viganò da parte di scrittori come Sebastiano Vassalli e di studiosi come An-
1 I. Calvino, Taccuino di viaggio nell’Unione Sovietica, in Id., Saggi. 1945-1985, a cura di M. Barenghi, Milano, Mondado-ri 1995, t. II, pp. 2433-2434. Dello stesso Calvino si veda il saggio del 1949, anno in cui venne pubblicato il romanzo L’Agnese va a morire: La letteratura italiana della Resistenza, in cui l’autore, pur non citando la Viganò, offre spunti assai acuti su autori come Pa-vese, Del Boca e Vittorini, per finire con un auspicio di stringente attualità: «La letteratura della Resistenza non ha fine, come non deve aver fine lo spirito della Resistenza», id., Saggi. 1945-1985, cit., t. I, p. 1500. Ormai classico pur nel non esiguo numero di opere dedicate alla Resistenza e alla letteratura ad essa legata è la monografia di G. FalasChi, La resistenza armata nella narrativa italiana, Torino, Einaudi 1976 e soprattutto, in relazione alla pro-sa resistenziale della Viganò, il terzo capitolo: Il racconto (e il ro-manzo), pp. 54-80.
RobeRto Risso306
drea Battistini, Calvino nota che il romanzo di Renata Viganò L’Agnese va a morire, (al tempo del Taccuino [1952] pubblicato in Italia da soli tre anni) è fra i libri recenti il più amato e let-to dai Sovietici: «Tra i libri più recenti, L’Agnese va a morire, di Renata Viganò (intitolato Tovàric Agnese), è pubblicato da diverse case editrici e tradotto in diverse lingue»2.
Libro unanimemente apprezzato, vincito-re di prestigiosi premi, di cui il Viareggio nel-lo stesso anno della pubblicazione per Einaudi, L’Agnese va a morire e soprattutto le altre ope-re di narrativa e saggistica della Viganò hanno goduto – pur con importanti ma rare eccezioni – di scarsissimo interesse critico3 e, soprattutto i non molti racconti e il romanzo Una storia di ragazze, non hanno destato interesse negando all’autrice il ruolo che merita nell’ambito della narrativa novecentesca. Una narrativa di valore e sostanza, impegnata e profondamente realisti-ca che trova nella descrizione del quotidiano e delle persone umili e popolari la chiave di volta per inscenare i drammi della vita e della storia, e particolarmente la povertà e la guerra.
2 I. Calvino, Saggi. 1945-1985, cit., t. II, pp. 2433-2434.3 Sull’opera di Renata Viganò è fondamentale la breve mo-
nografia di a. battistini, Le parole in guerra. Lingua e ideologia dell’“Agnese va a morire”, Ferrara, Italo Bovolenta Editore 1982. Purtroppo dopo trenta anni dalla pubblicazione di quest’opera re-sta valida la constatazione di Battistini per cui: «A scorrere l’elen-co degli studi sull’opera di Renata Viganò, che peraltro nessuno si è curato di compilare nella sua interezza, si fa presto ad arriva-re alle fine» (ivi, p. 3). Asor Rosa si sofferma sull’Agnese va a mo-rire analizzando la funzione del popolo e particolarmente del con-tado nell’ambito della Resistenza, e definisce il romanzo in questi termini, forse un po’ riduttivi: «Un’onesta e in taluni punti intensa rievocazione della Resistenza emiliana». Cfr. A. asoR Rosa, Scritto-ri e popolo. Saggio sulla letteratura populista in Italia, Roma, Sa-monà e Savelli 1965, p. 247. Nella scarsità scoraggiante di contri-buti sull’opera di questa autrice rinvio a: C. daly, Dissimulation, female embodiment and the Nation: Renata Viganò’s L’Agnese va a morire, in «Carte italiane», I, 14, 1994, pp. 98-109.
Il tema della maternità nella narrativa resistenziale 307
Personaggio di straordinaria e ben dissimu-lata complessità, la protagonista eponima del romanzo L’Agnese va a morire (1949), imperso-na la parte piú vitale e inerme della popolazio-ne4 travolta dalla bufera della guerra mondiale e della guerra civile e allude al lento, inevitabile e necessario percorso verso la Resistenza e la Li-berazione: «Lavoro, paura, e morti»5. Percorso di evoluzione e impegno che la conduce alla consa-pevolezza e al sacrificio supremo. Massiccio ‘an-gelo del focolare’6, donna di campagna, lavanda-ia sposata ad un uomo mite e minato da un gra-ve male polmonare (con ogni probabilità la tu-bercolosi), Agnese è una lavoratrice semianalfa-beta, pratica, di un buon senso di campagna, e fin dalla prima pagina del romanzo si presenta come persona di azioni semplici, concrete, im-mutabili come l’ambiente cui appartiene:
Guardandolo, l’Agnese si sentì stanca […] Sorrise, un sor-riso rozzo e inatteso sulla sua faccia bruciata dall’aria […] Disse improvvisamente, con la rassegnata incredulità dei poveri […] L’Agnese piegò la sua schiena rigida e grassa, e riprese la carriola7.
4 «L’Agnese è la sintesi, la rappresentazione di tutte le don-ne che sono partite da una loro semplice chiusa vita di lavoro duro e di famiglia povera per aprirsi un varco dopo l’altro nel pen-siero ristretto a piccole cose, per trovarsi nella folla che ha costru-ito la strada della libertà», R. viganò, La mia guerra partigiana, in ead., Matrimonio in brigata, Milano, Vangelista 1976, p. 143.
5 R. viganò, L’Agnese va a morire, Torino, Einaudi 1949 e 1994, p. 123. Tutte le citazioni del romanzo saranno fatte, salvo diversa indicazione, da questa edizione.
6 Fra le molte opere dedicate all’argomento rinvio a: G. laz-zaRi, Le parole del fascismo, Roma, Argileto 1975 e soprattutto alle opere di V. de gRazia, How fascism ruled women, Berkeley-Los An-geles, University of California Press 1992 e della stessa autrice: The culture of consent, Cambridge-New York, Cambridge Universi-ty Press (1981), 2002.
7 R. viganò, L’Agnese va a morire cit., p. 11. Scrive g. Pulli-ni a proposito di questo personaggio: «La protagonista è una don-na rozza, ignorante, estranea a qualsiasi interesse politico, la ti-pica contadina settentrionale resistente alla fatica fisica, materna
RobeRto Risso308
Dall’incontro con il soldato sbandato dopo l’otto settembre – episodio marginale all’inter-no di quella «gigantesca operazione di salvatag-gio, forse la più grande della nostra storia»8 – dell’inizio del romanzo a tutte le conseguenze – deportazione e morte del marito per delazio-ne dei vicini di casa, collaborazione con i par-tigiani organizzati anche in pianura, uccisione di un tedesco e lotta armata nelle paludi – la trama dell’opera, lineare e piana come la quo-tidianità pur devastata dalla guerra e dalle sue infinite tribolazioni ed atrocità, segue l’inevita-bile percorso della donna dall’ignavia biologi-ca e astorica al sacrificio della propria vita in nome dell’ideale di libertà, indipendenza e giu-stizia del proprio popolo e della propria nazio-ne. Il complesso rapporto fra linearità e sim-bolismo della figura e della vicenda umana di Agnese, come di non pochi personaggi soprat-tutto femminili dei racconti9, risiede nell’appa-rente mancanza di evoluzione mentale, sociale e culturale della protagonista. Immobilità e im-permeabilità del tutto apparenti poiché lo svi-luppo dei personaggi della Viganò, il loro entra-
e virile nello stesso tempo», id., Il romanzo italiano del dopoguer-ra (1940-1960), Milano, Schwarts Editore 1961, p. 170. Notevole è inoltre l’analisi svolta da M. guglielMinetti nella monografia Dal-la parte dell’io. Modi e forme della scrittura autobiografica nel No-vecento, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 2002 in cui soprat-tutto il settimo capitolo è rilevante ai fini dell’argomento di queste pagine: La memorialistica della Resistenza, pp. 99-113.
8 Così Anna Bravo definisce la distribuzione di vestiti civili ai soldati sbandati dopo l’armistizio, e precisa: « [operazione] che viene condotta in assenza di direttive politiche e in gran parte per iniziativa delle donne cosiddette comuni», cfr. A. bRavo, Resisten-za civile, in Dizionario della Resistenza, a cura di E. Collotti, R. Sandri e F. Sessi, vol. I, Storia e geografia della Liberazione, Tori-no, Einaudi 2000, pp. 269.
9 Nella non vasta produzione narrativa dell’autrice sono due le raccolte di racconti cui farò riferimento in questo saggio: Arriva la cicogna, Roma, Edizioni di cultura sociale 1954 e il citato, po-stumo Matrimonio in brigata.
Il tema della maternità nella narrativa resistenziale 309
re nella vita e nella storia, viene rappresentato attraverso le azioni e le reazioni, non con la de-scrizione dei moti dell’animo, che pure non sono assenti. Il personaggio dell’Agnese appare molto semplice perché l’autrice la rappresenta nell’at-to della resistenza ‘fisica’ al male della guerra «col suo grosso corpo»10, con «la faccia dura e spaventata»11, vittima della duplice e insensa-ta brutalità nazi-fascista come dell’insidiosa e non meno pericolosa attività delle spie, dei de-latori, dei collaborazionisti. Questa realtà disu-manizza il personaggio: «Il mondo sembrava un altro, nuovo, estraneo, dove lei non avrebbe piú lavorato: le diventava inutile la sua vecchia for-za di contadina»12 e allo stesso tempo segna l’i-nizio di una lenta metamorfosi o meglio di un’e-voluzione13 che muove, non a caso, da un sen-so di accettazione e di stupore: «Allora le spie-garono che cosa avrebbe dovuto fare, e lei dice-va di sì, meravigliata che fossero cose tanto fa-cili. Si vedeva che era contenta, che prendeva coraggio»14.
Il rifiuto istintivo della prevaricazione e del-la violenza della sopraffazione, durante una fase cruciale della guerra civile in cui la brutalità e le violenze sono sistematiche e indiscriminate15,
10 R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., p. 14.11 Ivi, p. 15.12 Ivi, p. 29.13 In questo senso Vassalli vede nel personaggio di Agnese:
«Un simbolo di qualcosa di piú grande e di piú importante» in sen-so umano prima che socio-politico o storico. Cfr., S. vassalli, Intro-duzione, in R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., p. 2.
14 R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., p. 22. 15 Scrive Enzo Collotti: «Il comportamento [dei tedeschi oc-
cupatori] nei confronti della popolazione fu caratterizzato da un crescendo di episodi di violenza che si scaricò in una quotidiana teoria di eccidi e di stragi, in dipendenza o meno dal rafforzamento del movimento di resistenza e dello spostamento del fronte sotto l’incalzare dell’avanzata dal Sud verso il Nord degli eserciti anglo-americani», E. Collotti, L’occupazione tedesca in Italia, in Diziona-rio della Resistenza, cit., p. 54.
RobeRto Risso310
rifiuto che si evolve nel corso della narrazione in consapevolezza politica e storica, e che informa di sé la funzione materna di Agnese nei confron-ti dei Partigiani, trova nello sputo e nell’azione dello sputare una prima e costante16 rappresen-tazione di disprezzo e di dissenso ‘fisico’, imme-diato e viscerale. È tuttavia opportuno sottoli-neare che lo sputo di Agnese non si limita alla prima parte dell’opera in cui la protagonista è in-colta e in-consapevole ma continua lungo il corso della narrazione, durante e oltre l’evolu-zione del personaggio, rappresentandone la co-stante tensione fra natura e inconsapevolezza e consapevole appartenenza ad un movimento storico in divenire: la Resistenza17.
16 L’azione dello sputare torna costantemente nel romanzo in occasione dell’incontro di Agnese con i fascisti e i nazisti, gesto simbolico quanto netto di rifiuto integrale e di disprezzo: «Davan-ti alla casa del fascio si raschiò la gola, raccolse in bocca la sali-va e sputò per terra» (p. 16); «L’Agnese disse “[i tedeschi] possono ammazzarmi, se vogliono”, e sputò per terra» (p. 27); «Allora spu-tò per terra e cambiò l’onda [della radio] per consolarsi, in qual-che modo, con la voce straniera» (p. 49); «Lei stava zitta e sputava per terra. In silenzio, col suo largo viso smorto e il suo grande cor-po irresoluto, riusciva a tenersi in disparte» (p. 52); «Stette ferma a vederli [i tedeschi] andar via, e stette ferma ancora un bel pez-zo dopo che non li vide piú. Poi sputò per terra, nel posto preciso dove erano stati seduti» (p. 110). Anche in una delle brevi prose biografiche scritte dall’autrice e intitolate Donne della Resistenza, al termine del profilo di Edera De Giovanni, compare la narrazio-ne di uno sputo di sfida e disprezzo della donna contro il nemico: «Cinque uomini giovani e una ragazza di vent’anni. Cadevano sot-to i proiettili fitti. Ma prima la ragazza si voltò, sputò con disprez-zo, muta. La videro bene alla luce della luna. E lei prese la scarica nel petto», R. viganò, Edera De Giovanni, in Donne della Resisten-za, a cura di Ead., Bologna, S.T.E.B 1955, p. 45.
17 Un contributo importante sull’argomento delle donne nel-la/della Resistenza è il volume di a. bRavo - a.M. bRuzzone, In guerra senz’armi. Storie di donne. 1940-1945, Roma-Bari, 1995, particolarmente il terzo capitolo intitolato Madri (pp. 57-82) cui si devono aggiungere gli atti del Convegno di Conselice (ottobre 1976) dell’Istituto storico della Resistenza di Ravenna: Le Donne ravennati nell’antifascismo e nella Resistenza: dalle prime lotte so-ciali alla Costituzione della Repubblica, a cura di G. Franco Casa-dio, J. Fenati, Ravenna, Edizioni del Girasole 1977. Mi sono inol-
Il tema della maternità nella narrativa resistenziale 311
La rappresentazione di Agnese come don-na, come donna che vive e combatte, culmine di una tematica che attraversa trasversalmente la non cospicua produzione letteraria di Renata Viganò, rende unico il personaggio, di una com-plessità problematica, indimenticabile, pervaso di un’umanità affascinante e struggente. Dal-le prime descrizioni di Agnese nella Resistenza:
Il suo contributo alla lotta clandestina prese il carattere di un lavoro costante, eseguito con semplicità, con disci-plina, come fosse sprovvisto di pericolo. Temeva soltanto di non fare abbastanza, di non riuscire a comprendere, di sbagliare a danno di altri. Era contenta quando le diceva-no “brava”, come una scolara promossa18.
Umile e occupata in umili attività, come fare la calza, tratto che l’avvicina ad altri per-sonaggi femminili dei racconti: «Comperò del-la lana di pecora. Si mise a fare delle calze per i partigiani, quando era sola, la sera, vicino al fuoco»19, azione pur umile ma sempre inquadra-ta in un contesto di guerra e resistenza armata, quindi azione non piú comune ma eccezionale e necessaria alla causa. Sempre nell’ottica dell’or-dinaria eccezionalità della situazione della pro-tagonista, Agnese si trova a un certo punto ob-bligata dalle contingenze a vestirsi ‘da regina’, momento in cui la rara e fine ironia dell’autrice può emergere dagli orrori della guerra: «S’infilò quel vestaglione vistoso che le arrivava ai piedi, chiuso sul fianco e sul petto da grossi nodi di nastro viola. Sorrise vedendosi così addobbata […] I partigiani ridevano come matti, le faceva-no grandi inchini grotteschi: “Signora marche-
tre avvalso di opere di carattere generale e di più ampio respiro quali, l’opera di R. battaglia, Storia della Resistenza italiana. 8 set-tembre 1943-25 aprile 1945, Torino, Einaudi 1964.
18 R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., p. 43.19 Ivi, p. 44.
RobeRto Risso312
sa, i miei rispetti“. Lo studente fece l’atto di ba-ciarle una mano»20, ma si rimette gli abiti ugua-li e logori per onorare un matrimonio in briga-ta: «E l’Agnese? Non c’è? Non si vede la vesta-glia dell’Agnese! Sono qui, rispose lei. Era una grossa cosa bruna, confusa nell’ombra. Per fare onore agli sposi, s’era tolta la vestaglia e aveva indossato il suo logoro vecchio vestito di casa»21. Il contrasto fra normalità-quotidianità ed ecce-zionalità del momento storico è rappresenta-to nel personaggio di Agnese dal contrasto fra la solidità fisica: «Una donna grassa, ansante, sola, quasi vecchia»22 e: «Quella donna pesan-te, anziana, carica di roba, piantata nella ter-ra e nell’acqua come una statua non finita»23 e il movimento incessante, progressivo, di presa di coscienza, processo lento di cambiamento ra-dicale dalla lentezza e timidezza dell’inizio: «L’A-gnese non riusciva a tener dietro ai loro discor-
20 Ivi, p. 74.21 Ivi, p. 89.22 Ivi, p. 154.23 Ivi, p. 156. A conferma del carattere ‘visivo’ e ‘filmico’ di
tutta una serie di situazioni e descrizioni del romanzo, c’è la re-alizzazione della versione cinematografica dell’Agnese va a mori-re di Giuliano Montaldo, film del 1976, anno della morte dell’au-trice, film assai ‘fedele’ al romanzo, per cui si veda L. bonaPaRte, Giuliano Montaldo e “L’Agnese fa a morire”, Milano, Ghisoni 1976, agile guida e commento alla visione del film e raccolta di dati su regista, attori, bibliografia e filmografia. La semplicità apparente del susseguirsi degli avvenimenti del romanzo non deve inganna-re, come già osservava Battistini nel citato saggio sulla lingua e sullo stile del romanzo, la complessità e quindi il grande fascino dell’opera consistono principalmente nella delineazione dei carat-teri dei personaggi attraverso il susseguirsi delle azioni e delle re-azioni nell’ambito della situazione fuori dal comune e da ogni lo-gica. Come scrive Falaschi, del resto, la narrativa della Resistenza tende a rappresentare la vita come: «Un cozzo di avvenimenti, un cumulo di esperienze vissute piú che pensate, sicché le attività di-pendenti dall’agire – come il pensare, l’immaginare e il ricordare – sono ridotte al minimo e vertono su elementi concreti immedia-tamente recuperati alla dinamica del racconto», G. FalasChi, Il rac-conto (e il romanzo), cit., p. 64
Il tema della maternità nella narrativa resistenziale 313
si […] Le mancarono a un tratto le parole, per-ché tutti si erano voltati a guardarla»24, fino alla sicurezza e all’azione, alla consapevolezza e alla morte non cercata ma nemmeno fuggita, fino al sacrificio supremo:
Lavoro, paura, e morti. Allora lei era piú forte nel corpo e piú tarda a capire: adesso il cervello le si era fatto pronto, ma il corpo s’indeboliva […] Lei adesso lo sapeva, lo capi-va. I ricchi vogliono essere sempre piú ricchi e fare i pove-ri sempre piú poveri, e ignoranti, e umiliati. I ricchi guada-gnano nella guerra e i poveri ci lasciano la pelle25.
L’ironia, sottile e sottesa nel corso del ro-manzo, emerge in seguito con dirompente ama-rezza in vari racconti, alcuni dei quali sono pic-coli capolavori narrativi e per i quali ben si adat-ta la celebre definizione calviniana di racconto: «Il racconto è un’operazione sulla durata, un incantesimo che agisce sullo scorrere del tem-po, contraendolo o dilatandolo»26. In questi rac-conti l’autrice gioca sulla duplicità di termini ed espressioni legati da un lato alla storia e alla politica e dall’altro, non a caso, alla sfera della femminilità. Due casi, certamente i piú eviden-ti fin dai titoli, titoli in cui la duplicità dei ter-mini si rivela in tutta la sua latente ambiguità, sono i racconti Bandiera rossa e l’eponimo Arri-va la cicogna. Nel primo racconto l’allusione po-litica del titolo – di racconti di guerra e comun-que fortemente politicizzati si tratta – non trova
24 R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., p. 45.25 Ivi, pp. 123 e 166.26 I. Calvino, Rapidità, in Lezioni americane, id., Saggi 1945-
1985, a cura di M. Barenghi, Milano, Mondadori, 1995, t. I, p. 660. A proposito del racconto come genere e del suo rapporto con la narrativa della Resistenza scrisse Falaschi: «Il racconto è il pro-dotto più tipico di tutta la letteratura partigiana», g. FalasChi, Il racconto (e il romanzo), cit., p. 34. Renata Viganò si cimentò in en-trambi i generi letterari, legati alla Resistenza e non, producendo romanzi e racconti di ottima qualità e di notevole fattura.
RobeRto Risso314
nel testo nessuno sviluppo socialista o comuni-sta bensì un atto di resistenza coperto dalla più femminile delle funzioni corporali: il mestruo27. Come l’Agnese del romanzo che con un colpo ben assestato uccide un tedesco, l’Amedea del racconto, dopo aver coperto materiali partigia-ni compromettenti con «degli indumenti intimi che le servivano per un disturbo comune», al poliziotto fascista che la ferma consegna la bor-sa «senza pudore» e nel pronunciare la battuta cruciale del racconto: «bandiera rossa», lo col-pisce duramente: «e intanto consegnò al poli-ziotto un pugno calmo, robusto, solenne, che lo sbattè per terra»28. Altrettanto legato alla sfera della femminilità è il gioco di parole (e di signi-ficati) fra l’aereo che porta bombe su bombe – detto ‘cicogna’ con amara e nera ironia popola-re – e l’arrivo della cicogna che porta un nuovo nato, un parto durante uno dei tanti bombarda-menti alleati:
Ma questa era un’altra cicogna, e non aveva niente a che fare con il tenero, simbolico uccello volatile creato per noi dalla sollecitudine delle nostre mamme e nonne. Questa era una cicogna di guerra, e non portava bambini, e veni-va a vedere dove erano le case ancora in piedi per poter-le buttar giú dai suoi colleghi bombardieri. Però i bambini arrivavano lo stesso, pure sotto le bombe e le granate. Fi-
27 La protagonista di questo racconto apparso nel 1976 nel-la raccolta di racconti intitolata Matrimonio in brigata per alcuni versi sconcertante ricorda per molti aspetti l’Agense del roman-zo, della quale, per assonanza, richiama il nome, e non solo: «L’A-medea […] da quando era rientrata in città a lavorare come staf-fetta del Gap si sentiva sempre timorosa di sbagliare», R. viganò, Bandiera rossa, in ead., Matrimonio in brigata, Milano, Vangelista 1976, p. 55. Come l’Agnese, poi, l’Amedea viene malmenata da un tedesco che: «La buttò via come uno straccio» (Ibidem) e come l’A-gnese nella sua brigata nella palude, l’Amedea in città: «Nella base faceva la cuoca, aveva imparato a pulire le armi, lavava e stira-va», (ivi, p. 56).
28 R. viganò, Bandiera rossa, cit., p. 57.
Il tema della maternità nella narrativa resistenziale 315
niti i loro nove mesi di aspettativa, volevano nascere anche se trovavano un mondo di rombi e di scoppi e di sangue29.
La situazione in cui si trovano le due fami-glie che condividono lo stesso cascinale ne L’A-gnese va a morire, l’Agnese stessa, ormai vedo-va e la famiglia della Minghina, composta da un uomo inetto, dalla Minghina stessa, donna avi-da e pettegola, come avide e pronte alla prosti-tuzione e alla delazione sono le due figlie, que-sta situazione di convivenza forzata, appun-to, rispecchia la guerra civile del Paese, diviso dall’odio, dal timore e dal tradimento nonché or-mai in preda alle devastazioni fisiche e morali della guerra civile:
Avevano paura: la Minghina e le figlie per se stesse, l’Agne-se per i compagni. Se ne vendicavano dandosi a vicenda le notizie che facevano dispiacere, che rammentavano a cia-scuna di essere in potere dell’altra. Dietro la Minghina c’e-rano i fascisti, dietro l’Agnese i partigiani: tiravano, ognu-na dalla sua parte, la corda tesa della minaccia30.
Nel dopoguerra Renata Viganò scrisse un volume di biografie di donne partigiane, di ‘don-ne della Resistenza’ in cui si colgono nella real-tà delle vicende storiche non pochi espisodi, si-tuazioni, personaggi e tragedie che le offrirono materiale per le narrazioni dei racconti e del ro-manzo31. Proprio ne L’Agnese va a morire la nar-razione in terza persona permette all’autrice di pronunciarsi circa le altre donne, quelle che per
29 ead., Arriva la cicogna, Roma, Editori Riuniti 1954, p. 26. (Il racconto dà il titolo alla raccolta).
30 ead., L’Agnese va a morire, cit., p. 50.31 Documento di particolare interesse è a questo proposito
uno scritto del 1949: La storia di Agnese non è una fantasia, posto in appendice all’edizione citata del romanzo L’Agnese va a morire (pp. 243-346) in cui l’autrice ricorda con commozione i vari perso-naggi reali e le vicende ad essi legate che coesistono nel personag-gio dell’Agnese del romanzo.
RobeRto Risso316
timore, interesse o per necessità contingenti de-cisero di stare dall’altra parte:
Fra le più assidue [nella casa del fascio] c’erano le figlie della Minghina: giovani piuttosto belle, resistenti con la loro beata forza di contadine tolte al lavoro dei campi, felici di dominare e attente a portare a casa il più possibile: per quietare la madre, che si persuadeva solo col guadagno. Il padre, invece, non era molto contento, ma aveva tre don-ne contro, lo facevano tacere, non lo tenevano in conside-razione; finì per abituarsi, perché in casa c’era parecchio vino che gli piaceva, si mangiava meglio, e poteva lavorare un po’ meno, dormire all’ombra nel pomeriggio32.
Specularmente le donne e gli uomini della Resistenza nel romanzo, «c’erano, e non si co-nosceva il luogo: comparivano e scomparivano come ombre, ma ombre col fucile carico, col mi-tra che sparava. Ogni uomo, ogni donna poteva essere un partigiano, poteva non esserlo. Que-sta era la forza della resistenza»33. Resistenza fatta di gente comune, come l’Agnese, contadi-na lavandaia, gente che poteva mimeticamente passare completamente inosservata dal nemico:
Ma per le strade non c’era quasi nessuno, Qualche don-na con la testa fasciata dallo scialle, degli uomini rari, con l’aspetto affaticato e innocuo […] La forza della resistenza era questa: essere dappertutto, camminare in mezzo ai ne-mici, nascondersi nelle figure piú scialbe e pacifiche. Un fuoco senza fiamma né fumo: un fuoco senza segno. I te-deschi e i fascisti ci mettevano i piedi sopra, se ne accorge-vano quando si bruciavano34.
Questo essere normali e comuni rende i par-tigiani umani, uomini e donne che, pur nell’e-roismo e nel sacrificio estremo, restano reali, concreti, umani, vicini, palpitanti, contrapposti
32 R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., p. 41.33 Ivi, pp. 243-246.34 Ivi, p. 158.
Il tema della maternità nella narrativa resistenziale 317
per antitesi ai tedeschi dis-umani e ai fascisti sub-umani, animali, bestie: «Davano [i fascisti della Repubblica di Salò] dietro alle donne come animali, ma se una stava dura non si attentava-no a insistere battevano in ritirata […] Facevano lunghi discorsi in piazza, ma scappavano come conigli ad ogni piú lontano rombo d’aereo: scap-pavano nel sotterraneo della casa del fascio»35. Né i fascisti rifuggono dalle atrocità, al contra-rio si uniscono ai tedeschi nei crimini di guerra, anche i piú ignobili. Rivelatore e paradigmatico è l’episodio del partigiano impiccato nella pri-ma parte del romanzo, dove: «Uno di essi [i fa-scisti], con un bastone, si mise a dare dei colpi regolari alle ginocchia del morto che oscillava in qua e in là con il ritmo stesso della campana»36. Né mancano gli orrori della deportazione, rife-riti alla protagonista da un testimone oculare,
35 Ivi, p. 40. Eccessivamente riduttivo mi pare il giudizio di Gabriele Pedullà a proposito della prosa narrativa di Renata Vi-ganò nell’ambito della pur meritoria antologia einaudiana di rac-conti della Resistenza da lui curata. Nel cappello introduttivo al racconto della Viganò antologizzato il curatore scrive: «Nel mon-do di Renata Viganò domina un manicheismo rassicurante nel-la sua scontatezza (i più generosi potrebbero parlare, adorniana-mente, di “ingenuità epica”) […] A distanza di parecchi decenni, di questo universo in bianco e nero più di tutto sconcertano la man-canza di confidenza con la lingua italiana e la costante inadegua-tezza stilistica dell’autrice», cfr., Racconti della Resistenza, a cura di G. Pedullà, Torino, Einaudi 2005 e 2006, pp. 261-262. Oltre a mettere la parola – romanzo – fra virgolette (ivi, p. 261) riferendosi all’Agnese va a morire, stupisce il giudizio sulla lingua e sullo stile dell’autrice, quando venticinque anni prima Andrea Battistini, in un’opera dedicata proprio alla lingua e allo stile dell’autrice, aveva enunciato e ampiamente dimostrato come la prosa del romanzo fosse, al contrario: «Curata nei dettagli, lenta nei processi narrati-vi, statica nelle descrizioni paesaggistiche, in una sorta di mimesi verbale […] Per evitare uno stacco tra l’autore e i suoi personag-gi, dilata quella lingua quotidiana nelle descrizioni e nei commen-ti del narratore, sicché l’impasto stilistico del romanzo appare so-vente compatto e omogeneo […] L’insieme dei traslati de L’Agnese dimostra una padronanza linguistica e stilistica non comune», A. battistini, Le parole in guerra, cit., pp. 4; 21e 25.
36 R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., p. 28.
RobeRto Risso318
compagno di sventura del marito di Agnese e a differenza di quest’ultimo, scampato alla depor-tazione con la fuga. Straziante è l’episodio della bambina morta (che non sarebbe eccessivo ve-dere come eco dell’episodio manzoniano di Ce-cilia) spinta fuori da un finestrino del treno: «Poi lo [il corpo morto della bambina] lasciò cadere, e sentimmo il colpo che fece sul marciapiede»37, lasciando sul treno la madre in uno stato di do-lore estremo: «La donna cascò giú su quelli che stavano sotto, la tenevano stretta perché vole-va battere la testa contro lo sportello, e si strap-pava i capelli e i vestiti. Finalmente si mise fer-ma, e sembrò morta anche lei»38. Ne L’Agnese sono inoltre narrate le atroci rappresaglie nazi-ste39, le stragi di civili tristemente note: «Dicono sempre dieci italiani fucilati per un tedesco»40, e appunto l’uccisione del tedesco Kurts scate-na una strage in cui i tedeschi, «guidati da quel-li che vi conoscono»41 bruciano la cascina e si accaniscono sulla famiglia che la occupa, «del-le sgualdrine e delle spie»42, ma pur sempre de-gli esseri umani, donne cui viene riservata una fine atroce:
Li hanno ammazzati a baionettate: erano come delle be-stie. A una delle ragazze piantarono la baionetta nella gola, e poi giú, fino in fondo alla pancia. Fu trovata così, quando
37 Ivi, p. 35.38 Ibidem.39 Le rappresaglie, aspetto odioso dei crimini di guerra, e
che in anni recenti si tende a minimizzare e dimenticare in nome di assurde equiparazioni o, peggio, in onore del ‘sangue dei vinti’, trovano nei profili biografici (ma di racconti pur sempre si tratta, seppur veri) contenuti nella citata raccolta Donne della Resisten-za. Terribile è quello narrato in Maria Giacobazzi (pp. 35-37) con la strage di vecchi, donne e bambini fatti saltare in aria con gra-nate, o, come nelle pagine dedicata ad Irma Bandiera (pp. 15-17): «ammazzata a furia di tortura».
40 R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., p. 75.41 Ivi, p. 75.42 Ibidem.
Il tema della maternità nella narrativa resistenziale 319
lasciarono che la gente seppellisse i cadaveri, tutta aper-ta. – Si fermò un momento: certo doveva essere stata una cosa orribile. Finì in fretta: – Era incinta. Aveva dentro il bambino43.
Bestialità crudele e spietata, il «lavoro della paura»44, che l’autrice introduce nella sua ope-ra mettendola in bocca ai tedeschi stessi, sotto forma di minaccia, per mimesi riproducendo il loro italiano approssimativo e freddamente ru-dimentale: «Ma si nostro camerata ferito muo-re, noi fucilare tutti, anche donne e bambini. Tutti»45, aspetti orrendi di un fenomeno diffu-so che anche gli storici definiscono: «particolar-mente feroce»46. Il compito di rappresentare l’a-trocità della guerra nella sua molteplicità e sfac-cettatura di orrori, miserie ed ingiustizie, è con-dotto dalla Viganò con scrupolo letterario e do-cumentaristico, in un processo narrativo che ingloba e integra descrizione e narrazione, svi-luppo della trama e caratterizzazione dei per-
43 Ivi, pp. 75-76. L’accanimento sulle donne, la brutalità profanatrice dei nazi-fascisti è inoltre narrata nella strage di Mar-zabotto che la Viganò descrive nel profilo di Bruna e Matilde Zebri nel citato Donne della Resistenza: «Ammazzarono la Matilde spre-cando un nastro intero di mitragliatrice quando era già morta al primo colpo. Alla Bruna tagliarono il ventre con le baionette poi-ché s’erano accorti che stava per avere un bambino. E il bambino lo tirarono fuori, fecero la solita cosa di tirarlo in aria e sparargli. Lo avevano già fatto in altri posti», (ivi, p. 61).
44 Così la protagonista del romanzo definisce i crimini tede-schi e fascisti sulla popolazione. Nel terzo capitolo della terza par-te de L’Agnese va a morire, nel rogo e nell’eccidio di un villaggio, «[i tedeschi] un giorno, all’improvviso, bruciarono un villaggio, e non sapevano perché proprio quello e non un altro», (ivi, p. 160).
45 Ivi, p. 108.46 Enzo Collotti e Tristano Matta così contestualizzano i cri-
mini sulla popolazione civile: «Particolarmente feroce e sistema-tica divenne la repressione quando subentrò [nei comandi tede-schi] la convinzione che per combattere il movimento partigiano non fossero più sufficienti operazioni di polizia ma occorresse ac-quisire un’ottica di tipo squisitamente militare», cfr. e. Collotti-t. Matta, Rappresaglie, stragi, eccidi, in Dizionario della Resisten-za, cit., vol. I, p. 255.
RobeRto Risso320
sonaggi. Le mine e i campi minati, realtà allora come ora terribile e molto diffusa, trova spazio nel romanzo:
E cominciarono a seminare le mine. Era una semina ric-ca, abbondante, più fitta ed estesa di quella del frumento. Campi interi ne furono coperti; fili spinati intorno, e car-telli funerei col teschi e le tibie incrociate, come le etichette sulle bottiglie di veleno. E dappertutto la scritta: “minen”. Sugli argini, nei fossi, nei ponti, a fianco delle strade: “mi-nen, minen”47.
Alle atrocità dei nazi-fascisti, alla conno-tazione sub-umana dei fascisti, si aggiunge, in modo complementare, la raffigurazione dei te-deschi come dis-umani, come tristi e squallide macchine di morte, distruzione e sofferenza, si-stematici e puntuali, privi di sentimenti umani, addirittura dis-umanizzati nelle sembianze fisi-che, seriali, stereotipate e costanti. I tedeschi nel romanzo non avevano: «niente di vivo»48, né il più umano e comprensibile dei sentimenti (e da don Abbondio in poi, umanamente lettera-rio) la paura, li umanizza, al contrario, li allon-tana dall’umanità accentuandone la dis-umani-tà, la ferinità: «La loro stessa paura […] li faceva feroci»49. Ogni loro aspetto, qualsiasi pur mini-mo dettaglio è legato nel romanzo al regno mi-nerale o a quello della morte, e della non-uma-nità: «Gli occhi pallidi del tedesco […] lui si mise a ridere, ma solo con la bocca piena di denti di metallo, gli occhi rimasero gli stessi, fissi e li-quidi come se fossero colmi d’acqua»50.
Uniformità e sgradevolezza connotano i te-deschi anche in altre opere della Viganò, che nell’eponimo racconto della raccolta Matrimonio
47 Ivi, p. 133. 48 Ivi, p. 99.49 Ivi, p. 100.50 Ivi, p. 104.
Il tema della maternità nella narrativa resistenziale 321
in brigata, scrive: «Si ricordava le facce squalli-de sotto gli elmetti, le parevano tutte uguali»51, e ne L’Agnese va a morire sottolinea ancora la di-mensione non umana52 dei tedeschi, ora ridot-ti a pure ‘matricole’: «E furono i soliti tedeschi rigidi e senza vita, numeri di matricola, ai co-mandi di un pazzo»53. Uno spiraglio d’umanità, o meglio di non assoluta dis-umanità, si trova in contrasto, nel romanzo, con il crescente vigo-re del movimento partigiano: «Il tedesco stava lì, con gli occhi spenti, la faccia stanca. Forse pen-sava all’inverno del suo paese, in quel momen-to era un uomo, un povero uomo in mezzo alla guerra»54. Non può esistere pietà per l’oppres-sore dis-umano che imperversa sempre e co-munque sui civili inermi e innocenti, che fa del-lo sterminio e della ferocia il proprio fregio e le divisa della propria guerra, il tedesco è e resta il nemico, fisso nello stereotipo:
Era il tipo autentico del ‘tedesco invasore’ non specializ-zato, stupido e furbo e crudele nello stesso tempo, faceva solo quello che gli veniva comandato, lo faceva con pesan-tezza, con cattiveria, meticoloso come un ragioniere. Il re-sto non gli importava55.
Alla cieca brutalità dei nazi-fascisti, agli stenti e ai rischi della guerra civile si uniscono, nella narrativa resistenziale di Renata Viganò,
51 R. viganò, Matrimonio in brigata, cit., p. 13.52 Nelle pagine dedicate a Livia Venturini e a Rosa Zanotti in
Donne della Resistenza, l’autrice così descrive la dis-umanità dei tedeschi: «Era gente per cui non significava nulla una sparatoria, adoperavano il mitra come il contadino adopera la zappa. Il conta-dino taglia erba inutile, rivolta il blocco di terra che riluce al sole e darà grano. I tedeschi infilavano il caricatore, incominciavano il lavoro, chi ci fosse davanti non importava. Giovani, vecchi donne bambini. Poi il caricatore era vuoto. Si cambiava. Un lavoro come un altro», (ivi, p. 55).
53 ead., L’Agnese va a morire, cit., p. 106.54 Ivi, p. 159.55 ead., Matrimonio in brigata, cit., p. 21.
RobeRto Risso322
i difficili rapporti con gli Alleati anglo-america-ni, i lunghi indugi, i bombardamenti a tappeto, naturalmente (allora come oggi) indiscriminati, e tuttavia, pur nell’amarezza di una situazione durissima, all’annuncio degli Alleati ai Partigia-ni di lasciare le formazioni in attesa di tempi più propizi, i Partigiani reagiscono di conseguenza, senza soggezione né servilismo:
Le formazioni restano. Il proclama serve soltanto per far conoscenza con i nostri alleati e a provare una volta di più che se ne infischiano di noi. – Era [il Comandante] irrita-to e stanco: posò i piedi contro la stufa, le scarpe bagna-te fumavano. – Non sarà male mostrare che ce ne freghia-mo di loro56.
I bombardamenti alleati sono anch’essi una costante narrativa e, drammaticamente ri-vis-suti nella memoria della narrazione, spesso ve-lata, la narrazione, di un’ironia amara – a tratti amarissima – e sempre consapevole della realtà storico-politica che ha prodotto gli eventi nar-rati. Esemplare il quinto capitolo della quinta parte de L’Agnese va a morire, in cui la Viganò descrive in un primo momento gli effetti nefa-sti dell’arrivo: «dei motori dell’aereo: era “Pippo” che iniziava il suo lavoro di ogni notte»57, ‘lavo-ro’ di ricognizione cui seguono i bombardamen-ti, i cui effetti vengono poi descritti ‘da terra’, dal basso, in questi termini:
Un mucchio di macerie tra l’orto e il frutteto. Dove erano state le belle camere e la grande cucina, il forno e il por-tico, non c’era piú niente: in pezzi anche le pietre. Una li-nea di meno nel paesaggio, un vuoto che lo rendeva stra-no, sconosciuto, un posto cambiato. E un’altra famiglia che due ore prima aveva tante cose, adesso se ne anda-va a cercare un ricovero per la notte, con le mani vuote e
56 Ivi, p. 141.57 Ivi, p. 115.
Il tema della maternità nella narrativa resistenziale 323
il vestito che portava addosso; e contentarsi se erano tut-ti salvi58.
A queste descrizioni si aggiunge, punto no-tevole in quanto assai infrequente, se non uni-co nella narrativa resistenziale dell’autrice, un brano apertamente fantastico, amaramente iro-nico, ovvero il bombardamento visto nell’imma-ginazione dell’io narrante, dai fautori a bordo degli aerei:
Ma passarono gli aerei alleati, sopra, al ritorno dal bom-bardamento, e avevano qualche bomba rimasta. Forse un aviatore, di buon umore perché rientrava al campo, disse al compagno di volo: – Scommetto che ci prendo in quella casa là, – (agli anglo-americani piacciono le scommesse), – e il collega rispose: – scommetto di no. – Allora provia-mo? – Proviamo, – e fissarono la posta in dollari o sterli-ne. Poi giù in picchiata contro la casa bianca. Una bomba, due bombe, niente. E il collega sorrise. Un giro, e di nuovo giù in picchiata: una, due, tre bombe, le ultime, dopo non ce n’erano più. Un altro giro sulla nuvola di fumo e di ter-ra, e il collega s’era fatto serio: – Bravo. Bel tiro. Hai vinto la scommessa. – E via, in rotta, verso il campo, la mensa, il comodo letto degli ufficiali e sottoufficiali aviatori ingle-si e americani59.
58 Ivi, p. 116. Rilevanti a questo proposito sono due saggi apparsi su riviste di forte carattere storico: L. Poggi, Antifascism and the reshaping of democratic consensus in Post-1945 Italy, in «New German Critique», 67, 1996, pp. 101-110 e a.R. PeRRy, “Pip-po volava di sera”: Unraveling the mistery of a World War II Italian narrative, in «Italica», 79, 2002, pp. 95-113.
59 R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., pp. 116-117. Singo-lare coincidenza che nel romanzo d’esordio di G. beRto, Rosso di sera, Milano, Longanesi 1946 (ma cito dalla seconda edizione di due anni successiva), ci sia una situazione molto simile, un bom-bardamento alleato ‘vissuto’ nell’immaginazione del narratore dal-la parte degli aviatori: «Pronti. Tutti a bordo hanno un attimo di tensione. Gli apparecchi sono sull’obbiettivo […] Ma gli altri nel cielo non pensano a ciò. Essi non sanno nulla della gente che si preparano ad uccidere. […] Ora essi sono sulla via del ritorno. […] E se per fare ciò essi hanno prodotto una somma di dolore umano che niente potrà cancellare, nessun bene mai sulla terra, questa è una cosa che non ha importanza. Essi non vi pensano, e non ne
RobeRto Risso324
Il personaggio di Agnese, forte nel suo pro-cesso di evoluzione e di consapevolezza all’inter-no dei meccanismi della resistenza armata e di organizzazione militare (e civile), trova nella ma-ternità figurata e ideale, ‘generazionale’ nel sen-so più alto e storico del termine, la sua fonda-mentale funzione esistenziale oltre che resisten-ziale ed operativa, preludio necessario e inevita-bile al sacrificio supremo, immolazione non cer-cata ma vissuta eroicamente nella sua atroce ineluttabilità. La funzione materna è più con-servatrice e confortatrice che propriamente ‘ge-neratrice’, Agnese e il marito Palita non hanno figli e per questo la maternità di Agnese si fa in seguito generale, allargata, generazionale nei confronti di tutti coloro che resistono, i patrioti che con il loro sacrificio volontario forgiano e ri-creano la Nazione futura, libera, indipendente e democratica60.
hanno colpa, a causa del male universale. In breve si perde nel-la distanza il chiarore degli incendi, e gli uomini volavano sotto le stelle. Anche le stelle volano, a una fantastica velocità verso i luo-ghi cui essi appartengono, in un’altra parte della terra. Appena tra qualche ora, saranno sul Kentucky, sul Missouri, sulla Cali-fornia. E ciascuno di quegli uomini che ha distrutto case e crea-ture umane può pensare con amore ad altre case e ad altre crea-ture umane», ivi, pp. 68-70. Al lirismo accomodante di Berto che scrisse la prima stesura del romanzo durante la forzata perma-nenza in un ‘Fascist Camp’ in Texas, e la cosa ha il suo peso, Re-nata Viganò contrappone un’ironia amara e impietosa che nulla ha di accomodante o simpatetico nei confronti degli Alleati. Anche in Donne della Resistenza l’autrice non lesina amarezza e rimpro-veri agli aviatori anglo-americani, quando, descrivendo una mani-festazione di donne per il cibo scrive: «Si erano [le donne che sta-vano raggiungendo la manifestazione] dovute buttare nei fossi per la strada perché i caccia cosiddetti alleati si calavano in picchiata a mitragliare gagliardamente, anche se era passata la “cicogna” e aveva trasmesso che si trattava di donne in giro per i fatti propri e non di una colonna di militari tedeschi. In mancanza di meglio qualche cosa dovevano pur fare gli aviatori di quei caccia bombar-dieri anglo-americani. Voli di allenamento e sparare a pieno o a vuoto per non fare arrugginire i nastri delle mitragliere», ivi, p. 52.
60 Per una lettura del romanzo della Viganò in quanto nar-rativa resistenziale al femminile rinvio al recente contributo di
Il tema della maternità nella narrativa resistenziale 325
Il tema di Agnese come madre di suo mari-to, poi dei Partigiani e perfino dei tedeschi che la chiamano costantemente ‘mama’, è un filo con-duttore che attraversa e uniforma l’intero ro-manzo, sottile e costante nelle pur varie sfac-cettature e sfumature linguistiche e di significa-to. La componente profondamente rurale e do-mestica di Agnese, il suo configurarsi come ‘lar-ga’, ‘massiccia’, ‘solida’, l’avvicina anche fisica-mente alla dimensione rurale e generatrice del-la terra, della campagna feconda e immutabile. Agnese è materna e idealmente madre di molti, a partire proprio dal marito: «il solito Palita dei suoi tanti anni passati con lui, senza ardore, con un bene pacifico, profondo, attivo, un bene anche da madre»61, e perfino nei ricordi più lie-ti del passato il marito viene scambiato da ter-zi – e non per scherzo – per suo figlio: «Si era-no fermati tre giorni in città […] Palita era ardi-to, disinvolto, e pareva molto piú giovane, tan-to che il dottore credette che lei fosse la mamma […] – Suo figlio ha avuto una grave malattia, Si-gnora, Se l’è cavata bene […] Come rideva, Pa-lita, per lei che era diventata rossa!»62. La ‘vera’ maternità ideologica e fattuale è tuttavia quel-la nei confronti dei Partigiani, figli ideali, fauto-ri del futuro della Patria e del mondo nuovo, del nuovo sistema di libertà giustizia e uguaglianza. Questa maternità ‘ideale’ (ma ideale fino a che punto?) di Agnese viene non casualmente san-cita dal Comandante subito dopo la fuga dalla cascina e la drammatica confessione della don-na di aver ucciso un tedesco: «Poi il Comandan-te parlò, ed a lei parve di ascoltarlo in un sogno.
S.M. KonewKo, “L’Agnese va a morire” and Meanings of Compas-sion in the Female Partisans’ Struggle against German Nazis and Italian Fascists, in «Forum Italicum», 2, 2010, pp. 385-404.
61 R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., p. 43.62 Ivi, p. 63.
RobeRto Risso326
Disse proprio così: – “Clinto, la mamma Agnese viene con noi.”»63.
La ‘maternità’ di Agnese tende ad identifi-carsi con la sua tipica caratteristica di ‘donna di casa’, di ‘angelo del focolare’ (seppur senza figli biologici) tanto caro all’ideologia fascista e alla propaganda sessista del ventennio64. Nel ro-manzo della Viganò tuttavia questa figura to-pica e rassicurante è capovolta, non snatura-ta, tutt’altro, semplicemente ‘adattata’ alla fun-zione e alla realtà concreta e fattuale della Re-sistenza in cui Agnese è sì ‘angelo del focolare’ e donna di casa, ma il focolare e la ‘casa’ sono il fulcro della rivolta, della resistenza accanita e della lotta armata contro il nazifascismo:
Coi primi lavori nell’accampamento l’Agnese sentì perder-si in lei quel senso di precarietà che l’aveva tenuta sospesa dal primo passo della sua fuga. Rinasceva l’abitudine alla vita, aveva fame, sete e sonno come gli altri. Quando vide Gim che tirava fuori i tegami e le pentole, ridivenne donna di casa […] La capanna acquistò un’aria di abbondanza65.
La funzione protettrice e ‘materna’ di Agne-se è sancita e ribadita dalle parole del Coman-dante a piú riprese, dove, in una comunità pa-ramilitare, disciplinata e gerarchica come una formazione partigiana, le parole di chi coman-da sono legge necessaria quanto inoppugnabi-le, e nel caso di Agnese la sanzione dall’alto con-
63 Ivi, p. 57.64 Oltre ai citati saggi della De Grazia rinvio a una raccolta
che, pur non trattando direttamente l’opera della Viganò illustra esemplarmente la sua eredità storica, culturale e letteraria: C. lazzaRo-weis, From margins to mainstream. Feminism and fictional models in Italian women’s writing. 1968-1990, Philadelphia, Uni-versity of Pennsylvania Press 1993 e particolarmente i saggi dei capitoli 4 e 5: The female bildungsroman (pp. 94-119) e The histor-ical novel: history as female subjectivity (pp. 120-157).
65 R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., p. 66.
Il tema della maternità nella narrativa resistenziale 327
ferma ed ufficializza una realtà universalmente sentita e benevolmente accettata:
Il Comandante entrò, sapeva già tutto, e strinse la mano all’Agnese con un sorriso vago, sforzato. – Povera mam-ma Agnese, – Disse. – Quanta strada hai fatto. […] [Il Co-mandante] Si volse all’Agnese che friggeva la carne […] – Tu cosa ne dici, mamma Agnese? – Io non capisco niente, – rispose lei, levando dal fuoco la padella, – ma quello che c’è da fare, si fa. […] Tu verrai con me, mamma Agnese. Clinto invece rimane qui. C’è bisogno di lui. […] Devi man-giare, mamma Agnese, – disse la voce attenta e calma [del Comandante] – Come fai a lavorare se non mangi? […] Era-no pronti, tutti e tre. Il Comandante si rivolse all’Agnese: – Mamma Agnese, tu riposati e va’ a letto presto […] Buo-nanotte, Mamma Agnese […] I ragazzi vanno via, Mamma Agnese, – Disse il Comandante. – Quello è davvero un po-sto terribile66.
Sancita dalle parole del Comandante, la ‘maternità’ di Agnese diviene una realtà concre-ta, anti-retorica, comunemente e generalmente accettata da tutti e dall’Agnese in primis: «Era stata con loro come la mamma, ma senza re-torica, senza dire: io sono la vostra mamma. Questo doveva venir fuori coi fatti, col lavoro»67. Fatti, lavoro e dura realtà della lotta armata clandestina pur costantemente illuminati dal-la funzione protettrice e rassicurante di Agne-se, chiamata ‘mamma’ a più riprese dalla co-munità dei Partigiani durante quella fase com-plessa e delicata che seguì la: «svolta più decisi-va eseguita dal movimento partigiano […] il fat-to decisivo per le sorti future della Resistenza […] la pianurizzazione»68, e particolarmente dal
66 Ivi, pp. 125; 142; 150; 152; 165; 183; 191.67 Ivi, p. 92.68 Così Roberto Battaglia descrive la pianurizzazione: «I par-
tigiani filtrarono attraverso le maglie dei rastrellamenti, toccaro-no le colline e poi si sparsero come in tanti rivi nella pianura pa-dana, pervenendo quasi alle soglie delle grandi città. Si attuò cioè
RobeRto Risso328
partigiano ‘Clinto’: «Avanti, muovetevi, – diceva Clinto. – Sei qui anche tu, come mai, mamma Agnese. Abbiamo fame […] Clinto aprì la por-ta: il vento portò dentro la neve. Erano le tre del pomeriggio, e pareva già sera. – Buona notte e buon Natale, mamma Agnese, – dissero prima di uscire»69.
La funzione di madre opera nel lento pro-cesso di evoluzione della consapevolezza del personaggio, processo che conduce Agnese, anzi ‘mamma Agnese’, dall’immobile consapevo-lezza rurale all’impegno sociale, storico e politi-co: «Questo era il Partito, e valeva la pena di far-si ammazzare»70. La stessa consapevolezza del personaggio, «Lei adesso lo sapeva, lo capiva»71, giunge alla conclusione dell’essenzialità e uni-cità della propria funzione individuale e collet-tiva: «Bisognava cambiare il mondo»72, attraver-so e grazie all’azione degli individui sugli indivi-dui, iterazione tanto dialettica quanto fattuale:
Ed era tutta gente come Magòn, come Walter, come Tar-zan, come il Comandante, gente istruita, che capisce e vuole bene a tutti, non chiede niente per sé e lavora per gli altri quando ne potrebbe fare a meno, e va verso la morte mentre potrebbe avere molto denaro e vivere in pace fino alla vecchiaia. E appena si arriva, dice: – Hai mangiato? Hai bisogno di qualche cosa? – e prima di andare via dice: – Buona notte e buon Natale, mamma Agnese73.
La funzione materna di Agnese si estende con naturalezza anche nei confronti di coloro che non sono partigiani e il cui coinvolgimen-
quel fatto grandioso della Resistenza invernale che può chiamarsi “il miracolo della pianurizzazione”», R. Battaglia, Storia della Resi-stenza italiana, cit., p. 456.
69 R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., pp. 148 e 165.70 Ivi, p. 167.71 Ivi, p. 166.72 Ibidem.73 Ibidem.
Il tema della maternità nella narrativa resistenziale 329
to nella guerra è solo passivo, di vittime, di co-loro che deboli o ignari, la guerra la subiscono e ne sono travolti. Il personaggio di Agnese, prima e soprattutto durante il suo processo di evolu-zione e consapevolezza, si estende verso di loro maternamente e protettivamente, come una na-turale estensione della madre-terra e, con le do-vute cautele, della madre-patria74. L’episodio che meglio riflette questa condizione si trova nel sesto capitolo della seconda parte del roman-zo, quando un bambino, Mario, arriva in bici-cletta all’accampamento partigiano, spaventato a morte: «Il bambino scoppiò a piangere sulla porta, non poteva parlare. Diceva: – Il babbo… il babbo… – disperato, con le mani sulla fac-cia. Gli furono attorno in dieci, ma si calmò sol-tanto contro il braccio dell’Agnese»75. Specular-mente l’Agnese funge da madre anche nel puni-re, sostituendosi alla madre di una ragazza pro-prio nello schiaffeggiare, anch’esso atto saluta-re: «Questi doveva darteli tua madre!» e materno per eccellenza:
[…] Se una vuol bene a un partigiano non si fa baciare da un porco tedesco. – Era difficile per l’Agnese fare un di-scorso tanto lungo, non trovava più le parole, la voce si strozzava in gola per la rabbia covata tutta la notte. – An-date all’inferno! – Disse la ragazza, e cercò di svincolarsi, dette uno strappo al braccio; ma l’Agnese la teneva forte, gridò: – Questi doveva darteli tua madre! – e con la mano
74 Sul rapporto fra il concetto di Madrepatria e la Resisten-za, e particolarmente fra l’opera di Renata di Viganò e il concetto di (Madre)Patria si dovrebbe indagare con scrupolo e attenzione. È auspicabile che una monografia sul concetto di Madrepatria veda finalmente la luce, libera dalle pastoie dell’ideologia che sequestra le parole e lega i concetti. Opere di non trascurabile impatto, an-che se non propriamente legate alla produzione della Viganò sono: L. MuRaRo, L’ordine simbolico della madre, Roma, Editori Riuniti 1991; M. viRoli, Per amore della patria. Patriottismo e nazionalismo nella storia, Bari, Laterza 1995 e 2001; W. baRbeRis, Il bisogno di patria, Torino, Einaudi 2004.
75 R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., p. 122.
RobeRto Risso330
libera le dette due schiaffi, uno di qua e uno di là, misura-ti, grossi, pesanti76.
Colmo dell’ironia – ironia che pur misura-ta e rara, spesso molto amara, non è assente nella narrativa resistenziale di Renata Viganò – nell’ambito della mimesi dei partigiani con la popolazione civile, per sfuggire ai rastrellamen-ti nazifascisti, Agnese ‘si traveste’ da madre, in questo naturalmente molto aiutata dall’e-tà e dall’aspetto, appunto, ‘materno’: «Dissero che erano sfollati dal loro paese distrutto da un bombardamento, e inventarono una parentela: l’Agnese era la mamma di Clinto, e il Coman-dante un cugino di lei. Per rimediare alle rispo-ste difficili, pagarono molto per l’affitto»77. Il ‘tra-vestimento’ viene ripreso più volte, indipenden-temente dall’episodio appena citato, dai tede-schi stessi che, ingannati dall’aspetto di Agne-se, la chiamano ‘mama’ con insistenza:
Bono, bono. Io carrozzella! – aggiunse [il tedesco] indican-do il fiasco, e si toccò la fronte, per dire che era ubriaco. – E tu andare a casa con mama –. Strizzò l’occhio all’Agnese, puntò anche a lei un dito contro il petto: –Tu mama niente sapere partesani? – Va all’inferno, porco, – rispose l’Agne-se a mezza voce, e la Rina intervenne, atterrita, con la so-lita lagna: – Niente sapere, noi scappare bum bum, paura, inglesi niente bono78.
La maternità ‘generale’ del personaggio, in parte ascrivibile al fenomeno del ‘maternage’ de-scritto da Anna Bravo79, in piccola parte retaggio
76 Ivi, pp. 170-171.77 Ivi, p. 139.78 Ivi, p. 105.79 Scrive la storica: «Per le donne c’è una sfumatura partico-
lare: gli sbandati sono giovani uomini in pericolo che si rivolgono loro come a figure forti e salvifiche, vale a dire materne. E proprio a causa di questa vulnerabilità le donne li considerano spesso fi-gli virtuali, e per proteggerli danno vita a un maternage di mas-
Il tema della maternità nella narrativa resistenziale 331
ancestrale e in gran parte reazione consapevo-le e suprema all’orrore, all’ingiustizia e alle umi-liazioni mentali e materiali della guerra, è la ca-ratteristica fondamentale dell’Agnese, ciò che la rende utile e indimenticabile nella pur enorme letteratura di guerra e della Resistenza, e colle-ga il personaggio dell’Agnese ad altri personag-gi femminili della narrativa resistenziale dell’au-trice, anch’esse ‘madri’ che non temono nulla per se stesse: «L’Agnese si levò con poca voglia. L’inverno era lungo, la paura era lunga. Lei non aveva paura per sé non le restava più niente da perdere, ma le dispiaceva per “quei ragazzi”»80. Si tratta di madri che, come l’Agnese, muoiono con il sollievo che le sofferenze dei propri figli si-ano, in un modo o nell’altro, finite. Paradigma-tico sin dal titolo è un racconto intitolato Morte di una madre: «La vecchia signora chinò la testa sul petto, dispiegò le gambe con un grande so-spiro, senza avvedersi che urtava un altro cor-po devastato. Il suo ultimo, accecante pensiero prima del buio fu questo: “Come sono conten-ta che tu sia morto, Ferruccio!”»81. La maternità nella narrativa resistenziale dell’autrice prende varie forme, anche quella vicaria fino al sacrifi-cio supremo di sé, come in alcuni intensi pas-saggi delle biografie di alcune delle ‘donne del-la Resistenza’:
All’improvviso, un tonfo, un tremare profondo del suolo. Si fece tutto buio, la piccola luce che veniva dalla porta fu cancellata. Irene si stringeva al petto il bambino non suo, le pareva di farselo suo in quel momento. Urla e lamenti, corpi travolti nel crollo. Lei credeva di non aver niente, non
sa che rappresenta una delle espressioni specificamente femmi-nili della resistenza civile italiana», cfr. A. bRavo, Resistenza civile, cit., p. 270.
80 R. viganò, L’Agnese va a morire, cit., p. 169.81 ead., Morte di una madre, in Matrimonio in brigata, cit.,
p. 53.
RobeRto Risso332
sentiva male. […] Le donne, le mamme pensavano ai propri figli dispersi chi sa in quale terra, chi sa se piú vivi, lo fa-cevano come una speranza: Quello che mangia questo ra-gazzo, un’altra mamma lo darà a mio figlio”. E così furono presi a cena quei tre partigiani82.
Una eco non irrilevante di questo sentire l’autrice la inserisce nei versi con i quali apre la raccolta di biografie delle donne della Resi-stenza, poesia intitolata L’anagrafe trista: «Non guardarono occhi di madri / già in pianto per altri dolori. / Dalla vita si misero fuori / per essere nella Resistenza»83, versi forti nella loro chiarezza anti-retorica, nella testimonianza, co-erente e continua in tutta la produzione resi-stenziale di Renata Viganò, dei sacrifici e del dolore della guerra, civile e non. Fondamenta-le resta la maternità del personaggio dell’Agne-se e dei personaggi femminili all’Agnese simili o assimilabili verso i Partigiani, culmine di tutta la narrativa resistenziale dell’autrice: maternità ideale che si rivolge ad un futuro certo non lon-tano, collettivo, di tutto un Paese, di una Nazio-ne, della Patria intera: «In Italia non rimaneva-no che i partigiani per l’onore della Patria. Tut-ti quelli che tanto di patria avevano gridato per vent’anni erano scappati o nemici»84.
82 Irene Callegari e Maria Giacobazzi, in ead., Donne della Resistenza, cit., pp. 29 e 37.
83 Ivi, p. 13.84 Ivi, p. 61.
«Povera mamma Agnese…» Il tema della maternità nella narrativa resistenziale di Renata Viganò. - «Po-vera mamma Agnese…» The theme of motherhood in Renata Viganò’s “narratives of resistance”.
Roberto Risso
Muovendo dall’analisi della narrativa di Rena-ta Viganò e particolar-mente dai racconti del-le raccolte Arriva la cico-gna e Matrimonio in bri-gata e dal romanzo L’A-gnese va a morire il sag-gio analizza le immagini e il concetto di maternità nella prosa dell’autrice in relazione alla narrati-va resistenziale e bellica del periodo. Viene segui-to, sul filo di molteplici e coerenti spunti testuali, lo sviluppo del tema del-la maternità, reale e me-taforica, all’interno del-le opere, nel tentativo di delineazione di una po-etica del ruolo centrale della donna come per-sona e come madre, in guerra e non.
Beginning with an analysis of Renata Vi-ganò’s “narratives of resistance” – in partic-ular, as they unfold in her short-story collec-tions, Arriva la cicogna and Matrimonio in brig-ata, as well as in the novel, L’Agnese va a morire – my essay will focus on Viganò’s rep-resentations of moth-erhood within the con-text of these war and resistance narratives typical of the period. Based on a variety of relative textual refer-ences, I will analyze Vi-ganò’s poetics and the role of women as both mother and member of society in times of war and peace.
Riassunto - Abstact
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 335-346
AlessAndro GAudio
Guido Morselli e la questione meridionale: divagazione etnologico-letteraria
Negli ultimi capitoli di Uomini e amori, ro-manzo scritto da Guido Morselli negli anni Quaranta e, proprio nella sua secon-
da parte, ambientato in Calabria1, ho rinvenu-to due sequenze decisive per chiarire il rapporto tra l’intellettuale (nato a Bologna, ma lombardo d’adozione) e l’Italia meridionale2 e che ben pre-parano la riflessione, ben più organica, che egli dedicherà alla questione nel corso degli anni
1 Da ora in poi, nel citare da Uomini e amori, farò riferimen-to all’edizione inclusa in G. Morselli, Romanzi, vol. I, a cura di E. Borsa e S. D’Arienzo, Milano, Adelphi 2002, indicando tra paren-tesi soltanto il numero della pagina in cui è reperibile ciascun pre-lievo. Sulla genesi del romanzo si veda, in questo stesso volume, la relativa nota al testo (ivi, pp. 1531-1553). Un capitolo di Uomi-ni e amori, quello che include la scena quasi incestuosa tra Lucia Weiss e suo fratello Giorgio, venne pubblicato su «La Provincia» il 7 febbraio 1948: occasione in cui venne annunciato il progetto di pubblicare l’intera opera. Dopo molte revisioni, però, Morselli ab-bandonò questa idea e il romanzo fu edito per la prima volta sol-tanto nel 1998, sempre per Adelphi (a cura di P. Fazio); l’edizio-ne del romanzo è affiancata da una nota al testo del curatore (pp. 411-425, poi ripresa e aggiornata all’interno del volume citato dei Romanzi) e dal saggio di V. FortichiAri, intitolato L’officina del pri-mo romanzo (pp. 427-449), all’interno del quale ben si chiarisce la curiosa interferenza tra i ricordi personali dello scrittore e la ste-sura di Uomini e amori.
2 Su tale argomento e sulla rappresentazione della Calabria nella riflessione morselliana, si veda renAto nisticò, Quel Diario di Morselli testimonia un Sud “diverso”, in «Calabria», a. XXXIV, n. 226, giugno 2006, pp. 56-60 e, soprattutto, id., Nel paese “dove gli uccelli non cantano e le campane non suonano”: Morselli a Catan-zaro, in Mario Casaburi (a cura di), Per Augusto Placanica. Ricor-di e Studi, Cosenza, Abramo 2010, pp. 519-555: questo secondo saggio amplia e ridiscute gli assunti di quello del 2006.
AlessAndro GAudio336
Cinquanta3. La prima sequenza è giocata intor-no all’immagine – «tutta pittorica» (p. 453) – di Mariarosa, montanara calabrese con la quale, uno dei protagonisti della storia, il giovane pit-tore Vito Antonicelli dei signori di Cambria, ha una relazione e che gli ispira una magnifica Ma-linconia di Calabria. A delineare il carattere pe-culiare del dipinto, che incarna la quintessen-za della sua arte, e a intitolarlo così, interviene Saverio Maggio, l’«anti-ego» (p. 178) di Cambria, chiarendo con eloquenza la stretta relazione tra la «giunone calabrese» (p. 455) – altrove defini-ta «creatura semianimalesca» (p. 470) – e il suo ambiente: «Nei tratti di Marirò – spiega Saverio, rivolgendosi all’amico – tu hai espresso la mal-inconia di questo paese, che la violenza del sole non riesce a diminuire. Queste genti mediter-ranee, immensamente diverse da noi a dispet-to delle convenzioni amministrative, sono una razza segregata, decaduta, mortificata» (p. 454). In molti altri momenti della storia la riflessione di Saverio contribuisce a identificare «il centro d’irradiazione» (p. 152) dell’espressione artistica di Cambria, ponendosi sempre come specchio sul quale prendere coscienza dialetticamente del proprio ideale estetico, così da avere la pos-sibilità di rivederlo e di correggerlo. A questo punto del romanzo (quasi alle ultime battute), attraverso le parole di Saverio, Vito compie il passo decisivo del suo processo di maturazione: tanto sul piano artistico, facendosi finalmente interprete della «realtà essenziale delle cose» (p. 198), quanto sul piano umano, ponendosi cons-apevolmente quale frammento di una totalità più ampia e non come monade solitaria e inac-cessibile. Con la sua Malinconia di Calabria Vito
3 G. Morselli, Proposta per risolvere il problema meridiona-le [inedito, 1956], ora in id., La felicità non è un lusso, a cura di V. Fortichiari, Milano, Adelphi 1994, pp. 73-87.
Guido Morselli e la questione meridionale 337
è arrivato, finalmente, a un’opera che esprime interamente le sue intenzioni (anche quelle in-consce e all’artista non immediatamente chi-are): il ritratto di Marirò (che, è bene ricord-arlo, la rappresenta con il corpetto dischiuso e con una mammella che le trabocca da una mano, cfr. pp. 451-452), svuotato di ogni arti-ficio così come di una troppo ingenua aderen-za alla realtà, di questa finisce per cogliere il valore impudico, sostanziale, secondo le modal-ità che acutamente è ancora una volta Saverio a comprendere: «tu cogli, sotto una superficiale vivacità, la rassegnazione e l’avvilimento di chi si aggira sulle rovine della sua patria. […] tut-to, quaggiù, la stessa avventizia patina di mo-dernità che incontri da qualche parte, si guasta presto; tutto qui è logoro, sciatto, negletto: per-ché questa gente, nonostante una sua appar-ente avidità, non dà importanza alle cose di cui si serve, è assente o indifferente, vive ai margi-ni di una civiltà che la ignora e che essa ignora» (p. 455). Il chiaroveggente spirito che anima or-mai l’arte di Vito Cambria ha svelato il segreto di un popolo calabrese «rassegnato e distante» (ibidem), quel suo motivo ispiratore che Saver-io, dal canto suo, riesce a desumere con lucidità dalle sembianze di Marirò4.
Gli «occhi gravi» (p. 447), i «capelli scurissi-mi» (ibidem), «le anche larghe e colme, simili alla
4 La natura bipolare della sensibilità di Saverio, che si al-lontana dall’oggetto per scorgerne meglio la natura, emerge da un appunto di Morselli risalente all’8 dicembre 1943: «Nei visi dei montanari che affollavano la piccola chiesa, Saverio si sforzava di trovare qualche assomiglianza col pubblico domenicale della pieve di S. Orsola» (G. Morselli, Diario, a cura di V. Fortichiari, Milano, Adelphi 1988, pp. 24-25). Anche Nisticò sottolinea il simbolismo insito nel ritratto di Marirò, nonché il parallelismo tra la passivi-tà erotica della donna e la «subalternità economico-culturale del Mezzogiorno nei confronti del Settentrione» (r. nisticò, Nel paese “dove gli uccelli non cantano e le campane non suonano” cit., pp. 544 e 551).
AlessAndro GAudio338
zolla che rivolta il vomero fra solco e solco» (ibi-dem), l’«oscurità densa come nell’anfratto di un monte, percorsa da una tenue vena azzurrina» (ibidem) che si adunava nella piega della gam-ba dietro al ginocchio, «la viva e potente inerzia di un fusto di quercia» (p. 450) del suo corpo, le sue «membra vaste, dalla mollezza ubertosa» (p. 452): sono tutti particolari di una femminilità «protesa», segnata da una «dolcezza ferina e ma-terna» (p. 447) che attrae Vito irresistibilmente o, ma è la medesima cosa, istintivamente. Nel congiungersi carnalmente con Marirò (e, poi, nel ritrarla), egli sente «la propria esistenza dilatarsi a dismisura» (p. 448) sino a cogliere in fondo agli elementi distintivi di quella donna la «segreta connessione fra tutto quanto esiste» (p. 449), tra egli stesso e quella terra «bella ma non ridente, su cui non si spande il suono fes-toso delle campane» (p. 456)5 e, persino, fra la montanara calabrese e Lucia Weiss, sua aman-te durante il periodo milanese della sua esisten-za (cfr. p. 449). È questa la totalità sulla quale Cambria riflette mediante la sua opera artistica e che, da essa, sembra discendere per necessità: il pittore, dal canto suo, non si cura di riprod-urla con esattezza6. Si tratta dell’intuizione di una complessità che assume i tratti della gio-vane donna e che, per questo tramite (segreto, si è detto, ma non falso), giunge anche agli oc-chi di Saverio, il quale ne definisce il punctum, il particolare che ferisce lo sguardo, e il senso che ne deriva (studium).
5 Del medesimo tenore è un appunto diaristico, datato 3-4 maggio 1944: «Calabria: paese dove gli uccelli non cantano, e le campane non suonano» (G. Morselli, Diario, cit., p. 66).
6 Nonostante Vito Cambria amasse definirsi «artista obietti-vo», anche la sua Signora in attesa, ritratto di Marina Danzi, non avrebbe mantenuto che «un’imprecisa rassomiglianza» con il mo-dello, fino a indurre lo stesso artista a definirlo «un ritratto fatto a memoria, non col soggetto sotto gli occhi» (p. 79).
Guido Morselli e la questione meridionale 339
La seconda sequenza fa parte di un seg-mento di testo che Morselli in parte espunse dalla versione definitiva di Uomini e amori, ro-manzo, come è noto, largamente abbozzato all’interno delle sue notazioni diaristiche. Pro-prio la sezione cui si fa qui riferimento fu scrit-ta già prima del 1945, quando ancora Morsel-li si trovava in Calabria (come i due protago-nisti del suo romanzo, in qualità di ufficiale di una brigata di fanteria di stanza a Catanzaro), e contiene alcune interessanti considerazioni sul-lo spirito dei suoi abitanti, forse troppo positiva-mente addotto a cause meteorologiche: «Chissà, si chiese [Saverio], che una certa vita interiore, un certo metabolismo dello spirito, non sia in-fluito dal grado igrometrico, non sia modificato, danneggiato da questa quasi assoluta secchez-za dell’atmosfera» (p. 1550, ma si veda la stesu-ra definitiva, largamente rielaborata, a p. 462). Subito dopo e con maggior precisione, Saver-io, ricordando le parole «di un vecchio famoso parlamentare siciliano» (p. 1550), sostiene (ed è questa la parte cassata durante il processo di revisione del dattiloscritto compiuto all’inizio degli anni Cinquanta) che «la questione meridi-onale è una questione di mentalità, ma anzitut-to di mancanza d’acqua. […] Questo è il Sud: un involucro eccessivo sopra un corpo inerte» (ibidem). L’aridità del Sud assurge, non troppo scherzosamente, a prima causa della sua con-dizione deprivata e, ben più seriamente, a meta-fora di un’esistenza condotta secondo principi comportamentali sommari e, dunque, discutibi-li: «A pensarci bene, la sua [di Saverio] vita era stata tutta un esilio in un interminabile Sud, un trascinarsi in mezzo a gente non più di quella estranea e ostile a ogni suo bisogno, a ogni suo istinto profondo. L’ambiente in cui si era vol-ta la sua esistenza sociale [quella su cui è in-centrata la prima parte del romanzo], e persi-
AlessAndro GAudio340
no quella familiare, era stata meno arida, ideal-mente, che non fosse questa nel senso materi-ale?» (ibidem)7. Tutto sommato, anche durante il forzato isolamento calabrese, Saverio – e ad at-testarlo sono le pagine che, originariamente, er-ano state inserite nel corpo del romanzo – riesce a trovare appagamento e felicità (anche fisica): sensazioni che ricordano da vicino alcuni aspet-ti della sua vita passata e che somigliano, para-dossalmente, all’esaltazione provata da Vito tra le braccia di Marirò: tale imprevista omogenei-tà segnala un animo che, per quanto «déraci-né» (p. 461), è ancora dotato di una disposizione critica che gli consente di isolare la propria per-sonalità dall’oggetto osservato, senza discostar-sene troppo, e che, proprio in ragione di ciò, ri-esce a comprendere la radicale alterità del Sud. Lo fa, anche nel momento in cui, per risolvere la questione meridionale, suggerisce una soluz-ione che, al netto della metafora cui si è fatto prima riferimento, sembra essere frutto di una riflessione sull’argomento che ormai dispera di trovarne la soluzione: «Bisognerebbe – ammette
7 La distanza tra Nord e Sud viene verificata da Morselli in alcune riflessioni presenti nei quaderni privati e, quasi sempre, immediatamente trasformata in romanzo, secondo quella transi-zione continua dalla notazione autobiografica alla creazione fan-tastica, così significativa per il suo modo di raccontare. La fun-zione di canovaccio letterario accordata da Morselli agli appunti diaristici risulta, più volte, ben evidente: il 29 dicembre 1943, ad esempio, lo scrittore racconta come «Saverio seguiva da solo la strada montana che dal Timpone mena con un tragitto di una quindicina di chilometri in Sila; e il grigiore diffuso, la quiete au-tunnale dei monti […] gli avevano richiamato alla mente un lon-tano soggiorno a L., d’inverno» (G. Morselli, Diario cit., p. 38); op-pure, qualche settimana dopo, il 23 gennaio 1944, quando scrive: «Vi sono paesaggi che si ripresentano al nostro animo, trasferen-dosi da un luogo materiale all’altro. Il poggio coronato di pini di Alpignano l’ho rincontrato in Calabria, in certi scorci montani del-la strada che da S. Elia va alla Sila» (ivi, p. 50). È proprio la stessa simmetria dei luoghi che, in Uomini e amori, sarà posta al centro dei pensieri nostalgici di Saverio.
Guido Morselli e la questione meridionale 341
Morselli – che la penisola avesse una cerniera all’altezza di Napoli, e poterla periodicamente abbassare sotto il livello del mare» (p. 1550).
Qualche anno dopo, però, partendo da con-siderazioni altrettanto sconfortanti sulle con-dizioni del Sud e dei suoi abitanti, Morselli proverà a stilare una proposta (più articolata e meno provocatoria rispetto a quella affidata alle pagine del romanzo e poi, come si è visto, qua-si completamente depennata anche da quelle) all’interno di un articolo scritto tra il gennaio e il febbraio del 1956, ma rimasto inedito sino a pochi anni fa: nella Proposta per risolvere il problema meridionale, Morselli espone un per-corso che, per certi versi, coincide con quello effettivamente seguito negli anni successivi dai governanti italiani per tentare di far fron-te all’annoso problema, ormai divenuto (come d’altronde aveva paventato lo stesso scrittore) cronico. A colpire, nel saggio morselliano, è l’esigenza, sentita come irrinunciabile, di por-tare a termine il programma di rinnovamento in cinque-sette anni: strategia a scadenza ab-breviata che consentirebbe, sosteneva già allora Morselli, di vincere la ‘guerra del Sud’ evitando che a combatterla siano le generazioni succes-sive e che, poi, sarebbe equivalso ad accettare di averla persa.
Morselli ha piena coscienza dello stadio men che elementare della civiltà del Sud per-ché l’ha vissuta in prima persona; proprio per questo, da settentrionale, inizia il suo artico-lo ammettendo di sentirsi in colpa e rinuncian-do una volta per tutte alle false speranze ali-mentate dagli interventi parziali, ritenuti in-sufficienti, finanziati in gran parte dalla Cassa del Mezzogiorno. Questa semplice considerazi-one induce Morselli a dichiarare l’inadeguatezza delle risorse italiane con una cognizione della situazione non tanto diffusa tra gli intellettua-
AlessAndro GAudio342
li del Nord: «allo sforzo nazionale bisogna si ag-giungano aiuti esterni. […] Aiuti che, in teoria, dovremmo poterci attendere da una delle due parti, l’America o la Russia»8. L’auspicio di Mor-selli è che Mosca e Washington inviino imme-diatamente tecnici ed economisti che stabilis-cano la natura dell’intervento e ne quantifichi-no la portata; tuttavia, egli stesso non rinuncia a fornire alcune importanti indicazioni: ad es-empio, stima che per trasformare il Sud serva-no cinquecento milioni all’anno «per almeno 6-7 anni»9. Secondo Morselli, è oltremodo necessa-rio che tale richiesta sia espressa con chiarezza e in tempi brevi e che sia suffragata da «proget-ti elaborati e particolareggiati, con le statistiche e i conti», ma anche – aggiunge – dalle «immag-ini vive, i colori umani del dramma del nostro Sud, i documenti cinematografici presi apposi-tamente nei luoghi che hanno descritti i Levi, i Tommaso Fiore, le Guaita, le Ortese»10. Lo «sta-to d’emergenza» che si vive nel Sud (che dovreb-be essere sottoposto a un regime giuridico, am-ministrativo, doganale e fiscale «di piena eccezi-one […] simile al regime che vale, in guerra, per le zone d’operazioni»)11 giustificherebbe ampi-amente l’urgente richiesta che – prevede Mor-selli – sarà senz’altro accettata dagli Stati Uni-ti o dalla Russia per la posizione strategica che l’Italia detiene sullo scacchiere mediterraneo e perché sarebbero gli americani o i russi stessi
8 G. Morselli, Proposta per risolvere il problema meridiona-le cit., pp. 74-75.
9 Ivi, p. 76. 10 Ivi, p. 78. Renato Nisticò, negli articoli citati in preceden-
za, propone un parallelismo tra Marirò e Giulia la Santarcange-lese di cui Carlo Levi parla nel Cristo si è fermato ad Eboli (r. ni-sticò, Quel Diario di Morselli… cit., p. 58 e id., Nel paese “dove gli uccelli non cantano e le campane non suonano” cit., pp. 549-550).
11 G. Morselli, Proposta per risolvere il problema meridiona-le cit., p. 84.
Guido Morselli e la questione meridionale 343
a gestire l’intervento: il Sud, infatti, non sareb-be in grado di coordinarlo autonomamente per via di quella «“forma mentis” loica e statica, a sfondo speculativo e contemplativo» che affligge anche la burocrazia e che «va rivoluzionata»12. A trarne beneficio sarebbe anche la meridional-istica, categoria dello spirito e disciplina socio-logico-giuridico-morale poco incline all’azione e troppo alla dissertazione e alla evagatio mentis.
L’azione prevedrebbe, prima di tutto, la cos-truzione di case prefabbricate (che «dovranno affluire, a decine di migliaia, ai porti di Napo-li, di Bari, Messina, ecc.»)13, messe in opera ac-canto ai centri abitati da sgomberare (anche con l’uso della forza, con i bulldozers, il tritolo e i lanciafiamme, suggerisce Morselli) e da bonifi-care in fretta e a tutti i costi, perché, per riscat-tare il Sud, «la riforma a dosi omeopatiche, frammentaria, dislocata, diluita in 30 e 40 anni [quella, insomma, che è poi toccata in sorte al Paese], non serve»14. A trasformazione compiu-ta, seguirà un processo di industrializzazione (destato dalle stesse energie locali e non da in-vestitori settentrionali) così come una sponta-nea evoluzione economica, cui si accompag-nerà «quella degli animi, delle intelligenze, delle volontà»15. È Morselli stesso a definire violen-to tale metodo d’intervento e a sancirne la ne-cessità; violento, celere e sommario, ma del tut-to privo di palliativi e, precisa lo scrittore, con-cepito in modo da escludere «solo l’ingiustizia e l’arbitrio, i campi di concentramento e il lavo-ro forzato»16. Alla guerra di posizione, condotta in trincea da funzionari dislocati ovunque, ac-
12 Ivi, p. 81. 13 Ivi, p. 83. 14 Ivi, pp. 83 e 85. 15 Ivi, pp. 85-86. 16 Ivi, p. 86.
AlessAndro GAudio344
comodati sulle loro poltrone, Morselli vorrebbe sostituire – secondo la logica della guerra in-cruenta alla base, qualche anno dopo, delle vi-cende narrate in Contro-passato prossimo17 – un’azione gestita da un general staff di tecnici che sieda solo in jeep e dorma sotto la tenda» e che «manu militari» faccia sì che il Sud non res-ti passivo e attardato «in un mondo che avanza senza tregua, economicamente e socialmente»18.
Nelle more di una proposta che prevede una risoluzione così drastica Morselli sembra covare il dubbio che comunque lo sforzo non possa es-sere sufficiente. Ciò si nota bene, se si pone in relazione dialettica la sfera malinconica del sen-timento pittorico, di cui ci si è occupati nella pri-ma sezione di questo paragrafo, a quella razio-nale dell’azione economica programmata, sulla quale Morselli si concentra con il saggio dedica-to alla questione meridionale: per comprende-re la sua complessa natura sono necessari tan-to la delicata sensibilità dell’artista, che però ri-conosce il suo senso grazie allo spirito d’osser-vazione del critico, quanto il freddo calcolo e la disciplina dello statista, che nondimeno si nu-tre dell’eloquente insistenza di chi ha bisogno di aiuto: a ciascuna delle figure contemplate serve, però, uno scatto ulteriore dell’intelligenza che consenta di assumere la piena coscienza di un fenomeno così composito. Non è un caso che Morselli individui in una sorta di intellettuale attivo, coinvolto e distaccato al medesimo tem-po, la figura ideale destinata a occuparsi effica-cemente del problema del Sud.
17 «Quando ci si muove, – dicono Visentin e Rommel al ge-nerale Di Cesare, appena fatto prigioniero – diventa tutto possibi-le» (G. Morselli, Contro-passato prossimo, Milano, Adelphi 1975, p. 85).
18 G. Morselli, Proposta per risolvere il problema meridiona-le cit., pp. 86 e 87.
Guido Morselli e la questione meridionale: divagazio-ne etnologico-letteraria - Guido Morselli and the Sou-thern question: an ethnologic and literary digression
Alessandro Gaudio
Il saggio ricostruisce la riflessione di Guido Morselli sulla questio-ne meridionale, sotto-lineando l’evidente cor-rispondenza tra alcune sequenze del roman-zo Uomini e amori am-bientate in Calabria e la Proposta per risolve-re il problema meridio-nale, articolo scritto tra il gennaio e il febbra-io del 1956 e poi pub-blicato soltanto dopo la morte dell’autore in La felicità non è un lusso. Per comprende-re la complessa natu-ra del fenomeno sono necessari tanto la deli-cata sensibilità dell’ar-tista, che però ricono-sce il suo senso grazie allo spirito d’osserva-zione del critico, come avviene nella vicenda di Saverio e Vito narra-ta nel romanzo, quanto il freddo calcolo e la di-sciplina dello statista: Morselli sembra, però, consapevole del fatto che a ciascuna delle fi-gure contemplate ser-va uno scatto ulterio-
This essay sums up Guido Morselli’s reflec-tions upon the South-ern question, highlight-ing the obvious likeness of some passages in the novel Uomini e amo-ri (Men and Loves), set in Calabria, and the ar-ticle Proposta per risol-vere il problema meridi-onale (Proposal to solve the Southern question), that he wrote between January and Febru-ary 1956 and was post-humously published in La felicità non è un lus-so (Happiness is not a Luxury). The under-standing of the complex nature of the phenom-enon requires both the refined sensibility of the artist, that nonetheless recognizes its meaning thanks to the powers of observation which is typical of a critic, as told in Saverio and Vito’s ep-isode in the novel, and the cold calculation and discipline of a states-man: yet Morselli seems to know that each of the abovementioned figures
Riassunto - Abstact
re dell’intelligenza che consenta di assume-re la piena coscienza di un fenomeno così com-plesso.
need a further burst of intelligence in order to be perfectly aware of such a complex phe-nomenon.
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 347-359
Gabriele belletti
L’istituzione dell’espressivismo oggettuale nel primo Caproni
Nella sua prima raccolta in versi1 – com-piendo in essa rilievi di struttura e di situazione2 – è possibile affermare che
1 G. Caproni, Come un’allegoria, in id., Tutte le poesie, Mila-no, Garzanti 1999.
2 Ricordiamo qui, bordeggiando, che i procedimenti meto-dologici anceschiani atti a far emergere dal complesso intrico di relazioni in cui vivono i sistemi istituzionali sono i rilievi. I rilievi di struttura si applicano solo al testo (a uno dei testi del campo), hanno il compito di reperire e mettere in risalto, prelevare tutte le dichiarazioni esplicite ed implicite che scoprono una certa idea di poesia. Ci forniscono solo un’astratta realtà atemporale, asto-rica delle istituzioni, ci mostrano i fili portanti che sostengono un principio istituzionale nella sua interna sistematicità. In questo modo si mettono in luce i sistemi operativi, i materiali della poe-sia, ma non ancora l’“edificio” della poesia. Per giungere a ciò ci si inoltrerà nell’analisi fornita dai rilievi di situazione, che permetto-no di inserire le istituzioni in un determinato tempo, nei contor-ni dei movimenti, periodi, in cui esse sono contenute. Esistono, inoltre, rilievi di situazione logica implicanti una procedura ordi-nativa, una costruzione dell’“edificio” con i materiali ricavati, rin-tracciano il senso che lega le istituzioni trovate, ordinandole cro-nologicamente e poi distinguendole secondo la loro tipologia (in questo modo si rende evidente la permanenza o meno di una isti-tuzione le sue variazioni e permanenze). Attraverso tale analisi logico-situazionale si verifica anche un’altra differenziazione tra le stesse istituzioni. Si avranno istituzioni cardinali – fondamenta dell’“edificio” – e istituzioni vicarie – secondarie, accessorie, come ad esempio l’analogia nelle poetiche crepuscolari o i forestierismi nelle poetiche della neo-avanguardia. La differenza tra i rilievi di struttura e i rilievi di situazione logica dipende dal fatto che i pri-mi si muovono «da un orizzonte sistematico generale per poi re-cuperare il sistema breve dell’istituzione», mentre gli altri partono «da una istituzione particolare e poi ricostruiscono il sistema del-la istituzione stessa» (l. anCesChi, Le istituzioni della poesia, Mila-no, Bompiani 1968, p. 34). Dai rilievi di situazione logica si pas-sa ai rilievi di situazione storica che contestualizzano la poetica in una situazione storico culturale; infatti il perché della poetica, se-condo l’estetica comprensiva anceschiana, è esterno ad essa. Si
Gabriele belletti348
Caproni si avvale di quella che qui si deno-minerà istituzione dell’espressivismo ogget-tuale, altra declinazione della poetica degli oggetti3 – istituzione certo cardinale4, analiz-zata ed estendente la propria presenza dalle poetiche novecentesche a quelle del primo decennio del nuovo secolo5.
Riprendendo in mano la raccolta Come un’allegoria (1932-1936), contraddistinta da una particolare «cantabilità sciolta e incanta-ta» e da una «leggerezza prosodica»6, si appu-ra come le cose scelte e riscontrabili nelle liri-che siano portate ad assumere espressioni – si potrebbe dire connotazioni “somatiche” – antro-pomorfe7 assecondano la mimica e il sentire del
intende così correlare le istituzioni situandole nel tempo, nella storia, nella vita della cultura e nella vita di ogni singolo artista, inserendo il nostro “edificio” oramai edificato in un certo “quartie-re” – per continuare ad utilizzare la terminologia anceschiana. Si vede, per concludere, come le istituzioni riescano ad essere una delle vie «attraverso le quali si può cogliere la vita della storicità celata nella vita dell’arte» (ivi, p. 37) e i rilievi consentono un lavo-ro in comune che coinvolge diversi studiosi, un continuo lavoro di gruppo. Quindi risulteranno molto utili sia alla storia della lette-ratura sia alla critica letteraria.
3 «Il metodo della analogia e quello delle equivalenze ogget-tive sono forse i motivi più insistenti che percorrono in senso sin-cronico che in senso diacronico la sintassi poetica del Novecento secondo particolari e disformi disposizioni e risalti» (l. anCesChi, Poetiche del Novecento in Italia, a cura di L. Vetri, Venezia, Marsi-lio 1990, p. 114).
4 «Esse [le istituzioni] si amalgamano in poetiche (che pri-vilegiano questa o quella istituzione), che avranno tanta più for-za quanta maggiore sarà la responsabilità con cui affrontano quel problema situazionale della poesia che intendono risolvere» (l. an-CesChi, Poetiche del Novecento in Italia, cit., p. 279).
5 Si vedano soprattutto T. lisa, Poetiche dell’oggetto da Lu-ciano Anceschi ai Novissimi. Linee evolutive di un’istituzione del-la poesia del Novecento, Firenze, Firenze University Press 2007 e M.a. GriGnani, Slittamenti del correlativo oggettivo nella poesia del Secondo Novecento, in «Italianistica», a. 2002, nn. 2-3.
6 n. lorenzini, Il presente della poesia. 1960-1990, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 86
7 Ci permettiamo di citare qui anche il nostro contributo nel rilevare la presenza dell’istituzione della poetica dell’oggetto e in
L’istituzione dell’espressivismo oggettuale 349
soggetto. Sono espressioni mutevoli e diversifi-cate nel loro manifestarsi, in modo da favorire le modificazioni dell’ambiente tutto8 in cui vengo-no ad essere, adeguandosi ad esso e/o condizio-nandolo. Un’interdipendenza, insomma, tra ciò che il poeta percepisce, sente, e ciò che da tali soggettive percezioni fanno germinare nel pae-saggio9 in cui abita – sia esso interiore o este-riore – o viceversa. Il paesaggio vivente, “espres-sivo”, come quello della prima silloge capronia-na, è costruito attraverso sguardi, fiati e, più in generale, “atteggiamenti” delle cose. Molti sono gli esempi a questo proposito, si veda «il fiato del fieno», «ride il sole», «bocca ancora / asso-pita», «il sangue ferveva / di meraviglia», «gota del prato», «memoria stanca della sera», «balbet-tanti parole ancora / infantili», «la terra, con la sua faccia / madida di sudore, / apre assonna-ti occhi d'acqua / alla notte che sbianca», «im-pensieriva / la sera», «sereno cuore», «lo sguardo del mare», «il fiato / del giorno», «o sera, / con la tua pallidezza». Si può constatare, inoltre, come il suddetto “espressivismo” sia aderente spesso a una istituzione di più ampio respiro – quella definibile con i termini “trapianto/mutazione” – istituto che il poeta adotta per denotare la mi-scelazione intenzionale – di senso biunivoco –
particolare sotto la sua particolare manifestazione dell’Io di cose: G. belletti, Cosa perde l’Io. le istituzioni letterarie e la poesia di Fa-bio Pusterla, in «Poetiche», a. 2009, n. 1, pp. 139-165. Io di cose che si manifesta già assieme alle prime manifestazioni dell’istitu-zione della poetica dell’oggetto – avvenuta in seno alla Scapiglia-tura di fine Ottocento (si veda il Soliloquio delle cose del crepusco-lare Corazzini in Poemetti in Prosa, ad esempio).
8 Sarebbe auspicabile un approfondimento dell’istituzione Spazio nelle poetiche in generale e novecentesche in particolare (si veda, per fare solo due esempi, lo spazio mentale in Giudici o il pozzo zanzottiano).
9 Per un’accurata ricognizione sul tema si veda G. bertone, Lo sguardo escluso. L‘idea di paesaggio nella letteratura occidenta-le, Novara, Interlinea, 1999.
Gabriele belletti350
tra soggetto e oggetto10. Tale “chirurgia poetica” si attua nel momento in cui le parti, le caratteri-stiche del mondo antropico vengono trapianta-te all’interno, nel “corpo” stesso, delle cose («nel vento è vivo / un fiato di bocche accaldate»; «l’e-co / d’un canto nell’aria serale»; «nel tocco del-le campane / c'è ancora qualche sapore / del giubiloso soggiorno»; «vento che si accalora / di risa sui maturi fieni») o quando è il soggetto – o i soggetti – ad accogliere “porzioni” degli og-getti più o meno materiali che con lui si me-scolano e interagiscono11 («bruciò il tuo viso / dal caldo sangue tinto / d’un segreto pensiero»;
10 Anche nelle raccolte successive come, ad esempio, Il Con-te di Kevenhüller (1986), vi è uno «scivolamento continuo di ge-rarchie tra io e mondo» – dovuto alla messa in crisi della centra-lità dell’io lirico propria del Secondo Novecento – accompagnato da «dubbi sistematici sulla raffigurabilità del mondo» il di cui pa-esaggio «è vagheggiato come costruzione formale» e resta da par-te dell’autore la consapevolezza della sempre «imperfetta dicibili-tà dell’oggetto» (M.a. GriGnani, Slittamenti del correlativo oggettivo nella poesia del Secondo Novecento, cit., p. 289). Addirittura, in seguito, «lo sguardo, l’occhio, si separano dalla coscienza della percezione, al punto che non si saprà più indicare un’area seman-tica definita né per la presenza né per l’assenza, nella dispersio-ne frantumata di voci sempre più inconsistenti ed effimere […] Il viaggiatore, il «disabitante» restato senza parole, affonda così, di grado in grado, in un tempo ripetitivo e sospeso esterno alla sto-ria» (n. lorenzini, Il presente della poesia. 1960-1990, cit., pp. 88 e 90).
11 Si veda la costanza di questa modalità poetica in Capro-ni in ciò che Colangelo rileva nella lirica Ad portam inferi appar-tenente ai Versi livornesi: «Annina immersa, come l’oggetto di un incubo, in una specie di smog, emblematico dell’incertezza e della fragilità: in una sostanza mortifera che riesce a penetrare persi-no nell’ambiente chiuso della sala d’attesa, e che non solo circon-da gli esseri viventi e gli oggetti, ma accoglie in essi lo sgretola-mento, la scomparsa» fino a che «Annina finisce per dissolversi, lei stessa, in una nuova sostanza di nebbia», (s. ColanGelo, «Tra la mano e la spiga». Caute ipotesi su Caproni, in Un’altra storia. Pe-trarca nel Novecento italiano, atti del convegno di Roma 4-6 otto-bre 2001, a cura di A. Cortellessa, Roma, Bulzoni 2005, p. 178). Si veda, inoltre, come nelle raccolte caproniane si ripeta il motivo avvolgente, atto estremo di mescolazione, «della nebbia che cala a confondere ogni ipotesi di trascrizione mimetica del reale» (Dopo
L’istituzione dell’espressivismo oggettuale 351
«un fresco / vento che sala il viso»; «s’illumina-no come esclamate, / ad ogni scoppio di razzo, / le chiare donne sbracciate / ai balconi»; «voci e canzoni cancella / la brezza»; «estate ansiosa / come una febbre sale / al tuo viso, e lo bru-cia / col fuoco dei suoi gerani»; «sopra un’illu-minata / pelle di giovani donne / si cancellano gli astri»). Da rilevare, inoltre, come l’allittera-zione12 – assai presente nella raccolta («prati ba-gnati», «bocche accaldate», «sfrenate / rincorse», «ultimo lembo», «schianti / chiari», «un’illumina-ta / pelle») – si faccia spesso vero e proprio cor-relativo oggettivo acustico. Il fonosimbolismo, infatti, accompagna regolarmente l’istituzione del “trapianto”, in quanto le parole giustappo-ste contengono le lettere facentesi “segnali” – si potrebbe dire “genetici” – del “trapianto/mesco-lamento” stesso, sono, cioè, indicazioni sonore – ricordando «come sia l’accordo fonico a creare, quasi per gemmazione spontanea, il gioco del-le immagini e dei significati»13 – che permetto-no di avvertire che, anche se l’oggetto di cui la parola è significante sta avendo un mutamen-to, alcuni “elementi” poetici – ortografici e so-nori – permangono (si conserva, cioè, una «con-tinuità musicale»14). Rappresentativo in questo senso il trinomio «uccello», «stella» e «cielo» di Ri-cordo: «il sangue ferveva / di meraviglia, a vede-re / ogni uccello mutarsi in stella / nel cielo». Il poeta, oltre a cantare metaforicamente l’avven-to della sera, unisce all’alterazione – questa vol-ta sono implicati solo oggetti – l’indizio acusti-
la lirica. Poeti italiani 1960-2000, a cura di E. Testa, Torino, Ei-naudi 2005, p. 19).
12 Si ricordi, come sottolinea Mengaldo, che «per Caproni in principio è la rima (o l’assonanza e consonanza)», cfr. p.V. MenGal-do, Poeti italiani del Novecento, Milano, Mondadori 1978, p. 701.
13 Ibidem.14 G. paMpaloni, nota di, in Giorgio Caproni, Poesie 1932-
1986, Milano, Garzanti 1989, p. 815.
Gabriele belletti352
co del suono della “l”, presente in tutti e tre gli elementi coinvolti. Altri trinomi riscontrabil nel-la raccolta e soggiacenti alla medesima tecni-ca poetica sono «terra» - «frutto» - «sbucciato», «astro» - «scompare» - «rondine», «terra» - «su-dore» - «apre», «bruciò» - «segreto» - «pensiero», «cancella» - «pelle» - «fanciulla», «allegra» - «illu-minata» - «cancellano».
Dopo aver accertato la presenza dell’istitu-zione delle metamorfosi/trapianti nel loro aspet-to prettamente spaziale, concernendo, vale a dire, corpi e fenomeni nel loro essere primaria-mente “materiali” e in contatto tra loro, occor-re riferirsi, tenendo conto, quindi, anche della dimensione temporale, alle relazioni che sus-sistono tra ciò che l’io percepisce nel presen-te, nell’attualità del suo cantare – seppur, co-munque, fittizia, poetica, naturalmente – e ciò che, piuttosto, è per lui ricordo, temporalmen-te distante, colto come lontano («E fu quell'aro-ma acre / e lontano, alla riva / giunto del sere-no cuore, / a volgerci sui nostri passi / insieme compiuti invano», Dalla villa Doria). Tra ricordi e sensazioni “in atto” – come si vedrà prenden-do in prestito le qui utili categorie dell’empiri-smo humeano – vi sono relazioni e legami va-riegati, vi è un “dialogo”costante che asseconda la volontà del poeta di creare una peculiare “fi-sica-esistenziale”15 e di far incontrare e intera-gire due dimensioni temporali: quella della me-moria e quella del presente – che lo ingloba e in cui è coinvolto. Le liriche sono composte per la maggior parte al tempo presente, liriche in cui sono disseminati, però, molti ricordi, si canta-no immagini e sensazioni riaffacciantesi da una temporalità trascorsa, appartenente al passato più o meno prossimo. Per facilitare l’esplicita-
15 G.l. beCCaria, Caproni. La poesia e oltre, in «L’indice», anno I, n. 1, Torino, 1984
L’istituzione dell’espressivismo oggettuale 353
zione delle modalità di intersezione e di relazio-ne tra memoria e presente, per specificare, cioè, tali movimenti dimensionali, ci avvaliamo qui – come già accennato – di tre categorie prodotte in seno all’empirismo inglese – nello specifico all’empirismo humeano. Sembra utile scanda-gliare la poetica di Come un’allegoria descriven-dola attraverso l’uso di queste classi, sì filoso-fiche16, ma non per questo meno utili per espli-citare il pensiero poetico dell’autore, ricordan-do che Caproni ha «la vocazione a comunicare esperienze piuttosto che verità perentorie anche quando», come è accaduto per Hume al termi-ne del Trattato, approda all’orizzonte ontologi-co delle domande senza risposta sull’identità»17: quella di impressione di sensazione (ciò che nel presente si percepisce attraverso i sensi: «Ne-gli occhi nascono come / nell'acque degli acqui-trini / le case, il ponte, gli ulivi», «Spira l’odor dei fumi / acre, sull’allegra fiammata»), quella di idea di sensazione (l’idea, cioè, di una sensa-zione ricordata: «Ricordo / una chiesa antica, / romita, / nell’ora in cui l’aria s’arancia»), e di impressione di riflessione (sensazione provocata dall’idea di sensazione, dal ricordare cioè qual-cosa che è stato o che in parte è rimasto: «Dal-la pianura ventosa / della tua terra ho avuto / quest'aspra volontà, io sento ancora / fresco
16 «Un’impressione [di sensazione] colpisce dapprima i no-stri sensi e ci fa percepire il freddo o il caldo, la sete o la fame, un qualsiasi piacere o dolore. Di questa impressione una copia resta nella mente, anche dopo che l’impressione cessa, ed è quella che chiamiamo idea [di sensazione]. Quest’idea di piacere o di dolore, quando torna ad operare sull’anima, produce le nuove impressio-ni di desiderio o di avversione, di speranza o di timore, che posso-no giustamente essere chiamate impressioni di riflessione, perché da esse derivano» (D. huMe, Trattato sulla natura umana, in Opere filosofiche I, Roma-Bari, Editori Laterza 1999, p. 19).
17 M.a. GriGnani, La costanza della ragione. Soggetto, ogget-to e testualità nella poesia italiana del Novecento, Novara, Interli-nea 2002, p. 134
Gabriele belletti354
sulla mia pelle il vento / d'una fanciulla pas-satami a fianco / di corsa», Sei ricordo d’esta-te, «c’è ancora qualche / sapore / del giubiloso soggiorno»). Emblematiche in questo senso le li-riche che aprono e chiudono la raccolta. La pri-ma, Marzo, canta il gesto dell’aprire18 attraverso un’impressione di sensazione, dove la fanciulla che apre la finestra si situa nel tempo presente e viene “vista” dal poeta, percepita: «ride il sole / bianco sui prati di marzo / a una fanciulla che apre19 la finestra» e termina con la chiusura, l’appannamento della finestra-memoria stessa («da me segreta ormai / silenziosa t’appanni / come nella memoria»), con un lasciare il ricor-do lontano (le idee di sensazione), senza più la possibilità di legarlo al presente, di ricordarlo, in modo da farlo tramutare in impressione di ri-flessione. Momento, questo, in cui la compre-senza di impressioni di sensazione e idee di sen-sazione viene a scemare, dopo che per tutto il corso della raccolta poetica vi è stato il tentativo di mescolare, ripopolare, il passato con la me-diazione delle impressioni di riflessione scatu-rite dal ricordo e agganciarle alle vivide impres-sioni del presente, quasi a voler tentare di non far chiudere il varco temporale e sensoriale, di rivivere esperienze rimanifestantesi e di mante-nere vive cantare le relazioni, i trapianti conti-nui, che sussistono tra memoria e dimensione presente20. Al contrario, sul finire della silloge,
18 Gesto che è definibile esso stesso istituzione letteraria no-vecentesca se si fa riferimento, ad esempio, alla raccolta dal titolo, appunto, Aprire, di Antonio Porta.
19 Il gesto dell’aprire è disseminato per tutta la silloge, ac-compagnato spesso dal gesto del nascere e da altri sinonimi: «frut-to appena sbucciato», «negli occhi nascono», «nasce sulle colline», «apre assonnati occhi», «sguscia obliquo / il sole», «fanciulla ap-pare, s’affaccia».
20 I movimenti e l’interazione tra passato e presente si ri-scontrano anche in altre opere del corpus poetico di Caproni, si veda quanto dice, ad esempio, De Robertis su Il seme del piange-
L’istituzione dell’espressivismo oggettuale 355
si verifica un annebbiamento21, quasi una ne-crosi della memoria – così come avverrà anche ne Il seme del piangere, in cui si canta di Anni-na e dello «svanire dei suoi ricordi»22, dove «la fi-gura dell’immaginazione […] soccombe, in una nuova morte del passato»23 – è un lasciare anda-re i vividi pensieri ancorati alla dimensione del tempo trascorso, senza poterli più attualizzare nel presente, come se tutto sia stato un’illusio-ne costruita attraverso «il gioco indistinto del-le rime e degli espedienti formali tradizionali a suggerire fortemente, sottolineando il carattere di artificio del fare poetico, quel sentimento del-la poesia come inganno e illusione che è uno de-gli aspetti più sottili e inquietanti di Caproni»24. Sembra esserci un Tu biograficamente esistito dietro questa duplice necessità, da un lato di richiamare, rivivere determinate impressioni e, dall’altro, di distanziarsene col procedere della raccolta, dovuto a quello che Colangelo chiama, riferendosi a raccolte più tarde – e che sembra costante già come istituzione nella prima raccol-ta caproniana – il «dramma della cronologia»25.
re: «si tratta […] di impressioni, immagini, ricordi con figure, fram-menti […] di volta in volta in un comporre più spazioso, e insieme stretto, che la memoria esalta» (G. de robertis, Il seme del piange-re, in Altro Novecento, Firenze, Le Monnier 1962, p. 484)
21 Si noti come, «il mutismo, la perdita della parola risoluti-va e cominucativa, è un tema che ha fatto l’intea storia della poe-sia di Caproni» (s. ColanGelo, Il soggetto della poesia del Novecen-to italiano, Milano, Mondadori 2009, p. 80).
22 Cfr. Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, cit., p. 2023 s. ColanGelo, «Tra la mano e la spiga». Caute ipotesi su Ca-
proni, cit., p. 172.24 p. V. MenGaldo, Poeti italiani del Novecento, cit., p. 701.25 «Vi sono figure che tentano di ristabilire un contatto lun-
go un asse temporale (e familiare), che le disperde, invece, e le iso-la le une dalle altre» (s. ColanGelo, «Tra la mano e la spiga», cit., p. 174). Nel Congedo del viaggiatore cerimonioso addirittura «il col-loquio si è fatto muto, nella verificata impossibilità di dialogo, per assenza di interlocutori [...] come se l’alterità, davvero, si deline-asse sul filo della cancellazione, dell’assenza o dell’allusione, ad
Gabriele belletti356
Questo semi-celato Tu è quello di una donna – si veda come il genere femminile, al di là di que-sto specifico Tu, sia comunque ben rappresen-tato, anche in forme “secondarie” («una fanciul-la che apre la finestra», «risa di donne», «chia-re donne», «vento / d’una fanciulla») – questo Tu, si diceva, si fa ricordo appannato, si allon-tana, chiude la finestra e con essa il legame col presente, ci si distacca dalle idee di sensazione, quindi. Se la prima manifestazione del Tu fem-minile si palesa nel presente – nella lirica che da inizio alla raccolta – nel corso del corpus poetico è sempre fatta riemergere dalla memoria (Ricor-do, Dalla villa Doria, Sei ricordo d’estate, Dietro i vetri), per poi, in ultima istanza, ri-annegare in essa. È un modo di far rivivere un ricordo attor-niandolo da altre vivide reminiscenze e/o circo-stanze illuminate, rumorose e vivaci, un tenta-tivo di coinvolgere nei movimenti del presente ciò che invece è, irrimediabilmente, distante e segregato in una dimensione mentale e appan-nata. Perché, si ricorda qui, «il “qui e ora” non è per Caproni una condizione di cui ci si possa pacificamente compiacere»26. Le idee di sensa-zione sono sempre più difficili da rievocare e le impressioni smettono gradualmente, per volon-tà poetica – quasi, anticipando l’inevitabile di-menticanza e i meccanismi tragici della memo-ria, a volersi tutelare dal dolore – di emoziona-re, “toccare” sensorialmente il poeta e lo lascia-no ammutolito di fronte al vuoto, all’inesorabi-le dettame selezionatore della memoria – dovu-to sia a una volontà di dimenticare, sia alla na-turale perdita di contenuti mentali – iscrivibile nella sua “teologia negativa”.
avvalorare, tra io, egli, noi, una solitudine senza scampo» (n. lo-renzini, Il presente della poesia. 1960-1990, cit., pp. 84-85).
26 I. CalVino, Nel cielo dei pipistrelli, in «La Repubblica», 19 dicembre 1980
L’istituzione dell’espressivismo oggettuale 357
È altresì interessante verificare come, nel-la silloge, oltre a manifestarsi l’incontro tra dif-ferenti dimensioni temporali e spaziali, esista-no veri e propri “conduttori”, “trasportatori” fa-cilitanti i trapianti dimensionali stessi. Le im-pressioni più ricorrenti – siano esse di sensa-zione o di riflessione – sono quelle aventi a che fare con l’aria, in particolar modo col vento e col fumo27, i quali, espandendosi ed essendo con-tinuamente mobili, si fanno materia-collante, permettono l’incontro, cioè, tra l’oggetto da cui queste “correnti”, più o meno durevoli, vengono prodotte e l’ambiente e i partecipanti della “sce-na poetica” – tra cui anche lo stesso poeta che si fa io-personaggio. È una sorta di estensione delle dimensioni che, tramite queste collanti, si prolungano, si espandono, si slabbrano. Così si affaccia una costellazione ariosa e coinvolgen-te di elementi, quasi topoi della raccolta: «fiato del fieno bagnato», «pianura ventosa», «nel ven-to è vivo / un fiato di bocche», un fresco / ven-to che sala il viso», «nel soffio / della sua bocca sento / quant’è labile il fiato / del giorno», «cal-de / folate, di sugheri arsi / e di fumo», «voci e canzoni cancella / la brezza», «nel vento che si accalora», «spira l’odor dei fumi». Anche la luce ha la stessa funzione mescolatoria del fumo, sia per quanto riguarda la possibilità di una conti-nua mutevolezza delle sfumature degli oggetti/soggetti, dovuta al variare dei momenti del gior-no cantati, sia per quel che corncerne i bagliori, i fuochi prodotti dall’uomo stesso, i quali han-no conseguenze nel paesaggio («infiamma anco-ra / la gota del prato», «chiari fuochi / festo-si», «nasce sulle colline […] la prima luce», «notte che sbianca», «s’illuminano come esclamate, / ad ogni scoppio di razzo, / le chiare donne», «so-
27 Si ricordino qui altri topoi caproniani, quali la nebbia ne Il seme del piangere.
Gabriele belletti358
pra un’illuminata / pelle di giovani donne. Si è spento: sbiadisce il giorno, cade / l’ultimo lem-bo di sole»). Interessante è rilevare come spes-so, nella medesima lirica, si colgano “in diret-ta” – proprio grazie a tali “conduttori” dimensio-nali – i passaggi da un momento della giorna-ta a un altro e, di conseguenza, i cambiamen-ti di luminosità, di sfumatura: «l’aria s’arancia» vs. «vedere / ogni uccello mutarsi in stella / nel cielo», Fine di giorno, «chiari fuochi / festosi» vs. «fra poco il fuoco / si spenge». Attuando ulterio-ri rilievi di struttura nella poetica implicita del-la raccolta caproniana si appura come sia fre-quente un ulteriore stratagemma “impressioni-stico” per dare all’istituzione del trapianto una valenza cardinale: nelle liriche sono immessi veri e propri grumi contrapposti semanticamen-te – oltre, come suddetto, acusticamente. Sono riscontrabili, cioè, binomi, contrasti giustappo-sti, stati sensoriali che regolano una continua trasformazione – ancora – degli oggetti/soggetti cantati. Emerge un coagulo principale, riassu-mibile, in maniera quasi eraclitea, col binomio di ancipiti caldo / freddo: «fiato del fieno bagna-to» vs. «ride il sole», «infiamma ancora / la gota del prato» vs. «nel vento è vivo / un fiato di boc-che accaldate», «bruciò il tuo viso / dal caldo sangue» vs. «dove recava il sentiero / umido», «chiari fuochi / festosi» vs. «sento ancora / fre-sco sulla mia pelle il vento», «nel vento che si ac-calora / di risa sui maturi fieni», «nella frescura un suono / da sonagliere randagie / di cavalle in sudore».
L’istituzione dell’espressivismo oggettuale nel primo Caproni - The institution of the espressivismo ogget-tuale in the first Caproni
Gabriele Belletti
L’articolo rileva nella prima raccolta capro-niana, Come un’allego-ria, l’istituzione dell’e-spressivismo oggettua-le, declinazione del-la novecentesca poeti-ca degli oggetti. Si indi-vidua, cioè, un’interdi-pendenza tra ciò che il poeta percepisce, sente, e ciò che tali percezio-ni fanno germinare nel paesaggio in cui abita – sia esso interiore o este-riore – o viceversa. Tale espressivismo è ade-rente a una istituzio-ne di più ampio respi-ro, quella del trapianto/mutazione, che il poe-ta adotta per la misce-lazione intenzionale di soggetto e oggetto e che si accompagna ad al-tre istituzioni, come, ad esempio, il fonosimboli-smo. Per rilevare i mo-vimenti dimensionali, l’autore si avvale di ca-tegorie prodotte in seno all’empirismo inglese – nello specifico all’empi-rismo humeano – come quelle di impressione di sensazione e di impres-sione di riflessione.
In his first book, Come un’allegoria, Capro-ni makes use of what is called espressivis-mo oggettuale, a decli-nation of the 1900s po-etica dell’oggetto. There is an interdependence between what the poet perceives, feels, and what these perceptions create in the landscape where he lives – be it internal or external – or vice versa. The espres-sivismo is related to another institution, the trapianto/mutazione, which the poet adopts to mix intentionally the subject and the object and it is accompanied by particular modes of fonosymbolism. To de-tect these dimensional movements, the author of the article adopts some categories of the empiricism – specifi-cally of Humean em-piricism – such as im-pressions of sensation and impressions of re-flection.
Riassunto - Abstact
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 361-383
IlarIa MarIa roMIlIo
Tra Laborintus e Storie naturali: modalità del corpo sterile
Ogni scrittura richiede un tempo di gesta-zione, e di quel tempo reca sempre in sé i segni. Maneggiare i detriti di una socie-
tà – corpo collettivo – involucro malato di merci corrose è stato per gli esordi in versi di Edoardo Sanguineti quel tempo fecondo. Laborintus è non solo l’imprescindibile punto di partenza di un ostinato e compatto percorso di attraversamento del presente lungo i confini del corpo, ma anche, e oggi ancora di più, un ottimo strumento otti-co per rileggere a ritroso una scrittura della sto-ria e di una storia umana, di una sorta di com-media tragicamente non morale, materialmente diaristica, eppure anonima: risalendo alle origi-ni di un corpo comune, esaminato nelle sue fun-zioni di base, reiette, rimosse in genere dalla pro-nuncia ad alta voce, e riportando l’io al suo pri-mitivo azzeramento linguistico, l’operazione del poeta combacia con la direzione dello sguardo di chi la rilegge oggi e si esprime dunque, tuttora, nella sua compiutezza. Ridisporsi cioè all’ascolto di Laborintus non significa tanto rivolgersi profe-ticamente all’indietro quanto considerare la di-mensione finita di quella stesura circolare, glo-bale, che bloccava il presente come sotto forma-lina e che poteva pertanto già ritenersi esaurita.
Quella di Sanguineti è da subito una pa-rola chiusa nei suoi contorni quotidiani – an-che quando è settoriale o desueta – ossia nella sua impraticabilità, ma che claustrofobicamen-te cerca di superare la porosità delle membrane fisiche, contingenti della lingua, col risultato di sfrangiarsi lungo il verso e di lasciarvi dissemi-
IlarIa MarIa roMIlIo362
nate parti di sé, sotto forma di incisioni lessicali e di desquamazioni sintattiche. Ma prima che sia la parola ad agire, tra l’elasticità e la secchezza dello spazio verbale, è il corpo a porsi come stru-mento permeabile di espressione della realtà, e ancora prima, è il corpo nel suo esserci a darsi come sostanza muta e a rivelarsi solo in un se-condo tempo attraverso la forma. Tra questi limiti si realizza la sterilità: nel nucleo vuoto dell’uomo, in organi cavi, l’attrito tra presenza e insufficien-za di sé è materia costante di scontro con l’inca-pacità di creare dal nulla. Sulla procreazione si misura l’esiguità dell’io, la sua quantificabile sot-tigliezza, quasi a trasformare l’ossessione capita-lista per la produzione in una nuova economia del corpo: entrambe si scoprono deficitarie. La sterilità in Laborintus è propriamente fisiologica e in questo senso naturale, come avviene prima della maturazione sessuale – tutti nasciamo ste-rili – ma è già avvertita come definitiva, patolo-gica. Il soggetto non giunge mai ad una condi-zione fertile, dunque è già confinato nell’ultima fase della vita; pur risolvendosi in disfacimento, è un’assenza a priori, determinata dalla storia.
L’espulsione del soggetto è istinto fisico e insieme atto di coscienza necessario alla pe-netrazione della realtà abortiva segnata dall’e-splosione atomica. Se infatti, come scriveva Ro-land Barthes nel 1967, «il mondo capitalista, il mondo morale, il nostro mondo, è letteralmen-te abietto: da respingere»1, non solo l’io si sco-pre scoria ingombrante, smaltimento anomalo, ma lo fa attraverso una lingua morta (e lingue morte, anche), incancrenita, sterile: «è proprio la forma stessa dello scrittore – continuava Bar-
1 Barthes presentava Sanguineti per il Catalogo Feltrinel-li. R. Barthes, Edoardo Sanguineti visto da Roland Barthes, in N. Lorenzini - E. Risso (a cura di), Album Sanguineti, Lecce, Manni 2002, p. 18.
Tra Laborintus e Storie naturali 363
thes – che, presto o tardi, dovrà venir coinvol-ta nella sua stessa critica del mondo: la lingua mediante cui si oppone il rifiuto, derivando ap-punto da ciò che si rifiuta, dev’essere a sua vol-ta rifiutata»2. Il senso del dire «io» è negato, pri-ma di ogni intento poetico, dall’impossibilità di riproduzione del corpo, dalla sterilità appunto, dalla mutilazione fisica generate concretamente da Hiroshima. L’assenza minaccia poi la stessa ripetizione linguistica, la creazione formale del sé, se la lingua è corpo. Esso si aggira, sgravato e ormai semi-cadaverico, nel budello di una re-altà analogamente sgravata di pesi, dove rista-gnano ineliminabili residui organici. La putrefa-zione che contamina ogni elemento, ogni atomo del paesaggio – linguistico, culturale, sociale in definitiva – sfalda un io già sezionato, decompo-sto, di cui non si ritrova più la versione integra: Erminio Risso sottolinea come, proseguendo l’o-perazione di dissezione artaudiana, Sanguineti giunga in quel testo ad un «linguaggio degli or-gani senza corpo, di parte che però non vale più metonimicamente per il tutto, ma piuttosto spa-zio di carne dove si registrano le trasformazioni storico-sociali»3. È un corpo tracciato al limite tra vita e morte, in un’ibrida fase di composizio-ne e dissolvimento, «confine organico sepolcro»4, entro il cui profilo terroso si depositano, sca-vando, materiali della realtà in potenziale ger-minazione: ma l’attecchimento si risolve poi in «orinazione dell’encefalo»5, in sporca secrezione linguistica. Allora è anche «il materiale verbale dell’Eliogabalo di Artaud, […] escrementi, me-
2 Ibidem.3 E. rIsso, Laborintus di Edoardo Sanguineti: testo e com-
mento, Lecce, Manni 2006, p. 18.4 Laborintus 2; in E. sanguInetI, Laborintus, Varese, Magen-
ta 1956, ora in Id., Segnalibro. Poesie 1951-1981, Milano, Feltri-nelli 1982, p. 14.
5 Ibidem.
IlarIa MarIa roMIlIo364
struo, sperma ed altri liquidi corporali»6 a com-porre l’impasto solido dell’uomo, a definirne il perimetro sotteso tra scarti e funzioni vitali.
Attraverso la viscidità del soggetto e la pa-ludosità della lingua il labirinto rivela la sua anima fermentativa e antifermentativa, dove l’a-nima, anzi, «le anime» vengono ricondotte a una consapevolezza tutta terrena: «l’accelerata evo-cazione delle anime procede mediante l’appara-to / escretorio per eccellenza che suggella ri-tualmente il sacrificio / dello sperma […]»7. Ol-tre alle antiche leggende che affidano alla luna tanto i morti quanto il liquido seminale e oltre all’affinità tra escrezione e sessualità suggerita dalla psicoanalisi, il richiamo è proprio ad una fisicità bassa, basilare, nucleare che, alla luce di un protagonismo esclusivo nelle opere a veni-re, perde ogni residua sublimazione. L’individuo non è altro che materia immersa nella materia, a formare un collage di cose composite dal qua-le, come dal brodo primordiale o da un corpo ri-dotto a fango, potrebbe crearsi qualche forma di vita – o di linguaggio – anche se larvale, amebi-ca. Ormai prossimo alla «riduzione al verme lu-cido / e nero […]»8, tra cadavere e feto, il cor-po si prosciuga in un non-luogo di collosa de-composizione e di impenetrabile procreazione, nell’ossessivo tentativo di generare senso por-tato avanti da una lingua-madre che si ripete:
[…]livida nascitur bene strutturata Palus; lividissima (lividis-sima terra)(lividissima): cuius aqua est livida; (aqua) nascitur! (aqua) lividissima!et omnia corpora oh strutture! corpora o strutture mor-tuorum
6 E. rIsso, op. cit., p. 90.7 Laborintus 3; in E. sanguInetI, Segnalibro, cit., p. 15.8 Laborintus 7; ivi, p. 22.
Tra Laborintus e Storie naturali 365
corpora mortua o strutture putrescunt; generantur! amori![…]generazione tu! liquore liquore tu! lividissima mater9:
Come il non-luogo si caratterizza per non essere né identitario né relazionale né storico, il mondo post-atomico, pur conservando fram-menti minimi di esistenza dell’io, rileva l’azze-ramento dei valori vitali, disseminato com’è di corpi anonimi, di «strutture» che tentano la ri-produzione attraverso il linguaggio. Ma questa è destinata a fallire, non potendo trovare un ter-reno fecondo nel paesaggio contemporaneo del corpo. La sterilità ne contamina ogni aspetto: più che da immagini solide e stabili, la morfo-logia dello spazio è consegnata alla sottile linea (grafica e semantica insieme) della punteggia-tura, che nel suo rarefarsi o infittirsi diventa segnale sismico di un’attività intermittente, se non di una radioattività più o meno sommersa. I segni di interpunzione oscillano tra operazio-ni di taglio e di cucitura del testo, intervenen-do comunque chirurgicamente e quindi doloro-samente su di esso, anche quando la superficie è intatta, lasciata al suo tessuto fluido: è pro-prio l’assenza a farsi pesante alienazione, pri-vazione di legami nutritivi, di cordoni ombelica-li tra le parole. «Se Laborintus è il resoconto di una schizofrenia, questa schizofrenia è quella della realtà effettuale […]: una situazione psico-patologica collettiva, prodotta dalla realtà ma-teriale, dalle condizioni sensibili di vita»10, scri-ve sempre Risso. La sterilità si presenta pertan-to come paradigma tangibile del presente, inca-pace di produrre individui a loro volta prolifici, laddove paradossalmente la società neocapita-lista esige una produttività esasperata. È anzi
9 Laborintus 26; ivi, p. 47.10 E. rIsso, op. cit., p. 40.
IlarIa MarIa roMIlIo366
esattamente questa dissennata ansia da presta-zione, che fa dell’uomo una merce, ad affligge-re «quelli che non sanno crescere», destinati a moltiplicarsi in «quelli che non possono cresce-re», «quelli che non devono crescere», fino alla constatazione asettica e crudele di una colletti-va castrazione: «in questo tempo / noi che non dobbiamo crescere»11.
L’unione tra io e mondo può avvenire sol-tanto nella fisicità, attraverso una fecondazione assistita dal linguaggio, mezzo primo di media-zione con la realtà, salvo poi risolversi spesso in aborto spontaneo. Sebbene infatti la lingua sia contatto, gesto, protrusione diretta all’esterno, il raggiungimento di un rapporto completo con le cose è destinato a fallire o a generare ibri-di incastrati tra pronuncia ed espulsione. È già una «poesia vescicosa»12 – come sarà più avan-ti in Glosse – un prodotto deforme che il cor-po crea somaticamente, senza riuscire a farne strumento efficace di comunicazione. Se il cor-po è detrito tra i detriti, è atomizzato, è disorga-nico, la sterilità non ne è la conseguenza, bensì la causa; nell’impossibilità a covare, nutrire, a farsi «tana» (e allora sì che «è la fine, sul serio»13) il corpo non ha che da sfaldarsi:
abbiamo parlato più volte del frantumarsi del soggetto, ma noi stiamo assistendo anche a un frantumarsi del corpo. In fondo abbiamo sentito sempre il corpo come qualcosa di compatto e unitario. L’anima poteva dividersi, ma il cor-po è stato un poco il rifugio del soggetto, anche involonta-riamente14.
11 Laborintus 6; in E. sanguInetI, Segnalibro, cit., p. 19.12 Glosse 14; in E. sanguInetI, Il gatto lupesco. Poesie 1982-
2001, Milano, Feltrinelli 2002, p. 122.13 Cose 8; ivi, p. 346.14 E. sanguInetI, Sanguineti/Novecento: conversazioni sulla
cultura del ventesimo secolo, a cura di G. Galletta, Genova, Il me-langolo 2005, p. 108.
Tra Laborintus e Storie naturali 367
Il senso ultimo, l’eventuale riserva dell’uo-mo sta proprio nel corpo e nella sua possibili-tà di riprodursi, di non finire materialmente con la propria morte: se ciò viene negato, non resta più nulla. Il vuoto del soggetto è esposto al rico-noscimento, la sua inutilità al rischio della tau-tologia o dell’ecolalia: «erano appunto le propag-gini propedeutiche della mia vita / (aspettando la mia vita) che intendevo illustrare / (passe-rò oltrepasserò la mia vita)»15. Solo aderendo al dato fisico, all’immediato esserci, a una carna-lità, come scrive Niva Lorenzini, «per nulla evo-cativa né evasiva»16, l’io può trovare uno spazio da riempire, non di senso ma con i sensi, con un consistente «liquame del mio me»17, a metà tra fecondità e scarto organico: «la storia dell’Io non è tanto la storia di una coscienza, quanto la storia di un corpo e delle sue pulsioni […]. Così il corpo acquista storicità». La vita è agita dalla materia, che allo stesso tempo è plasmata dal-la realtà quotidiana, poiché – continua Sangui-neti – «l’esperienza corporea non è un’esperien-za naturale»18; le spinte plastiche della cultura immergono il linguaggio nel corpo, ne fanno un prodotto storicamente collocabile («la parola è concretamente […] una ideologia nella forma del linguaggio»19). È il nuoto non a caso a proporsi come probabile paradigma di un incontro ferti-le tra soggetto da un lato e spazio-tempo dall’al-tro: non è solo gesto istintivo nella Palude («tu e tu mio spazioso corpo / di flogisto che ti alzi e ti
15 Laborintus 4; in E. sanguInetI, Segnalibro, cit., p. 17.16 N. lorenzInI, La poesia: tecniche di ascolto. Ungaretti Ros-
selli Sereni Porta Zanzotto Sanguineti, Lecce, Manni 2003, p. 213. 17 Codicillo 4; in E. sanguInetI, Il gatto lupesco, cit., p. 14.18 E. sanguInetI, Sanguineti/Novecento: conversazioni sulla
cultura del ventesimo secolo, cit., p. 104-105.19 E. sanguInetI, Per una letteratura della crudeltà, in Id., Ide-
ologia e linguaggio, a cura di E. Risso, Milano, Feltrinelli 2001, p. 109.
IlarIa MarIa roMIlIo368
materializzi nell’idea del nuoto»20) ma anche atto consapevole, se di nuovo, più tardi, Sanguineti scriverà che «il precetto è: nuotare naturalmen-te dentro / la storia»21. Il nuoto riporta natural-mente ad un movimento di dimensione intrau-terina, prenatale, forma dunque di sopravvi-venza istintiva; d’altra parte non esiste un luo-go protetto per l’io, e il tempo di gestazione su-bisce ugualmente formazioni anomale, concre-zioni malate a metà tra non-nati disfatti e mor-ti intatti. L’acqua in Laborintus è liquido amnio-tico, estensione feconda, ma è insieme sostan-za fluida in cui disfacimento e ricomposizione si amalgamano – in modo non del tutto estraneo a quanto avviene sempre nel liquido amniotico, dove convivono nutrimento e desquamazioni fe-tali – secondo un ciclo patogeno di incubazioni e mutazioni:
[…]mia costale corteccia eventuale mia flora tumore dome-sticoproporzionale e regno parco subacqueo aut lente ruolo di ruota deambulabistriste ruota e stridente e grinzoso chi partorirà in una barae sibilante chi nascerà morto semplicee conclusa (detta ironia tecnica)durante dondolanti globi carnosi tubulati crudi cubidolce mucosa[…]22
È un nuoto tra arti e organi sparsi, o me-glio un nuoto di arti tra arti, quasi in un ma-gazzino di parti del corpo o in un laboratorio di raccolta di residui chirurgici. Il risultato è infat-ti un «montaggio di organi»23, assemblati però al di fuori di una catena, così come in disor-
20 Laborintus 1; in E. sanguInetI, Segnalibro, cit., p. 13. 21 Stracciafoglio 3; ivi, p. 233.22 Laborintus 9; in E. sanguInetI, Segnalibro, cit., p. 24.23 E. rIsso, op. cit., p. 18.
Tra Laborintus e Storie naturali 369
dine appaiono le parti del discorso: sono pez-zi di corpo e pezzi di lingua a ibridarsi nel ven-tre di una realtà cancerogena, pericolosamente gravida, forse già extra-uterina. La lingua si fa in parallelo levatrice sgocciolante parole come cellule sfaldate, membrane squamate da «can-crena», «tessuto mortificato», «casa necrotica», «libero carcinoma»24. Quello ulcerato, straziato, che va decomponendosi sulla pagina, potreb-be effettivamente essere un corpo che ha vis-suto l’esplosione atomica; l’intero Laborintus è colpito da «distorsioni relative di fronte a lun-ghi funghi fumosi / che si gonfiano», e si trat-ta appunto di un’«ustione linguistica»25, di nuo-vo dell’epidermico impasto di linguaggio-io-sto-ria. Se la «bella sintassi del mio corpo»26 – scrive ancora Sanguineti – è infettata, escoriata, non c’è superficie dove ancorarsi: il corpo è la pagi-na, dunque anch’essa viene contaminata. È la volta poi del soggetto, deformato e smembrato fino alla regressione grottesca a materia grez-za, contorno plastico primitivo, privo di conte-nuto: «l’inappartenenza del linguaggio al sogget-to, e del soggetto al linguaggio, obbliga il sog-getto, se voglia comunicare, a servirsi di paro-le d’altri. Accade così che l’altrui eserciti la fun-zione del proprio senza prenderne il luogo, ché luogo non v’è dove è il vuoto. E il vuoto lingui-stico, l’indigenza segnica sono la condizione di partenza di Laborintus»27. Sembra impossibile trovarvi, alla fine, proprio un «fetus; maximus fetus»28: del resto, sebbene la nascita signifi-chi l’emersione dalla palude e la felice espulsio-
24 Tutte le citazioni sono sempre da Laborintus, 9; in E. san-guInetI, Segnalibro, cit., p. 24.
25 Laborintus 2; ivi, p. 14.26 Laborintus 7; ivi, p. 21.27 F. CurI, Del patetico, in N. Lorenzini - E. Risso (a cura di),
Album Sanguineti, cit., p. 47.28 Laborintus 27; in E. sanguInetI, Segnalibro, cit., p. 48.
IlarIa MarIa roMIlIo370
ne di lingua e soggetto, restano cose «quae pin-gi non possunt»29, parti negate alla generazione del verbo, che il linguaggio – dantescamente – non riesce a toccare.
Le parole non arrivano alla realtà, alla sto-ria, allora è il testo-corpo a riversarla dall’inter-no, come accade molti anni dopo nei «materia-li» teatrali di Storie naturali: «se vuoi proprio che ci ritorna su, la vita, io dico che ci ritorna – ma come una minestra che ce la siamo digeriti male, non so – che c’è lo stomaco come in tempesta, con i crampi. – Insomma, quella è la vita che uno si vomita – questa, piuttosto»30. Sono le vi-scere a tenere dentro, a far fermentare, più che a far crescere, la vita come in una cavità uteri-na, sempre a rischio di vuoto, di incompletezza (e ancora la psicoanalisi interpreta certe patolo-gie, maschili e femminili, come il senso di pri-vazione, di difetto di un ventre che non genera). In Storie naturali infatti soggetti anonimi, defini-ti solo da lettere, inutilmente tentano di comu-nicare, di toccarsi, di agire, ma sono confina-ti in sacche cieche, senza legami, tanto che an-che il corpo è a rischio di scomparsa e deve con-tinuamente essere riconfermato dalla pronun-cia, quasi a scriversi addosso la sua storia. Nel buio divorante, chiuso in uno spazio che «è tut-to vuoto»31, il corpo deve essere creato dal nul-la, per assemblaggio cellulare, embrionale, ma ancora risulta abortivo. La fecondità sembra af-fidata unicamente alla voce: «quelle che impor-tano davvero, sono le parole. – […] sono come delle mani, sì. – Sono le mani per le cose che non ti puoi toccare. –»32. La lingua è gesto, coin-cide col tatto e porta avanti l’evidenza del cor-
29 Ibidem.30 E. sanguInetI, Storie naturali, Lecce, Manni 2005, p. 36.31 Ivi, p. 87.32 Ivi, p. 188.
Tra Laborintus e Storie naturali 371
po, che qui è invece oscurata agli occhi e all’e-sistenza stessa: costretta, prosciugata, al limi-te della sua pronunciabilità, in uno spazio com-presso da soggetti in bilico tra morti e non-nati, è una vita vissuta o forse ancora da vivere a cer-care in tutti i modi di uscire facendosi sentire, toccare. Già in Laborintus sembrava soprattutto la pelle a coprire la distanza dalle cose, a dare il senso di un’espansione fluida dei sensi sulla re-altà laddove essa si faceva più dura, rappresa, intoccabile («con l’epidermide intiera tocchiamo terra»33; «alta (dunque erettiva) eruzione del tat-to perché la vita è così insufficiente / […] / ho formulato molte ipotesi per vivere parlo di con-ferire decoro / al mio processo penso a un de-coro muscolare tattile abile di irritabilità / […] / e parole / ancora tagliano le labbra (io sono qui con un virtuoso discorso)»34), pur affrontando l’abrasione, la lesione, la lacerazione. È la pelle, cioè la carnalità più immediata, ad assorbire l’e-sperienza e a farne scrittura, attraverso un lin-guaggio che è materia, ideologia di un corpo vis-suto quotidianamente: «l’io è prima di tutto un corpo, la vita non è che la storia di un corpo»35.
Quando Sanguineti precisa che l’uomo «passa in modo coatto dall’orizzonte della na-tura all’orizzonte della cultura»36, pensa di cer-to anche ai conflitti che l’Es groddeckiano sfo-ga per via somatica, facendoli uscire attraver-so lo spazio sicuro ma sottile dell’involucro cu-taneo. Parallelamente Marshall McLuhan, nel-la Galassia Gutenberg, sosteneva che la scrit-tura fonetica avesse detribalizzato l’indivi-duo dividendo l’occhio dall’orecchio, provocan-
33 Laborintus 4; in E. sanguInetI, Segnalibro, cit., p. 17.34 Laborintus 5; ivi, p. 18.35 Nota di Sanguineti a Storie naturali, cit., p. 226.36 E. sanguInetI, Ritratto del Novecento, a cura di N. Lorenzi-
ni, Lecce, Manni 2009, p. 32.
IlarIa MarIa roMIlIo372
do così una reale «frattura» e rendendo l’uomo uno «schizofrenico»37. Questo perché, secondo il semiologo, «la scrittura è il muro di cinta di spa-zi e di sensi non-visivi. […] E mentre la parola è una estrinsecazione (articolazione) di tutti i sen-si simultaneamente, la scrittura è un’astrazio-ne della parola»38. Sul foglio si realizza insomma inevitabilmente un appiattimento, una riduzio-ne addirittura alla mono-dimensione, in cui la vista assume un controllo totale ma per sua na-tura distaccato: l’occhio non tocca ciò che vede o ciò che legge, mentre la parola parlata pren-de corpo nella gola, nella bocca e in tutti i suoi organi per poi andare a percuotere quelli dell’o-recchio. Sanguineti, prendendo atto esattamen-te di un «Io alfabeticamente organizzato, anzi al-fabeticamente traumatizzato»39, agisce in dire-zione di un recupero dei sensi, di una loro rein-carnazione nella pagina per evitare precisamen-te di chiuderla nella sublimazione della lettura; le parole devono farsi porose e penetrare il cor-po, entrare e uscire dai suoi tessuti per esse-re vissute. È così che, attraverso una forte vo-cazione non solo orale, bensì teatrale della po-esia, il poeta mette in scena un corpo che cer-ca di «praticarsi»40 la vita e il linguaggio, mate-rialmente. Nel teatro, ancora di più, Sanguineti rinforza la dimensione plastica della voce, poi-ché questa è «una produzione “corporea”: essa non è un veicolo per idealizzare l’esperienza […] della corporeità, ma è anzi uno strumento per
37 M. MCluhan, La Galassia Gutenberg. Nascita dell’uomo ti-pografico, Roma, Armando Armando Editore 1976, p. 47.
38 Ivi, p. 74.39 Il complesso di Cratilo; in E. sanguInetI, La missione del cri-
tico, Genova, Marietti 1987, p. 224.40 Scriverà in Postkarten 62: «la poesia è ancora praticabi-
le, probabilmente: io me la pratico, lo vedi, / in ogni caso, pratica-mente così: / con questa poesia molto quotidiana […]»; in E. san-guInetI, Segnalibro, cit., p. 222.
Tra Laborintus e Storie naturali 373
esprimerla in tutta la sua materialità»41. Non solo però la parola è generata dal corpo, come una sua appendice, una protesi carnosa, ma è pure essa stessa a generare la vita, secondo la compenetrazione lingua-corpo:
perché una voce è tutto – non so bene come dire, ades-so. – E se una voce non è niente, invece – se due voci non sono niente – se non esistono – allora, è che niente è nien-te, proprio. – E allora, è che anche la mia voce non è nien-te. – E io, che mi sento questa mia voce che non esiste – io ho lo spavento, qui […] Perché una voce che è una voce, quella ti fa il mondo. – Perché ti dice tutte le cose, ecco – non so bene come dire. – E ti dice il martello, il carciofo, la coda del gatto, l’Asia sud-orientale, un numero, due nu-meri, 30, 71. – Una voce che è una voce, quella ti riempie di tante e tante cose, intorno, dentro42.
La minaccia di disgregazione definitiva dell’io è incarnata dalla possibilità di annul-lamento della voce, quindi del corpo: la steri-lità risale fino all’ultimo strumento produtti-vo, all’unico prolungamento efficace rimasto. La parola si propone ancora come liquame, melma con cui plasmare il mondo, non certo in virtù di un suo potere demiurgico, bensì per la sua resi-dua capacità di generare significato nonostan-te il suo avanzato stato di disfacimento: «sai la frutta matura, marcia – mettiamo le pere, che si fanno tanto molli, piene di roba che è un po’ come un fango – una pastetta lì, che ti appic-cica tutte le dita – be’, io me la sento così, la mia testa, a pensarci. […] È come che mi mar-ciscono i pensieri, capisci»43. Tanto nel teatro quanto nella poesia di Sanguineti è proprio il linguaggio quotidiano, usato, masticato, a ca-
41 Un teatro anatomico. Conversazione con Edoardo Sangui-neti a cura di C. Longhi; in E. sanguInetI, Storie naturali, cit., p. 230.
42 E. sanguInetI, Storie naturali, cit., p. 153.43 Ivi, p. 96.
IlarIa MarIa roMIlIo374
ricarsi di senso, per il suo valore di atto fisiolo-gico, necessario. Gli accumuli di oggetti, di fat-ti, di nomi, insomma di cose che si depositano lungo le opere del poeta, costituiscono il ma-teriale storico ammassato ogni giorno nelle vi-scere dell’io, da espellere verbalmente, in modo più o meno sano («nelle mie feci fecondamen-te / sanguinolente»44); sono sempre quelle stes-se «cose» ad intaccare l’integrità del soggetto, a frammentarne il corpo. La voce è continuamen-te tesa tra saturazione e vuoto, o meglio la satu-razione si scopre di fatto vuoto: se in Laborintus la ripetizione ossessiva di segmenti di discorso – come nel caso di «sopra questo orizzonte» – si risolveva poi in «nulla di nulla», «negazione», «cerchio di nulla»45, in Storie naturali l’incessan-te presenza linguistica domina una visione az-zerata, effettivamente dissolta nel buio. È una «postura catatonica»46, come scrive Niva Loren-zini, già prossima a quella cadaverica («la vita è stare lunghi distesi, la testa al livello delle gi-nocchia, le ginocchia al livello dei piedi»47) ad in-contrare la dinamicità del linguaggio, il suo pro-lungarsi verso l’esterno; ma la voce ancora crea un soggetto segmentato, scomposto, a metà tra autopsia e fetazione deforme:
io, sono come uno che non è lì completo, invece, capisci. – Mettiamo uno che ci ha un braccio, che ci ha una coscia – un occhio – e tutto il resto, no – gli manca. – Sono dei pezzi che non ti fanno niente – nemmeno se ti metti lì a cucirli, uno con l’altro, lì insieme. – Allora, l’importante ti diventa il vuoto, diciamo così, mica il pieno. […] Ma sì, ci stavi me-glio con il vuoto, ecco, persino – con il vuoto lì completo48.
44 Cose 35; in E. sanguInetI, Il gatto lupesco, cit., p. 373.45 Tutte le citazioni sono da Laborintus, 16; in E. sanguInetI,
Segnalibro, cit., p. 35.46 N. lorenzInI, “Storie naturali”: istruzioni per l’uso, introdu-
zione a E. sanguInetI, Storie naturali, cit., p. 7.47 E. sanguInetI, Storie naturali, cit., p. 62.48 Ivi, p. 57-58.
Tra Laborintus e Storie naturali 375
Nel buio avvolgente, fibroso, come già nel-la palude, la materia può allo stesso modo for-marsi e sfaldarsi, e l’uomo non è che materia, né più né meno delle cose. Lo spazio prenatale viene a coincidere con quello ultratombale, non solo in quanto anch’esso non-luogo di pura fisi-cità, ma anche perché la vita non vi attecchisce: passa così a reintegrarsi nelle pareti assorben-ti del vuoto, fino alla scomparsa («come un pez-zo di ghiaccio che si scioglie – ma meno anco-ra che il ghiaccio, si capisce – come l’acqua che sta sciolta, magari – che evapora – ma meno – meno ancora che l’acqua – ecco, come il vapore che si perde, lì nell’aria – che nemmeno lo vedi – ma meno, sì – meno ancora che il vapore – molto meno, ancora – niente»49). È evidente che l’io è oggettivamente privato della possibilità di procreazione, essendo privo anche di se stesso; tuttavia inconsciamente scopre delle fantasie di gravidanza, proiettate su un corpo maschile – condannate quindi allo straniamento e al falli-mento – ma soprattutto su un corpo necrotico, tumido, tumorale:
U2 […] è vero che ti stai gonfiando tanto. Guarda lì.U1 La pancia?U2 Ma sì, la pancia lì.U1 Anche – anche sotto.U2 Sotto dove?U1 Ma sì, anche più sotto – di più – capisci?[…]U1 Eh, ma sto diventando anche un po’ fecondo, però – di-ciamo così.U2 […] Ma sarai sterile, tu, come – non lo so, come cosa50.
Non si tratta certo di un gonfiore gravido; al contrario, esso risulta tanto più allucina-to quanto più chiaramente isterico. È l’ultimo
49 Ivi, p. 215.50 Ivi, p. 31.
IlarIa MarIa roMIlIo376
atto di una volontà (pro)positiva del mondo, di un tentativo di riscatto dal ristagno del presen-te che dichiara in partenza la sua impraticabi-lità. In questo caso, poi, si assiste a una doppia negazione: la lingua crea un corpo che non può creare, così anch’essa si scontra con la propria infertilità. La parola nasce proprio dal bisogno fisico di contatto, di unione, di comunicazione in definitiva, e a questo scopo non bastano la boc-ca e l’orecchio, tutto il corpo viene coinvolto, tut-ti i sensi e tutti gli organi. Alla fine sembra che il parto avvenga con i due punti, ma non si conclu-de mai, di fatto, poiché essi si moltiplicano au-tonomamente, come per scissione, nel testo. Le parole restano suscettibili di vita propria, di mo-vimenti tangibili: «un produttore di testi non ha da vantare privilegio alcuno sopra i sensi che un proprio testo, una volta partorito, produce per forza propria, come dispositivo autogeno, cam-minando sopra le proprie gambe robotiche»51, ri-conosceva il poeta stesso. La lingua è una prote-si meccanica e vitale del corpo, nell’ibridazione che caratterizza genitori e figli; allora anche un uomo può legittimamente partorire. Groddeck sosteneva che nell’essere umano la compresen-za repressa dell’elemento maschile e femminile – e qui si potrebbe tornare a Laborintus – gene-ra squilibri e fratture, e che «l’unica cosa strana nell’idea di un uomo di avere un bambino è che essa venga così accanitamente negata»: «anche l’uomo più mascolino – scrive – non si vergogna di dire che ha dei pensieri in gestazione, parla delle creature del suo cervello, e definisce “par-to difficile” il frutto di un lavoro faticoso»52. Per Sanguineti non si tratta semplicemente di proie-
51 La missione del critico; in E. sanguInetI, La missione del cri-tico, cit., p. 205.
52 G. groddeCk, Il libro dell’Es. Lettere di psicoanalisi a un’a-mica, Milano, Adelphi 1966, p. 18-19.
Tra Laborintus e Storie naturali 377
zioni metaforiche, quanto della precisa consape-volezza di un potere creativo stroncato da condi-zioni fattuali ineliminabili:
non so che senso mi può avere (né se può avermi un sen-so, nemmeno) questo miorattrappirmi irriflesso:scavando e riscavando, tuttavia, si arriva a strati, qui,che oso defirnire monacali, ancora quasi intatti: (e a trat-ti, e forse a forza,al più, toccati occasionalmente, accidentalmente, in pas-sato): (e poi, di nuovo,precipitosamente risepolti): (anche a falde uterine, se mi ostino, giù, molli):[…]53
Il corpo si trova sempre a metà tra fangosi-tà e trasparenza, tra decadimento e leggibilità, come unica realtà fedele in quanto oggetto con-creto, terreno di valutazione oggettiva. Il sog-getto continua ad acquisire autonomia acuen-do precisamente il suo stato di “cosificazione”, diventando materiale storico-linguistico esso stesso: l’azione livellante della storia assotti-glia l’io fino a farlo coincidere con la carta o con «una specie di striscia dura, tracciata con un pennarello»54, completando in questo modo la compenetrazione testo-corpo. La reazione però non è l’appiattimento, al contrario un acuirsi di tutti i sensi, forse nell’illusione di un recupe-ro di organicità e di unità del corpo, che appare spezzato comunque dalle incisioni grafiche del-la lingua: «io devo (a me stesso, dissi); la figu-ra essere; una giustificazione; / (illustrazione); della disperazione; una spiegazione devo; del-la storica / impartecipazione (patita) alla sto-ria: / della sofferta alienazione55». La pronun-
53 Scartabello 9; in E. sanguInetI, Segnalibro, cit., p. 291.54 Postkarten 38; ivi, p. 198.55 Purgatorio de l’Inferno 2; ivi, p. 73.
IlarIa MarIa roMIlIo378
cia è tesa a contrastare ancora l’«ipertrofia dello sguardo, e cioè della coscienza […] direttamen-te proporzionale alla distrofia dello spessore vi-tale» e dunque a smentire l’idea che «l’io – conti-nua Elio Gioanola – può sopravvivere solo a pat-to di salvare la propria “distanza” raziocinante, allontanandosi dall’esternità del mondo sporco, disordinato, viscerale»56. Sanguineti punta pro-prio all’opposto: la sua è un’adesione bassa al corpo e ai suoi umori, tanto da arrivare a defi-nire la poesia «una macchina organica», «rigo-rosamente fisiologica», che contempla peraltro i «nove mesi da gestante classica»57. La consta-tazione dell’improduttività del linguaggio – e del soggetto – genera talvolta scissione, ma si trat-ta sempre di fatto fisico, esaltato anzi dalla se-parazione: «a futura memoria scrivo (e vivo): / ma scrivendo (e vivendo) […] / […] quello che ho scritto è scritto (e ho vissuto il vissuto che ho vissuto)»58. La scrittura non è dunque ripetizio-ne di sé – e in questo non può essere feconda – e non è neanche, poi, atto di parola, se con esso si intende unicamente la trasposizione di pensie-ri; è il corpo ad allestire un «teatro del tatto»59, incisi su di sé i segni di una vita quotidiana, di dettagli da appuntarsi: «preparandomi la pelle, come un’oleosa lavagnetta magica / (e magne-tica): / […] perché il mio corpo è un testo, ve-ramente, / vivente, da cima a fondo»60. Il voler-si imprimere la realtà addosso, tatuarsela dolo-rosamente deriva dall’essere ricoperti di corpo, come un’espansione ingombrante, una protru-sione ineliminabile («che casino, il corpo! – Che
56 E. gIoanola, Tuo per sempre vivente inesistente, in N. Lo-renzini - E. Risso (a cura di), Album Sanguineti, cit., p. 91.
57 Cose 18; in E. sanguInetI, Il gatto lupesco, cit., p. 356.58 Codicillo 2; in E. sanguInetI, Il gatto lupesco, cit., p. 12. 59 Nota di Sanguineti a Storie naturali, cit., p. 225.60 Stracciafoglio, 45; in E. sanguInetI, Segnalibro, cit., p. 276.
Tra Laborintus e Storie naturali 379
uno se lo trascina sempre addosso, anche se non ci ha voglia»61).
Il percorso poetico di Sanguineti prosegue verso un ulteriore smembramento tragicomico del testo-corpo, verso una vera dissezione anzi, operata ludicamente sulla scena della pagina. È un nuovo «teatro anatomico»62 anche quello degli organi che i vari Stracciafoglio, Scartabel-lo, Codicillo e simili costituiscono, proprio come prolungamento cartaceo, e di scarto soprattut-to, del poeta; quasi a cercare di ritrovare nella tradizione amanuense – per McLuhan «intensa-mente audio-tattile», anzi espressamente carat-terizzata dalla «partecipazione di tutti i sensi»63 – un contatto diretto, carnale, fertile tra individuo e realtà, pur risolto sardonicamente nel nulla:
questo mio me, questo straccio di carta uso bollo, formato protocollo, piegatoe ripiegato a francobollo: (le quattro volte, le sedici, le ses-santaquattro: questomio me che fu già in folio, in quarto, in sedicesimo: questo mio me, qui mein sessantaquattresimo: in un ennesimo, qui ridicolo, mi-nimo): tu puoi cavarciun ochettino, un aeroplanino: (puoi sforbiciarci qui un lembo, un pochino:produrci un girotondino di netti pupazzetti cartilaginosi-netti: estrarciuna quaterna, ma non di più: con l’ultima creatura lì in tutù):[…]64
Il soggetto si scopre solo linguaggio, prodot-to di serie destinato al consumo, all’esaurimen-to veloce. Ma Sanguineti va oltre una tragicità
61 E. sanguInetI, Storie naturali, cit., p. 68.62 La philosophie dans le théâtre, Fanerografie; in E. sanguI-
netI, Il gatto lupesco, cit., p. 195.63 M. MCluhan, op. cit., p. 55.64 Codicillo, 5; in E. sanguInetI, Il gatto lupesco, cit., p. 15.
IlarIa MarIa roMIlIo380
chiusa in se stessa: la sua presa di coscienza è talmente profonda da poter affrontare questo annichilimento con la libertà dell’ironia, la leg-gerezza del fou rire del poeta-acrobata, che del-la propria lingua-corpo fa divertimento, trave-stimento giocoso. Destreggiandosi tra gli osta-coli del linguaggio come tra quelli della realtà, egli riesce ad attraversarli con lo spirito del gat-to lupesco, viaggiatore dissacrante che accumu-la incontri, conversazioni, avvenimenti del mon-do, destinati a travestirsi anch’essi, come «ma-teriale fabbricabile»65 per la poesia. E se dunque «il significato dell’arte, evidentemente, è quello di interpretare le infinite forme dell’esperienza umana, così come storicamente si verificano»66, l’aderenza agli eventi aumenta nel caos da essi generato, compattato però da una comune con-dizione residuale. Il linguaggio – scomposto anch’esso, come sono gli arti spostati dalla loro corretta e sana posizione – va a comporre il luo-go d’azione della poesia, allo stesso tempo non-luogo: spazio di scorie e secrezioni corporee che il testo-corpo trascina, sparge, come unica iden-tità possibile («mi tiro dietro questi versi come una porta, sbattendomeli, per chiudermici den-tro: / perché, appunto, uno non può spezzettar-si troppo»67). È proprio il corpo a secernere il lin-guaggio, ad espellerlo, non più che escremento; in questo è comunque segno vitale, prova tangi-bile di essenza: «in principio è il silenzio: / (poi si è fatto saliva, muco, sangue, sudore, orina): / (si è fatto sperma, merda): (e gesto)68». In fon-do anche il parto non è altro che un’espulsione
65 E. Sanguineti - A. Gnoli (a cura di), op. cit., p. 20.66 E. sanguInetI, Sanguineti/Novecento: conversazioni sulla
cultura del ventesimo secolo, cit., p. 63.67 Stracciafoglio 33; in E. sanguInetI, Segnalibro, cit., p. 264.68 Premessa (Poesie fuggitive 1996-2001); in E. sanguInetI, Il
gatto lupesco, cit., p. 444.
Tra Laborintus e Storie naturali 381
viscerale, e allora anche la deiezione sarà gesto fecondo, a suo modo:
la poesia, che fu già esprimibile come un’escrezione, una scremata secrezione[mentale(come un’organica escrescenza notoriamente improdutti-va), è uno schiumoso[escremento,oggi: (e dice, in conclusione, deiezione):manifesti così la tua natura, è probabile:non sei, non sarai mai, però, il proverbiale baco della seta: (anche se, defecandoi tuoi versi, ti imbozzoli comunque, per progressivi aggiu-stamenti lenti, dentrola sarcofagica tua discarica verbale):svendo (sterline 5) un copròlito fatto di parole69:
I detriti della Palude sono prosciugati in un unico impasto verbale, come se la consistenza melmosa si andasse seccando, rendendo più dura la massa; è ancora un io putrido, oggetto di rifiuto, ad offrirsi come materiale da labora-torio, campione ultimo di un’umanità in via di decomposizione. La dissezione è dunque anche verifica, analisi, registro (linguistico, anche): se ne occupano in particolare le parentesi e i due punti, che si moltiplicano come piaghe nel te-sto-corpo, incidendo lo spazio dell’esperienza e della pagina. Se i due punti aprono ulterior-mente a possibilità ulcerose della materia ver-bale, le parentesi contengono – nel senso stret-to del tenere insieme come argini – l’«emorra-gia di parole»70. O forse sono anch’esse «coliche lessicali»71, contrazioni necessarie allo sviluppo di significato, pur non dando ragione alla strut-tura del discorso e anzi tagliando il tessuto del testo:
69 Glosse 16; ivi, p. 124.70 Scartabello 31; in E. sanguInetI, Segnalibro, cit., p. 313.71 Stracciafoglio 14; in E. sanguInetI, Segnalibro, cit., p. 245.
IlarIa MarIa roMIlIo382
con un progetto di inventario globale, ci sono nato, si può dire, io: (e questospiega, insieme, e insidia, e inficia, il mio sentimento del-la totalità):mi vedo,vedi, il mondo, quindi, come un catalogo permanente, an-che, e un’esposizione[permanentedi sé stesso, moltiplicato per esempi e eventi: (da classifi-care): (da ordinaree riordinare): (e da modificare):è un polimorfo, l’universo, perverso72
Lo sguardo lucido di Sanguineti, ormai emerso dalla Palus Putredinis, non smette di perlustrarla, per mettere ancora in evidenza il labirinto: è la storia a seminare ogni genere di detrito, ma il corpo vi pone rimedio coi suoi, di detriti. Secondo la formula gramsciana «dell’ot-timismo della volontà e del pessimismo della ragione»73, la vitalità di Sanguineti si dispiega proprio in quella putrefazione da cui far scatu-rire energia, dinamismo, fertilità. Scrive Curi, a proposito di Laborintus, che «la scrittura so-pravvive alla scomparsa del soggetto»74. Non a caso il poeta lascia in eredità i due punti: cor-po che separa la lingua, afasica apertura della parola, è questo esile segno vuoto a caricarsi di tutta la forza di un «linguaggio che partorisce»75 in ambiente sterile.
72 Stracciafoglio 39; ivi, p. 270.73 «Dopo di che cerco di godermi la vita il più possibile»; E.
Sanguineti - A. Gnoli (a cura di), op. cit., p. 110.74 F. CurI, La poesia italiana del Novecento, Roma-Bari, La-
terza 1999, p. 266.75 Laborintus 10; in E. sanguInetI, Segnalibro, cit., p. 25.
Tra Laborintus e Storie naturali: modalità del cor-po sterile - Between Laborintus and Storie naturali: modes of the sterile body
Ilaria Maria Romilio
La scrittura di Edoar-do Sanguineti è stata percorsa e guidata, da sempre, dall’attenzio-ne al corpo, non solo e non tanto come mezzo di espressione e comu-nicazione quanto come vero soggetto autono-mo e attivo. Proprio per questo dall’esfoliazio-ne dei suoi testi – ed in particolare da due dei più emblematici, Labo-rintus e Storie natura-li – emerge la capacità del corpo di scatena-re la crisi dell’io attra-verso la manifestazio-ne della sterilità: essa è dunque motivo, e non sintomo, di una pato-logica disgregazione umana.
Edoardo Sanguineti’s writing had always been crossed and guided by a great attention to the body, not only and not mainly considered as a means of expression and communication but seen as a completely autonomous and active subject. For this rea-son, the exfoliation of his texts – especially of two of his most emblem-atic works, Laborintus and Storie naturali (Nat-ural Histories) – reveals the body’s capability of provoking the crisis of the self through the dis-play of sterility: which is consequently the cause, and not the symptom, of a pathological human disgregation.
Riassunto - Abstact
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 385-423
Federica Paolini
Antonio Porta: poesia al limitetra speech act e performance
La poetica dello sguardo: tra soggettività e og-gettività
In uno dei suoi racconti più celebri, Der Sand-mann, pubblicato nel 1817 all’interno dei Racconti notturni, Ernst T.A. Hoffmann de-
scrive un sogno fatto da Nathanael, studente di fisica e letteratura nella misteriosa città di G. Nel sogno il protagonista sta finalmente per spo-sare la donna amata, Clara, nome che richiama un’immagine di luminosità, luce della ragione e dello spirito che si contrappone alle tenebre dell’inconscio e delle superstizioni. L’unione dei due giovani è però impedita dal sopraggiungere del terribile Coppelius, personaggio che incarna tutte le paure infantili rimosse, ma non anco-ra superate, di Nathanael. Con «le sue manac-ce ossute e pelose»1 (sono questi dettagli impor-tanti, attraverso i quali si comincia ad intrave-dere la superficie degli incubi dell’infanzia che ancora perseguitano il protagonista), Coppe-lius cava gli occhi della ragazza e li getta sul cu-ore di Nathanael, che inizia allora a sanguinare. Clara riesce a strappare il giovane dal suo de-lirio e a riportarlo alla realtà. Nathanael sem-bra persuaso eppure, guardando bene Clara, ha l’impressione che sia la Morte a guardarlo attra-verso gli occhi di lei.
A questo punto ci sarebbe già molto da dire sugli innumerevoli elementi di carattere per-
1 E.T.A. HoFFmann, L’uomo della sabbia, in id., Racconti not-turni (1817), Firenze, Giunti 1997, p. 7.
Federica Paolini386
turbante che si intrecciano nella vicenda nar-rata da Hoffmann. Il racconto, infatti, presen-ta in embrione molti di quei meccanismi oscuri del funzionamento della psiche umana che alla fine del secolo saranno scandagliati dalla teoria psicanalitica freudiana. Ma c’è dell’altro. Prose-guendo nello scorrere dell’intreccio il lettore as-siste insieme al protagonista ad una scena tanto grottesca quanto spaventosa: il misterioso Cop-pelius e il suo amico Coppola, appellativi deri-vanti entrambi dal nome di una parte specifica dell’anatomia oculare detta «coppa», sono inten-ti a contendersi ferocemente il corpo della bam-bola Olimpia, strattonandolo fino a far schizza-re fuori dalle orbite gli occhi, che finiscono per rotolare come biglie sul pavimento. Si scopre al-lora che Olimpia, la donna di cui Nathanael si è follemente innamorato, non è altro che un au-toma dagli occhi di vetro. Dall’ossessione di Na-thanael per l’oggetto-occhio, e per tutto ciò che concerne la sfera della percezione visiva, emer-ge chiaramente la volontà dello scrittore di spie-gare le origini di questa mania attraverso le tur-be mentali che affliggono il protagonista. Se, per un istante, si trascurasse il fatto che Antonio Porta scrive i Rapporti circa centocinquant’an-ni dopo il Der Sandmann di Hoffmann e che, ov-viamente, si tratta di poesia e non certo di lette-ratura fantastica, alcuni versi tratti da Rappor-ti umani XIV potrebbero servire a rendere una descrizione perfetta della scena della bambola Olimpia che perde gli occhi di vetro:
sono biglie di vetro, ricordati di quegli anni, e lifa schizzare via, né inquietudini né incertezze, conil mantello rosso, con le piume, rimbalzano sul pa-vimento, sciolgono nell’acqua la miscela dell’iride.2
2 A. Porta, Rapporti umani, XIV, in id., Tutte le poesie. (1956-1989), a cura di N. Lorenzini, Milano, Garzanti 2009, p. 133. Tutte
Antonio Porta: poesia al limite 387
Che in questi versi con l’espressione «biglie di vetro» il poeta voglia riferirsi in realtà agli «oc-chi» è Edoardo Sanguineti a sottolinearlo, e lo fa in quelle pagine di Ideologia e linguaggio nelle quali spiega la poesia di Porta attraverso i con-cetti di «frantumazione del narrato» e «ambigui-tà dei frantumi»:
«sono biglie di vetro, ricordati di quegli anni» fin qui po-trebbe alludere ad un ricordo, e che si tratti di vere biglie di vetro. Segue un gesto cattivo, un po’ inquietante: «sono biglie di vetro, ricordati di quegli anni, e li / fa schizzar via». L’ambiguità deve essere risolta. Il gesto non è poi così tanto cattivo in se, ma è lo scarto di genere, quel «li», invece di «le», riferito a biglie. L’insidia grammaticale contiene la rivelazione di ciò che le biglie possono nascondere: si trat-ta di occhi. […] Il tema portiano si declina, in primo luogo, come deve, sul versante fisiologico, insistendo sopra orrori anatomici di varia portata.3
È possibile ricostruire gli avvenimenti de-scritti da Porta soltanto attraverso un’atten-ta operazione che conduca a far combaciare i vari tasselli che costituiscono la ‘storia’, risol-vendo gli enigmi linguistici posti in modo più o meno consapevole dal poeta, in modo da as-sottigliare gradualmente il velo d’ambiguità che agisce come un filtro su oggetti e personaggi. Nei Rapporti umani XIV gli occhi appaiono sem-plicemente come ‘cose’, sono ridotti alla stregua di puri oggetti inanimati scissi da un corpo-ma-nichino che assomiglia a quello della bambola Olimpia, un corpo che è continuo bersaglio di crudeltà e sevizie. Il «tema traumatico»4 in Por-ta diventa allora per Sanguineti «trauma temati-co». Questa la regola di lettura da seguire: «sce-
le citazioni a seguire dei testi poetici di Antonio Porta, a meno che non diversamente specificato, saranno tratte da questa raccolta.
3 e. Sanguineti, Ideologia e linguaggio, (1965), Milano, Feltri-nelli 1975, p. 127.
4 Ivi, p. 124.
Federica Paolini388
gliete sempre, interpretando, la strada peggiore, e sarete nel giusto».5 Detto ciò, Sanguineti con-tinua la sua analisi rintracciando nei versi di Porta la storia di una nevrosi infantile da ricol-legare al tema freudiano della castrazione e del complesso edipico, originati entrambi dalla per-dita dello stato di narcisismo primario durante il processo di crescita e sviluppo dell’individuo:
in senso psicanalitico le poesie di Porta vanno concepite come esercizio per rivivere la scena. La costante mancan-za di identificazione dei soggetti in azione trova una spie-gazione chiara se si pensa a quali figure si tratta di occul-tare e denunciare nello stesso tempo. Gli occhi vitrei che schizzano via dalle palpebre sono riconducibili ad Edipo che si acceca.6
Alla minaccia di castrazione proveniente dalla figura paterna ognuno risponde secondo i propri mezzi, strutturando progressivamen-te un’identità psichica in base all’accettazio-ne della perdita e alla costruzione del linguag-gio. Ed è proprio da un’analisi del racconto di Hoffmann Der Sandmann che Freud, in seguito agli studi già condotti da Ernst Jentsch7, pren-de spunto nel 1919 per il suo celebre saggio Il perturbante8, Das unheimlich, ovvero l’incon-sueto, il non familiare, restituzione teorica del funzionamento inconscio della mente umana. Con Freud una volta per tutte l’Io smette di es-sere inteso cartesianamente come un qualco-sa di monolitico per divenire un’entità scissa, un apparato che funziona soltanto attraverso la
5 Ivi, p. 127.6 Ivi, p. 131.7 Cfr, E. JentScH, Sulla psicologia del perturbante (1906), in
aa.VV., La narrazione fantastica, a cura di G. Goggi, Pisa, Nistri-Lischi 1983, pp. 399-410.
8 Cfr. S. Freud, Il perturbante, (1919), in id., Opere 1917-1923, a cura di C. Musatti, Torino, Bollati Boringhieri 1977, vol. IX, pp. 81-118.
Antonio Porta: poesia al limite 389
compresenza dinamica di due o più istanze in conflitto tra loro.
Negli anni sessanta Jacques Lacan, basan-dosi sul pensiero freudiano e sulle teorie strut-turaliste di Ferdinand de Saussure, giunge ad affermare che l’Io non è altro che la modalità ri-flessa della coscienza perché non sub-stantia, non supporta i fenomeni psichici. Al di qua di quell’Io riflesso, non autonomo, sta un io Altro che è realmente autonomo, irriflesso. L’incon-scio, per Lacan, ha la stessa struttura del lin-guaggio, è desiderio che diviene linguaggio. E il desiderio, a sua volta, trae origine da un biso-gno incessante di colmare una mancanza, biso-gno che si esprime attraverso la parola. La de-strutturazione del linguaggio che caratterizza I Rapporti coinciderebbe dunque con una deco-struzione dell’identità psichica del poeta, una sorta di ritorno ad uno stato prelinguistico per mezzo della demolizione di quell’Io che, in ef-fetti, in questi testi tende a scomparire del tut-to, almeno apparentemente, come soggetto per far posto all’oggetto, alle ‘cose’. Il poeta, spie-ga infatti Porta in Nel fare poesia, «“sta den-tro” l’oceano prelinguistico […] è colui che at-traversa queste stratificazioni come un palom-baro, in discesa e in ascesa, e prova un’irresi-stibile vocazione a rendere conto di queste di-scese-ascese»9. In termini di poetica, le parole di Porta coincidono con quanto dichiara Alfre-do Giuliani nell’antologia I Novissimi a propo-sito della «riduzione dell’“io”»10 e della «dialetti-ca dell’alienazione», concetti utilizzati per intro-durre un modo del tutto innovativo di intendere la poesia. Demolire l’Io per far posto alle ‘cose’ è quello che si intende per «poetica degli ogget-
9 A. Porta, Nel fare poesia, Milano, Sansoni 1985, p. 5.10 A. giuliani, Introduzione, in I Novissimi. Poesie per gli anni
’60 (1961), a cura di A. Giuliani, Torino, Einaudi 2003, p. 22.
Federica Paolini390
ti»: rifondare il linguaggio attraverso una visio-ne del mondo che si adatti meglio alla follia del reale, una visione «schizomorfa»11, come la defi-nisce Giuliani:
da principio sembra che Porta s’affidi interamente a un guardare stravolto, accanito sui fenomeni traumatici del-la cronaca, e che il suo problema sia di trovare l’espressio-ne adeguata, plastica, alla ripida sintesi del suo occhio.12
Un’importanza fondamentale in questo contesto assume dunque la percezione e in par-ticolare quella di tipo visivo, un ambito che Tz-vetan Todorov ha analizzato a fondo in un suo testo del 1970, La letteratura fantastica13. È chi-aro che Hoffmann, sebbene con un secolo di an-ticipo rispetto a Freud, aveva intuito una par-ticolare connotazione mentale legata alla sfera dello sguardo nel momento in cui informa il let-tore che, in una lettera all’amico Lothar, Natha-nael scrive che «non vi è niente di più strano e di più folle della vita reale»14, aspetti che il poeta può cogliere solo come l’«oscuro riflesso di uno specchio opaco». Tenendo presente il fatto che l’analisi di Todorov esclude dall’ambito del fan-tastico sia il genere poetico che quello allegori-co proprio perché esplicitamente costruiti sul-la finzione, è pur vero che quanto egli scrive in merito ai significati connessi alla sfera della per-cezione nella letteratura fantastica può tornare utile per un’interpretazione generale delle im-plicazioni psicologiche connesse al tema del-lo sguardo in letteratura. Soffermandosi a lun-go sull’analisi di Der Sandmann, racconto che considera uno dei più efficaci rappresentan-
11 id., Prefazione 1965, in I Novissimi…, cit., p. 7.12 id., Introduzione, cit., p. 30.13 Cfr. t. todoroV, La letteratura fantastica (1970), Milano,
Garzanti 1977.14 E.T.A. HoFFmann, L’uomo della sabbia, cit., p. 16.
Antonio Porta: poesia al limite 391
ti del fantastico ottocentesco, Todorov individ-ua la categoria dei cosiddetti «temi dell’Io», que-gli spazi tematici cioè che afferiscono all’ambito della percezione sensoriale e della coscienza. Così come per Freud, questo tipo di percezioni sono, per Todorov, strettamente connesse allo spazio della follia e della psicosi, al superamen-to del confine tra fisico e mentale, tra soggetto e oggetto. Nell’ambito del pur più sbiadito, se confrontato con gli esiti raggiunti da Hoffmann, genere fantastico italiano, Camillo Boito scrive sul finire dell’Ottocento un racconto in cui il protagonista, tormentato dai fantasmi dei sen-si di colpa del passato, è assalito dall’immagine di una macchia grigia che, come una «lacerazi-one purulenta»15 della cornea, gli offusca la vis-ta spingendolo al limite della follia. La macchia informe invade lo spazio del corpo, si dilata, si restringe, contorce l’anatomia dell’occhio assu-mendo un peso quasi corporeo:
notate poi che, quando chiudo gli occhi per dormire, io sento la mia macchia dentro di me. E allora c’è un suppli-zio diverso. La macchia non si aggira più intorno a sé stes-sa, ma cammina, corre. Corre in su, e nel correre tira in su la pupilla; sicché mi pare che il globo dell’occhio debba rovesciarsi, arrotolando dentro nell’orbita. Poi corre in giù, poi corre dalle parti, e il globo dell’occhio la segue, e i lega-menti quasi si schiantano, ed io dopo un poco mi sento do-lere, proprio effettivamente dolere gli occhi.16
«Mi pare che il globo dell’occhio debba ro-vesciarsi, arrotolando dentro nell’orbita»: Boi-to assume qui un’ottica quasi da Palpebra ro-vesciata. In questo testo del 1960 Porta forni-sce una dimostrazione evidente della «capacità
15 c. Boito, Macchia grigia, in id., Senso. Nuove storielle vane (1883), Ravenna, Allori Edizioni 2005, p. 124.
16 Ivi, p. 125.
Federica Paolini392
di “presentazione” delle immagini»17 che, a pare-re di Giuliani, «gioca una parte essenziale nella dialettica tra struttura e dissociazione (cioè tra linguaggio e mondo)»:
Il naso sfalda per divenire saliva il labbroalzandosi sopra i denti liquefa la curva masticatacon le radici spugnose che mordono sulla guancia,ragnatela venosa: nel tendersi incrina la mascella,lo zigomo s’impunta e preme nella tensione dell’occhiocontratto nell’orbita dal nervo fino in golapercorsa nel groviglio delle corde dal battito incessante.18
L’occhio è spettatore immobile e contem-poraneamente vittima delle sevizie esercitate su un corpo di cui, suo malgrado, è parte in-scindibile. È attraverso i sensi che il corpo per-cepisce il mondo e contemporaneamente pren-de coscienza di sé stesso. Nelle auto-percezio-ni corporali l’individuo quindi è contempora-neamente corpo-oggetto e corpo-soggetto, così come una mano toccata è allo stesso tempo la mano che tocca e viceversa. La palpebra rove-sciata, scrive Stefano Colangelo alludendo a Ba-taille, costituisce un «rigoroso esercizio di “criti-ca dell’occhio”»19 in cui ritmo e sguardo si alle-ano per sottoporre il corpo a processi che con-ducono allo sfaldamento e alla decomposizione:
il sistema accentuativo resta fermo e percussivo, mentre la sintassi affronta in profondità il movimento dello sguar-do formante; […] A contatto con quell’accadere, lo sguar-do si fa prolungato e penetrante, e colma la scrittura di una decisa accentuazione, di una serie di scatti istanta-nei che richiamano proprio quelli di una palpebra sul glo-bo oculare.20
17 a. giuliani, Lettera a Leo Paolazzi, 10 maggio 1959, con-servata presso l’Archivio Antonio Porta, Centro Apice, Milano.
18 A. Porta, La palpebra rovesciata, 1, p. 103.19 S. colangelo, L’«usus videndi» di Antonio Porta, in id., Me-
trica come composizione, Bologna, Gedit 2002, p. 99.20 Ivi, pp. 99-100.
Antonio Porta: poesia al limite 393
Leggendo Porta non si può fare a meno di notare che lo spazio della sua poesia è popola-to da miriadi di specchi, vetri, occhi inanimati che crepitano e rotolano via, veli e tende che fil-trano lo sguardo impedendo una visione limpi-da e completa, come in un meccanismo di sca-tole cinesi architettato con l’obiettivo di far per-dere l’orientamento, di spaesare. Nei Rappor-ti il mezzo occhio viene sfruttato da un punto di vista duplice: da un lato esso è rappresen-tato in modo ossessivo, come un oggetto inani-mato da ferire e su cui infierire, una «biglia di vetro», appunto, che rotola via lontano dal cor-po («e punge gli occhi il vento dell’incendio»21, «gli occhi di porcellana sul punto di staccarli»22), dall’altro l’occhio rappresenta un metodo di co-noscenza, una modalità, anche se non l’unica, di investigazione del reale («lo sguardo allo spec-chio scruta l’inesistenza»23, «guardò la tavola di ghiaccio, l’occhio / cristallino»24, «[…] e gli uc-celli ascolta / levarsi sopra gli occhi», «s’arresta dietro gli occhi»).
La psicanalisi fornisce al riguardo delle in-terpretazioni utilissime. Per Freud, come già ac-cennato, il timore di perdere gli occhi allude alla paura originaria della castrazione, al mito di Edipo che si acceca quando giunge a conosce-re la verità. Ogni elemento connaturato a que-sto tipo di percezione (occhiali, lenti, specchi…) apre l’accesso all’irrazionale, alla follia, all’am-biguo. La ragione rifiuta di credere a ciò che l’occhio vede riflesso nello specchio perché l’im-magine riflessa nega il principio di non contrad-dizione. Per questi motivi il tema dello sguardo è stato molto sfruttato anche nel cinema surre-
21 A. Porta, Europa cavalca un toro nero, 8, p. 77.22 id., A) Movimenti, II, da Cara, p. 158.23 id., In re, p. 102.24 id., Il vento soffia sul limite, p. 93.
Federica Paolini394
alista. Si pensi ad esempio a Un chien andalou (1929) di Louis Buñuel, all’inquadratura forte-mente suggestiva dell’occhio di donna (in real-tà un occhio di vitello) tagliato da un rasoio, im-magine che il regista accosta a quella di una nuvola lunga e sottile che si staglia sulla sfe-ra lunare. Adriano Spatola, analizzando la poe-sia di Porta in un articolo apparso su «Malebol-ge» nel 1964 con il titolo Poesia a tutti i costi25, mette in evidenza l’aspetto grottesco, un’«ironia del patetico» quasi surrealista presente nei te-sti portiani di quegli anni. A proposito dell’uti-lizzo del corpo umano da parte di Porta, Spatola scrive che si tratta «del corpo scomponibile, ma-novrabile di un manichino, di uno di quegli as-surdi, mostruosi, spesso disgustosi manichini prodotti dalla macabra fantasia di certi surrea-listi». Più che un’ottica surrealista, però, incen-trata sulla visione, sul distacco ironico e sul so-gno, è riscontrabile nei Rapporti una concezio-ne del corpo e delle sue parti anatomiche basa-ta più decisamente sulla matericità e sulla vio-lenza messa in atto contro il reale, sulla rabbia del poeta per lo «stupro» che la società («avverti-mento utile: la società / materasso, gommapiu-ma, carta / assorbente»26) mette in opera quoti-dianamente nei confronti dell’individuo («peda-te con rabbia e macchie / d’inchiostro»), il quale non sente più il suo corpo come suo, ma, attra-verso un processo di straniamento e di de-sen-sibilizzazione, lo percepisce come altro da sé, come oggetto su cui infierire (suggerimenti in-dispensabili provengono / dal barman: lo stu-pro ha efficacia»). Il corpo umano in Porta vie-ne fatto a pezzi, smembrato, preso a pedate. Ed è in particolare contro l’occhio, colpevole proba-
25 Cfr. a. SPatola, Poesia a tutti i costi, in «Malebolge», n. 2, 1964, pp. 51-53.
26 A. Porta, Di fronte alla luna, p. 83.
Antonio Porta: poesia al limite 395
bilmente di assistere impotente allo «stupro» in atto, che si scaglia la violenza furiosa messa in scena dal poeta, come accade in Europa cavalca un toro nero (1958):
Dalla trama delle calze salel’azzurro dell’asfissìa. Guarda,strofina un fiammifero, incendiai capelli bagnati d’etereluminoso. Le tende divampanocrepitando. Li scaglia nel fienileil cuscino e la bottiglia di benzina.Gli occhi crepano come uova.Afferra la doppietta e sparanella casa della madre. Gli occhisono funghi presi a pedate.27
Questo testo viene citato da Giuliani nella lettera indirizzata a Leo Paolazzi del 10 maggio 1959 quale esempio della «capacità “presentati-va” delle immagini»28 che il critico riconosce, fin dall’inizio, essere caratteristica fondante della poetica portiana. Ed è per mezzo delle immagi-ni, per mezzo della presenza oggettuale che Por-ta percepisce lo spazio del mondo e costruisce quello della poesia.
L’ottica attraverso la quale il poeta inten-de il reale chiama direttamente in causa la fe-nomenologia di Husserl e di Merleau-Ponty. In Le visible et l’invisible (1964) Merleau-Ponty de-finisce la percezione come la risultante di sen-sazioni atomiche causali, e come tale attribui-sce ad essa una dimensione attiva, non passiva, in quanto è attraverso il proprio corpo che l’in-dividuo si apre nei confronti del mondo. Punto di partenza di tale concezione è l’abbandono del dualismo cartesiano tra anima e corpo, tra co-scienza e mondo. Il corpo non è solamente un
27 id., Europa cavalca un toro nero, 7, p. 79.28 A. giuliani, Lettera a Leo Paolazzi, 10 maggio 1959, cit.
Federica Paolini396
oggetto di studio potenziale per la scienza, ma è condizione indispensabile al conoscere. Se esso è apertura percettiva al reale, anche la coscien-za, di conseguenza, assume una sorta di dimen-sione corporea. Il metodo fenomenologico pre-suppone la sospensione di ogni presa di posizio-ne precostituita nei confronti del mondo per ri-condurre l’esistenza al suo darsi fenomenico. La conoscenza è intesa allora come un «ritornare alle cose stesse», come puro sguardo capace di cogliere intuitivamente e descrivere le strutture:
ritornare alle cose stesse è ritornare a quel mondo che pre-cede la conoscenza, del quale la conoscenza sempre par-la, e in rapporto al quale ogni schematizzazione scientifica è un linguaggio-segno astratto e derivato, come la geogra-fia lo è in relazione al territorio in cui noi abbiamo impa-rato per prima cosa cos'è una foresta, una prateria o un fiume.29
Per Merleau-Ponty la pittura, e in secon-do luogo la scultura, offrono un accesso privi-legiato a ciò che egli chiama Essere. Ne offre un esempio nel saggio L’oeil et l’esprit del 1961:
quando attraverso lo spessore dell'acqua io vedo il fondo piastrellato della piscina, non è che lo veda nonostante l'acqua e i riflessi, io lo vedo attraverso di essi e a causa di essi. Se non ci fossero distorsioni, riverberi della luce del sole, se fosse che senza quel riflesso ho visto la geome-tria delle piastrelle, allora io cesserei di vederlo come è e dove è – il che significa al di là di qualunque luogo identi-co e specifico.30
29 m. merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, Routled-ge, London 1995, p. IX, citazione tratta da a. erJaVec, Evidenzia-tori deittici: Bryson, Merleau-Ponty e oltre, in «Parol on-line», giu-gno 2000, trad. it. a cura di R. Milani.
30 G.A. JoHnSon, «Eye and Mind». The Merleau-Ponty Aes-thetics Reader. Philosophy and Painting, Northwestern University Press, Evanston 1993, p. VIII, citazione tratta da a. erJaVec, Evi-denziatori deittici…, cit.
Antonio Porta: poesia al limite 397
Profondità, spazio, colore: queste sono le scene che il pittore intuisce e rappresenta. Il pittore è colui che si sforza di rappresentare il mondo come viene percepito, ovvero come som-ma di visibile e invisibile. Nella sua riflessione sull’opera di Cézanne31 Merleau-Ponty individua nella pittura la forma più pregnante di esplicita-zione del linguaggio del corpo vissuto. Soggetto della percezione non è un Io trascendentale, ma un corpo agente e senziente. Il segreto della pit-tura consiste perciò nel rivolgersi al corpo come apertura e veicolo verso la conoscenza. Il filoso-fo critica l’atteggiamento delle scienze moderne che si ostinano a voler creare modelli astratti e generici invece di vedere il mondo nella sua con-cretezza e corporeità. Il corpo di cui parla Mer-leau-Ponty è un corpo enigmatico, caratterizza-to da una costruzione a chiasmo: è sintesi di ciò che vede e che tocca e di ciò che viene visto e che viene toccato. I prodotti della pittura perciò non sono mai copie, calchi degli oggetti rappre-sentati, ma vere e proprie celebrazioni dell’enig-ma della visibilità. La ‘cosa’ è posta in fondo allo sguardo e all’esplorazione dell’individuo, senza dover presupporre nulla che possa essere inse-gnato dalla scienza del corpo altrui:
io devo constatare che il tavolo di fronte a me mantiene un rapporto singolare con i miei occhi e il mio corpo: io lo vedo solo se è nel loro raggio d’azione; sopra di esso c’è la mas-sa oscura della mia fronte, sotto c’è il contorno più inde-ciso delle mie guance: entrambe visibili al limite, e capaci di nasconderlo, come se la mia visone del mondo stesso si facesse da un certo punto del mondo. Di più: i miei movi-menti e quelli dei miei occhi fanno vibrare il mondo, come si fa muovere un dolmen con un dito senza scuotere la sua solidità fondamentale. Ad ogni battito delle mie ciglia una tenda si abbassa e si rialza, senza che al momento io pen-
31 m. merleau-Ponty, Le doute de Cézanne (1945), trad. it. Il dubbio di Cézanne, Milano, Il Saggiatore 1963.
Federica Paolini398
si di imputare questa eclissi alle cose stesse; a ogni mo-vimento degli occhi che frugano lo spazio di fronte a me, le cose subiscono una breve torsione che io imputo a me stesso; e quando cammino per la strada, con gli occhi fis-si sull’orizzonte delle cose, tutto ciò che nelle vicinanze mi circonda sussulta a ogni rumore del tacco sull’asfalto, poi si assenta nel suo luogo.32
«Come se se la mia visione del mondo stes-so si facesse da un certo punto del mondo», «ad ogni battito delle mie ciglia una tenda si abbas-sa e si rialza, senza che al momento io pensi di imputare questa eclissi alle cose stesse»: si è proiettati verso Aprire:
Dietro la porta nulla, dietro la tenda,l’impronta impressa sulla parete, sotto,l’auto, la finestra, si ferma, dietro la tenda,un vento che la scuote, sul soffitto nerouna macchia più oscura, impronta della mano,alzandosi si è appoggiato, nulla, premendo,un fazzoletto di seta, il lampadario oscilla,un nodo, la luce, macchia d’inchiostro,sul pavimento, dietro la tenda, la paglietta che raschia,sul pavimento gocce di sudore, alzandosi,la macchia non scompare, dietro la tenda,la seta nera del fazzoletto, luccica sul soffitto,la mano si appoggia, il fuoco nella mano,sulla poltrona un nodo di seta, luccica,ferita, ora il sangue sulla parete,la seta del fazzoletto agita una mano.33
Aprire è stato definito da Sanguineti in oc-casione del convegno «Antonio Porta: il proget-to infinito» tenutosi a Bologna il 14-15 mag-gio 2009, un «non-racconto»34, un testo afasico, rapsodico, in cui lo sviluppo narrativo è conti-
32 id., Le visible et l’invisible (1964), trad. it. Il visibile e l’in-visibile, Milano, Bompiani 2003, pp. 34-35.
33 A. Porta, Aprire, I, p. 123.34 Cfr. Edoardo Sanguineti legge e commenta «Aprire», dvd al-
legato a il «Il verri», n. 41, 2009.
Antonio Porta: poesia al limite 399
nuamente ostacolato dal deflagrare di immagi-ni che restano senza sviluppo. Precedentemen-te, in Ideologia e linguaggio, il critico parago-nava le immagini portiane a dei «fotogrammi di una pellicola cinematografica ridotti a enigma-tiche istantanee cui è naturalmente sottratta la compiutezza di senso loro derivante unicamen-te dalla continuità del movimento»35. La scena descritta da Porta è quella di un delitto, un as-sassinio perpetrato al tempo presente tra conti-nue tensioni muscolari e vetri fatti a pezzi che si infrangono così come si infrange la narrazio-ne, tra le iterazioni continue degli avverbi («die-tro», «sopra», «sotto») e l’attenzione ossessiva nei confronti degli oggetti («la tenda», «le calze», «la seta»). Tutto questo si traduce, dal punto di vi-sta del ritmo, in un uso esemplare della metrica accentuativa, come spiega Colangelo:
[…] le virgole e gli ictus si dispongono al servizio di una se-quenza visuale, cercando un passo riconoscibile al di fuori non solo della forma chiusa, ma anche della stessa tradi-zione metrica sillabica; il poeta lavora al segmento e al re-spiro, rendendo costante il numero delle sillabe toniche e giocando con la massima libertà sulle atone; […].36
Il ritmo percussivo della metrica accentua-tiva segmenta la narrazione, frantuma lo spa-zio del verso soffocando la respirazione. Allo stesso modo lo spazio dell’evento è interamen-te costruito sulla presenza di oggetti che dan-no luogo alla percezione e contemporaneamen-te agiscono come dei filtri, dei veli che impedi-scono continuamente allo sguardo di spaziare e di avere una visione completa dei luoghi e degli avvenimenti in corso. Il lettore non è più spetta-tore passivo, ma è calato a pieno nello svolger-
35 e. Sanguineti, Ideologia e linguaggio, cit., p. 124.36 S. colangelo, L’«usus videndi» di Antonio Porta, cit., p.
104.
Federica Paolini400
si dell’evento che prende corpo soltanto sotto i suoi occhi. In ambito cinematografico si sortisce un effetto molto simile quando le riprese ven-gono effettuate con una camera a mano, come nel caso di una pellicola da 35 mm del collettivo Dogma 95, girata direttamente nella location e senza la ‘cancrena’ e la finzione derivante dall’u-tilizzo di scenografie o di effetti speciali.
A proposito di Aprire Niva Lorenzini scrive:
lo spazio è quello asfittico di chi sta dietro, di chi sta den-tro, bloccato in una geometria rigidamente perimetrata, Di lì preme per sottrarsi alla reclusione, facendo urtare le pa-role contro le virgole che sezionano e disarticolano, e in-troducendo la sorpresa, lo choc del dato imprevisto, ab-norme, in una struttura apparentemente compatta. Viene così stravolta la percezione normalizzata.37
Lo spazio della poesia è costruito con la tecnica del montaggio discontinuo di immagi-ni stravolte che si illuminano sotto un flash che il poeta getta sulla banalità del quotidiano. Per questa tendenza a generare rapsodie di immag-ini, la poesia di Antonio Porta è stata spesso ac-costata, come sottolinea ancora Sanguineti in Ideologia e linguaggio, alle produzioni dell’école du regard, etichetta che più che una scuola in-dica un particolare clima culturale sviluppato-si in Francia a partire dalla fine degli anni cin-quanta. Alle origini di questa corrente di pen-siero si colloca il romanzo Les gommes (1953) di Alain Robbe-Grillet, interamente costruito intorno al mito di Edipo. Robbe-Grillet mette in atto con quest’opera un capovolgimento del punto di vista narrativo: l’attenzione non è più rivolta al personaggio e alle azioni che egli com-
37 n. lorenzini, Corporalità e crudeltà nella poesia degli anni sessanta, in G. Butcher e M. Moroni (a cura di), From Eugenio Montale to Amelia Rosselli: Italian Poetry in the Sixties and Seven-ties, Leicester, Trubador Publishing 2004, p. 6.
Antonio Porta: poesia al limite 401
pie, ma alle ‘cose’, attraverso una descrizione metodica e spesso persino geometrica degli og-getti. Spetta al lettore ricostruire sia la storia che l’esperienza emozionale compiuta dal per-sonaggio a partire dai dettagli e dal flusso con-tinuo di libere associazioni e interruzioni, come avverrebbe in una seduta di psicanalisi. A prop-osito del nouveau roman di Robbe-Grillet, Ro-land Barthes scrive che «le costellazioni di og-getti non sono espressive ma creatrici»38, ciò sig-nifica che «esse fanno il delitto, non lo svelano: in una parola, sono letterali». Se però nel nou-veau roman l’oggetto non evoca altro che il pro-prio esserci legittimandosi unicamente come is-tituzione ottica, nel caso di Porta le cose non stanno esattamente così. Per quanto si scagli contro l’Io cercando di sommergerlo di ‘cose’, di oggetti del quotidiano, questo non vuol dire che il poeta riesca a soffocare l’espressione del-la propria individualità. Anzi:
in Porta non c’è lotta tra corpo e anima, sono i corpi che vincono, e al più l’anima è una ferita aperta che ancora provoca dolore e strazio. Entrambi sono comunque coin-volti in un processo di degradazione e di dissoluzione. Por-ta è la voce di questa condizione, di questi «rapporti».39
Come fa notare Sanguineti, anche se de-gradata e ferita una soggettività in Porta conti-nua ad esistere, ed esiste proprio perché il poe-ta cerca con tutti i mezzi di reprimerla. Si trat-ta di una soggettività che lacera sé stessa e il proprio corpo per mezzo del reale e che si espri-me per mezzo di questa lacerazione. È come se un Io del sottosuolo cercasse di aprirsi un var-co per tornare in superficie, cosa che accadrà in modo esplicito più in là nel tempo, quando
38 r. BartHeS, Letteratura letterale (1955), in id., Saggi critici, Torino, Einaudi 1972, pp. 29-30.
39 e. Sanguineti, Ideologia e linguaggio, cit., p. 127.
Federica Paolini402
ad esempio nelle Brevi lettere ’76 l’Io ricompare attraverso lo squarcio chiuso di una parentesi. Ma «la parentesi», fa notare Iosif Brodskij, «è l’e-quivalente tipografico di ciò che sta in fondo al cervello»40 e, continua Stefano Colangelo, «l’“io” tra parentesi non è solo l’“io” del profondo, ma quello dell’oltre, del discorso che si sporge al di là di se stesso».41
Se fossero gli oggetti a vincere, allora la po-esia di Antonio Porta potrebbe trovare un equi-valente in campo artistico nella Pop art. Ma se, come scrive Sanguineti, «sono i corpi che vinco-no, e al più l’anima è una ferita aperta che anco-ra provoca dolore e strazio»42, allora le cose cam-biano: il linguaggio è azione, è «speech act»43, è performance.
Porta vs Bacon: flash puntato sul corpo
Che cosa rende le case moderne così di-verse, così affascinanti? È la domanda che nel 1956 si pone Richard Hamilton, artista dell’in-glese Indipendent Group (IG), in un collage che è poi divenuto emblema della Pop art. In un ap-partamento arredato alla moda dell’epoca spic-ca una serie infinita di oggetti cult e figure ste-reotipate: Mr. Muscolo che regge un lecca-lecca Chupa-Chups come fosse una racchetta da ten-nis, una Pin-up fumettistica seduta in atteggia-mento provocante sul divano, un aspirapolve-re Hoover e uno stemma della Ford. Con i suoi ritagli Hamilton si limita però a prendere atto
40 i. BrodSkiJ, Dolore e ragione, Milano, Adelphi 1998, p. 236, in S. colangelo, Aperta parentesi, «io», chiusa parentesi, in «Il verri», n. 41, ottobre 2009, pp. 45-46.
41 S. colangelo, Aperta parentesi, «io»…, cit.42 e. Sanguineti, Ideologia e linguaggio, cit., p. 127.43 J. PiccHione, Introduzione a Antonio Porta, Bari, Laterza
1995, p. 27.
Antonio Porta: poesia al limite 403
dell’avvento e della vittoria della società della merce e dell’abbondanza, a riprodurre, magari con una vena d’ironia, gli stereotipi che la nuo-va economia impone.
Altrove l’arte Pop dimostra invece uno spi-rito maggiormente critico, come nel caso dell’ar-tista americano George Segal, specializzato nel fissare frammenti di vita in calchi di gesso ot-tenuti direttamente da modelli umani. In real-tà, inserire Segal tra le icone scintillanti del Pop costituisce un azzardo, se non un’inesattezza. L’artista statunitense non si limita, come Ha-milton, ad esibire lo splendore dei nuovi prodot-ti dell’industrial design, ma riesce a cogliere e a rappresentare la monotonia squallida dell’esi-stenza di uomini-manichino che accanto a que-sti oggetti si muovono, restando però chiusi nel loro solipsismo. I calchi di Segal non conserva-no niente di umano, fatta eccezione per forma e dimensioni. Non si tratta di uomini, ma di fan-tasmi, sagome bianche che ricordano vagamen-te com’era l’uomo un tempo, prima che venisse schiacciato dalle ‘cose’, quasi una rappresenta-zione avveniristica di quale potrebbe essere il futuro dell’essere umano nel caso in cui non si svegliasse in tempo dal torpore mentale che lo immobilizza.
Questi uomini-fossili si muovono in am-bienti reali, urbani o domestici, perfettamen-te ricostruiti, ricordando da vicino l’atteggia-mento degli zombies del fim L’alba dei morti viventi (1968) di A. Romero, attacco esplicito alla società dei consumi. Per mostrare la man-canza di spirito critico e di umanità dell’uomo-automa che abita il mondo contemporaneo, in questa pellicola Romero ha una trovata tanto geniale quanto elementare per l’immediatez-za della metafora: i morti, tornati sulla Terra, scelgono come punto d’incontro uno dei luoghi che era loro più caro in vita, il centro commer-
Federica Paolini404
ciale, e sono ossessionati da un solo pensiero, quello di nutrirsi. L’analogia con quello che il regista vede delinearsi come futuro prossimo dell’uomo non potrebbe essere resa in modo più chiaro. In modo simile il calco umano di Cinema mostra il rapporto conflittuale, l’attra-zione fortissima, e contemporaneamente l’im-potenza estrema, che prova l’individuo davan-ti all’incalzare dell’oggetto e della nuova eco-nomia. Ma l’arte di Segal non è che l’eccezione che conferma la regola. E la regola, nel Pop, è la vittoria schiacciante delle ‘cose’ sull’uomo. Al contrario, all’incirca nello stesso periodo, l’arte Informale parte dal proposito di afferra-re una realtà lontana dai nuovi status symbol, scarta dal suo raggio d’azione tutti gli aspetti di superficie della vita, tutti i prodotti della tec-nologia e della moda, come utensili, macchi-ne, vestiti. Sfrutta materia e materiali, anche se di origine industriale, soltanto in virtù delle loro proprietà intrinseche, della loro «carne»44 e del loro spessore. Il suo obiettivo è catturare la realtà in tutta la sua durezza attraverso un «ritorno alle cose stesse», come propone Rena-to Barilli45 sulla scia di Merleau-Ponty, al di là della loro superficie, oltre tutto ciò che è perce-pito come non autentico.
Nel caso di Francis Bacon il discorso cam-bia ancora. I suoi personaggi indossano giacche e cravatte alla moda, sono circondati da ogget-ti di design moderno, geometrico, perfettamen-te contestualizzabile. È d’obbligo, però, preci-sare due aspetti fondamentali: l’arte di Bacon non costituisce né un’interpretazione suis ge-
44 Cfr. R. Barilli, Il sogno di Bacon, in «Il verri», n. 9, 1963, ora in Informale Oggetto Comportamento. La ricerca artistica negli anni ’50 e ’60, cit., p. 107.
45 id., Aspetti del «ritorno alle cose stesse», in Informale Og-getto …, cit., p. 180-193.
Antonio Porta: poesia al limite 405
neris della Pop art, in quanto le sue tele scava-no ben oltre la superficie dell’esistenza, né un ritorno alla vecchia pittura, quella che ritrae i dettagli delle ‘cose’ cercando di farle assomiglia-re il più possibile alla realtà. Esiste, lo spiega Barilli, una differenza fondamentale tra Bacon e la pittura tradizionale:
l’universo su cui si affaccia la visione del figurativo tradi-zionale è illuminato da una luce che vi piove da sempre, luce di Dio, o della ragione, o del sole, o di un fuoco arti-ficiale: luce che invade abbondantemente tutte le cose ac-cordando ad ognuna di esse un equo rilievo, a seconda dei gradi di dignità e di importanza che loro rispettivamente competono. L’universo di Bacon sta invece nelle tenebre più assolute, finché non si applichi ad esso l’attenzione dell’artista; e quando poi questa si accende, ha da contare esclusivamente sulle sue forze, non può sfruttare una pre-cedente illuminazione diffusa in modo omogeneo, non può farsi portare sull’onda di quella; c’è dunque ormai un'uni-ca fonte di raggi luminosi, e questa è affidata al pittore, fa anzi tutt’uno con lui, coincide con la sua vista.46
Oggetti e personaggi, osserva Barilli, sono invasi da un fascio di luce artificiale, un neon che funziona a intermittenza e che li fa vivere in modo frammentario, discontinuo. Come avvie-ne per il mezzo fotografico, più si contrae il tem-po d’esposizione più l’immagine risulterà mossa e sfocata. E Bacon è capace di ridurre al mini-mo il tempo di posa in modo che le sue figure, sorprese dalla luce abbagliante del flash, resti-no immortalate nell’attimo cruciale in cui com-piono gesti e movimenti. È un’illuminazione vio-lenta che opera con violenza, assale personag-gi ignari catturati nella loro intimità, secondo i modi di quel giornalismo cronachistico che pro-va un gusto quasi sadico nello ‘svergognare’ le proprie vittime.
46 id., Il sogno di Bacon, cit., p. 108.
Federica Paolini406
Tutto il resto è tenebra. L’artista punta il fascio di luce solo su ciò che il suo sguardo se-leziona, in modo che unicamente la scena fo-tografata risulti visibile, isolata dal contesto. È una tecnica pittorica che per certi versi ricor-da quella di Caravaggio, con la differenza, però, che mentre quest’ultimo illumina la scena con una luce teatrale proveniente per lo più dall’al-to o da un lato, Bacon utilizza invece un’illumi-nazione fredda, un neon che si diffonde in modo frontale sul ritaglio di scena che interessa met-tere in evidenza. Colpiti da questo fascio di luce improvviso i personaggi si accorgono di essere spiati e rivolgono a loro volta uno sguardo atto-nito, carico di sensi di colpa, sul voyeur, su co-lui cioè che direziona il faro. È come se l’artista fosse interessato al colpo di scena, al momento cruciale, anche se restano oscuri i criteri di va-lutazione adottati per selezionare tali momenti che anzi spesso, ad un occhio non attento, po-trebbero sembrare banali, privi di una qualsia-si importanza così come può esserlo il semplice gesto di sbadigliare:
[…] strumenti tanto intensi e violenti quali appunto il flash, il faro, il riflettore non possono essere fatti in-tervenire a caso, sarebbe un inutile spreco; sappia-mo bene che al contrario li si impiega in casi d’ecce-zione, quando si tratti di fissare l’acme di un’azione, di un episodio, o quando qualcosa di inquietante si annunci all’orizzonte, quando sia da temere la pre-senza di un pericolo. E così si dica per Bacon: i suoi sguardi intensi e concentrati non vanno a illuminare una tranche de vie qualunque, permutabile con mol-te altre, non si rivolgono su un brano grigio e neu-tro, ma segnano piuttosto il punto culminante di un qualche avvenimento […].47
47 Ivi, p. 110.
Antonio Porta: poesia al limite 407
Bacon però, al contrario dei cronisti, non cerca l’esteriorità dello scoop, ma piuttosto l’at-timo perturbante, brutale, una «tranche de vie» normale solo in apparenza. Il suo modo di ope-rare si avvicina, e per molti aspetti in modo sor-prendente, al «fare poesia»48 di Porta. Ricapito-lando quanto detto finora, cominciano già a de-linearsi dei punti di contatto evidenti tra il pit-tore e il poeta:
1. costruzione della scena, sia poetica che pittori-ca, attraverso un flash puntato su ogni singolo frammento di immagine al fine di isolare l’avve-nimento e riviverlo attraverso un procedimento inconscio.
2. Conseguente contrasto luce / buio, sfruttato per mettere in evidenza soltanto il fatto salien-te. Questo aspetto si traduce, in Bacon nell’atti-tudine quasi teatrale ad illuminare solo ciò che è posto sotto un riflettore immaginario coinci-dente con lo sguardo del pittore; in Porta nell’a-fasia linguistica, nel non riuscire a comunicare, nell’omettere ciò che lo sguardo del poeta non afferra e non vuole sia afferrato.
3. Il carattere perturbante, spesso anche sadico, dell’immagine. Messa in scena della violenza e delle mutazioni corporali.
La poetica dello sguardo è dunque il punto di partenza della ricerca artistica di entrambi, pittore e poeta. La luce che invade lo spazio del-la poesia e quello della tela non è «una luce che vi piove da sempre, luce di Dio, o della ragione, o del sole, o di un fuoco artificiale»49, come fa no-tare Barilli, ma una luce che nasce dallo sguar-do dell’artista, il quale unicamente su quell’av-venimento e su quegli oggetti pone la propria
48 Cfr. A. Porta, Nel fare poesia, cit.49 R. Barilli, Il sogno di Bacon, cit., p. 108.
Federica Paolini408
attenzione. Nella poesia di Porta il lettore non può avere una visione d’insieme, è un lettore tutt’altro che onnisciente che si ritrova proietta-to nel bel mezzo della scena insieme a quell’«io» che non c’è eppure compare come sguardo che scruta e seleziona l’immagine da mettere a fuo-co, da presentare. Nel cinema si raggiunge lo stesso effetto attraverso un procedimento chia-mato «sutura», una tecnica di montaggio delle immagini che si potrebbe definire quasi chirur-gica. L’operazione consiste nel tagliare, limita-re il campo visivo dello spettatore a ciò che si vuole venga visto attraverso una sequenza di in-quadrature che presentano la storia in manie-ra predeterminata. Lo spettatore è dunque co-stretto a lasciarsi guidare dal regista attraver-so una trama di scorci prestabiliti, a «rivivere la scena»50, come suggeriva Sanguineti, sen-za potersi avvalere di una qualsiasi difesa ulte-riore. È quanto avviene in The Shining, film di Stanley Kubrick del 1980, e in particolare nella scena, arcinota, in cui una camera a mano se-gue la corsa del bambino sul triciclo attraverso il labirinto di stanze e corridoi dell’Overlook Ho-tel, Colorado, teatro dell’intera vicenda. Il cam-po visivo dello spettatore coincide con quello del bambino che si muove, in modo apparentemen-te casuale, attraverso una serie di barriere (por-te chiuse o semiaperte) e luoghi anonimi eppu-re inquietanti (pareti lunghissime, corridoi sen-za fine), filtrati da inquadrature ristrette e spes-so volutamente ‘sbagliate’. Gli ‘sbagli’ e le in-coerenze continue sono sfruttati per sortire un effetto destabilizzante: la macchina da scrivere del protagonista cambia più volte colore, i car-dini delle porte sono posizionati ora da un lato, ora dall’altro, la posizione stessa dei personaggi cambia sensibilmente a seconda dell’angolazio-
50 e. Sanguineti, Ideologia e linguaggio, cit., p. 131.
Antonio Porta: poesia al limite 409
ne dell’inquadratura. Questa lunga serie di ‘er-rori’ e di ingenuità apparenti concorrono a non lasciar spazio alla ricerca di una spiegazione plausibile da parte dello spettatore, che finisce per perdere definitivamente la certezza di una visione-controllo sulla scena e sulla sequenza degli eventi, e anzi vi precipita dentro senza riu-scire più a scorgere una via d’uscita.
Per ragioni affini testi come Aprire sono co-struiti attraverso serie incessanti di contraddi-zioni e successioni illogiche di gesti e movimen-ti: «l’orecchio, poi aprire, un’incerta, non si apre, / risposta, le chiavi tra le dita»51, «dietro la ten-da c’è, la notte, il giorno»52, «è mattina, il ferro dei passi remi e motori, / i passi sulla sabbia, il ven-to sulla sabbia, / le tende sollevano i lembi, per-ché è notte». Si tratta di cronache di movimenti e stati che si affermano per poi subito dopo negar-si, chiusi in un ritmo martellante di un va e vie-ni che presuppone una catena spezzata di cellu-le, embrioni di racconto che racchiudono ognu-no un tentativo di moto soffocato in uno spasmo. L’avanzare dello sguardo è continuamente bloc-cato da filtri posti in modo cadenzato («la ten-da», «la porta», «la finestra»), barriere che costi-tuiscono vie d’accesso possibili, eppure impene-trabili, alla conoscenza. È un procedere che si dà per scatti successivi, continui tentativi smorza-ti sul nascere di un corpo che, immerso fino al collo nell’azione scenica, non riesce ad effettuare il movimento necessario per arrivare a conosce-re la realtà degli avvenimenti in atto. E la lingua fa lo stesso, è come un balbettìo o un’omissione continua «dove dominano i ritmi della respirazio-ne […] il pizzicato ossessivo e profondo del con-trabbasso più che la percussione dei tam tam»53.
51 A. Porta, Aprire, VI, p. 125.52 Ivi, III, p. 124.53 id., Nel fare poesia, cit., p. 25.
Federica Paolini410
Ne scaturisce una narrazione dal ritmo spezza-to, discontinuo, che mette in dubbio il fatto stes-so che cose e personaggi continuino ad essere lì anche quando il riflettore scenico si spegne. Tut-to questo avviene in modo sistematico, al pari di una performance che si svolga sotto il ritmo per-cussivo della musica elettronica, o come in quei prodotti di videoart in cui l’immagine è generata dall’intensità delle onde sonore che, a loro vol-ta, generano onde luminose in alternanza luce / buio. Viene il dubbio, legittimo, che tutto ciò che si vede (che si legge, ma è come se si vedesse) esi-ste solo in quanto e solo finché il poeta, o il pitto-re, vi dirigono lo sguardo.
In Portrait of George Dyer in a mirror Bacon pone la figura all’interno di una struttura di-segnata da un fascio di luce che traccia un se-micerchio sul pavimento. Si tratta della tecni-ca cui l’artista ricorre spesso per ‘isolare’ i suoi personaggi da tutto il resto, da tutto quello cioè che non è essenziale o che si vuole tacere. La scena è occupata soltanto da un uomo taglia-to in due da una linea bisettrice e da una spe-cie di leggio contenente uno specchio. L’uomo è ritratto in un atteggiamento scomposto o, più precisamente, il rapido movimento del corpo ha fatto sì che l’immagine risultasse sfocata, im-possibile da precisare, tanto che una parte del-la testa resta visibile solo parzialmente. Le due metà del viso si ritrovano invece riflesse nello specchio che il personaggio è volto a guarda-re. Lo specchio, dunque, è in grado di cattura-re un’immagine che l’occhio nudo non riesce a cogliere, qualcosa di opaco, di ‘altro’ rispetto a ciò che normalmente si vede, «un oscuro riflesso dentro uno specchio senza luce»54, scriveva Na-thanael all’amico Lothar.
54 e.t.a. HoFFmann, L’uomo della sabbia, cit., p. 16.
Antonio Porta: poesia al limite 411
L’immagine nello specchio demolisce ogni costruzione logico-razionale elaborata dalla mente umana in quanto nega il principio di non contraddizione: nel riflesso il volto dell’uomo non compare come un tutt’uno, ma è diviso in due dal penetrare di una superficie azzurra che sembra riflettere un luogo diverso (un cielo, for-se) dalle pareti della stanza che ospita la scena.
Guardando meglio nello specchio si viene a conoscenza di altri dettagli importanti: la pelle dell’uomo è completamente coperta da abrasio-ni, ematomi dovuti, si potrebbe immaginare, ad una colluttazione, ma non viene fornito nessun elemento che possa aiutare a conoscere la cau-sa di queste ferite. Corpi e ombre, la figura e il suo riflesso hanno la stessa identica consisten-za, sono definite dallo stesso tipo di pennellata.
Uno spessore maggiore invece sembra ave-re il fumo della sigaretta che il personaggio tie-ne tra le dita, in assoluta disobbedienza alle ge-rarchie che i diversi livelli percettivi impongono nella vita reale. Una cosa è certa: Bacon non re-alizza imitazioni del mondo così come lo si co-nosce attraverso la mediazione dell’organo-oc-chio, è ‘altro’ ciò che lo preoccupa.Per prima cosa la presenza insistente dello specchio. Ba-con la sfrutta come via d’accesso al doppio, a ciò che Lacan chiama l’«Altro», la parte inconscia, l’unica autentica, dell’individuo. C’è però un’en-nesima incongruenza nel dipinto che concorre ad aumentare il carattere perturbante della sce-na: l’immagine riflessa non guarda colui che si specchia né colui che guarda il quadro, ma è ri-volta altrove, in una direzione sconosciuta. Le figure intessono un rapporto strettissimo con il soggetto che guarda, quell’Io che Porta si osti-na a negare nei Rapporti ma che si appresterà a riproporre, benché chiuso tra parentesi55, nel-
55 Cfr. S. colangelo, Aperta parentesi, «io», …, cit., p. 42.
Federica Paolini412
le Brevi lettere ’76. I personaggi di Bacon sono anzi una proiezione dell’Io dell’osservatore che, incanalato da uno sguardo complice, si ribalta sulla tela come Es, come Altro, svelando l’atteg-giamento non del tutto inconsapevole del sog-getto, il cui grado di coscienza è, sì basso, ma non nullo. Tutto il processo si svolge ad un li-vello quasi onirico. In Dialettica del sogno Roger Caillois scrive:
la personalità del dormiente viene usurpata da una perso-nalità sovrapposta, che egli vede vivere fuori dal suo con-trollo, in piena indipendenza, ma in maniera che giunge in qualche modo a comprometterlo […]. In altri momenti guarda quella sua emanazione aggirarsi tra i personaggi e segue rabbrividendo, o con indifferenza, i gesti che vengo-no compiuti al di fuori di lui, come su una scena, su uno schermo, al di là di uno specchio.56
Il metodo di creazione delle immagini duran-te il sogno segue un procedimento che non è to-talmente diverso da quello svolto dalla sfera della percezione durante la veglia. La differenza radi-cale tra i due stati si concentra invece sul piano sintattico. La costruzione del linguaggio in am-bito percettivo segue le regole della successione spazio-temporale e della logica, come fa quel tipo di pittura che si pone l’obiettivo di rappresenta-re la realtà in tutte le sue sfumature e secondo le leggi che la prospettiva impone. Nel sogno, in-vece, ogni immagine esiste singolarmente, per sé stessa, senza dover sottostare a rapporti gerar-chici con lo spazio circostante. Nell’attività oni-rica i riferimenti a coordinate spaziali ci sono e sono molteplici (strade senza fine, oggetti enor-mi, scale che si rimpiccioliscono, ecc.), ma non hanno la funzione di creare uno spazio organico, logico. Non ci sono sfumature e passaggi gradua-
56 R. cailloiS, Dialettica del sogno, in «Tempo presente», n. 1, 1962, p. 9.
Antonio Porta: poesia al limite 413
li di colori e dimensioni come invece nella real-tà filtrata dal processo percettivo: le ‘cose’ assu-mono i contorni di visioni allucinate, istantanee, isolate. È «object dans son évidence autonome»57, come annotava Umberto Eco nel 1961 in «Lettre Ouverte» con riferimento all’Informale, o la «visio-ne schizomorfa»58 che Giuliani indica come con-dizione indispensabile per una poesia novissima e che spinge Sanguineti a interpretare l’opera di Porta come un susseguirsi di «fotogrammi di una pellicola cinematografica»59.
Per isolare le figure Bacon generalmente le racchiude all’interno di uno spazio circoscrit-to e geometrico, di solito un cilindro del qua-le sono rese in modo evidente le due basi cir-colari. Questo schema strutturale non implica immobilità, ma aiuta a raggiungere l’isolamen-to del personaggio, poiché per Bacon, scrive Gil-les Deleuze, «il quadro comporta una pista, una specie di circo come luogo».60 Nel libro intitolato Francis Bacon. Logica della sensazione Deleuze spiega in modo chiaro il perché l’artista ricorra a questo procedimento:
Bacon lo dice spesso: per esorcizzare il carattere figurati-vo, illustrativo, narrativo che la Figura necessariamente avrebbe se non fosse isolata. La pittura non ha né modelli da rappresentare, né storie da raccontare. È come se aves-se due vie possibili per sfuggire al figurativo: verso la for-ma pura, per astrazione; oppure verso il puro figurale, per astrazione o isolamento. Se il pittore ha cara la Figura, se prende la seconda via, sarà dunque per opporre il «figura-le» al figurativo.61
57 u. eco, Les «Novissimi», la névrose et l’éngagement, in «Lettre Ouverte», n. 3, 1961; ora in N. Lorenzini - E. Risso (a cura di), Album Sanguineti, Lecce, Manni 2002, p. 80.
58 A. giuliani, Prefazione 1965, cit., p. 7.59 e. Sanguineti, Ideologia e linguaggio, cit., p. 127.60 G. deleuze, Francis Bacon. Logica della sensazione, Mace-
rata, Quodlibet 2008, p. 9.61 Ivi, p. 14.
Federica Paolini414
Il figurativo corrisponde dunque alla rap-presentazione. Ma l’isolamento della figura per Bacon è condizione indispensabile al fare pitto-rico, e ciò significa rompere con la rappresenta-zione per attenersi alla presentazione dell’even-to. In altri termini, la pittura di Bacon è un’ar-te che si dà in re, e non ante rem, così come, lo sottolinea Barilli62, è in re l’evento presentato da Porta attraverso un linguaggio tendente ad eliminare ogni intervallo discorsivo o descritti-vo per lasciar spazio ad una, libera apparente-mente ma in realtà predeterminata, successio-ne di fotogrammi.
Ciò che insieme alla figura viene presenta-to (oggetti, pavimento, pareti) non è posto dietro di essa, ma accanto, come dimostra il fatto che le ombre, quando sono presenti, non sono tan-to scure da evidenziare la posizione preminen-te del personaggio nello spazio del quadro, né il suo collocamento rispetto ad una sorgente lu-minosa. Esse sono piuttosto macchie di color grigio chiaro che hanno la stessa preminenza della figura e degli oggetti, senza volersi assu-mere il compito di stabilire una relazione di pro-fondità o di lontananza. Le campiture di colo-re sono date l’una accanto all’altra poiché la co-struzione dello spazio non è predeterminata, ma si dà nell’istante stesso in cui ha luogo la per-cezione. La critica al figurativo spinge Bacon a pensare le sue figure come se fossero sculture:
non ci ho ancora provato, ma a forza di pensarle come sculture, d’un tratto ho capito come potevo dipingerle. In-venterò delle strutture dove le immagini sembrano sorgere da fiumi di carne. Sembra un’idea tremendamente roman-tica, invece è del tutto formale. […] Ci dovrebbe essere un marciapiede elevato, su cui si muovono immagini di gente reale, colta durante la passeggiatina quotidiana, come sor-
62 Cfr. R. Barilli, La neoavanguardia italiana, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 62.
Antonio Porta: poesia al limite 415
gessero da pozze di carne. Vorrei proprio delle figure che sorgono dalla propria carne con tanto di cappello a bom-betta e ombrello, ma dovrebbero avere la stessa intensità delle figure della Crocifissione.63
«Figure che sorgono dalla propria carne», uomini vestiti alla moda che hanno «la stes-sa intensità delle figure della crocifissione». È lo stesso Barilli ad accostare le figure di Bacon ai personaggi della poesia di Porta, «apparente-mente convinti di una loro normalità, come di volti affacciati allo specchio, ma costretti a sco-prire (o siamo noi a farlo per loro) di aver subi-to una degradazione irrimediabile»64. E non è un caso che Porta intitoli In re uno dei testi com-presi nei Rapporti:
Lo sguardo allo specchio scruta l’inesistenza,i peli del sopracciglio moltiplicano in labirinto,l’occhio nel vetro riflette l’assenza, nel foltoi capelli, temporanea parrucca, sgomentano le mani:cadono sulle guance.
L’inquietudine prolungata mette in evidenzail mortale infinito dei pori dilatati,estrema avventura di un oggetto che si trucca,sceglie una direzione inconsapevole o folle.
Dietro il lavabo il corpo in oscillazionesfugge l’abbaglio, rivoltante presenza,indicatrice e lampante, nella camera a vuototra le piume mulina la soffocazione.65
In questi versi lo sguardo percepisce le parti anatomiche del volto riflesso come staccate dal corpo, come ‘altro’ da sé. I capelli diventano una «temporanea parrucca» che spaventa le mani
63 F. Bacon, La brutalità delle cose. Conversazioni con David Sylvester, Roma, Fondo Pier Paolo Pasolini 1991, pp. 69-70. I cor-sivi sono nostri.
64 Cfr. R. Barilli, La neoavanguardia italiana…, cit., p. 66.65 A. Porta, In re, p. 102.
Federica Paolini416
cadendo sulle guance. La scena, gli eventi pre-sentati hanno un carattere perturbante, si svol-gono nell’inquietudine più profonda. Chi leg-ge Porta si trova nella stessa situazione di colui che osserva una tela di Bacon: lo spettatore-let-tore guarda il personaggio guardarsi allo spec-chio («estrema avventura di un oggetto che si trucca»), e facendolo sceglie la strada dell’incon-sapevolezza o della follia, finendo per percepi-re sé stesso come un oggetto riflesso nello spec-chio. Negli ultimi quattro versi il soggetto spec-chiante torna infine a percepirsi come un’unità, un corpo, una «rivoltante presenza» da contrap-porre al sentimento dell’«inesistenza» e dell’«as-senza» prevalente nella prima quartina. Più che pezzi di manichini scomponibili, come li inten-de Adriano Spatola66, le parti anatomiche disse-minate qua e là nei testi portiani degli anni ses-santa sono pezzi di carne umana vera e propria, di cui è possibile percepire peso, forma e mate-ricità. Non è l’ottica distaccata e a tratti ironica dei surrealisti quella che prevale nella poesia di Porta, altrimenti accostabile alla pittura di Dalì e di Magritte o anche a quella Pop art di genere più critico come i calchi di Segal. È invece una poesia fatta di corpo, di materia, popolata da ‘cose’ e personaggi che, è utile ripeterlo, «sem-brano sorgere da fiumi di carne», o meglio, «da pozze di carne», come accade alle figure ‘inca-strate’ in una tela di Bacon. Il personaggio di In re sta «dietro il lavabo» e lì cerca di nascondere la propria degradazione, di sfuggire l’«abbaglio».
In Figure standing at a Washbasin Bacon presenta una figura sfocata, colta nell’atto spa-smodico di aggrapparsi all’ovale del lavabo per non mostrare il proprio stato di degradazione fuggendo attraverso il tubo di scarico. I corpi di
66 Cfr. A. SPatola, Poesia a tutti i costi, cit., pp. 51-53.
Antonio Porta: poesia al limite 417
Bacon sono chiusi in una solitudine che esclu-de ogni spettatore. Deleuze precisa:
fin dall’inizio, la Figura è il corpo, e il corpo ha luogo nello spazio cinto dal tondo. Ma il corpo non è semplicemente in attesa di qualcosa che provenga dalla struttura, esso at-tende qualcosa in se stesso, compie uno sforzo su sé stes-so per diventare Figura. Adesso qualcosa avviene proprio nel corpo: esso diventa sorgente del movimento. Il proble-ma non è più quello del luogo, bensì dell’evento. Se vi è sforzo, e anche intenso, non è affatto uno sforzo ecceziona-le, quasi si trattasse di un’impresa superiore alle forze del corpo e diretta a un soggetto determinato. È proprio il cor-po che si sforza, o piuttosto è in attesa di fuggire. Non sono io che tento di fuggire dal mio corpo, è il corpo stesso che tenta di fuggire da… Insomma, uno spasmo; il corpo come plesso, e il suo sforzo o la sua attesa di uno spasmo.67
«Sono i corpi che vincono»68, osservava San-guineti analizzando I rapporti. In Bacon la sce-na è completamente costruita sui movimen-ti spasmodici e disperati che i corpi compiono per fuggire l’abiezione e l’orrore dell’esistenza. E questo sforzo è teso ad eliminare ogni parven-za di spettacolo, e dunque ogni spettatore che di quell’abiezione può farsi testimone. La sce-na allora si riduce ad inquadrature ristrette su muscoli e tendini calcificati nell’attesa, attesa che accada qualcosa o attesa di fuggire, certa-mente attesa che finisca l’umiliazione insoppor-tabile di dover mostrare ad altri e a sé stessi la propria abiezione. Questa tensione estrema che contrae e dilata i muscoli è definita da Deleuze «atletismo»,69 termine che sottolinea la tragicità, apparentemente ingiustificata, che accompagna tutta la dinamica. Le azioni compiute dai corpi infatti non sono prettamente atletiche. Si tratta di gesti comuni come sbattere la porta davan-
67 g. deleuze, Francis Bacon…, cit., pp. 40-41.68 e. Sanguineti, Ideologia e linguaggio, cit., p. 127.69 g. deleuze, Francis Bacon…, cit., p. 33.
Federica Paolini418
ti ad un intruso o specchiarsi, movimenti che comporterebbero un’esecuzione semplicissima e che invece le figure compiono in modo goffo a causa di uno spasmo immobilizzante, teso a fuggire quella che in In re Porta chiama «rivol-tante presenza»70.
Il poeta agisce in modo molto simile nel mo-mento in cui spezza il movimento dei suoi per-sonaggi in atomi chiusi, anch’egli costringendo-li a scatti, a sforzi spasmodici per cercare di li-berarsi. Quanto scrive Niva Lorenzini a propo-sito dello spazio della poesia in Aprire fornisce delucidazioni utilissime per cogliere la vicinan-za estrema del modo di operare di Porta e di Bacon. Conviene ripeterlo: in Porta «lo spazio è quello asfittico di chi sta dietro, di chi sta den-tro, bloccato in una geometria rigidamente peri-metrata. Di lì preme per sottrarsi alla reclusio-ne […]»71. Se il ruolo svolto da oggetti-filtro come tende, porte e finestre in Aprire è dunque quello di ostacolare tanto la percezione visiva quanto il movimento del personaggio, e del lettore, all’in-terno dello spazio della poesia, in In re l’even-to coincide con lo spazio delimitato geometrica-mente dai contorni dello specchio, la cui super-ficie riflette, come accade in Bacon, una realtà ‘altra’, opaca, deformata e deformante.
Figure standing at a Washbasin è la presen-tazione pittorica dello sforzo estremo compiuto da una figura che «preme per sottrarsi alla reclu-sione» e che, in preda ad uno spasmo, reagisce nella maniera più illogica possibile, cercando di cacciare la testa nel tubo di scarico del lavandi-no anziché dirigersi verso la finestra che si trova alle sue spalle, unica ‘vera’ via di fuga presenta-ta nel quadro. Si tratta, paradossalmente, di un movimento che rende immobili: se da un lato la
70 A. Porta, In re, p. 102.71 N. lorenzini, Corporalità e crudeltà…, cit., p. 6.
Antonio Porta: poesia al limite 419
figura è spinta irresistibilmente a nascondere la sua vergogna, la sua abiezione, dall’altro com-pie uno sforzo del tutto inutile perché anziché indirizzarla alla fuga la immobilizza rendendola incapace di agire razionalmente. Questo il moti-vo per cui i volti dei personaggi appaiono in Ba-con deformati, tumefatti, eccessivamente allun-gati o allargati: essi sono lo specchio di questa lacerazione, è come se somatizzassero la con-traddizione che li dilania dall’interno nelle mo-struose escrescenze che sfigurano loro il volto. Precisa Deleuze: «la Figura non è soltanto il cor-po isolato, ma il corpo deformato che fugge»72, o che tenta di fuggire da sé stessa.
In un ennesimo ritratto di George Dyer (Two studies of George Dyer, 1968) la figura è inten-ta a guardare se stessa attraverso uno specchio buio, nero, e nel riflesso vede il suo volto de-formarsi, contorcersi e assumere sembianze be-stiali. La testa viene coinvolta in questo proces-so di sgretolamento della forma e finisce per as-sumere dei tratti animali. Per Bacon non con-tano tanto i tratti del volto quanto più precisa-mente la testa, intesa non come insieme di ossa che vanno a costruire la struttura del cranio, ma come appendice carnosa, tumore del corpo:
il corpo è Figura, non struttura. Inversamente la Figura, essendo corpo, non è volto e neanche ha volto. Essa ha però una testa, perché la testa è parte integrante del cor-po. Può addirittura ridursi alla testa. Come ritrattista, Ba-con è pittore di teste, non di volti. Tra le due cose c’è una grande differenza.73
Deleuze continua la sua analisi affermando che i corpi, o meglio, le teste di Bacon sono abi-tate dallo spirito animale che è nell’uomo, ma-
72 g. deleuze, Francis Bacon…, cit., p. 46.73 Ivi, p. 51.
Federica Paolini420
iale, cane o uccello che sia, e questo spirito ani-male spinge il pittore a «disfare il volto, ritrovare o far emergere la testa sotto il volto». Sono dun-que delle teste-carne e non delle teste-struttu-ra, non si tratta né di somiglianze tra uomo e animale né dell’animale come forma, ma «dell’a-nimale come tratto, per esempio un tratto fre-mente di uccello in avvitamento […]»74. La car-ne è ciò che accomuna l’uomo alla bestia, e la carne presentata da Bacon è carne viva perché assume su di sé tutte le sofferenze causate dal-la violenza in atto nei confronti delle teste-carne e ne sfigura i volti rendendoli carne viva (flesh, chair) o persino carne da macello (meat, viande).
Nella storia del pensiero occidentale ogni malformazione, ogni mostruosità fisica è con-siderata come anormale, come deviazione dal-la norma. L’uomo, animale razionale, è l’indivi-duo inteso come soggetto unitario, sintesi equi-librata di un corpo sano e di una mente lucida. Questa concezione ha resistito a lungo ed è sta-ta definitivamente smantellata soltanto dall’av-vento della psicanalisi, votata allo studio non dell’uomo razionale ma di quello del sottosuo-lo, del «sub-umano», di ciò che Lacan chiama «Altro». In Bacon il lato più oscuro della psiche traspare soprattutto attraverso le deformazioni corporali, conseguenza dell’azione dello spirito-animale che anima la carne delle figure e che viene presentato dal pittore o attraverso la de-formazione in atto delle teste o accanto alle figu-re stesse, sotto forma di riflesso nello specchio o di vera e propria presenza animale. In Frag-ment of a Crucifixion è vera la seconda ipotesi. Al centro della composizione c’è il grido della car-ne macellata, sanguinante, ferita dallo sguardo di un ammasso animale che si sporge giù dalla croce. Il buco nero della bocca spalancata che
74 Ivi, p. 52.
Antonio Porta: poesia al limite 421
emette l’urlo non è che un’ennesima possibile via di fuga per la carne martoriata. Ma la figura, come accade sempre in Bacon, resta chiusa in un movimento immobile. Carne macellata e am-masso animale sono costruiti con la stessa ma-teria corporea e sanguinolenta. «La testa-carne macellata è un divenire-animale dell’uomo.
E in questo divenire, l’intero corpo tende a fuggire, e la Figura tende a raggiungere la strut-tura materiale»75. La figura è tesa nell’atto del-la fuga ma non può muoversi realmente perché resta chiusa all’interno di una geometria rigida costruita proprio per isolarla da tutto il resto. L’effetto sfocato delle teste, che in Bacon sinte-tizza movimenti e deformazioni corporee in atto come in una fotografia venuta mossa, trova in Porta, oltre alla tecnica della «frammentazione del narrato», una seconda via per esprimersi: il «divenire animale», la metamorfosi dell’uomo in animale. I riferimenti alla carne e agli animali nei testi portiani sono altrettanto fitti che nel-la pittura di Bacon. Corpi e teste per Porta sono in continuo divenire, si sciolgono («il naso sfalda per divenire saliva»76), si dilatano («le narici dila-tate… labbra moltiplicate…labbra dilatate»)77, si fagocitano a vicenda («per piccole sevizie, aspet-tano / morsicature, lente masticazioni»78). Il vol-to si contorce, mutila sé stesso fino a rendersi irriconoscibile, finendo per assumere dei trat-ti animali.
Porta non si limita ad utilizzare la figura animale per fini retorici. Non si tratta dell’ani-male come forma o come somiglianza ma, come in Bacon, dell’«animale come tratto»79, come me-
75 Ivi, p. 69.76 A. Porta, La palpebra rovesciata, p. 103.77 id., Rapporti umani, II,V, p. 127.78 Ivi, p. 128.79 g. deleuze, Francis Bacon …, cit., p. 52.
Federica Paolini422
tamorfosi o via di fuga. Nei testi portiani il «far-si animale»80, come suggerisce Barilli, costitui-sce una via d’accesso a forme di soggettività e di percezione più complesse della sfera del visivo. I riferimenti all’universo zoologico sono sempre accompagnati da un contesto che permette agli animali di non esistere soltanto a scopo metafo-rico, ma agli animali Porta chiede azioni, happe-ning, polisensorialità senza confini.
80 Cfr. R. Barilli, Il farsi animale chiave d’accesso al mondo di Porta, in «il verri», n. 41, ottobre 2009.
Antonio Porta: poesia al limite tra speech act e per-formance - Antonio Porta: poetry at the border be-tween speech act and performance
Federica Paolini
In questo articolo si propone una riflessio-ne sulla poesia di An-tonio Porta negli anni sessanta in rappor-to, o in contrapposizio-ne, ad alcune corren-ti artistiche del ’900, quali il Surrealismo, la Pop Art, l’Informale e la pittura di Francis Bacon. Il corpo umano è ‘presentato’ da Por-ta non come struttu-ra verosimigliante, ma come carne viva (flesh, chair) o carne da ma-cello (meat, viande), e in quanto tale diviene oggetto di una crudeltà non semplicementen-te ‘rappresentata’, ma messa in scena
This essay deals with Antonio Porta’s po-etry of the sixties in relation, or in con-trast, with some ar-tistic movements of the twentieth centu-ry, such as Surreal-ism, Pop Art, Informal Art, and the paintings of Francis Bacon. Porta “presents” the human body not as a verisimil structure, but as living flesh/chair or meat/vi-ande, and make it the object of a cruel ap-proach which is not simply ‘represented’, but staged.
Riassunto - Abstact
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 425-445
Giuliana Benvenuti
Raccontare la colonia. Sul «romanzo storico» italiano contemporaneo.
Se è vero, come ha scritto Uspenskij1, che narrare il passato vuol dire fare in modo «che un avvenimento venga percepito
come rilevante per la storia; cioè semioticamen-te marcato sul piano storico» non sarà priva di significato la rinnovata attenzione della nostra recente letteratura per l’impresa coloniale ita-liana. Per questo, all’interno delle tante narra-zioni che negli ultimi trenta anni almeno han-no fatto del romanzo storico e delle sue trasfor-mazioni (docudrama, factfiction) uno dei generi di maggiore interesse e successo, vorrei soffer-marmi appunto su quelle opere che riscrivono, reinterpretano, fanno riaffiorare la memoria e il trauma del colonialismo italiano.
Le modalità secondo le quali queste nar-razioni organizzano il passato come un testo e lo leggono dal punto di vista del presente, sono differenziate, come vedremo, anche in vir-tù della diversità che distingue gli autori «italia-ni» (Camilleri, Brizzi, Lucarelli, Longo, Manfre-di, Domenichelli, Coscia tra gli altri) dalle au-trici e autori «migranti» e/o «postcoloniali» (tra esse Dell’Oro, Ghermandi, Ali Farah), una di-stinzione a ben vedere estremamente problema-tica perché l’etichetta «postcoloniale» indica un post- che caratterizza il presente come appun-to successivo all’epoca della decolonizzazione, al quale dunque tutti gli autori e le autrici in questione sono parte. Tuttavia, l’etichetta «post-
1 B. uspenskij, Semiotica e storia, Milano, Bompiani, 1988, p. 15.
Giuliana Benvenuti426
coloniale» non è un mero indicatore tempora-le, implica al contrario l’assunzione consapevo-le di una prospettiva critica nei confronti dello spazio-tempo coloniale che finisce per metter in discussione la stessa definizione di «letteratu-ra italiana», in particolare il suo ancoraggio alla nazione. Negli ultimi vent’anni in Italia abbia-mo assistito all’emersione di voci autoriali che abitano un’Italia che si muove verso un orizzon-te post-nazionale, con tutto ciò che una simile definizione implica anche sul piano letterario. Si tratta delle voci costitutive della «letteratura postcoloniale italiana», etichetta ancora poco in uso presso la critica letteraria italiana, che indi-ca un insieme di testi nei quali la modernità eu-ropea emerge come modernità sfigurata, anche, e significativamente, dal colonialismo. Testi di autrici e autori come Gabriella Ghermandi, Cri-stina Ali Farah, Erminia Dell’Oro, Igiaba Scego, Shirin Ramzali Fazel, non raccontano semplice-mente un’altra storia, contrapposta, entro una prospettiva duale, al racconto dominante, bensì costringono il critico letterario e lo storico a fare i conti con la compresenza di storie e memorie che interrompono la continuità della narrazione della storia nazionale.
La presa di parola di autori migranti e pro-venienti dalle ex-colonie ha iniziato a mettere in questione il canone della letteratura italia-na e l’identità che su di esso si fonda, un ca-none che ha, fino a tempi recenti, escluso ogni riflessione sul nesso tra formazione dello Sta-to-nazione e impresa coloniale2. Le scritture mi-
2 Tra le più recenti opere di storici e critici letterari che han-no dato vita ad un ripensamento del ruolo del coloniasmo nel-la formazione dell’identità italiana cfr., tra gli altri, D. RodoGno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche d’occupazione dell’Italia fascista in Europa 1940-1943, Torino, Bollati Boringhieri 2003; V. peRilli, Miti e smemoratezze del passato coloniale italiano, in «Controstorie», n. 1, 2008, http://www.controstorie.org/content/
Raccontare la colonia 427
granti e postcoloniali sono un luogo di nego-ziazione all’intersezione tra lingue e culture, ri-mettono in gioco e in movimento le costruzioni identitarie degli stati nazionali, incrinano la re-lazione stretta stabilitasi tra lingua, letteratu-ra e nazione, fondativa, com’è noto, dell’identità nazionale italiana. Interpretando l’impianto te-leologico della Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis, Ezio Raimondi ha scrit-to che questa «fenomenologia dello spirito italia-no» è «un’invenzione»3 nella quale «tutti gli ele-menti, anche i particolari minori sono ricondot-ti ad un unico vettore, che è il progredire della letteratura italiana, il definirsi della sua inter-na identità, il realizzarsi della sua modernità»4. Siamo in presenza della «invenzione di una tra-dizione», di un processo di ricostruzione storica che Hobsbawm considera cruciale nella forma-zione dello Stato-nazione5.
view/8/32/; G. ZaffiRi, L’Impero che Mussolini sognava per l’Italia, Napoli, The Boopen 2008; N. laBanca, Oltremare. Storia dell’espan-sione coloniale italiana, Bologna, Il Mulino 2002; A. schiavulli, La guerra lirica. Il dibattito dei letterati sull’impresa di Libia (1911-1912), Ravenna, Giorgio Pozzi Editore 2009; L. Ricci, La lingua dell'impero. Comunicazione, letteratura, e propaganda nell'eta del colonialismo italiano, Roma, Carocci 2005.; G. tomasello, L’Africa tra mito e realtà. Storia della letteratura coloniale italiana, Palermo, Sellerio 2004; M. paGliaRa, Il romanzo coloniale. Tra imperialismo e rimorso, Roma-Bari, Laterza, 2001; R. Bonavita, Spettri dell’altro, Bologna, il Mulino 2009; G. BaRReRa, Dangerous liaisons. Colonial Concubinage in Eritrea, 1890-1941, Evanstone (Illinois), Northwe-stern University 1996; B. soRGoni, Parole e corpi. Antropologia, di-scorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eri-trea (1890-1941), Napoli, Liguori 1998.
3 E. Raimondi, Letteratura e identità nazionale, Milano, Bru-no Mondadori, 1998, p.
4 E. Raimondi, Letteratura e identità nazionale, cit., p. 15. Si veda anche R. ceseRani, Raccontare la letteratura, Torino, Bollati Boringhieri 1990.
5 Scrive Hobsbawm: «Non dobbiamo lasciarci fuorviare da un paradosso curioso, ma comprensibile: in genere le nazioni mo-derne, con tutto il loro armamentario, pretendono di essere l’op-posto della novità, si dichiarano radicate nell'antichità più remo-ta, stanno al polo opposto delle comunità costruite, cioè umane,
Giuliana Benvenuti428
Rispetto a questa costruzione identitaria che è stata capace di durare piuttosto a lun-go tra Otto e Novecento, la coesistenza oggi sul suolo nazionale di forme sociali e culturali non omogenee, originarie di luoghi tra loro anche profondamente diversi, introduce un elemento di instabilità che, entro il quadro della lettera-tura, è ben espresso dalla pressione esercita-ta sul canone dalle opere di scrittori migranti e postcoloniali. Un ulteriore elemento di com-plessità e discontinuità è la presenza in queste opere di uno spazio e di un tempo che si con-frontano con l’universo di partenza e con quel-lo di arrivo costringendo il critico letterario e lo storico a riflettere su rappresentazioni del pas-sato che riposano sulla linearità e la scansione cronologica della Storia europea, a confrontar-si con l’emersione di tracce di storie che sono rimaste sino ad ora invisibili. Tracce che ven-gono alla luce in narrazioni implicate in «una dimensione del tempo non separabile dai tem-pi soggettivi, dalle vite degli antenati come delle nuove generazioni»6. A essere posta in questione non è dunque solo la rimozione del colonialismo italiano e delle sue efferatezze operata nel sen-so comune, che riposa sul mito degli «italiani
sono tanto «naturali» da non richiedere altra definizione che l'au-toaffermazione. Al di là delle continuità storiche o di altro genere inglobate nei concetti moderni di «Francia» e «francesi» – che nes-suno si azzarderebbe a negare – questi stessi concetti contengono inevitabilmente in sé una componente costruita o “inventata”. E proprio perché tanta parte di ciò che soggettivamente costituisce la “nazione” moderna rientra nella categoria di questi artifici, ed è legata a simboli o discorsi opportunamente addomesticati (quali la “storia nazionale”), in genere di origine relativamente recente, il fenomeno nazionale non può essere correttamente indagato senza considerare con grande attenzione «l’invenzione della tradizione», in E.J. Hobsbawm e T. Ranger (a cura di), L’invenzione della tradi-zione, Torino, Einaudi 1994, p. 13.
6 Cfr. G. pRoGlio, Memorie oltre confine. La letteratura postco-loniale italiana in prospettiva storica, Verona, Ombre corte 2011, p. XXX.
Raccontare la colonia 429
brava gente», già demistificato da storici come Del Boca, Labanca, Triulzi e altri7. Certo, queste narrazioni sono portatrici di un diverso punto di vista sulla storia coloniale dell’Etiopia, della Libia, della Somalia, dell’Eritrea, ma non è solo questo il punto, quanto piuttosto la circostan-za che in questi testi la letteratura e la storia di-vengono territori dai confini incerti8.
Per comprendere dunque i punti di contat-to e le divergenze che la produzione narrativa di argomento coloniale presenta nell’odierno pa-norama letterario italiano è necessario compie-re una operazione preliminare: superare la di-stinzione netta tra letteratura italiana e lette-ratura della migrazione e/o post-coloniale, per consentire la comparazione tra opere che usual-mente vengono trattate separatamente, essen-do la letteratura migrante o postcoloniale confi-nata in un recinto, magari dorato, entro il qua-le critici che quasi solo di essa si occupano co-struiscono categorie interpretative ad hoc. Il che non significa misconoscere le peculiarità di que-sta produzione, bensì farle emergere quali par-ti di un campo letterario in tensione all’inter-no di un’indagine relazionale che mostri secon-do quali modalità, dal punto di vista del presen-te, si selezionino e si interpretino gli avvenimen-ti passati in rapporto a come nella conoscenza collettiva se ne conserva il ricordo. Nelle riscrit-
7 Cfr. tra gli altri A. del Boca, Italiani brava gente?, Vicenza, Neri Pozza 2005; id., Gli italiani in Africa Orientale, 4 voll. Roma-Bari, Laterza 1976-84; N. laBanca, Una guerra per l'impero. Memo-rie della campagna d’Etiopia 1935-36, Bologna, Il Mulino 2005; E. saleRno, Genocidio in Libia, Manifestolibri 2005; A. tRiulZi, Dopo la violenza. Costruzioni di memoria nel mondo contemporaneo, Napo-li, 2005; id., Il ritorno della memoria coloniale, dossier «Afriche & Orienti», 1, 2007.
8 Cfr. f. sossi, intervento al seminario La letteratura colonia-le e postcoloniale italiana. Una giornata di studio, organizzato dal-la Fondazione Istituto Gramsci dell’Emilia Romagna, Bologna, 19 Gennaio 2010.
Giuliana Benvenuti430
ture della storia da parte di autori e autrici mi-granti le ragioni complesse della riapprorpiazio-ne del passato individuale e collettivo si intrec-ciano con la ricerca di identità. In Shame, Rush-die affronta nuovamente questo nodo e scrive:
All migrants leave their pasts behind, although some try to pack it into bundles and boxes – but on the journey something seeps out of the treasured mementoes and old photographs, until even their owners fail to recognize them, because it is the fate of migrants to be stripped of hi-story, to stand naked amidst the scorn of strangers upon whom they see the rich clothing, the brocades of continui-ty and the eyebrows of belonging9.
Una prima analisi potrà prendere le mosse dai due romanzi di Carlo Lucarelli, L’ottava vi-brazione, e di Gabriella Ghermandi, Regina di fiori e di perle10, e dalle osservazioni in merito già svolte da Paolo Jedlowski11, nel tentativo di approfondirle e precisarle. Lucarelli riprende il romanzo coloniale per descrivere la mentalità, l’immaginario, l’ideologia e lo sguardo del colo-nizzatore italiano, Ghermandi si riallaccia alla tradizione orale etiope e riprende dalla nostra tradizione il primo romanzo critico verso il co-lonialismo, quello di Flaiano, per «riscriverlo» in modo a sua volta critico.
Una ricostruzione storicamente fedele della mentalità e dello sguardo del colonizzatore ita-liano in Etiopia è offerta nel romanzo di Lucarel-li, che affronta una delle «pagine nere» dell’im-presa coloniale italiana, la sconfitta di Adua12.
9 S. Rushdie, Shame. A Novel, London, Vintage 1995 (1983), pp. 63-64.
10 G. GheRmandi, Regina di fiori e di perle, Roma, Donzelli 2007.
11 P. jedlowski, Passato coloniale e memoria autocritica, «il Mulino», n. 2, 2009, pp. XXX.
12 C. lucaRelli, L’ottava vibrazione, Torino, Einaudi 2008. Di lucaRelli si veda anche Ferenti. Racconto nero in tre fotografie e un
Raccontare la colonia 431
Se nella storia dell’Italia contemporanea il co-lonialismo è stato a lungo considerato una sor-ta di parentesi poco seria, non fondativa dell’i-dentità nazionale e non cruciale nei processi di modernizzazione, la circostanza che uno dei più noti romanzieri contemporanei, personag-gio pubblico e televisivo, decida di affrontare il passato coloniale non pare secondaria, denun-cia al contrario la volontà di riaprire una ferita non sanata, mettendo in luce le dinamiche delle relazioni coloniali13. Prima delle scritture recen-ti, fra i pochissimi segni di attenzione occorre menzionare subito il più celebre, che è il roman-zo di Ennio Flaiano, Tempo d’uccidere, pubbli-cato la prima volta nel 1947. Un romanzo po-tente, quello di Flaiano, per l’acuta critica del colonialismo condotta a mostrare come l’espe-rienza dell’invasione della colonia possa portare a una destrutturazione della Verità e la Razio-nalità della Storia. Il romanzo di Flaiano, inol-tre, mette in forse il nucleo portante dell’imma-ginario colonialista: la presunzione della cono-scibilità da parte del colonizzatore dell’alterità dei colonizzati14.
disegno, Milano, «Corriere della Sera», 2008, ora in aa.vv., Sei fuo-ri posto: storie italiane, Torino, Einaudi 2010, dove uno dei perso-naggi dell’Ottava vibrazione, Caraffa, diventa protagonista. Sulla sconfitta degli italiani ad Adua cfr. A. del Boca, Adua. Le ragioni di una sconfitta, Bari-Roma, Laterza 1997.
13 Prima delle scritture recenti, fra i pochissimi segni di at-tenzione occorre menzionare subito il più celebre, che è il roman-zo di e. flaiano, Tempo d’uccidere, pubblicato la prima volta da Longanesi nel 1947. Come ricorda Jedlowski «Il libro di Flaiano per più di cinquant’anni è rimasto pressoché l’unico romanzo ita-liano che abbia riguardato il passato coloniale. Neppure il cinema ha trattato il tema. Si possono citare solo due film: uno di Giu-liano Montaldo, nel 1989, tratto dallo stesso romanzo di Flaia-no, e Le rose del deserto di un Mario Monicelli ormai novanten-ne, nel 2006».
14 Per un’analisi di questi aspetti della scrittura di Flaiano mi permetto di rinviare a G. Benvenuti, Da Flaiano a Ghermandi:
Giuliana Benvenuti432
Il romanzo di Lucarelli riprende l’illustre tradizione del romanzo storico, entro però la cor-nice di una narrativa che ricorre frequentemen-te all’intersezione tra generi letterari, in questo caso il romanzo storico, il giallo e il vero e pro-prio «romanzo coloniale»15, compreso quello fa-scista, successivo ai fatti rappresentati nel ro-manzo di Lucarelli, che tuttavia Lucarelli sem-bra avere presente, quale fonte per la rappre-sentazione dello «sguardo coloniale», fortemente razzista e maschilista. La centralità della com-ponente «rosa», spesso cardine dello sviluppo del plot, permetteva ai romanzi del colonialismo di riallacciarsi a quella rappresentazione della sensualità e del mistero delle donne indigene, all’immagine della Venere nera, che tanta parte ha avuto nella letteratura esotista, mantenen-do tuttavia una salda gerarchizzazione razzia-le, che sarà all’origine della crisi di questo stes-so sottogenere. L’intreccio di questi romanzi è tinto di rosa al punto che con le leggi razziali fi-nirà per esaurirsi16. L’eros è parimenti il moto-re dell’azione del romanzo di Lucarelli: il trian-golo amoroso tra il tenente, l’uomo d’affari e la moglie di quest’ultimo, la relazione del tenen-te con Aicha, le perversioni sessuali dell’ufficia-le sospettato di essere un assassino di bambi-ni, sono i centri propulsivi dai quali si dipartono gli intrecci costitutivi del romanzo, che procede sulla via del giallo, del romanzo di guerra e d’av-
riscritture postcoloniali, in corso di stampa presso la rivista «Nar-rativa», n.2, 2012.
15 Pensiamo ai fortunati romanzi di e. salGaRi, La favorita del Mahdi, Milano, Guidoni 1887, La Costa d’Avorio, Genova, Do-nath 1898 e Le Pantere di Algeri, Genova, Donath 1903 o a quel-lo di e. scaRfoGlio, Il cristiano errante, Roma, Enrico Voghera Edi-tore 1897, ma anche ai numerosi racconti di viaggio e alla varia pubblicistica che prospera soprattutto dopo la sconfitta di Dogali.
16 R. Bonavita, Spettri dell’altro. Letteratura e razzismo nell’I-talia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2009.
Raccontare la colonia 433
ventura e del rosa, seguendo il ritmo dell’inve-stigazione e degli intrecci amorosi. Del resto, la stessa copertina evoca l’eros e il mistero, ricor-rendo alla consueta sovrapposizione tra il fasci-no e il mistero femminili e quelli della terra afri-cana. QUI NON SAREBBE MALE RIPRODURRE LA COPERTINA – è POSSIBILE??
Rispetto al rapporto tra il tenente e la don-na indigena, la ricostruzione storicamente fede-le della mentalità del colonizzatore porta alla ri-produzione degli stereotipi razzisti dei quali è portatore il protagonista che si innamora del-la donna bianca, mentre intrattiene un rappor-to di esclusivo possesso erotico con la «cagna nera». La donna nativa è reificata, privata di ca-pacità intellettive e riflessive, relegata alla sfe-ra istintuale. Aicha, donna kumena innamora-ta del protagonista è rappresentata con i tratti di un deciso primitivismo, che incarna l’Africa nera con il suo portato di erotismo esotizzante. Alla torsione verso il giallo e il noir del romanzo storico si intreccia la ricerca di verosimiglian-za: la ricerca storica e la consulenza di storici di professione servono, oltre che alla ricostru-zione dei luoghi e dei tempi degli eventi, a ren-dere plausibile la mentalità dei protagonisti, il loro sguardo, i loro desideri. L’atteggiamento del protagonista, spesso critico verso la campagna d’Etiopia, è fedele alla costruzione di un perso-naggio formato dall’ideologia colonialista e delu-so dall’esperienza della colonia.
La ricerca di verosimiglianza ci conduce al romanzo storico, nel quale, Manzoni docet, la parte di invenzione deve restare plausibile, sot-toposta appunto alle regole della verosimiglian-za. In tale ricerca la componente storica del ro-manzo tuttavia si esaurisce per lasciare spa-zio a una dimensione leggendaria, evocata dalla quarta di copertina che recita: «Dove una pagi-na oscura della nostra storia diventa leggenda».
Giuliana Benvenuti434
Vero è che, come ha notato Jedlowski, la parola «leggenda» evoca qualcosa di lontano e sfuma-to, che confligge con la precisione della ricostru-zione storica, ma soprattutto evoca avvenimenti che hanno qualcosa di eroico, ha un senso che è difficile intendere come peggiorativo e sicura-mente non include o sollecita ad alcun atteggia-mento critico17. Leggendo il libro, tuttavia, an-corché l’innalzamento del tono verso l’epica sia presente soprattutto nella descrizione della bat-taglia di Adua, non possiamo non constatare il fatto che di una epica rovesciata si tratta. De-gli «eroi», di questi personaggi a ben vedere poco leggendari, vengono messe in mostra l’ottusità, la perversione, l’incapacità e la Storia ci appa-re intessuta della piccolezza di meschine grati-ficazioni di desideri e istinti deviati, facendo ap-parire l’impresa coloniale piuttosto farsesca che leggendaria. Tale curvatura dell’epica verso la farsa, i cui intenti critici verso il colonialismo sono evidenti, priva la storia della componente tragica e propone al lettore un’immagine in fon-do consolatoria della sconfitta di Adua, prodotta in ultima istanza dalla insufficienza dell’esercito italiano sul piano morale prima ancora che su quello militare. Lucarelli svela al lettore i moti-vi della sconfitta, del fallimento: l’inadeguatezza dell’Italia rispetto alle proprie pretese di diveni-re una grande potenza coloniale. E così facendo riprende il giudizio già espresso, dopo Dogali e dopo Adua, da molti osservatori ottocenteschi, critici del modo nel quale i governi, e in partico-lare il governo di Crispi, condussero l’impresa. Ma, certo, Lucarelli compie un passo oltre: sma-schera la pretesa superiorità dell’uomo bianco e colonizzatore che decostruisce mostrando la piccineria dei colonizzatori, la loro verità uma-na, intessuta di debolezze e corruzione, il loro
17 Cfr. jedlowski, cit., p. XXX.
Raccontare la colonia 435
essere tutt’altro che all’altezza della presunta «missione civilizzatrice».
è insomma l’auscultazione del carattere de-gli italiani il nucleo di questo romanzo factfictio-nal nel quale ad essere al centro dell’osservazio-ne non sono tanto gli eventi quanto le relazio-ni, le reazioni, i sentimenti, la quotidianità fat-ta di microcorruzione, consunzione, disillusio-ne, degli italiani in colonia. I personaggi del ro-manzo sono funzioni di un’indagine delle moti-vazioni del fallimento, un fallimento annunciato e motivato dalla scarsa efficienza di un esercito che in colonia riproduce i guasti di una italia-nità intessuta di rilassatezza, indolenza, oppor-tunismo e scarso attaccamento agli ideali della patria che caratterizzano tanto le truppe, quan-to le alte gerarchie militari. Gli italiani vi sono ritratti come colonialisti disorganizzati: riemer-ge l’immagine del colonialismo straccione, quel-lo di chi era meno avanzato (in termini di pro-gresso tecnologico e apparato militare) di altre potenze coloniali, ma soprattutto era incapace di disciplina. L’Africa è il luogo nel quale cado-no barriere e, lontani dal controllo sociale subi-to in patria, i protagonisti possono perdersi nel-le loro piccolissime e ben poco eroiche storie di ordinaria corruzione. La colonia appare come lo spazio-tempo nel quale gli italiani sfogano desi-deri e ambizioni che non avrebbero trovato rea-lizzazione in patria, nel quale l’Africa è, secondo la nota definizione di Flaiano, uno «sgabuzzino delle porcherie». In questa messa in scena del-la pochezza dei colonizzatori, parodia della pro-paganda colonialista, risiede l’intenzione critica di quest’opera, che tuttavia trova il proprio li-mite nella negazione della tragedia e nel silen-zio al quale sono sostanzialmente consegnati i colonizzati, nonostante l’attenzione dello scrit-tore si rivolga, fatto raro nella narrativa italiana di argomento coloniale prodotta da scrittori au-
Giuliana Benvenuti436
toctoni, alle lingue dei colonizzati. La ricostru-zione delle relazioni in colonia resta consegna-ta al punto di vista del colonizzatore, al contra-rio di quanto accade nella cosiddetta letteratu-ra «postcoloniale», se intesa come corpus di te-sti portatori di un caratteristico effetto di decen-tramento del discorso coloniale e postcoloniale, che intende far riemergere la voce dei subalter-ni18, esclusa dagli apparati ideologico-discorsivi dominanti, dalle categorie politiche e da criteri di rappresentazione che ne distorcono e neutra-lizzano la soggettività. In risposta a tale esclu-sione la narrativa può proporsi come «il terreno sul quale sperimentare strategie di alterazione della discorsività, e quindi anche della storia»19. Nei testi di scrittici e scrittori «migranti» e/o «postcoloniali» il tentativo di recupero di memo-rie minacciate dall’oblio o quello di ricomposi-zione di memorie divise passa attraverso la ri-cerca di tracce e racconti almeno quanto attra-verso un lavoro di ricostruzione storica minu-ziosa e ha il proprio compimento nella messa in intreccio romanzesca. Vale dunque per questa scrittura ciò che Carlo Mazza Galanti ha scritto di autori impegnati a fare i conti con la memo-ria della Shoah:
Le indagini condotte dai narratori di Sebald, Modiano e Pe-rec sono storiche e autobiografiche allo stesso tempo. Ve-rità storica e scrittura letteraria si confondono nel tentati-vo di costruire zone di intelligibilità nella confusione della “post-memoria” (cfr. Hirsch 1997; Robin 2005). L’autofin-
18 Per chiudere il discorso su L’ottava vibrazione possiamo osservare che è opera da ascriversi a quella «letteratura dell’estre-mo» che sembra essere l’unica via per prendere la parola «quan-do ci si sia resi conto di non avere altro materiale da costruzione fuori della sterminata distesa di immagini e clichè che fungono da ossatura morfologica al modo in cui si forma la rappresentazione dell’esperienza» (cfr. D. GiGlioli, Senza trauma, Macerata, Quodli-bet 2011).
19 Cfr. pRoGlio, Memorie oltre confine, cit. p. xxx.
Raccontare la colonia 437
zione, a sua volta, sarà da considerarsi un’implicazione del paradigma indiziario: l’immaginazione è il collante che unisce le macerie, che dà senso ai frammenti sopravvissu-ti alla distruzione20.
L’alternarsi di storie di personaggi reali e immaginari contribuisce alla rielaborazione di un passato traumatico a livello personale e col-lettivo dando vita a romanzi che si lasciano alle spalle la scrittura cronachistica e di testimo-nianza caratteristica della prima stagione del-la scrittura di migrazione in Italia. Si tratta di opere che affrontano in modi diversi il nostro passato coloniale e nelle quali l’intreccio di sto-ria, memoria e letteratura si offre quale forma di «conoscenza integrativa»21.
In questa cornice rientra il romanzo di Ga-briella Ghermandi, Regina di fiori e di perle, che ha attirato l’attenzione della critica, ha posto in rilievo la problematicità dalla relazione con la lingua italiana (che per l’autrice, nata in Etiopia da madre italiana e padre etiope, è lingua pater-na e lingua del colonizzatore22), ha offerto una riscrittura della storia da una prospettiva che è anche di genere, nel punto di intersezione tra autobiografia e storia, polifonia e rivendicazione di parola. La voce narrante di questo romanzo è Mahlet, protagonista e «cantora» che racconta la propria singolare vicenda dall’infanzia all’età
20 Cfr. c.m. Galanti, Paradigma indiziario e fotografia: Se-bald, Modiano, Perec, in aa.vv., Guardare oltre. Letteratura, foto-grafia e altri territori, a cura di S. Albertazzi e F. Amigoni, Roma, Meltemi 2007, pp. 89-105.
21 Secondo la definizione offerta da E. said nell’Introduzione alla prima raccolta antologica di scritti del collettivo dei Subaltern Studies (riferita in quella sede alla storia indiana coloniale e post-coloniale), cfr. R. Guha - G. Ch. Spivak (a cura di), Subaltern Stu-dies. Modernità e (post)colonialismo, Verona, Ombre Corte 2002.
22 Cfr. I. sceGo, La questione della lingua in Ghermandi e Ali Farah, cit. Scrittrice e performer teatrale, Gabriella Ghermandi è nata ad Adis Abeba nel 1965 da padre italiano e madre eritrea e si è trasferita a Bologna nel 1979.
Giuliana Benvenuti438
adulta. Questo piano narrativo, costruito come un romanzo di formazione, s’intreccia al pia-no del racconto della storia etiope dalla vittoria di Adua contro gli italiani (1896) fino alla fine del regime di Mengistu (1991). La storia etio-pe è narrata a partire dalla raccolta di racconti di storie individuali, inseriti nella trama del ro-manzo. Mahlet, come Ghermandi, è una «racco-glitrice di storie» che toccano i nodi salienti della vicenda coloniale italiana: le atrocità della guer-ra, l’eroismo della resistenza etiope, le conse-guenze delle leggi razziali, l’uso dell’yprite.
La scrittura diviene per Mahlet, alter ego di Ghermandi, l’unica via di accesso a un passa-to che qui è collettivo e personale a un tempo: è ricerca di sé e presa di parola che afferma la propria presenza nel mondo, una presenza in-dividuale, ma anche collettiva. La ricerca stori-ca apre la strada alla polifonia, riportando i rac-conti (frutto di interviste, come il paratesto ci rammenta) di protagonisti della resistenza etio-pe o di uomini e donne che hanno vissuto l’epo-ca coloniale dalle due parti, dei colonizzati e dei colonizzatori. In questo modo il romanzo vuo-le essere restituzione della memoria di una col-lettività attraverso l’intersezione e l’intarsio ro-manzesco delle voci e l’invenzione di una cor-nice narrativa. Alla presa di parola dell’autrice italo-etiope corrisponde una precisa assunzione di responsabilità, che si concretizza nella con-tronarrazione della storia della colonizzazione italiana dell’Etiopia e nel tentativo di introdur-re nel racconto un doppio accento e un doppio sguardo.
La riscrittura della storia risponde a una esigenza di verità e prevede che il testo produ-ca un «effetto di realtà» che poggia sulla ricerca storica e sulle interviste, che si costruisce a li-vello testuale mediante la specifica combinazio-ne tra le informazioni trasmesse al lettore nel
Raccontare la colonia 439
paratesto e la storia-cornice, la storia appunto di Malhet, che come l’autrice diviene «cantora» delle storie che raccoglie, compiendo il proprio destino, annunciato fin dall’incipit del roman-zo. Questa combinazione di elementi provenien-ti dalla biografia dell’autrice, presentati al letto-re nel paratesto, e costruzione della protagoni-sta in relazione a tali elementi possiamo ipotiz-zare che svolga una funzione analoga a quella che a suo tempo, in Scott e Manzoni, era svol-ta dalla finzione del manoscritto ritrovato, se è vero che, come ha notato Fasano: «La finzione del manoscritto ritrovato, nella versione scot-tiana, e poi manzoniana, non perviene dunque anch’essa al mondo del favoloso edel romanze-sco, ma al contrario è allegoria dello sforzo di documentazione su cui si fonda l’istanza di re-altà del narratore»23.
La narratrice ci racconta di come le sia ac-caduto di raccogliere le storie, ci racconta nel-la storia-cornice come ha incontrato i tanti nar-ratori che prendono la parola; l’autrice ci avver-te, nel paratesto, di aver fatto delle interviste. La storia-cornice che ripercorre la vita della prota-gonista raccoglitrice e narratrice di storie serve anche a mostrare il percorso di ricerca dello sto-rico-romanziere, lo sforzo di documentazione su cui si fonda l’istanza di realtà del romanzo. Tut-tavia, la circostanza che la funzione a suo tem-po svolta dal manoscritto ritrovato sia collegata a informazioni relative alla biografia dell’autrice, alla sua vicenda personale, richiamata in mol-te forme nel paratesto (l’immagine di copertina è immagine dell’autrice QUI SAREBBE BELLO POTER RIPRODURRE LA COPERTINA, i ringra-ziamenti ricordano al lettore la sua origine etio-
23 P. fasano, L’importazione del romanzo storico in Italia. Scott e Manzoni, L’imbroglio romanzesco. Una teoria della comu-nicazione nei «Promessi Sposi», Firenze, Le Monnier 2007, p.71.
Giuliana Benvenuti440
pe) e dal cortocircuito tra autrice e protagonista cantora spinge il lettore a creare tra tali vicende biografiche e ciò che viene narrato un nesso con la verità e la realtà fondato non solamente sulla documentazione, quanto, e più essenzialmente, sulla testimonianza, e poco importa che non sia quasi mai testimonianza diretta, quanto raccol-ta di racconti, leggende ed esperienze altrui. La ricostruzione e la raccolta tramite interviste di racconti e di esperienze vissute da altri sta in un rapporto di reciprocità con la ricostruzione autobiografica e autofittiva: la ricerca identita-ria ha una dimensione storica e sociale. Quel-la di Ghermandi è una narrazione la cui istan-za di realtà è sorretta dal valore testimoniale (in modo diverso ma analogo rispetto a Saviano).
Il manoscritto ritrovato introduce un’istan-za di realtà che non sollecita adesione emoti-va, mentre gli aspetti legati alla biografia che spesso il paratesto degli scrittori postcoloniali e migranti ci presentano prevedono un’istanza di realtà veicolata dal vissuto, personale e col-lettivo, e intessuta di empatia. I racconti raccol-ti sono proposti come frammenti sopravvissu-ti alla distruzione che attraverso l’intreccio nar-rativo riprendono vita e costituiscono un appel-lo al lettore. L’esito è, nel caso di Regina di fio-ri e di perle, un romanzo che descrive la possi-bile ricomposizione di memorie divise in vista di una necessaria coabitazione nel presente. L’ur-genza di narrare nasce da un duplice movimen-to: da un lato il timore dell’oblio, dall’altro l’ur-genza di scrivere per gli ex colonizzatori. Regina di fiori e di perle si propone come un organismo narrativo nel quale può prendere forma una co-noscenza storicamente fondata quanto affetti-vamente connotata, lontana dall’ironia postmo-derna, intessuta del dramma di una moderni-tà sfigurata. Per questo schiude tutto il suo si-gnificato se commisurato alla volontà, in epoca
Raccontare la colonia 441
postcoloniale, di non dimenticare e di far pro-cedere la ricomposizione da un processo di co-noscenza anziché di rimozione collettiva. Gher-mandi guarda alla costruzione di un nuovo or-dine di rapporti possibile: la scrittura è il luogo della memoria e della riconciliazione, è cura di un trauma, è ciò che consente di immaginare un futuro. Si tratta dunque di un caso di «me-moria che prende posizione»24. Lo scavo stori-co serve al reperimento di voci negate, alla ri-costruzione della storia dei vinti, alla custodia di una memoria che dev’essere salvata da un oblio che rischia di essere definitivo. Ma ha an-che, accanto a una volontà di ripristino di ve-rità neglette, una valenza che potremmo defi-nire «performativa»: chiama in causa il lettore, lo interpella, ne sollecita la dimensione affettiva e psicologica, gli chiede complicità e collabora-zione. Come scrive la postfatrice, Cristina Lom-bardi-Diop, esso è «un gesto verso l’elaborazio-ne di una memoria che, nell’Italia contempora-nea, segna finalmente il tempo di sanare quel-la ferita»25. Il lettore, in altri termini, è chiama-to a impegnarsi con la scrittrice in una comune opera di conciliazione e apertura di spazi futuri di convivenza, è spinto a immaginare un futu-ro di possibile coabitazione, una nuova colletti-vità a venire26.
Da questo punto di vista il romanzo di Gher-mandi rientra in una più ampia produzione di romanzi «storici» – definizione di genere da in-tendersi qui in tutta la provvisorietà che la stes-sa analisi dei due romanzi ha messo in luce e che vede nella produzione narrativa contempo-
24 Cfr. P. jedlowski, Passato coloniale e memoria autocritica, cit., p. XXX.
25 In Regina di fiori e di perle, cit., p. XXX.26 Cfr. G. aGamBen, La comunità che viene, Torino, Bollati Bo-
ringhieri 2001.
Giuliana Benvenuti442
ranea molte altre possibili declinazioni27 – oggi presenti sulla scena, che potremmo definire provvisoriamente «performativi», nei quali cioè il tessuto evocativo e affettivo chiede al lettore partecipazione emotiva e una risposta soggetti-va dinanzi a un’esperienza personale affettiva-mente connotata e insieme collettivamente rap-presentativa. Nel caso di Gabriella Ghermandi il coinvolgimento del lettore è funzionale alla ri-lettura critica del passato in vista delle ragioni di un presente di riconciliazione, in altri casi – Saviano, Wu Ming in particolare – il lettore vie-ne coinvolto in narrazioni che hanno l’intenzio-ne di modificarne la percezione del presente, o del passato e attraverso esso del presente, per spingerlo piuttosto al rifiuto, alla negazione di un assetto di potere, alla resistenza, all’azione.
Concludendo, e tornando alla limitata ana-lisi qui proposta, credo che sia possibile affer-mare che tra i romanzi di Lucarelli e Gherman-di esiste una differenza che riguarda in primo luogo la posizione dell’autore: se Lucarelli si in-serisce nel quadro della evoluzione che dal ro-manzo storico muove verso le sue trasformazio-ni postmoderne e oltre, Ghermandi si colloca entro questo quadro rivendicando e incarnando una posizionalità specificamente postcolonia-le, che incrina la linearità del racconto storico-letterario eurostatunitense e rivendica una spe-cificità in-between, un «doppio sguardo» spiaz-zante, ma soprattutto rivendica alla parola let-teraria la capacità di intervenire sulla realtà at-traverso un processo di revisione della memoria storica affettivamente connotato. Non si tratta di una questione che attiene esclusivamente al
27 Cfr. D. meZZina, Memoria, epica, inesperienza. Il romanzo storico negli anni Zero, in V. Santoro (a cura di), Notizie dalla post-realtà. Caratteri e figure della narrativa italiana degli anni Zero, Macerata, Quodlibet, 2010, pp. 61-94.
Raccontare la colonia 443
piano di ciò che viene raccontato, ma riguarda il piano dell’enunciazione. Che gli enunciati pro-vengano da chi è portatore di una identità ibri-da non è infatti secondario, se è vero che pro-prio da questa circostanza deriva sia la difficoltà nella presa di parola di autrici e autori «migran-ti» – etichetta che comprende autori immigrati, figli di immigrati e figli di unioni miste –, sia lo statuto di testimonianza e quello correlato di ve-rità al quale l’enunciato pretende. Il punto è di-rimente, perché riguarda tutta la narrativa e la poesia scritta da autori migranti, la cui identità e biografia vengono sistematicamente ricorda-te al lettore proprio perché, anche quando scri-vono romanzi a pieno titolo (anche fantastici o allegorici o fiabeschi o altro ancora) la posizio-ne dalla quale proviene l’enunciazione è essen-ziale nell’orientare la ricezione. Per questo nella mia brevissima lettura ha avuto un certo peso l’analisi del paratesto, che ha appunto la fun-zione di orientare un lettore che spesso cerca in questi romanzi una chiave per comprendere l’alterità, un aiuto nella elaborazione di processi di dialogo e negoziazione caratteristici del pre-sente globalizzato. Vi è dunque un cortocircuito che andrebbe meglio analizzato tra le aspettati-ve del pubblico italiano e i testi di autori e au-trici migranti. Lo sguardo interno di Lucarelli, come quello degli altri autori «italiani» che han-no raccontato la colonia, è interno alla nazione, all’Europa, ai suoi valori estetico-letterari e alle ragioni del mercato, è costitutivamente diverso da quello degli autori migranti, che tuttavia, ne-cessariamente, con questa lingua, letteratura, nazione e mercato, con questi valori estetico-letterari si confrontano.
Raccontare la colonia. Sul «romanzo storico» italia-no contemporaneo. - Telling the colony’s tale. On the contemporary «historical novel» in Italy.
Giuliana Benvenuti
Se nella storia dell’I-talia contemporanea il colonialismo è stato a lungo considerato una sorta di parentesi non fondativa dell’identità nazionale e non crucia-le nei processi di mo-dernizzazione, l’atten-zione della nostra re-cente letteratura per l’impresa coloniale mo-stra l’urgenza di “ri-scrivere” quel passato a partire da un’attuali-tà che vede l’Italia coin-volta nei flussi migrato-ri caratteristici del pre-sente globale e postco-loniale. All’interno del-le tante narrazioni che negli ultimi trenta anni almeno hanno fatto del romanzo storico e del-le sue trasformazio-ni (docudrama, factfic-tion) uno dei generi di maggiore interesse e successo, è importante fermare l’attenzione su quelle opere che riscri-vono, reinterpretano, fanno riaffiorare la me-moria e il trauma del colonialismo italiano. Le modalità secondo le
Colonialism has been long seen as a period of Italian contemporary history which didn’t contribute to the found-ing of a national identi-ty and didn’t play a cru-cial role in the process-es of modernization, yet recent literature has drawn attention to the colonial enterprise, de-mostrating the urgen-cy of “rewriting” that past starting from the involvement of Italy in the migrations that are typical of the global and postcolonial present situation. Within the many tales that at least during the last thir-ty years have made the historical novel and its new forms (docudrama, factfiction) one of the most interesting and successful genres, the works aiming at rewrit-ing, reinterpreting, dis-closing the memory and trauma of Italian colo-nialism deserve more attention. The ways in which these tales orga-nize the past as a text
Riassunto - Abstact
quali queste narrazio-ni organizzano il pas-sato come un testo e lo leggono dal punto di vi-sta del presente, sono differenziate anche in virtù della diversità che distingue gli auto-ri «italiani» dagli auto-ri «migranti» e/o «post-coloniali». Per questo il contributo offre lettu-ra comparativa del ro-manzo L’ottava vibra-zione di Carlo Lucarelli e di quello di Gabriella Ghermandi Regina di fiori e di perle.
and read it from a con-temporary point of view differ from each oth-er according to the dif-ferences between “Ital-ian” writers on the one hand, and “migrant” and/or “postcolonial” writers on the other hand. In such a context, this essay compares Carlo Lucarelli’s nov-el L’ottava vibrazione “The eightth Vibration” to Gabriella Gherman-di’s novel Regina di fio-ri e di perle (Queen of Flowers and Beads).
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 447-453
Fausto Curi
Brevi riflessioni su Zanzotto e Sanguineti
Ora che la morte, e solo la morte, li ha con-giunti, sembra più doverosa qualche ri-flessione su di loro collocandoli uno di
fronte all’altro. Il raffrontarli può anticipare un’analisi che, quando verrà, se verrà, sarà for-se più agevole.
Negli ultimi anni si era stabilita fra loro non certo un’amicizia, ma una sorta di non bellige-ranza fondata su un reciproco rispetto senza af-fetto. Nessuno dei due si era sforzato di capi-re le ragioni dell’altro, ma nessuno dei due ave-va cercato di imporre all’altro le proprie ragio-ni. Sanguineti continuava a pensare che Zan-zotto fosse un poeta ermetico e che le trasfor-mazioni che si erano determinate nella sua poe-sia, che egli comunque non apprezzava, fossero state provocate da un non pacifico incontro con i Novissimi. Zanzotto, per contro, era rimasto fermo al parere negativo espresso sui Novissimi nel suo articolo del 1962, nel quale li aveva con-trapposti a Michaux, da lui molto amato. Nul-la però di tale contrapposizione si manifestava esplicitamente negli ultimi anni. Niva Lorenzini riuscì persino a farli incontrare a Bologna. Alla sera si andò a cena tutti insieme e, ch’io ricor-di, come non vi furono manifestazioni d’affet-to, così fu assente l’ostilità reciproca. Indubbia-mente faceva una certa impressione vedere due antichi e illustri avversari sedere l’uno di fronte all’altro intenti a condividere tranquillamente la stessa bottiglia di Sangiovese.
Per i novant’anni di Zanzotto, e, pochi gior-ni dopo, per la sua morte, si è assistito a uno
Fausto Curi448
spettacolo non sempre decoroso. In troppi han-no voluto prendere la parola e parlare della sua poesia senza avere alcun titolo per farlo. Una stridula poesia sulla poesia, un querulo e ine-sperto metalinguaggio. Ma Zanzotto aveva alle spalle la più potente delle case editrici. Ed era molto amato, molto amato da molti. Era facile amare Andrea. Viveva appartato, e tuttavia pre-sente, in una modesta casa di un piccolo paese veneto. Gli italiani spesso in maggioranza han-no votato Berlusconi ma amano, o fingono di amare, le persone modeste e inoffensive. In re-altà Zanzotto, nei modi pacati ma sottilmente pungenti che preferiva, proprio inoffensivo non era: si batteva in difesa di quello che si è so-liti chiamare “il territorio” e non aveva avuto paura di inimicarsi i militanti della Lega Nord, sempre pronti a mostrare la loro sciatteria cul-turale e il loro ottuso fanatismo. E anche que-sto piace agli italiani: pensare di avere un poe-ta nazionale, così nazionale da provocare le an-tipatie e le ire di una minoranza antinazionale, che non capisce quello che il Presidente Giorgio Napolitano vorrebbe invece che capisse: è così bello, così confortante essere uniti, condivide-re il modo di pensare, collaborare nell’interes-se supremo di una patria cara ormai a pochi e sempre più dileggiata. È quasi banale ricorda-re che Zanzotto rappresentava un’Italia diver-sa, anzi opposta all’Italia degli spaghetti e dei mandolini. Un’Italia colta, ma non troppo, te-nacemente legata al “territorio” senza però fa-natismi, appartata ma sempre disponibile, si-lenziosa e tuttavia pronta a prendere la paro-la ove fosse necessario. Un’Italia davvero “alla mano”. Rappresentata da un poeta nazionale dopo tanti poeti rappresentativi solo di sé stes-si. E poi un poeta nazionale che sembrava qua-si un contadino, affabile e semplice di modi, di abiti, perfino di parola.
Brevi riflessioni su Zanzotto e Sanguineti 449
Facciamo attenzione. Sentimenti e pensie-ri come questi non appartenevano soltanto ai poco colti. Inconsciamente, erano condivisi an-che da molti tutt’altro che sprovvisti di cultura. Non lo si dice con compiacimento, ma la verità è che soltanto un manipolo di studiosi agguerri-ti sapeva quale intelligenza acuminata e lucida, quale cultura complessa e raffinata si celavano dietro quei maglioni ineleganti, sotto quei buffi berrettini, dietro quella voce legata così radical-mente al dialetto.
Alla morte di Zanzotto qualcuno ha som-messamente fatto presente che egli meritava il premio Nobel. Davvero? E allora perché, quan-do, poche settimane prima, il Nobel per la let-teratura è stato assegnato allo svedese Tomas Tranströmer, ignoto ai più, ma che tutti, nes-suno escluso, si sono affrettati a dire di cono-scere e di ammirare, perché nessuno degli am-miratori di Zanzotto ha avuto il coraggio di di-chiarare che il premio sarebbe dovuto andare al poeta di Pieve di Soligo? Forse perché il Nobel è un premio che piace ai giornali ma non merita l’attenzione degli studiosi? Eppure – per limitar-si all’Italia – esso è stato assegnato, senza pro-teste e senza riserve, a un poeta, Eugenio Mon-tale, molto amato da critici esigenti e rigorosi quali Gianfranco Contini, D’Arco Silvio Avalle, Dante Isella. E Nabucco (Contini), sia pure nei suoi modi giocosi e ironici, non mancò di comu-nicare per lettera la sua contentezza a Eusebio (Montale). Non si dica, allora,che, in Italia, la politica è dominata dal conformismo e dall’ipo-crisia, perché ipocrisia e conformismo sono ben presenti anche nella letteratura, o, se si preferi-sce, nella pubblicistica.
Quando è morto Sanguineti non vi sono sta-ti né conformismo né ipocrisia. Né, d’altronde, potevano esservi. Nessun lutto nazionale. Giu-
Fausto Curi450
sto, perché egli non era un poeta nazionale. Non era neppure “un grande italiano”, quale, secon-do il Capo dello Stato, era stato Zanzotto. Era un poeta comunista, poco amato anche da molti suoi compagni. Non moltissime testimonianze, tutte o quasi tutte congrue, nessuna voce sgua-iata. I nemici, che egli aveva numerosi, soprat-tutto in sede politica, preferirono tacere. D’altro canto il silenzio, per non dire di alcuni ridicoli tentativi di dileggio, o il rifiuto, avevano accom-pagnato una parte non piccola della sua attività di scrittore e di intellettuale. Seguìta e sostenu-ta invece da critici di diversa cultura, non nume-rosi, ma autori di prove quasi sempre significa-tive. E da molti, moltissimi giovani. Quando, in uno dei momenti più pericolosi per la democra-zia, a lato del Campiello gli fu assegnato inopi-natamente un premio ed egli, prendendo la pa-rola, parlò in difesa della Costituzione e di Anto-nio Gramsci quale maggiore intellettuale italia-no del Novecento, sul suo energico discorso calò il gelo di tutti i presenti, che lo isolarono per tut-to il resto della serata. Ma, se, alla sua morte, vi fu chi mi comunicò la notizia piangendo, posso testimoniare anche della commozione di perso-ne che lo avevano avversato o che non avrei mai pensato potessero interessarsi della sua sorte.
Non era facile amare Sanguineti. Infastidi-va, in primo luogo, il suo comunismo tenace e militante, che egli era persuaso di avere il dove-re di manifestare animosamente, a voce o per iscritto, ogni volta che fosse necessario. Sangui-neti non ha mai avuto tessera di partito, ma for-se anche per questo, o nonostante questo, era fastidioso anche a molti comunisti. Disturbava forse la sua libertà di pensiero e di comporta-mento, che pure egli sapeva disciplinare rigoro-samente, per esempio collaborando strettamen-te in varie occasioni con il partito. Su un altro versante infastidiva sia il suo linguaggio poeti-
Brevi riflessioni su Zanzotto e Sanguineti 451
co, giudicato quasi incomprensibile, sia la sicu-rezza con cui egli si muoveva sul piano cultura-le e politico, sia i suoi giudizi netti, severi, spes-so sarcastici, sia la sua risoluta battaglia contro il moderatismo e il conformismo.
Se, come proponeva Sanguineti, il linguaggio di uno scrittore ne cela e al tempo stesso ne rive-la l’ideologia; e se, come proponeva Goldmann, uno scrittore non rappresenta solo se stesso, ma anche un determinato gruppo sociale, un crite-rio utile alle distinzioni (qualunque uso poi si vo-glia fare di tali distinzioni) può essere quello del-la rappresentatività sociale. Molto schematica-mente, e molto ellitticamente, possiamo indicare due modelli, opposti più che diversi. Sanguine-ti poeta, per esempio, rappresenta gruppi socia-li rivoluzionari, che si riconoscono (si riconosce-vano) quasi sempre nell’estrema sinistra, come mostra, poniamo, una poesia come questa:
A proposito della quale sembra lecito parla-re di un nuovo realismo, riguardante però, più ancora che il tema, il linguaggio, attento a co-stituire una forma di comunicazione nuova e quindi a custodire un perfetto equilibrio fra si-gnificanti e significati, fra elementi verbali e og-
9 milioni (abbondanti) di voti al Partito (per la Camera), e 179deputati (+2) nelle politiche di domenica scorsa, li abbiamo festeggiatiieri, al Delfino di Erchie, con cannelloni, coniglio al forno,e Lacrima Christi: (io rivedevo ancora Federico, sotto il palco, al comiziodi chiusura a Portanova, con il fazzoletto rosso al collo (un tovagliuolorubato al Moby Dick di Rotterdam, per la verità, ma un lascito di VaskoPopa, sempre, intanto), laggiù a urlare: “7 maggio rosso”): ti contemplo che leggila Questione meridionale di Gramsci: questo nostro libretto rosso, comeho detto in piazza: dove ho detto, anche, con un gesto largo così:queste magnifiche bandiere rosse: ho detto altre cose enormi,enormemente vere, tra lo stupore di tanti (compresa quella studentessa,che conosci anche un po’ tu, che ha due occhi che non finiscono più),del tipo: io voto per il PCI perché tengo tre figli (ecc. ecc. ecc.)): (Postkarten, 15)
Fausto Curi452
getti, evitando sia l’astrattezza del significante irrelato, autonomo, sia la piattezza di un signi-ficato precostituito, esorbitante. Zanzotto, per contro, rappresenta la borghesia che si ricono-sce in una politica di centrosinistra, tanto cul-turalmente raffinata quanto politicamente mo-derata, intenta a degustare le squisite e speri-colate avventure di un significante affidato solo a sé stesso, incurante della prassi e in definitiva responsabile della mancanza di una comunica-zione che non sia la comunicazione di un’espe-rienza esclusivamente verbale:
Salti saltabecchi friggendo puro-puranel vuoto spinto outréti fai più in làintangibile – tutto sommato –tutto sommatotuttosei più in làti vedo nel fondo della mia serachiusascurati identifico tra i non sic i sighti disidentificosolo no solo sìpiena di punte immite frigidati fai più in làe sprofondi e strafai in te sempre più in tefotti il campodecedi versonel tuo sprofondibrilli feroce inconsutile nonnullal’esplodente l’eclatante e non si sentenulla non si senteno sei saltata più in làricca saltabeccante là
L’oltraggio
(Oltranza oltraggio)
Riassumendo e concludendo: la carriera poetica di Sanguineti va dalla non comunicazio-ne a una nuova comunicazione; la carriera poe-tica di Zanzotto va dalla comunicazione alla non comunicazione.
Brevi riflessioni su Zanzotto e Sanguineti - Brief con-siderations on Zanzotto and Sanguineti
Fausto Curi
I due scrittori sono qui visti nell’ineliminabile contrapposizione del-le loro poetiche e nelle idee assai diverse che di essi si è venuta fa-cendo l’opinione pub-blica più autorevole. Per quanto, in partico-lare, riguarda la poesia, Curi mette in luce che, mentre il cammino di Sanguineti va dalla non comunicazione a una nuova comunicazione, il cammino di Zanzotto va invece dalla comuni-cazione alla non comu-nicazione.
This essay deals with the undeniably con-trasting poetics of these two writers and the ex-tremely different opin-ions of the most influ-ential scholars about them. Curi highlights the fact that, especial-ly in poetry, Sanguineti moves from non-com-munication to a new communication, while Zanzotto moves from communication to non communication.
Riassunto - Abstact
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 455-459
Fausto Curi
Avere cura della propria morte
“Ogni Esserci deve sempre assumersi in pro-prio la sua morte”. Così Heidegger in Essere e tempo. Ci sono però diversi modi di assu-
mersi la propria morte. Non c’è dubbio che uno di questi modi sia il suicidio. Quanto più un suicidio è progettato e eseguito meticolosamen-te, tanto più suscita sgomento in chi ne ha no-tizia. Perché costui, persuaso com’è della vita, o, pur scontento, o infelice, comunque vincola-to alla vita, vede nel gesto di chi si dà persua-so la morte un atto che o ripugna al suo stes-so vivere, o gli è violentemente estraneo, assai più di quanto può essergli estraneo un suicidio improvviso e impulsivo. Al di là dello sgomento e del dolore che ha provocato in molti, c’è, nel suicidio di Lucio Magri, una sorta di esemplari-tà che non deve sfuggire a chi quello sgomento e quel dolore abbia saputo superare.
Guardato da un certo punto di vista il co-munismo è la lotta che ha come scopo di con-sentire a ogni donna e a ogni uomo di disporre liberamente della propria vita. L’abolizione dello sfruttamento, la liberazione del lavoro sono pra-tiche finalizzate a sciogliere l’esistenza di ogni individuo dai vincoli che la opprimono, a con-sentirle l’esercizio di una piena libertà. Perché il comunismo non dovrebbe darsi cura anche del-la morte? Perché – si obbietterà – la morte sfug-ge a ogni progettazione, a ogni cura. La morte è in sé libera quanto è necessaria, ineluttabi-le. Nulla può costringerla, orientarla, decidere il suo cammino. Come non si può essere libera-ti dalla morte, così non si può liberare la mor-te, che è libera per suo conto. Nella sua assoluta
Fausto Curi456
libertà essa è, per l’essere umano, la costrizio-ne suprema, l’estrema violenza. Nulla la giusti-fica, se non la progressiva, umiliante, irrimedia-bile decadenza del corpo dell’uomo. Gli ottimi-stici, benevoli De senectute sono un insulto che si aggiunge all’oltraggio perpetrato dalla morte sull’essere umano.
Vi sono però casi, certo assai rari, in cui è possibile disporre liberamente della propria morte. Uno di questi casi è quello che porta il nome di Lucio Magri. Certamente Magri non ha voluto esortare al suicidio. E forse egli non era del tutto consapevole dell’esemplarità del suo gesto. L’atto che ha compiuto, tuttavia, ha un significato simbolico che non può sfuggire. Vuol dire, quell’atto, che, anziché aspettare la morte, e subirla, è possibile andarle incontro, prece-derla, sceglierla, decidere al suo posto. Natural-mente questo non ci libera dalla sua ineluttabi-lità, dalla sua violenza. In certo qual modo però l’attenua, e rende l’essere umano protagonista di un evento che altrimenti lo vedrebbe soltanto vittima. Siamo quasi sempre disarmati, impo-tenti di fronte alla morte. Magri non lo è stato. Ha avuto il coraggio difficile della propria mor-te. E questo coraggio ha avuto senza ambizioni eroiche, senza atteggiamenti teatrali, da uomo che voleva essere il più possibile comune. Pro-babilmente sapeva che il suo gesto lo portava ad essere, e sia pure solo per un aspetto, un anti-leopardiano. Ma il fatto non deve averlo turba-to più di tanto. Perché se a Leopardi, indossa-ti i panni di Plotino, premeva tutelare con buo-ne ragioni la vita di Porfirio, e la vita di tutti, a Magri, al contrario, premeva tutelare la pro-pria morte, e probabilmente la possibilità di una morte per tutti libera e dignitosa.
Conviene rileggere almeno le parole conclu-sive di Leopardi-Plotino, fra le più alte che la let-teratura italiana abbia prodotto: non certo per
Avere cura della propria morte 457
smentire Magri, ma affinché le due diverse posi-zioni appaiano con maggiore chiarezza:
Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme: non ricu-siamo di portare quella parte che il destino ci ha stabili-ta, dei mali della nostra specie. Sì bene attendiamo a te-nerci compagnia l’un l’altro; e andiamoci incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente, per compie-re nel miglior modo questa fatica della vita. La quale sen-za alcun fallo sarà breve. E quando la morte verrà, allora non ci dorremo: e anche in quell’ultimo tempo gli amici e i compagni ci conforteranno: e ci rallegrerà il pensiero che, poi che saremo spenti, essi molte volte ci ricorderanno, e ci ameranno ancora.
Non si tratta, per noi tutti, di assumere come modello Leopardi piuttosto che Magri, o Magri piuttosto che Leopardi. Si tratta di riflet-tere con la massima attenzione su due diverse proposte, che sono davvero diverse comunque le si consideri: per la fisionomia intellettuale e culturale dei due proponenti e principalmente per il senso e il fine dei progetti che essi o di-segnano o mettono in atto. Per la verità, da un lato un testo letterario, da un altro lato un com-portamento psicologico-pratico. Realtà profon-damente differenti, quindi, ma avvicinate dalla circostanza che nel testo letterario vi è non poco di autobiografico. È evidente, in ogni caso, che quei progetti hanno un punto in comune, giac-ché, pur derivandone conseguenze opposte, ri-guardano entrambi il suicidio. O meglio: riguar-dano l’intera vita umana contemplata dal pun-to di vista del suicidio. È questa, la vita uma-na, che è in gioco. E che assume un’importan-za tanto rilevante perché se ne misura il valo-re non solo senza escludere la morte, che – ha detto qualcuno – è pur sempre parte della vita, ma concentrando lo sguardo sulla morte come possibilità. Esaminate le due proposte, e tutto ciò che esse implicano, se a una scelta si vor-
Fausto Curi458
rà giungere, qualunque essa sia, si avrà a di-sposizione una pluralità di analisi e di riflessio-ni, proprie e altrui. Chi, per sua fortuna e per sua volontà, avrà potuto e saputo disporre libe-ramente della propria vita, potrà, se vorrà, sem-pre che permanga altrettanto fortunato e volon-teroso, disporre liberamente della propria mor-te. Ma sarà pure un disporre liberamente della propria morte sperimentarla nella propria men-te e liberamente decidere di rinviarne l’avvento.
Avere cura della propria morte - Taking care about one’s own death
Fausto Curi
Prendendo spunto dal suicidio assistito di cui è stato recentemen-te protagonista l’intel-lettuale comunista Lu-cio Magri, ma non sen-za soffermarsi sul com-portamento opposto del Plotino di Leopardi, Curi manifesta alcune riflessioni che riguarda-no la morte e gli atteg-giamenti che razional-mente è possibile assu-mere di fronte ad essa.
Taking the recent as-sisted suicide of the communist intellec-tual Lucio Magri as a starting point, but also taking into account the opposite behavior of Leopardi’s Plotino, Curi deals with death and the different ratio-nal approaches to it.
Riassunto - Abstact
Poetiche, vol. 13, fasc. 2/3-2011, pp. 463-470
Ugo Perolino, Oriani e la narrazione della nuova Italia, Massa, Transeuropa, 2011, pp. 150.
La letteratura critica su Alfredo Oriani pre-senta caratteristiche che oltrepassano, per quantità e qualità, i limiti normalmente connes-si alla condizione di un autore minore del XIX secolo. All’inizio del Novecento il caso Oriani ac-quisisce un notevole valore strategico nell’am-bito di una più ampia guerra di posizione tra contrapposti schieramenti egemonici. Alla mos-sa di Croce, che alla rivalutazione dei roman-zi degli anni Novanta (di notevole valore lettera-rio: Vortice e Gelosia, e il complesso e stratifica-to La Disfatta) accompagna una lettura di im-pianto neohegeliano della Lotta politica, rispon-deranno presto i giovani nazionalisti – De Fren-zi e Corradini – che guardano in altre direzio-ni: l’Africa, l’espansione coloniale, l’organicismo della nazione non sufficientemente unificata e risvegliata dalle lotte risorgimentali. La rottura dei cardini dello Stato liberale viene esattamen-te diagnosticata da Renato Serra nelle Lettere in concomitanza con la guerra di Libia, e, sul piano del costume letterario, con la generale ri-valutazione dei libri di Oriani. Ma la continui-tà del dibattito critico (l’«orianesimo postumo», secondo una formula di Croce) risulta da quel momento costante: tra le due guerre, l’appro-priazione da parte di Mussolini e del fascismo, da un lato, le note di lettura di Gramsci e di Go-betti, dall’altro; nel secondo dopoguerra la revi-sione di Spadolini e gli appunti sul romanzo di Giacomo Debenedetti, per citare soltanto alcuni momenti significativi, tra i molti che documen-tano l’importanza del caso Oriani nei principali snodi politico-culturali del Novecento.
Recensioni464
Tra i contributi bibliografici più recenti oc-corre almeno accennare alla monografia di Mar-co Debenedetti, Alfredo Oriani. Romanzi e teatro (presentazione di Dante Bolognesi, introduzio-ne di Marino Biondi, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2008), orientata sulle scritture per la scena e le opere teatrali, in precedenza poco indagate dal-la critica. In ultimo, il saggio di Ugo Perolino, Oriani e la narrazione della nuova Italia (Massa, Transeuropa, 2011), svolge un’attenta analisi della multiforme produzione (romanzo, poesia, giornalismo) della scrittore faentino. L’organici-tà non risulta confermata soltanto dalla divisio-ne cronologica dei capitoli, che seguono il dive-nire delle opere dagli anni Settanta al primo de-cennio del XX secolo, disegnando un compiuto profilo biografico. La coesione del lavoro critico è soprattutto determinata da una strumentazio-ne metodologica originale – da Foucault a Žižek, da Lacan a Laclau – in una prospettiva inter-pretativa rinnovata. Un secondo merito non tra-scurabile del libro consiste nella consultazione di archivi manoscritti ed epistolari inediti che consentono di documentare i rapporti editoriali, l’influenza di un giornalista d’assalto come De Frenzi, i movimenti postumi del figlio Ugo per assicurare fortuna politica e redditività editoria-le al nome e all’opera del padre.
Nella prima parte del saggio monografico lo studioso focalizza la sua attenzione sulla sta-gione degli anni Settanta, caratterizzata da un controverso apprendistato letterario che vede Oriani attivo tanto sul piano della tecnica nar-rativa – la sperimentazione vertiginosa e abnor-me del feuilleton, la ricerca di un pubblico, l’am-mirazione per George Sand, i primi scandalosi romanzi (Memorie inutili, Sullo scoglio, Al di là) decorati da scene torbide e perverse – quanto su quello della versificazione poetica (la polemi-ca anticarducciana di una raccolta dimentica-
Recensioni 465
ta e non memorabile intitolata Monotonie). È la stagione che va da Memorie inutili a No, un ro-manzo stratificato e complesso, nel quale sono riformulati criticamente gli assunti ideologici giovanili. La monografia firmata da Ugo Pero-lino valorizza testi apparentemente marginali, eccentrici, “scandalosi” (il racconto lungo Sul-lo scoglio, la Lettera a Giuda) dai quali si ricava-no però penetranti osservazioni sul clima degli anni Settanta dell’Ottocento, uno snodo decisi-vo (e non soltanto per Oriani) a causa della ces-sazione improvvisa delle mobilitazioni ideologi-che risorgimentali e per la traumatica scoperta di una difficile normalità, con trasformazioni di larga portata nella vita culturale, economica e civile del paese. Nel corso del decennio lo scrit-tore faentino procede da una dimensione ribel-listica, non priva di suggestioni e rivendicazioni di ordine sociale, che è caratteristica del clima scapigliato dei primi anni Settanta, verso una visione storico-politica fondata sul primato del-le élites, in linea con una generale revisione dei valori di riferimento del mondo mazziniano e re-pubblicano.
Nella seconda parte del volume viene ap-profondito il rapporto dialettico con Carducci, con particolare riguardo al motivo centrale della fondazione del populismo quale antidoto all’a-vanzata del socialismo. In questo campo Oriani e Carducci presentano alcune analogie, che non oscurano però la diversità dei metodi, dei valo-ri, delle proposte letterarie, estetiche ed etico-politiche. Un denso capitolo è dedicato all’ana-lisi stilistica della Lotta politica, trattato storico e progetto operativo destinato a trovare qualche accoglienza soltanto presso la generazione suc-cessiva, ma anche grande romanzo della nazio-ne. Il capitolo intitolato Stile e retorica della “Lot-ta politica” analizza le procedure testuali, lingui-stico e retoriche attraverso le quali i differenti li-
Recensioni466
velli evidenziati – la pragmatica della comunica-zione politica, il tableau storico, il romanzo del-la nazione, il lirismo della individualità eroiche – vengono fusi nelle campiture di una prosa ma-gniloquente, scolpita, crinita (seconda una iro-nica definizione di Borgese).
Nella terza parte del libro lo studioso pro-pone una analisi dei punti di innesto nella com-pagine novecentesca. Un capitolo cospicuo è dedicato al romanzo Vortice, da molti ritenuto il capolavoro di Oriani, di cui viene valorizzata la tessitura nichilistica, l’incidenza dell’attimo-morte, una radicalità meditativa che si ritroverà nelle riviste del Novecento e nel discorso di Mi-chelstaedter. I romanzi di Oriani – Vortice e Ge-losia in particolare – forniscono un preciso ri-scontro all’affermazione della democrazia come pratica partecipativa, fenomeno collettivo in cui prendono forma e si misurano forze e tecniche nuove. Non a caso intere sequenze dei più im-portanti e significativi romanzi orianiani (ed è importante l’avere rimarcato lo spessore di que-sta isotopia testuale) sono ambientate nei luo-ghi politici per eccellenza: le aule delle ammini-strazioni locali, i Consigli provinciali e comuna-li (frequentati dallo stesso Oriani), il Parlamen-to, ma anche le piazze e gli affollati caffè dove la ritrovata libertà economica e politica esercita la propria energia distruttrice e creativa in un ma-reggiare di laceranti tensioni.
Piero Pieri
Recensioni 467
Antonio Pietropaoli, Dissezioni, Oèdipus, Salerno/Milano, 2011, pp. 96.
Antonio Pietropaoli – autore di queste gusto-se Dissezioni, che escono presso Oèdipus dopo circa vent’anni di silenzio poetico – è un raffinato studioso di letteratura del Novecento, un profon-do conoscitore dei meccanismi linguistici e reto-rici, un fine artigiano della parola, ma è prima di ogni altra cosa un “poeta civile”, nell’accezio-ne “pasoliniana” del temine (o, se si preferisce, un poeta underground, “da marciapiede”, come di recente l’hanno definito altri due poeti “di raz-za”: Ferdinando Tricarico e Gabriele Frasca).
Profondamente convinto della funzione eti-ca della poesia – che deve anzitutto esprimere “cose”, pronunciarsi sui fatti, non gingillarsi con le parole –, Pietropaoli è homo politicus, immerso fino al collo nel proprio tempo, nella storia, nel-la società, alle quali guarda con distacco ironico, alle volte con sorriso beffardo, ma senza ombra di cinismo. L’imperativo contenuto nella poesia eponima che apre la raccolta è chiaro: evitare di porsi «al centro della scena» e scegliere piutto-sto di stare «ai margini, in angolo» (Dissezioni, p. 5) da dove è possibile scrutare con occhio limpi-do la realtà, «dissezionarla» a freddo, “autoptica-mente”, attraverso l’uso di una «penna petrosa» (Senza titolo, p. 69), corrosiva, che scava nel fon-do delle cose come la lama di un bisturi.
Nelle sei sezioni che compongono il volu-metto (Ritagli, Dissonanze, Poesie politiche, Di-slocazioni, A una passante, e l’ultima e più cor-posa Scherzi e allegorie) e nelle altre poesie “sciolte”, l’ammaliante gioco fonico-ritmico dei versi ha di sicuro un effetto “ipnotico” sul let-tore che, anche in solitudine, tenderà a legger-li a voce alta, scandendo bene le singole paro-
Recensioni468
le per meglio assaporarne i suoni; un gioco ele-gante che non si traduce mai in vuoto giroton-do di parole, in compiaciuto esercizio metrico-stilistico (anche se chi scrive esibisce una pa-dronanza perfetta degli “strumenti del mestiere” per averli studiati e insegnati per lunghi anni). Le parole di Pietropaoli sono tutt’altro che lievi “fantocci sonori”, piuttosto sono lacerti di carne viva, frammenti di una «materia pulsante» (Poe-sia-farmaco, p. 58) che il poeta, «tutto ridotto in pezzi e brani» (Ritagli 1, p. 7), offre in dono «così come viene / e gli sovviene (sparati nelle vene)» (Dissonanze 5, p. 14).
L’aspirazione-illusione del poeta (di ogni poeta) di orchestrare «divine dissolvenze […] / con neolatina orchestrina con ocarina malan-drina» (Dissonanze 6, p.14) è da tempo crolla-ta sotto i colpi di una cultura di massa, imbe-vuta di reality e pubblicità, che ha trasforma-to attori e opinionisti TV in nuovi idoli e profeti, sottraendo ogni tipo di legittimazione etico-po-litica all’azione degli intellettuali. L’uso insistito di proverbi, citazioni e luoghi comuni probabil-mente è l’unico modo che resta al poeta per en-trare in contatto con una società soggiogata dai new-media, dominata da blog e social network, responsabili di aver impoverito e omologato la nostra lingua oltre ogni misura. Quella che Se-rianni ha definito la “lingua di plastica” (fatta di slogan e detti popolari) è forse lo strumento adatto per parlare alla “tribù” («o italiani, bra-va gente intelligente / belli ma poveri, coriacei e ruspanti», Evviva Cava, p. 23) e per denunciare storture e malcostume politico («viviamo nel pa-ese di cuccagna / dove si batte per un pugno di paglia / chi sa bene che sotto ogni magagna / c’è bello pronto un asino che raglia», Il paese di cuccagna, p. 22).
Se la crisi è globale e la decadenza (socia-le, politica, culturale) irreversibile, anche il lin-
Recensioni 469
guaggio poetico non è immune dal degrado: «[…] lo strumento strimpella spelacchiato e non sfor-na granché / passi falsi parole mancate epo-chés» (ibidem). Eppure, le parole di Pietropao-li non hanno nulla di stantìo o di falso o di ap-prossimativo, risuonano dure e taglienti anche quando sono quelle “logore” della tradizione let-teraria, o quelle un po’ insulse delle canzonette e dei proverbi; parole che, manipolate e ricollo-cate nei versi, si trasformano in colpi sparati da una «pistola fumante», bocconi di un cibo ama-ro da digerire che «ti sazia e ti spazia /contem-poraneamente» (Poesia-farmaco, p. 58).
Non dobbiamo insomma lasciarci inganna-re dall’apparente leggerezza e facilità dei ver-si, nei quali dilaga la comicità beffarda e spes-so oscena dell’autore attraverso la fitta trama di allitterazioni, assonanze, consonanze, paro-nomasie che fanno letteralmente esplodere i si-gnificanti senza però mai svuotarli dei significa-ti: questi ultimi sono quasi sempre inattesi, “di-slocati” altrove, annidati in parole («mai desun-te o presunte da altri testi / ma materiate di so-gni e di prole», Solo soletto, p. 78) che improv-visamente precipitano nel testo (in genere verso la fine) e ne dischiudono il senso. È il caso della poesia dedicata a Partenope, un ritratto crudo e duro della città di Napoli, reso ancora più inci-sivo dal gioco della citazione colta (nei due versi iniziali) e dall’estrema concisione degli enuncia-ti: «così Partenope continua a tessere / la sua tela come un canestro di ginestre / una distesa di case bocca a bocca / un nido di vipere / un mare di boschi crepitanti / che il cuore dell’in-fame distoglie e rinfresca. Non la cattedrale nel deserto è cosa grave / ma che deserto e catte-drale son una cosa» (Dislocazioni 6, p. 35).
Ancora più inquietanti, per il loro sapore va-gamente testamentario, sono i versi dell’ultima quartina di solo soletto: «solo soletto me ne vo per
Recensioni470
questi / testi tascabili tra bile e frottole / sapien-te di niente / e a tutti i pretesti / restìo, in festa, pronto per la botola» (p. 78). Le esibite citazioni colte, il gioco delle allitterazioni, il tono comples-sivamente canzonatorio e auto-ironico non rie-scono certo a nascondere – qui come in altri te-sti – il sentimento angosciante di una vecchiaia presentita e assai temuta. «Abitiamo lo spazio / siamo abitati dal tempo» (p. 91) recitano gli ulti-mi due versi de Il tempo ritrovato in cui, tra cita-zioni proustiane e baudelairiane e rime raffinate («aquiloni che planano lenti / disegnano ghirigo-ri e stenti», ibidem), emerge l’immagine di un po-eta che si è lentamente dissanguato («un poco al giorno»), che si è disamorato «della vita / come della morte / fino ad incartapecorirsi» (ibidem).
La vecchiaia, odiosa e indecente, è per il po-eta «un aratro senza pietà» (Bilanci, p. 81) che travolge ogni cosa, scava nel corpo («a fatica mi allaccio le scarpe / […] / invecchio riflesso in uno specchio / mi cruccio per i miei intoppi», Larve, p. 79; «la vista si guasta», Bilanci, p. 81), e induce a «fissare punti fermi /assodare qualco-sa», ovvero a fare dolorosi e inutili bilanci («tutto frana sfuma dilegua», ibidem, p. 80). Anche gli amici e i familiari sono coinvolti nella frana del tempo che corrode l’unità della cellula-famiglia («la cellula non resiste per niente / petalo a pe-talo si sfoglia» ivi, p. 81) e incrina il significato delle parole («le parole si scheggiano / mi avvito nel vuoto», ibidem). Il sentimento della fine che si appressa spaventa il poeta, rischia di para-lizzarlo nei ricordi, di ridurlo al silenzio; meglio forse sfidare la morte «a viso aperto» («prendere tempo, stancarla, farla desistere?» (ivi, p. 80) e beffarla con un uso “straniato” del linguaggio, la cui affilata ironia lascia l’amaro in bocca, scava impietosamente nel fondo tragico dell’esistenza.
AlessAndrA ottieri
Indice del fascicolo
Poetiche 2-3/2011
171 Fausto Curi
Sul soggetto nella poesia
185 Fausto Curi
Nuova psicoanalisi e metapsicologia pragmatica Freud, Lacan e altro
211 ElisabEtta CaldEroni
Arte e civiltà urbana nel giovane D’Annunzio giornalista
237 GiorGio siCa
Il Giappone di Ezra Pound
269 MiMMo CanGiano
La tentazione dell’impressione. RiguardoaigiudizidiBoinesuSoffici
305 robErto risso
«Povera mamma Agnese…» Il tema della maternità nella narrativa resistenziale di Renata Viganò.
335 alEssandro Gaudio
Guido Morselli e la questione meridionale: divagazione etnologico-letteraria
347 GabriElE bEllEtti
L’istituzione dell’espressivismo oggettuale nel primo Caproni
361 ilaria Maria roMilio
Tra Laborintus e Storie naturali: modalità del corpo sterile