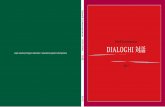Il Velo Scolpito. Dialoghi tra filosofia e letteratura
Transcript of Il Velo Scolpito. Dialoghi tra filosofia e letteratura
a cura di Danilo Manca
postfazione di Antonio Prete
Con contributi diAlessandra Aloisi, Stella Ammaturo, Matteo Bensi,
Gabriele De Luca, Chiara Mastroberti, Martina Piperno, Edoardo Raimondi, Lorenzo Serini,
Valentina Serio, Marta Vero
Il velo scolpitoDialoghi tra filosofia e letteratura
Edizioni ETS
C!"#$ %&!'# (!))*'(#!
00_pped_mastro 24/06/14 12:04 Pagina 3
© Copyright 2013EDIZIONI ETSPiazza Carrara, 16-19, I-56126 [email protected]
DistribuzionePDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]
ISBN 978-884673811-0
www.edizioniets.com
00_pped_mastro 28/05/14 09:18 Pagina 4
Alle studentesse e agli studenti dell’ex Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Pisa
00_pped_mastro 28/05/14 09:18 Pagina 5
Introduzione
Scolpire un veloDanilo Manca
Forse questo non era un libro da scrivere. Le ragioni sono almeno tre.In primo luogo, è inusuale, forse didatticamente inappropriato, sicura-
mente accademicamente inopportuno che studiosi appartenenti a diversilivelli di ricerca si incontrino in un laboratorio allestendo un’unica fucinadi idee.
Questo volume ospita, infatti, contributi di studiosi che si trovano a di-versi stadi della loro formazione. C’è chi ha appena discusso la tesi di lau-rea triennale, chi invece sta per discutere quella di magistrale, c’è chi haconcluso gli studi universitari, chi sta scrivendo la tesi di dottorato e chicerca una collocazione per non interrompere con il dottorato la sua passio-ne per la ricerca. E poi, a tessere le fila di questa strana esperienza, c’è undono del Prof. Antonio Prete, docente emerito di Letterature comparate al-l’Università di Siena, studioso e poeta del pensiero poetante, che a marginedel volume ha provato ad afferrare l’intrigo di suoni sprigionato dai pensie-ri qui raccolti.
Tutti questi studiosi hanno messo in piedi un laboratorio di filosofia del-la letteratura: uno spazio in cui si riflette sulla letteratura e ci s’interroga suimodi in cui la letteratura fa riflettere, uno spazio in cui la poesia viene mes-sa in dialogo con la filosofia. Il finanziamento ottenuto dal Consiglio deglistudenti dell’Università di Pisa per l’organizzazione di attività studenteschesenza scopo di lucro ha consentito di raccogliere in un volume i resocontidelle nostre riflessioni.
Alle spalle di questo volume c’è l’appassionato sostegno della Prof.ssaAntonietta Sanna, la stima critica del Prof. Leonardo Amoroso, i consiglimaieutici del Prof. Luca Crescenzi. Ci sentiamo di ringraziare questi tre do-centi dell’Università di Pisa perché nel corso dalla loro attività didattica, diricerca, e non solo, ci hanno insegnato tanto sul rapporto tra filosofia e let-teratura, e sull’importanza della lettura.
In secondo luogo, all’interno di un sistema universitario sempre più por-tato a distinguere le discipline, a separare la filosofia dalla letteratura, aframmentare il sapere umano e la sua storia in microcosmi autoreferenziali,incapaci di interagire fra loro, dimentichi della loro comune provenienza,risulta difficilmente immaginabile una ricerca di filosofia della letteraturache coinvolga la riflessione estetica, la critica letteraria, la filologia, la psico-logia dell’arte e la teoria della letteratura. Sicuramente da questo punto di
00intro 7_mastro 28/05/14 09:28 Pagina 7
vista l’impertinenza e il fresco acume di giovani studenti e studentesse si so-no rivelati utili e proficui.
Se proprio non sono stati abbattuti quei confini che separano la filosofiae la poesia, si può dire che nei loro confronti sia stato esercitato un dubbioscettico. È stata sospesa qualsiasi adozione acritica di questi confini; nonsono stati trascurati, ma sono stati indagati con sospetto e attenzione. Sonostati circoscritti, si è cercato loro un senso, si è visto se vi è un limite oltre ilquale è difficile esprimersi sull’appartenenza di un testo all’ambito dellameditazione filosofica o della creazione poetica. Si è mostrato come la lette-ratura ospiti un’ineludibile componente filosofica e perché la filosofia nonpossa fare a meno della creazione poetica nel suo bisogno di conoscenza.
Tuttavia, c’è un terzo motivo a convincermi che questo non era proba-bilmente un libro da scrivere.
A innervare e connettere tutti i contributi qui raccolti è l’idea secondocui non si può parlare di poesia se non in poesia. In altre parole, i diversicontributi arrivano a sostenere che non vi è modo migliore di riflettere sullaletteratura se non affidandosi alle strategie retoriche offerte dalla stessa let-teratura, senza chiamare in causa le tipiche tecniche argomentative e assio-matico-deduttive della filosofia.
Nonostante siano queste le convinzioni che fungono da filo conduttoreper i contributi raccolti, paradossalmente, qui non si troveranno né dialoghiné soliloqui, né cronache né racconti mitici, né in prosa né in versi. Questovolume ospita soltanto saggi brevi intenti a dimostrare come degli anfibidel pensiero, in costante movimento tra la filosofia e la letteratura, tra ilpensiero concettualizzante e quello poetante, abbiano reso tema della pro-pria fantasia poietica la stessa attività artistica, convinti della necessità chele arti della parola debbano meditare sulla loro stessa forma.
Se questo non era un libro da scrivere, perché è stato scritto? La struttu-ra contraddittoria del libro ne rivela la funzione: tutti i saggi mostrano co-me la letteratura disponga, di per sé, dei mezzi per riflettere criticamentesulla propria natura; non ha bisogno cioè della filosofia per comprendersi.Tuttavia, nel momento stesso in cui la letteratura decide di provare a com-prendersi, arriva a ospitare nell’orizzonte della forma poetica un contenutoe un motivo filosofico. Di per sé la letteratura non avrebbe neanche biso-gno di comprendersi: in quanto fine a se stessa, a stento avverte la necessitàdi giustificare la propria presenza; eppure si cimenta in questa impresa,perché?
A questa domanda possono rispondere solo dei contributi che analizza-no in forma di critica filosofica il rapporto conflittuale che alcuni poeti in-trattengono con domande e motivi filosofici di cui sentono investita la loroesperienza letteraria. Dispiegare con gli strumenti della riflessione filosoficaquesto conflitto, giocato tutto all’interno dell’attività poietica, significa ren-dere conto del tentativo della letteratura moderna di superare la filosofia
8 Danilo Manca
00intro 7_mastro 28/05/14 09:28 Pagina 8
1 Italo Calvino, Filosofia e letteratura, testo scritto per un numero speciale della rivista«The Times Literary in Supplement», intitolato Crosscurrents, 28 settembre 1967. La versione initaliano compare per la prima volta con il titolo Tra idee e fantasmi in «Fiera Letteraria», n. 43,26 ottobre 1967, ora pubblicato in Id., Saggi, vol. I, Meridiani Mondadori, Milano 2007, p. 188.
2 Ivi, p. 189.3 Ibidem.
inglobandola in sé, trasformandola alla maniera dell’hegeliana Aufhebungin un momento della sua esperienza.
Senza pretese di finzione, dunque, di una particolare specie di finzioni siparlerà in questo libro. Di quelle finzioni che fingono di non sapersi finzio-ni, per riuscire, nella finzione, a dir qualcosa di vero sulla finzione.
* * *
Italo Calvino non ha avuto remore a sostenere che il rapporto tra filoso-fia e letteratura è una lotta che non esige di essere risolta. Una lotta in cui«lo sguardo dei filosofi attraversa l’opacità del mondo» e «riduce la varietàdell’esistente a una ragnatela di relazioni tra concetti generali, fissa le regoleper cui un numero finito di pedine muovendosi su una scacchiera esaurisceun numero forse infinito di combinazioni»1. Invece la letteratura ridonaagli astratti pezzi degli scacchi dei nomi, una certa concretezza, dei «campidi battaglia polverosi o mari in burrasca»2, e alla fine butta all’aria le regoledel gioco prescritte, le scompagina, le riordina, sperimenta nuove combina-zioni. A scoprire le nuove regole del gioco sarà di nuovo l’istinto critico einvestigativo dei filosofi, «tornati alla riscossa a dimostrare che l’operazionecompiuta dagli scrittori è riducibile a un’operazione delle loro»3.
Il problema è che spesso l’eterna lotta tra filosofia e letteratura si svolgesu un terreno più accidentato dei polverosi campi omerici, e più tormenta-to di qualsiasi mare in burrasca che il Pequod possa solcare. Spesso accadeche la battaglia si svolga nell’animo di un unico individuo, un pensatore eun poeta al contempo, uno che si lascia trasportare dalle onde della suaimmaginazione, ma che avverte anche le esigenze della ragione. E alloraprova a tenere insieme i frammenti della propria interiorità. Una fatica delgenere ha permesso a Leopardi di scoprire in che modo il poeta si appro-pri dell’ineludibile istanza sistematica del filosofo. Su questo punto si sof-ferma Alessandra Aloisi nel primo saggio qui ospitato: Leopardi e l’idea disistema.
Secondo Leopardi, un vero pensatore non può non avere un sistema. Ilprocesso di generalizzazione non deve mirare a impoverire la complessitàdell’esistente, quanto piuttosto a cogliere i rapporti attraverso cui si posso-no scorgere meglio i particolari. Questo è possibile a patto che il sistemanon sia una prigione di parole e nozioni imposta alla realtà, ma qualcosa direale esso stesso. Alessandra Aloisi si sofferma diffusamente su questo pun-to: intendere la natura come un sistema significa dare fondamento ontolo-
Introduzione. Scolpire un velo 9
00intro 7_mastro 28/05/14 09:28 Pagina 9
4 Alessandra Aloisi, Leopardi e l’idea del sistema, infra, p. 34.5 I. Calvino, Filosofia e letteratura, cit., p. 189.
gico all’atteggiamento del filosofo e legittimarne persino il metodo di com-prensione dell’esistente.
Il pensatore sistematico brama una conoscenza completa della natura.Anche se essa non potrà mai essere guadagnata, l’istanza del filosofo nonpuò essere ignorata: «Infatti, proprio perché in natura non si può conosce-re perfettamente nessuna cosa ignorando le relazioni che essa ha con tuttele altre, abdicare alla conoscenza del tutto significherebbe rinunciare inpartenza alla conoscenza delle singole parti»4.
Ad assicurare che le connessioni colte dal pensiero si radichino nei realicomportamenti della natura vi è quella facoltà che il filosofo condivide conil poeta: l’immaginazione, la quale non si limita a creare o inventare, ma èintesa da Leopardi come una “vena”, un “entusiasmo”, un “vigore” passeg-gero del corpo che influenza anche lo spirito. Una disposizione innata,dunque, che si può tradurre nella facoltà di creare immagini, metafore e si-militudini, oppure può provare a pensare la natura cogliendone l’insieme.Leopardi ha frequentato entrambe queste disposizioni dell’immaginazione: lavena delle similitudini come la vena del sistema.
La lotta tra letteratura e filosofia non può essere risolta. Le due parti con-dividono la stessa materia prima, le parole, e nelle loro brame si lascianoguidare dalla stessa facoltà, l’immaginazione. Calvino sostiene che «solo seconsiderata permanente e sempre nuova», la lotta garantisce che «la sclerosidelle parole» non si chiuda sopra di noi «come una calotta di ghiaccio»5.
Su quel campo accidentato, che è l’animo del Leopardi poeta e pensato-re, si svolge una battaglia destinata a non avere né vinti né vincitori. Si trat-ta di una strana battaglia, perché invece di generare morti, garantisce unasopravvivenza: quella della vena poetica in un’epoca che non può fare ameno della riflessione filosofica.
In La poesia inattuale. Materiali per Leopardi e Vico, Martina Pipernomostra come l’epoca e il contesto culturale in cui vive Leopardi gli impedi-scano di eludere nella sua poesia la componente ragionativa. Attorno aquesta constatazione, il contributo ricostruisce le tappe che hanno scanditoil tentativo leopardiano di recuperare la vena poetica dei maestri greci e la-tini, quella disposizione che produsse le favole antiche. Intento di fondo èrintracciare un’influenza di Vico nella produzione antecedente il 1828, datain cui è attestato che Leopardi lesse la Scienza nuova.
Quando Leopardi descrive a Giordani la conversione che agli inizi del1816 gli permise di scoprire la propria vena poetica, parla di un passaggiodall’erudizione al bello: un passaggio esibito nell’Inno a Nettuno con finearte da poeta piuttosto che con argomentazioni filosofiche. Leopardi fingedi tradurre un testo greco di autore incerto, mette in pratica la capacità
10 Danilo Manca
00intro 7_mastro 24/06/14 12:08 Pagina 10
6 Martina Piperno, La poesia inattuale. Materiali per Leopardi e Vico, infra, p. 44.7 Ivi et infra, p. 49.
fantastica di parlare per sostanze animate, di ricreare delle personificazionidi forze naturali ancestrali, allo stesso modo in cui Vico riteneva si compor-tassero i primi uomini.
Ad aprire il sipario sul palcoscenico dove si svolge l’esibizione della ri-nascita della poesia, sta invece quell’abilità leopardiana nel creare artifici,che gli permette di scrivere alla maniera antica simulando una traduzione.«L’Inno a Nettuno potrebbe essere stato originato dal desiderio di recupe-rare, falsificandola, l’ingenuità caratteristica della poesia greca, l’aderenzatotale dell’uomo alla realtà, e del poeta alla sua creazione»6. Qualche annopiù tardi, nel 1822, questo desiderio viene smascherato e portato in scena asua volta, grazie alla metafora della triplice primavera, quella della natura,quella dell’età della fanciullezza, quella del genere umano, la primavera incui si poteva far poesia perché si era un tutt’uno con la natura.
Se, come sostiene Vico, la fantasia degli antichi sorgeva dal loro crederealle favole senza dubbio alcuno, l’unico modo per ritagliare alla finzione unruolo nell’epoca moderna, è quello di rendere poesia la perdita della venapoetica, di anelare il tempo in cui gli elementi naturali avevano non solosensi e passioni, ma anche compassione per la condizione degli esseri uma-ni. «Leopardi cerca di ricostruire attraverso la poesia, sentendolo “dentrodi sé”, nella propria primavera (della propria vita), il significato mitico lietoe beneaugurante della primavera astronomica, e di rievocare così la prima-vera del genere umano»7.
* * *
In una riflessione sul legame tra filosofia e letteratura, il ricorso a Vicodiventa, del resto, ineludibile, perché mostra come la lotta tra logos e poie-sis non sia qualcosa d’inventato dalla riflessione moderna, ma si radichi nel-lo stesso divenire storico dell’umanità. Questo scontro infinito è il residuodel percorso d’incivilimento dell’uomo.
Vico si sentiva fluttuare tra le burrasche scatenate dallo scetticismo piùsfrenato e dal razionalismo astratto; cercò un appiglio nel senso comune,provò a vedere quale ruolo ritagliare nel processo della conoscenza allapercezione, all’esperienza e alla corpolentissima fantasia; scoprì quanto siastata importante per il progresso dell’uomo la sua capacità pratica di crea-re, la sua poieticità congenita.
Su questo punto insistono i due saggi di Gabriele De Luca e di MatteoBensi. Con due approcci diversi e altrettanto originali, entrambi rileggonoVico in base alle influenze esplicite o implicite che questi ha esercitato sullariflessione estetica di Samuel Taylor Coleridge e sull’interpretazione filolo-gica della letteratura di Erich Auerbach.
Introduzione. Scolpire un velo 11
00intro 7_mastro 24/06/14 12:08 Pagina 11
8 Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, tr. it., lievemente modificata, in Id.,Opere in prosa, a cura di Fabio Cicero, Bompiani, Milano 2006, pp. 677-678. Cfr. infra, p. 58.
9 Gabriele De Luca, Finzione e fruizione poetica in Vico e Coleridge, infra, p. 58.10 Ivi et infra, p. 60.
Il saggio di Gabriele De Luca, Finzione e fruizione poetica in Vico e Cole-ridge, è innervato da una domanda fondamentale: la finzione gioca ancoraun suo ruolo nel processo di conoscenza umana, oppure si rivela qualcosadi superfluo? La lettura simultanea di Vico e Coleridge arriva a dimostrareche “finzione” si dice in molti sensi.
Quando, in un famoso passo della Biographia Literaria, Coleridge de-scrive il processo compositivo alla base delle Lyrical Ballads, definisce la fe-de poetica come una «volontaria e temporanea sospensione dell’incredu-lità»8. L’attenzione di Coleridge è dunque rivolta «all’interesse e alle emo-zioni che personaggi e situazioni sovrannaturali sono in grado di produrrenel momento in cui sono considerate vere»9.
L’occhio di Coleridge è puntato sul processo di fruizione di un’operad’arte. Nella vita di ogni giorno l’incredulità è l’atteggiamento normalmen-te adottato per distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. La fruizione diun’opera d’arte si basa sulla capacità di fingere da parte del soggetto fruito-re, lettore, osservatore, uditore che sia. Davanti a un prodotto artistico ci il-ludiamo consapevolmente, o meglio fingiamo di credervi, ci comportiamocome se fosse vero, gli riconosciamo una verosimiglianza. «Il ruolo dellospettatore all’interno del gioco dell’illusione, inoltre, non si esaurisce inun’iniziale scelta di adesione alla finzione: attraverso uno sforzo immagina-tivo, lo spettatore dovrà contribuire continuamente a completare gli spazivuoti creati dall’artista»10.
Vico racconta come nei primi uomini lo stupore e la meraviglia prendes-sero il sopravvento davanti al balenare di un fenomeno atmosferico. L’inca-pacità di trovare una spiegazione per quanto li terrorizzava, li indusse amettere inconsapevolmente in atto una finzione: risalivano dall’effetto allasua causa, s’ingegnavano a delineare i caratteri della figura che potessespiegare un fulmine; Giove nasceva così dalla robusta ignoranza che porta-va i primi uomini a credere a quell’immagine che scolpivano nella loro te-sta, senza rendersi conto di esserne gli artefici; non conoscevano l’incredu-lità perché avvinti dalla fantasia.
Gabriele De Luca prova a spiegare come la fantasia congenita dei primiuomini non sia stata persa in quelli che Vico definisce i “tempi addottrina-ti”. È stata piuttosto rielaborata, è diventata un procedimento consapevoledi sé, che consente all’uomo di muoversi con sicurezza sul confine tra realee fittizio. Da un inconsapevole demiurgo della realtà, l’uomo impara a esse-re un creativo lettore del mondo.
In Auerbach sulle tracce di Vico. Un contributo sulle nozioni di Ansatz e
12 Danilo Manca
00intro 7_mastro 24/06/14 12:08 Pagina 12
11 Matteo Bensi, Auerbach sulle tracce di Vico. Un contributo sulle nozioni di Ansatz e Fi-gura, infra, p. 74.
12 Erich Auerbach, Filologia come arte critica, in Aa.Vv., Vico in Europa zwischen 1800 und1950, a cura di P. König, Winter, con prefazione di M. Vialon, Heidelberg 2013. Cfr. infra, p. 78.
Figura, Matteo Bensi prende in considerazione forse il maggior esempio dirielaborazione moderna dell’umana disposizione poietica. Auerbach era unlettore talmente appassionato di Vico da servirsi della sua teoria filologicacome spunto per la sua operazione culturale. Il contributo affronta accura-tamente la questione, mostrando come non solo dietro il contenuto di Mi-mesis, ma persino alla base della sua struttura portante, si annidi un atteg-giamento vichiano.
Auerbach ritiene che la realtà sia sempre presente nell’opera artistica.Vico riteneva non si potesse ricostruire la storia dell’incivilimento umanosenza far riferimento all’esperienza e al senso comune. Auerbach interpretail divenire della letteratura come un percorso di mutamento della percezio-ne della realtà.
Ogni saggio di Mimesis inizia con una breve citazione. Per Auerbach sitratta di un Ansatzpunkt, un abbrivio, «uno spunto parziale da cui si desu-me l’intero, la parte che significa il tutto»11. La citazione letteraria è un ca-so concreto che illumina sul contesto culturale, geografico, stilistico in cuiopera l’autore. Questo sistema di riferimenti per connessioni metonimicheche consente ad Auerbach di procedere dal testo al contesto, rispecchia ilpensiero concreto dei primi poeti delle nazioni barbariche vichiane. Vicostesso, nella Scienza nuova, individua nelle connessioni metonimiche il pro-cedimento originario della prima lingua. Introducendo la nozione di “pen-siero figurale” Auerbach rielabora in chiave moderna, addirittura rendescientifico e oggettivo, quello che presso i barbari antichi era l’atteggiamen-to più naturale possibile.
La posta in gioco è davvero alta. Da agente interpretante, Vico diventasoggetto interpretato. Vico rivelò la poieticità dei primi uomini, Auerbachrileva l’artisticità che si cela dietro l’approccio filologico vichiano. «Vicoera un anziano maestro di scuola, del tutto dimentico di sé, che non si sen-tiva un poeta; chiamò in aiuto la sua fantasia, ma la sua è tuttavia una fanta-sia assolutamente obiettiva; non viveva nelle tendenze in movimento delsuo tempo, viveva nei suoi oggetti, e quando speculava fantasticamente, lofaceva a partire dai suoi oggetti, non dai suoi sentimenti o dalle tendenzedella sua generazione»12.
* * *
Quando si chiama in causa Vico si impara a ricercare l’origine dell’artenell’attività mitopoietica dei primi uomini. Nel saggio Il forgiatore di mitinel pensiero di Ernst Cassirer, Valentina Serio approfondisce la questione
Introduzione. Scolpire un velo 13
00intro 7_mastro 24/06/14 12:08 Pagina 13
13 Valentina Serio, Il forgiatore di miti. Cassirer lettore di Hölderlin, infra, p. 88.14 Ernst Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, 3 voll., a cura di E. Arnaud, La Nuova
Italia, Firenze, 1966: vol. II, p. 274.15 Cfr. V. Serio, Il forgiatore di miti. Cassirer lettore di Hölderlin, infra, p. 90.
cercando di individuare il punto di passaggio dalla forma spirituale del mi-to a quella dell’arte.
Nella mitopoiesi originaria l’uomo è in stretto contatto con la natura, al-la quale «si sente vincolato come per continuata ligamenta, muovendosi se-condo un ritmo unitario, respirando in un medesimo afflato»13.
Inizialmente, la rappresentazione simbolica delle cause di ciò che mera-viglia e spaventa l’uomo primitivo avviene del tutto inconsciamente. Tutta-via, il fatto che la percezione sia nella sua dimensione primitiva originariasempre compenetrata di elementi emotivi, spinge il mitopoieta ad attribuirealle immagini, da lui spontaneamente prodotte, sempre delle qualità fisio-gnomiche: quello che viene vissuto come fonte di gioia ed eccitazione avràfattezze benevoli e fascinose, quello che invece viene ritenuto fonte di tri-stezza e angoscia sarà rappresentato con tratti repellenti e minacciosi. Que-st’associazione di sentimento e percezione che porta a una graduale antro-pomorfizzazione degli agenti naturali segna e orienta il passaggio dalla mi-topoiesi a quella forma conscia di produzione simbolica che è l’arte. Rap-presentando con fattezze umane gli dèi che sovrintendono ai diversi feno-meni naturali, l’uomo arriva progressivamente a comprendere che la spie-gazione di quello che vede e non capisce non deve essere semplicemente ri-cercata all’esterno di sé, ma può annidarsi nella sua interiorità: «È stata sol-tanto l’arte che, permettendo all’uomo di raggiungere la propria immagine,ha scoperto anche in certo qual modo la specifica idea dell’uomo come ta-le. Nella rappresentazione plastica degli dèi si può seguire quasi passo pas-so l’evoluzione che qui si è compiuta»14.
Quando il forgiatore di miti acquista consapevolezza del suo fare pro-duttivo, si trasforma gradualmente in un artista, cioè in una specie di alchi-mista che usa le parole come degli alambicchi e delle serpentine per subli-mare le emozioni umane, senza privarle al contempo di quella vis creativache le caratterizza15. Nel suo contributo, Valentina Serio coinvolge lo scrit-to di Cassirer dedicato a Hölderlin e l’idealismo tedesco, per capire se inepoca moderna il legame tra arte e mitopoiesi venga in qualche modo con-servato. In Hölderlin, Cassirer vede, infatti, quel poeta che ha tentato diriunificare le due figure dell’artista e del mitopoieta e di recuperare, dun-que, il senso originario dell’umana creatività simbolica.
Quando l’uomo inizia a dimenticare gli antichi dèi pagani, secondo Höl-derlin, la sua poesia e la sua arte si distaccano dalla natura. Motivo per cuiHölderlin rende tema delle sue liriche la nostalgia per questa condizioneperduta.
14 Danilo Manca
00intro 7_mastro 24/06/14 12:08 Pagina 14
16 Marta Vero, Dalla poesia riflessiva al linguaggio geroglifico. Sull’estetica di F. Schlegele Novalis, infra, p. 99.
Hölderlin non scorge negli dèi del passato e negli elementi naturali (lu-ce, terra, etere) solo delle rappresentazioni inadeguate di quello che la filo-sofia avrebbe reso esplicito tempo dopo. In quanto simboli essi sono glistrumenti in virtù dei quali il contenuto concettuale viene generato. Nel-l’ottica di Cassirer, questo messaggio consente al pensiero in versi di Höl-derlin di riscoprire una nuova ingenuità: un sentimento capace di svelarequali esigenze tipicamente umane giacciano dietro la nascita di una doman-da filosofica.
* * *
Com’è possibile la poesia in un’epoca eminentemente riflessiva quale lamodernità? Tutti gli articoli sinora descritti sviluppano questa domanda, al-la base della quale vi è la convinzione che poesia e natura siano un tutt’uno,come rende esplicito la poetica di Hölderlin.
Interrogarsi sulla possibilità che la poesia possa essere in grado di rico-struirsi un suo ruolo nel mondo moderno significa riconoscere la riflessionecome l’agente del distacco e individuare nella filosofia il risultato cui giungel’uomo quando separa contemplazione, azione, sentimento e fare artistico.
In quel mirabile manifesto di un’epoca che è il saggio Sulla poesia inge-nua e sentimentale, Schiller individua due modi del sentire alla base di duediverse forme poetiche: da una parte, la poesia nata dal rapporto d’armoniache intercorre tra uomo e natura; dall’altra parte, la poesia figlia del senti-mento di distacco dalla natura, generata dalla nostalgia per un legame dete-rioratosi con l’avvento della riflessione autoreferenziale.
In antichità l’uomo era natura, la poesia era qualcosa che nasceva sponta-neamente; anche nel periodo moderno ci sono degli esempi d’ingenuità, maessa nasce piuttosto dal genio del singolo individuo, capace di vivere in un’e-poca artificiosa, ma di crescere culturalmente sotto il cielo greco. Il poetasentimentale è, invece, colui che trasforma la domanda sulla possibilità dellafilosofia in epoca moderna in contenuto della produzione poetica stessa.
Nel saggio intitolato Dalla poesia riflessiva al linguaggio geroglifico. Sul-l’estetica di F. Schlegel e Novalis, Marta Vero analizza l’esperienza del proto-romanticiscmo jenese con l’intento di mostrare come la riflessione filosoficapossa diventare fruttuosa per l’attività poetica.
Schlegel e Novalis hanno sistematicamente rielaborato in chiave esteticaconcetti fondamentali della Wissenschaftslehre fichtiana. Quest’atteggiamen-to li indusse a credere che «non è il pensiero ad asservire a sé il sentimentopoetico, ma è piuttosto la concreta attività poietica della poesia a piegare iconcetti elaborati dalla filosofia ai suoi interessi e ai suoi obiettivi»16.
L’inevitabile tendenza dell’io a riflettere sul proprio pensare induce, ad
Introduzione. Scolpire un velo 15
00intro 7_mastro 24/06/14 12:08 Pagina 15
17 Novalis, Poesia, in Lavori preparatori per raccolte di frammenti diverse (fine 1797 - inizio1798), Fr. n. 31-32, tr. it. in Opera filosofica, vol. I, cit., p. 472. Cfr. infra, p. 98.
18 Cfr. M. Vero, Dalla poesia riflessiva al linguaggio geroglifico, infra, pp. 101-104.
esempio, Schlegel a immaginare una poesia trascendentale che sia capace,al contempo, di produrre versi e di riflettere criticamente sulla propria atti-vità. La tendenza a oltrepassare la dimensione finita, a congiungersi conl’infinito, ha indotto Novalis a vedere nella filosofia una propedeutica al-l’attività poetica: «Se il filosofo si limita a ordinare, disporre, il poeta sciol-ga ogni legame. Le sue parole non sono segni generali – sono suoni – paro-le magiche, che muovono intorno a sé belle schiere»17.
La rielaborazione estetica del concetto fichtiano di Streben, di tensioneoppositiva e connettiva tra reale e ideale, consentì ai due autori di indivi-duare nell’incompiutezza e nella virtualità i caratteri precipui della poesiaromantica. Marta Vero affronta accuratamente questo punto: se nelle loroopere, nei loro romanzi, con i loro frammenti, i due autori apparentementenon hanno saputo creare un modello indimenticabile di poesia moderna,un capolavoro che la rappresenti, è perché non lo consentivano quei carat-teri che essi stessi attribuivano a tale poesia.
Schlegel e Novalis arrivano a sostenere che l’incomprensibilità di ciò cheè incompiuto e allusivo è un fattore costitutivo e non del tutto riprovevoledella poesia romantica. Se il poeta, infatti, vuole portare a rappresentazionela vita, il paradossale legame che intercorre fra la natura e l’io che avanza lesue ipertrofiche pretese, non può non immaginare una poesia in qualchemodo oscura, che sappia elevare ma anche deludere, che lasci intravederequalcosa solo nella misura in cui lascia cadere un velo sulla realtà, che rap-presenti la complessità della vita solo limitandosi ad accennare, senza pre-tendere di spiegare.
Quando dei concetti vengono tradotti in strategie poetiche, viene supe-rato il linguaggio astratto, generico e universalizzante della riflessione filo-sofica. Questa è la conclusione cui approda il saggio di Marta Vero. Novalise Schlegel esprimono quest’idea ricorrendo all’immagine del “geroglifico”.Trasformando un’immagine in una figura elargitrice di senso, in una figurache comunica, il geroglifico permette un rischiaramento graduale, ma maiconclusivo, del contenuto simbolicamente rappresentato18. La poesia ro-mantica deve adottare questa stessa strategia rappresentativa per conviverecon una riflessione sulle condizioni del proprio svolgersi. Solo se si adoperaun linguaggio in cui il significato della parola, nel suo darsi, si sottrae, solose rimane un fondo d’incomprensibilità, allora si riesce a elevare l’empiricoall’ideale e, al contempo, a esprimere l’ineludibile distanza che li separa.
Anche il protagonista del contributo di Edoardo Raimondi, Johann PaulFriedrich Richter, in arte Jean Paul, intraprende la sua riflessione esteticadall’idea che la filosofia possa fare a meno delle metafore per esporre la sua
16 Danilo Manca
00intro 7_mastro 24/06/14 12:08 Pagina 16
19 Jean Paul, Clavis fichtiana seu leibgeberiana, Bayreuth 1800, tr. it. di Eleonora de Con-ciliis e Hartmut Retzlaff, Cronopio, Napoli 2003, p. 56. Cfr. infra, p. 110.
20 Ivi, p. 46. Cfr. infra, pp. 108-109.
prospettiva: persino un fautore del primato della filosofia come Fichte puòprivarsene. Infatti, il modo in cui quest’ultimo descrive la scissione e laconsecutiva sintesi dell’Io assoluto in un Io empirico e nel Non-Io della na-tura, secondo Jean Paul, conserva una sua forza immaginifica. Tuttavia, leconclusioni cui egli approda sono in stretta antitesi con quelle cui giunseroi proto-romantici jenesi, i fratelli Schlegel in particolare.
Agli occhi di Jean Paul, Fichte ha sbagliato a pensare che la sua filosofiapotesse essere una spiegazione scientifica della realtà, quando, invece, quel-lo che essa rende possibile è una trasposizione in poesia del nichilismo chepervade la realtà.
Il saggio, intitolato Jean Paul e le immagini poetiche della sua epoca, sisofferma sulla figura di Leibgeber, uno degli alter ego ideati dall’autore diLipsia, l’uomo diventato folle dopo aver provato a conformare la propriavita alla dottrina di Fichte.
Leibgeber si appassiona alla Wissenschaftslehre a tal punto da identifi-carsi con quell’io astratto lì rappresentato, creatore del mondo e di se stes-so. Questo lo induce a sviluppare un poli-egoismo che, invece di alimentarel’idea che l’Io sia il principio originario del Tutto, mostra come la sua iper-trofia lo porti a essere un nulla: quello che è tutto e non è nessuno, è sestesso, ma anche il suo altro, uno e molteplice al contempo, il lettore dellaWissenschaftslehre, ma anche il suo autore.
A quest’assurdo risultato giunge un linguaggio che, mentre inseguival’oggettività, si è, invece, trovato a corrodere dall’interno le pretese univer-salizzanti della filosofia.
Accompagnando alle sue estreme conseguenze le deduzioni fichtiane,Jean Paul mostra quanto possa divenire ridicolo un discorso che provi asbarazzarsi dei particolari che costituiscono il reale.
Jean Paul accusa di leibgeberismo i fratelli Schlegel. A suo parere hanno«solo fedelmente ripetuto ciò che hanno detto Kant, Fichte e Goethe»19,
senza riuscire a trasfigurare esteticamente la loro posizione; hanno conti-nuato a vedere nel linguaggio una «tecnica del puntiforme eseguita con ato-mi», «un’algebra logica», che «si allarga, fino a che l’intero universo se nesta lì, con tutte le sue forze e i suoi colori, trasparente come un vuoto earioso non-Io»20.
Questi motivi inducono Jean Paul a opporre, nel finale della sua Vor-schule der Ästhetik, alla poesia trascendentale la nozione di “poetische Poe-sie”. Piuttosto che auto-fondarsi inglobando la critica in se stessa, la poesiaromantica dovrebbe auto-distruggersi; piuttosto che aspirare ad avere la fi-losofia in seno, dovrebbe ridicolizzare la filosofia, sino a renderla tema di
Introduzione. Scolpire un velo 17
00intro 7_mastro 24/06/14 12:08 Pagina 17
21 Edoardo Raimondi, Jean Paul e le immagini poetiche di un’epoca, infra, p. 112.22 Antonio Prete, Poesia e filosofia, in Meditazioni sul poetico, Moretti&Vitali, Bergamo
2013, p. 63. 23 Ibidem.24 A. Prete, La vita e le forme: miraggi, corrispondenze, in Meditazioni sul poetico, cit., p. 70.
un racconto umoristico; piuttosto che presentarsi come conclusione a-stori-ca e senza genere della storia delle produzioni poetiche, dovrebbe inveceessere interprete di un’epoca storica particolare. «Jean Paul si pone a metàfra classico e moderno, nichilismo e materialismo, imitazione e creazione,fantasia e immaginazione. Mentre porta alle estreme conseguenze la ten-denza dell’io all’ipertrofia, al contempo cerca un’immagine compiuta dellasua realtà storica: dopo il sogno folle vi è il risveglio assennato condottotramite il ricorso al comico, all’umorismo e all’arguzia»21.
* * *
Indagini sul modo in cui filosofia e letteratura dialogano, si scontrano,provano a convivere, ci hanno portato a vedere nel linguaggio la cifra dellaloro differenza.
La filosofia si è spesso limitata a usare il linguaggio come strumento, apiegarlo alle sue esigenze. La poesia invece ha sempre lavorato sul linguag-gio. Questo l’ha indotta a trasformare i limiti del linguaggio in pregi, a in-travedere delle potenzialità nell’incapacità di esprimersi e nelle difficoltàgenerate dal bisogno di comunicazione.
In Meditazioni sul poetico, Antonio Prete ha definito la poesia «un’espe-rienza intensiva e allo stesso tempo interrogativa del linguaggio», mentre hascorto nella filosofia «un’esperienza intensiva e allo stesso tempo interrogati-va della conoscenza»22. Se la poesia è «pensiero che espone il suo ritmo, lasua lingua, la sua musica», la filosofia è, invece, «pensiero che espone i modidella conoscenza, anzi il ritmo stesso della conoscenza»23. Anche la filosofia,in quanto linguaggio, ha dunque il suo ritmo; quel ritmo che, ad esempio,trasforma in inferenze le analogie carpite da una meditazione poetica.
Spesso la filosofia tenta di incastonare in una deduzione le suggestioniofferte da un componimento ispirato. Si comporta un po’ come mi sonoappena comportato con la “poesia in prosa” di Antonio Prete.
Spesso la filosofia tenta di non essere estranea alla vita, di sfuggire all’ac-cusa d’astrazione e di esibire nei suoi discorsi le contraddizioni in cui si arti-cola la realtà. Altrettanto spesso, però, fallisce. Al contrario, «nella linguadella poesia, nelle sue forme, è possibile scorgere, come in una sorta di in-tensiva presenza, le relazioni, le asimmetrie, le dissonanze, gli orditi, gli ara-beschi, le dimenticanze, le contaminazioni che legano la filosofia alla vita»24.
Interrogando il linguaggio, la poesia diventa quindi un’esperienza in-tensiva della filosofia che anonimamente s’annida fra le maglie della vita;
18 Danilo Manca
00intro 7_mastro 24/06/14 12:08 Pagina 18
25 Chiara Mastroberti, Immagini della metamorfosi nell’opera di Rainer Maria Rilke, infra,p. 117.
26 Rainer Maria Rilke, Il diario fiorentino, tr. it. di G. Zampa, BUR, Milano 1990, pp. 207-209. Cfr. infra, p. 121.
27 C. Mastroberti, Immagini della metamorfosi nell’opera di Rainer Maria Rilke, infra, pp.120-121.
28 Ivi et infra, p. 125.
un’esperienza che sa mettere in risalto il ritmo, la lingua e, perché no, lamusica della conoscenza nei suoi stadi nativi.
In Immagini della metamorfosi nell’opera di Rainer Maria Rilke, ChiaraMastroberti coglie un’esperienza di questo genere nelle evoluzioni e nelleinvoluzioni di uno dei maestri della poesia del primo Novecento.
Un «desiderio di rappresentare il divenire senza arrestarlo, di mostrarela metamorfosi in atto in modo da assecondarne il movimento»25, ha spintoRilke a modificare, nel corso della sua produzione, strategie e convinzionipoetiche.
Il contributo in questione attraversa quest’esperienza rintracciando tretappe fondamentali. Negli appunti del Florenzer Buch e nelle prime raccol-te liriche, un Rilke a tratti acerbo prova a riconquistare una certa «frater-nità ed eguaglianza con le cose che è come una protezione reciproca»26.Con quest’intento Rilke annichilisce completamente le pretese del suo io esi lascia trasportare dall’ispirazione. Tuttavia, presto si rende conto che «lecose sono, di fatto, mute se il loro mormorare indistinto non riceve atten-zione da parte dell’io e non viene tradotto in parole nuove»27.
I Neue Gedichte segnano il passaggio a un approccio più compositivo,focalizzato sulla ricerca di una parola che sappia farsi cosa. Ad affascinareRilke sono, in questo secondo periodo, la scultura di Rodin e la pittura diCézanne. Ma l’influenza dell’arte astratta lo confonde: nelle Aufzeichnun-gen des Malte Laurids Brigge, il poeta avverte di essere un mago evocatoreche ha finito per contaminare l’equilibro della natura: «L’arte riflette l’im-magine di un mistificatore e restituisce il mondo esterno in frantumi»28.
Il poeta oscilla tra l’istinto a lasciarsi trasportare dal divenire delle cose ela spinta a dare loro delle forme. Nelle Duinenser Elegien un Rilke oramaimaturo rende fruttuoso il suo smarrimento: solo quando riesce a dare deltu alle cose, l’io del poeta arriva a soggiornare presso di esse; specchiandosiin loro produce immagini della sua stessa metamorfosi.
* * *
L’esperienza di Rilke ci racconta di una poesia che ha cresciuto nel suogrembo la filosofia per estirparne le pretese. Attraversando lo spasmodi-co desiderio del poeta di lasciar parlare le cose e di zittire il proprio ego,arriviamo a un punto quasi opposto a quello cui ci avevano condottomolti articoli precedenti. Non siamo più nel tempo in cui la filosofia sembra
Introduzione. Scolpire un velo 19
00intro 7_mastro 24/06/14 12:08 Pagina 19
29 Lorenzo Serini, Nietzsche e Valéry: la filosofia di fronte all’epilogo, infra, p. 131.30 Paul Valéry, Quaderni, tr. it. a cura di Ruggero Guarini, vol. I, Adelphi, Milano 1985.
Cfr. infra, p. 133.31 Friederich Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extra-morale, in La filosofia nell’epoca
tragica dei Greci, tr. it. a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, p. 357. Cfr. infra, p. 135.
essere regina e la poesia è chiamata a trovare un ruolo alla sua corte. L’intensiva e interrogativa esperienza del linguaggio poetico di cui ci fa
dono Rilke rivela un nuovo mondo: quello in cui la filosofia è chiamata ainterrogarsi sul linguaggio di cui si serve, pena il rischio di costruire castellidi parole e mondi di carta, lontani e avulsi dalle più urgenti domande sul-l’esistenza umana.
In Nietzsche e Valéry: la filosofia di fronte all’epi-logo, Lorenzo Serini af-fronta di petto la questione. Si rivolge a due autori particolari: da una par-te, «un filosofo tedesco che manifesta la volontà di “tornare al mondo co-me francese”», dall’altra «un poeta francese cui manca un tedesco che portia termine le sue idee»29.
Una crisi esistenziale convinse Valéry ad annotare ogni mattina sul suodiario i suoi pensieri. Ma, scoprire, indagare e illuminare la storia dellamente umana, non è altro che un’interrogazione del linguaggio: «Il mio è illavoro di Penelope, questo lavoro su questi quaderni – giacché consiste nel-l’uscire dal linguaggio ordinario e ricadervi, uscire dal linguaggio in genera-le – vale a dire dal – passaggio e ritornarvi»30.
Valéry ripercorre la strada solcata da Nietzsche. Quando l’uomo ha di-menticato che il linguaggio è essenzialmente una produzione di metafore eha creduto di poter incastonare il divenire della vita in una serie di concettifissi, non è più stato in grado di comprendere che «le verità sono illusionidi cui si è dimenticata la natura illusoria, sono metafore che si sono logora-te e hanno perduto ogni forza sensibile, sono monete la cui immagine si èconsumata e che vengono prese in considerazione soltanto come metallo,non più come monete»31.
Il tempo in cui la filosofia si trova alle prese con il suo epilogo è il tempoin cui inizia a chiedersi se può sopravvivere anche dopo aver abbandonatoil suo sterile linguaggio astratto e universalizzante.
Lorenzo Serini mostra come la misosofia di Valéry e la critica genealogicadi Nietzsche mettano in risalto i limiti della filosofia per riscoprine le poten-zialità. Quando vengono ribaltate tutte le convenzioni linguistiche in uso,quando vengono meno tutti gli idoli linguistici, il discorso filosofico si apreal pensiero del possibile, scopre quale libertà dischiuda l’orizzonte del nulla.
Cruciale nelle riflessioni di Valéry e Nietzsche diventa lo stile, più diogni contenuto. Il modo in cui lo spirito vive e costruisce la sua libertà al dilà del linguaggio banale è la chiave per la vita della filosofia nell’epoca delsuo congedo.
20 Danilo Manca
00intro 7_mastro 24/06/14 12:08 Pagina 20
32 F. Nietzsche, Frammenti Postumi 1888-1889, vol. VIII, t. III, 15 [117], tr. it. di S.Giametta, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1974, p. 264. Cfr. L. Serini,Nietzsche e Valéry: la filosofia di fronte all’epilogo, infra, p. 143.
33 Stella Ammaturo, Il Socrate architetto di Paul Valéry, infra, p. 149.34 Ivi et infra, p. 147.35 P. Valéry, Eupalinos, in Eupalinos. Preceduto da ‘L’anima e la danza’ e seguito dal ‘Dialogo
dell’albero’, tr. it. a cura di Vittorio Sereni, con introduzione di Enzo Paci, Mondadori, Milano1947, p. 76. Cfr. infra, p. 151.
Il pensatore e il poeta – chi dei due sia Valéry, chi Nietzsche, poco im-porta – arrivano a identificare nell’equilibro instabile di ogni danzatrice,nel suo tentativo di volo, il paradigma dello spirito libero, di quell’uomopronto a diventare ciò che è.
Una filosofia danzante è un pensiero capace di creare, una filosofia ca-pace di «avventurarsi su ogni corda, danzare su ogni possibilità»32. Questoè il tarlo che pungola Nietzsche, non consentendogli di identificare total-mente il filosofo con l’uomo che ha abbandonato la creatività.
La possibilità che una rivoluzione del proprio linguaggio renda la filoso-fia non estranea all’arte è l’unica risorsa che nell’epoca del suo epilogo anco-ra impedisce alla filosofia di capitolare. Questa consapevolezza è il punto dipartenza di Stella Ammaturo nel saggio Il Socrate architetto di Paul Valéry.
Nel § 14 de La nascita della tragedia Nietzsche si chiede se non si possaimmaginare un Socrate artista distinguendo l’eroe dialettico dei dialoghiplatonici dall’uomo che ha voluto morire perché ha capito che solo la mor-te poteva curare la malattia da cui, come ogni uomo, era affetto: la pauradella morte stessa. Questa domanda è stata il tafano di Nietzsche, lo ha co-stretto a oscillare continuamente «fra la visione di Socrate come spettatoredella morte della tragedia antica e l’ipotesi, invece, che in quell’esperienzadi vita si possa scorgere il germe di un Socrate capace di innalzarsi al di so-pra della prigione dialettica allestita per lui dal suo discepolo Platone»33.
Stella Ammaturo ricostruisce la visione aporetica di Socrate maturata daNietzsche, per comprendere le origini di un interessante progetto di Valéry:scrivere «una serie di dialoghi pseudo-platonici, che arrivassero a immaginarel’esistenza di Socrate dopo la sua morte, lì dove il Fedone si era fermato»34.
In Eupalinos, Socrate riprende nell’aldilà il suo dialogo con Fedro. Stra-namente lo fa quasi malvolentieri, perché gli sembra che dopo la morte tut-to diventa irriconoscibile: «La verità è davanti a noi e noi non comprendia-mo più»35.
Fedro gli racconta di Eupalinos, l’architetto che ha trasposto in immagi-ne matematica le caratteristiche proporzioni di una ragazza di Corinto untempo felicemente amata. Socrate rimane affascinato dalla figura dell’archi-tetto, l’uomo capace di plasmare la propria vita; perciò, decide di provare apensare come sarebbe stata la sua vita se invece di essere filosofo avessescelto di essere architetto.
Introduzione. Scolpire un velo 21
00intro 7_mastro 24/06/14 12:08 Pagina 21
36 S. Ammaturo, Il Socrate architetto di Paul Valéry, infra, p. 157.37 Ivi et infra, p. 160
Solo perché è morto, Socrate riesce a immaginare un’esistenza alternativaa quella che lo ha contraddistinto e reso famoso. Un Socrate senza il pro-blema della morte è sottratto al limbo della decadenza, tra il rifiuto dellamusica tragica e l’istinto a comporre miti, a scrivere inni ad Apollo, a met-tere in versi favole di Esopo. Il Socrate architetto è uno spirito libero ca-pace di «riconoscere al logos facoltà che oltrepassano quelle della meradialettica»36.
Il contributo di Stella Ammaturo ci riporta all’origine dell’intero dialogotra filosofia e letteratura, al momento in cui l’una scompaginava quella chel’altra ordinava. Aggiunge però un elemento che forse riassume l’intera in-dagine con la quale si cimentano tutti gli articoli del volume. Questi dialoghitra filosofia e letteratura mostrano, infatti, come la filosofia non possa fare ameno della letteratura e come la letteratura divenga consapevole di non po-ter evitare di essere filosofica. Grazie alla poesia, la filosofia comprende chela metafora non genera sempre oscurità, spesso illumina quelle zone d’om-bra che il linguaggio astratto non riesce neanche a intravedere; grazie alla fi-losofia, l’arte comprende che non può non meditare su se stessa.
Quando Socrate riconosce a un’arte come l’architettura il compito di ri-strutturare il reale non sta facendo altro che elevare l’arte a meditazione filo-sofica per eccellenza. Un’esperienza intensiva e interrogativa del linguaggioche diventa un’esperienza intensiva e interrogativa della conoscenza: «Il dia-logo tra Socrate e Valéry sul legame tra scienza e arte, musica e architettura èla favola che lascia intravedere le origini dell’impulso umano a conoscere»37.
* * *
Un’introduzione non può ospitare delle conclusioni. Un’introduzioneannuncia, dischiude, invita, accompagna. Magari può delineare un orizzon-te. Alla fine di un’introduzione siamo appena sulla soglia del castello, ab-biamo attraversato il guado. Alla fine di qualsiasi introduzione c’è il veroinizio. Alla fine di questa introduzione vorrei soffermarmi sul titolo: Il veloscolpito.
Come ho potuto illustrare, tutti gli autori di cui si parla in questo volu-me si interrogano sulla natura dell’atto poietico, su quello che accade nelmomento in cui si crea una finzione.
Le finzioni dell’arte sono un sottile velo che si adagia sul mondo reale.Sono un velo che copre e lascia intravedere al contempo; sono un velo chesottolinea: aderendo alla realtà ne lascia risaltare i contorni, evidenzia quel-lo che uno sguardo ingenuo trascura. Le finzioni di cui si parla in questo te-sto sono quelle della letteratura, dell’arte della parola che si fa immagine.Lo scalpello della parola mette in rilievo il velo, ne rivela la natura fittizia,
22 Danilo Manca
00intro 7_mastro 28/05/14 09:28 Pagina 22
nello stesso momento in cui lo crea. Il velo nasconde alcuni tratti dellarealtà, ne mette in evidenza degli altri. Quando la letteratura incontra la fi-losofia, il linguaggio che cela s’intreccia con il linguaggio che scolpisce, chepuntualizza, che definisce, che recupera quella forma annidatasi in ogniinforme.
Scegliendo una metafora come titolo si decide di lasciare alla letteraturala prima e l’ultima parola sul contenuto filosofico da lei ospitato. Una me-tafora non può essere spiegata del tutto; è nella sua natura conservare unazona d’ombra, un momento di ambiguità, una componente incomprensibi-le. Sono proprio questi tratti, però, a rendere la metafora più virtuosa dimolti concetti incapaci di carpire la contraddittorietà insita in ogni espe-rienza umana.
Scolpire un velo è come parlare di musica e ballare d’architettura. Scol-pire un velo è come filosofare sulla letteratura.
Introduzione. Scolpire un velo 23
00intro 7_mastro 28/05/14 09:28 Pagina 23
























![Sulle tracce della letteratura socratica antica [ 1993 ]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63131167c32ab5e46f0c4092/sulle-tracce-della-letteratura-socratica-antica-1993-.jpg)