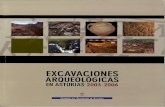Poesia, storia e narrazioni esemplari: Droctulf da Croce a Borges, in "BIZANTINISTICA", vol. XIII,...
Transcript of Poesia, storia e narrazioni esemplari: Droctulf da Croce a Borges, in "BIZANTINISTICA", vol. XIII,...
BizantinisticaRivista di Studi Bizantini e Slavi
SERIE SECONDA
Anno XIII - 2011
FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL’ALTO MEDIOEVOSPOLETO
R A S S E G N E E D I S C U S S I O N I
ALESSANDRO IANNUCCI
Poesia, storia e narrazioni esemplari:Droctulf da Croce a Borges
1. Le notizie storiche sul duca svevo Droctulf sono scarne e incer-te; ma i pochi dati a disposizione consentono di ricostruire una biogra-fia avventurosa e non priva di fascino 1.
Paolo Diacono (Historiae Longobardorum III 18-19) ne delinea unbreve ritratto dai caratteri fortemente romanzeschi, come tipico del suostile 2 e si sofferma in particolare sul suo passaggio alla causa impe-riale (seque partibus imperatori tradens). Droctulf, di origine sveva o
1 Per una prima ricostruzione e per la raccolta delle fonti, cfr. J. R. MARTINDALE, The Proso-pography of the Later Roman empire, III, A.D. 527-641, Cambridge-New York, 1991, pp. 425-427; S. GASPARRI, Droctulfo, in Dizionario biografico degli Italiani, XLI, Roma, 1992, ora con-sultabile anche online alla url: <http://www.treccani.it/enciclopedia/droctulfo— (Dizionario-Bio-grafico)/> nonché S. COSENTINO, Prosopografia dell’Italia bizantina (493-804), I, A-F, Bologna,1996, pp. 382-383. Un più ampio profilo – a tratti discutibile osserva GASPARRI, Droctulfo, cit. –è quello di G. P. BOGNETTI, Tradizione longobarda e politica bizantina nelle origini del ducato diSpoleto, in ID., L’età longobarda, III, Milano, 1967, pp. 461-469. Il nome è attestato anche nelleforme Droctulfus e Drocton (in Paolo Diacono) e Dróktwn (in Teofilatto Simocatta) nonchéDrocdon (in Agnello) e l’ormai usuale Drogdone. Sulle diverse forme del nome – e per una ric-chissima rassegna delle presenze di Droctulf nell’erudizione specie romagnola, materiale ancoratutto da esplorare – cfr. il « Catalogo Santi Muratori » della Biblioteca Classense di Ravenna,cassetto donn—eca, numeri 16424 – 16431 e 16434 – 16445: il catalogo digitalizzato è ora di-sponibile anche online: <http://www.classense.ra.it/main/index.php?id—pag=218>. Sulle vicendenarrate, in generale, cfr. J. FERLUGA, L’organizzazione militare dell’Esarcato, in Storia di Raven-na, II, Dall’età bizantina all’età ottoniana, a cura di A. CARILE, 2. Territorio, economia e società,Venezia, 1991, pp. 379-387, in part. 383.
2 Su questo si vd. per es W. GOFFART, The Narrators of Barbarian History (A.D. 550-800).Jordanes, Gregory of Tours, Bede, and Paul the Deacon, Princeton, 1988; più in generale, e conparticolare riguardo agli aspetti storici si può far riferimento a Paolo Diacono: uno scrittore fra
ALESSANDRO IANNUCCI234
alamanna (ex Suavorum, hoc est Alamannorum, gente oriundus), sa-rebbe cresciuto in una condizione di servitù presso i Longobardi, se-gnalandosi tuttavia per le proprie doti, fisiche in particolare, fino a ot-tenere gli onori del ducato. Ma appena gli fu possibile si rivoltò con-tro i Longobardi appunto ulciscendae suae captivitatis diventando undifensore dell’impero nella guerra contro il re Autari, prima durantel’assedio di Brescello, poi a Ravenna nella riconquista del porto diClasse 3:
III (18) Dopo questi avvenimenti, il re Autari mosse all’assalto della città diBrescello, posta sulla riva del Po. In essa si era rifugiato, abbandonando iLongobardi, il duca Droctulf e, passato all’imperatore e unitosi ai soldati im-periali, resisteva accanitamente all’esercito longobardo. Costui era di originesveva, cioè alamanna, ed era cresciuto tra i Longobardi e, poiché era fisica-mente idoneo, aveva meritato l’onore del ducato; ma appena gli si offrì l’oc-casione di vendicare la sua servitù, subito insorse opponendosi alle armi deiLongobardi. Contro di lui i Longobardi condussero dure guerre e alla fine losconfissero insieme alle milizie che stava aiutando e lo costrinsero a ritirarsia Ravenna. Brescello fu presa e le sue mura rase al suolo. Dopo di che il reAutari fece una pace triennale con il patrizio Smaragdo, che governava alloraa Ravenna. (19) Con il sostegno di questo Droctulf di cui abbiamo detto,spesso i soldati di Ravenna combatterono contro i Longobardi e, costruita unaflotta, cacciarono, con il suo aiuto, i Longobardi che occupavano Classe. Alui, quando ebbe raggiunto il termine della sua vita, eressero un’onorevole se-poltura davanti alla chiesa del beato martire Vitale 4.
Il longobardo Droctulf dunque diventa un guerriero al servizio del-l’impero 5 e risiede a Ravenna, dove i resti della sua dimora, poi di-
tradizione longobarda e rinnovamento carolingio, Atti del convegno internazionale di studi (Ci-vidale del Friuli e Udine, 6-9 maggio 1999), a cura di P. CHIESA, Udine, 2000.
3 L. SCHMIDT, Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. DieOstgermanen, München, 19342, pp. 603-604, dubita della notizia di una presenza di Droctulf aClasse che tuttavia è confermata dall’epitaffio in sua memoria, tramandato dallo stesso PaoloDiacono (su cui cfr. infra n. 14): cfr. L. CAPO, Paolo Diacono. Storia dei Longobardi, a cura diL. CAPO, Milano, 1992, p. 424. L’assedio di Brescello va presumibilmente datato al 584 (cfr.MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman empire, cit. a nota 1, 426) la conquista diClasse tra il 575 e il 576 (ibid.). Una cronologia più alta, ma poco probabile, è proposta da BOGNETTI,Tradizione longobarda e politica bizantina nelle origini del ducato di Spoleto cit. (nota 1).
4 Trad. CAPO, Paolo Diacono. Storia dei Longobardi cit. (nota 3), pp. 147-149.5 Sui complessi rapporti tra re longobardi e i “duchi” attratti dalla presenza bizantina in Ita-
lia, cfr. Y.-M. VERHOEVE, Le royaume lombard et les duchés: formes et moyens d’une intégration
POESIA, STORIA E NARRAZIONI ESEMPLARI 235
venuta sede del palazzo episcopale, sono ancora visibili in un muroadiacente l’antico complesso di San Teodoro, oggi noto come Battiste-ro degli Ariani 6. Teofilatto Simocatta (Historiae II 17-19) racconta lasua brillante partecipazione alla lotta contro gli Avari, nei Balcani nel586, come u‘postráthgov di Giovanni Mistacon; Droctulf è definito di« stirpe longobarda » – Loggóbardov d’ ouƒtov tò fûlon – e « uomostraordinariamente coraggioso e dotato di una robustezza particolar-mente adatta alla guerra » – a’när a’lkimåtatov kaì pròv tòn pólemone’mbriqéstatov.
Un epitaffio sepolcrale, ricordato da Paolo Diacono e da due ma-noscritti altomedievali 7, ricostruisce con accenti ancora più suggestivila singolare biografia di Droctulf 8. Si tratta di un epigramma di 32
progressive, in Médiévales, LI (2006), pp. 1-12, nonché W. POHL, The Empire and the Lombards:Treaties and Negotiations in the Sixth Century, in Kingdoms of Empire: the Integration of Bar-barian in Late Antiquity, ed. by W. POHL, Leiden - New York, 1997, pp. 75-134.
6 Cfr. AGNELLI ET ANDREAS Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, 86, ed. O. HOLDER EGGER,Hannover, 1878 (M.G.H., Scriptores Rerum Langobardicarum et Italicarum, saec. VI-IX), p. 317:« Infra urbem vero Ravennam ecclesiam sancti Theodori non longe a domo Drocdonis, qua do-mus una cum balneo et sancti Apolenaris monasterio, quod in superiora domus structum, episco-pium ipsius ecclesiae fuit ». Si vd. anche il commento a cura di D. MAUSKOPF DELYIANNIS, Thur-nout, 2006 (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 199). Il complesso monumentale diquella che oggi è la “Piazzetta degli Ariani”, e comprende oltre al Battistero, le vestigia di unantico muro, presumibilmente parte dell’edificio di Droctulf di cui qui si sta trattando, e la basili-ca dello Spirito Santo, presentano una intricata stratigrafia interna in cui andrebbero descritti e ri-costruiti i numerosi mutamenti e interventi lungo un periodo ormai di quindici secoli. La tutela ela valorizzazione di questo singolare crocevia di storie e tradizioni risulta particolarmente delica-to anche in ragione delle diverse proprietà e competenze di ogni sua parte a esclusione, parados-salmente, del muro di Droctulf che è da considerare, allo stato attuale, una “proprietà in corso didefinizione”; al riguardo, un gruppo di ricerca del Dipartimento di Beni Culturali dell’Universitàdi Bologna, sede di Ravenna – la cui sede è appunto affacciata sulla piazzetta degli Ariani – stasvolgendo analisi di tipo storico, diagnostico e giuridico finalizzate a una complessiva riqualifi-cazione dell’area monumentale sia da un punto di vista conservativo sia di quello della comuni-cazione / valorizzazione. Sulla presenza dell’arianesimo a Ravenna si può far riferimento a TH.S. BROWN, The Role of Arianism in Ostrogothic Italy: the Evidence from Ravenna, in The Ostro-goth from the Migration Period to the Sixth Century, An Ethnographic Perspective, ed. by S. J.BARNISH and F. MARAZZI, Woodbridge - Rochester (NY), 2007, pp. 417-441; per il muro di Droc-tulf si vd. anche E. CIRELLI, Spolia e riuso di materiali tra la tarda antichità e l’alto medioevo aRavenna, in Hortus Artium Medievalium, XVII (2011), pp. 39-48.
7 Si tratta del Parisinus 528 (X sec.) e del Palatinus 833 (IX-X sec.).8 CAPO, Paolo Diacono. Storia dei Longobardi cit. (nota 3), p. 475, osserva che non vi è
traccia di un’iscrizione sepolcrale a San Vitale ed ovviamente « la presenza dell’epitaffio in Pao-lo non indica necessariamente una sua conoscenza diretta né dell’iscrizione né di Ravenna ». Tra
ALESSANDRO IANNUCCI236
versi che stabiliscono un legame profondo tra l’avventuriero svevo-longobardo e la città di Ravenna, e ancora tra il ‘barbaro’ e l’impero.Proprio in relazione all’adesione di Droctulf alla causa imperiale è sta-to notato che mentre Paolo Diacono offre una spiegazione « di tipogermanico, forse più attendibile », quella dell’epitaffio è invece « tipi-camente “romana” » e sarebbe motivata dall’amore per l’impero 9.
Questi versi sono quindi generalmente letti e utilizzati per la lorofondamentale funzione di documento storico e prosopografico 10; mabenché siano tendenzialmente giudicati privi di valore estetico 11, sitratta anche di “vera poesia”, per riprendere (e non a caso), una cate-goria crociana oggi in disuso. Infatti, proprio attraverso l’immaginescolpita da questo epitaffio, certo a tratti oscuro ma non privo di gra-zia e di qualità compositive, Droctulf trascende la storia e l’erudizioneper diventare un significativo personaggio “letterario”, protagonista delracconto Storia del guerriero e della prigioniera di Jorge Luis Borges,pubblicato in El Aleph (Buenos Aires: Losada, 1952) 12.
In Borges, erudito lettore e narratore altrettanto erudito, è notoriamen-te forte il gusto della trouvaille o della citazione fittizia e allusiva 13; in
le ulteriori labili testimonianze su Droctulf, va segnalata la lettera con cui papa Gregorio racco-manda Droctulf all’esarca africano Gennadio I (cfr. Epistulae IX), presumibilmente nel 598, cfr.al riguardo COSENTINO, Prosopografia dell’Italia bizantina cit. (nota 1), p. 382.
9 Cfr. CAPO, Paolo Diacono. Storia dei Longobardi cit. (nota 3), p. 474; al riguardo si notinoin part. i vv. 7-8 su cui si focalizzerà il seguito di queste pagine.
10 Cfr. per es. supra n. 3; si noti anche che il riferimento ai vv. 31 ss. al « sacerdotem Iohan-nem » (vescovo di Ravenna tra il 606 e il 632, cfr. AGNELLI ET ANDREAS Liber Pontificalis Eccle-siae Ravennatis, 104-107, ed. cit. nota 6, pp. 342-343) stabilisce anche il 606 come terminus postquem della morte di Droctulf. In generale per l’utilizzo dell’epitaffio in chiave prosopografica sivd. per es. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire cit. (nota 1), nonché GA-SPARRI, Droctulfo cit. (nota 1).
11 CAPO, Paolo Diacono. Storia dei Longobardi cit. (nota 3), p. 475, un po’ ingenerosamentedefinisce « astruso » l’epitaffio; più articolato e duro il giudizio per es. di G. PEPE, Il medio evobarbarico d’Italia, Torino, 1963, p. 316 « L’epigrafe (sic!) che pure è tra le migliori, nata in am-biente di persistente cultura classica, come Ravenna, svela povertà costruttiva dei retori: la con-trapposizione corpore-meritis; l’accostamento suavus-suavis, l’enfasi “amans semper romana etpublica signa” e via dicendo » (ma cfr. infra n. 20).
12 Opera presto tradotta in italiano nella Biblioteca di Letteratura della Feltrinelli: cfr. J. L.BORGES, L’Aleph¸ trad. di T. MONTATTO, Milano, 1959 (e Milano, 19752, nella collana Universaleeconomica, da cui qui si cita).
13 Lo stesso Borges, in Altre inquisizioni, trad. it. Milano, 1976 (Buenos Aires, 1952) ha af-fermato che « La letteratura è un sistema di citazioni »; una raccolta di racconti in cui è dichiara-tamente esplicitato il motivo della citazione e discussione di libri immaginati è Ficciones, Bue-
POESIA, STORIA E NARRAZIONI ESEMPLARI 237
questo caso la citazione che introduce e innesca il racconto è inveceautentica e corretta:
A pagina 278 del libro La poesia (Bari, 1942), Croce, riassumendo un testolatino dello storico Paolo Diacono, narra la sorte e cita l’epitaffio di Droctul-ft; ne fui singolarmente commosso, e in seguito compresi perché 14.
La pagina in questione fa effettivamente parte delle postille com-prese nella seconda parte dell’opera di Croce 15 e credo sia opportunoriportarla per intero, anche perché per quanto nota ai lettori e agli stu-diosi di Borges 16 sembra invece trascurata dai biografi di Droctulf:
Poesia dove si trova (p. 95). – Mi piacerebbe andare notando, per offrirneesempi, la poesia che alza il capo dove meno si aspetterebbe. Era un tempoin San Vitale di Ravenna l’epitaffio (serbatoci da Paolo Diacono) di un ale-manno Droctulft, che aveva abbandonato i longobardi per difendere contro diloro quella città,. L’epitaffio versificato conteneva un attestato di gratitudine
nos Aires, 1944, trad. it. Finzioni, Torino, 1955 da cui vale la pena ricordare dalla premessa (p.5) questa sorta di dichiarazione di “poetica” della citazione fittizia: « Delirio faticoso e avvilentequello del compilatore di grossi libri, del dispiegatore in cinquecento pagine d’un concetto la cuiperfetta esposizione orale capirebbe in pochi minuti! Meglio fingere che questi libri esistano già,e presentarne un riassunto, un commentario ». Sulle citazioni di Borges si veda l’arguta sintesi diU. ECO, Sugli specchi e altri saggi, Milano, 1985, p. 165: « Borges sembra aver letto tutto (e an-
che di più, visto che ha recensito libri inesistenti »); più estesamente cfr. L. BLOCK DE BEHAR,Borges, la pasión de una cita sin fin, Albany (NY), 2002 = Borges. The Passion of an EndlessQuotation, transl. by W. EGGINTON, Albany (NY), 2003.
14 BORGES, L’Aleph cit. (nota 12), p. 46. Si noti la forma Droctulft rispetto a Droctulf cheBorges deriva da Croce (e che del resto era vulgata nella tradizione erudita meno recente); nellepagine che seguono non si uniformeranno le due forme anche per focalizzare con maggiore chia-rezza la distinzione, necessaria, tra il Droctulf degli studi storici ed eruditi, e il Droctulft di unadiversa tradizione poetico-letteraria che qui s’intende esplorare.
15 L’edizione cui fa riferimento Borges è presumibilmente Poesia. Introduzione alla critica estoria della poesia e della letteratura, 3a ed. riveduta e accresciuta, Bari-Roma, 1943 (e non1942), data che pure compare nell’avvertenza in cui Croce fa riferimento ad « alcune aggiuntealle postille che formano la seconda parte del volume ».
16 Cfr. per es. F. DAUSTER, Notes on Borges’ Labyrinths, in Hispanic Review, XXX,2 (1962),pp. 142-148; J. ALAZRAKI, El texto como palimpsesto: Lectura intertextual de Borges, ibid., LII,3(1984), pp. 281-302; S. MOLLOY, Signs of Borges, Durham, 1994, pp. 33-41; V. BRLJAK, Borgesand the North, in Studies in Medievalism, XX, Definiing Neomedievalism(s) II, ed. by K. FUGEL-SO, Cambridge, 2011, pp. 99-128, alla p. 109. Accenna al racconto di Borges anche P. CESARETTI,Ravenna. Gli splendori di un impero, Milano, 2006 (cfr. la rec. di S. RONCHEY, Il Foglio, 2 gen-naio 2007). Si vd. anche la bibliografia cit. infra a n. 30.
ALESSANDRO IANNUCCI238
per quell’uomo, che aveva sacrificato l’affetto per i suoi cari alla nuova pa-tria (« contempsit caros, dum nos amata ille, parentes / hanc patriam reputansesse, Ravenna suam »). Ma, nel dettare questi distici, l’ignoto autore è presoda una visione lirico-epica del personaggio, e in pochi tratti lo scolpisce nellasua fisica possanza e nella sua particolare maestà e umanità di barbaro:
Terribilis visu facies, sed mente benignus,Longaque robusto pectore barba fuit
Dal giorno che lessi i Rerurm longobardorum scriptores, questo Droctulftentrò nella schiera delle figure poetiche che vivono nel mio ricordo 17.
Non è qui il caso di riprendere la vessatissima questione del temaper troppi anni al centro di una discussione talora stucchevole sulla di-stinzione tra “poesia” e “non poesia” e più in generale sul superamen-to dell’ingombrante eredità di Croce nella critica letteraria 18. Tuttavianon si può fare a meno di notare che, almeno per quanto riguarda l’e-pitaffio di Droctulft, questa distinzione è sicuramente efficace, ed anziper vari motivi necessaria. O almeno lo è stata per Borges sul cui rac-conto – essenzialmente incentrato sui 4 versi dell’epitaffio scelti e ci-tati da Croce – occorre ora fermare l’attenzione.
Borges è colpito dai tratti poetici e dalla potenza simbolica dellevicende di Droctulft, di cui metterà a fuoco in particolare il passaggio
17 Questa postilla (p. 286) rimanda a una pagina del capitolo IV intitolata « L’odio per ilbrutto, l’indulgenza per le imperfezioni e l’indifferenza per le parti strutturali » in cui Croce met-
te in guardia dai pregiudizi che talora impediscono di « godere la poesia dove si trova, perché,come talvolta fiorisce solitaria su aride rocce intellettuali e in altri luoghi inospiti, così può fiori-re in mezzo alle cose brutte » (cfr. CROCE, La poesia cit. nota 15, p. 95).
18 Cfr. B. CROCE, Poesia e non poesia. Note sulla letteratura europea del secolo decimonono,
Bari, 1923 nonché CROCE, La poesia cit. (nota 15). In realtà, a posteriori, la questione sembracollegarsi più al contesto culturale italiano che si apriva al formalismo europeo più che alla teo-ria critica e all’estetica di Croce in senso lato; a questo riguardo si vedano G. CONTINI, L’influen-za culturale di B. Croce, Milano-Napoli, 1967 e G. ORSINI, L’estetica e la critica di Croce, Mila-no-Napoli, 1976, nonché E. RAIMONDI, Teorie della letteratura e della critica nel Novecento, in
Guida allo studio della letteratura italiana, a cura di E. PASQUINI, Bologna, 1985, pp. 199-222.Un profilo critico succinto ma attento anche al recupero di Croce nell’età del post-formalismo èquello di F. LORIGGIO, Croce, Benedetto, in Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Ap-proaches, Scholars, Terms, General Editor and Compiler I. R. MAKARYK, Toronto-Buffalo, 1993
(repr. 2000), pp. 281-282; più ampiamente cfr. R. WELLEK, La teoria letteraria e la critica diCroce, in Letteratura Italiana Einaudi, a cura di A. ASOR ROSA, IV, L’interpretazione, Torino,1985, pp. 351-412, nonché M. E. MOSS, Benedetto Croce Reconsidered, Hanover-London, 1987.
POESIA, STORIA E NARRAZIONI ESEMPLARI 239
dalla condizione di ‘barbaro’ a quella di romano ‘civilizzato’, solo ap-parentemente un ‘tradimento’ delle proprie origini. Subito dopo l’ini-zio del racconto, l’attenzione di Borges si sofferma sulla icastica rap-presentazione di Droctulft in cui avverte « il curioso contrasto tra l’a-spetto atroce di quel barbaro e la sua semplicità e bontà » 19 e – comela sua fonte, Benedetto Croce, – trascrive quegli stessi versi 5-6(« Terribilis visu facies... etc. ») che fissano in modo indelebile la fi-gura titanica dell’oriundo e umanissimo guerriero 20.
« Droctulft entrò nella schiera delle figure poetiche che vivono nelmio ricordo », aveva annotato Croce. Borges trasforma in narrazionequesta immagine e, a quanto pare, non si limita alla lettura di Crocema cerca ulteriori informazioni per ricostruire lo scenario complessivoin cui collocare questo personaggio. Sicuramente consulta The Declineand the Fall of the Roman Empire di Edward Gibbon in cui sono tra-scritti gli stessi versi, come postilla Borges in una nota a pié paginadel racconto 21. La probabile lettura delle icastiche pagine del Gibbonsu « State of Italy under the Lombards » (vol. IV, cap. XLV) avrà pre-sumibilmente sollecitato la ricostruzione dichiaratamente immaginariadello scenario in cui si collocano le vicende del guerriero longobardo:
Immaginiamo, sub specie aeternitatis, Droctulft, non l’individuo Droctulftche indubbiamente fu unico e insondabile (tutti gli individui lo sono), ma iltipo generico che di lui è di molti altri come lui ha fatto la tradizione che èopera dell’oblio e della memoria. Attraverso un’oscura geografia di selve epaludi, le guerre lo portano in Italia, dalle rive del Danubio e dell’Elba; forsenon sapeva che andava al Sud e che guerreggiava contro il nome romano.Forse professava l’arianesimo, che sostiene che la gloria del Figlio è un ri-flesso della gloria del Padre, ma è più verosimile immaginarlo devoto dellaTerra, di Hertha, il cui simulacro velato andava di capanna in capanna su un
19 BORGES, L’Aleph cit. (nota 12), p. 45, n. 1.20 L’efficacia di questi versi, d’altra parte, è notata anche in ambito storiografico: sono infatti
citati anche da PEPE, Il medio evo barbarico d’Italia cit. (nota 11), p. 171, che, malgrado quantoosserverà più oltre a p. 317 (cfr. supra, n. 11) annota al riguardo: « sembrano quasi giustificaticerti quadri storici dell’800 con quelle facce feroci, quelle spallacce, quelle lunghe barbe attribui-te ai guerrieri nordici ».
21 BORGES, L’Aleph cit. (nota 12), p. 46 n. 1; anche in questo caso si tratta di una citazioneesatta: alla n. 49 della terza parte del cap. XLV (Borges si limita all’indicazione del capitolo)Gibbon infatti scrive: « The epitaph of Droctulf (Paul, l. iii. c. 19) may be applied to many of hiscountrymen: Terribilis visu facies, sed corda benignus Longaque robusto pectore barba fuit » (sinoti la variante corda per mente).
ALESSANDRO IANNUCCI240
carro tirato da vacche, o degli dèi della guerra e del tuono, che erano rozzeimmagini di legno, avvolte in stoffe e cariche di monete e cerchi di metallo.Veniva dalle selve inestricabili del cinghiale e dell’uro; era bianco, coraggio-so, innocente, crudele, leale al suo capo e alla sua tribù, non all’universo 22.
Questa « oscura geografia di selve e paludi » è un territorio dellameraviglia, in cui i guerrieri come nei racconti di fiabe sono semprebuoni e leali. Borges non ha verificato le sue fonti – del resto non eratenuto a farlo – quindi lo immagina e lo fraintende come « leale alsuo capo e alla sua tribù », ignorando (o fingendo di ignorare) che ilduca longobardo è in realtà di stirpe sveva e che in ogni caso i Lon-gobardi non erano la sua tribù. Ma nella costruzione narrativa e sim-bolica, questa presunta lealtà è necessaria per poter poi immaginarel’incontro con l’ordine e la perfezione della cultura romana, pur in de-clino, e quindi una conversione totale e spirituale:
Le guerre lo portano a Ravenna e là vede qualcosa che non ha mai vista, oche non ha vista pienamente. Vede il giorno e i cipressi e il marmo. Vede uninsieme che è molteplice senza disordine; vede una città, un organismo fattodi statue, di templi, di giardini, di case, di gradini, di vasi, di capitelli, di spa-zi regolari e aperti. Nessuna di quelle opere, è vero, lo impressiona per la suabellezza; lo toccano come oggi si toccherebbe un meccanismo complesso, ilcui fine ignoriamo, ma nel cui disegno si scorgesse un’intelligenza immortale.Forse gli basta vedere un solo arco, con un’incomprensibile iscrizione in eter-ne lettere romane. Bruscamente, lo acceca e lo trasforma questa rivelazione:la Città. Sa che in essa egli sarà un cane, un bambino, e che non potrà maicapirla, ma sa anche ch’essa vale più dei suoi déi e della fede giurata e ditutte le paludi di Germania. Droctulft abbandona i suoi e combatte per Ra-venna. Muore, e sulla sua tomba incidono parole che non avrebbe maicomprese:
Contempsit caros, dum nos amat ille, parentes,Hanc patriam reputans esse Ravenna suam 23.
L’enfasi posta su questi versi sembra esplicitare l’interesse di Bor-ges per un cosmopolitismo ideale in cui ogni individuo può scegliersiovunque una patria, a prescindere dalle origini. Ma anche in questocaso si avverte una lacuna del discorso; al verso immediatamente pre-
22 BORGES, L’Aleph cit. (nota 12), p. 47.23 Ibid., pp. 47 ss.
POESIA, STORIA E NARRAZIONI ESEMPLARI 241
cedente (v. 14) Droctulf era stato definito « vastator genti adfuis ipsesuae »; l’asprezza di queste parole, la cruda violenza del sostantivo va-stator certo non facevano scandalo in un epitaffio di fine VI secoloMa in un racconto del dopoguerra questo verso, che anche Croce nonaveva preso in considerazione, avrebbe condizionato lo sviluppo narra-tivo. L’eroe guerriero avrebbe forse dovuto cedere il passo al soldatosanguinario.
L’incontro con una presunta perfezione romana evoca un’idea diromanità classica e cristallizzata che certo non può corrispondere aitempi bui descritti da Paolo Diacono e da Edward Gibbon: nell’epitaf-fio non è presente il « marmo », l’ordine architettonico in cui è sinte-tizzata una fortunata idea di classico (peraltro oggi del tutto supera-ta) 24 intesa come « organismo fatto di statue, di templi, di giardini, dicase, di gradini, di vasi, di capitelli, di spazi regolari e aperti ». Macome la lealtà fittizia, anche questa idea di classico – peraltro noncongrua a uno scrittore con un gusto sanguinetiano per l’esotico comeBorges 25 – è necessaria perché consente di creare quell’artificiosacontrapposizione tra “barbarie” e “civiltà” che struttura il racconto e dicui Borges intende ribaltare il significato. Per il guerriero la barbariedei Longobardi è messa a confronto, almeno in apparenza, con la su-periore civiltà romana e bizantina; ma, come si vedrà a breve, nel pro-seguo del racconto s’innesta un contrasto analogo e speculare in cuiper la prigioniera è la presunta civiltà dello Yorkshire ad essere con-trapposta alla barbarie argentina della Pampa. Questa dialettica funzio-nale alla strategia compositiva del breve racconto porta a rovesciarel’idea del “tradimento” di Droctulft in quella della “conversione” edella preveggenza. Con la sua scelta di campo il guerriero longobardodiventa piuttosto un precursore:
24 Al riguardo si vd. le riflessioni di D. LANZA, Dimenticare i Greci, in I Greci. Storia culturaarte e società, a cura di S. SETTIS, III, I Greci oltre la Grecia, Torino, 2001, pp. 1443-1464, sui
tentativi di ricostruire i Greci « a misura di scrupoloso grecista » (p. 1460); per una prospettivacontemporanea sulla “permanenza del classico” cfr. Di fronte ai classici. A colloquio con i Greci
e i Latini, a cura I. DIONIGI, Milano, 2002.25 Ovviamente sarebbe più congruo affermare che Sanguineti ha avuto un gusto “borgesiano“
per ciò che è esotico, ma l’affermazione « i classici ci interessano perché sono esotici, e chiamia-mo ‘classico’ solo una cosa che sia cosiffatta » è appunto di E. SANGUINETI, Due interventi su
« Riscrivere, rappresentare Edipo », in Edipo classico e contemporaneo, a cura di F. CITTI e A.IANNUCCI, Hildesheim - Zürich, 2012, pp. 385-392, alle pp. 389-390.
ALESSANDRO IANNUCCI242
Non fu un traditore (i traditori non sogliono ispirare epitaffi pietosi), fu un il-luminato, un convertito. Alcune generazioni più tardi, i longobardi che aveva-no accusato il disertore, procedettero come lui; si fecero italiani, lombardi, eforse qualcuno del loro sangue – un Aldiger – generò i progenitori dell’Ali-ghieri... Molte congetture è dato applicare all’atto di Droctulft; la mia è la piùspiccia; se non è vera come fatto, lo sarà come simbolo 26.
Nella sua straordinaria erudizione Borges avrà sicuramente lettoanche la Poetica di Aristotele. Quest’ultima frase (se non è vera comefatto, lo sarà come simbolo) e in generale questa concezione in cuiBorges si mostra interessato all’universale racchiuso in Droctulft e nonad una sua documentabile e individuale biografia (immaginiamo, subspecie aeternitatis, Droctulft, non l’individuo Droctulft) sembra rie-cheggiare o spiegare appunto un’idea fondamentale di Aristotele quan-do nella Poetica (1451a-b) afferma che la poesia è più universale del-la storia, e proprio per questo più autentica, vera ed efficace:
Faneròn dè e’k tøn ei’rhménwn kaì o√ti ou’ tò tà genómena légein, toøto poihtoûeºrgon e’stín, a’ll’ oiƒa aªn génoito kaì tà dunatà katà tò ei’kòv hª tòa’nagkaîon [...].diò kaì filosofåteron kaì spoudaióteron poíhsiv i‘storíav e’stín. h‘ mèn gàrpoíhsiv mâllon tà kaqólou, h‘ d’ i‘storía tà kaq’ e√kaston légei.
Da ciò che si è detto è chiaro che compito del poeta non è dire le cose avve-nute, ma quali possono avvenire, cioè quelle possibili secondo verisimiglianzao necessità [...].Perciò la poesia è cosa di maggiore fondamento teorico e più importante del-la storia perché la poesia dice piuttosto gli universali, la storia i particolari 27.
In definitiva, Droctulf è prima di tutto un personaggio storico: lesue vicende individuali si intersecano con quelle dell’Italia nell’ultimoscorcio del VI sec. ed anzi contribuiscono a chiarire questo complessocontesto storico. Ma è anche un personaggio dell’immaginario narrati-vo, consegnato da Borges alla contemporaneità come simbolo dellanecessita di scegliere e se necessario di cambiare 28. E in questo sce-
26 BORGES, L’Aleph cit. (nota 12), p. 48.27 Trad. di D. LANZA, Aristotele. Poetica, a cura di D. LANZA, Milano, 1987, p. 147.28 Significativo a questo riguardo il sorprendente recupero del Droctulft di Borges come mo-
dello di “cambiamento” nella sfera della formazione manageriale dove i temi della vision e delcambiamento organizzativo sono costantemente al centro dell’attenzione: cfr. R. PANZARANI, L’in-
POESIA, STORIA E NARRAZIONI ESEMPLARI 243
nario “letterario” il duca longobardo è non solo ugualmente autenticoe meritevole di attenzione, ma anche occasione di conoscenza e inter-pretazione: del passato, oggetto proprio della ricerca storica, ma anchedel presente come lo stesso Borges ci spiega.
La storia del guerriero, infatti, è messa in relazione con un’altravicenda, quella della prigioniera, attraverso un singolare gioco dispecchi rovesciati. L’epilogo del tradimento visionario e profetico diDroctulft è infatti coniugato e riletto alla luce di un’ulteriore narrazio-ne simbolica, appresa questa volta da una tradizione orale (forse d’in-venzione o forse no) rappresentata dalla propria nonna paterna di cuiBorges riporta il racconto: vi si narra il percorso opposto a quello diDroctulft di una donna inglese che, originaria dello Yorkshire, arrivataa Buenos Aires perde i propri genitori durante una scorreria di predonidella Pampa ed è fatta loro prigioniera. Divenuta moglie del capo del-la banda si adatta quindi alla vita ‘barbara’ del deserto:
Disse tutto questo in un inglese rozzo, mescolato di araucano, e dietro il rac-conto si scorgeva una vita feroce: le tende di cuoio di cavallo, i falò di ster-co, i banchetti di carne bruciacchiata o di viscere crude, le furtive marce al-l’alba, l’assalto ai chiusi, l’urlo e il saccheggio, la guerra, i cavalieri nudi chestimolano le bestie, la poligamia, il fetore e la stregoneria. A tale barbaries’era ridotta un’inglese. Mossa dalla pena e dall’indignazione mia nonna laesortò a non tornare dai suoi. Promise che l’avrebbe protetta, che avrebbe ri-scattato i suoi figli. L’altra rispose che era felice, e la sera tornò al deserto 29.
Una singolare e straordinariamente moderna idea di “civiltà” emer-ge da questo racconto di Borges 30, più intenso ed efficace di qualsiasiteoria sul dialogo e il confronto tra “civiltà” diverse 31. E da questo
novazione dovunque, in FOR Rivista per la Formazione, LXIV (2005), pp. 27-33. Sui singolarirapporti tra management e letteratura cfr. A. IANNUCCI, I letterati e il management. Archetipi, eti-mologie e tradimenti, in Miscellanea di studi offerti ad Antonio Carile, a cura di E. MENESTÒ eG. VESPIGNANI, Spoleto, 2012, in corso di stampa.
29 BORGES, L’Aleph cit. (nota 12), p. 50.30 A questo tema è dedicato il capitolo Going Native: Beyond Civilization and Savagery in
”Historia del guerrera y de la cautiva” in D. BALDERSTON, Out of Context. Historical Referenceand the Representation of Reality in Borges, Durham, 1993, pp. 81-98; cfr. anche J. R. PODETTI,Civilización, barbarie y frontera en Jorge Luis Borges, in Humanidades. Revista de la Universi-dad de Montevideo, VIII-IX,1 (2008-2009), pp. 87-102, con ulteriori rinvii del tema nell’opera diBorges.
31 Al riguardo, basti qui ricordare due saggi recenti in cui si troverà ulteriore bibliografia: TZ.
ALESSANDRO IANNUCCI244
punto di vista torna alla memoria una pagina importante, e forse unpo’ trascurata di J. Lotman in cui si afferma, e si dimostra, come lapoesia sia un linguaggio in grado di codificare, conservare e trasmette-re in breve spazio un numero altissimo di informazioni e conoscenzecon un’efficacia spesso superiore ai risultati che possono ottenere altrilinguaggi (tra cui quello saggistico) 32.
Non esistono barbari e civiltà superiori in conflitto tra loro; non esi-stono “invasioni barbariche” – sembra dire Borges – se non negli incubiche a volte il presente riflette sulle stesse ricostruzioni storiche. Per que-sto non possono esserci stati tradimenti, abiure, improvvisi passaggi dauna parte all’altra; in ogni caso quanto interessa al narratore sono i singoliuomini, protagonisti di scelte individuali che possono diventare oggetto dicontemplazione universale. Questo, in definitiva, il messaggio che Borgesriesce a evocare dai lacerti di quanto rimane della vicenda storica e indi-viduale del duca longobardo; il Droctulft di Croce e Borges (e prima an-cora dello stesso anonimo autore dell’epitaffio) appartiene all’immagina-rio e non alla storia, alla sfera delle narrazioni simboliche e non a quelladella documentata (e documentabile) prosopografia. Come lo stesso Bor-ges ha chiarito, la sua versione della storia di Droctulft – che va comun-que aggiunta alla catena di versioni cui anche queste pagine intendonocontribuire – è « la più spiccia »; e proprio per questo, soggiunge subitodopo « se non è vera come fatto, lo sarà come simbolo ».
Questa dichiarata natura di simbolo sembra innescare quella di mi-to il cui valore semantico primario, dal greco mûqov è appunto quello diracconto, narrazione 33. Il filologo classico Walter Burkert ha illustra-
TODOROV, La paura dei barbari. Oltre lo scontro delle civiltà, trad. it. Milano, 2009 (Paris 2008)e U. CURI, Straniero, Milano, 2010.
32 Cfr. J. M. LOTMAN, La struttura del testo poetico, trad. it. Milano, 1985 (Mosca, 1970), p.31: « L’arte è il mezzo più economico e compatto di conservare e trasmettere l’informazione. Mal’arte possiede anche altre qualità, che sono del tutto degne di attrarre l’attenzione dello speciali-sta cibernetico, e col tempo, forse anche dell’ingegnere costruttore. Avendo la possibilità di con-centrare un’enorme informazione in una superficie molto ristretta (confronta il volume di un rac-conto di Cechov ed un manuale di psicologia) il testo artistico ha anche un’altra specialità; essotrasmette ai diversi lettori una differente informazione, a ciascuno nella misura della usa com-prensione; esso dà al lettore una lingua, nella quale è possibile assimilare una successiva porzio-ne di informazione a una seconda lettura. Esso si comporta come un organismo vivente, che sitorva in reciproco rapporto con il lettore e ammaestra questo lettore ».
33 Si vd. al riguardo le riflessioni sul racconto di R. BARTHES, Introduction à l’analyse structu-rale dés récits, originariamente pubblicato in Poétique du récit, Paris, 1977 e poi in Communica-
POESIA, STORIA E NARRAZIONI ESEMPLARI 245
to la natura del mito in un modo per certi versi definitivo, facendo ri-corso sia agli studi e alle teorie mitografiche dei classicisti, sia all’an-tropologia storica del mondo antico, sia infine alle analisi comparativi-ste e folcloriche, da Propp a Lévi-Strauss 34. Burkert chiarisce la fun-zione gnoseologica del mito rispetto alla comune opinione che, alme-no in quegli anni, ne associava il significato alle nozioni di finzione,inganno, inverosimiglianza 35. In breve, i miti sono racconti tradiziona-li, e si distinguono da altre forme di racconto perché dotati di una pro-pria sintassi che costruisce il significato con modalità peculiari; da talipremesse i miti – di cui non è dato sapere, né è d’interesse saperequando siano stati raccontati una prima volta – si cristallizzano in tra-me esemplari e diventano verbalizzazione di fenomeni di importanzacollettiva, con particolare riferimento a istituzioni e modi di rappresen-tazione della famiglia o della città, a rituali religiosi o infine a feno-meni naturali 36.
Le narrazioni intorno al duca Droctulft qui prese in esame nonpossono essere considerate “mito”, almeno non dal punto di vista deirequisiti postulati da Burkert. In particolare non si tratta di un raccon-to tradizionale ma al contrario è una storia minima destinata a restarepoco nota e a non prestarsi a funzioni metonimiche o eponime. Droc-tulf, proprio perché figura “storica”, non diventerà mai un nome uni-versale in grado di richiamare un contenuto narrativo 37. Tuttavia quel-
tions, VIII (1981), da cui la prima diffusione in lingua italiana (L’analisi del racconto, Milano,1969), fino alla versione definitiva nel volume L’aventure sémiologique, Paris, 1985 e trad. it.L’avventura semiologica, Torino, 1991.
34 Cfr. W. BURKERT, Mito e rituale in Grecia. Struttura e storia, Roma-Bari, 1996 (Berkeley -Los Angeles, 1979); i riferimenti di Burkert sono in G. KIRK, Myth: Its Meaning and Functionsin Ancient and Other Cultures, Berkeley - Los Angeles, 1979 e ID., The Nature of Greek Myths,Harmondsworth, 1974; V. PROPP, Morphology of the Folktale, Bloomington, 1958 (Leningrad,1946); C. LÉVI-STRAUSS, Antropologie Structurale, Paris, 1958 e ID. Mythologiques, I, Le cru et lecruit, Paris, 1964.
35 Con modalità diverse, in quegli stessi anni prendeva forma un’ulteriore modalità di recupe-ro del mito come forma e occasione di conoscenza da parte di J. P. Vernant e della sua scuola:cfr. in part. J. P. VERNANT, Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique, Pa-ris, 1965.
36 Con estrema sintesi questa è la tesi di BURKERT, Mito e rituale in Grecia cit. (nota 34), pp.3-57.
37 Come avviene, per esempio, per il nome di Edipo su cui merita di essere ricordata la cele-bre battuta di Antifane (fr. 189 Kassel-Austin, qui citato nella traduzione di G. Avezzù in Edipo.Variazioni sul mito, Venezia, 2008, p. 10): « Gli spettatori conoscono la trama prima ancora che
ALESSANDRO IANNUCCI246
la « visione lirico-epica del personaggio » che Croce coglie in PaoloDiacono e nell’epitaffio, quella storia dapprima solo evocata e poinarrata in uno dei molti modi possibili da Borges sembra in qualchemodo andare oltre i consueti confini del “racconto” in quanto genereletterario. E in ogni caso ci conserva qualcosa di non meno significati-vo e autentico delle diverse ricostruzioni storiche di questo affascinan-te duca che, come recita l’epitaffio di cui si è discusso, « per i suoimeriti continua a vivere ovunque nel mondo » 38.
la tragedia cominci. Dico Edipo, e quelli tutto il resto già lo sanno: Laio il padre, Giocasta lamadre, queste le figlie, questi i figli, il suo destino, il suo passato... ».
38 Cfr. v. 2 « Nam meritis toto vivit in orbe suis ».