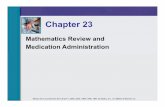Palilia 23 Krise und Wandel
Transcript of Palilia 23 Krise und Wandel
Palilia 23Krise und Wandel
© 2011 Deutsches Archäologisches InstitutDer Autor/die Autorin hat das Recht, für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch unveränderte Kopien dieser PDF-Datei zu erstellen bzw. das unveränderte PDF-File digital an Dritte weiterzuleiten. Außerdem ist der Autor/die Autorin berechtigt, nach Ablauf von 24 Monaten und nachdem die PDF-Datei durch das Deutsche Archäologische Institut der Öffentlichkeit ko-stenfrei zugänglich gemacht wurde, die unveränderte PDF-Datei an einen Ort seiner/ihrer Wahl im Internet bereitzustellen.
Roberto Spadea
Crotone tra i Dionisi ed Agatocle
PDF-Dokument des gedruckten Beitrages
Deutsches Archäologisches Institut Rom
Krise und WandelSüditalien im 4. und 3. Jahrhundert v. Chr.
Internationaler Kongress anlässlich des 65. Geburtstages von Dieter Mertens, Rom 26. bis 28. Juni 2006
Herausgegeben von Richard Neudecker
2011
Dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden
Umschlagbild:Selinunt, Tempel C mit punischem Viertel im Vordergrund (DAI Rom [Selinunt-Archiv], Foto: D. Mertens)
Redaktion: Deutsches Archäologisches Institut RomTextredaktion: Marion MenzelSatz, Bild und Prepress: Punkt.Satz, Zimmer und Partner, Berlin
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 978-3-89500-865-8
© 2011 Dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbadenwww.reichert-verlag.deAlle Rechte vorbehalten.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit neutralem pH-Wert.Printed in Germany.
Roberto Spadea
Crotone tra i Dionisi ed Agatocle
Abstract: In this paper the general status of Kroton in the IVth and IIIth centuries BC. is examined. Kroton was con-quired by Dionysius I after the battle of Elleporos, but the presence of the Sicilian tyrants during about twenty years don’t seems to have produced signs of crisis in the town planning.
The excavations demonstrate that the maritime port had a florent period (zone of the «Granaio») and in the town area a building extention can be noted.
In the IIIth century the presence of Agathokles and Pyrrhus and the arrive of the Brettioi produced a progressive decline. In this perspective three coin-hoards, recently discovered in «Fondo Gesù», are considered.
Il contenuto di questo intervento è la prosecuzione di ri-cerche per le quali fu aperto il dibattito scientifico quasi vent’anni or sono a Napoli, in un Convegno1 organizzato da Alfonso Mele, che non può essere con noi e che voglio ringraziare per avermi voluto vicino a riprendere il tema «Crotone» relativamente ad un periodo così importante e denso di avvenimenti per la storia della polis achea.
Aprendo dirò subito che è necessario prima di ogni cosa aggiornare il quadro, presentato ed esaminato in più sfaccettature a Napoli in un tempo ormai lontano, tenendo conto delle ricerche che la Soprintendenza svolge giorno per giorno nell’area della città antica2, del-la quale non va mai dimenticata l’estesa superficie che gli scavi continuano a confermare.
La tirannide dionigiana
Converrà ripercorrere dapprima gli avvenimenti storici che interessarono la polis nel corso del IV secolo a. C. partendo dalla tirannide dionigiana, che durò per quasi venti anni, fino agli avvenimenti che, alla fine del secolo, vedono la città al centro di vicende politiche e militari, in particolare i rapporti con Siracusa e con i Brettii3, alle quali è attribuito un ruolo fortemente incisivo per la vita di Crotone, con ripercussioni su tutto il fronte della Magna Grecia.
Nella prima metà del IV a. C. Crotone è al centro del-la Lega italiota con eventi che mettono alla prova il suo potenziale militare ed economico. La polis è impegna-ta ad inviare navi a Reggio contro Dionigi di Siracusa, ed ancora è contro il tiranno alleato con i Lucani nella battaglia di Laos e in quella più importante dell’Ellepo-
ro. Al termine di questi accadimenti Crotone esce du-ramente provata in perdita di forze umane e di risor-se economiche. Nella città, che all’inizio del IV secolo a. C. si presentava particolarmente attiva e popolosa, nel 378 a. C. entra Dionisio di Siracusa e la presenza si-racusana si ritiene abbia termine intorno alla metà del IV secolo a. C., quando Dione pone fine all’occupazione che, dopo dodici anni (Dionisio I muore nel 367 a. C.), era proseguita con Dionisio II. Difficile, tenendo conto della parzialità delle ricerche archeologiche e dalla va-stità dell’area occupata dalla città antica, poter riscon-trare segni di devastazioni, di cui è pur eco nelle fonti4, o di contrazioni e di mutamenti all’interno dell’abitato. Dirò anzi che le corrispondenti stratigrafie e gli scavi dei frammenti di unità abitative messi in luce nella zona occidentale e centrale della polis non confermano né negano un periodo di crisi. È necessario per questo os-servare che i diversi livelli, da quelli arcaici sino a quelli dell’inizio del III secolo a. C., si sovrappongono l’un l’al-tro senza strati d’abbandono o di distruzioni evidenti. Al contrario, nella città, negli anni seguenti la presen-za del tiranno siracusano, si riscontra una crescita con una nuova riscrittura del suo tessuto urbano, sulla quale vale la pena soffermarsi.
Non starò qui a richiamare le dense e fondamentali osservazioni di Alfonso Mele sul periodo post-dioni-giano5. Nella seconda metà del IV secolo a. C. Crotone riparte con una crescita economica di grande rilievo, fa-vorita anche dalla richiesta di prodotti di sussistenza da parte di altre poleis del mondo greco, afflitte in questi anni da carestia6. La città (fig. 1) deve in ogni caso tene-re conto dei nuovi equilibri territoriali, quelli a nord, in
1 Mele 1993 e particolarmente Mele 1993a, 235–291.2 Un grazie a Gregorio Aversa, Alfredo Ruga, Giovan-
na Verbicaro e Francesco Cristiano che mi sono stati vicini mentre stendevo queste note.
3 Mele 1993a, 266–267.4 Basterebbe richiamare la spoliazione dionigiana
di un ex voto di grande valore quale il mantello di Alkisthe-nes nel santuario di Hera a Capo Colonna: Ps. Arist. De Mir. Ausc. 96; Athen. 12, 541 B.
5 Mele 1993a, 264–265.6 Mele 1993a, 268.
108 Roberto Spadea
Fig. 1 Crotonea S. Luciab Fiume Esaroc Vigna Nuova
d Trincea Acquedottoe Collina della Batteriaf Ospedaleg Campo Sportivo
h ‹Ceramico›i Via Telesioj Scavo Rachelik P. Pertusola
l Fondo Gesùm Cantiere del ‹Granaio›
109Crotone tra i Dionisi ed Agatocle
cui si affacciano dalla metà del IV secolo a. C. i Brettii, che controlleranno la fascia costiera con il santuario di Apollo Aleo a Krimisa, l’importante area di Petelia e il Neto, asse che congiunge il mare con l’entroterra silano e le sue enormi risorse, che sarà il perno del territorio brettio. A Crotone una rinascita delle attività produtti-ve è verificabile, come vedremo, soprattutto nel settore centrale della polis e può essere collegata ai buoni rap-porti che intercorrono fra la città e Siracusa, come tra l’altro fa vedere il rilevante peso della moneta siracusa-na allineata con Corinto (‹pegasi›) che svolge un ruolo determinante nella Magna Grecia di questo periodo ed alla quale Crotone si associa confermando il momento di ottima ripresa7. Crotone è infatti al centro di correnti commerciali in cui le risorse del suo territorio giocano un ruolo di primo piano: si pensi al grano, al legno, alla pece (questi ultimi fulcro dell’economia dei Brettii), al suo arsenale marittimo e al suo porto, forza non di poco conto per la polis, sul quale si esprime una fonte autore-vole come Polibio8. Per il porto le nuove ricerche, anche se svolte nell’ambito di una vera e propria archeologia d’emergenza, permettono di formulare concrete ipotesi sull’organizzazione di una piccola ma significativa por-zione dello spazio abitato sulla sponda destra dell’Esa-ro, nel cantiere del ‹Granaio› (fig. 1-m), dove si trovano tracce significative di piccole attività industriali come per esempio fornaci ed altri opifici per la lavorazione di metalli ferrosi di cui sono state recuperate le scorie, con pozzi dove poter attingere l’acqua. Ancora nel cantiere del ‹Granaio› è stato possibile osservare la presenza di un manufatto interpretabile come canale di drenaggio industriale, che andava a scaricare in un’ansa del fiume e questo comportò una parziale modifica della maglia urbanistica crotoniate, fatto che, come vedremo, diver-rà usuale in questo periodo nell’abitato.
Tali attività fanno pensare ad un vero e proprio quar-tiere sviluppatosi intorno all’area del porto, che sempre di più ritengo faccia capo ad un articolato e diversifica-to sistema di punti d’approdo, non escluso anche a un porto-canale, che sfruttava il tratto finale dell’Esaro ed in particolare il suo estuario per garantire la protezione alle imbarcazioni.
Le stratigrafie dell’area esplorata coprono un arco che va dalla seconda metà del IV secolo a. C. all’abbandono di questo settore urbano, alla fine del III secolo a. C.
I segni più evidenti della ripresa si colgono, a mio av-viso, nella realizzazione del circuito murario, nei reim-
pieghi di materiale lapideo di considerevoli dimensioni, nella qualità del costruito e delle decorazioni, che sotto-lineano le intense attività della città, che raggiunge un notevole livello di autonomia produttiva sia nella qualità, sia nella quantità.
Il circuito delle mura
Alla metà del IV secolo a. C. un imponente circuito mu-rario doveva proteggere la città, percorrendo la corona delle alture che circondano Crotone. Dopo la liberazio-ne dalla tirannide dionigiana il problema di una difesa solida e sicura doveva essere particolarmente sentito dai politai crotoniati. La superficie dell’area abitata era di ragguardevole estensione ed una fonte autorevole come Tito Livio fa riferimento ad un circuito di XII miglia9, aggiungendo che tale misura si riferiva a prima del pas-saggio di Pirro.
Nel periodo arcaico l’unica ipotesi proponibile per la difesa della città resta quella di punti fortificati dislo-cati sui modesti rilievi che circondano l’area dell’abita-to da nord a sud-est. Alcuni di questi punti presentano maggior valore strategico e partono dalla cima più alta a sud-est nella zona di Santa Lucia fino a raggiungere, abbassandosi, l’Esaro, poi Vigna Nuova e chiudere verso nord, occupando il trincerone dell’acquedotto e la col-lina della Batteria (fig. 1 d–e). Questi punti permettono il controllo dell’entroterra meridionale, rappresentato dalla vallata dell’Esaro e delle vie d’accesso alla città e di collegamento verso settentrione ed occidente.
La scelta di quei nuclei obbligati per la difesa è con-fermata alla metà del IV secolo a. C. L’imponenza e la vastità delle opere sono commisurate alla lunghezza del complesso, che, riferendosi ancora alla misura liviana, somma a oltre diciassette chilometri10. L’impianto pre-vide per la maggior parte dell’apparecchio murario l’u-tilizzo di blocchi di pietra locale (calcarenite) di varia misura e pezzatura, tagliati con precisione ed adattati alla morfologia delle colline argillose, sulle quali era ne-cessario impiantare fabbriche solide e ben fondate, con lo studio dei drenaggi e di ogni altra opera accessoria. Con ogni probabilità il materiale proveniva dalle cave del Marchesato e in particolare dalle aree intorno Isola Capo Rizzuto11, ubicate a meridione e distanti dalla cit-tà almeno venti chilometri, fatto per il quale certamente si richiese un considerevole sforzo organizzativo, se si pensa ai trasporti per terra e per mare, peraltro anche
11 Spadea 1983, 142 e Marino 1996, 26. 34. Altri ritrova-menti di non poco conto sono quelli emersi in occasione della costruzione del porto turistico poco a Nord di Le Castella dove sulla bassa falesia che orla il promontorio è stata a stento preservata una superficie dove sono evidenti i segni di cava con colonne e blocchi.
7 Cfr. infra.8 Pol. 10, 1.9 Liv. 24, 3.10 La misura del circuito riferita ad un miglio di mt
1480 assommerebbe a km 17.760 e potrebbe sembrare esage-rata, ma di poco rispetto alla realtà dei luoghi.
110 Roberto Spadea
onerosi. Per le mura crotoniati basterebbe pensare al tratto scoperto in località Santa Lucia e scavato da Hen-ri Treziny all’inizio degli anni Ottanta (fig. 1-a); a que-sto si aggiungono le evidenze ‹al negativo› individuate da Alfredo Ruga nella trincea di spoliazione spagnola sul Cimone Rapignese12, altre sul fiume Esaro, dove era l’attraversamento, probabilmente rafforzato da grate13. Lungo il tratto terminale dell’Esaro ricognizioni hanno accertato opere di contenimento anch’esse in blocchi e dopo il tratto messo in luce a ‹Vigna Nuova›14 altre trac-ce sono sulla collina della ‹Batteria›, fino alla recentissi-ma scoperta, in occasione dei lavori del «canale-scolma-tore»15, di un piccolo tratto, perfettamente allineato con il tracciato principale delle mura, nei pressi della strada che collega Crotone a Papanice. Infine va ricordata l’arx cittadina, dove murature in blocchi sono state rinvenute nel Castello di fronte alla caserma ‹Sopra Campana›.
Per cantieri di tale imponenza, torno a ripetere, era necessario provvedere in modo efficiente agli approvig-gionamenti, con lo spostamento e il deposito di grandi quantità di pietra in luoghi accessibili ai cantieri dove fosse possibile preparare i materiali, dalla lavorazione alla finitura. È necessario pensare a precisi progetti, che prevedono la presenza di ingegneri esperti nella polior-cetica, considerata la diversità di opere militari quali torri, postierle ed altro, progetti che fanno supporre un contatto con esperienze avanzate, fra le quali spicca quella di Siracusa, che in quegli stessi anni realizza ope-re di grande impegno quali le grandi mura e il Castello Eurialo16. Per questo collegamento basta pensare anco-ra una volta alla presenza di gente di Siracusa nella città.
Città e attività edilizia
Come si è detto prima, la ripresa della città nella se-conda metà del IV secolo a. C. interessa vari compar-ti, tanto da avere fatto pensare, come si è detto prima, che in questo periodo di tempo si riscriva una nuova storia dell’urbanistica di Crotone. Accanto all’attività di costruzione delle mura si verifica una rinascita dell’im-pianto urbano, del quale saranno rispettati assi, orien-tamenti e misure delle strade e degli isolati. Permane sempre l’articolazione in tre grandi blocchi perpendico-lari alla linea di costa e divergenti di 30° tra loro e non
meraviglia che proprio in questa fase si studino nuove soluzioni, come quella che definisce la «cerniera» tra I partizione (n/s) e II partizione (30° ad est), che Giovanna Verbicaro17 propone convincentemente di riconoscere nella zona dell’‹Ospedale› (fig. 1-f). Grande cura è ora dimostrata nel ridefinire e rimodulare gli spazi, inseren-do monumenti ed aree pubbliche.
La ricerca archeologica negli ultimi decenni, in con-siderazione della saturazione edilizia delle cosiddette aree centrali (Duomo – Piazza Pitagora – inizio del tri-dente Veneto/Cutro/Nicoletta), si è spostata da un lato verso l’asse di via Mario Nicoletta, la zona del ‹Fondo Gesù› e oltre, e dall’altro verso il quartiere di San Fran-cesco, aree tutte prossime al fiume Esaro, esondato nel 1996: tragico avvenimento questo, che tuttavia ha per-messo una ricerca archeologica mirata. Infatti, pur do-vendosi rispettare i criteri dell’emergenza imposti dalla pesante situazione, è stato possibile ricavare dati prezio-si per l’urbanistica dell’abitato antico18.
Nel lungo asse della via Di Vittorio sono state sca-vate piccole sezioni che confermano la ripresa edilizia di questo momento: pieno rispetto degli assi fondamen-tali, isolati allungati e allineati con i precedenti. Ma se sostanzialmente si conferma l’impianto originario, non bisognerà trascurare il fatto che fin dalla seconda metà del V secolo a. C. la Magna Grecia era stata interessata da nuove idee per progettare e realizzare la città, come dimostra la panellenica fondazione di Turii19.
Le principali osservazioni interessano il settore dell’e-dilizia privata. L’attenzione si concentra su grandi spa-zi abitativi, ad esempio l’area ‹Gravina›20, dove grande attenzione è dedicata all’esposizione, alla distribuzione degli interni, in cui compare la pastàs, alla salubrità dei locali legata a una razionale insolazione e naturale venti-lazione, alla cura dei dettagli, come le pareti intonacate e i particolari stuccati, all’approvvigionamento idrico e ad altri elementi d’innovazione che confermano uno stato di benessere21. Per le tecniche edilizie con scaglie di pietra e tegole paraguttae sempre fondamentale è il riferimento alle ricerche nell’area della Banca Popolare di Crotone22.
Un rilevante esempio a questo proposito si ricava dalla casa della curva nord-est del ‹Campo Sportivo› scavata nel 199923 (fig. 1-g). Questa presenta una pianta organizzata intorno ad un›ampia corte quadrata, deli-
12 Si tratta dei lavori di scavo preventivo eseguiti in oc-casione della realizzazione di un complesso museale dedicato dall’Amministrazione Comunale di Crotone a Pitagora.
13 Orsi 1912, 64.14 Borrello 1993, 50.15 Canale di drenaggio progettato a seguito dell’allu-
vione del 1996.16 Mertens 2006, 424–433.17 Verbicaro 2005, 20.
18 Ruga 1998 a, 90–92.19 Greco 1999. Basterebbe per ciò pensare all’iniziale
amicizia tra Turi e Crotone negli anni tra il 448 e il 443 a. C. Cfr. Mele 1993a, 240.
20 Cimino 1993.21 Racheli 1998, 79.22 Racheli 1993, 589.23 Lo scavo fu eseguito in condizioni di emergenza su
richiesta del Comune di Crotone per permettere la realizzazio-
111Crotone tra i Dionisi ed Agatocle
mitata da blocchi squadrati di reimpiego e pavimentata con un piancito di tegole (fig. 2). In un ambiente di non grandi dimensioni, accanto alla cucina, è riconoscibile un piccolo balneum, caso analogo a quello riscontrato in dimore signorili della Sicilia di età ellenistica e nella ‹Casa dei Leoni› a Locri24.
Alla metà del IV secolo a. C. riporta la presenza di materiale architettonico lapideo (colonne, frammenti di capitelli dorici e basi ioniche) e fittile (sime, grondaie a teste leonine) da collegare a strutture murarie orto-gonali tra loro, che farebbero pensare alla presenza di una stoà demolita nel corso del III secolo a. C. quando, in conseguenza di un evento traumatico, la presenza di materiali di risulta in questo manufatto attesta la fine dell’intero quartiere al quale il complesso appartiene.
La casa del ‹Campo Sportivo› si sviluppa ai lati di uno stenopos, i cui battuti pavimentali confermano le cro-nologie proposte. In questo, come in altri casi, i muri si fondano sui precedenti impianti, alcuni dei quali risal-gono fino all’inizio del VII secolo a. C.
Altro riferimento importante è costituito dalle ricer-che in una proprietà privata ubicata nella via Telesio,
ancora nel comparto in direzione del fiume Esaro (fig. 1-i)25. Qui è stata scavata un’articolata e vasta abitazione che occupava una superficie di 490 mq con cortile, poz-zo, portico e ambienti che si affacciano su questo. Dai crolli del tetto, a testimoniare di essere davanti ad un edificio di riguardo, provengono un gruppo di antefisse del tipo ‹Artemis Bendis› (fig. 3)26, frammenti d’intona-
ne di una tribuna mobile (curva nord) dello Stadio ‹E. Scida› in conseguenza della promozione della locale squadra nella serie B del campionato di calcio. I lavori, diretti da chi scrive, furono seguiti da Gregorio Aversa e Alfredo Ruga che ringrazio.
24 Barra 1992, 42–48.25 Ruga 1998b (propr. Zito e Candigliota).26 Aversa 1998, 40–41.
Fig. 2 Stralcio planimetrico dell’area archeologica ubicata sotto parte della curva nord dello stadio ‹E. Scida›
Fig. 3 Ricostruzione parziale del tetto ad antefisse con il volto di Artemis Bendis dall’area di via Telesio a Crotone
112 Roberto Spadea
co colorato, abbondanti materiali ceramici e soprattut-to, dagli strati di distruzione, che sembra sia avvenuta in modo violento (strati con tracce d’incendio, ghiande missili, punte di freccia), sono da segnalare due statuet-te fittili femminili di alto livello (figg. 4–5): queste sotto-lineano ancora una volta come la polis attraversasse un periodo di benessere.
Il continuo riutilizzo nelle murature in questo e in quasi tutti i cantieri archeologici di Crotone, di grandi blocchi, in alcuni dei quali sono conservate tracce del-la lavorazione con anathyroseis ben curate, consente, come si diceva, di pensare, per le fasi precedenti, a co-struzioni e monumenti di grande rilievo, evidentemente perduti nel corso del periodo compreso tra il V e la pri-ma metà del IV secolo a. C. Il riutilizzo sottolinea quella carenza di materiale lapideo di cui si è più volte detto e l’impegno economico che presiede alla costruzione delle grandi mura e di altri monumenti. Un’ulteriore at-testazione, questa, della disponibilità finanziaria e della buona capacità di spesa della città.
Il Ceramico?
Un’altra testimonianza della vivacità che la società di Crotone attraversa nel periodo che segue la tirannide dionigiana è rappresentata dai risultati delle ricerche di Alfredo Ruga nella zona retrostante il ‹Campo Sporti-vo›, tra questo e l’‹Ospedale› (fig. 1-h), avvenute negli anni Novanta del secolo trascorso27. Qui s’impianta nel corso del IV secolo a. C. un’area strettamente connessa alla lavorazione dell’argilla. Considerata la poca distanza intercorrente tra quest’area e il piazzale che è di fronte al ‹Campo Sportivo› in direzione nord, dove, negli anni Ottanta, Paola Bottini e Antonio Capano misero in luce un piccolo complesso di abitazioni con annesso labo-ratorio di produzione ceramica28, si è pensato di inter-
27 Ruga 1998c, 44–46.28 Spadea 1983, 155, e Spadea 1998b, 41–43. La problema-
tica delle case laboratorio con tutta la sistemazione del com-parto dedicato a tali attività produttive è stato oggetto della tesi di dottorato di Giovanna Verbicaro in corso di stampa.
Fig. 4 Statuetta di tanagrina dall’area di via Telesio a Cro-tone
Fig. 5 Statuetta di tanagrina dall’area di via Telesio a Cro-tone
113Crotone tra i Dionisi ed Agatocle
pretare l’area di scavo della quale abbiamo appena detto come il ‹Ceramico› della città. L’ipotesi è stata sottopo-sta ad attenta e profonda disamina, considerati qualche dubbio ed incertezza che vale la pena affrontare subito.
I risultati conseguiti in questa zona assumono in ogni caso un ruolo di importante indicatore per la si-tuazione di Crotone in questo periodo di tempo. L’area è in uso fin dalla seconda metà del V secolo a. C. e le ri-cerche hanno accertato che in questa parte si estendeva l’abitato con resti di due isolati e parte di uno stenopos. Tale situazione sembra permanere fino alla prima metà del IV secolo a. C.; dalla seconda metà del IV secolo a. C. si coglie, invece, una trasformazione radicale quando sugli strati di obliterazione di tali isolati si verifica un sostanziale cambiamento di destinazione: sorge un im-pianto di tipo industriale che coinvolge anche il piano urbanistico crotoniate, sovrapponendosi ad isolati e al reticolo stradale. L’area è ora libera e si raccolgono indizi di impianti di lavorazione dell’argilla. Emergo-no distanziatori, valvole di fornace e soprattutto scar-ti di lavorazione, rappresentati da vasi di varia forma, malcotti ed ancora impilati. La diffusione e la tipologia degli scarti fa pensare ai risultati conseguiti da Agnese Racheli in un altro scavo condotto negli anni Ottanta del secolo scorso in un’area (fig. 1-j) che è all’estremo opposto dello scavo Ruga, tuttavia visibile ed interes-sata a simile destinazione d’uso, se pensiamo alle ‹case laboratorio› intermedie fra la prima e questa seconda area. Nonostante la limitata estensione del saggio, fu possibile recuperare scarti di fornace dello stesso tipo di quelli di cui abbiamo appena detto. A questo punto si potrebbe pensare che tutta la grande area compresa tra l’‹Ospedale›, il ‹Campo Sportivo› a mezzogiorno, la via Cutro in direzione nord e i rialzi argillosi intorno al Cimone Rapignese (scavo Racheli), fosse destinata ad impianti produttivi e specializzata nella fabbricazione di vasi. Qualche dubbio desta il fatto che nella grande superficie retrostante l’‹Ospedale› (area tra l’altro pros-sima ad una collina d’argilla) si sarebbe attesa la pre-senza di consistenti gruppi di fornaci (nel corso dello scavo sono emersi i resti di pochi impianti deteriorati), come dovrebbe essere proprio di un’area così specializ-zata, destinata alla produzione di manufatti necessari al vivere quotidiano. Il paragone con la vicina area del-le ‹case laboratorio›, dove attività industriali collegate a fornaci e alla cottura dell’argilla sono presenti sin dall’età arcaica, permette però di fugare ogni dubbio. E questo tipo di attività si estende, appunto dall’età arcai-ca, nell’area ‹Pertusola› al di là della via Cutro a fronte del ‹Campo Sportivo› (fig. 1-g) dove sono le già citate ‹case laboratorio›. In poche parole sembra quasi che la polis abbia deciso di concentrare in questo settore, as-sai vicino alla ‹cerniera› di due partizioni dell’impianto urbano, una grande attività produttiva specializzata in
lavorazioni industriali con pozzi e fornaci in cui l’ar-gilla, da annoverare tra le risorse primarie di Crotone, gioca un ruolo determinante. Tutto questo poi compor-ta la formazione e crescita di ‹ateliers› e di professiona-lità come ceramisti, pittori ed artigiani della terracotta che, attraverso l’analisi del materiale scavato, risultano essere aggiornati su forme e modelli in linea con quella che possiamo definire la koiné ellenistica magno gre-ca. Oltre alla produzione delle forme d’uso quotidiano, tanto nella ceramica fine da mensa (kylikes, skyphoi, lekanai, piatti, oinochoai, askoi, piedi di focula, lastre di arule, prove di antefisse etc) che in quella da fuoco (pentole, brocche, bacini, catini, lopades) si riscontra a Crotone la presenza di botteghe emergenti con produ-zioni più raffinate ed eccellenti e nella ceramica a fi-gure e nelle forme decorative ottenute a stampo. Nella coroplastica sono da rammentare le statuette tipo Ta-nagra, alcune delle quali abbiamo appena visto prima (via Telesio), altre caratterizzate da vivace policromia, o le lastre figurate con scene di combattimento tra figure mitologiche; nelle terrecotte architettoniche e antefis-se rimanderei ancora al tipo della Bendis (cui ho fatto cenno per il cantiere di Via Telesio, fig. 1-j), databili tra il 360–340 a. C.
Tra i reperti mobili rinvenuti nelle discariche si se-gnalano inoltre enormi quantità di vasellame comune verniciato e non, con numerosissimi scarti vetrificati o deformati da un’errata cottura; poi, gli impastatoi, le valvole-distanziatrici per impilare il vasellame da cuo-cere e moltissimi distanziatori a cuneo, alcuni con sigle incise.
Il santuario di Capo Colonna
Un uguale fervore si può cogliere nel santuario di Hera Lacinia a Capo Colonna, santuario autonomo da Kro-ton, nondimeno strettamente collegato ad esso perché punto di riferimento principale del sacro rappresenta-to da Hera, la cui presenza è radicata nella città e nella sua chora. Qui per il periodo cronologico che stiamo trattando, nonostante la ricerca archeologica sia da ri-tenersi per alcune zone ancora parziale, sono presenti due significativi complessi monumentali, riflesso della ripresa di cui si è parlato per l’abitato.
Si tratta dell’hestiatorion (edificio H) e del katago-gion (edificio K), le cui principali fasi sono comprese tra la seconda metà del IV secolo a. C. e la prima metà del III secolo a. C. (fig. 6).
I due complessi sono stati indagati da Florian Seiler negli anni Ottanta e Novanta del secolo passato29 e sono esito di progetti adeguati a quella circolazione di uomini
29 Seiler 1996, 253–256.
114 Roberto Spadea
ed idee cui prima facevo cenno e non è un caso, come bene ha rilevato lo stesso Seiler, che entrambi raccol-gano le migliori lezioni d’architettura provenienti dai centri e santuari più importanti della Magna Grecia e della madre patria. Lo stesso Florian Seiler ha richia-mato per l’hestiatorion soluzioni di simmetria e di ra-zionalità30 che non trovano ancora confronti per le tec-niche costruttive e per altre particolari soluzioni, come per esempio i canali di drenaggio.
Non è possibile arrivare per questi due complessi monumentali a definizioni cronologiche precise, perché l’indagine stratigrafica condotta esemplarmente da Sei-ler ha bisogno di ulteriori approfondimenti, né si è in grado di associare con sicurezza alla loro copertura spe-cifiche terrecotte architettoniche. Il katagogion, che è collocato lungo la via sacra, potrebbe avere preceduto la costruzione dell’hestiatorion in uno spazio retrostante la zona verso mare dominata dal tempio classico e forse solo il katagogion potrebbe avere avuto una copertura fittile con sime-grondaie a testa leonina, i cui confronti riportano comunque ad anni successivi al 360 a. C.
La verifica delle terrecotte architettoniche, eseguita da Gregorio Aversa, ha consentito di accertare l’attivi-tà di un’officina al servizio del santuario che si svilup-pa con continuità dai primi decenni del V secolo a. C. alla fine dello stesso secolo. La scelta dei medesimi mo-tivi decorativi (kyma lesbio, teste leonine) consente di
riconoscere tale coerenza. L’intera sequenza registra comunque un’assenza nelle produzioni proprio tra gli inizi e la metà del IV secolo a. C., quando i modelli del V secolo a. C. vengono ripresi in maniera corsiva per il probabile rifacimento di coperture di edifici già esisten-ti. E l’assenza di tipi databili al III secolo a. C. fa pensare alla cessazione di ogni attività dell’officina.
Agatocle
Negli anni finali del IV secolo a. C. la città comincia ad essere interessata da fenomeni di trasformazioni dell’impianto urbano, come abbiamo visto per l’area del ‹Ceramico›. È stato possibile individuare in tre diversi punti ristrutturazioni di unità abitative e di isolati.
Nell’area ‹G.V. Gravina› si chiude un ambitus allo scopo di ricavare due unità più piccole da una più gran-de; nel cantiere di via XXV Aprile, si chiude uno steno-pos; ancora, nell’area ‹Romano›, nel ‹Fondo Gesù›, un muro trasversale sbarra uno stenopos (fig. 7). Altre va-riazioni sono state verificate nell’area di ‹Vigna Nuova›, dove nella cosiddetta stoà alcuni resti murari documen-tano una ristrutturazione legata non più al santuario ma ad attività artigianali31. In questi esempi, come per il ‹Ceramico›, sembra si possa pensare con sufficiente concretezza che il piano urbanistico, fondamentale nel passato remoto e in quello recente, non costituisca più
30 Seiler 1996, 253. 31 Spadea 1998c, 94–95.
Fig. 6 Panoramica prospettica (da ovest) dell’area del santuario di Hera Lacinia a Capo Colonna
115Crotone tra i Dionisi ed Agatocle
un punto di riferimento per la città. Peraltro nell’orien-tamento dello stenopos del ‹Fondo Gesù›, come in al-cuni frammenti murari rinvenuti in altri piccoli saggi limitrofi, è stato possibile cogliere una differente de-clinazione degli assi urbani fondamentali, spostati qui +40° ad est rispetto a +30° di declinazione, che è usuale per gli assi del comparto centrale crotoniate di cui il ‹Fondo Gesù› fa parte. Ed è proprio la chiusura delle strade a porre in evidenza lo stravolgimento del piano regolatore, se si considera che gli assi stradali sono la linea guida della maglia urbanistica della città, così che, interrompendo questa unità, si deve pensare a nuove sistemazioni per il comparto dove tali anomalie sono state rilevate.
L’inizio del III secolo a. C. deve ritenersi di grande importanza per la vita di Crotone. Gli avvenimenti storici più significativi si datano intorno al 296 a. C. e riguardano l’attacco di Agatocle alla città, attacco par-ticolarmente intenso, tanto che una fonte autorevole come Diodoro narra i particolari di questo assedio por-tato contro la città «da mare a mare»32: un particolare che permette di ricostruire una linea fortificata anche dalla parte della costa. Diodoro parla dell’utilizzo di ca-
tapulte e della costruzione di gallerie e sottolinea che la caduta del megistos oikos, monumento di assoluto va-lore per la vita della polis, segnò l’avvio della presa di Crotone.
Nel Convegno napoletano avevo avanzato l’ipotesi di identificare il megistos oikos con l’Heraion di Vigna Nuova, dove, negli strati coevi agli avvenimenti di cui parliamo, sono state riscontrate tracce di incendio e punte di freccia33. Seguirono saccheggi ed uccisioni con la devastazione della città. Tracce dell’assedio si desu-mono dal ritrovamento di numerose punte di freccia in vari cantieri cittadini34, associate a ghiande missili.
I tesoretti del ‹Fondo Gesù›
A questi dati la ricerca archeologica aggiunge ora il re-cupero di due tesoretti monetali, avvenuto nell’ottobre 2005, nell’area tecnica dei ‹Fratelli Romano› in un setto-re centrale del ‹Fondo Gesù› (fig. 1-l).
Uno è costituito da quattordici monete in elettro e oro e da sessantasette esemplari in argento, con un pic-colo nucleo di gioielli in oro e argento. Il piccolo tesoro era stipato in una brocchetta di terracotta. Il secondo,
32 Diod. 20, 4.33 Si vedano in proposito i blocchi del paramento mu-
rario rinvenuti in una cava moderna, non più esistente (cava Messina), ubicata ai margini del ‹Fondo Gesù›.
34 Alfredo Ruga ne ha censito almeno 13 differenti tipi
Fig. 7 Planimetria dell’area di scavo nel ‹Fondo Gesù› di Crotone
negli strati di fine IV secolo a. C. dai cantieri di Vigna Nuova, di via Di Vittorio, del ‹Fondo Gesù›, di via Telesio, di via XXV Aprile, del ‹Ceramico›, dell’‹Ospedale›, di ‹Microcitemia›, della ‹Banca Popolare di Crotone› solo per ricordare i più im-portanti.
116 Roberto Spadea
trovato non molto lontano e disperso nel terreno, conta circa 180 monete di bronzo.
I due tesoretti sono stati restaurati e sono in avanzato corso di studio da parte di Ermanno Arslan e Alfredo Ruga, da cui ho attinto le fondamentali informazioni che vado ad esporre.
I ripostigli si riferiscono probabilmente ad episodi di-versi e separati nel tempo.
Il primo ripostiglio. Il primo ripostiglio, riunendo oro, argento e gioielli, appare come un classico episodio di ‹tesaurizzazione› d’emergenza, con raccolta di materiali in metallo prezioso, destinato ad assicurare il massimo valore con il minimo di volume.
Le monete in elettro sono siracusane (otto da venti-cinque litre e due da dodici litre e mezzo) e cartagine-si (uno statere). Quelle in oro sono di Filippo III con i tipi di Filippo II di Macedonia (due stateri delle zecche di Teos e di Pella databili al 318 a. C.) e di Alessandro Magno (uno statere). Si tratta del tipo di circolante clas-sico per questa fase storica e le autorità emittenti erano le potenze maggiori, che si contendevano il controllo del Mediterraneo.
La composizione del nucleo delle sessantasette mone-te d’argento (poco più di 500 grammi di metallo coniato) comprende nominali pesanti (tetradrammi, didrammi e stateri), con pochi nominali più piccoli (quattro dioboli e cinque dracme ridotte) e ciò indica una forte selezione nel materiale da destinare all’occultamento, scegliendo quello di maggior peso e valore.
Fra gli esemplari due sono di emissione molto pre-cedente: uno statere incuso di Metaponto con la spiga, che viene datato al 470–440 a. C. e un altro di Caulonia, datato al 425–400 a. C. Tutte le altre monete sono più recenti, datate tra la metà del IV secolo a. C. e l’inizio del secolo successivo. Esse sono riferibili ad alcune delle maggiori città che in questa fase emettono moneta in Magna Grecia: Velia (sette didrammi), Neapolis (sette didrammi), Taranto (due didrammi) e Turi (un didram-mo e un diobolo). A queste si affiancano le medesime potenze che abbiamo visto nella moneta d’oro: Siracu-sa, con due tetradrammi, Cartagine con altri due tetra-drammi ‹siculo-punici›, e infine un tetradrammo con il volto di Alessandro Magno. Fortemente significativa appare la presenza dei ‹pegasi› (fig. 8), con stateri e drac-me ridotte, emessi a Corinto e nei centri a Corinto col-legati, in una specie di unione monetaria, che dominò per un certo periodo il mercato della moneta, in colle-gamento con precise vicende politiche che coinvolsero tutta la nostra area35. Si tratta trentaquattro stateri e di cinque dracme, il 58% delle monete in argento.
Ermanno Arslan ritiene che il possessore del cospi-cuo tesoretto dovesse essere un mercante di passaggio o un banchiere o un cambiavalute o qualcuno che tesau-
rizzava valuta ‹estera›, ben sapendo di doverla cambiare se voleva spenderla, forse per sfiducia nella valuta locale. Per Arslan chi lo occultò venne comunque coinvolto in un episodio drammatico e non ebbe la possibilità di re-cuperare il tesoro.
Le date di emissione delle monete più recenti, che l’analisi del tesoretto permetterà certo di meglio di pre-cisare, ma non di modificare radicalmente, sembrano portare ai primissimi anni del III secolo a. C., quando Crotone venne coinvolta in un episodio devastante. Si ritorna così all’assedio e alla presa da parte di Agato-cle di Siracusa, nel 296 a. C., di cui ho detto prima. Il saccheggio della città dovette essere radicale e non è affatto difficile immaginare che i cittadini, terrorizza-ti, tentassero di occultare gioie e monete per salvarli dalla rapina degli invasori. Alcuni non vennero trovati durante il saccheggio e sono giunti fino a noi, con una composizione talvolta simile, come uno da Crotone, lo-calità San Francesco, rinvenuto nel 196136, che presenta significative analogie con il nostro e, probabilmente, ha la medesima data di occultamento, un altro rinvenuto presso il fiume Esaro, un altro ancora segnalato nel 1977, forse simile al nostro, sempre dal fiume Esaro37.
Infine, Arslan e Ruga propongono come probabile data di occultamento del tesoretto il termine della for-tuna dei ‹pegasi› e del loro dominio del mercato, per le scelte diverse di Agatocle di Siracusa nell’emissione della propria moneta (nel 295 a. C.), nel quadro di una manovra per il controllo del mercato.
Da segnalare come fatto molto importante la presen-za dei pochissimi medi nominali (tre dioboli) di Croto-ne, la città ove è avvenuto il ritrovamento.
35 Mele 1993, 266.36 Attianese 1977, 362–363 e Arslan 2006, 24.37 Attianese 1977, 364–365 e Arslan 2006, 24.
Fig. 8 Stateri corinzi con pegasi
117Crotone tra i Dionisi ed Agatocle
Le oreficerie. Accanto alle monete nella brocchetta del ‹Fondo Gesù› era contenuto un ristretto ma interessan-te campionario di oreficerie ed argenterie di ornamento personale, che al momento non trova riscontri precisi tra altri rinvenimenti di Crotone38.
Spiccano innanzitutto gli orecchini (fig. 9). Si tratta di oggetti raggruppabili in tre serie di ampia diffusione nell’Italia antica (Puglia, Basilicata, Calabria) e rientrano nell’ambito di produzioni tipicamente tarantine, dove le botteghe recepivano modelli e influssi provenienti da varie aree geografiche e soprattutto dal mondo alessan-drino, dando agio ad abilissimi artigiani di creare piccoli capolavori in lamina d’oro con applicazioni a granula-zione e filo d’oro. Essenzialmente essi sono inquadrabili nella tipologia con teste leonine singole o doppie poste alle due estremità, cave all’interno, la cui produzione si inquadra tra l’ultimo quarto del IV secolo a. C. e la prima metà del III secolo a. C.
Seguono gli anelli, presenti con due esemplari d’oro a castone circolare liscio, dell’ultimo ventennio del IV secolo a. C., che trovano confronti ancora in produzioni tarantine però di argento dorato, un anellino d’oro con castone a losanga a profilo continuo, decorato ad inci-sione con un volatile ad ali aperte, databile nel primo venticinquennio del III secolo a. C., e i resti di un anello d’oro a castone mobile, forse uno scarabeo, scomparso già in antico, che costituisce una buona esemplificazio-ne di queste produzioni dell’ultimo quarto del IV secolo a. C. Si aggiungono poi un elegante bracciale spiralifor-me d’argento massiccio, con estremità a testa di serpen-te, inquadrabile tra le produzioni della prima metà del III secolo a. C. e due fermatrecce in lamina d’argento. Di una collana, infine, si conservano tre vaghi in lamina d’oro a formare elementi a ‹barilotto›.
Chiudono la rassegna dei preziosi due fibule d’argen-to, databili ancora tra la fine del IV e la metà del III se-colo a. C., coerentemente con il resto delle gioiellerie.
Mi limito a dire, in attesa della definitiva edizione di queste gioie, che questo ritrovamento è ancora at-testazione del benessere economico attraversato dalla città per tutta la seconda metà del IV secolo a. C. e bru-scamente interrotta dalla devastante presa di Agatocle all’inizio del III secolo a. C. quando fu necessario oc-cultarle.
Il secondo ripostiglio. Il secondo ripostiglio, con oltre 180 monete, presenta ben maggiori difficoltà di inter-pretazione, ma anche più interessanti prospettive criti-che. In attesa dell’edizione di Ermanno Arslan e Alfre-do Ruga, in questa sede si possono solo indicare alcuni aspetti molto evidenti e fortemente problematici.
È assente la moneta di Crotone. Ciò potrebbe avere due spiegazioni: o il nucleo giungeva da altro luogo, dove la moneta di Crotone non era presente, o il nucleo po-trebbe essersi formato in un’epoca nella quale la zecca di Crotone non batteva più moneta ed era chiusa. Ci si stu-pisce però – in quest’ultimo caso – che nella massa del circolante locale, dalla quale avvenne il ‹prelievo› delle monete del tesoretto, non vi fosse più alcuna moneta di Crotone, emessa in grandissima abbondanza nelle epo-che precedenti e sicuramente ancora circolante.
Un altro elemento problematico è dato dalla massic-cia presenza della moneta di Siracusa: il 78%. Ad essa si associano monete di Messana, di Reggio, di Locri, di Terina, di Noukria, da ritenere veicolate dalla moneta siracusana.
Una presenza di moneta siracusana in modo così pe-sante non può che porre interessantissimi problemi. Se la formazione dovesse risultare locale, si avrebbe una conferma della ‹colonizzazione› monetaria cui si è fatto sopra cenno, ma una verifica delle vicende storiche che coinvolgono Crotone e Siracusa, nel corso del III secolo a. C., specie intorno alla metà del secolo, non sembra giustificare una presenza così vistosa dei Siracusani di Ierone II nella città. Nei coevi strati di frequentazione dell’area dove è stato rinvenuto il tesoretto la percentua-le di moneta crotoniate è superiore rispetto a quelle di altre zecche. Un’ipotesi possibile è che questo gruzzolo rifletta una raccolta di moneta non locale da convertire e il riferimento cronologico è il 260 a. C., epoca in cui si datano i nominali più recenti, siracusani, emessi da Ierone II. La formazione del gruzzolo è graduale, come attestano i pezzi più antichi, e non di emergenza. Averlo trovato nel terreno e non in un contenitore conferma che il gruzzolo di almeno 180 pezzi di bronzo non era destinato ad essere conservato per un lungo periodo, ma accantonato per essere cambiato a breve. Pertanto prende valore l’ipotesi Arslan che il suo possessore fosse un cambiavalute o un esponente del ceto medio artigia-no e mercantile.
38 Sui gioielli del Fondo Gesù, in corso di studio da parte di chi scrive, si forniscono in questa sede alcune antici-pazioni.
Fig. 9 Orecchini aurei a testa di leone di produzione tarantina
118 Roberto Spadea
Ritornerei su questa prima parte del III secolo a. C. – e siamo alla fine – richiamando quel fondamentale pas-so liviano dove si fa allusione al passaggio di Pirro e a devastazioni conseguenti quel passaggio39. A Crotone, a stento – dice Livio – era occupata metà della grande su-perficie urbana. Nello specifico i fatti storici cui riferirsi sono quelli della conquista di Crotone da parte del con-sole Cornelio Rufino del 277 a. C., conquista devastante se il numero degli abitanti secondo le fonti si riduce a 2000 e se la città stessa non compare tra i socii navales che intervengono accanto a Roma nel corso della I guer-ra punica (264 a. C.)40.
Gli scavi condotti in tutte le parti della grande area cittadina accertano un arresto dei livelli di frequenta-zione negli anni intorno alla prima metà del III secolo a. C. Più che segni di distruzione emergono segni di un finale abbandono. Tale è il caso del complesso di Via Te-lesio nel quale si verifica un crollo nella prima metà del secolo e dove si assiste ad una sporadica frequentazione ascrivibile agli ultimi decenni del III secolo a. C., in rap-porto forse alla presenza di gruppi brettii. E ancora è il caso del complesso del ‹Campo Sportivo›, dove la stoà,
per la quale Gregorio Aversa e Alfredo Ruga propongo-no una ricostruzione con ordini sovrapposti (frammen-ti di capitelli dorici e di sime di grondaia a teste leonine ed elementi di ordine ionico), è demolita nel corso del III secolo a. C. Prosegue un abbandono, che interessa l’intero comparto edilizio, iniziato già nella prima parte del secolo. Lo stesso vale per l’area del cosiddetto Cera-mico, dove le produzioni documentate dalle discariche si arrestano alla prima metà del III secolo a. C.
Le poche riprese, localizzate nella parte finale del III secolo a. C., si circoscrivono via via all’area più prossima alla collina del Castello, ad esempio in quella della Ban-ca Popolare di Crotone. Qui si registrano restringimenti degli ambienti abitativi e differente destinazione d’uso del cortile (da residenziale ad artigianale), ma con tec-niche frettolose, che non fanno più caso alle linee guida del piano regolatore che aveva distinto Crotone nei pe-riodi della sua ἀκμή. Il tutto in perfetta sintonia con il quadro delle fonti.
Ma qui mi fermo con un grato pensiero per Alfonso Mele, cui devo stimoli e suggerimenti che non poco mi hanno aiutato nella stesura di questo intervento.
39 Liv. 24, 3. 40 Mele 1993a, 286.
119Crotone tra i Dionisi ed Agatocle
Abbreviazioni bibliografiche
Arslan 2006 E. A. Arslan, Moneta, ripostigli, economia, in: R. Spadea (ed.), Il tesoro nasco-sto. Monete e gioielli di età ellenistica dal «Fondo Gesù» di Crotone (Crotone 2006) 21–24.
Attianese 1977 P. Attianese in: Gazzettino Numismatico 6, 1977, 362–365.Aversa 1998 G. Aversa, Le decorazioni architettoniche: in Spadea 1998, 39–41.Barra 1992 M. Barra Bagnasco, Le strutture e la vita dell’area, in M. Barra Bagnasco (ed.),
Locri Epizefiri IV. Lo scavo di Marasà Sud. Il sacello tardo arcaico e la «casa dei leoni» (Firenze 1992).
Borrello 1993 L. Borrello, Lo scavo in località «Vigna Nuova», in: Mele 1993, 45–50.Cimino 1993 G. Cimino, Lo scavo dell’area «G. V.Gravina-Pignara» a Crotone. Risultati
preliminari, in: Mele 1993, 37–44.Crotone 1983 Crotone. Atti del ventitreesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taran-
to, 7–10 ottobre 1983 (Taranto 1984).Greco 1999 E. Greco (ed.), La città greca antica. Istituzioni, società e forme urbane (Roma
1999).Marino 1996 D. Marino, Cave d’età greca nella chora meridionale della pòlis di Kroton.
Note topografiche e tipologiche, in: A. Dell’Era – A. Russi (ed.), Vir bonus, docendi peritus. Omaggio dell’Università dell’Aquila a Giovanni Garuti, Gervasiana 6 (San Severo 1996) 17–38.
Mele 1993 A. Mele (ed.), Crotone e la sua storia tra IV e III sec. a. C., Atti del Seminario Internazionale, Napoli 13–14 febbraio 1987 (Napoli 1993).
Mele 1993a A. Mele, Crotone greca negli ultimi due secoli della sua storia, in: Mele 1993, 235–291.
Mertens 2006 D. Mertens, Città e monumenti dei greci d’Occidente (Roma 2006).Orsi 1912 P. Orsi, Crotone, NSc, suppl. 1912, 60–64.Racheli 1993 A. Racheli, Lo scavo nell’area della «Banca Popolare Cooperativa» (Via Panel-
la), in: Mele 1993, 51–60.Racheli 1998 A. Racheli, Lo scavo della Banca Popolare di Crotone, in: Spadea 1998, 76–80.Ruga 1998a A. Ruga, Gli scavi in via Di Vittorio e in Via Telesio. Lo scavo in Via Di Vitto-
rio, in: Spadea 1998, 90–93.Ruga 1998b A. Ruga, Lo scavo in Via Telesio, in: Spadea 1998, 92–93.Ruga 1998c A. Ruga, Il quartiere dei vasai, in: Spadea 1998, 44–55.Seiler 1996 F. Seiler, L’architettura sacra, in E. Lattanzi et al. (edd.), I Greci in Occidente.
Santuari della Magna Grecia in Calabria (Napoli 1996) 250–258.Spadea 1983 R. Spadea, La topografia, in: Crotone 1983, 119–166.Spadea 1998 R. Spadea (ed.), Kroton. Scavi e ricerche archeologiche a Crotone dal 1985 al
1998 (Milano 1998).Spadea 1998b R. Spadea, Le aree di produzione in: Spadea 1998, 41–44.Spadea 1998c R. Spadea, Lo scavo di Vigna Nuova, in: Spadea 1998, 93–95.Verbicaro 2005 G. Verbicaro, Ricerche sull’edilizia domestica in Magna Grecia, Siris 6, 2005,
5–25.
120 Roberto Spadea
Fonti iconografiche
Fig. 1 Rielaborazione Eugenio Donato, Lamezia Terme (Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici della Cala-bria). – Fig. 2. 7 Rilievo ed elaborazione Paolo Morelli (Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici della Cala-bria). – Fig. 3 Foto Gregorio Aversa (Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria). – Fig. 4. 5. 8. 9 Domenico Critelli (Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria). – Fig. 6 autore.
Indirizzo
Dr. Roberto SpadeaSoprintendenza per i Beni Archeologici della CalabriaVia Domenico Romeo, 289123 Reggio [email protected]
Inhalt
Schriftenverzeichnis Prof. Dr. Ing. Dr. h. c. Dieter Mertens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Richard NeudeckerEinführung. Geschichten von Krise und Wandel im Süden Italiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pier Giovanni GuzzoFra i Brettii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Andreas ThomsenZentralisierungsprozesse im Hinterland von Selinunt. Pizzo Don Pietro und Castello della Pietra . . . . . . . . 27
Alessandro NasoReperti italici nei santuari greci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Stefano VassalloTrasformazioni negli insediamenti della Sicilia centro-settentrionale tra la fine del V e il III secolo a. C. con nota preliminare sul teatro di prima età ellenistica di Montagna dei Cavalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Maurizio GualtieriOrganizzazione insediativa e sviluppi istituzionali nell’hinterland magno-greco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Massimo OsannaSiedlungsformen und Agrarlandschaft in Lukanien im 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Roberto SpadeaCrotone tra i Dionisi ed Agatocle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Enzo LippolisTaranto nel IV secolo a. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Hans-Peter IslerL’insediamento a Monte Iato nel IV e III secolo a. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Sophie HelasDer politische Anspruch Karthagos auf Westsizilien. Mittel und Wege der Machtsicherung . . . . . . . . . . . 175
Malcolm Bell, IIIAgrarian Policy, Bucolic Poetry, and Figurative Art in Early Hellenistic Sicily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193


























![[2014-10-08] Demografischer Wandel als gesellschaftliche Krise – Deutsche Alterungsdiskurse der Gegenwart und die wachsende Kritik an deren Demografisierung und Dramatisierung (37.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63233d71807dc363600accc0/2014-10-08-demografischer-wandel-als-gesellschaftliche-krise-deutsche-alterungsdiskurse.jpg)