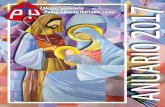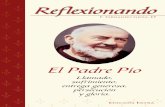The Re-establishment of Meaning and Purpose: Madri. and Padre Muzhub in the Punjabi Diaspora
Padre Ferrua e l'epigrafia pagana
Transcript of Padre Ferrua e l'epigrafia pagana
129
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI
PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA*
Nonostante gli indubbi meriti conseguiti da padre Ferrua nell’ambito dell’epigrafiae delle antichità cristiane se si passa anche solo rapidamente in rassegna la sua prodigiosaattività scientifica (oltre 450 titoli, prescindendo dalle oltre 1600 segnalazioni e recensioniapparse tra il 1935 e il 1998 su La Civiltà Cattolica) si resta colpiti dalla versatilità dei suoiinteressi e dalla solidità delle sua preparazione. Padre Ferrua incarna la figura di studiosocompleto del mondo antico, in grado di muoversi, per limitarci al campo epigrafico, conuguale sicurezza tra le iscrizioni cristiane e pagane, latine e greche (come dimostrò fin dalsuo contributo scientifico del 1939 su alcune iscrizioni inedite di S. Agnese f.l.m. e di S.Pancrazio, fuori Porta Aurelia, ma anche nel lungo articolo apparso nella Rivista di Archeo-logia Cristiana del 1941 sull’epigrafia sicula pagana e cristiana), un tipo di studioso chenel corso della seconda metà del ’900, con il prevalere delle specificità e delle specializza-zioni, divenne sempre più raro. Forse Padre Ferrua fu quasi costretto a occuparsi anche diepigrafia pagana, soprattutto nel caso di Roma, dalle sue pazienti e sistematiche ricerchenelle catacombe dell’Urbe, cosciente delle difficoltà che spesso incontrava l’epigrafista, inmancanza di sicuri indizi interni, nel distinguere un testo cristiano da uno pagano.
Quasi a volersi giustificare dall’intromettersi, sempre in punta di piedi e con cautela,in un campo di ricerca che evidentemente non sentiva del tutto proprio, Padre Ferrua, chesapeva di potersi avvalere dell’amicizia e dell’esperienza di Attilio Degrassi, all’inizio deisuoi contributi sulle iscrizioni pagane che andava di volta in volta pubblicando, esordivaspesso con frasi del tipo: “Nel ricercare con grande studio ed assiduità le antiche iscrizionicristiane delle catacombe romane, secondo il compito prefissomi fin da principio per lacontinuazione delle ICUR del De Rossi, spesso m’imbatto in lapidi pagane intere o fram-mentarie, che dagli antichi cristiani furono riadoperate per chiudere le loro tombe nel corsodei secc. IV e segg.”1. “Sono generalmente tavole marmoree riadoperate per chiusura ditombe cristiane o in altri lavori della catacomba, qualche volta buttate dentro di essa dalsopratterra attraverso frane o lucernari”2. “Per contribuire in qualche modo al lavoro di S.Panciera pubblico rapidamente una serie di schede che mi sono venuto formando nellepause del lavoro troppo più impegnativo della pubblicazione delle ICUR”3 e così via.
Complessivamente nel campo dell’epigrafia pagana ho contato nella sua bibliogra-fia curata nel 2005 da Antonella Mollicone una settantina almeno di titoli (senza conside-rare le numerose recensioni apparse in varie sedi e le segnalazioni bibliografiche ricorrentinei vari fascicoli de La Civiltà Cattolica)4. Seppure non poté raggiungere l’altissimo nu-mero delle iscrizioni cristiane da lui edite, è comunque considerevole anche il gruppo diiscrizioni latine pagane soprattutto di Roma rese note negli anni da Padre Ferrua, all’incirca1500, nel lungo arco di tempo compreso tra il 1939 e il 1994.
* Il testo è di G.L. GREGORI; le Appendici 1-2 sono state redatte da M. GIOVAGNOLI. Nelle note con la sigla LB si fa riferimentoalla Lista Bibliografica finale dove sono stati riuniti i contributi di Padre Ferrua relativi all’epigrafia pagana.
1 LB 28, p. 3.2 LB 32, p. 127.3 LB 49, p. 367.4 MOLLICONE 2005.
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 129
I primi contributi apparvero su Epigraphica, del quale Padre Ferrua fu fedele e as-siduo collaboratore dal primo numero della rivista, apparso nel 1939, e fino al 1970 (inrealtà egli aveva esordito nel campo dell’epigrafia pagana sino dal 1935 con un articoloin La Civiltà Cattolica sulla collana delle Inscriptiones Italiae il cui primo fascicolo erauscito nel 1931). Numerosi articoli apparvero anche nei Rendiconti dell’Accademia deiLincei (nel decennio tra il 1973 e il 1984) e nei Rendiconti della Pontificia AccademiaRomana di Archeologia (di cui era divenuto socio corrispondente nel 1943 ed effettivonel 1944). Più sporadicamente ricorse per i suoi contributi sull’epigrafia pagana alla Rivistadi Archeologia Cristiana5, al Bullettino della Commissione Archeologica Comunale6, allaRivista Storica di Antichità7, agli Atti della Società Romana di Storia Patria o ad altresedi. Altri lavori apparvero poi in volumi miscellanei.
Solitamente i suoi contributi sulle iscrizioni pagane hanno un carattere topografico,proprio perché strettamente connessi con il progredire delle sue ricerche nelle catacomberomane e dei lavori di edizione dei fascicoli delle ICUR, salvo tornare più volte sugli stessicomplessi catacombali o sulle stesse vie antiche, attingendo di volta in volta a schede pro-prie o a quelle tratte dai taccuini o dai diari di scavo di studiosi precedenti, quali Armellini,de Rossi, Josi, Stevenson, Visconti, da lui rintracciate in pazienti ricerche d’archivio o dibiblioteca e che si sono in molti casi rivelate utilissime soprattutto nel fornire i dati sullaprovenienza di pezzi già editi8. Talora fu proprio l’apporto di testi pagani alla conoscenzadella topografia di Roma a suggerirgli lo spunto per qualche nuovo lavoro9.
Passando rapidamente in rassegna i titoli dei suoi contributi sull’epigrafia pagana,troviamo più volte il complesso monumentale di S. Agnese e il primo tratto di via Nomen-tana10, ma soprattutto le catacombe di S. Sebastiano, Domitilla, Pretestato, Vibia e il relativotratto della via Appia con i ritrovamenti di vigna Codini11, ma anche le catacombe dei SS.Marcellino e Pietro, con particolare riguardo alle stele della guardia del corpo a cavallodell’imperatore che proprio qui aveva il suo sepolcreto fino a quando Costantino sciolse ilcorpo, fedele a Massenzio12. E ancora la zona di via Latina13, le catacombe di S. Tecla14,
5 LB 7, 17, 27, 59.6 LB 4, 29, 40.7 LB 48.8 Vd. ad esempio LB 40, dove sulla base degli appunti di G.B. DE ROSSI vengono corrette le provenienze delle seguenti iscrizioni:
CIL, VI 24704 non dal coemeterio S. Soteridis ma dalla catacomba di Vibia; CIL, VI 11520 non dalla catacomba di Ciriaca madalla catacomba di Pretestato; CIL, VI 22480 dall’ipogeo di Vibia, mentre prima si sapeva genericamente di un rinvenimentoavvenuto vicino alla vigna Amendola sull’Appia. Altro caso è LB 55 dove, in base al codice Vat. Lat. 13046, Ferrua riconducealla vigna di Lorenzo Fortunati (già Nardi) posta in via Cupa fuori porta Pia CIL, VI 12866, 16966, 19200, 26634. Consultandogli atti della Lipsoteca del Vicariato, precisa inoltre la provenienza dalla catacomba di S. Agnese delle seguenti iscrizioni: CIL,VI 15360, 19082, 23593, 37758, 37939, 38008, 38487, 38567, 38738, 39094a. Nello stesso contributo Ferrua ipotizza una pro-venienza dal Cimitero Maggiore di CIL, VI 14980, 25279, 25722, dal momento che sono state viste nella villa Crostarosa chesi estendeva al di sopra di questo. Propone una diversa lettura di CIL, VI 28942 (risultata essere opistografa), di CIL, VI 9661alle rr. 6-8 e dell’epigrafe pubblicata da P. Fasola, in RAC, 37 (1961), p. 251.
9 LB 21.10 LB 2, 30, 54, 55.11 LB 8, 9, 17, 27, 28, 40, 45, 47, 50, 54, 56, 67.12 LB 16, 32. 13 LB 18, 28. 14 LB 57.
130
PADRE ANTONIO FERRUA NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 130
Priscilla15 e il relativo tratto di via Salaria16, la catacomba di S. Ippolito e la via Tiburtina17,quella di Commodilla18 e il sepolcreto pagano di via Ostiense19.
Non mancano neppure contributi di carattere miscellaneo su iscrizioni viste in luo-ghi diversi di Roma, alcune già edite sulla base di fonti manoscritte e da lui ritrovate pressoantiquari romani20, o su epigrafi di collezioni private, come quella del Pontificio IstitutoBiblico21, ora trasferita ai Musei Vaticani, o il lapidario Armellini22. I controlli autopticipermisero spesso a Padre Ferrua di correggere i testi di iscrizioni pubblicate in CIL, VI23.
Non pochi articoli furono dedicati a due argomenti tra loro molto diversi ma chestavano a lui parimenti a cuore, mi riferisco agli Atti dei Fratelli Arvali e alle tavole lusorie.
Degli Acta Fratrum Arvalium Padre Ferrua pubblicò nuovi frammenti, asportatigià in antico dal bosco della dea Dia alla Magliana e rinvenuti vuoi nelle Grotte Vaticane24,vuoi nella catacomba di Calepodio25 al terzo miglio della via Aurelia Antica (ora ripresida J. Scheid)26. Merita una parola in più questo secondo caso, perché in uno stesso fram-mento furono registrati gli atti di ben quattro anni (mentre normalmente essi si riferisconoa uno o al massimo a due anni).
Quanto alle tavole da gioco iscritte, alcune erano state già edite, ma erano bisognosedi correzioni di lettura; la maggior parte era tuttavia inedita. Le tavole erano state spessoriutilizzate nelle catacombe come chiusura di tombe a loculo, con le lettere a vista, al paridi molte iscrizioni sepolcrali pagane27. Padre Ferrua riuscì a rintracciare anche alcuni raritavolieri con simboli cristiani (uno ad es. presenta l’arca di Noé e un pastore con pecore)e alcuni esemplari, altrettanto sporadici, con lettere dell’alfabeto greco.
Sul tema dei tavolieri a 36 caselle iscritti Padre Ferrua raccolse schede per quasi 50anni, pertinenti soprattutto a Roma; molte di esse rimasero inedite e furono raccolte nel2001 in un bel volume d’insieme, che comprende 200 numeri di catalogo, a cura di MariaBusia nella collana del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, in occasione del cente-simo compleanno dell’autore28. Queste tavole da gioco presentano le caselle disposte su trefile orizzontali parallele, ciascuna delle quali divisa a metà da un elemento centrale. I for-mulari sono più ricchi di quanto si potrebbe immaginare: la maggior parte si riferisce algioco praticato sui tavolieri stessi, ma non mancano allusioni ad altri tipi di giochi. PadreFerrua ha il merito di aver rispolverato l’interesse per questo tipo di documenti, un po’ di-
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI - PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA
15 LB 62.16 LB 63.17 LB 51.18 LB 61.19 LB 26, 58.20 LB 2, 33, 34, 39, 49.21 LB 52.22 LB 68.23 Cfr. ad esempio LB 54, pp. 92-96, dove vengono corrette parzialmente le letture delle seguenti iscrizioni: CIL, VI 16115,
17083, 32684, 36025, 36919.24 LB 10, 11.25 LB 29, 59.26 SCHEID 1998, nr. 65.27 LB 12, 13, 14, 31.28 LB 69.
131
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 131
menticati dopo gli studi pioneristici di Garrucci e di Ihm29, del cui lavoro Padre Ferrua sidichiarò continuatore fin dal suo primo contributo in materia risalente al 1946, acquisendonel corso degli anni una competenza sui formulari più in uso, che gli consentì di avanzarespesso sicure proposte di integrazione per gli esemplari conservati mutili. Intanto nel 1940egli aveva contribuito con una serie di interventi apparsi su La Civiltà Cattolica, il Bullet-tino della Commissione Archeologica Comunale e la Rivista di Archeologia Cristiana afar conoscere l’importante complesso di iscrizioni dipinte e graffite nel Mitreo rinvenutosolo pochi anni prima sotto la chiesa di Santa Prisca30.
Padre Ferrua non trascurò neppure questioni attinenti alla tradizione epigrafica ma-noscritta, con uno studio sulle provenienze delle lapidi della ex collezione Capponi (inbase ai dati contenuti in un ms. Vaticano)31 e con una serie di contributi nei quali mise afuoco gli interessi epigrafici, in particolare, del sacerdote romano secentesco FrancescoMaria Torrigio32, di Giovanni Zaratino Castellini33 e di Andrea Alciato34, figure molto notedi umanisti del ‘500; dalle carte di quest’ultimo Padre Ferrua poté ricavare dati sulle pro-venienze di parecchie epigrafi romane, mentre da alcuni codici conservati nelle bibliotechedi Roma egli recuperò alcune iscrizioni inedite trascritte dal Castellini, di cui lodò la pre-parazione storico-antiquaria ed epigrafica unita a uno spirito critico raro per i suoi tempi.
Nel 1994 pubblicò il suo ultimo lavoro scientifico sull’epigrafia pagana: la recen-sione ai 3 volumi postumi di G.B. Brusin sulle Inscriptiones Aquileieae35. Continuò invecea scrivere segnalazioni e recensioni in La Civiltà Cattolica quasi fino alla fine della suavita (le ultime dieci sono apparse infatti nel 1998).
Già da questa rapida carrellata dovrebbe emergere la varietà degli interessi di PadreFerrua nel campo dell’epigrafia latina pagana. Per comprendere il significato del suo ap-porto agli studi non dobbiamo dimenticare né i modi spesso fortuiti in cui egli aveva rea-lizzato le sue schede, accumulate nel corso di molti anni e spesso edite a distanza di moltotempo da quando egli aveva eseguito le autopsie, né i tempi in cui Padre Ferrua curò lasua formazione nel campo dell’epigrafia latina pagana, quasi da autodidatta, lavorandodirettamente sui testi e avendo come unico punto di riferimento l’edizione delle iscrizionidi Roma apparsa nel VI volume del CIL a cura della scuola mommseniana, con tutti i suoipregi, ma anche con alcuni inevitabili limiti (l’ultimo supplemento a cura di E. Bang erauscito nel 1933, prima di quelli del tutto innovativi del 1997 e del 2000 curati da G.Alföldy).
Questa premessa è necessaria per capire come mai Padre Ferrua in genere trascri-vesse i testi secondo il vecchio modello del CIL, vale a dire con lettere maiuscole e senzascioglimenti delle abbreviazioni, molto spesso, soprattutto nei contributi più vecchi, senzafoto o con le foto solo dei pezzi più significativi, prediligendo gli apografi, peraltro moltoaccurati, con qualche essenziale riga di commento sugli aspetti salienti dell’onomastica,
29 IHM 1891.30 AE 1940, 75-78.31 LB 25.32 LB 48.33 LB 23, 24.34 LB 65, 66.35 FERRUA 1994.
132
PADRE ANTONIO FERRUA NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 132
del formulario e della datazione. Al termine delle schede epigrafiche, solitamente numerosein ciascun articolo, non mancano notazioni complessive anche di tipo storico, linguisticoe topografico (sui titolari di sepolcri e sulle misure degli stessi) e di storia sociale.
Naturalmente alcuni commenti risentono delle conoscenze del tempo: un esempioper tutti, l’uso spesso improprio del termine colombario per edifici sepolcrali di II sec.,quando ormai è appurato che tale tipologia di sepolcri, con nicchie per riporre le olle dischiavi e liberti, in genere non supera l’età giulio-claudia. Ne consegue anche l’imprecisadatazione proposta per alcune sicure tabelline di colombario, per le quali Padre Ferrua sug-gerisce su base paleografica il II sec.36, mentre la datazione va certamente rialzata al secoloprecedente. Per comprendere poi le difficoltà che Padre Ferrua dovette affrontare nell’iden-tificazione dei testi da lui schedati (talora non si tratta infatti di veri inediti, ma di documentivisti già dagli editori del CIL, magari in uno stato di conservazione migliore: vd. Appendice2), occorre ricordare che a quel tempo non esistevano le attuali banche dati di EDR o Man-fred Clauss, che consentono in pochi secondi di riconoscere un’epigrafe come nuova o comegià edita e che i poderosi volumi di CIL, VI, unico strumento di lavoro a disposizione diPadre Ferrua, dispongono di un indice dei gentilizi e dei cognomi solo dagli inizi degli anniOttanta del secolo scorso, mentre bisognerà aspettare la metà degli anni Settanta per poterusufruire degli utilissimi indici computerizzati di tutte le parole contenute nelle iscrizioni diCIL, VI lemmatizzate nel loro contesto. Era dunque inevitabile che qualche testo, soprattuttose mutilo, da lui ritenuto inedito fosse in realtà già presente in qualche fascicolo di CIL, VI.
Credo che le intenzioni di Padre Ferrua fossero soprattutto quelle di diffondere laconoscenza di testi, rimasti inediti dai tempi del loro ritrovamento. Com’è noto, le iscri-zioni pagane rinvenute in catacomba, per le ragioni che ho detto sopra, vennero spesso ri-mosse dal luogo di ritrovamento e murate negli ambienti esterni o lungo le scale d’accesso,con l’intenzione di separare le iscrizioni pagane da quelle cristiane; le prime finirono cosìspesso per essere trascurate. In buona sostanza non dobbiamo a mio avviso giudicare illavoro di Padre Ferrua nel campo dell’epigrafia pagana secondo il metro con cui oggi noiapprestiamo o giudichiamo l’edizione critica di nuovi documenti epigrafici, per il cui com-mento ormai non possiamo prescindere dalla componente archeologica del contesto d’ap-partenenza, da un’accurata descrizione del supporto iscritto e dei caratteri paleografici,dalla componente filologica e da un’analisi di tutti gli aspetti storico-antiquari presenti neltesto. Elementi che, presi in considerazione complessivamente, potranno poi condurre aun corretto inquadramento cronologico del documento.
L’elevato numero di iscrizioni, spesso per la verità ridotte a frustuli, schedate daPadre Ferrua nell’arco di tanti decenni lo spinse, nei casi da lui ritenuti più disperati omeno significativi, a proporre soltanto un apografo, senza avventurarsi in una trascrizioneche evidentemente doveva apparirgli poco eloquente quando non rischiosa. Sia per questaragione, sia perché effettivamente nei suoi contributi Padre Ferrua pubblicava di volta involta decine e decine di nuovi testi, solo una parte di essi fu poi schedata nel più consultato
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI - PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA
36 LB 45.
133
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 133
repertorio epigrafico ad uso degli studiosi, l’Année épigraphique; molti dei suoi documentinon hanno circolato come avrebbero meritato e rimasero noti solo a coloro che leggevanoe schedavano i suoi lavori a stampa.
Se la maggior parte dei testi da lui editi sono di carattere sepolcrale e si riferisconoa defunti di media o bassa condizione sociale e giuridica (schiavi e liberti), non mancanoanche importanti iscrizioni di carattere sacro e imperiale, nonché frammenti di epigrafiattribuibili a sepolcri di senatori e cavalieri. Molti di essi sono stati ripresi da alcuni deimaggiori epigrafisti dei nostri tempi: in particolare Géza Alföldy nei due recenti volumidi supplemento alle iscrizioni imperiali e senatorie di Roma, Silvio Panciera in varie sedi,John Scheid nella sua recente edizione degli Atti dei Fratelli Arvali37 e Michael Speidel,nel suo corpus generale delle stele degli equites singulares, la guardia del corpo a cavalloche aveva il proprio sepolcreto sulla via Labicana all’altezza delle catacombe dei SS. Mar-cellino e Pietro38. Costoro, talvolta accettando, talvolta migliorando e integrando le letturedi Padre Ferrua, hanno comunque sempre riconosciuto l’importanza del suo lavoro.
In realtà Padre Ferrua dedicò parte delle sue energie pure a iscrizioni d’altre cittàsoprattutto d’Italia: dal suo Piemonte alla Sicilia39, passando per Capua, con il celebretempio di Diana Tifatina e il relativo corredo epigrafico musivo pavimentale attestante la-vori di rifacimento effettuati dai magistri Campani nel 74 a.C. con i proventi della stipe diDiana40, e per la località di Polla, con il suo famoso per quanto problematico elogio, chetanti interrogativi ha sollevato sull’identificazione del console promotore dei lavori stradalida Reggio a Capua41. Il suo fascicolo delle Inscr. It. relativo ad Augusta Bagiennorum ePollentia del 1948 rappresenta tuttavia la sua fatica maggiore42.
In questa sede mi limiterò a presentare alcuni testi di un qualche interesse, selezio-nandoli tra il ricchissimo materiale romano reso noto da Padre Ferrua e che non ha forseattirato finora l’attenzione che meritava. Nell’Appendice 1 Maurizio Giovagnoli riprenderàin esame alcune iscrizioni che non sono state accolte nei principali repertori epigrafici.
Parecchi testi interessanti per un verso o per l’altro si ritrovano in uno dei tanti articolidedicati alle iscrizioni pagane dalla via Nomentana, dove egli riservò una lunga digressioneall’iscrizione, in molti frammenti, di M. Consius Cerinthus, già edita da Dessau su segnala-zione di de Rossi, giungendo alla conclusione che si trattasse di due copie della stessa epi-grafe da riferire alla piccola comunità di Ficulea. Egli aprì così la strada agli ulteriori studidi I. Di Stefano Manzella e di S. Panciera, che hanno consentito di attribuire i frammentistessi a tre esemplari, in cui si ricordava che un edificio, forse ornato di statue, e un porticoerano stati costruiti in memoria di Cerinto che, nella sua veste di accensus velatus, avevaassistito nelle cerimonie religiose non solo gli imperatori Claudio e Nerone, ma anche tutti
37 SCHEID 1998.38 SPEIDEL 1965.39 LB 7, 38, 42, 46.40 LB 20, su cui da ultimi vd. BATINO 1996 (AE 1996, 429) e POBJOY 1997 (AE 1997, 316).41 CIL, X 6950 cfr. p. 1019 = CIL, I2 638 cfr. pp. 725, 833, 922 = ILLRP 454 = Inscr. It., III, 1, n. 272: LB 19 su cui vd. con
altra bibliografia SUSINI 1997, pp. 393-408; FRANCIOSI 2002 e da ultimi CANALI DE ROSSI 2007, pp. 231-235, che identifical’autore dell’elogium con Cn. Pompeius Magnus, e DONATI 2009, pp. 75-79, che pensa piuttosto a P. Popillius Lenas consoledel 132 a.C.
42 Vd. il contributo di G. MENNELLA contenuto in questo volume.
134
PADRE ANTONIO FERRUA NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 134
gli altri consoli che si trovarono ad inaugurare le feriae latinae dal 27 fino agli ultimi annidi Nerone43.
Nello stesso contributo merita di essere ricordata anche l’iscrizione inedita vistada Padre Ferrua nella catacomba di S. Alessandro di un cavaliere o più probabilmente diun senatore (come hanno già riconosciuto gli editori dell’AE), che fu all’inizio della car-riera triumviro capitale o monetale, seviro eq. Rom., tribuno militare della legione XIIIGemina e che non ho ritrovato nel recente supplemento di G. Alföldy a CIL, VI44.
Importante sotto il profilo topografico si rivela il frammento di architrave con men-zione del vicus Longus della regio VI (od. Via Nazionale), riutilizzato nel coemeteriummaius sulla via Nomentana e interpretato da Padre Ferrua come insegna di palazzo o comededica a divinità da parte degli abitanti del vicus stesso45: credo che esso sia piuttosto dainquadrare nel gruppo delle cosiddette dediche compitali di edicole, erette dai magistriprimi del vicus stesso, cioè dai presidenti entrati in servizio al momento dell’istituzioneaugustea dei vici, risalente in linea di massima al 7 a.C.46.
Dal momento che di vari altri frammenti Padre Ferrua diede solo l’apografo, omet-tendo la trascrizione del testo, è sfuggito ai repertori epigrafici il frammento 42 h (dallacatacomba di S. Nicomede sempre sulla via Nomentana), riunito in una tavola collettivadi frammenti di poca o “niuna” importanza o novità e attribuibile invece a un latercolo divigili, riconoscibile per la forma al vocativo dei nomi esclusiva di questo genere di docu-menti (Padre Ferrua pensava piuttosto ad un latercolo di appartenenti a un’associazionefuneratizia composta da schiavi, dei quali s’indicava anche il padrone al genitivo)47.
Tra le iscrizioni di varia provenienza, viste personalmente da Padre Ferrua o recu-perate nelle carte di studiosi precedenti (in questo caso l’Armellini che la notò in un murodi via delle Sette Chiese), segnalo il caso di CIL, VI 37292, data come inedita da Ferrua,ma che era stata schedata da T. Ashby in via delle Sette Chiese prope vineam de Merodee che Padre Ferrua rintracciò anche in una scheda di Francesco Gatti, dove la si dicevacopiata nel muro di cinta della vigna incontro a Tormarancia48. A mia volta ho visto ilpezzo nel giardino di un casale di via delle Sette Chiese (con altri pezzi della collezioneSantambrogio). Nonostante vi si ricordi un sevir equitum Romanorum e un tribunus mili-tum di legione, essa non è stata riconosciuta come senatoria e fu pubblicata nel CIL tra itituli militum; in realtà, se ho inteso bene, essa conserva le tappe iniziali del cursus di unsenatore49 .
Importante anche l’iscrizione metrica di una pantomima ritrovata negli scavi di viadelle Terme di Caracalla e vista da Padre Ferrua nel Museo Nazionale Romano: … saevosAeacidas saltavi, carmen amavi50, mentre per restare nel mondo dello spettacolo è giusto
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI - PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA
43 CIL, XIV 4014; cfr. LB 30, DI STEFANO MANZELLA1994 e PANCIERA, DI GENNARO 2009-2010. In generale sugli accensi vd. DI
STEFANO MANZELLA 2000.44 LB 30, pp. 118-119, nr. 18b (AE 1964, 116). Vd. ora GREGORI 2014.45 LB 30, pp. 134-135, nr. 40 (AE 1964, 126); COARELLI 1999.46 Cfr. su questo problema FRASCHETTI 2008.47 LB 30, pp. 136-137.48 LB 33, pp. 39-40, nr. 43.49 Cfr. GREGORI 2014.50 LB 35, pp. 94-97, nr. 132 (AE 1968, 74). Da ultimo AVETTA 1985, pp. 139-140, nr. 128. Sui protagonisti della scena teatrale
vd. da ultimo con bibliografia precedente GREGORI 2011, pp. 179-194.
135
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 135
ricordare che negli scavi degli anni Sessanta presso la catacomba di Felicita in via Salariasi recuperò l’epitaffio di Aeolus, qualificato come mimologus (attore o compositore dimimi) e come gymneros (= esperto di ginnastica) a sottolineare la sua preparazione atletica,mentre per H. Solin Gymneros potrebbe essere stato il cognome di un altro personaggio oun secondo cognome di Eolo51.
Spostandoci dal mondo del teatro a quello del circo non possiamo trascurare l’im-portante frammento trovato in occasione dei lavori di costruzione del Pontificio IstitutoOrientale, menzionante lavori di restauro ad un edificio sito presso il Circo Massimo effet-tuati da un prefetto urbano di IV o meglio di V sec.52.
Per l’ambito anfiteatrale ricordo, perché è un testo che ha fatto discutere, una lastrinadi colombario appartenuta alla collezione epigrafica di H. Wollmann, ambasciatore tedescopresso la Santa Sede, una parte della quale, rimasta inedita, fu pubblicata da Padre Ferrua:vi si menziona Idumaeus schiavo di Tiberio che si qualifica come maternus e a veste gla-diatoria53. Oggi sappiamo che maternus non era il nome di un secondo personaggio, maun aggettivo usato per indicare che il defunto era appartenuto al gruppo di schiavi che Ti-berio aveva nel 29 d.C. ereditato da sua madre; dato il suo raro nome è facile supporre cheegli avesse fatto parte del contingente servile che Livia aveva a sua volta ereditato da Erodeil grande e da sua sorella Salome (come ha ben dimostrato H. Chantraine). Quanto alle fun-zioni da lui svolte in vita, non si tratterà di un guardarobiere imperiale addetto agli abiti in-dossati dal principe in occasione dei munera gladiatoria, quanto piuttosto di un responsabiledegli abiti da parata sfoggiati dai gladiatori durante la pompa che apriva gli spettacoli.
Spostandoci alla Catacomba di Pretestato sulla via Appia ricordo la rara dedica diuna schola e di una statio erette sulla via Latina da un evocatus in età severiana, forse de-stinata a un corpo di guardia delle milizie urbane piuttosto che a un collegio54.
Stessa provenienza per un frustulo menzionate una statio degli abitanti di Segni55,ma soprattutto devono essere ricordate le seguenti iscrizioni: a) l’epigrafe sepolcrale (riu-tilizzata poi per una donna) di un funzionario imperiale equestre di III sec., con carrieraprima militare e poi palatina che fu tra l’altro procurator ad olea comparanda per regionemTripolitanam56; b) il rarissimo caso di un dispensator della legione terza (uno schiavo im-periale nato nel palazzo con funzioni di tesoriere della cassa militare)57; c) l’epitaffio di unarchimagiro imperiale (vale a dire di un capocuoco), che confermerebbe l’ipotesi dell’esi-stenza in zona di una sede di un collegio funeratizio di cuochi imperiali, con una continuitàdi vita documentata dai numerosi graffiti catacombali fino all’età cristiana58. Qui il liberto
51 LB 63, p. 223, nr. 5 (AE 1990, 104); da ultimo SOLIN 1998, p. 365, nr. 6.52 LB 39, pp. 116-117, nr. 184; CIL, VI 41388. Vd. da ultimo LIVERANI 1999.53 LB 52, p. 29, nr. 10 (AE 1979, 33), ripreso in EAOR, I, 4. Riguardo all’amministrazione degli spettacoli vd. da ultimo GREGORI
2011, pp. 35-39.54 LB 45, p. 67, nr. 8 (AE 1973, 75); CIL, VI 40623. Cfr. GRELLE, SILVESTRINI 2001, p. 107.55 LB 45, p. 68, nr. 10 (AE 1973, 77).56 LB 45, pp. 68-69, nr. 11 (AE 1973, 76); CIL, VI 41295.57 LB 45, pp. 74-75, nr. 21 (AE 1973, 83). Sui dispensatores vd. VULI ’C 1910; AUBERT 1994, pp. 196-199; CARLSEN 1995, pp.
147-158.58 LB 45, 75-77, nr. 22 (AE 1973, 84). In merito alla statio cocorum cfr. MINEO 2001, p. 104 che però non ricorda l’iscrizione
pubblicata da Ferrua; vd. da ultimo SPERA 2004, pp. 26-29. Sulla presenza lungo il tratto iniziale della via Appia di iscrizionirelative a cuochi, capocuochi e structores cfr. ORLANDI 2009.
136
PADRE ANTONIO FERRUA NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 136
Eustathes, parlando in prima persona, usa per indicare i figli l’espressione: eis quos Cae-sari n(ostro) dedi, che non ha confronti se non in un’analoga iscrizione di cuochi, dallastessa zona, già pubblicata nel 1937 da Josi: iis quos ego domino n(ostro) dedi59.
Tra i testi non accolti nell’AE, menziono quello, dalle catacombe di S. Sebastiano,in cui si ricorda un’hydria cum basi, probabilmente da intendere come urna funeraria, se-condo un uso raro, ma non ignoto nell’epigrafia romana (ad es. CIL, VI 15883), assenteperò, a quanto pare, nelle fonti letterarie, dove i riferimenti rinviano a contenitori destinatiall’acqua, al vino, o alla farina60. Non è del resto questo l’unico caso in cui l’epigrafiafornì a Padre Ferrua materiale per l’aggiornamento delle voci del TLL61.
Le ricognizioni in catacomba hanno consentito talora di recuperare sorprendente-mente anche iscrizioni imperiali, sulla cui collocazione originaria è difficile però avanzareipotesi, essendo anche esse state riutilizzate per chiudere loculi. È questo il caso ad es. diuna rara dedica posta dal tribuno e dai centurioni di una coorte delle milizie urbane a dueimperatori, a un Cesare e a un’Augusta, rinvenuta nelle catacombe di S. Ippolito e corret-tamente attribuita al III sec. da Padre Ferrua che individuava i dedicanti nei pretoriani,vista la vicinanza del luogo di ritrovamento con i loro castra62. Ma vorrei ricordare ancheun frammento proveniente dal pavimento di S. Costanza e poi murato lungo lo scalone diaccesso alla chiesa di S. Agnese sulla via Nomentana, interpretato come di natura sacra,mentre si tratterà piuttosto di una dedica a imperatori forse di IV sec.: fundatoribus (?)aeternae pacis e conservatoribus forse imperii Romani o libertatis63.
Non meno importante è il contributo dato da Padre Ferrua all’edizione di sempliciiscrizioni sepolcrali pagane, alcune delle quali comunque importanti per il formulario oper l’onomastica dei personaggi (gentilizi e cognomi in taluni casi rarissimi, quando nonprivi di confronti).
Mi limito a ricordare la dedica dalla catacomba di Commodilla posta dai genitorialla figlia Licinia Clementilla che visse poco più di 5 anni, dove è presente un raro riferi-mento alla sua genesis e un formulario del tutto particolare64. Interessante è anche l’epitaffiodi un bambino di 4 anni, che presenta lo stesso gentilizio Fabricius della madre e che fuiscritto alla Collina, tribù urbana in cui spesso venivano registrati proprio gli illegittimi65.
Degni di nota sono anche i due frammenti della Galleria lapidaria Vaticana, di prove-nienza ignota, riconosciuti nel 1956 da Padre Ferrua come appartenenti allo stesso cippo, incui oltre alla menzione di uno schiavo imperiale dal raro nome africano Abinnerichus, compare
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI - PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA
59 AE 1937, 159.60 LB 47, p. 131, nr. 10; cfr. TLL, VI, 3, 1952, cc. 3133-3134.61 FERRUA 1957; FERRUA 1981; FERRUA 1982; FERRUA 1984; FERRUA 1986.62 LB 51, p. 114, nr. 14; cfr. CIL, VI 40701 con la proposta di attribuzione agli Augusti Valeriano e Gallieno, al Cesare Valeriano
Iunior o Salonino e all’Augusta Cornelia Salonina, piuttosto che a Settimio Severo, Caracalla, Geta e Giulia Domna.63 LB 54, p. 86, nr. 6; CIL, VI 40823: Teodosio e i figli?. Per altre iscrizioni imperiali rinvenute nella medesima zona cfr. FUSCO
2006, p. 108.64 LB 61, p. 183, nr. 6 che è stata immeritatamente omessa in AE: cuius genesis posita est / a parentibus eius / ante mensem VIIII
/ quam nasceretur eam / victuram tempus supras / hor(as) IIII ((semis)).65 LB 62, p. 7, nr. 4: rinvenuto nelle catacombe di Priscilla e menzionato nel giornale degli scavi del 1888/89, Padre Ferrua poté
rintracciare solo un calco conservato presso la Commissione di Archeologia Sacra; oggi sappiamo che l’originale è conservatoad Anacapri nella villa San Michele. A tal proposito vd. inoltre THYLANDER 1962, p. 142, nr. 33; THOMASSON 1997, pp. 45-46,nr. 37.
137
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 137
il servo vicario Prepon impiegato negli horti Serviliani66. D’incerta localizzazione, la loroesistenza fu confermata negli anni a seguire anche da altri documenti epigrafici (pubblicatitra il 1958 e il 1973) rinvenuti negli scavi dell’autoparco Vaticano67.
È opportuno infine ricordare le tabelline di colombario, da lui recuperate nella ca-tacomba tra il primo e il secondo miglio della via Latina, dove erano state riutilizzate e at-testanti l’esistenza nei pressi di un colombario degli schiavi e dei liberti dell’importantefamiglia senatoria degli Scribonii Libones.
Mi rendo conto che quest’esemplificazione è troppo cursoria e non rende sufficientemerito al contributo dato da Padre Ferrua al settore dell’epigrafia pagana. La varietà deitesti da lui, a seconda dei casi, editi, rintracciati, emendati o commentati è però tale che èimpossibile proporre una rassegna esaustiva. Molti documenti, accolti nei grandi repertorie da lì nelle banche dati, sono entrati ormai nel mondo degli studi e contribuiscono a man-tenere vivo il ricordo di questo grande maestro e studioso. Molti sono purtroppo anchequelli sfuggiti, per alcuni dei quali si rinvia all’Appendice 1.
66 LB 21, pp. 613-614 (AE 1958, 278). Sugli Horti Serviliani vd. da ultimo CHIOFFI 1996.67 Vd. AE 1959, 300 (Veneria de hortis Servilianis); VÄÄNÄNEN 1973, nrr. 70, 79 (due servi ex hortis Servilianis), 55 (un Caesaris
servus ex hortis Servilianis atriarius).
138
PADRE ANTONIO FERRUA NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 138
Lista Bibliografica dei contributi di Padre Ferrua sull’epigrafia latina pagana (conesclusione delle semplici segnalazioni bibliografiche e recensioni):
1. Un’opera grande che si rinnova. Le Inscriptiones Italiae, in La Civiltà Catto-lica, 86, 6 (1935), pp. 189-199.
2. Antiche iscrizioni inedite di Roma, in Epigraphica, 1 (1939), pp. 142-150.3. Nuove tracce dell’Apostata a Treviri?, in Epigraphica, 1 (1939), pp. 198-202.4. Il Mitreo di Santa Prisca, in BCom, 68 (1940), pp. 59-96.5. Il Mitreo sotto la Chiesa, in La Civiltà Cattolica, 91, 2 (1940), pp. 354-361.6. Analecta Sicula, in Epigraphica, 3 (1941), pp. 252-270.7. Epigrafia sicula pagana e cristiana, in RACr, 18 (1941), pp. 151-243.8. Analecta romana, I. S. Sebastiano, in Epigraphica, 4 (1942), pp. 41-68.9. Analecta romana, II. S. Sebastiano, in Epigraphica, 5-6 (1943-1944), pp. 3-
26.10. Nuovi frammenti degli Atti degli Arvali, in Epigraphica, 7 (1945), pp. 27-34.11. I Fratelli Arvali e i loro Atti, in La Civiltà Cattolica, 97, 1 (1946), pp. 41-49.12. Tavole lusorie scritte, in Epigraphica, 8 (1946), pp. 53-73.13. Tavole da giuoco, in La Civiltà Cattolica, 98, 1 (1947), pp. 134-142.14. Tavole lusorie scritte, in Epigraphica, 10 (1948), pp. 21-58.15. Inscriptiones Italiae, IX, regio IX, 1, Augusta Bagiennorum et Pollentia, Roma
1948.16. Nuove iscrizioni degli equites singulares, in Epigraphica, 13 (1951), pp. 96-
141.17. Due mausolei da pagani cristiani presso San Sebastiano, in RACr, 28 (1952),
pp. 13-41.18. Iscrizioni inedite della via Latina, in Epigraphica, 16 (1954), pp. 18-34.19. La via romana delle Calabrie. Annia e non Popilia?, in ArchStorCal, 24 (1955),
pp. 237-245.20. Il tempio di Diana Tifatina nella chiesa di S. Angelo in Formis, in RendPontAc,
28 (1954-1956), pp. 55-62.21. Alcune iscrizioni romane con dati topografici, in Studi in onore di Aristide Cal-
derini e Roberto Paribeni, III. Studi di Archeologia e di Storia dell’arte antica,Milano 1956, pp. 607-619.
22. Giovanni Zaratino Castellini raccoglitore di epigrafi, in Epigraphica, 20(1958), pp. 121-160.
23. Giovanni Zaratino Castellini umanista e raccoglitore d’epigrafi, I – Gioventùe studi a Roma, in La Civiltà Cattolica, 90, 2 (1959), pp. 492-501.
24. Giovanni Zaratino Castellini umanista e raccoglitore d’epigrafi, II – Da Romaa Faenza, in La Civiltà Cattolica, 90, 3 (1959), pp. 393-406.
25. Della provenienza di alcune lapidi di Palazzo Capponi, in Epigraphica, 21(1959), pp. 3-12.
26. Nuove iscrizioni della via Ostiense, in Epigraphica, 21 (1959), pp. 97-116.
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI - PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA
139
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 139
27. Il cimitero sopra la catacomba di Domitilla, in RACr, 36 (1960), pp. 173-210. 28. Iscrizioni pagane nelle catacombe di Roma. Via Latina II, in Epigraphica, 23
(1961), pp. 3-21.29. Nuovi frammenti degli Atti degli Arvali, in BCom, 78 (1961-1962), pp. 116-129.30. Iscrizioni pagane nelle catacombe di Roma. Via Nomentana, in Epigraphica,
24 (1962), pp. 106-139.31. Nuove tabulae lusoriae iscritte, in Epigraphica, 26 (1964), pp. 3-44. 32. Iscrizioni pagane delle catacombe di Roma. Ad duas lauros, in Epigraphica,
27 (1965), pp. 127-159.33. Antiche iscrizioni inedite di Roma, in Epigraphica, 28 (1966), pp. 18-49.34. Sillogi d’iscrizioni campane di Francesco Antonio De Tomasi e Francesco Zaz-
zera, in Atti del Convegno di Studi Storici promosso dalla Società di Storia Pa-tria di Terra di Lavoro (1966), Roma 1967, pp. 275-289.
35. Antiche iscrizioni inedite di Roma-II, in Epigraphica, 29 (1967), pp. 62-100.36. Spigolature dalle carte di Alessio Simmaco Mazzocchi, in RendNap, 42 (1967),
pp. 1-32.37. Sopra un carme sepolcrale del Verano, in RendPontAc, 39 (1966-1967), pp.
145-152.38. Osservazioni sulle epigrafi segusine, in Segusium, 4 (1967), pp. 38-52.39. Antiche iscrizioni inedite di Roma-III, in Epigraphica, 32 (1970), pp. 90-126.40. Antiche iscrizioni inedite di Roma. Vigna Codini e Vibia, in BCom, 82
(1970/1971), pp. 71-95.41. Cimitile ed altre iscrizioni dell’Italia inferiore, I, in Epigraphica, 33 (1971),
pp. 99-104.42. Nuove osservazioni sulle epigrafi Segusine, in Segusium, 8 (1971), pp. 42-60.43. Iscrizioni dell’Italia Inferiore II, in Epigraphica, 34 (1972), pp. 131-148.44. Tre antichità nel giardino del Massimo, in Il Massimo, 51, 3 (1972), pp. 2-4.45. Le iscrizioni pagane della Catacomba di Pretestato, in RendLinc, 28 (1973),
pp. 63-99.46. Escursioni epigrafiche nell’Alto Novarese, in Bollettino Storico per la Provin-
cia di Novara, 64 (1973), pp. 3-21.47. Nuove iscrizioni pagane di S. Sebastiano, in RendLinc, 29 (1974), pp. 125-144.48. Iscrizioni antiche viste dal Torrigio, in RStorAnt, 5 (1975), pp. 161-171.49. Antiche iscrizioni di Roma inedite o mal note, in RendPontAc, 48 (1975-1976),
pp. 367-376.50. Nuove iscrizioni pagane di S. Sebastiano, in RendLinc, 33 (1978), pp. 35-56.51. Iscrizioni pagane della catacomba di Sant’Ippolito, in RendPontAc, 50 (1977-
1978), pp. 107-114.52. Lapidi inedite del Pontificio Istituto Biblico di Roma, in RendLinc, 34 (1979),
pp. 27-33.53. Iscrizioni pagane della Catacomba di S. Domitilla, in RendPontAc, 51-52
(1978-1979, 1979-1980), pp. 357-370.
140
PADRE ANTONIO FERRUA NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 140
54. Iscrizioni pagane della Catacomba di S. Agnese, in RendLinc, 35 (1980), pp.85-96.
55. Iscrizioni pagane di Via Nomentana, in RendLinc, 36 (1981), pp. 107-116.56. Iscrizioni pagane nella catacomba di S. Domitilla, in RendPontAc, 53-54
(1980-1981, 1981-1982), pp. 387-402.57. Il complesso cimiteriale di Santa Tecla. II. Le iscrizioni, in RendPontAc, 55-
56 (1982-1984), pp. 421-434.58. Iscrizioni del sepolcreto Ostiense, in RendLinc, 39 (1984), pp. 287-305.59. Nuovi frammenti degli Atti degli Arvali, in RACr, 61 (1985), pp. 255-262.60. Il Suarez e le iscrizioni antiche della Narbonese, in RendLinc, 41 (1986), pp.
207-217.61. Iscrizioni della catacomba di Commodilla, in RendPontAc, 59 (1986-1987),
pp. 181-191.62. Iscrizioni pagane della catacomba di Priscilla, in ArchStorRom, 110 (1987),
pp. 5-19.63. Iscrizioni pagane della via Salaria, in RendPontAc, 60 (1987-1988), pp. 221-
236.64. Iscrizioni pagane della Tuscia romana, in RendPontAc, 61 (1988-1989), pp.
343-352.65. Andrea Alciato e l’epigrafia pagana di Roma, in ArchStorRom, 113 (1990), pp.
209-233.66. Andrea Alciato (1492-1551) e l’epigrafia antica del Lazio, in ArchStorRom,
114 (1991), pp. 101-116.67. Nuove iscrizioni pagane di S. Sebastiano, in RendPontAc, 63 (1990-1991), pp.
263-277.68. Iscrizioni del lapidario Armellini, in RACr, 69 (1993), pp. 129-159.69. Tavole lusorie epigrafiche. Catalogo delle schede manoscritte. Introduzione e
indici a cura di MARIA BUSIA, Città del Vaticano 2001.
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI - PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA
141
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 141
* Desidero ringraziare le dottoresse BARBARA MAZZEI e AGNESE PERGOLA che mi hanno aiutato nella ricerca delle immagini fo-tografiche contenute nell’archivio della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Fondamentale è stata l’opera di revisione,finalizzata all’Appendice 2, compiuta dall’amico GIORGIO CRIMI.
1 LB 45, pp. 65-66, nr. 3; EDR101894 .2 LB 45, p. 66, nr. 4 (CIL, VI 40532); pp. 66-67, nr. 7 (CIL, VI 40624); pp. 67-68, nr. 8 (CIL, VI 40623); p. 66, nr. 6 (CIL, VI
40658); p. 66, nr. 5 (CIL, VI 40305). Da notare inoltre come dell’articolo pubblicato in LB 45 ben 52 iscrizioni sono confluitein AE 1973, 72-154.
3 L’iscrizione viene menzionata nella voce della Prosopographia Imperii Romani: PIR2, M 467. Successivamente viene presa inconsiderazione solamente da DEVREKER 1984, p. 669; CHIOFFI 1991, p. 340; FORNI 2007, p. 856, nr. 445.
4 Stessa sorte ha avuto anche l’iscrizione CIL, VI 1350 del clarissimus puer Aquilinus ( PIR2, A 984) che probabilmente dovevaavere in questa area il suo sepolcro. Vd. a tal proposito MINEO 2001, p. 105. Riguardo alle iscrizioni pagane rinvenute nella ca-tacomba di Pretestato vd. SPERA 2004, pp. 22-23.
5 PIR2, M 467; vd. da ultimo MASIER 2009, pp. 228-229.6 RÜPKE 2005, p. 1149, nr. 2431.7 Riguardo alle proprietà della famiglia dei Memmii Reguli, sappiamo che il padre P. Memmius Regulus ne aveva una ad Ariccia
(CIL, XIV 2174 = CIL, XV 7842). Cfr. ANDERMAHR 1998, pp. 337-338.
142
APPENDICE 1*
Come è stato scritto in precedenza, padre Ferrua ha avuto il grande merito di far co-noscere e pubblicare un numero considerevole di iscrizioni pagane; di queste, molte sisono rivelate particolarmente utili per gli studi in vari ambiti delle antichità romane e gre-che. Durante l’opera di schedatura dei contributi dello studioso sono emersi alcuni docu-menti di indubbia rilevanza che, non essendo confluiti nell’Année épigraphique,potrebbero essere sfuggiti alla comunità scientifica. Si è quindi ritenuto opportuno ripro-porre in questa sede le epigrafi più significative.
1. Iscrizione frammentaria (27 x 87 x ?; lett. 10) rinvenuta nella catacomba di Prete-stato, menzionante C. Memmius Regulus, console del 63 d.C. (Fig. 1)1. Vi si legge:
C(aio) Memmio P(ubli) f(ilio) / Gal(eria) Regulo / - - - - - -
Nella breve scheda, priva di foto, Ferrua nota la sommaria scalpellatura di parte delledue righe del testo ed evidenzia il dato nuovo offerto dal documento, la registrazione diun membro della famiglia dei Memmii nella tribù Galeria. In seguito l’epigrafe, al con-trario di altri documenti pubblicati nello stesso contributo2, non è confluita né in AE nésuccessivamente nel volume di supplemento alle iscrizioni senatorie di Roma curato daG. Alföldy3.
Nonostante la frammentarietà dell’iscrizione, riutilizzata per chiudere un loculo nellacatacomba, diversi sono i motivi di interesse4. Tralasciando per il momento la menzionedella tribù, su cui si tornerà in seguito, è opportuno innanzitutto sottolineare come l’epi-grafe costituisca una delle poche attestazioni di C. Memmius Regulus, figlio del più notoP. Memmius Regulus console del 31 d.C.5. In considerazione dell’altezza delle lettere (10cm) si può supporre la natura funeraria dell’iscrizione che, dopo la formula onomastica,doveva probabilmente proseguire con il cursus del personaggio, di cui conosciamo soloil consolato e la carica di magister dei sodales Augustales6. Purtroppo non è invece pos-sibile capire se sulla via Appia fosse presente il solo sepolcro oppure se quest’ultimofosse inserito all’interno di una proprietà di C. Memmius Regulus comprendente ancheuna villa7.
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 142
8 CHIOFFI 2005a, p. 127; CHIOFFI 2005b, p. 216. Cfr. inoltre CHIOFFI 2005c.9 CIL, XV 7564a-b. Sulla topografia dell’area cfr. SPERA 2004, pp. 9-11. Per altri casi di presunte proprietà entro il III miglio
della via Appia vd. CHIOFFI 2003, pp. 453-460.10 AE 1967, 67; BRANDIZZI VITUCCI 1983, pp. 72-73 e da ultimo ANDERMAHR 1998, pp. 337-338. 11 BRANDIZZI VITUCCI 1983, p. 72.12 SOLIN 2001, p. 417.13 BRANDIZZI VITUCCI 1983, pp. 15-20.14 CIL, VI 30861 su cui vd. da ultimo BIANCHI 2008, pp. 29-30.15 CHIOFFI 2005c, pp. 107-110.16 Un altro possibile caso di reperto non proveniente dalla Tenuta della Falcognana è costituito dal cippo funerario posto da
Orfitus e Piso, identificati con i consoli del 175 e 172 d.C., a Cornelia Cethegilla. Quest’ultimo potrebbe provenire dall’areatra il III e il IV miglio della via Appia dove tre dediche sacre attestano il praedium alla fine del III d.C. di L. Cornelius ScipioOrfitus (su cui da ultimo vd. GRANINO CECERE 2004). Il cippo proverebbe che la famiglia dei Cornelii Scipiones Orfiti era giàin possesso della proprietà nel II d.C. Per quest’ultima ipotesi cfr. ANDERMAHR 1998, p. 242.
143
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI - PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA
Gli studi relativi alle proprietà residenziali dell’ordine equestre e senatorio hanno permessodi stabilire come forte criterio identificativo per la loro localizzazione una distanza non infe-riore a 5/6 km tra il luogo di rinvenimento dell’iscrizione e le mura Aureliane8. Ma anche sel’iscrizione provenisse dalla zona della catacomba di Pretestato, situata tra il II e il III migliodella via Appia, si potrebbe comunque pensare a una proprietà del console con annesso se-polcro. Infatti nella valle della Caffarella (I-III miglio) erano situate numerose ville tra cui adesempio quella del consolare Q. Vibius Crispus, curator aquarum nel 68-71 d.C.9.
Nel tentare di individuare la proprietà e il sepolcro del senatore è opportuno prenderein considerazione anche l’urna conservata nel Casale della Falcognana, ubicata tra il quat-tordicesimo e il quindicesimo chilometro della via Ardeatina, dedicata da un C. MemmiusRegulus al non altrimenti noto amico Cn. Pompeius Paulus10. Quest’ultimo, oltre a riceverel’urna, potrebbe anche essere stato sepolto all’interno della proprietà del nostro console.
La mancata menzione di cariche da parte dei due personaggi, probabilmente dovuta“alla familiarità del rapporto” tra i due11, ha fatto pensare che in realtà si trattasse di unsemplice omonimo del senatore12. Tale coincidenza onomastica rientrerebbe nella ten-denza, abbastanza ristretta, di riprendere il nome completo (o almeno il gentilizio e ilcognome) di personaggi illustri da parte di plebei. Tuttavia proprio l’iscrizione riutiliz-zata nella catacomba di Pretestato, che attesta a non molta distanza almeno un monu-mento funebre di C. Memmius Regulus, sembrerebbe rendere meno probabile questaseconda ipotesi.
Riguardo all’individuazione della proprietà, l’urna non sembra poter fornire elementinuovi dal momento che non si hanno dati certi sulla sua provenienza. Questa infatti faparte della collezione Lanza, costituita da reperti di diverso genere che sarebbero stati rin-venuti soprattutto tra il 1900 e il 1930 nel corso di lavori agricoli all’interno del casale13.Tra le iscrizioni assumono, nel nostro caso, particolare risalto un termine confinario e unafistula che testimoniano la presenza di un secondo praedium di proprietà della gens Rutilia,oltre a quello già noto tra il II e il III miglio della via Appia, dove fu rinvenuta in situ unabase con dedica sacra a Diana da parte di Rutilia Pollitta14. L. Chioffi, proprio per l’incer-tezza legata ai materiali rinvenuti nella tenuta della Falcognana, ha supposto che il terminuse la fistula possano provenire in realtà dalla proprietà all’inizio della via Appia15. Non sipuò quindi escludere che, come questi ultimi reperti, anche l’urna sia stata rinvenuta neipressi della catacomba di Pretestato16.
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 143
17 Su questo aspetto vedi GIOVAGNOLI 2014. 18 FERRUA 1955, pp. 165-166; EDR000819 e EDR000820. Successivamente l’iscrizione cristiana è stata pubblicata in ICUR, V
15328. Su questa catacomba vd. da ultimo SPERA 1999, p. 182 nr. UT310.19 FERRUA 1955 ipotizza anche che la I potesse far parte della formula in pace.
144
PADRE ANTONIO FERRUA NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE
Un altro motivo di interesse dell’iscrizione, come sottolineava lo stesso Ferrua, è lamenzione della tribù di appartenenza di C. Memmius Regulus e di conseguenza del padreP. Memmius Regulus, figura di rilievo nell’éntourage degli imperatori giulio-claudi. Diquest’ultimo sappiamo con sicurezza che fu console nel 31 d.C., ricoprendo un ruolo fon-damentale nella caduta di Seiano; dal 35 al 44 fu governatore di Mesia, Macedonia e Acaia;successivamente fu proconsole d’Asia e morì nel 61 d.C. Numerose sono le incertezze re-lative al suo cursus honorum e alla sua origine. Riguardo a quest’ultima, proprio l’iscri-zione di C. Memmius Regulus alla tribù Galeria consentirebbe di escludere una suaprovenienza dalla Gallia Narbonese e indurrebbe a pensare all’Italia come possibile suoluogo di origine17. L’iscrizione è databile alla seconda metà del I d.C., non essendo notala data di morte del console del 65 d.C.
2. Lastra opistografa (26 x 70 x 3) trovata nel cubicolo di una catacomba situata a circa50 m dalla catacomba della Santa Croce, lungo la via Appia18 (Fig. 2). Il supporto,che originariamente ospitava l’iscrizione di un liberto imperiale, fu tagliato e reim-piegato come chiusura di un loculo. Appartenente a questa seconda fase di utilizzoè l’epigrafe cristiana con il solo nome del defunto LEOI, da interpretare come Leono come forma errata del dativo Leonti19, e il graffito con la scritta Gaudenti, proba-bilmente il cognomen di un altro personaggio sepolto. Da notare inoltre il ricco ap-parato iconografico costituito da due graffiti: il primo raffigurante un calice colmodi liquido che viene versato in un vaso quadrato e un uccello che beve sotto, il se-condo caratterizzato dalla rappresentazione di un volatile che becca un grappolod’uva.
Sicuramente più complessa è invece l’iscrizione originaria del liberto imperiale, di cuipadre Ferrua propose la seguente trascrizione (Fig. 2):
Maurus Aug(usti) lib(ertus) tab(ularius) rat(ionis) - - -] / fecit se bibo hunc cubic[ulum- - - et] / Aquilinae uxori d[ulcissimae - - -] / quae vixit sine q[uerela mecum annis - - -].
Proporrei invece d’integrare:
Maurus Aug(usti) lib(ertus) tab(ularius) ra[t(ionis) patrimon(ii)?] / fecit se bibo hunccubic[ulum sibi et] / Aquilinae uxori d[ulcissima(e)] / quae vixit sine q[uerela].
Il dedicante dell’iscrizione è il liberto imperiale Maurus che fa realizzare un cubiculumper sé e per la moglie Aquilina. Quest’ultimo ricoprì l’incarico di tabularius, un archivistache svolgeva diversi compiti al servizio di una ratio, forse in questo caso la grande segre-teria centrale che gestiva i beni dell’imperatore (ratio patrimonii). Infatti la menzione di
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 144
20 Cfr. ad esempio AE 1979, 98 (ratio chartaria); CIL, VI 8528 (ratio castrensis); CIL, VI 8477 (ratio fisci frumentarii). Non sipuò tuttavia escludere la ratio hederitatium (cfr. CIL, VI 8438; XIV 2262).
21 FERRUA 1955 p. 166.22 LB 49, pp. 372-373 (AE 1978, 45); EDR076905.23 LB 49, p. 372.24 Cfr. ad esempio CIL, VI 3572 e CIL, XIV 162. La menzione della praefectura fabrum non sembra essere stata sempre un ele-
mento contraddistintivo del rango equestre. Su questa prefettura vd. con bibliografia precedente CERVA 2000.25 Con questo prenome e gentilizio conosciamo solo il prefetto d’Egitto d’epoca neroniana Ti. Claudius Balbillus (PIR2, C 813)26 Vd. a tal proposito AMELOTTI 1966, pp. 209-215.27 SOLIN 1996, p. 166. 28 SOLIN 1996, pp. 445-446.
145
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI - PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA
quest’ultima ratio, in forma abbreviata, è giustificata dall’impaginazione, che prevede unallineamento ad asse centrale e righe che si ristringono verso il basso e che fa escludere lapresenza di altre rationes quali quella chartaria, castrensis o fisci frumentarii che sonosempre ricordate per esteso20.
Ferrua, sulla base del formulario, data l’epigrafe non oltre il III d.C., ipotizzando cheanche questa fosse cristiana e che fosse stata posta a chiusura dello stesso cubicolo dovepoi sarebbe stata riutilizzata21. In realtà proprio il taglio del supporto farebbe escluderetale ipotesi. La paleografia inoltre, con lettere di modulo quadrato, permette di datare l’i-scrizione al II d.C. Alla luce di ciò occorre evidentemente riconsiderare la cronologia del-l’ipogeo che non si può basare sulla nostra epigrafe, nella quale manca qualsiasi indiziodi cristianità.
3. Nel corso di scavi compiuti negli anni 70 del secolo scorso all’interno del complessoCallistiano, a sinistra subito dopo il Quo Vadis?, furono rinvenute alcune iscrizioni,tra cui una sulla fronte di una base (Fig. 3)22. Ferrua, nel descriverla, notò la presenzasulla faccia superiore di fori per il fissaggio di una statua. La natura del testo (vd.infra) permette di riconoscere nella base il supporto di una statua probabilmentecollocata all’interno di un sepolcro. Presento la seguente proposta di trascrizione:
Ti(berio) Claud(io) [- - -] / praefec[to - - -] / ex codicil[lis eius - - -?] / Calam[us - - -et] / Aba[scantus - - -?].
L’iscrizione, secondo l’opinione di Ferrua, sarebbe stata posta in onore di un liberto diClaudio che aveva fatto carriera23. Tuttavia la presenza alla seconda riga di una prefetturaesclude di fatto la condizione libertina del defunto. Riguardo a tale carica, si può supporreche il nostro personaggio, probabile discendente di un liberto imperiale, sia riuscito a di-ventare praefectus fabrum o praefectus cohortis conseguendo verosimilmente la dignitàequestre24. Meno probabile che venisse ricordata una delle grandi prefetture presenti aRoma (annonae, vigilum….)25. L’iscrizione si chiudeva con i nomi di coloro che, seguendole volontà testamentarie del defunto (ex codicillis), avevano fatto realizzare la statua26;considerando la lacuna, a destra doveva essere ricordato alla terza riga verosimilmente,oltre a Calamus27 e Abascantus28, anche un terzo individuo, tutti in base all’onomasticaprobabilmente liberti del nostro personaggio.
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 145
29 LB 63, p. 228, nr. 14; EDR000941. Altre iscrizioni provenienti dalla catacomba di S. Felicita erano state pubblicate da FERRUA
1969.30 Sulla cymbalistria vd. POTTIER 1887; TLL, IV, 1906-1909, cc. 1588-1589; DE RUGGIERO 1910.31 CIL, V 519; VI 2254 su cui da ultimo SOLIN 1989, pp. 226-228; CIL, X 1538.32 Cic., Pis., X, 22.33 LB 61, pp. 187-189.34 LB 61, p. 189, nr. 29; EDR015656. Sulla presenza di membri del nucleo familiare in iscrizioni menzionati soldati cfr. PANCIERA
2006, pp. 1441-1452.
146
PADRE ANTONIO FERRUA NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE
Da evidenziare infine come la foto abbia permesso di interpretare correttamente l’ul-tima riga dove, sulla base dell’apografo, lo spazio tra la lettera B e A aveva in passato fattoescludere la presenza di un elemento onomastico. La paleografia permette di datare l’i-scrizione nel I d.C.
4. Iscrizione frammentaria (13 x 15 x 2; lett. 3) rinvenuta durante gli scavi del 1967-1968 all’interno della catacomba di S. Felicita (Fig. 4)29. Il testo recita:
- - - - - - / [- - -]TAE AV[- - -] / [- - - cy]mbalist[ria - - -] / - - - - - -
Nonostante la frammentarietà, l’iscrizione si contraddistingue per la menzione di unacymbalistria, suonatrice di uno strumento a percussione di origine orientale (cymbala) si-mile ai piatti moderni30. Si tratta di una delle rare attestazioni epigrafiche di questo me-stiere, in tutto quattro, di cui un’altra proveniente da Roma, connesse con il culto dellaMagna Mater31. Oltre all’ambito religioso, occorre comunque tener presente che il cembaloera impiegato anche in contesti privati quali i banchetti32. La paleografia, con la A privadi traversa, suggerisce una datazione al III d.C.
5. Un caso particolare è sicuramente offerta dal gruppo di sei epigrafi pubblicate daFerrua in base a un appunto preso da Augusto Bevignani, ispettore della Commis-sione di Archeologia Sacra dal 1896 al 1913, che le aveva viste nella catacomba diCommodilla33. Queste ultime però non erano state rintracciate successivamente néda Marucchi, durante le ricognizioni nel 1904-1905, né da Ferrua, che proprio perquesto motivo non era del tutto sicuro di quella provenienza. Tra le iscrizioni meritasicuramente attenzione l’epigrafe (12 x 50 x 3) posta da un soldato della coorte de-cima urbana alla figlia Iulia Secunda34:
D(is) M(anibus). / Iuliae Secundae que (!) vixit ann(os) III, m(enses) XI, / dies X /Iul(ius) Domit(ius) Secundianus mil(es) coh(ortis) X urb(anae) fil(iae) carissimae.
Da notare, oltre alla monottongazione del dittongo AE nel pronome relativo, l’onoma-stica del dedicante con la presenza di due gentilizi, entrambi abbreviati, e la mancanza dipraenomen. Quest’ultimo elemento, insieme alla paleografia, consente di datare l’iscri-zione al III d.C.
Il dato nuovo è costituito dal ritrovamento dell’iscrizione che è murata nell’atrio diuna abitazione situata a Cervaro, vicino a Cassino. A darne notizia fu nel 1973 Antonio
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 146
35 GIANNETTI 1973, pp. 472-473 (AE 1973, 177).36 LB 61, p. 189 nr. 32; MAINARDIS 2004, pp. 147-148, nr. 80 (AE 2005, 269).37 MAINARDIS 2004, p. 148.38 LB 26, pp. 97-98; EDR006578.39 Sui vigiles vd. RAMIERI 1996, pp. 38-53 e SABLAYROLLES 1996.40 CIL, VI 2983.41 SABLAYROLLES 1996, p. 348, nota 85.
147
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI - PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA
Giannetti che pubblicò l’epigrafe all’interno di un contributo relativo a nuovi documentiprovenienti dalla Campania e dal Latium Adiectum. Lo studioso però a causa dello statodi conservazione della lastra, che era stata nel frattempo divisa in due parti non combacianti(12 x 20 x 3; 12 x 16 x 3), suggerì di identificare il dedicante con un praetor urbanus,senza tuttavia escludere l’ipotesi di un urbaniciano (Fig. 5)35. Proprio tale lettura proba-bilmente non permise in seguito a Ferrua di collegare il testo di Cervaro, fortemente mutiloal centro, con l’iscrizione vista da Bevignani nella catacomba di Commodilla.
Oltre al documento in esame, è stata rintracciata anche un’altra iscrizione, appartenentesempre allo stesso gruppo e conservata al Museo di Storia e Arte di Trieste36. Si tratta diun’epigrafe funeraria, posta da Aelianus alla compagna Afrodisia, per la quale, a causadella mancanza di notizie relative al rinvenimento e all’acquisizione da parte del Museo,non era stata esclusa un’origine urbana37.
Alla luce di questi nuovi dati, è possibile ipotizzare che le iscrizioni, copiate da AugustoBevignani e non rintracciate da Ferrua, fossero probabilmente conservate nella catacombadi Domitilla prima di finire sul mercato antiquario.
6. Nella vigna Villani, situata all’imbocco di via delle Sette Chiese, venne scoperto unsepolcro al cui interno furono rinvenute diverse iscrizioni tra cui la seguente (Fig. 6)38:
D(is) M(anibus). / Q(uinto) Vibuleno / Aruntiano (!), mil(iti) / coh(ortis) IIII vig(ilum),vixit / ann(is) XXI; mil(itavit) ann(is) V, / m(ensibus) II; posuerunt / benemernti (!) et sibi/ Maniaca Ursilla / mater et Rullia / Vitalis et Flavius / Niceros.
Da notare i numerali soprallineati, ad eccezione del XXI, e la presenza di alcuni erroricommessi dal lapicida: alla r. 3 incise Aruntiano invece che Arruntiano, alla r. 7 benemerntiinvece che benemerenti; diverso il discorso alla r. 10 dove viene corretta l’errata incisioneFlavias in Flavius.
L’epigrafe viene posta in onore di Q. Vibulenus Arruntianus che morì a ventuno anni,dopo aver militato cinque anni e due mesi nella coorte IV dei vigili39. Queste due infor-mazioni consentono di approfondire le nostre conoscenze legate all’età dell’arruolamento,che mediamente riguardava i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 23 anni. In passatosi considerava come soglia minima i 17 anni, dando scarsa credibilità a un’iscrizione fu-neraria in cui era ricordata un M. Vigellius Primus morto a venti anni dopo aver militatosei anni e sei mesi nella coorte V dei vigili40. L’età di arruolamento di quest’ultimo, cheoscillava tra i 14 e i 15 anni, non era ritenuta possibile da Sablayrolles che pensava piut-tosto a un errore del lapicida, che avrebbe inciso un sei al posto di un tre41. Tale ipotesi
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 147
42 Sulla condizione dei vigili cfr. SABLAYROLLES 1996, pp. 178-181.43 KAJANTO 1965, p. 141; SOLIN 1996, p. 12.44 CIL, VI 1056 cfr. pp. 3071, 3777, 4320. Per le altre attestazioni del gentilizio Vibulenus vd. CIFANI 1992, p. 231. A queste oc-
corre aggiungere il Q. Vibulenus Agrippa menzionato in qualità di decurione nel senatus consultum di Copia / Thurii, forse daidentificare con il cavaliere suicidatosi durante un processo nel 33 d.C. Su quest’ultima ipotesi vd. COSTABILE 2008, pp. 134-135.
45 CIL, V 995 cfr. p. 1025; I. Aq. 525; ILS 6687.46 FELLETTI MAJ 1947, pp. 80-81, nrr. 7-8 (AE 1951, 173); EDR005028 e EDR073820.47 LB 30, pp. 120-121 (AE 1964, 117).48 FELLETTI MAJ 1947, p. 81, nr. 8 legge erroneamente alla seconda riga Anni ab Patavio.
148
PADRE ANTONIO FERRUA NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE
non sembra più sostenibile, soprattutto se prendiamo in considerazione il caso del nostroArruntius che divenne vigile a 15/16 anni. L’arruolamento quindi riguardava anche giovanidi 15 anni.
Il defunto presenta un’onomastica priva di filiazione che non fa necessariamentepropendere per una sua condizione libertina; infatti già dal II secolo d.C. erano presentiingenui all’interno delle coorti dei vigili42. Il gentilizio del personaggio, così come ilcognomen Arruntianus43, è poco diffuso ed è particolarmente raro a Roma dove è atte-stato solamente in altre tre iscrizioni, tra cui la base posta nel 205 a Caracalla dallacohors I vigilum in cui compare il cornicularius Vibulenus Mercurius che potrebbe es-sere parente del nostro personaggio44. Ancor più raro è invece il gentilizio della madreche offre come unico confronto l’epigrafe proveniente da Aquileia dove però Maniacusè cognomen45.
Non è possibile invece individuare il tipo di legame che univa il destinatario dell’i-scrizione e i due dedicanti menzionati dopo la madre, Rullia Vitalis et Flavius Niceros. Inbase all’assenza di praenomen nell’onomastica di quest’ultimo e tenendo presente la pa-leografia dell’iscrizione, il documento è databile alla fine del II d.C.
7. Nel corso del marzo del 1938 in via Cheren, un traversa di via Nomentana, venneroportati alla luce alcuni reperti archeologici tra cui due stele funerarie appartenute aun eques della III coorte pretoria46. Ferrua nel 1962 riprese in considerazione le dueepigrafi, correggendo in un caso la lettura sbagliata data dal primo editore47. Vengonoriportate di seguito le trascrizioni delle due iscrizioni, di cui solo la prima è confluitanell’AE (Figg. 7-8):
(A) L(ucius) Calpurnius / An(ni) f(ilius) Fab(ia) Patavio / eques cohor(tis) III / pr(ae-toriae)48.
(B) L(uci) Calpurni / Anni f(ilius) Fab(ia). / ((quadrati)) pedes XII.
Si tratta di due stele appartenenti all’area sepolcrale di L. Calpurnius di cui nel testoA si specifica sia la città natale, Padova, che la sua appartenenza al corpo dei pretoriani inqualità di eques. Non vengono invece indicati né il nome del centurione che era a capodella coorte III, di cui faceva parte, né soprattutto gli anni di militanza e di vita vissuti,possibile segno della realizzazione dell’area quando ancora il nostro personaggio era in
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 148
49 RICCI 1994, p. 16.50 SCHULZE 1966, p. 519.51 In merito alla misura abbastanza comune di piedi12 x 12 dell’area funeraria, cfr. GREGORI 2005.52 Cfr. ad esempio AE 1991, 129 e AE 1991, 109 su cui da ultimo GIOVAGNOLI 2012. In merito alla struttura dei testi vd. GREGORI
2005, pp. 85-88.53 Per una caso simile vd. i due cippi dell’area sepolcrale di Fabius Niceros (FRIGGERI - PELLI 1980, pp. 118-119, nr. 22a; CIL,
VI 35204).54 CIL, VI 2491, 2585, 2613 e 32649.55 Per le altre attestazioni di questa formula, espressa in alternativa con la formula in quadrato pedes e principalmente diffusa
tra la fine della Repubblica e l’inizio dell’Impero, vd. GREGORI 2005, p. 89, nota 117 (tale formula si protrae fino al II d.C. masu altri tipi di supporto: vd. ad es. MELLACE 2001, p. 304, nr. 270).
56 Vd. a tal proposito DI STEFANO MANZELLA 1987, p. 156.57 Vd. ad esempio il caso del pistor proveniente dalla catacomba di Domitilla (p. 82 del manoscritto) pubblicato in LB 56, p.
401.
149
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI - PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA
vita49. Riguardo alla sua onomastica, occorre evidenziare la mancanza del cognomen e lapresenza nella filiazione del raro praenomen Annius50.
Il motivo principale di interesse è però costituito dal rinvenimento di una secondocippo (testo B) in cui compare, dopo l’onomastica del defunto al genitivo, la misura del-l’area funeraria (12 piedi x 12 piedi)51. Si tratta dell'unico caso ritrovato di un secondosupporto iscritto che delimitasse l’area di sepoltura di un pretoriano; se inoltre si prendonoin considerazione i casi in cui sono stati trovati più esemplari dello stesso terminus sepul-cri, si può facilmente notare come questi rechino di norma il medesimo testo, con al mas-simo alcune varianti52. Qui invece le due stele presentano solo la formula onomastica incomune53.
Il testo B infatti si contraddistingue per la misura dell'area funeraria, elemento che ri-troviamo solo in altri quattro cippi/stele di pretoriani rinvenute a Roma54. Quest'ultima èper giunta espressa tramite l’inusuale formula quadrati pedes con la quale si indicava un'a-rea che occupava lo stesso spazio sul fronte stradale e sul lato interno. A differenza peròdegli altri casi55, occorre evidenziare la scelta del tutto originale del lapicida che sostituiscela parola quadrati con un “poligono quadrilatero, simile a un rettangolo poggiato sopra unlato lungo”56.
In base alla tipologia del supporto, all’onomastica del defunto priva di cognomen ealla paleografia è possibile datare le due iscrizioni nella prima età imperiale.
8. Padre Ferrua ha lasciato alla Biblioteca Apostolica Vaticana un manoscritto conte-nente un gruppo di iscrizioni rinvenute nelle varie catacombe di Roma e che, inquanto ritenute pagane, non erano confluite nella pubblicazione dei diversi volumidelle ICUR. L’intento dello studioso era quello di permettere ad altri di pubblicarei testi a cui, per sua stessa ammissione, non poteva dedicarsi. Tuttavia alcune epigrafivennero in seguito pubblicate dallo stesso Ferrua 57, mentre il resto, forse per laframmentarietà dei pezzi, non fu oggetto di alcuna edizione. Si tratta perlopiù difrustuli principalmente riconducibili a epigrafi sepolcrali che, nonostante i precisiapografi accompagnati dalle misure del supporto, non possono nella maggioranzadei casi essere integrati.
Non manca tuttavia qualche eccezione, come il frammento di un’epigrafe, mutila datutte le parti ad eccezione che in basso (30 x 31 x 3; lett. 4) rinvenuto nella catacomba
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 149
58 Si ringrazia il dott. MARCO BUONOCORE che ha consentito la consultazione del manoscritto FERRUA. Sulla catacomba di Do-mitilla vd. da ultimo PERGOLA 2004. Sulle epigrafi provenienti dalla catacomba di Domitilla cfr. A. FELLE, La documentazioneepigrafica della catacomba di Domitilla a Roma alla luce dell'Epigraphic Database Bari: nuovi elementi di riflessione, in13th International Congress of Greek and Latin Epigraphy, Oxford, 2nd-8th September 2007 (pubblicazione on line: http: //ciegl.classics.ox.ac.uk/html/webposters/30_Felle.pdf], settembre 2007).
59 Vd. a tal proposito GUNDEL 1953; KAJANTO 1971, pp. 12-15; CHASTAGNOL 1988, pp. 35-36.60 L’altro caso è rappresentato da CIL, VI 36911 cfr. p. 4352.
1 Cfr. già GREGORI 2004.2 Cfr. già SPEIDEL 1994, nr. 705.3 Cfr. già SOLIN 1998, p. 65.
Do-one, in
p: //
- -
150
PADRE ANTONIO FERRUA NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE
di Domitilla e più precisamente in uno dei nuclei presenti nel II piano, e databili all’etàseveriana o non più tardi della prima metà del III d.C.58. Il testo dell’iscrizione recita:
- - - - - - / [- - - devot- num]ini maiestati[que - - -].
Nonostante la frammentarietà del testo, si può riconoscere nell’epigrafe la parte finaledi una dedica imperiale in base alla formula devotus numini maiestatique eius o eorumcon la quale si evidenziava il carattere divino e l’auctoritas dell’imperatore59. Tale formulaè attestata dall’età severiana fino al VI d.C., arco di tempo in cui può essere quindi collo-cata cronologicamente l’iscrizione. L’esiguità del pezzo e la mancanza di una foto nonconsentono di ricavare maggiori informazioni. Si tratta in ogni caso della seconda iscri-zione proveniente dall’area della catacomba di Domitilla riguardante la casa imperiale60.
APPENDICE 2
Di seguito viene riportato un elenco delle iscrizioni edite da Padre Ferrua come ineditee che invece si sono rivelate già presenti nei volumi del CIL o altrove:
PUBBLICAZIONE FERRUA ANNÉE ÉPIGRAPHIQUE PRIMA PUBBLICAZIONE
LB 2, nr. 2 AE 1940, 83 CIL, VI 3898 = 32707aLB 6, nr. 35 AE 1982, 418 CIL, VI 28913LB 22, nr. 8 AE 1961, 114 CIL, VI 1846 = 37140aLB 22, p. 146 AE 1961, 117 CIL, VI 2551LB 26, p. 1011 AE 1962, 156 CIL, VI 13822LB 30, nr. 26 AE 1964, 118 CIL, VI 2790LB 30, nr. 38a CIL, VI 18854LB 32, nr. 252 AE 1966, 31 CIL, VI 19147LB 33, nr. 4 AE 1967, 32 CIL, VI 10018LB 33, nr. 14 CIL, VI 10337LB 33, nr. 283 AE 1967, 37 CIL, VI 4395
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 150
4 L’iscrizione fu vista, insieme ad altre, dallo studioso nella villa di S. Urbano alla Caffarella. In seguito le epigrafi entrarono afar parte della collezione Zeri. Si tratta di AE 1968, 36 = AE 1986, 92; AE 1968, 43 = AE 1986, 89; AE 1968, 47 = AE 1986,91; AE 1968, 56 = AE 1986, 97; AE 1968, 63 = AE 1986, 101; AE 1968, 71 = AE 1986, 106. Fa parte della collezione Zerianche il cinerario pubblicato da Ferrua in Epigraphica, 28 (1966), nr. 31 = AE 1986, 64.
5 A differenza del CIL, Ferrua nota che la lastra è opistografa. Viene riportato qui il secondo testo: D(is) [M(anibus)] / [- - -]mtiae[- - -] / [- - -]o me[- - -] / [- - -]s X[- - -] / [- - -] paren[tes - - -].
6 Ferrua riprende l’iscrizione dalla tradizione manoscritta, dove nella penultima riga erroneamente non è stato trascritto CAPI-TOLINAE.
7 Cfr. già SOLIN 1998, p. 74.8 Cfr. già SOLIN 1998, p. 382.9 Si tratta di un cippo rinvenuto a S. Sebastiano e pubblicato in due diverse sedi da Ferrua. Occorre tuttavia evidenziare comenella prima pubblicazione (FERRUA 1952 = AE 1955, 103) vi sia un errore relativo alla misura del recinto sul fronte stradale: infronte pedes X, mentre è XV.
10 Cfr. già SOLIN 1998, p. 219.11 Cfr. già SOLIN 1998, p. 219.
62 FT
63 Snin
64 R
151
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI - PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA
LB 33, nr. 29 AE 1967, 27 CIL, XIV 2687LB 33, nr. 43 CIL, VI 37292LB 33, nr. 44 CIL, VI 5813LB 33, nr. 46 CIL, VI 3578*LB 35, nr. 844 AE 1968, 63 CIL, IX 5495LB 35, nr. 106 AE 1968, 50 CIL, VI 35228LB 35, nr. 134 AE 1968, 73 CIL, VI 28523 LB 35, nr. 139 AE 1968, 23 CIL, VI 854 = 40838LB 39, nr. 159 CIL, VI 10144LB 39, nr. 1645 CIL, VI 23905LB 39, nr. 1926 CIL, VI 20385LB 40, nr. 407 AE 1975, 58 CIL, VI 18738LB 40, nr. 47 AE 1977, 134 CIL, VI 4091LB 45, nr. 248 AE 1973, 86 CIL, VI 34227aLB 47, nr. 2 AE 1975, 42 AE 1955, 1039
LB 47, nr. 32 CIL, VI 20082LB 48, nr. 20 CIL, XI 7898LB 48, nr. 21 AE 1976, 100 CIL, VI 23756LB 50, nr. 8810 CIL, VI 34537LB 53, nr. 17 AE 1982, 115 CIL, VI 16593;
ICUR, III 6637LB 53, nr. 20 AE 1982, 118 CIL, VI 21769LB 53, nr. 22 AE 1982, 120 CIL, VI 19745LB 53, nr. 30n, pars CIL, VI 32877LB 53, p. 366 CIL, VI 27897LB 53, nr. 34, pars CIL, VI 14016LB 53, nr. 37, pars CIL, VI 11913LB 53, nr. 40 CIL, VI 18582LB 53, nr. 69 CIL, VI 27047LB 54, nr. 2 AE 1980, 110 CIL, VI 18027LB 55, nr. 111 AE 1983, 76 CIL, VI 31846
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 151
152
LB 55, nr. 2 AE 1983, 77 CIL, XIV 3475LB 55, nr. 1512 AE 1984, 46 AE 1972, 38LB 58, nr. 144 MUSTILLI 1939, p. 29LB 58, nr. 147 Nsc (1919), p. 293;
THOMASSON 1961, nr. 25LB 58, nr. 152, pars CIL, VI 12987LB 58, nr. 160 MUSTILLI 1939, p. 30; BCom, 67 (1939), p. 181LB 58, nr. 161 MUSTILLI 1939, p. 42LB 58, nr. 191 FRIGGERI - PELLI 1980, nr. 22LB 62, nr. 4 THYLANDER 1962, nr. 33LB 62, nr. 19 CIL, VI 25814LB 63, nr. 30 v 1990, 111 CIL, VI 1831LB 64, p. 343 AE 1990, 340 CIL, XI 7543LB 67, nr. 115, pars AE 1993, 366 CIL, VI 13949LB 68, nr. 1 AE 1993, 250 AE 1988, 135LB 68, nr. 3 AE 1993, 252 AE 1988, 136LB 68, nr. 4 AE 1993, 253 AE 1990, 33LB 68, nr. 8 AE 1993, 256 AE 1990, 34LB 68, nr. 43 AE 1993, 278 AE 1988, 131LB 68, nr. 44 AE 1993, 279 AE 1990, 44LB 68, nr. 49 AE 1993, 283 AE 1991, 170LB 68, nr. 52 AE 1993, 284 AE 1990, 31LB 68, nr. 63 CIL, XIV 2767
12 Cfr. già SOLIN 1998, p. 66.
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 152
153
BIBLIOGRAFIA ABBREVIATA
AMELOTTI 1966 = M. AMELOTTI, Il testamento romano attraverso la prassi documen-tale. I, le forme classiche di testamento, Firenze 1966.
ANDERMAHR 1998 = A.M. ANDERMAHR, Totus in praediis. Senatorischer Grundbesitzin Italien in der Frühen und Hohen Kaiserzeit, Bohn 1998.
AUBERT 1995 = J.-J. AUBERT, Business managers in ancient Rome. A social and eco-nomic study of institores 200 BC-AD 250, Leiden - New York - Köln 1994.
AVETTA 1985 = L. AVETTA (ed.), Roma - via imperiale. Scavi e scoperte (1937-1950)nella costruzione di via delle terme di Caracalla e di via Cristoforo Colombo, Roma1985.
BATINO 1996 = S. BATINO, L’iscrizione pavimentale da S. Angelo in Formis. Una re-visione, in Ostraka, 5 (1996), pp. 15-21.
BIANCHI 2008 = A. BIANCHI, s.v. Rutiliae Pollittae praedium, in LTURS, V, 2008, pp.29-30
BRANDIZZI 1983 = P. BRANDIZZI VITTUCCI, La collezione Lanza nella tenuta della Fal-cognana, Roma 1983.
CANALI DE ROSSI 2007 = F. CANALI DE ROSSI, Due note di epigrafia tardo-repubbli-cana, in Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae. Provinciaeimperii romani inscriptionibus descriptae. Barcelona, 3-8 Septembris 2002, I, Barcelona2007, pp. 231-239.
CARLSEN 1995 = J. CARLSEN, Vilici and Roman estate managers until AD 284, Roma1995.
CERVA 2000 = M. CERVA, La praefectura fabrum, in Les Élites municipales de l’Italiepéninsulaire de la mort de César à la mort de Domitien entre continuité et rupture, Rome2000, pp. 177-196
CHASTAGNOL 1988 = A. CHASTAGNOL, Le formulaire de l’épigraphie latine officielledans l’antiquité tardive, in A. DONATI (ed.), La terza età dell’epigrafia, Faenza 1988, pp.11-65.
CHIOFFI 1991 = L. CHIOFFI, in Epigrafia. Actes du Colloque en mémoire de Attilio De-grassi, Rome 1991, pp. 338-344.
CHIOFFI 1996 = L. CHIOFFI, s.v. Horti Serviliani, in LTUR, III, Roma 1996, p. 84.CHIOFFI 2003 = L. CHIOFFI, I nomi dei proprietari dall’analisi epigrafica, in Suburbium.
Il suburbio di Roma dalla crisi del sistema delle ville a Gregorio Magno, Rome 2003, pp.437-484.
CHIOFFI 2005a = L. CHIOFFI, Sepulchra in extremis finibus…etiam in mediis posses-sionibus sepulchra faciunt, in Roman Villas around the Urbs. Interaction with Landscapeand Environment, Roma 2005, pp. 125-133.
CHIOFFI 2005b = L. CHIOFFI, Suburbana e sepulchra. Nomi di proprietari nel suburbiodi Roma dalle iscrizioni su monumenti funebri, in BCom, 106 (2005), pp. 215-239.
CHIOFFI 2005c = L. CHIOFFI, I patrimoni dei senatori nel suburbio di Roma: criteri diricerca epigrafica, primi risultati e nuove acquisizioni, in CahGlotz, 16 (2005), pp. 101-119.
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 153
154
PADRE ANTONIO FERRUA NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE
CIFANI 1992 = G. CIFANI, Iscrizioni funerarie latine inedite dall’area vestina (regioIV), in Epigraphica, 54 (1992), pp. 228-236.
COARELLI 1999 = F. COARELLI, s.v. Vicus Longus, in LTUR, V, 1999, pp. 174-175.COSTABILE 2008 = F. COSTABILE, Senatusconsultum de honore Ti. Claudi Idomenei, in
MinEpigrP, 13 (2008), pp. 71-160.DE RUGGIERO 1910 = E. DE RUGGIERO, s.v. Cymbalum, in Dizionario di antichità ro-
mane, II/3, Spoleto 1910, p. 1427.DEVREKER 1984 = J. DEVREKER, Recensione a R. SYME, Some Arval Brethren, in La-
tomus, 43 (1984), pp. 667-670.DI STEFANO MANZELLA 1987 = I. DI STEFANO MANZELLA, Il mestiere dell’epigrafista,
Roma 1987.DI STEFANO MANZELLA 1994 = I. DI STEFANO MANZELLA, Accensi velati apparentes
ad sacra: proposta per la soluzione di un problema dibattuto, in ZPE, 101 (1994), pp.261-279.
DI STEFANO MANZELLA 2000 = I. DI STEFANO MANZELLA, Accensi: profilo di una ri-cerca in corso (a proposito dei poteri collaterali nella società romana), in CahGlotz, 11(2000), pp. 223-257.
DONATI 2009 = A. DONATI, T. Annius T. f., in Epigraphica, 71 (2009), pp. 73-83.EAOR, I = P. SABBATINI TUMOLESI, Epigrafia anfiteatrale dell’Occidente romano, I.
Roma, Roma 1988.EDR: Epigraphic Database Roma.FELLETTI MAJ 1947 = B.M. FELLETTI MAJ, Rinvenimenti vari in via Cheren, in Nsc, 72
(1947), pp. 78-82.FERRUA 1952 = A. FERRUA, in FA, 7 (1952), nr. 5509.FERRUA 1955 = A. FERRUA, La catacomba della Santa Croce, in RACr, 31 (1955), pp.
153-171.FERRUA 1957 = A. FERRUA, Note al Thesaurus linguae latinae (Addenda et corri-
genda), in Aevum, 31 (1957), pp. 438-448.FERRUA 1969 = A. FERRUA, Nuove iscrizioni datate delle catacombe di Roma, in Epi-
graphica, 31 (1969), pp. 181-204.FERRUA 1981 = A. FERRUA, Note al Thesaurus linguae latinae. Addenda et corrigenda
al vol. I, in Vetera Christianorum, 18 (1981), pp. 309-331.FERRUA 1982 = A. FERRUA, Note al Thesaurus linguae latinae. Addenda et corrigenda
al vol. I, in Vetera Christianorum, 19 (1982), pp. 275-330.FERRUA 1984 = A. FERRUA, Note al Thesaurus linguae latinae. Addenda et corrigenda
al vol. I, in Vetera Christianorum, 21 (1984), pp. 33-82.FERRUA 1986 = A. FERRUA, Thesaurus linguae latinae. Addenda et corrigenda (A-D),Bari 1996.FERRUA 1994 = A. FERRUA, Le iscrizioni antiche di Aquileia di G. B. Brusin, in RACr,
70 (1994), pp. 161-180.FORNI 2007 = G. FORNI, Le tribù romane. I tribules, III, Roma 2007.FRANCIOSI 2002 = A. FRANCIOSI, La romanizzazione del vallo di Diano in età graccana
e l’elogio di Polla, in G. FRANCIOSI (ed.), La romanizzazione della Campania antica, I,Napoli, pp. 195-228.
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 154
155
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI - PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA
FRASCHETTI 2008 = A. FRASCHETTI, Le ere vicane in epoca augustea, in M.L. CALDELLI -G.L. GREGORI - S. ORLANDI (ed.), Epigrafia 2006 (ed.), Roma 2008, pp. 155-162.
FRIGGERI - PELLI 1980 = R. FRIGGERI - C. PELLI, Vivo e morto nelle iscrizioni di Roma,in Miscellanea, Roma 1980, pp. 95-172.
FUSCO 2006 = U. FUSCO, s.v. Nomentana via, in LTURS, IV, Roma 2006, pp. 96-113.GIANNETTI 1973 = A. GIANNETTI, Epigrafi latine della Campania e del Latium Adiec-
tum, in RendLinc, 28 (1973), pp. 469-495.GIOVAGNOLI 2012 = M. GIOVAGNOLI, Un sepolcro di liberti, in R. FRIGGERI, M.G. GRA-
NINO CECERE, G.L. GREGORI (ed.), Terme di Diocleziano. La collezione epigrafica, Milano2012, p. 218, nr. 13.
GIOVAGNOLI 2014 = M. GIOVAGNOLI, Sull’origine di P. Memmio Regolo, in ZPE, 190(2014), pp. 243-246.
GRANINO CECERE 2004 = M.G. GRANINO CECERE, s.v. L. Cornelii Scipionis Orfiti prae-dium, in LTURS, II, Roma 2004, pp. 161-162.
GREGORI 2005 = G.L. GREGORI, Definizione e misurazione dello spazio funerario nel-l’epigrafia repubblicana e protoimperiale di Roma. Un’indagine campione, in G. CRESCI
MARRONE, M. TIRELLI (ed.), Terminavit sepulcrum. I recinti funerari nelle necropoli diAltino, Roma 2005, pp. 77-126.
GREGORI 2004 = G.L. GREGORI, in Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. Leleges libitinariae campane. Iura sepulcrorum: vecchie e nuove iscrizioni. Roma 2004, pp.245-246, n. 70.
GREGORI 2011 = G.L. GREGORI, Ludi e Munera. 25 anni di ricerche sugli spettacolid’età romana. Scritti vari rielaborati e aggiornati con la collaborazione di Giorgio Crimi,Maurizio Giovagnoli, Milano 2011.
GREGORI 2014 = G.L. GREGORI, Breve nota su due “nuove” iscrizioni senatorie diRoma: CIL, VI 37292 e AE 1964, 116 (con appendice di G. Crimi), in Atti della XIX Ren-contre sur l’épigraphie du monde romain (Roma, 21-23 marzo 2013), Roma 2014, pp.553-562.
GRELLE - SILVESTRINI 2001 = F. GRELLE - M. SILVESTRINI, Lane apule e tessuti canosini,in Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane 6, Bari 2001, pp. 91-136.
GUNDEL 1953 = H.-G. GUNDEL, Devotus numini maiestatique eius. Zur Devotionsfor-mel in Weithinschriften der römischen Kaiserzeit, in Epigraphica, 15 (1953), pp. 128-150.
IHM 1891 = M. IHM, Delle tavole lusorie romane, in RM, 6 (1891), pp. 208-220.I. Aq.= J.B. BRUSIN, Inscriptiones Aquileiae, I-III, Udine 1991-1993.KAJANTO 1965 = I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki 1965.KAJANTO 1971 = I. KAJANTO, Un’analisi filologico-letteraria delle iscrizioni onorarie,
in Epigraphica, 33 (1971), pp. 3-19.KUBITSCHEK 1889 = J.W. KUBITSCHEK, Imperium Romanum tributim discriptum, Wien
1889.LIVERANI 1999 = P. LIVERANI, s.v. Circus Maximus, in LTUR, V, Roma 1999, pp. 236-
237.
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 155
156
PADRE ANTONIO FERRUA NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE
MAINARDIS 2004 = F. MAINARDIS, Aliena saxa. Le iscrizioni greche e latine conservatenel Friuli-Venezia Giulia ma non pertinenti ai centri antichi della regione, in MemLinc,18, 1, (2004), pp. 3-223.
MARI 2006 = Z. MARI, s.v. Nomentana via, in LTURS, IV, Roma 2006, pp. 113-117.MASIER 2009 = A. MASIER, Sodales. Dalle origini a Domiziano, Padova 2009.MELLACE 2001 = V.S. MELLACE, in G.L. GREGORI (ed.), La collezione epigrafica del-
l’Antiquarium del Celio, Roma 2001, p. 304, nr. 270.MESSINEO - SORELLA 1989/1990 = G. MESSINEO - R. SORELLA, Torraccio della Cec-
china, in BCom, 96 (1989/1990), pp. 180-189.MINEO 2001 = S. MINEO, s.v. Appia via, in LTURS, I, Roma 2001, pp. 103-106.MOLLICONE 2005 = A. MOLLICONE (ed.), Bibliografia del p. Antonio Ferrua S. I., Città
del Vaticano 2005.MUSTELLI 1939 = D. MUSTELLI, Il Museo Mussolini, Roma 1939.ORLANDI 2009 = S. ORLANDI, Stele di Epafrodito, structor a cybo di Domiziano, in F.
COARELLI (ed.), Divus Vespasianus, Roma 2009, p. 31.PANCIERA 2006 = S. PANCIERA, Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti
(1956-2005), con note complementari e indici, Roma 2006.PANCIERA - DI GENNARO 2009-2010 = S. PANCIERA - F. DI GENNARO, Ficulea: un nuovo
frammento epigrafico. Problemi storici e topografici, in RendPontAc, 82 (2009-2010),pp. 145-163.
PERGOLA 2004 = PH. PERGOLA, Domitillae coemeterium, in LTURS, II, Roma 2004,pp. 203-207.
POBJOY 1997 = M. POBJOY, A New Reading of the Mosaic Inscription in the Temple ofDiana Tifatina, in BSR, 65 (1997), pp. 59-88.
POTTIER 1887 = E. POTTIER, s.v. Cymbalum, in CH. DAREMBERG, EDM. SAGLIO (ed.),Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, I, Paris 1887, pp. 1697-1698.
RAMIERI 1996 = A. M. RAMIERI, I servizi pubblici, Roma 1996.RICCI 1994 = C. RICCI, Soldati delle milizie urbane fuori di Roma. La documentazione
epigrafica, Roma 1994.RÜPKE 2005 = J. RÜPKE, Fasti sacerdotum. Die Mitglieder der Priesterschaften und
das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdischchri-stlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr., Stuttgart 2005.
SABLAYROLLES 1996 = R. SABLAYROLLES, Libertinus Miles. Les cohortes de vigiles,Rome 1996.
SCHEID 1998 = J. SCHEID, Commentarii fratrum Arvalium qui supersunt: les copiesépigraphiques des protocoles annuels de la Confrérie Arvale (21 av.-304 ap. J.-C.). Re-cherches archéologiques à la Magliana, Rome 1998.
SCHULZE 1904 = W. SCHULZE, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin 1904.SOLIN 1989 = H. SOLIN, Due iscrizioni urbane nel Museo Archeologico di Napoli, in
Epigraphica, 51 (1989), pp. 226-230.SOLIN 1996 = H. SOLIN, Die stadtrömischen Sklavennamen. Ein Namenbuch, I-III,
Stuttgart 1996.
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 156
157
MAURIZIO GIOVAGNOLI, GIAN LUCA GREGORI - PADRE FERRUA E L’EPIGRAFIA PAGANA
SOLIN 1998 = H. SOLIN, Analecta Epigraphica 1970 - 1997, Roma 1998.SOLIN 2001 = H. SOLIN, Un aspetto dell’onomastica plebea e municipale. La ripresa
di nomi illustri da parte di comuni cittadini, in M.G. ANGELI BERTINELLI - A. DONATI (ed.),Varia Epigraphica, Faenza 2001, pp. 411-427.
SPEIDEL 1965 = M.P. SPEIDEL, Die equites singulares Augusti: Begleittruppe der rö-mischen Kaiser des zweiten und dritten Jahrhunderts, Bonn 1965.
SPEIDEL 1994 = M.P. SPEIDEL, Die Denkmäler der Kaiserreiten. Equites sengularesAuguste, Kölin 1994.
SPERA 1999 = L. SPERA, Il paesaggio suburbano di Roma dall’antichità al Medioevo.Il comprensorio tra le vie Latina e Ardeatina dalle mura Aureliane al III miglio, Roma1999.
SPERA 2004 = L. SPERA, Il complesso di Pretestato sulla via Appia. Storia topograficae monumentale di un insediamento funerario paleocristiano nel suburbio di Roma, Cittàdel Vaticano 2004.
SUSINI 1997 = G. SUSINI, Epigraphica dilapidata, Faenza 1997.THOMASSON 1961 = B.E. THOMASSON, Aus Einer Stadtrömeschen Inschriftensamm-
lung, in ORom, 3 (1961), pp. 179-190.THOMASSON 1997 = B.E. THOMASSON, A Survey of Greek and Latin Inscriptions on
Stone in Swedish Collections, Stockholm 1997.THYLANDER 1962 = H. THYLANDER, Inscriptions latines de San Michele d'Axel Munthe,
in ORom, 4 (1962), 129-157.VÄÄNÄNEN 1973 = V. VÄÄNÄNEN, Le iscrizioni della necropoli dell'autoparco Vati-
cano, Roma 1973.VULIĆ 1910 = N. VULIĆ, s.v. Dispensator, in Dizionario di antichità romane, II/2, 1910,
pp. 1920-1923.
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 157
Fig. 1 - Iscrizione funeraria di C. Mem-mius Regulus, console del 63 d.C.Foto EDR
Fig. 3 - Base di statua posta in onore di un Ti. Claud(ius) [- - -]. Foto PCAS
Fig. 4 - Iscrizione di una cymbalistria.Foto PCAS
Fig. 2 - Iscrizione funera-ria del liberto im-periale Maurus chericoprì l’incaricodi tabularius. DaFerrua 1955, p. 165
158
PADRE ANTONIO FERRUA NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 158
Fig. 5 - Iscrizione funeraria dell’urbaniciano Iul(ius) Domit(ius) Secundianus. Da GIANNETTI 1973, tav. II, figg. 2 - 3.
Fig. 6 - Iscrizione funeraria del vigileQ. Vibulenus Aruntianus. DaFERRUA 1959.
Fig. 7 - Stele dell’area sepolcrale del pretoriano L.Calpurnius An. f. Foto EDR.
Fig. 8 - Terminus sepulchri del pretoriano L.Calpurnius An. f. Foto EDR.
159
FRANCESCO PAOLO RIZZO - IL CONTRIBUTO SCIENTIFICO DEL PADRE ANTONIO FERRUA
IMPAGINATO_P_107_186_Layout 1 22/07/14 13:16 Pagina 159