Moretti e Nervi. Alcune considerazioni sul disegno della Stock Exchange Tower a Montreal...
Transcript of Moretti e Nervi. Alcune considerazioni sul disegno della Stock Exchange Tower a Montreal...
Allemandi & C.
Ingegneria e architettura in Italia negli anni cinquanta e sessanta
LA CONCEZIONE STRUTTURALE
LA CONCEZIONE STRUTTURALEIngegneria e architettura in Italia negli anni cinquanta e sessanta
A CURA DI
PAOLO DESIDERI
ALESSANDRO DE MAGISTRIS
CARLO OLMO
MARKO POGACNIK
STEFANO SORACE
UMBERTO ALLEMANDI & C.TORINO ~ LONDRA ~ NEW YORK
Unità di ricerca del Politecnico di Torino
Responsabile scientificoCarlo Olmo
Partecipanti al programma di ricercaMichela CombaSergio Pace
CollaboratoriDaniela FerreroAlberto BolognaCristiana Chiorino
Unità di ricerca di Venezia
Responsabile scientificoMarco Pogacnik
Partecipanti al programma di ricercaRoberto Masiero
CollaboratoriAlessandro BrodiniFrancesca MatteiLuka Skansi
Unità di ricerca del Politecnico di Milano
Responsabile scientificoAlessandro De Magistris
Partecipanti al programma di ricercaCino ZucchiAnna Bronovickaja (Istituto di Architettura di Mosca)
CollaboratoriGiulio BarazzettaPatrizia BonifazioMaria Vittoria CapitanucciIvica CovicFederico Deambrosis
Unità di Ricerca di Udine
Responsabile scientificoStefano Sorace
Partecipanti al programma di ricercaOrietta LanzariniGloria Terenzi
CollaboratoriFrancesca Mattei
Il volume è pubblicato con il contributo del MIUR, programma Prin 2008.La ricerca «La concezione strutturale. Ingegneria e Architettura in Italia negli annicinquanta e sessanta» coordinata dal prof. Carlo Olmo è stata condotta dalle seguenti unità:
Responsabile scientificoPaolo Desideri
CollaboratoreFernando Salsano
Coordinatrice scientifica per la pubblicazione e ilseminario «La concezione strutturale. Ingegneria eArchitettura in Italia negli anni cinquanta e sessanta»tenuto a Torino il 5, 6, 7, dicembre 2012Michela Comba
Si ringraziano Antonio Becchi (Max PlankInstitute for Science di Berlino), Harmut Frank(HCU-Hamburg), Marzia Marandola(Università La Sapienza di Roma), SergioPoretti (Università Roma Tor Vergata) e BrunoReichlin (Accademia di Architettura diMendrisio) che hanno partecipato comediscussants al seminario.
Sommario
7 Tra etica e scienza, tra liberalità e organizzazioneCARLO OLMO
19 Architettura e ingegneria
21 L’estetica dell’impersonaleMARCO POGACNIK
35 Costruzione e progetto nelle opere di Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti e Aldo FaviniGIULIO BARAZZETTA
49 Tecnica e architettura industriale: il cantiere Olivetti, due possibili protagonisti, alcune riflessioniPATRIZIA BONIFAZIO
63 Progettazione industriale e committenza in Lombardia tra gli anni cinquanta e settanta. Tra scienza e poesia: aspirazioni tecnologiche e sperimentazioni strutturali all’insegna di un nuovo umanesimo liberaleMARIA VITTORIA CAPITANUCCI
75 Il vocabolario strutturale di Carlo Mollino tra gli anni cinquanta e sessantaMICHELA COMBA
89 Moretti e Nervi. Alcune considerazioni sul disegno della Stock ExchangeTower a Montreal (1960-1965)ORIETTA LANZARINI
103 Una forte amicizia, una casa esile: Pier Luigi Nervi e Lina Bo BardiROBERTA MARTINIS
115 L’altra torre. Concezione strutturale, architettura e città nell’edificio in corso Francia a Torino (BBPR, Gian Franco Fasana e Giulio Pizzetti: 1955-1959)SERGIO PACE
129 Myron Goldsmith e l’Italia (1953-1955)LUKA SKANSI
144 Sedici edifici / Venti anni di architetturaFEDERICO PADOVANI - MARKO POGACNIK
161 Protagonisti della ricerca strutturale
163 Circostanze e fortune internazionali dell’ingegneria italianaALESSANDRO DE MAGISTRIS
181 Ascesa e declino della Scuola italiana di ingegneriaTULLIA IORI - SERGIO PORETTI
195 L’apporto di Mario Salvadori nella carriera statunitense di Pier Luigi NerviALBERTO BOLOGNA
205 La Nervi & Bartoli spa (1947-1961). La creatività applicata all’industria delle costruzioniPAOLO DESIDERI - FERNANDO SALSANO
217 Analisi e accertamento strutturale del Palazzo del Lavoro di TorinoSTEFANO SORACE - GLORIA TERENZI
229 Riccardo Morandi per il V padiglione di Torino EsposizioniEDOARDO BRUNO
241 Giorgio Dardanelli, Riccardo Morandi, Giorgio Rigotti, Silvano Zorzi e il Servizi Costruzioni e Impianti FiatRITA D’ATTORRE
253 Le coperture a grande luce nell’opera di Sergio MusmeciALESSANDRO BRODINI
265 I ponti di Fabrizio de MirandaFRANCESCA MATTEI
277 Come caleidoscopi: gli elementi modulari a guscio a supporto centrale nel dibattito degli anni cinquantaFEDERICO DEAMBROSIS
289 Biografie
89
Moretti e Nervi. Alcune considerazioni sul disegno della Stock Exchange Tower a Montreal (1960-1965)1
ORIETTA LANZARINI
Unico edificio realizzato del grande complesso denominato Place Victoria, laStock Exchange Tower a Montreal, opera corale di Luigi Moretti e Pierluigi
Nervi, è stata oggetto, in anni recenti, di una considerevole attenzione da parte degli stu-diosi, che hanno messo in luce alcuni aspetti significativi della sua progettazione2. Gra-zie a una ragguardevole mole di documenti, infatti, è possibile ripercorrerne, quasi gior-no per giorno, l’intricata storia, protrattasi, ufficialmente, dal novembre 1960 al maggio19653. A fronte di questa opportunità, però, nessuno studio ha finora ricostruito conprecisione la scansione cronologica del progetto, né tentato di dare un ordine al comples-so iter ideativo seguito da Moretti e Nervi, segnato da continui cambi di programmacomprensibili solo intrecciando documenti e disegni. Questi ultimi sono, indubbiamen-te, la fonte meno considerata nelle indagini sull’opera canadese: i saggi di Legault e Shep-pard, ad esempio, vengono illustrati da ben venti disegni di Moretti4, ma nella disami-na degli studiosi si trovano solo pochi accenni al loro ruolo nella progettazione, e nes-sun tentativo di datarli o metterli in sequenza, né tantomeno di confrontarli con quantoprodotto dal coautore Nervi5. Un’altra questione, toccata solo marginalmente dagli stu-di, riguarda il peso dell’indagine teorica dei due progettisti, in particolare di Moretti, sul-la genesi del complesso Place Victoria. Se osservazioni puntuali sono state formulate -in particolare da Legault, Sheppard e Vanlaethem - a proposito delle scelte tecnichecompiute nell’unica torre costruita, anche in relazione allo stato della ricerca sugli edi-fici alti in quel momento, meno approfondito è l’aspetto prettamente ideativo del pro-getto, rivelato principalmente dal corpus grafico prodotto da Moretti e Nervi. Questo è iltema che si propone di affrontare, nelle sue linee essenziali, il presente contributo. Prima di procedere all’analisi di alcuni disegni significativi, è necessario riassumere bre-vemente i passaggi fondamentali della storia della torre.
Nel 1953 la Nationale Handelsbank of Amsterdam apre una filiale a Montreal, la Mer-cantile Bank of Canada, la cui direzione è affidata a Henri Moquette con l’incarico diacquisire aree presso Victoria Square, cuore della downtown, per ospitarne la sede. Ter-minata questa fase nel 1958, il direttore interpella, senza successo, alcuni investitori lo-cali per sovvenzionare la costruzione di un complesso per uffici; il fallimento dell’ini-ziativa lo spinge verso una partnership con la Società Generale Immobiliare di Roma
90
(SGI), la quale interessa altri sette investitori italiani (BNL, Efibanca, Finsider, Gruppo Edison, IMI, Italconsult e Snia Viscosa). Nel novembre 1960, definiti gli ac-cordi tra le parti, viene istituita la «Place Victoria - St. Jacques Company», deputataalla gestione di un ambizioso progetto comprensivo di tre torri per uffici6. L’impegno della SGI nell’opera canadese porta al logico coinvolgimento di Luigi Mo-retti. Legato da stretta amicizia con Aldo Sammaritani, egli è considerato l’«architet-to dell’immobiliare» con la quale collabora in numerose occasioni; tra queste, una con-sulenza per il quartiere San Berillo a Catania affidatagli, nel 1957, assieme ad AlvarAalto e Pier Luigi Nervi7. La cooperazione tra quest’ultimo e l’architetto potrebbe averincoraggiato i vertici della SGI a riproporre i loro nomi per Place Victoria. Una deci-sione affatto vincolante rispetto all’esito ultimo dell’impresa: scegliere Nervi - «the “wizard” of modern reinforced concrete»8 - significava, infatti, ipotecarne il destinostrutturale con l’imposizione di un materiale, il cemento armato, talmente inconsuetoper gli edifici alti da diventare di per sé un tratto promozionale del progetto. Moretti e Nervi sono chiamati a operare in un contesto denso di vincoli. Montreal sitrova in una zona ad alto rischio sismico, oltre che soggetta a escursioni termiche digrande entità, parametri da considerare, assieme all’incidenza del vento, nella proget-
1. LUIGI MORETTI, STUDI PER LA STOCK EXCHANGE TOWER, MONTREAL, FEBBRAIO 1961 (?). AMM.
91
tazione di edifici alti. Per agevolarne il lavoro, è istituito un project management group gui-dato dal project manager Edward Landway, dello studio Panero-Weidlinger-Salvado-ri, composto da professionisti di diversi settori; tra questi, gli architetti associati Green-spoon, Freedlander & Dunne e gli ingegneri D’Alemagne & Barbacki, che saranno,non senza conflitti, i principali interlocutori dei «master builders» italiani9. Fin dal primo incontro, tenutosi a Montreal dal 11 al 14 gennaio 1961, vengono di-scussi «the broad principles of structural design» e Antonio Nervi - intervenuto per loStudio Nervi - segnala, da subito, l’opportunità di adottare per le torri una «reinforcedconcrete structure with a reticulated slab»10. Ai meeting successivi, il 19 e 21 gennaio,partecipa anche Moretti, il quale dimostra un precipuo interesse per l’inserimento delcomplesso nella città e per la possibilità di collegare «by way of underground levels thetotal complex of buildings, from Place Ville Marie level to Place Victoria level»11. Èdi questi anni, infatti, l’idea di Vincent Ponte, collaboratore di Pei, di creare un siste-ma di connessioni sotterranee del quale l’architetto romano afferra immediatamente lepotenzialità12.
All’indomani delle riunioni di gennaio, Moretti e Nervi iniziano a elaborare una pri-ma versione di progetto, messa a punto tra febbraio e luglio 196113. Un fattore che necondiziona, senza dubbio, l’azione progettuale è il grandioso programma architettoni-co di Place Victoria, ovvero il numero delle torri. Chi lo stabilisce, dunque? La rispo-sta più semplice è che sia Moretti a suggerire, forse direttamente a Sammaritani, questacombinazione di sicuro impatto promozionale. Come rivelano i suoi disegni, la pro-gressione dinamica delle tre torri, da ricondurre a unità, gli offre la preziosa occasionedi approfondire, su un tipo edilizio per lui inedito, alcune ricerche condotte fin daglianni giovanili. Una coppia di torri, vincolata da un fatale principio di simmetria, nonavrebbe avuto, e non avrà, la stessa forza iconica14.
In un primo studio, l’architetto approccia il problema in termini di strutturazione del-l’insieme dei tre edifici, mettendo sullo stesso piano otto combinazioni planimetricheequivalenti, alcune delle quali verranno sviluppate15. Al pragmatismo morettiano neldefinire un assortimento di forme possibili, non corrisponde, però, alcun esplicito rife-rimento alla struttura delle torri. Come si spiega un simile atteggiamento verso un tipodi edificio che non può quasi prescindere, per sua indole, dall’aspetto strutturale? Laposizione di Moretti nei confronti dei grattacieli costruiti a metà del XX secolo è chia-ramente espressa all’indomani del completamento della torre canadese, definita «unaforma nuovissima eppure classica che ripudia, finalmente, i grattacieli prismatici, conle stesse dimensioni in basso come in alto, e ripudia, quindi, quella astrattezza costrut-tiva che li privava del senso dell’effettiva presenza del peso e dello sforzo della materiache peraltro è alla base dell’emozione architettonica»16. A giudizio di Moretti, dunque,
2. LUIGI MORETTI, STUDI PER LA STOCK EXCHANGE TOWER, MONTREAL, FEBBRAIO 1961 (?). ALM,R. LEGAULT, PLACE VICTORIA: LA RISPOSTA DI MORETTI AL PARADIGMA MIESIANO, IN B. REICHLIN E
L. TEDESCHI (A CURA DI), LUIGI MORETTI. RAZIONALISMO E TRASGRESSIVITÀ TRA BAROCCO
E INFORMALE, MILANO 2010, P. 330.
92
il grattacielo prismatico, con la sua ineludibile consequenzialità di struttura e forma,non riesce a commuovere: il problema sembra essere, innanzitutto, formale e con la for-ma l’architetto tenta di risolverlo. Due studi inediti, forse tra i primi redatti, hanno un valore seminale per lo sviluppo delprogetto (fig. 1).Moretti lavora con Nervi, che stima e del quale aveva pubblicato su «Spazio» un’avio-rimessa, vera «cattedrale di cemento»17. Logico, quindi, che esordisca con una rifles-sione planimetrica e volumetrica, subito abbandonata, sulla torre Pirelli (1956-1961),che coesiste con pensieri generati dalla vicina torre cruciforme di Pei, così come dal grat-tacielo berlinese, in vetro e acciaio, di Mies van der Rohe (1921). Moretti assegna giàun ruolo decisivo alla piastra che sostiene e rende monumentali i fusti delle torri, unbasso e articolato volume che ne accompagna la scansione stereometrica. In altri tre studi, egli inizia a verificare l’impatto del complesso sulla città, tema al cen-tro dei suoi interessi18 (fig. 2). Com’è evidente, la parte basamentale risente di esperien-ze morettiane precedenti, in particolare la villa «La Saracena» a Santa Marinella (1954-
1957) e il collegio dell’Accademia Nazionale della Danza a Roma (1955-1968), men-tre in due varianti il fusto delle torri, nonostante sia molto articolato, è scandito ancheda balconi sporgenti, forse sulla falsariga del progetto per il Chicago Tribune di Gro-pius (1922).
In tali soluzioni, l’architetto continua la propria investigazione sulla forma delle torri,senza alcuna evidente riflessione sulla struttura che le sostiene, se escludiamo una sortadi nucleo resistente al centro di due varianti planimetriche19. Quali sono le ragioni ditale scelta, contraddittoria alla luce del concreto interesse di Moretti, mostrato in altreoccasioni, per le questioni strutturali? È possibile che l’architetto stia applicando al pro-getto quel principio di «trasfigurazione della struttura muraria» che aveva analizzatosu «Spazio» valendosi, come esempio, dell’architettura toscana dal XIII al XVI secolo20.Si tratta di «un processo trasfigurativo», egli osserva, che consente la «trasformazionedi una struttura muraria in una superficie espressiva i cui termini formali siano assolu-tamente estranei a ogni riferimento costruttivo»21. Dunque la struttura andrebbe del tut-to trascurata? Non necessariamente, ma c’è uno scopo superiore da perseguire: «salireall’astratto» - e «l’architettura è per sua natura arte eminentemente astratta» precisa Mo-retti - «può solo una superficie di una struttura muraria che non debba reggere, inten-do dire che idealmente sia posta a non reggere»22. Se il problema del grattacielo prisma-
3. PIER LUIGI NERVI E STUDIO NERVI, PIANTA E ALZATO DELLA STOCK EXCHANGE TOWER, MONTREAL, 15 FEBBRAIO 1961. CSAC.
93
94
tico è, in sintesi, la subordinazione della forma alla struttura, la forma deve tornare aesprimere se stessa, anche obnubilando la struttura. Mentre Moretti tenta di stabilire la priorità dell’involucro sull’ossatura portante, Ner-vi si concentra, comprensibilmente, sulla risoluzione strutturale delle torri. Come testimoniano i primi disegni (fig. 3), datati febbraio 1961, l’ingegnere e i suoicollaboratori studiano una sola torre-tipo di impianto quadrato, sorretta da pilastri an-golari, decrescenti dal basso verso l’alto, e da quattro sostegni al centro, mentre l’alza-to è ritmato da griglie di finestre. Circa un mese più tardi si consolida l’idea di inseriredue pilastri intermedi per ogni fronte e un nucleo centrale formato da travi disposte acroce di Sant’Andrea che, perfezionato, sarà adottato nel progetto finale23.Anche Moretti, a un certo punto, introduce nei disegni un’ossatura di sostegno agliangoli delle torri, forse prendendo atto di quanto stava studiando Nervi; tuttavia, l’ar-chitetto assegna al telaio strutturale un ruolo accessorio, quasi di semplice supportodelle scatole edilizie che muove ritmicamente al suo interno24; un probabile riferimen-to è il progetto del MOMA a New York di Howe e Lescaze (1930), che conferma lasua attenzione per gli edifici alti progettati prima dell’avvento massivo del grattacieloprismatico. Nervi, intanto, raggiunge la consapevolezza di quale struttura adottare. Il 7 giugno1961 scrive da Zurigo al proprio studio (forse al figlio Antonio): «ho fatto ancora va-ri pensieri sull’ossatura di Montreal e mi pare che la soluzione integrale quella di farportare tutto il carico sui pilastri esterni offra serissime possibilità di essere la migliore»25;le sue indicazioni si concretizzano in una serie di disegni nei quali l’impianto del pia-no-tipo26 è molto vicino alla soluzione presentata alla stampa da Marcello de Leva, pre-sidente della società Place Victoria, il 22 settembre 196127. Il piano attuativo di quelloche è definito «the largest office complex in the world» - sviluppato in soli otto mesi ecomprensivo di tre spettacolari torri di 51 piani per un costo di circa 90 milioni di dol-lari - prevede la costruzione di una prima torre, chiamata Stock Exchange Tower, en-tro il 1964, e in base al successo finanziario di questa, è preventivata la realizzazionedelle altre due entro dieci anni28. Perplessità riguardo la mastodontica scala del com-plesso erano affiorate già nel maggio 196129, ma solo l’anno seguente, la drastica rifor-ma del programma per Place Victoria troverà compimento.Il 6 febbraio 1962 Hugo Facci, dello studio Panero-Weidlinger-Salvadori, presentaalla «Ontario Concrete Association» di Toronto una versione aggiornata del proget-to: la coppia di pilastri centrali appaiono posizionati dietro al piano delle facciate, oralievemente bombate e segnate da un solo elemento verticale30. È la conseguenza, pro-babilmente, delle decisioni prese dopo l’incontro di gennaio 1962, durante il quale siera discusso dell’arretramento dei pilastri mediani anche a costo di una minore resa eco-nomica31. Inoltre, le condizioni climatiche di Montreal avevano imposto l’introduzio-ne, almeno da ottobre 196132, di un rivestimento di pannelli in cemento per protegge-
re la superficie esterna dei pilastri angolari dagli elevati sbalzi termici, anch’esso presen-te nella soluzione illustrata da Facci.
I cambiamenti citati, al pari dei documenti coevi, dimostrano come aspetti basilari delprogetto fossero, all’epoca, ancora in via di definizione. Questo stato di cose è testimo-niato anche da un bellissimo disegno di Moretti databile, probabilmente, a dopo la me-tà di gennaio 1962, poiché la pianta di una delle torri mostra già le facciate incurvate(fig. 4). Come in una sorta di stream of consciousness, l’architetto stratifica soluzioni pla-nimetriche, volumetriche e di dettaglio, mentre anima l’involucro delle torri corrugan-done la pelle vetrata o scandendone i fronti con sequenze ritmiche che sembrano anco-ra generarsi dalla trasfigurazione di strutture murarie.Ma il disegno suggerisce forse un tema più importante. Moretti ipotizza la sagoma deipilastri angolari in due piccoli studi, in alto a sinistra e al centro a destra, tra i pochidedicati a questa parte essenziale della costruzione. Nonostante i sostegni siano statiquasi risolti, almeno nei disegni di Nervi, egli li rappresenta curvilinei, rimarcando-ne il carattere scultoreo e autonomo, per poi farli aderire, senza integrarli, agli spigolidelle torri. La messa a punto dei pilastri angolari è, senza dubbio, la chiave per comprendere il de-corso, e molte delle antinomie, del progetto canadese. Benché il sistema strutturale sia
4. LUIGI MORETTI, STUDI PER LA STOCK EXCHANGE TOWER, MONTREAL, GENNAIO 1962 (?). ALM.
95
definito entro giugno 1961 circa, la forma dei sostegni d’angolo è oggetto di discussio-ni continue, persino di conflitti tra i progettisti, e viene concordemente accettata solo il24 aprile 196333. Il 14 giugno successivo si apre il cantiere34, ma a luglio Moretti deveancora ribadire per tramite della Ediltecno Canada, impresa preposta a gestire la co-struzione della torre, che «la forma del pilastro d’angolo esterno non dovrà essere cam-biata per nessuna ragione»35. Nel febbraio 1963, infatti, l’ingegner Barbacki, forse esa-sperato dai tentennamenti del team italiano, aveva suggerito una variante per i pilastriangolari che comportava apprezzabili vantaggi economici36. Del rifiuto dei progettistisi era fatto portavoce Antonio Cecchi, il 4 marzo seguente, in una lettera all’ingegnerPadoan della Ediltecno Canada: «Per un complesso di ragioni di ordine estetico, diingombro e strutturale l’arch. Moretti ha studiato e il prof. Nervi ha approvato una for-ma [dei pilastri] che si differenzia dalla Vostra», della quale rimarcava poi le qualità:«non differenziare troppo la forma della struttura da quella dell’involucro che l’archi-tetto progettista giudica meglio corrispondente alle esigenze estetiche della torre [può]compensare il maggior onere della esecuzione»37.
Considerando le «esigenze estetiche della torre» che ruolo ha il profilo dei pilastri an-golari? Come si spiega l’esigenza di Moretti di stabilirne personalmente il disegno, quan-do poteva lasciare allo Studio Nervi questa incombenza prettamente tecnica? La diffi-cile messa a punto dei pilastri è dovuta sia a ragioni strutturali, sia all’ambiguità che licaratterizza: la loro sagoma, infatti, non è a vista, ma protetta dall’involucro che ne se-gue, approssimativamente, il contorno esterno (fig. 5). È chiaro che a fronte di questadualità, il problema strutturale diventa inscindibile da quello figurativo.Se i pilastri non possono comunicare direttamente all’osservatore la fatica che compio-no per sostenere le torri - in modo tale da esibire quella «effettiva presenza del peso e del-lo sforzo della materia»38 che origina l’espressione architettonica -, tale compito devepassare al rivestimento che li nasconde. Nell’ottica della ricerca di Moretti, dunque, acosa equivale il disegno della sagoma del pilastro, o meglio, del suo involucro? Questaforma potrebbe avere, ai suoi occhi, il valore di una modanatura. Come scrive su «Spa-zio», «le modanature apposte agli elementi architettonici discontinui - pilastri, colon-ne, portali, finestre - assolvono la funzione di precisare, di scandire, l’individualità deisingoli elementi e di coordinarli in una legge spaziale comune». E ancora, la modana-tura ha «la capacità di addensare al massimo, il senso del concreto, il senso di esisten-za, di realtà obiettiva» dell’architettura, poiché «ogni cosa è visibile e con noi comuni-ca per la sua superficie». Se compito del pilastro è reggere fisicamente la struttura, l’in-volucro che ne costituisce la proiezione - ovvero la sua modanatura - «può spingersi apartecipare in pieno all’ideale travaglio struttivo dell’elemento cui appartiene»39 sconfi-nando nel campo dell’espressione architettonica, quella che Moretti insegue, a costo dianni di discussioni, e che manca, a suo giudizio, al grattacielo prismatico.
96
97
La dilazione del progetto, causata soprattutto dal braccio di ferro continuo tra le partiitaliana e canadese, consente di variare, senza grandi problemi, il «programma pubbli-citario» iniziale di Place Victoria durante l’incontro del 22-23 marzo 1962: l’ambizio-ne di costruire tre torri sussiste ancora, ma dai 51 piani iniziali più 5 basements, si passaa 42 piani e 4 basements40; nel novembre del 1962, però, le torri diventano definitivamen-te due, con i lati paralleli tra loro e disposte su un basamento comune41. Nonostante le continue revisioni del piano di lavoro, lo studio Nervi aveva consegnato,il 16 luglio 1962, la «relazione di calcolo finale con relativi schemi costruttivi» e stavacontinuando a produrre disegni generali e di dettaglio per procedere alla costruzione del-la prima torre42. Il cantiere si apre un anno più tardi, il 14 giugno 1963, ma il 21-22 giu-gno Moretti è impegnato a redigere nuovi disegni alla ricerca di una soluzione ottimaleper l’involucro, l’altra parte essenziale dell’architettura della torre assieme ai sostegni an-golari. Fin da luglio 1962, infatti, gli era stato chiesto di fornire con urgenza, oltre alla«sagoma definitiva dei pilastri d’angolo della torre», il «prospetto definitivo» e il «raggiodei curtain wall del mezzanino»43. L’architetto avanza due ipotesi. Nella prima, il vo-lume di base e le tre sezioni del fusto della torre, stretti dal telaio strutturale, si gonfiano,dando vita a un volume ottagono - «il cerchio degli uomini spezzato e respirante»44 -,che richiama il coevo grattacielo della Pan Am di Gropius (1958-1963). Nella secon-da versione, prossima a quella costruita, egli si concentra, invece, sul coordinamento trail corpo basamentale, il fusto della torre, entrambi piani, e i possenti pilastri angolari45.
5. PIER LUIGI NERVI E STUDIO NERVI, DETTAGLIO DEL PILASTRO ANGOLARE DELLA STOCK
EXCHANGE TOWER, MONTREAL, 28 GIUGNO 1962. CSAC.
98
1 Per l’aiuto e le utili osservazioni, desidero ringraziareAlessandro Brodini, Marko Pogacnik e Annalisa Via-ti. 2 Vedi C. ROSTAGNI, Luigi Moretti 1907-1973, Milano2008, pp. 135-146, 271-274; R. LEGAULT, Place Vic-toria: la risposta di Moretti al paradigma miesiano, A. SHEP-PARD, Place Victoria: il simbolo della collaborazione tra ar-chitetto e ingegnere, e S. PORETTI e G. CAPURSO, Tra-sfigurazioni di strutture, in B. REICHLIN e L. TEDESCHI
(a cura di), Luigi Moretti. Razionalismo e trasgressività trabarocco e informale, Milano 2010, pp. 329-351, 375-378;F. VANLAETHEM, Tour de la Bourse-Place Victoria, inC. OLMO e C. CHIORINO (a cura di), Pier Luigi Ner-vi. L’architecture comme défi, Cinisello Balsamo 2010, pp.174-177; C. ROSTAGNI, Luigi Moretti. Forma come strut-tura o struttura come forma? La torre della Borsa di Montreal,in G. BIANCHINO e D. COSTI (a cura di), CantiereNervi. La costruzione di una identità. Storie, geografie, paralle-li, Milano 2012, pp. 281-284.3 Dopo l’inaugurazione, il primo maggio 1965, i lavoridi completamento della torre continuano anche l’annoseguente. Il materiale documentario e grafico relativo alprogetto è conservato in Archivio Pier Luigi Nervi -MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Ro-ma (d’ora in poi APLN), Archivio Pier Luigi Nervi -Centro Studi Archivio Comunicazione, Parma (d’orain poi CSAC), Archivio Società Generale Immobilia-re Sogene e Archivio Luigi Moretti - Archivio Centra-le di Stato, Roma (d’ora in poi ALM), Archivio priva-to Moretti-Magnifico, Roma (d’ora in poi AMM). 4 LEGAULT, Place Victoria cit., pp. 330-332, 334 eSHEPPARD, Place Victoria cit., pp. 340, 342, 344-347; idisegni sono datati 1960-1965. 5 Alcuni disegni dello Studio Nervi sono editi in VAN-
LAETHEM, Tour de la Bourse-Place Victoria cit., pp. 175-177; il disegno pubblicato a p. 174, con la data 1961, èfirmato da Moretti: se ne trova copia in ALM ed è data-bile, in base ai documenti, all’inizio del 1963 (APLN,P43/3, 4 e 13 febbraio 1963: promemoria e lettera di A.Sheppard a G. M. Padoan).6 APLN, P43/2, dicembre 1961: Place Victoria, dattilo-scritto (d’ora in poi datt.), pp. 1-5. 7 Vedi ROSTAGNI, Luigi Moretti cit., pp. 135-146 e RO-STAGNI, Luigi Moretti. Forma come struttura o struttura co-me forma? cit., p. 281.8 APLN, P43/2, 22 settembre 1961: Speech by Mr. Mar-cello de Leva, datt., p. 2.9 Per l’organigramma completo, vedi APLN, 43/2, di-cembre 1961: Place Victoria, datt., pp. 6-8.10 APLN, P43/2, 11-14 gennaio 1961: verbale, datt., p.1. Per valutare i problemi, soprattutto tecnici, da affron-tare sono presi a modello tre complessi in via di conclu-sione, dei quali il team visita i cantieri durante questoprimo incontro, equiparabili a Place Victoria per pecu-liarità architettoniche, funzioni e resa economica: PlaceVille Marie di Pei (1956-1962), la CIBC Tower di Pe-ter Dickinson Associates (1958-62) e la CIL House diSOM (1958-1962). Inoltre, i partner italiani vengonoedotti riguardo alla vasta messe di normative edilizie lo-cali, e alla disponibilità e gestione dei materiali da co-struzione.11 APLN, P43/2, 21 gennaio 1961: verbale, datt., p. 2.12 V. PONTE, Montreal’s Multi-Level City Center, in«Traffic Engineering», September 1971, pp. 20-25, 78.13 L’incarico viene conferito ufficialmente ai progettistinel marzo 1961 (ROSTAGNI, Luigi Moretti. Forma comestruttura o struttura come forma? cit., p. 281). 14 La testimonianza di Sheppard, collaboratore di Mo-
Nei mesi seguenti, la costruzione procede rapida: il 27 luglio 1964 la topping-off cerimonysancisce la chiusura del 49° piano e il 1 maggio 1965 la Stock Exchange Tower - al-l’epoca, l’opera in cemento armato più alta al mondo, con i suoi 190 metri - viene inau-gurata; l’ipotesi di realizzarne una gemella, invece, tramonta definitivamente nel 197246. Dalle parole dedicate da Moretti alla torre, affiora la consapevolezza che la sua perso-nale battaglia contro il grattacielo prismatico era vinta: «Concepita in modo nuovissi-mo, secondo uno schema architettonico che esalta la forza costruttiva dell’edificio, con-centrandone l’espressione nei quattro pilastri d’angolo» e ancora «per la prima volta an-che lo schema delle grandi pareti vetrate [...] non è stato fatto piano e rigido, ma [...]come se i quattro piloni con la loro forza comprimessero il contenuto spaziale della tor-re»47. Un risultato possibile solo grazie al sodalizio vivo e dialogico tra Luigi Moretti ePier Luigi Nervi48, concordi nel fare della Stock Exchange Tower una straordinariamacchina, non solo tecnica, ma anche emozionale.
99
retti, sembra confermare l’ipotesi: «Una volta gli ho chie-sto [a Moretti]: perchè tre torri? Perchè non due, più al-te e grandi? L’idea fu respinta immediatamente: con tretorri si ha la sensazione di creare un insieme unitario,mentre due avrebbero generato una dualità» (SHEP-PARD, Place Victoria cit., p. 345).15 Il disegno è pubblicato in SHEPPARD, Place Victoriacit., p. 344. 16 ALM, b. 18, 1965?, L. MORETTI, La torre della Borsadi Place Victoria in Montreal, datt., pp. 1-2. Citato in LE-GAULT, Place Victoria cit., p. 330.17 L. MORETTI, Un progetto di Pier Luigi Nervi per un’avio-rimessa a Buenos Aires, in «Spazio», luglio 1950, 1, pp.50-51.18 Vedi disegni in LEGAULT, Place Victoria cit., p. 330e SHEPPARD, Place Victoria cit., pp. 344, 347. 19 Pubblicate in SHEPPARD, Place Victoria cit., p. 344. 20 L. MORETTI, Trasfigurazioni di strutture murarie, in«Spazio», gennaio - febbraio 1951, 4, pp. 5-16.21 Ibid., p. 9. Corsivo mio.22 Ibid., pp. 5, 9.23 Vedi scritto autografo di Nervi in APLN, P43/2, 14marzo 1961: Complesso Montreal. Calcoli orientativi e di-segni, datati 14, 17 e 18 marzo, in CSAC. 24 Vedi disegni in SHEPPARD, Place Victoria cit., pp.346-347.25 APLN, P39/4. Vedi anche appunti del 9 giugno 1961con la comparazione di vari sistemi strutturali (APLN,P39/1).26 Disegni, datati 15 e 23 giugno 1961, in CSAC. 27 Vedi nota 8. 28B. BANTEY, First of Proposed Skyscrapers Would Be Fi-nished In 3 Years, in «The Montreal Gazette», 23 Septem-ber 1961, p. 1. Vedi anche l’opuscolo Montreal. A NewHorizon, s.d. (1961) in ALM, b. 18. 29 APLN, P43/2, 17-18 maggio 1961: verbale, datt., p. 3. 30 APLN, P40/4, 6 febbraio 1962: H. FACCI, The Engi-neering Aspects of the Place Victoria Towers, Montreal, datt.LEGAULT, Place Victoria cit., pp. 330-331 afferma chequesta è la prima versione del progetto, a suo parere pre-sentata nel dicembre del 1961.
31 APLN, P43/3, 12-13, 15 gennaio 1962: verbale, datt., p. 2.32 APLN, P43/4, 5 ottobre 1961: verbale, datt., pp. 1-2. 33 «L’architetto Moretti ha approvato il disegno definiti-vo del pilastro d’angolo [...]. Ci ha confermato di averdiscusso questo dettaglio con il prof. Nervi, il quale neha approvato la sagoma, con le modifiche eseguite il 24aprile» (APLN, P43/3, 24 aprile 1963: promemoria datt.di W. Graff a Pifferi e Cellini). Questa procedura è con-fermata anche da SHEPPARD, Place Victoria cit., p. 349. 34 ALM, b. 18, s.d. (1966?), Place Victoria. A new conceptof total business environment, opuscolo a stampa, s.p.35 APLN, P43/3, 11 luglio 1963: lettera di Q. L. Carlson,vice presidente della Ediltecno Canada, alla EdiltecnoRoma.36 APLN, P43/3, 18 febbraio 1963: verbale, datt., p. 1. 37 APLN, P43/3. L’ing. Cecchi era amministratore de-legato della Ediltecno Roma. 38 Vedi nota 16. 39 L. MORETTI, Valori della modanatura, in «Spazio», di-cembre 1951 - aprile 1952, 6, pp. 6, 12. Corsivo mio.40 APLN, P43/3, 22-23 marzo 1962: verbale, datt., pp.1-7.41 LEGAULT, Place Victoria cit., p. 333; SHEPPARD,Place Victoria cit., pp. 349-350. 42 APLN, P39/5, 16 luglio 1962: Place Victoria St. Jac-ques Co. Montreal Canada. Relazione strutturale, datt.43 APLN, P43/3: Montreal - «Place Victoria Project» - Tor-re n. 1. Rapporto sulla situazione al 20 luglio 1962, datt., p. 6. 44 MORETTI, Trasfigurazione di strutture cit., p. 16. 45 Vedi disegni in SHEPPARD, Place Victoria cit., pp.340, 342. 46 Documenti in ALM, b. 18. 47 Vedi nota 16. Parzialmente citato in LEGAULT, Pla-ce Victoria cit., p. 329. 48 All’indomani del completamento dell’opera, nel 1965,Nervi dichiara a Samaritani come la collaborazione conMoretti fosse stata «particolarmente felice» essendosi ba-sata su «unità di idee e reciproca stima» (citato in RO-STAGNI, Luigi Moretti. Forma come struttura o struttura co-me forma? cit., p. 281).
100
Moretti and Nervi. Some observations on the design ofthe Stock Exchange Tower in Montreal (1960-1965)
The topic of this contribution is the Stock Exchange Tower in Montreal, designedby Luigi Moretti and Pier Luigi Nervi, the only finished building of a great com-
plex named Place Victoria, a compound firstly including three office towers, locatedin a strategic point of the downtown area.Recently, several studies have deepened some relevant, especially technical, features ofthe Canadian building, but both its origin and design development phase have notbeen retraced in detail yet. This survey is then structured on a double track: thanks tothe remarkable amount of recorded documents it is now possible to go through the sto-ry of Place Victoria, almost day by day, whereas by examining the sketches by Moret-ti and Nervi the main technical, architectural and formal issues are highlighted. A massive financial machine was activated to design and build the whole project:“Place Victoria - St. Jacques Co. Inc.”, born in 1960 from the partnership betweenthe Mercantile Bank of Canada and the Società Generale Immobiliare di Roma (SGI),supported by Canadian and Italian sponsors. If the ambitious scale of the design proj-ect is justified by the importance of the investment, choosing Moretti, the “official” ar-chitect of SGI, and Nervi, above all, - “the ‘wizard’ of modern reinforced concrete”-sealed the fate of the towers from the outset, by using a material - reinforced concrete -that was so unusual for tall buildings that became a promotional feature of the designproject.
The Italian “Master Builders” were assisted by a numerous technical staff, coordinat-ed by Project Manager Edward Landway from the Panero-Weidlinger-Salvadori stu-dio, where different professionals worked in; including architects Greenspoon, Freed-lander & Dunne and engineers d’Alemagne & Barbacki, playing a central role in thestory of the compound. There were many problems to be tackled. Montreal is a very delicate place from a seis-mic point of view and subject to elevated temperature excursions - these were standardsthat, together with the incidence of the wind, have to be considered when designingtall buildings. During the first coordination meetings, in early 1961, the main - tech-nical, urban and architectural - aspects were debated; furthermore, the Canadian partprovided their Italian partners with a wide range of technical and information materi-al. These were the basis from which Moretti and Nervi started developing their first de-sign version between February and July 1961. The drawings, which can be better interpreted if integrated with documents, prove thedifferent design approach the two masters had, even though it is clear that the multiple
101
changes of direction that Moretti creative pathway undertook, in this and followingphases, depended on the development of design project, that was managed simultane-ously by the Studio Nervi and vice versa. Moretti focused on the coordinated locationof the three towers, 51 floors each, laid on a sort of articulated basement floor. His draw-ings reveal how, as a result of the surveys he had carried out since a young age, he man-aged to establish an expressive dialogue between the towers as a whole - keeping theirdistance from coeval prismatic skyscrapers - and the urban fabric, almost without con-sidering technical solutions. On the other hand, Studio Nervi, from the first sketches,focused on a single square-shaped tower-type, supported by four massive corner pi-lasters and a central core made of two crossing beams. On 22nd September 1961 «the largest office complex in the world» was publicly pre-sented: the first of the two towers, named Stock Exchange Tower, housing the stockexchange and other prestigious companies, was scheduled to be built within 1964, theother two towers would have to be completed in the following ten years. Nevertheless,the project was cut down dramatically in November 1962, when the number of tow-ers was reduced to two. The Stock Exchange Tower building site opened in June 1963,the topping-off ceremony took place on 27th July 1964 and the tallest concrete building inthe world, 190 m high, was officially inaugurated. The idea to build a twin tower fi-nally failed in 1972, instead.
So, what happened in the two years between the presentation of the design project andthe beginning of the construction phase? The documents indicate an everlasting trial ofstrength between the Italian and the Canadian parts: the main topics for discussionwere the corner pilasters, determining the structural and architectural expression of thetower and whose ultimate section was outlined in April 1963, but also the position ofthe intermediate piers, affecting, on the other hand, the appearance of the external part,which may have been specifically provided by Moretti. The pragmatic attitude of theCanadian team, careful at reducing costs by looking for the most convenient solution,was opposed by the architect’s iron will, sympathetic with Nervi in this matter, to main-tain all the formal and technical features of the design project. The goal was achieved,eventually: as Moretti declared, the Stock Exchange Tower was “conceived in an in-novative way, according to an architectural scheme emphasising the building strenghtof the tower, whose expression is focused on the four corner pilasters” as if “they couldsqueeze the spatial content of the tower”.























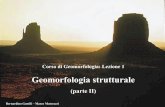












!["Un filosofo mancato" Aporie della concezione plotiniana della natura ["A Philosopher manqué". On Some Difficulties in Plotinus' Doctrine of Nature]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63240d803c19cb2bd106ce51/un-filosofo-mancato-aporie-della-concezione-plotiniana-della-natura-a-philosopher.jpg)




