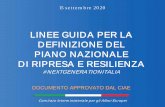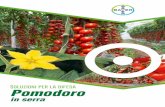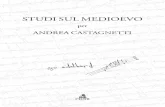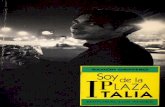M. Reali, Gli Insubres nella tradizione erudita: una “identità immaginata”?, in A. Sartori, A....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of M. Reali, Gli Insubres nella tradizione erudita: una “identità immaginata”?, in A. Sartori, A....
FRATELLI LEGA EDITORIFAENZA
EPIGRAFIA E ANTICHITÀ
29
MAURO REALI
GLI INSUBRESNELLA TRADIZIONE ERUDITA:
UNA «IDENTITÀ IMMAGINATA»?
MAURO REALI
GLI INSUBRES NELLA TRADIZIONE ERUDITA: UNA «IDENTITÀ IMMAGINATA»? *
L’integrazione, argomento dei due nostri precedenti incontri, mi aveva portato a parlare (nel 2005, qui a Gargnano) di mesco-lanza etnica e culturale nell’Ager Insubrium, e dunque, in un certo senso, di «identità» (1); ma nondimeno di «autonomia», quando (nel 2008, a Pamplona-Olite) affrontai il tema della persistenza di microcomunità locali in età romana (2). Non volendo ripetere cose già dette, parlerò oggi di identità sotto un particolare punto di vista, al fi ne di capire quanto i concetti antropici e geo-storici di Insubres e Insubria (3) siano divenuti un elemento identitario caratterizzante nella tradizione degli studi eruditi lombardi (4).
* Un cordiale ringraziamento a Enzo Matera, Sandro Piazzesi e Antonio Sartori, per avere discusso con me alcune problematiche pertinenti a questo lavoro, nonché a Chiara Milani, Diret-trice della Biblioteca Comunale di Como, per avermi consentito l’accesso ad alcuni manoscritti ivi conservati.
(1) REALI, 2006, pp. 305-325 (2) REALI 2010, pp. 93-108. (3) È prassi abbastanza consolidata delimitare l’Ager Insubrium alle realtà di Mediolanum e
Comum; tale defi nizione – certamente imprecisa e comunque insuffi ciente – è motivata da ragioni di natura strettamente convenzionale. D’altronde anche chi, come Ulrico Agnati, ha allargato in un suo studio epigrafi co di carattere statistico l’area insubre anche a Ticinum, Laumellum e ai loro Agri, ha dovuto ammettere che questo territorio – che pure presenta alcune caratteristiche di omogeneità – «è evidentemente il frutto di una serie di ritagli operati per ragioni di studio» (AGNATI 1997, p. 169). Poiché non è certo questa la sede per una riconsiderazione dell’area insubre, rimando a GRASSI 1995 ed EAD. 2005, con vasta bibliografi a. Per quanto concerne gli aspetti culturali, sociali e antropici degli Insubres in epoca romana si vedano alcuni fondamentali studi di Antonio Sartori (come SARTORI 2000, pp. 55-70, oppure ID. 2010, pp. 15-24, o lo stesso intervento contenuto in questi Atti), ma anche i miei REALI 2004, pp. 69-86 e ID. 2010, pp. 93-108.
(4) Brevi ma effi caci osservazioni sul concetto di Insubria nella tradizione erudita sono in DIONIGI 2000, pp. 24-31, nonché in ID. 2002, passim. Ancora più pertinente all’argomento del mio lavoro è quanto contenuto in STORTI 2002, pp. 20-47; infatti Claudia Storti parla esplicitamente del forte valore identitario che i termini Insubres e Insubria ebbero nella storiografi a umanistica: valore che si mantenne pure nei secoli successivi, tanto da fungere da trait d’union tra antichità e modernità, anche in momenti di crisi del patriziato lombardo o di dominazione straniera di quello che fu il «territorio insubre».
368 MAURO REALI
Lo farò esaminando tre raccolte epigrafi che redatte tra il Cin-quecento e Seicento ad opera di Gaudenzio Merula, Bonaventura Castiglioni e Girolamo Borsieri; autori – per così dire – mino-ri poiché sui «mostri sacri» dell’Umanesimo epigrafi co lombar-do (5), e cioè Benedetto Giovio e i suoi Collectanea di iscrizioni di Comum (6), o Andrea Alciato e la sua importante Silloge epigrafi -ca milanese (7), hanno già scritto altri autorevoli studiosi.
Inizierò con Gaudenzio Merula, valido umanista di origine novarese, che editò nel 1538 un De Gallorum Cisalpinorum Anti-quitate ac Origine (8), opera in tre libri che menziona 29 iscrizioni latine (9). Il Merula, che sentì la «centralità» dell’eredità insubre, cercò anzitutto di dare dell’Insubria una nozione geografi ca pre-
(5) Oltre ai lavori specifi ci menzionati alle note successive è sempre utile il quadro d’insieme della cultura antiquaria del maturo umanesimo lombardo proposto in BARNI 1957, pp. 423-457.
(6) Il riferimento è all’opera manoscritta del dotto comense Benedetto Giovio (1471-1543), intitolata Veterum monumentorum quae tum Comi tum eius in agro reperta sunt collectanea (chi scrive ne ha visto i mss. Z 45 Sup. e G. 296 Inf. della Biblioteca Ambrosiana di Milano, nonché il ms. 4.4.12 della Biblioteca Civica di Como). Sul Giovio epigrafi sta sono ancora validi gli spunti proposti in CALABI 1972, pp. 5-37, da integrare con numerose osservazioni contenute negli studi relativi all’Alciato menzionati alla nota successiva.
(7) Per quanto concerne la Silloge epigrafi ca di Andrea Alciato (1492-1550), questa presenta – nei vari esemplari superstiti – titoli differenti: della complessa cronologia e della differente qualità di questi manoscritti si parla in CALABI 1999, pp. 28-35. Ida Calabi Limentani, infatti, cerca di defi nire tre fasi, partendo dal più antico e autografo «codice Trotti 353» (ora alla Biblioteca Am-brosiana), passando attraverso numerosi esemplari di «libro album» conservati in varie biblioteche milanesi e non, per fi nire al «codice di Dresda», arricchito di nuove iscrizioni. Non va comunque dimenticato che esiste un’edizione anastatica della silloge alciatina (riproduzione del cosiddetto «codice Biraghiano»), pubblicata a Milano nel 1973 a cura di Gianluigi Barni (= BARNI 1973): il titolo di questo manoscritto è Antiquae inscriptiones vateraque monumenta patriae. Sull’Alciato epigrafi sta, oltre al citato studio di Ida Calabi Limentani vanno menzionati BELLONI 1999 e SAR-TORI 1999, studi derivati da comunicazioni tenutesi in un convegno del 1993 dal titolo Andrea Alciato. Umanista europeo. Pur non riguardando prettamente la cultura epigrafi ca dell’Alciato, va citato anche il ricco e moderno commento (con numerose suggestioni bibliografi che) al Libro degli emblemi alciatino, curato da M. Gabriele (= ALCIATO 2009).
(8) Gaudenzio Merula (1500-1555) fu un erudito eclettico – che svariò dalla storia, alla geografi a, alla fi lologia – ed è considerato tra i maggiori esponenti della cultura del suo tempo, vero «principe degli umanisti novaresi», come lo defi nì Carlo Ramponi (RAMPONI 1955, pp. 189-196). I suoi rapporti di amicizia con Monsignor Bonaventura Castiglioni (v. infra) non solo si concretizzarono nei numerosi riferimenti castiglionei all’autorità dell’amico su questioni epigrafi -che o storico-geografi che, ma ebbero anche risvolti più personali: l’inquisitore Castiglioni «salvò» infatti il Merula dalla pericolosa accusa di contiguità con il luteranesimo. Il suo De Gallorum Cisalpinorum Antiquitate ac Origine, Lugduni 1538 ebbe numerose edizioni successive: quella che ho potuto consultare fu stampata a Bergamo nel 1593 (= MERULA 1593). Impossibile scindere la bibliografi a relativa ai suoi interessi epigrafi ci da quella dell’amico Castiglioni: segnalo pertanto – oltre a qualche specifi ca osservazione in CIL V, 2, pp. 627-628 – BERTAPELLE 1993-94, pp. 54-68, ma anche passim i miei REALI 2007 e ID. 2009A. Interessante qualche cenno su di lui anche in DIONIGI 2000, p. 27, come pure in SALMERI 1988, p. 306, nota 83.
(9) Le iscrizioni menzionate dal Merula nel suo lavoro sono: CIL V, 5472, 5478, 5491, 5503, 5604, 5595 (insieme con 6052), 5607, 5713, 5724, 5747, 5762, 5768, 5839, 5850, 5851, 5870, 5890, 5893, 5953, 5955, 5956, 5985, 6036, 6244, 6522, 6270, 6522, oltre ad una che riporterebbe il testo del ponte sul Rubicone. Non aggiungo altro perché vorrei riprendere la rifl essione sull’atteggiamento del Merula davanti alle epigrafi in un prossimo lavoro.
GLI INSUBRES NELLA TRADIZIONE ERUDITA: UNA «IDENTITÀ IMMAGINATA»? 369
cisa con la formula Quidquid terrarum, et urbium intra Ticinum, et Abduam, Padum et Alpeis clauditur, Insubria nominatur (10). Ma, soprattutto, «spese» ben 18 delle sue iscrizioni a corredo del capitolo V del primo libro, che è intitolato De familiis Insubrum et antiquissimis et clarissimis, creando una sorta di immaginaria con-tinuità tra un passato gallo-romano – fatto di nobili gentes latine – e un presente fatto di più o meno nobili famiglie lombarde che da esse derivano (11).
Tra le molte forzature interpretative merita particolare inte-resse quella relativa all’epigrafe milanese CIL V, 5890, desunta dall’Alciato: vi si menziona infatti un L(ucius) Titucius Merula, che il Nostro considera una sorta di antenato della sua stessa fa-miglia (12). La ricerca di legami con una comunità antica più «im-maginata» che reale – quella degli Insubri – porta dunque l’eru-dito a riappropriarsi di questo passato in prima persona, in forma soggettiva prima ancora che comunitaria. Egli pertanto non è solo erede di quel tempo, ma se ne sente ancora parte, con un evidente processo di eternizzazione di un periodo storico (13). Poco im-porta che tutto ciò sia o meno autentico: «l’imbroglio, l’illusione, la fi nzione» – cito alla lettera parole dell’antropologo Ugo Fabiet-ti (14) – sono sovente alla base della costruzione di un’identità.
Partendo da Gaudenzio Merula è facile arrivare al suo amico Monsignor Bonaventura Castiglioni (15), il cui Gallorum Insu-
(10) MERULA 1593, p. 32. (11) Il capitolo è alle pp. 28-29 di MERULA 1593. Sull’importanza della legittimazione della
nobiltà ad ogni costo, anche a costo di etimologie forzate o genealogie fantasiose, alcuni esempi in DONATI 1988, spec. pp. 93-290.
(12) L’iscrizione è menzionata in MERULA 1593, p. 18; il suo testo è noto solo da tradizione erudita e suscita più di una perplessità anche nella lezione suggerita dal CIL, e cioè: Trebia C(ai) f(ilia) Philumena / sibi et L(ucio) Titucio Merulae / VI vir(o), III vir(o), IIII vir(o) (sic!) testa/mento fi eri iussit.
(13) La letteratura di taglio antropologico presenta numerosi casi nei quali si costruiscono identità «dividendo, estraendo, classifi cando, irrigidendo ed eternizzando in una formula – cultura, tribù, etnia – una realtà (parziale) colta in un certo momento del fl usso storico in cui essa è inserita» (FABIETTI 1998, p. 82). Il concetto di identità è infatti oggetto di numerosi studi antropologici, che è pressoché impossibile menzionare in questa sede; e se il citato FABIETTI 1998 è comunque un buon punto di partenza (anche per la ricca bibliografi a), citerò anche ANDERSON 2000, che riprenderò infra, MATERA-FABIETTI 1999, che lega l’idea di identità a quella di memoria, nonché il recente REMOTTI 2007, che – come già anche aveva fatto l’Anderson – mette in luce i rischi di un’esasperazione dell’idea di appartenenza identitaria. Sulla necessità – per noi antichisti – di un approccio prudente a questo tipo di studi è utile leggere il contributo di Antonio Sartori in questi Atti.
(14) FABIETTI 1998, intitola Cultura, tribù, etnia: «imbroglio», illusione, fi nzione un capitolo del suo libro (pp. 51-71).
(15) Una completa biografi a del Nostro (Milano, 1478-1555) si trova in PALMA 1979, pp. 124-126, con adeguata bibliografi a. Per quanto concerne la sua attività erudita, egli è menzionato
370 MAURO REALI
brum Antiquae sedes fu dato alle stampe nel 1541 (16). L’auto-re fu un membro autorevole del clero ambrosiano, prevosto di Sant’Ambrogio e quindi commissario generale per l’Inquisizione nel Milanese, e la sua opera appena menzionata è la descrizione
in BARNI 1957 (spec. pp. 429-430) e BELLONI 1999, passim. I suoi interessi epigrafi ci – evidenti nel Gallorum Insubrum Antiquae sedes – sono ben noti al Mommsen, che inserisce Bonaventura Castiglioni nell’elenco degli autori di consultazione primaria per l’epigrafi a milanese (CIL V, 2, p. 628); su tale aspetto della sua personalità culturale si vedano soprattutto i miei REALI 1991, pp. 213-218; ID. 2007, pp. 221-135; ID. 2009, pp. 174-194, e una tesi di laurea inedita di alcuni anni fa, cioè BERTAPELLE 1993-94.
(16) Del volume di Bonaventura Castiglioni, Gallorum Insubrum antiquae sedes, Milano1541 (pp. 133 + indici) ho consultato la copia conservata presso la Biblioteca Braidense di Milano (= CASTIGLIONI 1541). È stata proposta nel 2008 una ristampa anastatica, corredata di traduzione italiana (fatta da Paolo Mathlouthi), di un’edizione successiva stampata a Bergamo nel 1593, che chiamerò convenzionalmente CASTIGLIONI 2008; essa comprende anche alcune note antiquarie (di G. Minella, alle pp. 7-10), epigrafi che (di M. Pasquero, alle pp. 169-177), archeologiche (di M. Rapi, alle pp. 179-206).
Fig. 1. Particolare da A. ORTELIUS, Parergon sive Veteris Geographiae aliquot Tabulae,del 1595 (riprodotta da DIONIGI 2000, pp. 86-87).
GLI INSUBRES NELLA TRADIZIONE ERUDITA: UNA «IDENTITÀ IMMAGINATA»? 371
dell’antico Ager degli Insubres, con particolare attenzione all’area tra Como e Varese. Oltre alle fonti letterarie, egli trascrive senza troppa precisione 43 iscrizioni latine (17), in parte desunte dal-l’Alciato e dal Giovio, al fi ne di documentare l’antichità delle fa-miglie insubri o svelarne i mores e la pietas religiosa.
Chi vi parla ha studiato a lungo questo testo (18); perciò gli esiti di ricerche già pubblicati saranno oggi solo accennati, per lasciar spazio a una signifi cativa novità.
Possiamo dire anzitutto che, come e forse più che nel caso precedente, l’opera castiglionea rappresenti un caso di rilettura del passato mediante il fi ltro della cultura e dei valori dell’autore, il quale dà della storia dell’Italia antica un’interpretazione davvero singolare (19): l’invasione gallica, il sacco di Roma (Roma a Gallis capta) come eventi cardine, e poi l’omologazione della storia dei Galli con quella dei Romani, tramite una consapevole censura dei loro confl itti. E tale ricerca di una «galloromanità» – per così dire – ad personam, è evidente anche nel catalogo epigrafi co: ne è un esempio il fatto che il Nostro insista di più nel commento delle cinque dediche sacre a Mercurio – divinità che Insubribus maxi-mo honori fuerat (20) – piuttosto che in quello a sette dediche a Giove; dio, quest’ultimo, storicamente troppo legato al «centro del potere» romano agli occhi di un apologeta dell’Insubria anti-ca, e che in virtù della qualifi ca di Ottimo Massimo era forse per-cepito quale pericoloso rivale del Deus Optimus Maximus della religione cristiana.
Ma il capolavoro di Bonaventura Castiglioni è di natura, per così dire, topografi ca, e cioè affermare che l’oppidum celeberri-mum quod ab eorum nomine Insubrium vocarunt, sarebbe Castel-seprio, nel territorio Varesino, poiché nos qui loca ferme omnia Insubrum qui ad Colles iacent perlustravimus, in quibus precipue eorum vetustae sedes extitere, pro comperto habemus eas fuisse ubi
(17) Un loro completo elenco, con un moderno conguaglio bibliografi co, è in REALI 2007, pp. 126-127; la loro trascrizione, a cura di M. Pasquero, è alle pp. 169-177 di CASTIGLIONI 2008.
(18) Alludo soprattutto ai miei REALI 2007, pp. 221-135 e ID. 2009A, pp. 174-194, nei quali ho affrontato molte questioni relative alla cultura epigrafi ca e antiquaria del Nostro, analizzando il problema del suo rapporto con le fonti (Merula, Giovio, Alciato…) e della correttezza delle sue trascrizioni (REALI 2007), e inserendo quindi il suo lavoro nella temperie culturale e valoriale della Lombardia controriformistica (REALI 2009A). Tutto quanto accennerò infra, trova in questi studi la propria giustifi cazione: pertanto vi rimando, evitando così di citarli continuamente.
(19) Lo fa specialmente nelle prime pagine dell’opera, e cioè CASTIGLIONI 1541, pp. 5-16 = CASTIGLIONI 2008, pp. 25-33.
(20) CASTIGLIONI 1541, p. 105 = CASTIGLIONI 2008, p. 95.
372 MAURO REALI
Castri Seprii vulgo reliquiarum disiecta vestigia visuntur (21). Cer-to Castelseprio ancora oggi mostra segni di un passato romano (per lo più tardo), e vanta una discreta documentazione epigra-fi ca (22); ma da ciò pensare che fosse questa – e non Mediola-num – la vera «metropoli» di quegli Insubres che abitavano inter Ticinum et Abduam, penes quos Cisalpinorum omnium authoritas fuit (23) è davvero troppo!
Eppure, al di là delle acrobazie etimologiche dell’autore il motivo di tale identifi cazione – pure da lui taciuto – è piuttosto chiaro: i resti di Castelseprio si trovano nei pressi di Castiglione Olona, centro che dai nobili Castiglioni prese il nome e col quale l’erudito aveva grande consuetudine. E io non so se il grande car-tografo fi ammingo Abramo Ortelius abbia mai sfogliato il Gallo-rum Insubrum antiquae sedes o abbia attinto ad altre fonti; eppu-re nel suo Parergon sive Veteris Geographiae aliquot Tabulae, del 1595 ( Fig. 1), in pieno territorio degli Insubres, lungo un fi ume che parrebbe l’Olona, egli colloca il toponimo di Insubria, in una posizione del tutto compatibile con quella di Castelseprio (24). Insomma, se Gaudenzio Merula vantava la detenzione di un nome romano, Bonaventura Castiglioni si gloriava invece di appartenere a una famiglia originaria del caput Insubriae: un altro tassello nella creazione di una «comunità immaginata» che mescola Galli e Ro-mani, pagani e cristiani e – soprattutto – passato e presente.
Giungo ora all’autore sul quale ho di recente lavorato più a lungo, tanto che dovrò riprendere con maggiore ampiezza in altra sede gli esiti delle mie ricerche. Si tratta di Girolamo Borsieri, comense, attivo nella prima fase del Seicento nell’entourage del cardinale Federigo Borromeo: egli fu – come l’ha defi nito l’ita-lianista Sandro Piazzesi – «un colto poligrafo», che svariò dalla
(21) Le citazioni latine relative a Castelseprio sono in CASTIGLIONI 1541, p. 15 = CASTIGLIONI 2008, pp. 32-33. Rimando anche alla traduzione italiana in CASTIGLIONI 2008, pp. 129-139, note 13-16; in queste note si commenta brevemente non solo l’identifi cazione di Castelseprio con il «mitico» centro di Insubrium, ma anche la questione etimologica relativa al mutamento di questo nome in Seprii Castrum: infatti il Castiglioni non pensa che il toponimo sia una deformazione di Severi Castrum, che presupporrebbe un legame con l’imperatore Severo.
(22) La bibliografi a su Sibrium e sulla Castelseprio medievale è ricchissima, e verte so-prattutto sulle strutture di fortifi cazione d’epoca tardo-antica e sulla straordinaria chiesa d’epoca longobarda di Santa Maria foris portas. Non mancano però anche studi sull’età romana, per la quale si vedano – da ultimo – le note in MARIOTTI 2009, pp. 58-59, ed alcune osservazioni passim in DE MARINIS-MASSA-PIZZO 2009, opera nella quale lo studio della Mariotti è contenuto.
(23) CASTIGLIONI 1541, p. 6 = CASTIGLIONI 2008, p. 26. (24) Non intendo addentrarmi in una disciplina – come la cartografi a – del tutto estranea
alle mie competenze, anche perché la mia consultazione di questa celebre carta di Abramo Ortelius (1528-1598) è avvenuta esclusivamente attraverso la «mediazione» di DIONIGI 2000, pp. 86-87.
GLI INSUBRES NELLA TRADIZIONE ERUDITA: UNA «IDENTITÀ IMMAGINATA»? 373
musica, alla poesia baroccheggiante, alla storiografi a, alla critica d’arte (25). Scrisse però anche una monumentale opera in 24 libri, mai pubblicata, dal titolo Theatrum insubricae magnifi centiae (26), nota al Mommsen ma in seguito largamente sconsiderata: essa era stata pensata, come dice lo stesso autore in una lettera ad Ettore Capriolo, quale «raccolta delle nostre antichità, particolarmen-te delle inscrittioni da me spiegate nel miglior modo ch’io pos-so» (27). Tale sforzo gli sarebbe stato chiesto dallo stesso Federigo Borromeo, cui il lavoro era dedicato; egli ambiva così a continuare l’opera di Andrea Alciato e di altri suoi degni epigoni, ma anche a purgare le hallucinationes – sono parole sue – di alcuni ignoranti Alciati scholiographi che si sono accostati alle antichità tamquam asini ad lyras (28). L’interesse geografi co svaria dal territorio di Milano, a quelli di Como, Novara e perfi no Lodi.
Il Theatrum, in realtà, ci resta in forma assai mutila. Anzitutto quel che si legge in un manoscritto autografo della Biblioteca di Como (4.4.21), che contiene i primi quattro libri (dove si raccol-gono iscrizioni pertinenti alle res sacrae) e qualche altra pagina sparsa; a ciò vanno aggiunti fogli (non pochi, in verità, poiché menzionano un centinaio di epigrafi …) contenuti in codici mi-scellanei conservati senz’altro a Parigi e forse ad Utrecht (29). Ho
(25) Gli studi – in verità neppure troppo numerosi – su Girolamo Borsieri (1588-1629) trovano nella ricca e recente monografi a PIAZZESI 2009, un importante momento di confl uenza: a questa rimando, come pure al più sintetico CARAMEL 1971, pp. 124-125. Impossibile però non citare anche GIUSSANI 1936, pp. 138-139; GATTI 1959, pp. 383-389; CARAMEL 1966, pp. 91-235.
(26) Sulle complesse vicende di questo lavoro si veda PIAZZESI 2009, pp. 109-113. Il Piazzesi, in queste pagine cerca di comprenderne l’ideazione e la redazione di un brogliaccio preparatorio defi nito Adversaria nel senso di «appunti». Parte di tale brogliaccio, e cioè il primo tomo, è con-servata – dopo vari «passaggi di proprietà» – nella Biblioteca Civica di Como, ed è il ms. 4.4.21 (= BORSIERI, Como), mentre gli altri due tomi furono portati a Lione dal fratello Alessandro. Questa dispersione è per noi molto problematica, perché il Mommsen (CIL V, 2, p. 631) parla di excerpta borsieriani – menzionanti alcune epigrafi – sia a Parigi (Parisinus Lat. 5894; Parisinus Lat. 8957) che ad Utrecht (in biblioteca Traiectina misc. 56 f. 89-95). Tra le note del lavoro del Piazzesi apprendo che in effetti i codici della Biblioteca Nazionale di Parigi 8957-8958 contengono un miscellanea di epigrafi dall’Italia e dalla Francia: maggiori dettagli sono preannunciati in un futuro lavoro di Paolo Vanoli (PIAZZESI 2009, pp. 110-111, nota 448). Nulla ho invece trovato sui presunti manoscritti di Utrecht.
(27) La citazione è riportata in PIAZZESI 2009, pp. 110-111; proviene dalla lettera al Sig. Hettore Capriolo, Milano, ms. sup. 3.2.43, pp. 294-295.
(28) La frase si trova in BORSIERI, Como, alla p. 105 del Proemium. (29) Vedi supra, nota 26. L’autografi a del manoscritto comense è oggi sostenuta da PIAZZESI
2009, a differenza da quanto sostenuto dal Mommsen in CIL V, 2, p. 631. Ho parlato personal-mente della questione con Sandro Piazzesi, il quale – soprattutto per motivi paleografi ci – non ha dubbi nel riconoscere la «mano» di un autore del quale ha visionato numerosi manoscritti; personalmente ritengo un ulteriore elemento a favore di questa ipotesi la frequenza di correzioni, cancellature, ripensamenti: questi farebbero pensare più alla penna di chi sta ideando il testo che a quella di uno che lo sta copiando.
374 MAURO REALI
lavorato solo sul manoscritto comense, condizionato non poco dal giudizio del Mommsen, che – pur con qualche distinguo – consi-dera il Nostro un confuso compilatore, dipendente per lo più dal Giovio e dall’Alciato, ai quali sovrappone ad arte decine di altre fonti (alcune libresche, altre autoptiche, in qualche caso addirittu-ra inventate) per accentuare la credibilità del suo scritto (30).
Certo, Borsieri consulta largamente l’Alciato poiché la mag-gior parte delle 140 iscrizioni del manoscritto comense compare già nei vari codici dell’Alciato stesso; sono però ben 48 i testi bor-sieriani che l’Alciato non menziona. E dipende pure dal Giovio, almeno per 16 testi, nonché da Bonaventura Castiglioni, che pro-poneva già 18 dei testi del Theatrum: e sui debiti del Nostro, po-tremmo andare avanti a lungo… Eppure per 18 epigrafi Borsieri è editio princeps nel CIL, anche se solo in 15 casi – 15 su 140, ri-badisco – formule come ex lapide o ex marmore lasciano supporre un’avvenuta autopsia.
Dobbiamo dunque assolvere il Borsieri dalle accuse del Mom-msen oppure ribadirne la condanna? Questo è un convegno, non un processo: mi limiterò dunque a esaminare qualche situazione campione, che mi consentirà di inquadrare meglio l’opera in esa-me nella temperie culturale della sua epoca. Sicuramente errori ce ne sono, come quando l’autore dice di avere desunto CIL V, 5693, da Vertemate (31), dall’Alciato, che mai cita questa iscrizione; op-pure quando fraintende CIL V, 5451, da Arcisate (32) (Fig. 2), an-cora oggi ben leggibile: e poco importa se – come dice lui – l’abbia desunta ex Torniello et Merula iuniore oppure – come sospetta il Mommsen – ex libris, poiché già edita da Castiglioni e Alciato.
Più convincente è il caso della celebre ara di Angera (CIL V, 5472) (33) (Fig. 3), dove il Nostro è preciso nel testo (Fig. 4),
(30) Così, tra l’altro, commenta il Mommsen in CIL V, 2, p. 631: Industria certe auctori [scl. al Borsieri] non defuit. Sed collectaneis eius caute utendum est. Nam primum veros auctores studiose celat, et exempli causa ex Iovio et Alciato quae sumpsit, passim proponit sub nominibus diversis, fortasse possessoris codicis vel amici ex codice eo titulum, quem Borsierio mitterent ut fi t, mutuati. Denique quamquam inscriptiones non confi nxit, tamen quae sibi displicerent, saepe coniunctura emendavit, etiam saepius hiatibus interpositis celavit. Quam ob rem in titulis ante descriptis exigua est utilitas Borsierianorum; sed quos ipse ex marmore excepit vel accepit exceptos ab amicis, neglegendi non sunt, neque exiguam iacturam ars nostra passa est Borsierianis plerisque omissis.
(31) CIL V, 5693: Herculi / Iuveni P(ublius) / Quinctius / de re / sua. (32) CIL V, 5451: Mercurio / L(ucius) Cominius / Pollio miles / leg(ionis) XIII / Gem(inae) /
benefi ciarius / legati consularis / aram et tectum / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). L’iscrizione vanta innumerevoli riedizioni, tra le quali segnalo le mie REALI 1989, nr. 40; ID. 2009B, pp. 78-80. Rimando a queste pubblicazioni per la fotografi a dell’iscrizione, come pure al mio REALI 2007, p. 131 per l’immagine della trascrizione del Castiglioni.
(33) CIL V, 5472; ecco il testo come proposto – da ultimo – in SARTORI 2009, pp. 366-367:
GLI INSUBRES NELLA TRADIZIONE ERUDITA: UNA «IDENTITÀ IMMAGINATA»? 375
Fig. 2. CIL V, 5451, da Arcisate (VA), come riprodotta in BORSIERI,
Como, p. 95.
Fig. 3. CIL V, 5472, da Angera (VA); Milano, «Civiche Raccolte
Archeologiche».
376 MAURO REALI
Fig. 4. CIL V, 5472, da Angera (VA), come riprodotta in BORSIERI, Como, p. 39.
Fig. 5. CIL V, 5472, da Angera (VA), come riprodotta dall’Alciato (da BARNI
1973, p. 155).
GLI INSUBRES NELLA TRADIZIONE ERUDITA: UNA «IDENTITÀ IMMAGINATA»? 377
Fig. 6. CIL V, 5226, da Brienno (CO); Milano, «Civiche Raccolte Archeologiche».
Fig. 7. CIL V, 5226, da Brienno (CO), come riprodottain BORSIERI, Como, p. 134.
378 MAURO REALI
Fig. 8. CIL V, 5246, da Como; Como, «Museo Giovio».
Fig. 9. CIL V, 5246, da Como, come riprodottain BORSIERI, Como, p. 143.
anche se nel disegno certo meno elegante del pictor che supportò l’Alciato (Fig. 5). Ed ancor maggiore è lo zelo nel ricopiare due arule da Brienno ora a Milano, cioè CIL V, 5225 e 5226 (34) (Fig. 6), delle quali Borsieri è editio princeps (Fig. 7); inoltre, sicura-mente ex marmore descrisse CIL V, 5246 (35) da Como (Fig. 8),
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / P(ublius) Quartius P(ubli) / f(ilius) Victor / P(ublius) Quartius Verus / (sex)vir/ -i? iun(ior/ -es?).
(34) CIL V, 5225 = REALI 1989, nr. 7: Iovi / O(ptimo) M(aximo) / P(ublius) Caesius / Ar-chigenes / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito); CIL V, 5226 = REALI 1989, nr. 8: Matro/nis / P(ublius) Caesius / Archigenes / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) = REALI 1989, nr. 8.
(35) CIL V, 5246 = SARTORI 1994, p. 21: Fortunae / Obsequenti / ord(o) Comens(ium) / voto pro / salute civium / suscepto.
GLI INSUBRES NELLA TRADIZIONE ERUDITA: UNA «IDENTITÀ IMMAGINATA»? 379
dove l’exemplum borsieriano (Fig. 9) non ha nulla a che invidiare a quello del prestigioso Giovio (Fig. 10).
Prodotto eterogeneo, dunque, il Theatrum, viziato dalla sua stessa mole, da un uso impreciso delle fonti, da qualche imperizia dell’autore e dalla scarsa propensione all’autopsia dei monumen-ti. Eppure – come lo stesso Mommsen scriveva – industria certe auctori non defuit. Un’industria carica di entusiasmo e campani-lismo, come quando attribuisce all’insubre Mediolanum un testo di tradizione alciatina – peraltro arduo e malamente trascritto – il quale è nientemeno che CIL XIII, 1036 (36), l’arco onorario per
(36) La complessità e la diffi coltà di lettura di questo testo (CIL X, 1036 = AE 1980, nr. 626) sono tali da suggerire di non proporne né una trascrizione né una rifl essione critica adeguata, del tutto estranea all’argomento del presente contributo.
Fig. 10. CIL V, 5246, da Como, come riprodotta da Benedetto Giovio(ms. 4.4.12 della Biblioteca Civica di Como).
380 MAURO REALI
Germanico nella città gallica di Mediolanum Santonum, l’attuale Saintes, in Francia. Ma per il Nostro, l’unica Mediolanum possi-bile era ovviamente Milano, la città dove a lungo aveva vissuto, sede della cattedra arcivescovile dell’amico Federigo Borromeo. Quest’ultimo, fi n dal momento del suo insediamento (1595), ave-va voluto dare alla sua Diocesi un’impronta ben precisa, mediante la valorizzazione di tutte le arti – nelle quali egli vedeva il rifl esso della sapienza e della bellezza di Dio – nonché la formazione di uno staff di dotti specialisti in ogni ambito umanistico, ed anche antichistico (37).
Dedicare a Federigo il Theatrum signifi cava dunque per il Borsieri offrirgli un quadro della magnifi centia dell’Insubria di ieri in quanto prefi gurazione della magnifi centia della Lombar-dia borromaica, ancorché sottomessa al dominio spagnolo: anche questa è stata – a suo modo – una relazione Iberia-Italia! La Lom-bardia della Biblioteca Ambrosiana di Milano, del Sacro Monte di Varese, dei quadri di Cerano, Procaccini e Morazzone (38). Le modeste epigrafi degli antenati, ma anche le loro monete o i loro bassorilievi (39), diventavano dunque – come e più di quanto era avvenuto qualche decennio prima per il Merula e il Castiglioni – un contributo fi nalizzato a costruire l’identità di una comunità «immaginata», un’operazione simbolico-culturale di trasmissio-ne di una memoria condivisa e sacralizzata. Complice di questa operazione era il latino, medium che accomunava questi umanisti con i loro antenati; e quando il latino – dopo il 1640 – perse il primato nei libri a stampa, secondo lo studioso americano Bene-dict Anderson (che è tra l’altro l’inventore del termine Imagined Communities, di cui oggi ho abusato) iniziò un lungo processo in cui – cito alla lettera – «le comunità sacre integrate da vecchi lin-guaggi sacri furono gradualmente frammentate, pluralizzate, ter-ritorializzate» (40). In poche parole: invece di cercare virtualmen-te nel passato i membri delle nostre comunità e costruire insieme
(37) Una buona, recente, sintesi della politica culturale di Federigo Borromeo è in BUZZI 2005, pp. 81-88, alle cui indicazioni bibliografi che si rimanda.
(38) Sulle interrelazioni tra la dominazione spagnola in Lombardia e la politica culturale dei Borromei – argomento tanto vasto da travalicare il tema di questa comunicazione – si vedano comunque i vari contributi raccolti in BISCOTTINI 2005.
(39) Interessante, tra gli altri, la riproduzione di un rilevo con fi gure equestri ora al Museo «Giovio» di Como, sul quale già scrisse GIUSSANI 1936, pp. 137-158 (Fig. 11).
(40) ANDERSON 2000, p. 38. Il libro è stato tradotto in italiano nel 1996, e poi riedito nel 2000: il titolo originale inglese è però B. ANDERSON, Imagined Communities, London-New York 1991.
GLI INSUBRES NELLA TRADIZIONE ERUDITA: UNA «IDENTITÀ IMMAGINATA»? 381
con loro un’identità spirituale, abbiamo dovuto cercarli tra i vicini di casa o i compatrioti e «immaginarci» più simili a loro di quanto non fossimo, per costruire quelle – piccole o grandi – identità politiche, nazionali e perfi no razziali che hanno caratterizzato il mondo contemporaneo. Identità delle quali – e qui concludo – gli eruditi di cui abbiamo oggi parlato avrebbero certo faticato a co-gliere il senso, e le avrebbero forse bollate – cito ancora il Borsieri – come hallucinationes.
Fig. 11. «Rilievo dei Cavalieri» ora al Museo «Giovio», come riprodotto in BORSIERI, Como, p. 249.
382 MAURO REALI
BIBLIOGRAFIA
AGNATI 1997 U. AGNATI, Epigrafi a, diritto e società. Studio quantitati-vo dell’epigrafi a latina di zona insubre, Como 1997.
ALCIATO 2009 A. ALCIATO, Il libro degli emblemi, secondo le edizioni del 1531 e del 1534, Introduzione, traduzione, commen-to di M. GABRIELE, Milano 2009.
ANDERSON 2000 B. ANDERSON, Comunità immaginate. Origine forme dei nazionalismi, Roma 2000² .
BARNI 1957 G.L. BARNI, La vita culturale a Milano dal 1500 alla scomparsa dell’ultimo Duca Sforza, in Storia di Milano (Fondazione Treccani degli Alfi eri per la storia di Mila-no), VIII, Milano 1957, pp. 423-457.
BARNI 1973 G.L. BARNI (a cura di), Andreae Alciati Mediolanensis I.C., Antiquae Inscriptiones Veteraq. Monumenta Patriae (edizione anastatica), Milano 1973.
BELLONI 1999 A. BELLONI, Andrea Alciato e l’eredità culturale sforze-sca, in Andrea Alciato umanista europeo, Atti del Con-vegno (Alzate Brianza 1993), in «Periodico della Società Storica Comense», 61 (1999), pp. 9-25.
BERTAPELLE 1993-94 A. BERTAPELLE, L’uso delle iscrizioni nel Gallorum In-subrum antiquae sedes di Bonaventura Castiglioni, tesi di laurea (rel. prof. A. Sartori), Università degli Studi di Milano, a.a. 1993-94.
BISCOTTINI 2005 P. BISCOTTINI (a cura di), La luce dei Borromeo nella Mi-lano spagnola, Milano 2005.
BORSIERI, Como G. BORSIERI, Adversariorum ad Theatrum Insubricae Magni-fi centiae, ms. 4.4.21 della Biblioteca Comunale di Como.
BUZZI 2005 F. BUZZI, Federico Borromeo uomo di cultura, vescovo e principe mecenate, in BISCOTTINI 2005, pp. 81-88.
CALABI 1972 I. CALABI LIMENTANI, La lettera di Benedetto Giovio ad Erasmo, in «Acme», 25 (1979), pp. 5-37.
CALABI 1999 I. CALABI LIMENTANI, L’approccio di Alciato all’epigrafi a milanese, in Andrea Alciato umanista europeo, Atti del Convegno (Alzate Brianza 1993), in «Periodico della So-cietà Storica Comense», 61 (1999), pp. 27-51.
CARAMEL 1966 L. CARAMEL, Arte e artisti nell’Epistolario di G. Borsieri, in «Contributi dell’Istituto di Storia dell’Arte medievale e moderna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore», I, Milano, 1966, pp. 91-235.
CARAMEL 1971 L. CARAMEL, in Dizionario biografi co degli Italiani, 13, Roma 1971, pp. 124-125, s.v. Girolamo Borsieri.
CASTIGLIONI 1541 B. CASTIGLIONI, Gallorum Insubrum Antiquae sedes, Milano 1541.
CASTIGLIONI 2008 B. CASTIGLIONI, Gli antichi insediamenti dei Galli Insu-bri. Anastatica e traduzione, Varese 2008.
DE MARINIS - MASSA - R. DE MARINIS, S. MASSA, M. PIZZO (a cura di), Alle ori-PIZZO 2009 gini di Varese e del suo territorio. Le collezioni del sistema
archeologico provinciale, Roma 2009.
GLI INSUBRES NELLA TRADIZIONE ERUDITA: UNA «IDENTITÀ IMMAGINATA»? 383
DONATI 1988 C. DONATI, L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII, Roma-Bari 1988.
DIONIGI 2000 R. DIONIGI (a cura di), Insubres e Insubria nella carto-grafi a antica, Gavirate 2000.
DIONIGI 2002 R. DIONIGI (a cura di), Insubres e Insubria: saggio bi-bliografi co e antologia di fonti, Varese 2002.
FABIETTI 1998 U. FABIETTI, L’identità etnica, Roma 1998.GATTI 1959 C. GATTI, Gerolamo Borsieri. Passi scelti della descrizione
del Territorio Comasco al Signor Antonio Magini, in G. MIGLIO (a cura di), Larius. La città e il lago nelle de-scrizioni e nelle immagini dall’antichità classica all’epoca romantica, tomo I, Milano 1959, pp. 383-389.
GRASSI 1995 M. T. GRASSI, La romanizzazione degli Insubri. Celti e Romani in Transpadana attraverso la documentazione sto-rica ed archeologica, Milano 1995.
GRASSI 2004 M. T. GRASSI, La romanizzazione degli Insubri, in Atti del Seminario «Le popolazioni dell’Italia antica», Museo Carlo Verri di Biassono 2003, Biassono 2004, pp. 35-46.
GIUSSANI 1936 A. GIUSSANI, Il rilievo dei cavalieri romani nel Museo Ci-vico di Como, in «RAComo», XV (1936), pp. 137-158.
MARIOTTI 2009 V. MARIOTTI, Il territorio a nord di Mediolanum in epoca romana. Alcune note su popolamento, società, e modelli insediativi, in DE MARINIS, MASSA, PIZZO 2009, pp. 51-65.
MATERA-FABIETTI 1999 E. MATERA, U. FABIETTI, Memoria e identità. Simboli e strategie del ricordo, Roma 1999.
MERULA 1593 G. MERULA, De Gallorum Cisalpinorum Antiquitate ac Origine, Bergomi 1593.
PALMA 1979 M. PALMA in Dizionario biografi co degli Italiani, 22, Roma 1979, pp. 124-126, s.v. Bonaventura Castiglioni.
PIAZZESI 2009 S. PIAZZESI, Girolamo Borsieri. Un colto poligrafo del Sei-cento, Firenze 2009.
RAMPONI 1955 C. RAMPONI, Il principe degli umanisti novaresi Gauden-zio Merula (nel IV centenario della morte), in «Bollettino Storico per la provincia di Novara», 46 (1955), pp. 189-196.
REALI 1989 M. REALI, Le iscrizioni latine del territorio comense set-tentrionale, in «RAComo», 171(1989), pp. 207-297.
REALI 1991 M. REALI, Iscrizioni latine reimpiegate nel complesso del monastero di Torba, in «Riv. St. Antichità», XXI (1991), pp. 197-218.
REALI 2004 M. REALI, Le microcomunità locali sulle nostre pietre, in Atti del Seminario «Le popolazioni dell’Italia antica», Museo Carlo Verri di Biassono 2003, Biassono, 2004, pp. 69-86.
REALI 2006 M. REALI, Forme diverse di integrazione nell’epigrafi a comense, in A. SARTORI, A. VALVO (a cura di), Atti del Colloquio «Italia-Hiberia / Hiberia-Italia», Gargnano del Garda - Brescia, 2005, Milano 2006, pp. 305-325.
384 MAURO REALI
REALI 2007 M. REALI, Parole per pochi, parole per tutti: note epigra-fi che sul Gallorum Insubrum antiquae sedes di Bonaven-tura Castiglioni (1541), in A. SARTORI (a cura di), Atti del Seminario Parole per tutti, III Incontro di Diparti-mento sull’epigrafi a, Milano 2006, Università degli Studi, «Acme», LX, III (2007), pp. 121-135.
REALI 2009A M. REALI, Cultores del passato celtico: erudizione, reli-giosità, folklore, in Atti Workshop FERCAN «Dedicanti e cultores: alcuni aspetti», Gargnano del Garda 2007, Mi-lano 2009, pp. 174-194.
REALI 2009B M. REALI, Echi di vita militare nell’epigrafi a sacra del-l’Ager Insubrium, in C. WOLFF, Y. LE BOHEC (a cura di), Atti del Congresso «L’armée e la religion», Lione 2006, Lyon 2009, pp. 77-85.
REALI 2010 M. REALI, Le «microcomunità» insubri: localismo o in-tegrazione?, in F. J. NAVARRO (a cura di), Pluralidad e integración en el Mundo Romano. Atti del Colloquio «Italia-Hiberia/Hiberia-Italia». Pamplona-Olite, 2008, Pamplona 2010, pp. 93-108.
REMOTTI 2007 F. REMOTTI, Contro l’identità, Roma-Bari 2007.SALMERI 1988 G. SALMERI, Letture di Strabone nel XV e XVI secolo, in
G. MADDOLI (a cura di), Strabone e l’Italia antica, Peru-gia 1988, pp. 289-312.
SARTORI 1994 A. SARTORI, Le iscrizioni romane. Guida all’esposizione, Como 1994.
SARTORI 1999 A. SARTORI, L’Alciato e le epigrafi : «tractavimus subsci-vis horis huiusmodi naenias», in Andrea Alciato umani-sta europeo, Atti del Convegno (Alzate Brianza 1993), in «Periodico della Società Storica Comense», 61 (1999), pp. 53-81.
SARTORI 2000 A. SARTORI, I rapporti tra città e campagna: l’osmosi de-mografi ca, in Atti del Congresso «Milano in età repubbli-cana e augustea», Milano 1999, Milano, 2000, pp. 55-70.
SARTORI 2009 A. SARTORI, Le pietre iscritte di Angera, in DE MARINIS, MASSA, PIZZO 2009, pp. 364-370.
SARTORI 2010 A. SARTORI, Gli Insubri ci sono anche oggi (Strab. V, 1,6), in F. J. NAVARRO (a cura di), Pluralidad e integración en el Mundo Romano. Atti del Colloquio «Italia-Hiberia/Hiberia-Italia». Pamplona-Olite, 2008, Pamplona 2010, pp. 15-24.
STORTI 2002 C. STORTI, Insubres sumus non latini. In nota alle fonti storiche lombarde sulla regio Insubria tra XV e XIX seco-lo, in DIONIGI 2002, pp.20-47.
Presentazione ....................................................................................... p. 7
Elio Franzini, Il dialogo tra le culture .............................................. » 11
Francisco Javier navarro, Senadores orientales y senadores hispanos: dos identidades contrapuestas ...................................................... » 14
Alfredo valvo, L’identità originaria dei Romani nei testi epigrafici più antichi ...................................................................................... » 37
Antonio D. Pérez zurita, Un aspecto de la autonomía de las ciu-dades: la gestión de la cura urbis .................................................. » 45
José D’encarnação, Identità e autonomie nella Lusitania romana occidentale ..................................................................................... » 65
Andreina MagioncalDa, Principes gentis ......................................... » 79
Antonio Sartori, L’identità delle identità ......................................... » 97
Carmen rueDa, Modelos de interacción: la divinidad como instru-mento de análisis en los procesos de transformación de la sociedad ibera (siglos III a.C.- I d.C.) .......................................................... » 107
Alfredo BuonoPane, Civis Anaunus: integrazione e identità etnico-culturale in area alpina. Un caso emblematico ............................ » 141
Enrique Melchor gil, Sobre los magistrados de las comunidades hispanas no privilegiadas (s. III a.C. - s. I d.C.) ......................... » 151
Gabriella PoMa, Gli Umbri a nord dell’Appennino: un’identità «fluida» .......................................................................................... » 173
Gonzalo cruz anDreotti, Identidad e identidades en el sur de la península ibérica en época romana: un problema histórico y geográfico ....................................................................................... » 209
INdICE
Giovanni Mennella, Presenze ebraiche tardoantiche nelle campagne vercellesi ......................................................................................... p. 227
Guido Migliorati, Identità e percezione delle externae gentes in dexippo, fr. 6 Jacoby .................................................................... » 237
donato FaSolini, Un tema caro a Giovanni Forni: l’anagrafia dei soldati ............................................................................................. » 247» 247
Maria Federica Petraccia - Maria traMunto, Il contributo dell’epigrafia alla storia politica e sociale di un municipio dell’Italia romana: Tuficum ........................................................... » 257
Marina vavaSSori, Nuclei familiari emergenti nell’area bergomense » 277
Joaquín l. góMez-Pantoja, un nuevo terminus Augustalis en Lu-sitania ............................................................................................. » 291
Maria Silvia BaSSignano, Pagi nella Venetia: alcuni esempi ............ » 319
Francisco Pina Polo, Los Cornelio Balbo: clientes en Roma, patronos en Gades ........................................................................................ » 335
Santiago Montero, Los aruspices y los cultos orientales. Identidad y alteridad ...................................................................................... » 355
Mauro reali, Gli Insubres nella tradizione erudita: una «identità immaginata»? ................................................................................. » 367
Cristina BaSSi, Onomastica e affermazione dell’identità: il caso di Monte S. Martino nel contesto del territorio dei Benacenses ..... » 385
Juan Manuel aBaScal Palazón, Bilingüismo literario y bilingüismo iconográfico como expresión de la identidad étnica en la Hispania romana ........................................................................................... » 413
Simona MarcheSini, Identità multiple o ethnic change durante la romanizzazione: il territorio attorno al Garda ............................ » 435
Simonetta Segenni, Contiones in ambito municipale: autonomia cittadina e ruolo del populus ........................................................ » 455
María Victoria eScriBano Paño, Autonomía e identidad en el cristianismo hispano (s. IV): conflictos internos y formas de solución .......................................................................................... » 465
Sergio lazzarini, Rinsaldare una città: Roma e Conum dopo la scorreria dei Reti. Spunti per un parallelismo fecondo tra diritto pubblico e privato ......................................................................... » 495
Angela Donati, Identità, autonomie: un binomio difficile .............. » 509























![Italia sacra w czasach Brunona [Italia sacra in the times of Bruno of Querfurt] (2010)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631a38abb41f9c8c6e0a1976/italia-sacra-w-czasach-brunona-italia-sacra-in-the-times-of-bruno-of-querfurt.jpg)